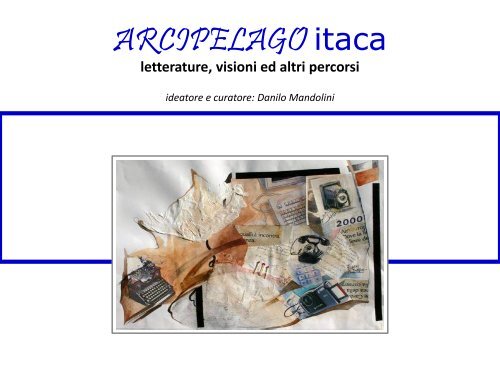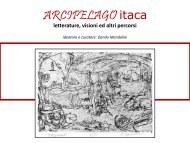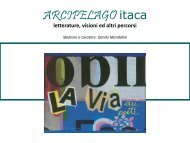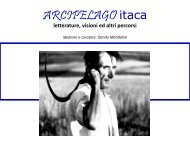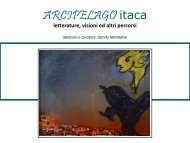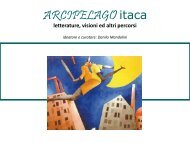Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Leonardo Mancino - Arcipelago Itaca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARCIPELAGO itaca<br />
letterature, visioni ed altri percorsi<br />
ideatore e curatore: Danilo Mandolini
*…+<br />
Ma ei non brama che veder dai tetti<br />
sbalzar della sua dolce <strong>Itaca</strong> il fumo,<br />
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi.<br />
Omero, Odissea - Libro I<br />
AVVERTENZA.<br />
ARCIPELAGO itaca è un’iniziativa realizzata senza fini di lucro, resa disponibile nel solo formato digitale e distribuita gratuitamente, via e-mail e tramite<br />
internet (www.arcipelagoitaca.it), a circa 700 tra associazioni ed operatori culturali, riviste di letteratura e non, critici, scrittori ed estimatori.<br />
ARCIPELAGO itaca non è da considerarsi una testata giornalistica in quanto non ha periodicità e non può pertanto essere considerata un prodotto<br />
editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001.<br />
Testi ed immagini contenuti in ARCIPELAGO itaca sono riprodotti, quando possibile e per lo più, previo espresso consenso dei relativi autori (sono<br />
sempre e in ogni caso citati gli autori e/o le fonti di reperimento).<br />
ARCIPELAGO itaca è un marchio registrato.
Le riproduzioni<br />
di cinque opere di Enzo Esposito<br />
e di singole opere di Giovanna Ugolini, Cosimo Budetta, Alfredo Malferrari e Giordano Perelli<br />
commentano questa terza apparizione di ARCIPELAGO itaca.<br />
L’ordine di presentazione degli autori di VOCI, eccezion fatta per le sezioni OPERA PRIMA e SOLO INEDITI -<br />
che sono rispettivamente in apertura e chiusura, è alfabetico.<br />
echi<br />
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>,<br />
con una testimonianza inedita di Biagio Balistreri<br />
ed un’intervista a cura di Raffaella Bortolin<br />
voci<br />
OPERA PRIMA: Le rondini di Manet<br />
di Anna Elisa De Gregorio<br />
Gianni Caccia<br />
Massimo Gezzi<br />
Franca Mancinelli<br />
Liliana Ugolini<br />
SOLO INEDITI: Marina Pizzi<br />
Collage Charles Baudelaire<br />
1 - 37<br />
38 - 56<br />
57 - 93<br />
94 - 127<br />
128 - 159<br />
160 - 192<br />
193 - 204<br />
205<br />
Quarta apparizione
GLI ARTISTI<br />
In copertina: un collage su carta (cm 70 x 50) di Giovanna Ugolini.<br />
Giovanna Ugolini è nata e vive a Firenze. Artista visiva poliedrica e prolifica è da sempre vicina alla poesia<br />
(www.giovannaugolini.it).<br />
Cosimo Budetta. È nato a Salerno nel 1939. Vive e lavora ad Agromonte, in provincia di Potenza. È tra i fondatori del Laboratorio<br />
“Dadodue” e uno dei promotori del “Gruppo di ricerca” di Pontecagnano (SA). È curatore delle edizioni d’arte “Ogopogo”<br />
(www.cosimobudetta.it).<br />
Enzo Esposito. È nato a Benevento, nel 1946. Vive e lavora a Milano. È stato esponente di spicco dei “Nuovi Nuovi”, gruppo<br />
fondato da Renato Barilli agli inizi degli anni ‘80. Ha partecipato a numerose esposizioni nei più importanti musei italiani e<br />
stranieri (www.enzoesposito.com).<br />
Alfredo Malferrari. È nato a Castelfranco Emilia (MO), nel 1946. Vive a Bologna.<br />
Giordano Perelli. Incisore e scultore. È nato a Bellocchi, nel 1943, e vive a Fano.
echi
Cosimo Budetta. Medusa, disegno su carta
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
Per continuare a contrastare, almeno idealmente, il silenzio che in questi anni sembra spesso accompagnare e seguire<br />
(a volte anche precedere) la morte dei poeti, dedichiamo qui un ampio spazio - con una selezione di liriche curata da<br />
Danilo Mandolini, una testimonianza inedita di Biagio Balistreri ed un’intervista di Raffaella Bortolin (da POESIE, 1966 -<br />
1998, Stamperia dell’Arancio, 2004) - al ricordo di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>: autore di versi e critico vissuto tra Marche e Puglia e<br />
recentemente scomparso alla soglia del compimento dei suoi 71 anni.<br />
Se allo spazio che segue si volesse attribuire un titolo, pensiamo che questo non possa non essere che quello -<br />
potente e probabilmente prossimo all’idea che lo stesso poeta aveva del vivere - utilizzato per la prima antologia della<br />
poesia manciniana: L’UTOPIA REALE, edita, nel 1994 e con un’introduzione critica di Giovanni Tesio, da Caramanica.<br />
L’utopia reale
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
1<br />
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong> è nato a Camerino (MC) il 7 dicembre del 1939.<br />
È stato poeta e saggista prolifico. Ha infatti pubblicato numerose opere in<br />
versi e contributi critici, soprattutto su autori italiani (Pier Paolo Pasolini,<br />
Paolo Volponi, Vittorio Sereni, Andrea Zanzotto, Carlo Levi, Cesare Pavese,<br />
<strong>Leonardo</strong> Sinisgalli, Franco Fortini, Vittorio Bodini, Rocco Scotellaro, <strong>Leonardo</strong><br />
Sciascia, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, David Maria Turoldo, Luigi<br />
Bartolini ed altri) e su questioni e problemi inerenti la letteratura del secolo<br />
scorso.<br />
Ha fondato e diretto la collana “I TESTI” dell’editore Lacaita e la collana “La<br />
biblioteca dell’invenzione” della casa editrice Stamperia dell’Arancio di<br />
Grottammare (AP). Con il poeta e critico Vincenzo Guarracino ha organizzato<br />
collane editoriali leopardiane.<br />
Ha collaborato con diversi quotidiani e alla realizzazione di programmi RAI,<br />
radiofonici e televisivi, soprattutto per le sedi regionali di Puglia e Basilicata.<br />
È stato traduttore dall’inglese, francese, spagnolo, portoghese, bulgaro,<br />
rumeno e dal latino e greco. Le sue poesie sono state tradotte in diverse<br />
lingue.<br />
Dopo lungo tempo trascorso in Puglia (lavorando nella scuola,<br />
partecipando attivamente alla vita culturale di questa regione ed intessendo<br />
rapporti con numerosi artisti di questa stessa terra) è ritornato<br />
definitivamente nelle Marche; regione, questa, dalla quale non si era mai, e<br />
di fatto, allontanato.<br />
È scomparso a Civitanova Marche (MC), all’inizio del mese di ottobre del<br />
2010.
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>. Le opere<br />
2<br />
Poesia<br />
• Tutto è luce, Pensiero ed arte, Bari, 1966<br />
• In tema d’esistenza (con prefazione di Adriano Grande), S.E.N., Roma, 1968<br />
• Alle radici dei gesti ed altre cose (con prefazione di Giorgio Barberi Squarotti), Lacaita, Manduria (TA), 1971<br />
• Per struttura s’intende… (con prefazione di Mario Lunetta), Geiger, Torino, 1973<br />
• La bella scienza (con prefazione di Giuliano Manacorda), Cappelli, Bologna, 1974<br />
• Il sangue di Hébert (con prefazione di Roberto Roversi e postfazione di Andrea Zanzotto), Lacaita, Manduria (TA),<br />
1979<br />
• Dopo la scienza, Ribichini, Castelplanio (AN), 1982<br />
• La dissipazione del talento - I colli Marchigiani, Levante, Bari, 1985<br />
• Dichiarazioni silenzio e giorni, Cappelli, Bologna, 1987<br />
• La casa la madre il colle e l’orto, Schena, Fasano (BR), 1989<br />
• In saturno in sogno e mistero ed altre poesie, Il Ventaglio (Paso Doble), Roma, 1991<br />
• L’ultima rosa dell’inverno, Campanotto, Udine, 1993<br />
• Albarosa del mattino, Stamperia dell’Arancio, Grottammare (AP), 1993<br />
• L’utopia reale (Antologia – Con introduzione critica di Giovanni Tesio), Caramanica, Marina di Minturno (LT), 1994<br />
• La curva di Peano, Stamperia dell’Arancio, Grottammare (AP), 1999<br />
• Breve e pianissimo, Signum edizioni d’arte, Bollate (MI), 2000<br />
• Vi dico prendendo la lira di poeta (quattro poesie per Floriana), con prefazione di Alberto Cappi e un’acquaforte<br />
originale di Antonio Laurelli, Macerata, edizione privata, 2002<br />
• Le virtù, le occasioni, le cose, GED – Biblioteca di Ciminiera, Civitanova Marche (MC), 2003<br />
• Ultimi canti della solitudine, Edizioni “Fiori di Torchio”, Seregno (MI), 2003<br />
• Dove un perfetto sofisma. Poesie, 2001-2003 (introduzione di Antonio Tricomi), Stamperia dell’Arancio, Grottammare<br />
(AP), 2003<br />
• Poesie, 1966 – 1998 (Antologia - A cura e con un saggio introduttivo di Massimo Fabrizi), Stamperia dell’Arancio,<br />
Grottammare (AP), 2004
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>. Le opere<br />
3<br />
Saggistica<br />
• Omaggio a Bodini, Lacaita, Manduria (TA), 1972<br />
• Omaggio a Scotellaro, Lacaita, Manduria (TA), 1974<br />
• Oltre Eboli la poesia. Antologia della lirica “civile” meridionale, Lacaita, Manduria (TA), 1979<br />
• Dove c’è la parola, in Biagio Balistreri, Respiro l’aria del sud, Lacaita, Manduria (TA), 1980<br />
• Nicola Vapzarov. Poesie e materiali, Ed. Quattrocittà, Bari, 1981<br />
• Respirare la speranza (sulla poesia di C. Francavilla), Schena, Fasano (BR), 1982<br />
• Lo scrittore vulnerabile, La Nuova Italia, Firenze, 1984<br />
• Per Vittorio Bodini, Fascicolo monografico di “In Oltre”, 1991 Luigi Bartolini e la metafora tra asperità e dolcezza, in<br />
Luigi Bartolini, Per queste piagge ove non altro, Stamperia dell’Arancio, Grottammare (AP), 1993<br />
• Transito e forza del ricercatore operoso. Luigi Bartolini e la critica nel centenario della nascita, Stamperia<br />
dell’Arancio, Grottammare (AP), 1995<br />
• Il rosso segnale della poesia. L’opera di Franco Matacotta, Stamperia dell’Arancio, Grottammare (AP), 2000<br />
• Dove è finito il gioco. L’infanzia nella poesia italiana del Novecento, Editoriale Sometti, Mantova, 2002.<br />
• Uomini e idee dell’Italia civile (ancora sull’utopia reale), Palomar, Bari, 2004<br />
• Scrittori e questione meridionale. Scrivere a Sud, scrivere il Sud, Palomar, Bari, 2006
Da Tutto è luce, 1966 e In tema d’esistenza, 1968<br />
Da Tutto è luce<br />
Gabbiani<br />
S’alzano<br />
in un momento<br />
i gabbiani<br />
sul mare.<br />
I pescatori,<br />
poeti malati sull’acqua,<br />
con voce<br />
di cartapecora<br />
vivono con loro<br />
e non s’accorgono.<br />
Schizzati<br />
nell’aria<br />
planando<br />
recitano i versi della natura.<br />
Senza bestemmie<br />
senza croci<br />
la vita<br />
loro<br />
senza rancori.<br />
Poeti malati di mare.<br />
Da In tema d’esistenza<br />
Poema in corollari<br />
Strilla l’uccello<br />
nel vento della sera.<br />
Rotola a valle<br />
quel suono di mistero<br />
il verde nuovo<br />
dopo la bufera,<br />
l’aperto gesto,<br />
il colore dei meli<br />
nei giardini<br />
il pensiero amaro<br />
che ai passi brevi d’una vita<br />
s’attanaglia<br />
come le nubi<br />
stanche<br />
in cima della groppa di montagna.<br />
Come la vita<br />
quando ti disarma.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
4
Da Alle radici dei gesti ed altre cose, 1971<br />
Lettera sulla condizione<br />
Ed io ti dico che il rancore esiste<br />
esiste<br />
l’uomo bocconi sulle pietre<br />
esiste e scende giù negl’interstizi<br />
e grumi sotto la storia di questa terra.<br />
a Vittorio Bodini<br />
Ed io ti dico che il rancore esiste<br />
esiste<br />
perché il poeta è<br />
prima di tutto<br />
un provocatore.<br />
Prima di tutti.<br />
Il discorso comincia nonostante il fuoco<br />
resta la favola di significato oscuro<br />
inviolata<br />
impenetrabile;<br />
il poeta non s’umilia né può umiliarsi<br />
a sostenere gli occhi con l’uomo della strada<br />
il suo vantaggio<br />
è vivere il rancore.<br />
Ecco perché ti dico che il rancore esiste<br />
troppe voci spente troppi ricordi<br />
e troppi voli a tratti nella notte<br />
troppi silenzi.<br />
Ed io ti dico<br />
che il rancore esiste.<br />
Ode al viaggio di notte<br />
Non c’è parete<br />
più nera<br />
che possa narrare<br />
la storia. L’uomo solo<br />
non vince i suoi pensieri<br />
né può contare<br />
le cose. Forse cerca<br />
una preghiera<br />
che non sa più dire<br />
forse<br />
cerca gli occhi<br />
che la mattina<br />
rendono più pesante<br />
più chiaro il suo presagio,<br />
forse in questa vita<br />
di sobbalzi<br />
cerca compagni per la morte<br />
forse.<br />
E lì si definisce<br />
il senso d’una sorte<br />
e l’anima si strugge<br />
mentre l’occhio<br />
fugge l’ombra e la paura.<br />
L’uomo solo non vince<br />
i suoi pensieri<br />
le luci fioche<br />
a margine<br />
d’un orizzonte sconosciuto<br />
venire e sparire in gioco<br />
venire e sparire,<br />
mentre la coscienza<br />
senza soste si muove<br />
e danze di terrori. Non c’è parete<br />
più nera né l’uomo<br />
può narrare la sua storia.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
5
Da Per struttura s’intende, 1973<br />
Poesia/no<br />
Sentire<br />
cercare<br />
vincere<br />
l’azzardo della partita per il poeta<br />
non c’è zona franca<br />
nell’hinterland dei segni<br />
delle parole che si fanno<br />
spruzzi di veleno e cose amare<br />
il male alle radici quello che vince<br />
le ragioni di ciascuno<br />
non c’è zona franca<br />
la mano irsuta stringe<br />
la colomba<br />
s’ingaggia “lotta di sangue”<br />
scrive il poeta i suoi graffi<br />
una circoncisione ogni giorno<br />
la memoria non recupera l’innocenza<br />
d’un tempo<br />
(chi sa - poi - quali furono le basi<br />
le radici<br />
i timori innocenti)<br />
per vincere l’azzardo della partita<br />
il poeta<br />
rischia<br />
in proprio<br />
l’usura senza manuali senza leggi<br />
se non quelle comprensibili alla sua ira di sempre<br />
alloscoperto!<br />
perché poi? dalla parte dei poveri cambiare il mondo?<br />
le parole?<br />
“Uccidetelo per i suoi pessimi versi!”<br />
Non ha diritto di far rivoluzione<br />
Manuale del perfetto guerrigliero<br />
Le parole faranno guerriglia quando non<br />
saranno più memorie di rituali osceni<br />
la colpa incorona lo stesso poeta<br />
Manualeeeeeeeeeee<br />
Il poeta per fare la sua guerra resti poeta<br />
per l’azzardo del mondo<br />
resista da miserabile.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
6
Da Per struttura s’intende, 1973<br />
Comitato di salute p…<br />
Il gufo il collo torto<br />
muore di fenomeni<br />
di gas<br />
non c’è buco peloso d’erba antica<br />
che possa ospitare le notti<br />
più<br />
gas<br />
“Fit enim placentia animae, quae pulchritudo<br />
dicitur, quandoque ex comprehensione simplici<br />
visibilium formarum ut patet…”<br />
(Vitellonis Opticae liber quartus, theorema 148).<br />
Una fila di previste<br />
utopie: poi si faranno I conti con le conseguenze<br />
del consumo industriale<br />
mostrare ma cosa?<br />
luna e stelle<br />
luce<br />
luna e stelle<br />
tutto ciò ch’è cagione<br />
di… bellezza<br />
gas<br />
cagione di morte;<br />
gli stessi colpevoli chiedono aiuto agl’innocenti<br />
così l’aurora discende da oriente<br />
gode la gobba di mostro il primo sole<br />
dinnanzi all’uomo esterrefatto<br />
la spirale calva<br />
eguale<br />
cagione e ronzio improvviso<br />
così comico (rima con economico!)<br />
raggiungere la morte facendo i conti<br />
con le conseguenze del consumo industriale (rima con feudale!)<br />
lo scrivere inutile<br />
il leggere inutile<br />
cantare inutile<br />
è tempo d’altri segni e suoni<br />
la rete, gli occhi-sangue di livore<br />
d’ira<br />
la rabbia nella rete immobile vittima<br />
in fondo è anche così che<br />
si muore d’amore.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
7
Da La bella scienza, 1974<br />
Come datare queste storie…<br />
come datare queste storie<br />
nate nel mese ics<br />
dal viaggio tale (e la partenza?<br />
l’arrivo? il tempo?)<br />
nate così.<br />
Occorreva rifare<br />
un viaggio tra gli angeli<br />
che sostano su queste<br />
scogliere<br />
le tribù amiche<br />
le tribù nemiche<br />
ancora le tribù amiche<br />
(una speranza che<br />
non si sopisce)<br />
ma i nemici esistono sempre.<br />
Raccontano di un grande<br />
di Spagna che si lanciò da queste finestre<br />
e si trovò<br />
l’anima trafitta d’alabarde<br />
nessuno racconta delle cento<br />
e cento alabarde<br />
delle cento picche e lance<br />
del fumo dietro<br />
le tibie<br />
bruciate, dei cumuli<br />
di membra di questo mezzo secolo<br />
d’angoscia. luglio 1971<br />
L’anima di questa terra<br />
E mentre portano<br />
sulla carretta che piscia sangue<br />
l’anima di questa terra<br />
senza rapporti senza presente<br />
suda<br />
e si lievita dentro<br />
contro tutti gli alfabeti<br />
contro<br />
la ragnatela di filo di ferro<br />
nero e ruggine<br />
il vetriolo d’una forza spavalda<br />
e mai sopita<br />
non è più il sangue<br />
di chi morde la coda<br />
è il sangue di<br />
. . . . . . . . . .<br />
spalle di popolo che<br />
rischia la vita<br />
mentre portano<br />
l’anima di questa terra<br />
l’occhio<br />
si volge messaggio alla luna.<br />
Molina, luglio 1971<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
8
Da La bella scienza, 1974<br />
Chiave d’antilettura gi<br />
Mixage<br />
non sono affatto triste<br />
triste<br />
anche se questi materiali<br />
mi diventano labili<br />
sotto la penna<br />
ho vissuto la vita<br />
di cento padri<br />
e cento madri<br />
non sono mai stato<br />
figlio.<br />
Chiave d’antilettura emme<br />
La morte<br />
passa tra noi<br />
di forma in forma<br />
come il quotidiano…<br />
…come se fosse<br />
l’ultimo compagno<br />
come se portasse<br />
(un tempo, ricordi?)<br />
i sorsi<br />
di latte nero ed utopia.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
9
Da La bella scienza, 1974<br />
Fatti parte diligente…<br />
Fatti parte diligente, prendi ancora (nonostante consigli e sventura)<br />
il tuo cahier d’inguaribile narcisista<br />
e dacci prova<br />
una volta ancora del veleno di carboncino nero.<br />
Penso proprio che tu scriva segni<br />
con un fallo anchilosato. Ma fatti parte diligente: scrivi,<br />
dicci ancora le cose come TU le vuoi<br />
inventa ancora le macchie di sangue che non hai mai visto<br />
e le infezioni e le cancrene che ti turbano il sonno. Tanto<br />
lo sai (tu stesso): non v’è differenza<br />
(ma non ce lo potrai imporre!)<br />
tra le tante ics ed i serpenti di gomma<br />
da circo tra le fandonie e l’arte (tua)<br />
tra le storie che crei ed il mondo che ti chiede sosta, una sola.<br />
Figlio dei caroselli di parole<br />
delle lune d’argento, amato canzonettista<br />
dalla folla di piazza la domenica sera. Non sai<br />
nemmeno contro chi conduci la macchina di guerra<br />
contro chi ti muovi<br />
e con chi stai<br />
e contro chi si rizza il tuo rancore.<br />
Ecco<br />
ma si faccia egregio signore parte diligente<br />
si faccia, forse è meglio, chi lo sa che il lei non s’addica<br />
alla perorazione…<br />
in fondo la storia si ripete. Il diritto dei potenti? una conferma.<br />
L’ultima volta, poi non starà a lei<br />
(né a me) decidere gl’incontri né s’addice continuare<br />
i sussurri e la menzogna. I codicilli, un mondo di cui<br />
ella - celebrato poeta -<br />
ha pieno diritto a farne parte.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
10
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
Morire con gli ulivi<br />
Morire<br />
con gli ulivi (degli ulivi) e con l’amaro<br />
(dell’amaro) delle foglie di tabacco<br />
magari rinascere se sarà rinascere Poi<br />
negli abitacoli<br />
dove trovarsi e provare l’offesa<br />
dove<br />
prender la forza e tutte le coscienze<br />
Fare il verso<br />
l’amore<br />
mangiare nel palmo della mano<br />
bere fino al veleno che s’abbarbica<br />
ed attanaglia il nucleo l’equilibrio<br />
sommerge<br />
senza sorpresa la macchina<br />
Sarà rinascere per mor…<br />
allora vale finirla<br />
i simboli cerchifoglie lampi<br />
uova di gesso e testa di corolle<br />
qualsiasi fiore<br />
qualsiasi nostalfermentazione ecco<br />
scrivere con le mani e la pazienza<br />
(esercizi blasfemo quot…)<br />
il poema della generazione<br />
ognuno sceglie poi proteggere l’uomo buono<br />
dalla società criminaltera della sublime<br />
conoscenza<br />
specifica dei mezzi della distruzione<br />
scarsa lungimiranza<br />
non aver la faccia (né cuore) della<br />
remissione dei peccati<br />
la lunga guerra dei giorni:<br />
vale battere ogni anfratto ogni sezione<br />
di parola, ogni<br />
sorriso osceno, battere il mito dell’oggetto completo<br />
in tutte le sue…<br />
anche<br />
inventare la forma è tempo perso<br />
inventare la vita con gli altri<br />
reticenze e memorie<br />
morte da sempre<br />
da sempre<br />
inventare per sé<br />
la morte empia senza perdono senza richiesta pietosa<br />
se camera deve essere<br />
“dopo la rivolta<br />
dopo la congiura”<br />
allora sia pure<br />
massa sanguigna attaccata dagli ossidi<br />
dai giorni<br />
dalle ferite<br />
dai veleni nati al caldo della volontà<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
11
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
irrevers… di fineeeeeeee<br />
sulla superficie contratta<br />
praticare il sentiero attendere la metastasi<br />
prima vivere<br />
l’altro (l’Altro)<br />
poi morire solo<br />
in compagnia del sangue<br />
della nascita<br />
prima ogni forza<br />
ogni<br />
efficienza usata contro gli obiettivi<br />
contro i bersagli poi<br />
togliere agli altri il peso dei lamenti<br />
una parola<br />
(lettera sulla condizione)<br />
arcangelo<br />
la classe uguale vita<br />
l’anima la morte<br />
e scrivere<br />
poesia con la sola parola<br />
possibile<br />
e violenza alle malincospirazioni<br />
Nota al testo<br />
(in L’utopia reale, 1994)<br />
Arcangelo Leone De Castris, a cui questa poesia è dedicata, offre la possibilità al poeta (“L’anima e la classe”) di verificare le attese rigorose dell’ideologia.<br />
Quel libro finisce dove comincia la misera e comoda decoscientizzazione politica di certi detrattori.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
12
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
Sed vitae…<br />
contro<br />
Mitomania del pittoresco morte<br />
basale delle antiche purità<br />
beneficenza<br />
diritto/conoscere i sensi delle cose<br />
vita a margine<br />
ed i sogni che passano<br />
ed i rancori per l’animo assorto<br />
del bracciante<br />
e aria di setole<br />
e criniera di cavallo bastardo<br />
crocifisso tra i pali della forca<br />
del carro: c’è<br />
una (la solita) rondine di più<br />
altro che vezioni e palinsesti<br />
l’utopia (altro)<br />
perché poi fattorizzare<br />
accanito ogni aspetto della condizione<br />
umana?<br />
i ragazzi sostano all’angolo<br />
battono la mano sulla spalla d’eros<br />
la supposta capacità d’inglobare<br />
mondo<br />
e mondi<br />
dove abbiamo mancato<br />
il geroglifico sociale genuflette ogni<br />
possibilità<br />
ed è lontano<br />
l’alterco<br />
hanno letto di politica culturale<br />
dei partiti della condizione<br />
tredicenne d’aprire cuore al bacio<br />
forsennato della solitudine<br />
già soli<br />
né vale accostarsi e parlare<br />
confessare l’assenza<br />
l’egoismo del sorriso corruttore<br />
- non è recuperare i meccanismi<br />
della circoncisione e dei fonemi<br />
in gioco!<br />
è l’uomo che non crede nemmeno<br />
a se stesso<br />
alle sue passioni<br />
alle mani<br />
al passo incerto<br />
al dubbio sul bersaglio dei segni<br />
di questi segni<br />
della vita-segno<br />
la macchina rossa<br />
veloce trapassa<br />
il gruppo dei ragazzi<br />
l’elmo di pietra<br />
la mano sicura<br />
ferma<br />
dura<br />
così<br />
si riempie il rito<br />
ed i delitti<br />
sed vitae<br />
ogni umana funzione<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
13
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
Pasolini vivo<br />
E mentre i monatti attendono alla finestra, solo il senso<br />
(non facile occasione) nelle piste d’un cielo: facci vivere<br />
fandonie, gli stracci soli con la loro dignità<br />
nulla vale che non sia conquistato dalle<br />
mani povere dell’uomo. Abbaiano nei vicoli cagne<br />
randage<br />
un lontano colloquio<br />
strano e stupidamente il cercare lo specchio negli occhi<br />
un verde bucciato contro il nero delle chiese e dei presagi<br />
contro i sigilli che poneva la tua voce di civetta malvagia<br />
e astuta: in fondo tentativo d’isolare le case dal mondo.<br />
Parlare<br />
di passione, axel, mentre il farsi è dentro, focoso corridore<br />
di parole ai pali del ritorno quando si perde ogni lingua<br />
e dove finisce la farsa ignobile (ora si esercitano…) dei corvi,<br />
dove<br />
si perde ogni pertinenza facile/folle, equivoche le voci<br />
equivoche parole, equivoco dei sospiri<br />
equivoco<br />
società, si castrano i poveri fanciulli/figli dei poveri<br />
dove?<br />
società-parola-idea<br />
denunciare angosce violenze viltà e realtà<br />
obietti contro la mitologia dell’intelligenza italica<br />
we will have a total poeta<br />
rivoltarsi e parlare e per dio!<br />
scegliere la parte<br />
celebrare-odiare-rivoltarsi<br />
volere/non volere un’epoca, bestemmia<br />
tranche de vie una parola, un verso, macchina da guerra<br />
costruita coi cristalli d’inchiostro veleno e sangue<br />
e pensare che non credevamo possibile scrivere<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
14
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
poesia<br />
col sangue, non credevamo possibile questa tua tragica<br />
semplicità per guarire<br />
dal male dei domìni di follia: tranche de vie. Nei sinuosi<br />
anfratti<br />
scoperti tra la miseria mondourlante<br />
tu<br />
lievemente malvagio mentre dissimulavi nelle viscere quelle<br />
malizie<br />
morire d’amore e d’utopia - dopo - sulle ceneri<br />
ritrovarsi a scrivere<br />
sulle tue ferite<br />
solo la miserabilità dei puri detrattori<br />
(on massacrerà les poètes)<br />
evangelo come piantarsi dentro un segno, cifra, una condanna<br />
privilegiare i poveri sani<br />
e tutte le altre facce senza classe senza storia. In un mondo<br />
ottuso più che cattivo<br />
tu né puro né santo<br />
né martire. Non muore facilmente<br />
neppure<br />
ad uso degli stolti savoir faire di merda il diavolo che si sceglie<br />
dentro<br />
e la coscienza<br />
sapere a che gioco giocare<br />
l’utopia del segno<br />
per uccidere i segni. Non fu inutile<br />
giungere e sentirsi dire “i nomadi i briganti”<br />
i sentimenti<br />
li portiamo con noi come i figli come le copule<br />
fin dove alberga lucida una pazzia, la bestia<br />
del poeta detrattore<br />
perché si cerca l’innocenza?<br />
Nota al testo<br />
(in L’utopia reale, 1994)<br />
La poesia è stata pubblicata in una cartella con<br />
altre (Per Pasolini detrazioni e laude) di Lunetta,<br />
Riviello, Matacotta, Roversi, Toti e con incisioni di<br />
Guerricchio e Verrusio. Un incontro romano con<br />
Pasolini privato fu dedicato per intero al<br />
brigantaggio come “a monte” della componente<br />
rivoluzionaria nel contadino meridionale. Facci<br />
vivere: Eduardo De Filippo su “Paese sera”, in un<br />
articolo in morte di Pasolini scrisse: “…faccio<br />
vivere la verità del Cristo povero”.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
15
Da Il sangue di Hébert, 1979<br />
Casa penale<br />
E che vuoto questo silenzio<br />
quest’aria ferma giocata<br />
nell’ombra<br />
l’abisso ci siamo vissuti tutti dentro<br />
la muraglia qui pensare la morte<br />
e quale fu l’assillo<br />
ci siamo vissuti dentro<br />
la storia il piccolo testardo al di qua<br />
della luce<br />
fuori l’abbaglio dei lampi<br />
la grande volontà la condanna la sfida spietata<br />
ogni parola nata<br />
dalla ragione ogni solerte pensiero ogni sguardo<br />
la faccia gonfia il dolore<br />
respinto dentro l’anima dalla pietra del muro<br />
fuori la belva mangia l’ultimo<br />
lacerto dell’italico consenso<br />
fuori la belva e la paura<br />
amore di morte<br />
e sentirai sacra sposa condizione<br />
fuori l’abisso beante<br />
altrimenti tragica la storia per le poche cose<br />
e tragico momento.<br />
Uno degli altri<br />
Settantaquarantasette chiaro sul petto<br />
Turi, 27 aprile 1977<br />
e<br />
che vuoto questo silenzio e la distanza<br />
gramsci ancora domani<br />
pure<br />
ancora non v’è tutto in questa stanza<br />
il carico di fiele le parole d’una scrittura<br />
fatta regno<br />
il bruciare del mercurio<br />
la mano pesante sulla fronte<br />
ora parlano<br />
non cantano<br />
quali parole<br />
se si potranno dire<br />
quei segni della morte sul muro<br />
e sulla pelle<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
16
Da Dopo la scienza, 1982<br />
* * *<br />
“Se un’idea padroneggiasse confondendo il mondo”<br />
in questo secolo di spaventose certezze<br />
la morte sarebbe compagna opportuna<br />
ad ogni svolta.<br />
La cosa s’è fatta storia<br />
storia la cosa<br />
e - tra gli inganni -<br />
salta ogni giorno la crosta del decrepito/morale.<br />
Il genere giustamente muore<br />
il campo si macchia d’argilla<br />
si capovolge<br />
diventa cielo di terra.<br />
E se una vergogna mai nascosta<br />
ai ricordi<br />
dovesse agire con labbra aperte<br />
in impressione d’ira<br />
risoluzione<br />
umana: giusto<br />
morire così misurando se stesso<br />
ogni statura.<br />
* * *<br />
Consegnare l’affronto d’una fioritura<br />
di versi e di passaggi<br />
all’asse di una ruota<br />
al latrato dei cani<br />
a una vecchiaia di numeri<br />
e di forme<br />
a una catasta<br />
di sonorità impiccate<br />
a una lista<br />
di scontati adempimenti,<br />
alla presunzione di combinare con la forza<br />
gli atti.<br />
La prospettiva, quella che resta, di un calare di luna<br />
sul corpo di un falso gioco versato<br />
da un vaso di terracotta come un’ode<br />
struggente sula discesa di un prato<br />
d’infanzia<br />
sulla merlatura di calce di città<br />
incoronata di sole<br />
sulla finzione di un accordo<br />
trapassato dallo stridente suono del grido.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
17
Da La dissipazione del talento – I colli marchigiani, 1985<br />
L’interlocutore antagonista<br />
Una parola tragica<br />
deposta dal caso<br />
sul palmo di una mano,<br />
una parola s’oppone<br />
alla corsa nei grigi angoli<br />
di periferia<br />
il gesto scoperto appena nell’usato<br />
avverte per sé le liturgie per<br />
vagare nel mare dei significati.<br />
Semplice e secco<br />
diritto, asciutto<br />
contro cerimoniali e riti<br />
contro la nevrosi, contro ogni<br />
pulsione<br />
il gesto infrange la canzone.<br />
* * *<br />
Quando ancora: ma quanto ci si metterà<br />
a morire<br />
e come sarà la via<br />
quali i fantasmi, le colpe,<br />
le prepotenze, l’accusa<br />
quanto tragico l’assedio,<br />
il rosso delle bacche,<br />
quali parole<br />
per quelle esplosioni rivolte<br />
ingenuamente sconvolte e lanciate alle stelle.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
18
Da La dissipazione del talento – I colli marchigiani, 1985<br />
Martino confessione e dolcezza<br />
Vivere nel mondo queste differenze,<br />
i programmi che urgono al di qua<br />
al di là dei soggetti,<br />
censire i momenti<br />
inventare premonizioni,<br />
tentare l’ordinazione delle malizie<br />
liberando la via a spiragli d’errore<br />
storie fraintese s’intrecciano ai racconti,<br />
alla presunzione di narrare<br />
le cose dette dall’uomo<br />
i suoi gesti consumati<br />
dimenticati a margine d’un’ossessione<br />
antica<br />
oltre e dentro questa vita c’è …<br />
la messa in scena<br />
lo scoppiettare del fuoco<br />
l’umana rissa di passioni<br />
il tema della complicazione<br />
la discendenza<br />
l’empietà<br />
l’evocazione<br />
che non vale il sacro d’una parola.<br />
Vivere nel mondo ogni condizione<br />
e col rifiuto<br />
di lasciarsi morire.<br />
Il padre<br />
Continua a tessere l’inevitabile perimetro<br />
del confine, il periodo delle silenziose<br />
assenze e dei ritorni attesi.<br />
A domandarsi, nel bozzolo<br />
di un sistema di eventi,<br />
come si concilia, nell’altrove, la parola dei pudori<br />
con le storie consegnate<br />
alla tessitura discreta<br />
sulle vele dei viaggi.<br />
S’è portato con sé quel modo<br />
di toccare gli oggetti molledolce<br />
che nasceva dall’aver riconosciuto<br />
da uomo la crudeltà del tempo delle scelte.<br />
Ora l’anima s’è arrampicata con i consueti<br />
passi delle ascese di una volta<br />
fin sul ramo più debole e sottile<br />
dell’albero delle solitudini.<br />
E noi che diremo - racchiudendola<br />
in un pugno - della vita?<br />
dei discorsi sbiancati dal freddo della luna?<br />
che, nell’immane tristezza delle veglie?<br />
Sapere quanto e come e perché<br />
getta angoscia (l’ombra sulla faccia)<br />
l’inascoltato richiamo<br />
d’una tentazione ultrapresente.<br />
E si comincia dal tutto lacerato:<br />
i ricordi<br />
sono capelli bianchi<br />
e minuscole memorie corrotte le mosche morte<br />
in fila<br />
lungo i colori dei fiori e lungo i muri.<br />
Nota al testo<br />
(in L’utopia reale, 1994)<br />
Riflessione su Heidegger sul tema dell’essere nel<br />
mondo. La poesia è dedicata da <strong>Mancino</strong> a Paolo<br />
Filiasi Carcano e a Felice Balbo.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
19
Da Dichiarazioni silenzio e giorni, 1987<br />
Variando autonome riproduzioni<br />
Praticando in parole e versi<br />
torna inevitabile stabilire pratiche distanze<br />
dal mondo delle gamme,<br />
delle dimensioni. Allora però<br />
le relazioni<br />
anziché farsi labili ed insicure<br />
si moltiplicano complesse<br />
e variabili<br />
riproducendo nei tessuti l’infinito<br />
accogliere incessante nella passione<br />
ogni senso della vita<br />
ogni precaria riconciliazione<br />
in termini, in fatti.<br />
Del modo di morire del poeta<br />
Davanti al portico della vecchia casa<br />
sostammo: con noi il nostro fantasma<br />
e gli artefatti sommari desideri<br />
di viaggi terrestri, di accordi.<br />
La morte dei poeti è come sussurro<br />
di addii, i versi come stelle<br />
come appassionati suoni di cembali<br />
dicono.<br />
Il volto si rifrange nelle pupille<br />
altrui, ancora calde le parole<br />
le allegrie<br />
e fresco l’inchiostro,<br />
appena sgusciati dall’idea i versi<br />
caratteri e parole.<br />
The dreamer sleeps forever<br />
with the dreamed<br />
(Il sognatore dorme sempre<br />
col sognato)<br />
una zattera solca scivolando<br />
il fiume nel sangue dei ricordi.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
20
Da Dichiarazioni silenzio e giorni, 1987<br />
Gli oggetti del poeta<br />
Quell’uomo solo e curvo nello sforza<br />
sul gibbo di collina<br />
e al di là della linea degli occhi<br />
uno spazio sterminato<br />
gli oggetti del poeta sono le lune<br />
altrui, i movimenti altrui, le parole<br />
altrui, gli sguardi, le compromissioni<br />
i pochi lindori<br />
gli oggetti del poeta si compongono<br />
misteriosi in espressioni ridenti<br />
in sofferti sguardi<br />
in rivelazioni<br />
la faccia, le facce, le maschere<br />
le forme<br />
aurore e tragici sposalizi<br />
e verginità e grembi<br />
nikel ed argento negli occhi dei bambini<br />
nelle premonizioni dei vecchi<br />
nelle premorienze degli uomini<br />
che discendono sempre quelle scale<br />
l’oggetto è lucida parola, nitida follia<br />
come per i marmi di Wildt<br />
di bianco<br />
e straordinarie fatture<br />
sotto la luce, tra gli alberi,<br />
sulla grande strada<br />
sul passo si ritrova la natura<br />
destandosi dal sonno il racconto dolce<br />
scivola nel sogno.<br />
Autobiografico<br />
Le parole che scriviamo non valgono<br />
la saggezza di non saperci vivi,<br />
il valore degli atti porta con sé<br />
tutta la debolezza dell’uomo indifeso<br />
contro menzogne, freddezze e malintesi.<br />
Corre il timore nel sangue, corre<br />
velocità apprezzabile nella mitezza<br />
degli sguardi. Conoscere gli uomini<br />
conoscendone i sarcasmi,<br />
allontanare l’usuale rapporto con le cose,<br />
dare anima al chiaro del volto<br />
ai segni che illuminano i sorrisi.<br />
E saper ridere interpretando quel po’ di mondo<br />
che s’è costretti ad attraversare<br />
come pericolo, come rischio. Sentire<br />
la coscienza di avvertire qualcosa<br />
sempre prima di saper morire.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
21
Da L’ultima rosa dell’inverno, 1993<br />
I margini dei fiori<br />
(come una variante della parola sfera)<br />
Chino sul bordo che segna i margini<br />
dei segreti fiori<br />
nell’attesa dello spalancarsi nudo del corpo<br />
la casa dei fiati<br />
dimora di memoria<br />
la bellezza si compone tentando il residuo<br />
gruppo delle follie notturne<br />
solo a tratti si riconosce<br />
come la linea di un dialogo sommesso<br />
una semplice chioma di labbra<br />
svegliandosi nel socchiudere la prima parola<br />
Parlare allora<br />
conserto il gesto<br />
contraddistingue il perché del languore di una rosa.<br />
Testo<br />
Si rompe negli accenti il paradigma<br />
dell’orto sulla collina cinto del muro dei mattoni<br />
nella dimensione<br />
v’è la doppia rivelazione<br />
consacrando l’equivoco delle distanze<br />
si stabilisce in successioni improbabili<br />
sempre meno di quanto sei<br />
ti ritrovi all’attracco<br />
per il minuscolo universo della mente<br />
l’approccio riduce il fatto nel narrato<br />
su tutto campeggia il rifiuto giusto solenne motivato<br />
all’invocazione<br />
risposta senza parole<br />
terminando l’être con un accordo<br />
insoluto nella mancata melodia.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
22
Da La curva di Peano, 1999<br />
LOGICA DEGLI ANNI<br />
Quando parli di mondo<br />
sei come la teoria stessa del tuo caos;<br />
per questo - forse - il movimento ti scaccia dalla vita<br />
ti prostra per un perdono al cospetto<br />
della perfezione dell’ordine.<br />
Gli anni letali presuppongono l’uscita<br />
per la grande porta smisurata,<br />
per l’infinita apertura.<br />
Essere l’unico superstite non ripaga nulla<br />
nemmeno serve la lunga sonata eseguita con passione amante:<br />
liberando la mente dalle pulsioni<br />
che pressano le ossa<br />
è pure inutile sapere che così si muore.<br />
Oggi il cielo offre immagini e richiami<br />
e labirinti che s’inventano in se stessi<br />
come fossero gli amici della rincorsa di allora,<br />
ed ora nel silenzio buio c’è un poeta che cerca<br />
di farsi dimenticare davvero.<br />
È sulla luna, sulle sue guance di pallido transfert,<br />
il vagabondaggio più triste<br />
plausibile e sereno:<br />
dunque<br />
il sogno, o un semplice malinteso.<br />
LARGHEZZA<br />
Il palmo della mano aperta<br />
non chiude, non possiede,<br />
non vuole reticenze/guadagni.<br />
Atto prodigo e senza tregua è questo,<br />
gettito e largesse<br />
risonanza e dispendio là dove l’anima<br />
si dissipa e il talento.<br />
Il palmo nelle sue linee si scompone<br />
al mondo, elargisce tessuti. C’è uno sguardo<br />
preciso per il centro della mano,<br />
dono e fasto, festa di sequenze<br />
dove la vita si cangia senza posa.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
23
Da La curva di Peano, 1999<br />
CREDERE COME<br />
Sei pure vittima<br />
e spazio e tempo,<br />
espiare una colpa a fondo pagina,<br />
anche dio è un dio morto agli occhi.<br />
Ecco, un segreto in più, questo un altro mistero<br />
scritto nel registro transitorio.<br />
Senti la morte che s’avvicina al meglio,<br />
il suo rapporto è relazione totale<br />
sul duello;<br />
incidente morale, che altro?<br />
volere un barlume di giusto essere<br />
e dare, come un sentimento che non marcisce,<br />
legame alla carne ultima.<br />
Entità non più nuda la condizione.<br />
CONOSCERE IL DOLORE E LA RAGIONE<br />
Forma o nuova forma di partire<br />
ritornare ancora una volta a dire<br />
di questo e dell’altro sentire,<br />
pensar di nutrir<br />
d’impegno la parola propria,<br />
la parola dell’altro.<br />
Dove profondo ed alto è ciò che si sente<br />
fin dentro anima e coscienza<br />
brucia la passione, ansima l’antico cuore;<br />
ineliminabile è il soffrire<br />
conoscendone il dolore.<br />
Sei felice perché il senso tuo<br />
nasce nel dolore<br />
fino alla morte. C’è sempre un altro<br />
che paga la tua felicità/desiderio di volere.<br />
Dov’ero?<br />
Dove ho vissuto? Dove quella casa?<br />
E dove il tempo?<br />
Sazio un vecchio saggio<br />
un sorriso felice attraversa lo spazio altrui;<br />
il termine del viaggio si pone<br />
nell’altro sereno di sé.<br />
È nell’apolide sapienza del mondo<br />
la resistenza del poeta, la sua residenza.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
24
Da Dove un perfetto sofisma. Poesie (2001–2003), 2003<br />
LA VOLUTA RECLUSIONE<br />
Il personaggio ch’è dentro di noi<br />
ora ci sfugge.<br />
Andare vale inaudita violenza,<br />
inquieti non sappiamo dove andare<br />
piantando in asso il mondo,<br />
le cose.<br />
Quale stregone oggi ci trasforma.<br />
Mostro senza scrupoli, pallidi inchiostri,<br />
nubi illeggibili come pagine indecifrabili;<br />
ci sfugge il personaggio.<br />
Questo corpo è tutto indolenzito,<br />
l’anima scende in basso,<br />
l’aria del torrente<br />
non m’inebria.<br />
Perdo conoscenza anche nel sonno<br />
si strappa il naufragio<br />
persino dalla tempesta del mare;<br />
la morte è un’immagine<br />
che vortica intorno a se stessa.<br />
- Chi sono io? E tu chi sei?<br />
Cade la domanda del tutto<br />
là dove ho l’abitudine di posare il capo<br />
per accogliere ogni altro quesito<br />
sulla vita.<br />
Le parole si vendicano della mia libertà<br />
facendo smorfie sulle ferite.<br />
Strillano i gufi lungo i giorni<br />
e si convive con l’istinto<br />
un volo d’anima e di fisiocrazie<br />
solenni.<br />
Dire, scrivere, parlare, evocare<br />
tutto della conoscenza<br />
delle creature dell’invenzione assassina;<br />
le conquiste di una strega<br />
si dispongono sul palmo della mano,<br />
le ombre fuggono via nella vertigine.<br />
La mia reclusione è tutta voluta,<br />
scelta ed amata, il corpo<br />
è fatto di fibre<br />
che accumulano dolore,<br />
che intimidiscono la morte.<br />
Pure sono incantate le notti<br />
le insondabili lotte fino all’alba.<br />
Verrà il giorno in cui non interrogherò più<br />
nessuno: non ci sarà risposta<br />
alle mie domande dalle due parti<br />
dello specchio<br />
e il poco tempo che sarò<br />
capace di controllare.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
25
Da Dove un perfetto sofisma. Poesie (2001–2003), 2003<br />
ESSERCI COME<br />
Il modo per cui siamo<br />
è tutt’uno col modo d’essere<br />
delle cose, degli altri<br />
che ci vivono intorno<br />
e come ci sembrano.<br />
Piccoli mondi in cui muoviamo<br />
i passi, attendere con pazienza<br />
ogni ricorrenza dei fatti<br />
suoni e toni, le azioni<br />
dell’essere<br />
dell’agire.<br />
Il modo più comune<br />
più giusto di vivere<br />
è conoscere in che armonia<br />
si legano mondi già formati<br />
e le identità, quelle nostre.<br />
Se è simbolo vero, se il vero c’è,<br />
si sente e davvero<br />
di significare un senso<br />
per cui si può morire.<br />
NOI GLI STESSI SOGNI<br />
Credere sia pur giusto associare<br />
il desiderio al rifiorire della natura,<br />
alla stagione;<br />
alle passeggiate notturne, a minuscole fedi<br />
a cosce nude sfiorate appena per caso<br />
sognando l’altro da godere;<br />
noi abituati nel pianeta dei se a fare<br />
poesia dell’incontro tra i corpi<br />
preoccupati di rose che sbocciano;<br />
siamo noi quelli che i sogni coltivano<br />
credendoli brandelli di sogno mentre<br />
sono infuocati tramonti e solo quelli;<br />
dall’altra parte del mondo s’intravede<br />
non più che un illusorio miraggio<br />
in un paesaggio eguale per gli occhi;<br />
tristissima idea (e perniciosa illusione)<br />
che il mondo produca meraviglie<br />
che la viltà (nostra) c’impedisce di prendere;<br />
ogni donna vive sul bilico sulle sue<br />
punte di piedi, gli uomini hanno sempre<br />
divaricate le gambe come per fare…<br />
silenzio, la pace, le stanze vuote<br />
oggi c’incantiamo al racconto delle prodezze<br />
nell’avventura;<br />
le domeniche deserte desolate reclamano<br />
l’assoluta necessità di pianto<br />
e il sé vago navigare la solitudine le noie;<br />
l’assoluto è precario se non vi fosse<br />
un concentrato pensare al più asettico<br />
distaccato possibile esistere nel nulla.<br />
A noi per produrre minuscole<br />
stelle danzanti serve un gigantesco silenzio<br />
orizzontale, improbabile,<br />
per navigare il cielo e gli stessi<br />
frequentati sogni scheletrica solitudine<br />
interminabili utopie dei viaggi;<br />
i passi rimbombano nel nulla<br />
vale una sconfitta raggomitolarsi<br />
come in un profumato bordello.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
26
<strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
L’ideatore e curatore di ARCIPELAGO itaca è nato e vive ad Osimo, nelle Marche. Rintracciare in internet<br />
(http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/mancino.htm) alcune poesie scritte da <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong> in dialetto<br />
osimano, tratte da LA CASA LA MADRE IL COLLE E L’ORTO (Schena, 1989) e tradotte in inglese, poi, da Luigi Bonaffini<br />
(Professore di Lingue e Letterature Moderne presso il Brooklyn College di New York) offre l’occasione per promuovere un<br />
ricordo, diciamo così, particolare di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>. Si riproducono, a seguire, due dei testi in dialetto osimano di cui<br />
appena in precedenza, nella versione in italiano dello stesso autore e nella traduzione, appunto, di Luigi Bonaffini.<br />
Legato ad Osimo da vincoli affettivi e di amicizia, <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong> ha collaborato con l’Amministrazione dello stesso<br />
comune nel settore delle attività culturali ed in occasione della realizzazione dell’antologia PER QUESTE PIAGGE OVE NON<br />
ALTRO edita nel 1993 dalla Stamperia dell’Arancio e dedicata a Luigi Bartolini - altro illustre osimano d’adozione -<br />
nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di quest’ultimo.<br />
L’utopia reale
Lasciando il tempo che. ..<br />
Lassa che la luce se 'zzitti 'ntell'incontro<br />
cull'ombra<br />
lassa che 'ntel silenzio se sfaldi sta calura<br />
sa la morte che la accumpagna e 'ntel giardì,<br />
lassa, che l'erba secca. e gialla se 'cciacchi<br />
su la terra arsa<br />
e lassa da venì l'ore de i ricordi che te strugge.<br />
Tornà a casa nun sarà possibile più<br />
e mai se potria rcumenzà: le cose sparse adè<br />
le poi trovà pe 'll'altre case, è dientate d'altri,<br />
pure i ricordi (e me va bè) troeranne altre case,<br />
altre mà<br />
e luoghi sconosciuti.<br />
La strada de volè tutto 'l bono<br />
d'esse<br />
nun porta da nisciuna parte.<br />
Let Time...<br />
Let the light hush in its encounter<br />
with shadows,<br />
let this heat crumble in the silence<br />
with death that attends it and in the garden,<br />
let the dry yellow grass be crushed<br />
on the burnt earth<br />
and let the hours come of the memories that eat at you.<br />
Going back home will no longer be possible<br />
and you could never begin again. Now scattered things<br />
can be found in other houses, belonging to others,<br />
even memories (but it's all right with me) will find other houses,<br />
other hands<br />
and unknown places.<br />
The road of wanting all that's good<br />
in life<br />
leads no place.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
Lascia che la luce si azzitti nell'incontro / con l'ombra / lascia che nel silenzio si sfaldi questa calura / con la morte che<br />
l'accompagna e nel giardino, / lascia che l'erba secca e gialla si acciacchi / sulla terra arsa / e lascia che vengano le ore<br />
dei ricordi che (ti) struggono. // Tornare a casa non sarà più possibile / e mai si potrebbe ricominciare: adesso le cose<br />
sparse / le puoi trovare per le altre case, sono diventate d'altri, / e pure i ricordi (ma a me va bene) troveranno altre<br />
case, / altre mani / e luoghi sconosciuti. // La strada di volere tutto il buono d'essere/vivere / non porta da nessuna<br />
parte. 27
Vedi la casa<br />
Vedi la casa<br />
che se nasconne<br />
dietro i bracci de j alberi<br />
a la campagna<br />
te accorgi che stai partenno<br />
'n'altra volta<br />
e ch'ei promeso de nun fallo più;<br />
st'inverno 'l vento<br />
mulinerà de faccia a le porte;<br />
camina su i muri 'l tradimento<br />
cume l'anima d'un geco,<br />
da la loggia su le scale<br />
pare de vede<br />
na figura che se scosta<br />
e pò se 'ppanna<br />
se ce fai caso bè<br />
somija cume a na madre<br />
uguale all'altre,<br />
a tutte,<br />
che specchia spianno la sorte<br />
'nte la faccia stessa sua;<br />
senti un lamento d'un cà<br />
vecchio che more.<br />
See the House<br />
See the house<br />
hiding behind<br />
the arms of the trees<br />
in the countryside<br />
you realize that you are leaving<br />
again<br />
and that you promised<br />
you wouldn't;<br />
this winter the wind<br />
will whirl outside the doors;<br />
betrayal walks on the walls<br />
like the soul of a gecko,<br />
from the landing on the stairs<br />
you seem to be seeing<br />
a figure that draws away<br />
and then fades<br />
if you look carefully<br />
it looks like any<br />
other mother,<br />
every mother,<br />
who glimpses at destiny<br />
in her reflected image;<br />
you hear the wail of an old<br />
dog dying.<br />
Vedi la casa / nascondersi / dietro le braccia degli alberi / alla campagna // ti accorgi che stai partendo / ancora una volta // e che avevi<br />
promesso / di non farlo più; // quest'inverno il vento / mulinerà a fronte delle porte; // cammina sui muri il tradimento / come l'anima<br />
di un geco,// dal ballatoio sulle scale / sembra di vedere // una figura che s'allontana / e poi sfuma // se ci fai caso attentamente /<br />
somiglia alla sagoma di una madre // eguale alle altre, / a tutte, // che di riflesso spia il destino / nella sua stessa immagine; // senti un<br />
lamento di un cane / vecchio che muore.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
28
L’avventura pugliese di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
Di Biagio Balistreri<br />
“La ricchezza maggiore nella vita e nella cultura di un popolo e di una nazione si costituisce quando la storia (fatta di eventi<br />
quotidiani, drammatici e persino leggendari) si scandisce con i versi dei suoi poeti a determinare il senso di epoche e vitalità,<br />
eroismi e tragedie collettive, attese e costruzioni, speranze e realizzazioni politiche nella complessità di un canto generale ricco di<br />
illuminazioni, pathos, motivi essenziali e reso in un tessuto di cospicua esistenzialità in un incessante evolversi di vita ideale<br />
intrecciato ad una vigorosa prassi politica.”<br />
Sembra l’inizio di un manifesto programmatico della letteratura vissuta come impegno. È invece l’incipit del saggio che <strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong> dedicava al poeta e martire bulgaro Nicola Vapzarov, saggio che apriva il volume antologico di traduzioni dei Canti di<br />
Vapzarov a cura dello stesso <strong>Mancino</strong> e di altri autori, che vedeva la luce nel 1981 per i tipi di Quattrocittà cooperativa editrice,<br />
iniziativa editoriale promossa sempre da <strong>Mancino</strong> con me, Lino Angiuli, Raffaele Nigro, Vincenzo Jacovino, Cristanziano Serricchio,<br />
Michele Lastilla, Enzo Pagano. Un’iniziativa che, come spesso accade, oltre a quel primo prodotto, che nasceva con il sostegno del<br />
Sindacato Nazionale Scrittori, avrebbe visto soltanto un’altra pubblicazione: Il Grassiere, testo teatrale di Raffaele Nigro.<br />
L’incontro con <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong> era avvenuto per caso alla fine del 1979. Egli era direttore didattico della scuola elementare di<br />
Bari frequentata da mio figlio, scuola nel cui consiglio d’istituto ero stato eletto.<br />
Ci avvicinava il comune orientamento politico. Tuttavia, quando mi capitò di dirgli per la prima volta che scrivevo poesie, iniziò a<br />
prendermi in giro, ridacchiando e chiedendomi con tono di cantilena: “e cosa scrivi, la donzelletta vien dalla campagna...?”<br />
Nel tempo avrei compreso il motivo di tale sfottimento: per <strong>Leonardo</strong> la letteratura era cosa di tale serietà e con tali implicazioni,<br />
da farlo naturalmente diffidare della possibilità di scrittura seria da parte di un dirigente bancario quale io ero.<br />
Poi si verificò l’inizio di un sodalizio che sarebbe durato diversi anni: detti a <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong> il dattiloscritto delle mie poesie, e<br />
lui ne fu entusiasta, al punto che ne volle la pubblicazione nella collana “I Testi” da lui diretta per l’editore Piero Lacaita di<br />
Manduria e volle scriverne egli stesso la prefazione. Da quel momento sarei stato travolto in un turbinio di proposte, di iniziative,<br />
di presenze a convegni in giro per l’Italia e di serate con amici scrittori (ricordo Paolo Ruffilli, Rodolfo Di Biasio, Umberto Piersanti,<br />
Aldo De Jaco, per citarne alcuni fuori dalla Puglia, e in Puglia Vittore Fiore, Lino Angiuli, Carlo Alberto Augieri, Raffaele Nigro,<br />
Michele Dell’Aquila, Vito Maurogiovanni, Antonio Verri, Vittorino Curci, Daniele Giancane e tanti altri i cui nomi, a distanza ormai<br />
di più di trent’anni, mi sfuggono).<br />
<strong>Leonardo</strong> sentiva la letteratura e in generale la cultura come impegno militante, e mai più avrei incontrato un animatore<br />
culturale capace come lui di coinvolgere e al tempo stesso di scontrarsi, di lottare e di trovare tutti i mezzi per continuare la<br />
propria<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
29
L’avventura pugliese di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
propria opera malgrado l’indifferenza imperante, allora come adesso, nella politica e nei protagonisti dell’agone sociale. Come ha<br />
scritto Vincenzo Jacovino, mi piace “ricordare l’uomo e l’intellettuale che ha vissuto con l’ansia di capire e la voglia imperiosa di<br />
agire”. Scoprire giorno dopo giorno la capacità con la quale conduceva il grande editore Piero Lacaita a perseguire finalità sempre<br />
più ambiziose, che lo portarono non soltanto a realizzare una delle più belle collane di poesia contemporanea, “I Testi Lacaita”,<br />
appunto, creata e diretta per molti anni da <strong>Mancino</strong> e poi continuata da Giacinto Spagnoletti, ma anche pubblicazioni di grande<br />
approfondimento letterario come l’Omaggio a Bodini, l’Omaggio a Scotellaro e, soprattutto, i due volumi dell’antologia Oltre<br />
Eboli: la poesia, punto di riferimento, per decenni, del grande laboratorio poetico meridionale.<br />
Tuttavia di quell’epoca ormai lontana, scandita dall’instancabile attività di <strong>Leonardo</strong>, il ricordo più caro, più divertente e più<br />
stimolante, è quello delle serate di lettura poetica “itineranti”, organizzate presso le biblioteche dei comuni pugliesi, serate che<br />
risultarono di grande successo e che, insieme a <strong>Leonardo</strong>, vedevano protagonisti me, Vittore Fiore, Lino Angiuli e Raffaele Nigro.<br />
Erano serate caratterizzate da una semplicità, una gioia e un’allegria nel portare la nostra parola poetica in giro per i paesi, da<br />
risultare il momento più autentico della nostra esperienza poetica e della nostra amicizia intellettuale.<br />
A distanza di qualche anno lasciammo tutti e due la Puglia, io per tornare nella mia Sicilia, <strong>Leonardo</strong> per raggiungere le sue<br />
Marche. Travolti dalle nostre pigrizie, da allora ci siamo sentiti soltanto tre o quattro volte, e della sua avventura marchigiana<br />
conosco ben poco. Ho perso certamente molto a non seguire più la sua sempre vivacissima attività culturale, e con dolore mi<br />
ripiego nel suo ricordo, riportando qui di seguito una sua composizione, scritta in occasione della morte di Tommaso Fiore e<br />
pubblicata nella breve raccolta intitolata Per struttura s’intende (Ed. geiger, 1973) nella quale già per intero si delineava la sua<br />
interpretazione dell’ideologia come chiave di lettura poetica del mondo.<br />
Biagio Balistreri, ex dirigente bancario, è nato a Roma, ma vive da oltre venticinque anni a Palermo, sua città di origine.<br />
Ha pubblicato tre libri di poesie: Respiro l'aria del Sud (I Testi, Lacaita Ed., Manduria, 1980), con prefazione di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>, segnalato al Premio<br />
“Viareggio-Opera Prima” e al Premio “Vallombrosa“ e vincitore del Premio “Campofranco” 1981; Generazioni (I Testi, Lacaita Ed., Manduria, 1985), con<br />
prefazione di Carlo Bernari e Tracce (Arnaldo Lombardi Ed., Siracusa, 1989), con disegni di Bruno Caruso.<br />
Un suo racconto, Il ficus di piazza Marina, è stato pubblicato in Raccontiamo Palermo – Nuova Ipsa Ed., Palermo, 1997.<br />
Sue poesie, racconti, interventi critici e interviste sono apparsi su numerose riviste, fra le quali: “Arenaria”, “Horus”, “Acquario”, “Nuovo Mezzogiorno”,<br />
“Target,” “Pensionante de’ Saraceni” e “Caffè Greco”.<br />
Della sua opera si sono occupati , tra gli altri: Ettore Albertoni, Loredana Cacicia, Antonino Contiliano, Gianni Custodero, Gigliola De Donato, Michele<br />
Dell'Aquila, Aldo Gerbino, Remo Giacone, Vincenzo Jacovino, <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>, Augusta Mazzella di Bosco, Walter Nesti, Raffaele Nigro, Giancarlo<br />
Pandini, Giuseppe Quatriglio, Franca Rossi, Paolo Ruffilli, Giuseppe Zagarrio e Lucio Zinna.<br />
Ha diretto, per l’editore Arnaldo Lombardi di Siracusa, la collana letteraria Percorsi.<br />
È stato membro permanente della giuria del premio letterario promosso dall’Associazione Scrittori e Artisti di Palermo.<br />
Con un suo omaggio a Guttuso è presente nel Catalogo della mostra del pittore organizzata dalla Provincia di Siracusa nel 2001.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
30
L’avventura pugliese di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong><br />
Carico di...<br />
il nostro il tuo<br />
il mio<br />
carico di disperazione e dove siamo<br />
dove l'immagine<br />
la nostra digrignata<br />
identità<br />
ricerca (absit iniuria...)<br />
lontana dalle fittizie<br />
conquiste<br />
noi tu io<br />
ricerca della condizione<br />
e lotta/e per risorgere<br />
nuove deità<br />
l'incrinatura delle coordinate<br />
per vedere meglio<br />
il nemico numero uno<br />
da abbattere<br />
chi sa chi morirà per primo<br />
e quali musiche<br />
e quali termini<br />
e perché la denuncia<br />
brucia ancora<br />
e fino<br />
a quando brucerà<br />
ten<br />
ta<br />
zio<br />
ne<br />
(quante perdite per il<br />
cammino e quante morti da sopportare)<br />
mai tentazione se non quella di morire<br />
con un « tu »<br />
più giù (molto più giù) delle labbra<br />
com'è logico che succeda<br />
occorre<br />
vivisezionare<br />
il contadino che muore (quando riesce a morire<br />
con pochi grammi di carne addosso!) per capire come<br />
anche<br />
perché<br />
dove<br />
quando<br />
la condizione del poeta<br />
è sempre guerra.<br />
.................................<br />
il contadino che muore...: tommaso fioreeeeeeee, quattro<br />
giugno settantatre, la fine.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
31
Poesia – Umanità<br />
INTERVISTA A LEONARDO MANCINO<br />
A cura di Raffaella Bortolin<br />
Come può e come deve esprimersi la poesia?<br />
Penso che la poesia debba esprimersi in parole, sensi, immagini. Voglio dire che ogni poesia vera, in rapporto al suo autore, deve contenere un<br />
motivo, un’importanza oggettiva che valga come fondamento della ricerca umana, filosofica, pensante e stilistica. Prima di tutto umana. D’altro<br />
canto, la poesia è esattamente l’opposto dell’appiattimento della prospettiva in cui ogni scrittura si immerge.<br />
Poesia come fondamento della ricerca umana: essa si rivela come un continuo interrogare e interrogarsi, senza indicare delle risposte<br />
precise. Qual è il fine di questo atteggiamento, e che cosa stimola a continuare a porsi certe domande, ad andare sempre oltre le cose e a<br />
cercare di dare adito a quel pensiero di infinito che si può ricollegare alla matrice leopardiana?<br />
Mi fa molto piacere che quando si parla di infinito ci si colleghi a Leopardi, ma penso piuttosto ad un infinito di cui vado alla ricerca e che è<br />
dentro di noi: un’infinità molto più interrogativa per il soggetto umano. La poesia non risolve assolutamente nulla, ma serve per distinguere i<br />
tempi della grande riflessione dai tempi della normale azione.<br />
Molto spesso si dice di me che io sia un poeta marchigiano, e in realtà lo sono; ma non bisogna dimenticare che ho vissuto trent’anni in Puglia e<br />
che ho vissuto tutta la condizione delle plebi meridionali, anche a livello politico, Quando ci si interroga sul destino dell’uomo, ci si deve<br />
rivolgere non solo al destino intellettuale, ma anche alla vita normale. Ecco perché la mia poesia è ricca di domande; i termini che ritornano<br />
sono l’anima della gente, la coscienza, il senso della vita, quelle ragioni che Pavese risolveva in due domande: “Per chi e perché scrivere?”, alle<br />
quali io aggiungo “Per chi e perché vivere?” Nessun essere umano può permettersi il lusso di vivere solo per sé.<br />
D’altro canto la poesia è una proiezione del proprio linguaggio, delle proprie idee, ed è bene che all’interno della fisionomia intellettuale e<br />
morale di un soggetto, in questo caso il poeta, vi sia anche una particolare attenzione per le condizioni di vita dell’altro. Ne La bella scienza vi è<br />
un sottotitolo: Epistemologia per il tramite dell’altro. L’altro non solo è la direzione verso cui si riflette e si pensa, ma è colui che aiuta il<br />
soggetto poetante a fare in modo che nella poesia l’altro ci sia come interlocutore privilegiato della coscienza. Quindi, se si volessero<br />
individuare eventuali ascendenze per la mia poesia, non è tra i poeti che andrebbero ricercate, ma tra i filosofi dell’esistenzialismo, come<br />
Martin Heidegger, Gabriel Marcel e l’italiano Enzo Pace.<br />
Come e dove colloca la sua poesia nell’ambito della cosiddetta “ideologia della scrittura”?<br />
Nel mio caso personale vi è tanta predilezione nell’accentuare – nel poema dal passo lungo – diversi elementi tematici per la creazione di una<br />
consistente coerenza estrema… Penso a Gli oggetti del poeta (1), Del modo di vivere del poeta (2) e Per l’infinità di Leopardi, tre mie<br />
composizioni che dedico idealmente ad uno tra i più straordinari poeti italiani del ‘900, Vittorio Bodini, meridionale, flamenco come uno<br />
spagnolo immortale.<br />
Chi vuole leggere la mia poesia sull’onda di una sorta di complicità con l’autore, dovrebbe tentare di ricostruire prima il senso complessivo del<br />
messaggio e poi avviarsi ad individuare le varie diversità o discontinuità; ovvero porre l’accento prima sull’interezza più che sui presupposti<br />
culturali e letterari che vi sono alle spalle. Con Leopardi sì, ma non tutto il viaggio.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
32
Poesia – Umanità<br />
Che cosa intende per “poema dal passo lungo”?<br />
Ho una predilezione particolare: quella di pensare ad una poesia che sia anche una sorta di romanzo in versi. Ne L’ultima rosa dell’inverno vi è<br />
proprio una poesia che parla della scrittura del romanzo, La formazione appassionata del “romanzo”: “se un romanzo vuol parlare / veramente<br />
/ ha il dovere di narrare dei mille trapianti / delle sequenze / innesti veri e falsi”. In questo si racconta tutto: non è il “parlare”, ed esso non ha<br />
ragione di esistere se non vi è l’eloquente e l’ascoltante; in questo la poesia deve essere fruibile, intelligibile, godibile, comprensibile, altrimenti<br />
non avrebbe senso. È più facile oggi dire “quel poeta è difficile”, ma quando si dice “quel narratore è incomprensibile”, il romanzo non si legge;<br />
e io voglio consentire alla poesia di avvalersi della capacità di essere compresa, come avviene per un’opera narrativa. D’altro canto non credo ai<br />
generi: o è poesia o non è poesia; in questo sono crociano.<br />
Quali sono i suoi temi prediletti?<br />
La ricerca del ruolo del poeta come iconografo morale della società in cui vive da sempre allo scoperto. E ancora, la dignità e la sacralità della<br />
vita; anche e soprattutto l’indagine accorata sui ritmi dell’esistenza umana e l’individuale farsi carico del problema della vita e dei gesti altrui.<br />
Nel visibile i miei temi sono anche la terra, il paesaggio e la natura, la condizione gestuale degli uomini, la prigione, l’esilio, la sacrosanta rabbia,<br />
ogni traccia necessaria per l’identificazione dei significati dell’azione, la donna, l’assente/presente. Nel gorgo sintattico si calano la vita,<br />
l’esistenza, l’anima e la mente, il cuore sempre in fuga, la memoria. Così posso odiare la funzione del poeta della o dalla residenza. Leopardi<br />
pare non voglia farmi partire, Keats mi chiama al viaggio avventuroso.<br />
Quando il poeta deve uscire allo scoperto?<br />
Se si riflette sulle ragioni per le quali Huizinga ha scritto La crisi della civiltà o Antonio Banfi Sulla crisi morale di un popolo, si comprende che è il<br />
momento di uscire allo scoperto quando la crisi sta muovendosi verso il profondo. Ma il poeta non lo fa solo come poeta, ma anche come uomo<br />
ed interprete dei bisogni culturali degli altri. Quindi egli è un’intelligenza con le intelligenze, una volontà con le volontà, un cuore con i cuori<br />
altrui.<br />
Oggi, in modo particolare, il compito del poeta finisce per essere fondamentale. Si dovrebbe prendere, ad esempio, Montale: egli scrive La<br />
bufera dopo la “bufera”, cioè dopo la guerra. Il poeta non deve rinunciare, in quanto poeta, alla sua essenza di uomo: deve vivere la coscienza<br />
della necessità della presenza umana, dell’altro, negli eventi. Egli così non scriverà mai delle piccole poesie, ma il poema della sua vita, e i lettori<br />
riconosceranno la validità di quella poesia interpretandola alla luce di ciò che nel tempo della scrittura è accaduto al mondo.<br />
Lei ha definito la condizione del poeta come una guerra: nel senso di rabbia, denuncia o altro?<br />
No. Nella poesia Un vecchio padre una mattina (3), si cita in corsivo il termine guerrato: che dice il poeta al padre e il padre al poeta? Identifica<br />
proprio la vita come qualcosa di guerrato: c’è un incontro di stimoli, di occasioni, di motivazioni che nella coscienza del soggetto devono creare<br />
per forza antinomie, antitesi, per giungere a delle sintesi ulteriori. Ma è il destino dell’intelligenza creativa dell’uomo, non solo del poeta, quello<br />
di vivere sempre in una conflittualità naturalmente intelligente. La rabbia può venire quando si scopre l’inanità, l’impossibilità di intervenire in<br />
modo che tutto sia migliore.<br />
Ne La lettera sulla condizione (4) dedicata a Vittorio Bodini, lei definisce il rancore come una condizione del vivere…<br />
Sì, ma ce dell’altro: ho coniato, per esempio, “sarcastironico”, “malincospirazioni”, che possono essere malinconie, aspirazioni, ma anche<br />
cospirazioni moralmente necessarie.<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
33
Poesia – Umanità<br />
Nel corso della sua esperienza poetica ed umana è riconoscibile una dimensione costantemente presente: il viaggio. Come deve essere<br />
interpretato?<br />
Penso che debba essere interpretato soprattutto partendo dalla mia convinzione personale, anche umana, secondo cui il poeta non sta bene<br />
“stabile” in nessun posto preciso. Già il fatto di immaginare il proprio movimento, il proprio attraversare il mondo, il proprio errabondo,<br />
necessario, ansito della conoscenza della condizione umana, è viaggio.<br />
Ho avuto vari momenti in cui ho ipotizzato un movimento dell’anima e del corpo. Nel 1959, arrivo in Puglia e non sono pugliese; riesco a vivere<br />
in quella realtà anche efficacemente, mettendo in gioco un protagonismo politico, culturale, ideologico; però non sto bene nemmeno lì, perché<br />
sento il richiamo della mia terra. Ho avuto una madre marchigiana e un padre pugliese, vengo dalla generazione in cui nulla era stabile: sono<br />
nato nel 1939, il che significa che già nel ’47-’48 potevo vedere che cos’era la società intorno a noi: un cumulo di macerie. Ho avuto dei maestri<br />
in filosofia e in critica letteraria, che mi hanno sempre spinto a riconoscere la necessità di essere qualcosa, quindi di servire.<br />
Il viaggio è anche un viaggio con l’immaginazione, ma io l’ho sentito come viaggio proprio del corpo, quindi tipico di colui che non ha una patria<br />
definita e definitiva.<br />
In una sua dichiarazione di poetica lei afferma che il poeta finisce sempre per scontare in solitudine il senso profondo e mobile del viaggio.<br />
Ciò, oltre che essere provocato dalla realtà contingente, è anche in parte voluto?<br />
Sì… Tant’è che io scrivo Canti da una solitudine invocata (5), ma è la mia solitudine: è attuata perché voluta. Volere è una cosa, invocarla è di<br />
più, cioè significa desiderarla, voler star soli, approfittare della capacità di riflessione sulle vicende umane e sulla storia.<br />
Non sopporto chi, per risolvere un problema, va a chiedere aiuto ad un altro; credo nell’aiuto scambievole, mutuo, sociale, ma dico che l’uomo<br />
deve risolvere da solo i suoi problemi; perché il problema del poeta è se stesso, filtrato attraverso tutte le interferenze che si vuole, ma è se<br />
stesso, assolutamente se stesso. E quando un poeta si sofferma a ragionare su qualcosa che riguarda l’altro da sé in rapporto a se stesso, i<br />
problemi sono forti. Sono forti perché così apprende ad essere gli altri. Quindi i drammi si scontano in solitudine, ed in letteratura lo scrivente<br />
resta solo a fare i conti con la sua produzione, sapendo che il valore dell’uomo sta in ciò che è, e non in ciò che fa.<br />
Nella mia poesia vi sono, comunque, degli ascendenti, degli antenati recenti, delle scritture che possono essere individuate come compagne<br />
culturali del viaggio per il tramite della poesia: Vittorio Bodini (“il Sud ci fu padre, nostra madre l’Europa”); Rocco Scotellaro (“ho capito fin<br />
troppo gli anni, i giorni e le ore, gli intrecci degli uomini…”); <strong>Leonardo</strong> Sinisgalli (“chi ama non riconosce, non ricorda, trova oscuro ogni<br />
pensiero, è straniero ad ogni evento”).<br />
Ma anche vivono in tanti miei versi: la leggenda di Recanati, un Cardarelli marchigianissimo negli accenti (in Prologhi, viaggi e favole),<br />
Matacotta e Bartolini, Paolo Volponi; e tutto in una linea di sviluppo attentivo.<br />
Qual è il significato che attribuisce al linguaggio e alla parola?<br />
Penso quello della comunicazione diretta ed immediata.<br />
La sua parola assume un significato che non solo effetto retorico.<br />
No, mi pongo proprio il problema di non essere retorico<br />
La sua parola, come l’ha definita Giovanni Tesio (6), è antiparola?<br />
Sì, perché nel momento in cui si ricerca la funzione della parola, si fa anche l’operazione di negare alla parola ogni funzionalità che non sia<br />
diretta<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
34
Poesia – Umanità<br />
diretta all’ascolto o alla sua lettura; quindi potrebbe essere antiparola; ma in quell’antiparola si deve mettere tutto il lavorìo, la fatica che lo<br />
scrittore fa per poter raggiungere la parola più efficace possibile. D’altro canto la poesia è linguaggio puro: quando si dice che la poesia è il<br />
linguaggio più puro e difficile, significa che è anche difficile determinarlo, crearlo, interpretarlo.<br />
È stata importante per lei l’esperienza della neoavanguardia?<br />
Sono convinto che la parola contenga in sé un significato di incarnazione: la poesia la chiamerei “parola incarnata”, cioè parola che si fa carne, si<br />
fa gesto, si fa volontà, si fa azione, si fa attività, si fa motivo, si fa configurazione dell’essere: la poesia è una forma di incarnazione, ovvero<br />
l’uomo è anche parola.<br />
La neoavanguardia l’ho ammirata, studiata ed apprezzata, ne ho acquisito qualche motivazione, ma non ne condivido l’ideologia perché il suo<br />
risultato è l’incomunicabilità. Però prendo atto che ai fini del perfezionamento dello stile, la ricerca dei neoavanguardisti è stata utile, anche al<br />
lettore. Perché? Perché, mentre loro facevano la loro rivoluzione da scrittori, spingevano a che il lettore facesse la sua rivoluzione da lettore,<br />
quindi la rivoluzione del gusto.<br />
La sua è una poesia metadiscorsiva?<br />
Perché metadiscorsiva? In ogni scrittura c’è la presenza del metadiscorso. Ma che cos’è poi il metadiscorso? Il metadiscorso è il tentativo,<br />
scrivendo, di superare una concezione della scrittura.<br />
Si può parlare di “concretezza linguistica”?<br />
Quando la poesia si gioca sul civile, penso proprio di sì.<br />
Molte mie poesie sono dichiarazioni di poetica. In molte poesie vive il richiamo a grandi figure come Antonio Banfi, Tommaso Fiore, i fratelli<br />
Rosselli tra gli altri. È una poesia esplicita.<br />
Reagisco alla mia concretezza; se sono concreto è perché lo desidero, e talvolta mi sciolgo in un canto che mi appassiona… Ma quello è<br />
l’esercizio della mia libertà: un poeta non può essere schiavo dello stile, né della storia, e nemmeno degli altri. Scrivere è come “ditta dentro”,<br />
non è una negazione dello stile.<br />
Come si articola il suo periodo poetico, anche dal punto di vista grafico?<br />
Innanzitutto prediligo usare i soggetti al termine delle frasi, anche di quelle lunghe; le mie poesie si distinguono, ad esempio, per le chiuse. Per<br />
me la poesia è la costruzione di un’idea che avviene per versi.<br />
Sottolineo, uso il sinonimo, ripeto molto, perché la parola gridata, scritta sulla pagina, diviene più efficace. Ad esempio, la parola amore: se io la<br />
ripeto una, due, tre volte, una volta in tondo, una volta in corsivo, una volta spaziata, una volta sottolineata, significa che ho attribuito ad essa<br />
diverse intensità; la sistemazione dei versi sulla pagina è importante.<br />
Ne La lettera sulla condizione (7) scrivo: “io ti dico che il rancore esiste”, perché “esiste / l’uomo bocconi sulle pietre”, che “scende giù<br />
negl’interstizi / e grumi sotto la storia di questa terra”; il rancore esiste perché il poeta è “prima di tutto” (spostato a margine estremo ed in<br />
corsivo) “un provocatore”.<br />
Il poeta deve fare in modo che chi legge una poesia faccia fatica, metta in atto le ragioni di una sua crescita, altrimenti a che cosa serve la<br />
poesia? Anche la coniazione di parole difficili serve a far riflettere. Così avviene anche in Chiave d’antilettura enne (8), dove si ha il ripetere di<br />
“non tacere, non tacere”; ancora: “la scimmia che ti vive / dentro / e macina sentenze”, ma macina anche “silenzi”, quindi, infine, l’alternativa è<br />
“non tacere<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
35
Poesia – Umanità<br />
“non tacere / allora e mai”; ovvero il senso del ruolo del poeta come provocatore. È il poeta che, in quanto uomo, si muove all’interno di uno<br />
spazio che gli altri hanno disertato e che lui viene ad occupare interamente, facendosi carico di molte responsabilità.<br />
In questo caso, poi, la poesia per me possiede un altro sinonimo ideologico, che si chiama verità, e nulla va più d’accordo con la verità che non<br />
tacere, perché il tacere significa sotterrarsi nell’afasia. Il silenzio, anzitutto, non è nemmeno parola; il “non tacere” è il contrario del silenzio,<br />
come la parola è il contrario di tutto ciò che è muto.<br />
Quale significato nascondono titoli come Chiave d’antilettura enne…?<br />
Il mondo, per essere capito, deve essere interpretato, e per avere l’interpretazione delle cose del mondo e della loro rappresentatività<br />
occorrono delle chiavi, ma non è detto che la lettura di una vicenda debba necessariamente soddisfare; e allora l’antilettura corrisponde alla<br />
necessità di voler comunque interpretare, tra le cose del mondo, quello che esse sono e il loro contrario: la dialettica che si usa deve servire per<br />
volere e scoprire la dialettica anche oppositiva delle vicende del mondo.<br />
Anche della contraddizione?<br />
Certo: la contraddizione è una risorsa energetica straordinaria non solo dello scrittore, ma direi dell’uomo.<br />
È possibile riscontrare, nelle sue poesie, tracce surrealistico-simboliste spagnole o di altre correnti filosofico-letterarie?<br />
Quando si legge un filosofo di forte sostanza ideologica, si va subito a ricercare un poeta di forte rilevanza, si cerca un apparentamento perché<br />
ambedue hanno dato risposte, ciascuno a loro modo, ad un interrogativo dell’essere umano, del soggetto; ma qui sorge anche l’altro problema:<br />
quale uomo? Quando io scrivo una poesia, ho già la fisionomia del mio lettore: pensando che i lettori possano essere anche tre, ho già tre<br />
caratteri diversi…<br />
Poi la latitudine: un libro può essere comprato a Palermo, un altro a Genova, un altro ancora ad Ancona…<br />
Esiste sempre un rapporto tra la filosofia e la poesia, perché la filosofia riesce ad universalizzare i problemi. Piersanti, ad esempio, che è un<br />
poeta straordinario nella trattazione del paesaggio, non canta solo l’albero, ma la natura, l’essere della natura, che significa essere nel mondo,<br />
respiro di vita… Sono concetti universali: il poeta è soggetto universale. Inoltre, riprendendo anche un certo senso cristiano della vita, si scopre<br />
che l’uomo più umile ha la dimensione straordinaria dell’universo.<br />
L’ideale del poeta è sapere che ci sono degli amanti della poesia, anche se non degli scriventi della poesia, pronti a dialogare e a dibattere con<br />
lui. È importante, infatti, che egli non dibatta solo con i critici letterari, ma soprattutto con il lettore. Il critico dovrebbe essere colui che indica al<br />
lettore possibili interpretazioni e chiavi di lettura per capire una certa opera, soprattutto ponendosi come discriminante l’interrogativo “perché<br />
ha scritto questo?”, e, “come lo ha scritto?”.<br />
In realtà c’è già nella parola “poesia” una sorta di universalità intrigante; l’aggettivo “poetico” si può aggiungere a tante cose: “volto poetico,<br />
linguaggio poetico, corpo poetico, fare poetico…”.<br />
Mi pongo delle domande e da qui nascono altre domande: si potrebbe dire che è un fatto sinonimale, un apparentamento concettuale. È il<br />
lettore che deve interpretare; io ho dato un messaggio, ma non posso dare una risposta.<br />
Allora, “per chi” e “perché” vale scrivere poesia e pensarla soprattutto?<br />
Scrivo poesia per sfuggire al fastidioso ed odioso strapotere che la vita esercita su di me e sulle mie libertà. Non mi faccio sopraffare, non mi si<br />
vedrà mai con la guardia abbassata, soccombere; non scriverò mai poesie reduce dalle sedute d’analisi, e tanto meno subirò la sopraffazione.<br />
Vivere al lettore<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
36
Poesia – Umanità<br />
Vivere è un dovere che si deve scontare. Il significato dell’esistenza è implicito alla lotta.<br />
Spero di non essere, per questa ragione di vivere, il solo. Sono disposto a capire chi si lascia morire, ma non transigo sulle ragioni dell’esistere<br />
ad ogni costo. Tanti motivi d’esistenza nel mondo li ritrovo nella vita stessa e nell’amore smodato per la mia. Attraverso gesti e parole, spesso<br />
forti e tragici, mi addentro quotidianamente in una sorta di disputa che mi esalta; in una disputa persino impari, ma con l’intenzione di rendere<br />
plausibile e protagonista il mio pensiero divergente e debole su e di. Comunque con l’orgoglio di chi ricerca una ragione linguisticamente<br />
“incarnata”.<br />
Molto spesso al tempo d’oggi, tragico e malvagio, creatività è una parola orrendamente usata in una società massificata e schiavizzante come la<br />
nostra, in cui anche gli intellettuali “fanno del loro meglio” perché sia culturalmente invivibile ed inaccettabile. “Essere creativo” è divenuto<br />
addirittura un mestiere. Ma in sé la creatività resta la capacità individuale di cogliere nessi e rapporti tra le cose e le idee in modo sempre<br />
nuovo. Poesia, quindi, è inventare scardinando i sistemi di pensiero tradizionali. È la conquistata libertà di pochi che diviene garanzia della<br />
libertà di molti.<br />
Qui si fonda la quotidiana domanda come istanza a me stesso: se, cioè, il linguaggio davvero costituisca il medium tra le incarnazioni storicoculturali<br />
dello spirito dell’uomo ed i grandi fenomeni che attengono alla coscienza.<br />
È ancora possibile, ma è assolutamente credibile che un’idea che è diventata socialmente condivisa, sia già divenuta tradizionale; ogni idea o<br />
idealità deve avere dentro di sé gli strumenti per rinnovarsi; quindi deve mettere alla frusta i soggetti. L’uomo deve avere sempre qualcosa da<br />
inventare.<br />
Lei si definisce un intellettuale?<br />
Io mi definisco una persona che avrebbe tanto voluto non essere un intellettuale, inteso in senso spregiativo. Intellettuale è qualsiasi persona<br />
che usa l’intelligenza per agire. In questo, l’intellettuale inteso semplicemente come scrittore mi sembra una deformazione e anche una forte<br />
riduzione, perché così inteso non sarà mai gli altri, ma solo se stesso.<br />
(1) In Dichiarazioni silenzio e giorni (5) In Dichiarazioni silenzio e giorni<br />
(2) Ibid (6) Nell’introduzione al volume L’utopia reale<br />
(3) In L’ultima rosa dell’inverno (7) In Alle radici dei gesti e altre cose<br />
(4) In Alle radici dei gesti e altre cose (8) In La bella scienza<br />
<strong>Leonardo</strong><br />
<strong>Mancino</strong><br />
37
voci
Enzo Esposito. Senza titolo,<br />
serigrafia polimaterica su carta
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
38<br />
Anna Elisa De Gregorio ed il contrappunto dominante della sua poesia di Danilo Mandolini<br />
La grande arte è un mestiere piccolo.<br />
Invisibile.<br />
Ivano Fossati, Invisibile<br />
C’è un passaggio, un sostantivo in realtà, nella puntualissima prefazione di Alessandro Fo all’opera prima<br />
in versi di Anna Elisa De Gregorio, che, se preso ed estrapolato dal contesto dello stesso elaborato critico<br />
introduttivo, e a guardar bene, può sorprendere e apparire come una curiosa coincidenza (quasi una stortura).<br />
La curiosa coincidenza alla quale ci si riferisce salta all’occhio soprattutto se si affronta la prefazione solo dopo<br />
aver letto tutte le liriche della raccolta e mettendo in parallelo queste ultime ed il resto della prefazione (il<br />
tono generale, i contenuti, tutto - insomma) proprio con la parola che determina la presunta bizzarria di cui si<br />
sta parlando. Il sostantivo “incriminato” (una sola volta utilizzato da Alessandro Fo e mai, insieme al relativo<br />
verbo, dall’autrice del libro) è inseguimento. Questo termine è stato ritenuto, sì, è stato percepito, in prima<br />
battuta e da chi ha messo a punto questa breve presentazione, come disallineato rispetto, ad esempio ed in<br />
particolar modo, alla “composta naturalezza, al passo (…) delicato del sogno” che il prefatore individua come<br />
tratti precipui della pronuncia di Anna Elisa De Gregorio. Non c’è nulla, infatti, ne Le rondini di Manet che<br />
raffiguri, anche solo lontanamente, dinamiche del linguaggio, del vedere e del sentire che non siano pacate.<br />
Il lettore attento, però, non tarderà ad accorgersi - magari aiutato da una nuova lettura dell’intero<br />
volume e seguendo, questa volta, l’ordine indicato dalla numerazione delle pagine - che la supposta stranezza<br />
evidenziata è tale (oltre che rappresentare lo spunto, quasi la scusa, per l’apertura di questo testo) soprattutto<br />
perché essa delinea una sorta di estremo molto diverso ed in qualche modo contrario rispetto a quello<br />
costantemente impiegato nel “gioco” del contrappunto dominante che attraversa orizzontalmente, quasi<br />
permeandone ogni riga, il libro d’esordio della poetessa anconetana.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
39<br />
Si è detto contrappunto… Si tratta di un contrappunto non così palese, però; di un “dispositivo” che<br />
mette in parallelo due effetti di contrasto non dichiarandone apertamente uno. L’effetto di contrasto,<br />
l’estremo dichiarato - rivelato anche dall’autrice nella Nota finale - è quello che mette al centro del fare poesia<br />
di Anna Elisa De Gregorio, quasi come fosse il punto di avvio per ogni riflessione, le piccole cose. Le piccole<br />
cose che interessano il poeta sono gli oggetti riposti, abbandonati o che si usano, le piante e la vita silenziosa<br />
di queste, le minime visioni degli uomini che nell’immediato tendono a svanire (l’eco delle frasi, i luoghi che si<br />
frequentano o anche solo si scorgono o che tornano per un attimo alla memoria). Questa materia e queste<br />
vicende apparentemente marginali sono come immobilizzate nel tempo che si fa sguardo vigile e sospeso ed<br />
offerto al lettore in un racconto che è volutamente leggero e minimo e, proprio per questo, unità di misura e<br />
speciale scandaglio, così li definisce Fo, ideali per filtrare la realtà e per esaltare quell’immenso opposto che il<br />
poeta sceglie di non dire troppo direttamente, di rendere in qualche modo nascosto, perché sa che non potrà<br />
mai essere compiutamente detto: la vita, l’essere al mondo di tutto ciò che nel mondo vive. Un esempio<br />
mirabile, anche per sintesi ed immediatezza, di quanto si è appena affermato è la prima delle due quartine<br />
che compongono il breve testo dedicato a Sandro Penna (uno tra i poeti del Novecento italiano più votati al<br />
racconto in versi delle piccole cose) e che , per l’appunto, s’intitola Un piccolo sogno: “Ho baciato un ragazzo, /<br />
la saliva e il sorriso, / e so perché si vive / la vita per un sogno.”.<br />
Le serie di haiku poste a chiusura di ognuna delle tre parti che strutturano la raccolta testimoniano e<br />
supportano, così come la delicatezza del timbro poetico (che tanto è sembrata stridere con il sostantivo<br />
inseguimento di cui all’inizio di questa nota), questo contrappunto continuo che ne Le rondini di Manet si<br />
concentra su ciò che è minuscolo - intimo, del singolo individuo - per esaltare ciò che è smisuratamente ed<br />
inspiegabilmente più grande e comune a tutti.<br />
Ma non è sempre del vivere, in fondo, sia esso osservato attraverso la prospettiva che va dall’esiguo allo<br />
straordinariamente più grande o viceversa, che il poeta e la poesia disquisiscono? Non è dell’essere degli<br />
uomini che si continua a trattare? Questo nostro esistere così variamente ed inesorabilmente imperfetto e,<br />
anche, semplicemente perfetto quando meno te lo aspetti (la cosiddetta eccezione che conferma la regola) è<br />
collocato dall’autrice, in particolar modo nella sezione centrale del libro, in una dimensione come sfocata che<br />
stupisce per la serenità con la quale si tenta di descrivere, usando ancora le parole di Fo, il mistero che ci<br />
avviluppa (un enigma che si materializza nei titoli e nei sottotitoli dati alle poesie; titoli e sottotitoli che sono
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
40<br />
innanzitutto un repertorio delle trascurabili imperfezioni e provvisorietà umane) e per la disinvoltura e<br />
l’originalità con le quali si dice la vicinanza, l’irrinunciabile e naturale connessione tra le nostre vite e le nostre<br />
morti: “Il confine è aperto / fra vivi e morti / infiniti varchi / dove i più cari / si confondono / sempre a<br />
richiamarci.”; “Radici in aria / e sotto terra i vivi / mondo a rovescio”.<br />
Ancora grazie alla Nota finale scopriamo che l’organizzazione della raccolta suggerisce il rilievo di tre<br />
ulteriori elementi che sono altrettanti scenari sui quali vengono come adagiate le singole poesie. Le tre<br />
“entità” in questione sono l’aria per i ventagli, l’acqua per l’imperfezione e la terra per ciò che è piccolo (si<br />
ricordino i titoli delle tre sezioni del volume: Le stanze dei ventagli, Le stanze imperfette e Minime stanze, dove<br />
la costante stanze può apparire funzionale ad orientare il lettore verso un’esperienza di realtà familiare e<br />
condivisibile). Si tratta di tre componenti, quelle appena elencate, talmente essenziali per la vita in questo<br />
mondo che - con il bagaglio delle riflessioni finora prodotte - non si può qui rinunciare alla necessità di<br />
dichiarare che l’opera in versi di Anna Elisa De Gregorio va diritta, procede in maniera mirata - arricchita dalla<br />
varietà dei punti di osservazione offerti al lettore - verso, dentro ed attraverso l’essenza di una modalità<br />
sorprendentemente articolata e dettagliata di interpretare, in versi, il nostro vivere.<br />
È una sorta di sublimazione della quotidianità che tende a non essere vista, questo Le rondini di Manet.<br />
È la celebrazione di ciò che è celato nei giorni e che, anche e per come è scrutato, sembra essere un volo; “un<br />
volo che” - così si esprime l’autrice - “porta in sé la direzione”.<br />
Le rondini di Manet di Anna Elisa De Gregorio, Edizioni Polistampa, Firenze, 2010<br />
La scelta di testi che segue è stata curata da Danilo Mandolini.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
41<br />
Da LE STANZE DEI VENTAGLI<br />
UN TEMPO STRAORDINARIO<br />
In cucina, da sfondo la credenza azzurra<br />
condominio di chicchere e piattini,<br />
uno sportello aperto e poi richiuso<br />
con lo scatto, sentore di caffè subito zittito.<br />
È la padrona di casa che sparecchia, severa.<br />
Ma un moto inatteso disordina le quinte:<br />
scomparsi grembiule e macinino,<br />
la severa si volta, da crisalide a farfalla,<br />
si accompagna sottovoce in una tarantella<br />
con abito nero, la balza in fondo che vola<br />
e piccolo ventaglio tre onde di capelli<br />
bianchi per diadema. In primo piano<br />
la credenza che guarda stupefatta<br />
in ballo due pantofole di panno.<br />
LA DISTRAZIONE DELLA BELLEZZA<br />
Culla di mare<br />
dondola il cesto africano,<br />
catenelle di paglia<br />
sui capelli. Copre la grazia<br />
dei polsi una tovaglia<br />
che nessuno compra.<br />
Solitario, più fantastico<br />
per il controsole<br />
il corpo clandestino,<br />
passi ridotti da un telo.<br />
Sollevano ai bordi del mare<br />
ventagli di rena le infradito:<br />
scontornati pensieri<br />
di una sabbia più fine,<br />
di un deserto splendente<br />
mentre racconta dei figli<br />
lontani, miracolosi sorrisi.<br />
Solo il mare è al suo posto.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
42<br />
I DOLCI POLSI DELLE ROSE<br />
a C.Wright<br />
Libri cari che durante la lettura diventano<br />
quaderni per appunti, tentativi di pensieri,<br />
risposte a matita sui primi fogli bianchi<br />
e, ai bordi della stampa, disegni di cornice.<br />
Un dito si ferisce sul taglio delle pagine:<br />
una goccia per essere fratelli di scrittura.<br />
Quando si spaginano libri, nascono ventagli,<br />
lettere in catena aprono parole,<br />
lasciando sfuggire code di cometa:<br />
sotto lo strato esterno nascono rose.<br />
STORIA DEI PENSIERI<br />
Stecche chiare di legno sostenevano<br />
il nero del tessuto: rose plissettate<br />
in piena luce, poi socchiuse come belle<br />
di notte, scomparivano alla fine nel nulla<br />
per un moto gentile e crudele della mano.<br />
L’idea di quelle rose in continuo mutamento<br />
e poi nascoste era la stessa che mi ero fatta<br />
dei pensieri, cangianti e soprattutto segreti.<br />
Si chiudevano in ventaglio al mio comando,<br />
possedevo io sola quella fragile membrana:<br />
voli di pipistrelli nelle grotte, germani reali<br />
che nuotano con splendide zampe palmate.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
43<br />
IN CHE POSTO RIPOSARE<br />
Sempre mio albero custode<br />
la pianta di fico, più vecchia<br />
dell’uomo e della Bibbia,<br />
monaco che porta in bisaccia<br />
una passione, albero che spesso<br />
digiuna e profuma sulla terra:<br />
notte in un cortile d’infanzia.<br />
Settembre per aprire un frutto<br />
sotto i rami, mangiare polpa e granelli<br />
dorati. Tante foglie palmate, tanti<br />
ventagli, una certa ruvidezza sul viso<br />
di chi prima di me con aria familiare<br />
si è appoggiato a questa ombra,<br />
occhi simili ai miei, simili pensieri.<br />
Albero tenerello di fico pitturato<br />
sulla Pala Gozzi quasi al centro<br />
del dipinto, appassito da un tocco<br />
di rosso, presagio di tramonto.<br />
Dove il ramo si divide in due,<br />
dove ogni foglia è mano aperta<br />
per implorare aiuto e forse darne.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
44<br />
LE STANZE DEI VENTAGLI<br />
Sassi in mare<br />
si allargano ventagli<br />
ancora e ancora<br />
Tempero il lapis<br />
ventaglietti di legno<br />
dentro il cestino<br />
Fisarmonica<br />
che apre la sua anima<br />
suona ventagli<br />
Arriva Batman<br />
un ventaglio nel cielo<br />
è l’aquilone<br />
Grande la mano<br />
che apre l’arcobaleno<br />
ventaglio a strisce<br />
Scuri ventagli<br />
le campane in preghiera<br />
sopra il tramonto<br />
Muove la fiamma<br />
in perenne daccapo<br />
ventagli su ventagli<br />
Preziosa notte<br />
un ventaglio di giada<br />
la mezza luna<br />
Segna il pendolo<br />
i suoi svelti ventagli<br />
suono del tempo<br />
Tondo ventaglio<br />
piano piano si chiude<br />
la luna in quarti
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
45<br />
Da LE STANZE IMPERFETTE<br />
COMINCIO DAGLI ULTIMI<br />
(i piedi imperfetti)<br />
Confidenza fraterna<br />
fra me e i piedi chiusi<br />
nelle scarpe, sostegno<br />
sulla terra umiliata<br />
dalla città d’asfalto.<br />
Volte verso gli insetti<br />
queste mie piante larghe<br />
ricevute dai nonni,<br />
ricordi di fatica<br />
i piedi senza grazia.<br />
Ora abitiamo al mare:<br />
non è la nostra casa,<br />
su una reggia d’acqua<br />
come orfani in gita<br />
senza padre a salvarci.<br />
NOTTI IMPERFETTE<br />
Quando la stanza<br />
diventa una nave<br />
facile mescolare<br />
tempo ai luoghi<br />
incontrare le ore<br />
in altri mondi.<br />
Abbandonata riva<br />
nell’incerto<br />
trasporto<br />
e più incerto destino<br />
quello che resta<br />
dell’intero giorno.<br />
Il confine è aperto<br />
fra vivi e morti<br />
infiniti varchi<br />
dove i più cari<br />
si confondono<br />
sempre a richiamarci.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
46<br />
LA RADIO PARLAVA<br />
(l’imperfezione della paura)<br />
Si sbrigava<br />
a legare pomodori,<br />
spingeva in terra<br />
canne come croci:<br />
gesti che rassettavano<br />
la terra<br />
più di preghiere<br />
sotto la paura.<br />
La radio parlava<br />
del terremoto.<br />
Per tutta quell’estate<br />
scendeva<br />
col bastone ogni mattina<br />
nell’orto,<br />
coglieva cetrioli<br />
e pomodori rossi.<br />
Mangiavamo insieme<br />
grandi insalate<br />
profumate di sedano<br />
in silenzio.<br />
ANNIVERSARIO DIMENTICATO<br />
(ricordo imperfetto)<br />
A quattro piedi<br />
sulle foglie d’autunno<br />
illuminati<br />
Tu avanti, io dietro<br />
calpestiamo le stesse foglie<br />
in ripetute nostre passeggiate.<br />
Dietro il velo rotto dei ragni<br />
novembre lavora sotterraneo<br />
custode della vita futura,<br />
letto per tutti i fruscii,<br />
che appartengono ai morti:<br />
anche per loro il mare è viola.<br />
Vorrei che fossi tu<br />
a custodirmi viso e mani<br />
se non saprò più farlo:<br />
anche quando non lo ricordi<br />
a novembre torniamo ogni anno<br />
custodi consacrati l’uno dell’altro.<br />
È stato il segreto condiviso<br />
di due vite, quello che già basta<br />
per dare senso al nostro camminare.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
47<br />
METAMORFOSI<br />
(l’amore imperfetto)<br />
L’amore fa cambiamenti<br />
nel tempo,<br />
si riconosce<br />
per un unico odore<br />
leggero<br />
nella polvere di talco.<br />
Fra un dito e l’altro<br />
dei piedi asciuga<br />
le pieghe del neonato,<br />
rispettoso<br />
sulla schiena sbiancata<br />
dei vecchi.<br />
Stessa cura, chiarore<br />
che sfarina<br />
nel nulla: noi due<br />
senza parlare<br />
per il vento dei vicoli<br />
sul porto.<br />
L’odore arriva a tratti,<br />
impreziosisce<br />
ogni gesto: prima<br />
di separarci<br />
riesco a stringere<br />
la tua mano fredda.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
48<br />
IMPERFETTA VOCE<br />
Facile silenzio la notte<br />
nella città di pace apparente.<br />
Si fa chiaro lo scivolare<br />
delle ruote sulla strada,<br />
le lancette che dalla cucina<br />
girano le ore, battono il cuore.<br />
Ritornano le verità di madre<br />
messe in dubbio alla luce<br />
dell’adolescenza (da ragazzi<br />
è sempre troppo giorno per sentire,<br />
si scappa dal buio delle stanze).<br />
Ogni inverno mia madre diceva:<br />
«Ci sono fiammelle nella legna<br />
giù in cantina, accatastate<br />
vite in un saio di penitenza,<br />
di notte diventano viventi».<br />
Disatteso richiamo: per paura<br />
ho negato le sue vere parole<br />
sotto coperte di silenzio.<br />
Stanotte le primitive fiammelle<br />
hanno un contorno, le ascolto.<br />
«Eppure, eppure…» dice la voce.<br />
LA MENTE IMPERFETTA<br />
Una sagoma sformata in piedi,<br />
dita strette alle lance del cancello,<br />
grate che entrano quasi nel pigiama:<br />
e le parole un soffio sulla strada.<br />
Adesso il cancello del manicomio<br />
è spalancato: pazienti effimeri,<br />
verde struttura di burocrazie.<br />
Nate dalla malattia disobbediente<br />
si intromettono le ombre di allora<br />
fra i cartelli da disperate stanze.<br />
Nient’altro che invocazioni libere<br />
in nicchie di mattoni, fra navate<br />
di legno con l’aria non troppo vecchia,<br />
non proprio abbandonata alla polvere.<br />
Erba corta che ogni anno torna nuova<br />
e alberi altrettanto smemorati,<br />
cresciuti accanto a vite senza nome.<br />
Per raccontarli basta la magnolia,<br />
per sapere gli alberi preservati<br />
dal dolore, isole di chiunque, ultimo<br />
o primo, sia disposto a uno sguardo.<br />
Portano segni sul tronco, intagliati<br />
cuori, appunti trascorsi di prigione.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
49<br />
LA LEGGEREZZA DEI VECCHI<br />
(inattesa perfezione)<br />
Si chiarisce nei vecchi l’idea<br />
notte dietro notte<br />
che le cose si perdono<br />
insieme con il peso delle ossa:<br />
in costante lentezza<br />
tutto traspare, si sveste,<br />
svuotate le case, i cassetti.<br />
Agli oggetti vanno via i contorni,<br />
nella valigia le carte trascorse<br />
tutte si riscrivono lievi,<br />
qualche pensiero sa di morire.<br />
Versando acqua sui bulbi<br />
comprati con troppa leggerezza<br />
viene da dire soldi spesi male<br />
(le foglie strette intorno al nulla),<br />
regalo mancato per il davanzale.<br />
Ma di ritorno dal viaggio<br />
distraente dei sogni la mattina<br />
nel dormiveglia il profumo<br />
del bianco avvento dei giacinti<br />
a divagare l’odore solito dell’orzo.<br />
Qualcosa ha cambiato direzione.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
50<br />
BREVI IMPERFEZIONI<br />
Il picchio batte<br />
sull’albero che muore<br />
becco sapiente<br />
Nessun vestito<br />
per gli alberi d’inverno<br />
scoperti i nidi<br />
Vola e si rompe<br />
fra i piatti dell’acquaio<br />
bolla di schiuma<br />
L’uomo di neve<br />
e l’uomo in un cartone<br />
diversa notte<br />
Da un fiore all’altro<br />
lega la tela il ragno<br />
ponte di mosche<br />
Radici in aria<br />
e sotto terra i vivi<br />
mondo a rovescio<br />
Violata chiesa<br />
anima della città<br />
caduta in pezzi<br />
Rami potati<br />
intimità perduta<br />
nella piazzetta<br />
Infreddolita<br />
sulle crepe d’asfalto<br />
trema la viola<br />
Sono un congedo<br />
i temporali sul mare<br />
a fine agosto
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
51<br />
Da MINIME STANZE<br />
LA PICCOLEZZA DELLE ANIME<br />
Prima voce: Sai che mi piace di più delle nespole<br />
del Giappone? I nòccioli. Due occhi di tigre,<br />
pietre che hanno specchi per riflettere misteri.<br />
Seconda voce: La nespola tiene la sua bellezza<br />
riservata, protegge i gemelli in camicie di placenta<br />
bianca, stanze per le sue due anime di luce.<br />
SCALE<br />
Giù per le mie scale quotidiane<br />
poco cittadine molto private<br />
mi scontro con il topo sbucato<br />
dalla grata di un giardino. L’urgenza<br />
di chi continuamente in fuga cerca<br />
liberi spazi verso fine certa.<br />
Girandosi davanti alle mie scarpe<br />
in cerca del passaggio nella rete<br />
addobbata di rampicanti fiori<br />
di passione non lo ritrova più<br />
e si dispera trottola rosa<br />
calamitato topo ai miei piedi.<br />
Torno indietro come musichetta<br />
di pianola, per scomparire suono<br />
lasciare libero il gradino verso<br />
una madre in disperato abbandono.<br />
Spelato di pena misero cuore<br />
il mio col suo tempo d’un passaggio.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
52<br />
VERSO ANCONA SUD<br />
Puntuali nelle sere precoci di novembre<br />
arrivano gli storni, calligrammi aperti<br />
si avvolgono in ventagli di scritture nere,<br />
semi di preghiere esaudite che entrano<br />
nei nostri giardini di latta incolonnati,<br />
occupano tutto il vetro del cruscotto<br />
verso una periferia sconsacrata.<br />
Rimane salvo il cielo<br />
e gli storni e il loro cantare<br />
che non ha domande, contrappunti<br />
di un volo che porta in sé la direzione.<br />
LE RONDINI DI MANET<br />
Due macchie in contrasto di colore,<br />
nel bianco la ragazza annuvolata<br />
da velature grigie, nel nero schiarito<br />
di antracite l’altra donna. Proprietà<br />
suprema del pennello di assegnare<br />
a ciascuna l’età: la giovinezza è piena<br />
di sé, la vecchiaia un po’ stanca.<br />
La luce che si muove e definisce<br />
profili in veletta, tese abbassate:<br />
è lei la vivace, la bella che vola,<br />
e con lei due rondini minuscole<br />
che planano a terra, segni di croce<br />
aperti fra il verdegiallo del prato<br />
a svegliare il silenzio del mondo,<br />
al di sotto del cielo, oltre la lentezza<br />
d’arcadia delle mucche e i tetti rosa.<br />
Felicità assordante il loro il canto.<br />
Laggiù vicino alle pale di un mulino<br />
quel segnaccio rosso da maestrina<br />
che annulla le nuvole: è un marameo<br />
del pennello stanco di perfezione.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
53<br />
UN SOGNO PICCOLO<br />
Ho baciato un ragazzo,<br />
la saliva e il sorriso,<br />
e so perché si vive<br />
la vita per un sogno.<br />
Svegliarsi la mattina<br />
innocenti e ripartire<br />
verso l’autunno mite,<br />
con un solo pensiero.<br />
A Sandro Penna<br />
LA GIACCHETTA DA ARLECCHINO<br />
a Monica B.<br />
Sembravi un alberello potato,<br />
i ginocchi scoperti dai calzoni a sbuffo<br />
come due piccoli nodi sui rami,<br />
giù per la strada sterrata da sola.<br />
Non avevi scelto la via delle case:<br />
senza voltarti, come si va a un esame,<br />
sulle spalle la giacchetta da Arlecchino<br />
e il cappello in testa nero a due punte.<br />
Al ritorno, in cucina sul vetro velato<br />
hai segnato col dito una sfera,<br />
una specie di omèga sul mondo,<br />
all’interno una bocca rivolta al sorriso.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
54<br />
LE COSE CHE NON SERVONO<br />
(dedicata a una ragazza)<br />
C’è chi lascia davanti<br />
ai cassonetti piante<br />
come si fa coi vecchi<br />
mobili, sono oggetti<br />
da tenere in vista:<br />
una speranza in fondo<br />
che qualcuno li accolga.<br />
E davvero succede<br />
che una ragazza prenda<br />
un vaso abbandonato<br />
e se lo porti a casa:<br />
paziente e grata attesa<br />
che una minuta foglia<br />
nasca, senza pretesa.<br />
Non racconto il finale,<br />
in fondo cosa importa.<br />
IL MESTIERE DELLA CHIAREZZA<br />
a G. N.<br />
Quanto del ridotto tempo<br />
alla chiacchiera ordinaria<br />
e quanto poco sguardo<br />
alla lumaca per terra<br />
all’infinita pazienza<br />
del suo vivere discreto.<br />
Riscrive il vecchio poeta<br />
rigo nero di formiche<br />
fra le pagine ospita<br />
il ramarro arreso al sole<br />
un barbagianni in attesa<br />
della biscia destinata.<br />
Nel disagio del paesaggio<br />
fa il mestiere del vento<br />
toglie polvere alle cose.<br />
Chiara striscia d’orizzonte<br />
alla mattina d’autunno<br />
poco aggiunge di domande.<br />
IL SETTIMO GIORNO<br />
Il settimo giorno<br />
non ha mattino,<br />
né sera<br />
dopo i giorni di creazione.<br />
Necessario per trovare<br />
una strada,<br />
quella ancora prima<br />
dell’infanzia,<br />
prima d’ogni paura:<br />
è un ritorno.<br />
E per quale<br />
sgranatura del tempo<br />
riconosceremo luoghi<br />
dove passano<br />
con splendore intransitivo<br />
le cose<br />
che accadono piccole<br />
ogni giorno?<br />
Questa era<br />
capacità dei poeti.
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
55<br />
MINIME STANZE<br />
Tre le farfalle<br />
un amore affollato<br />
o un haiku giallo<br />
Rugosa zolla<br />
conosce freddo e buio<br />
poi l’erba spunta<br />
Filo di bava<br />
luna su uno stelo<br />
la chiocciolina<br />
Dormono i gatti<br />
sul muro arrampicati<br />
capperi in fiore<br />
Povera strada<br />
sull’asfalto cucite<br />
toppe più scure<br />
Come un cagnetto<br />
la luna mi rincorre<br />
malinconia<br />
Sono schierate<br />
le quattro coccinelle<br />
scudi rossi<br />
Vedo immobili<br />
nel volo uccelli azzurri<br />
bevendo il tè<br />
Una foglia gialla<br />
sotto il tergicristallo<br />
multa d’autunno<br />
Nel buio un haiku<br />
mi ferma sulla soglia<br />
piccolo lume
OPERA PRIMA<br />
Le rondini<br />
Di Manet<br />
di Anna Elisa<br />
De Gregorio<br />
56<br />
Nata a Siena da genitori campani, Anna Elisa De Gregorio abita ad Ancona dal 1959. Qui lavora presso<br />
un’agenzia di marketing.<br />
Le rondini di Manet (Premio “Pisa” opera prima 2010) è la prima silloge di poesie che pubblica, anche se da<br />
sempre si interessa e scrive di poesia.<br />
Ha vinto il Premio “Haiku Empiria” 2008, l’edizione 2010 del Premio “Tommaso Grossi” e quella 2011 del<br />
Premio “Il lago verde”. Nel 2009 è inoltre risultata vincitrice del Premio “Tracanelli”, per la sezione in lingua<br />
italiana. Nello stesso anno ha ottenuto il secondo premio al concorso nazionale “Elsa Buiese” per una raccolta<br />
inedita in lingua italiana, il terzo premio al concorso nazionale “Città di Ischitella – Pietro Giannone”, per la<br />
poesia dialettale, ed è stata tra i tre segnalati per l’inedito al Premio “Sandro Penna”.<br />
Organizza incontri di poesia haiku e pubblica scritti di critica su alcune riviste letterarie.
Enzo Esposito. Senza titolo,<br />
tecnica mista su carta
Gianni Caccia<br />
57<br />
x<br />
È nato ad Alessandria nel 1962 e risiede a Novi Ligure, dove svolge la professione di insegnante di Lettere<br />
presso il Liceo Scientifico. Si è laureato in Lettere classiche all’Università di Genova con una tesi su Luciano di<br />
Samosata.<br />
Ha collaborato con le Edizioni Joker ed è stato redattore della rivista di cultura letteraria “La clessidra”, sulla<br />
quale sono apparsi suoi racconti e saggi critici. Altri suoi contributi sono stati pubblicati sulle riviste “Galleria”,<br />
“Concertino”, “Il lettore di provincia” e “Hebenon”. È redattore della rivista on-line “Senecio”.<br />
La sua passione per la cultura classica, in particolare greca, ha prodotto il saggio breve Il tifo, malattia del<br />
corpo e dell’animo nell’antica Grecia (Edizioni Joker, Novi Ligure, 1997) ed alcuni articoli apparsi sulle riviste<br />
“Atene e Roma” e “Sandalion”. Ha inoltre curato, per la collana dei classici della Newton Compton, l’edizione<br />
dei Dialoghi di Luciano di Samosata e del Fedro e della Repubblica di Platone.<br />
Ha pubblicato le raccolte di racconti Aperture (Edizioni dell’Orso, Alessandria, 1994), La Vallemme dentro<br />
(Edizioni Joker, Novi Ligure, 2000), La stadera (Edizioni Joker, Novi Ligure, 2005) e la raccolta di favole Anselmo,<br />
il locomotore color pompelmo (puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2010).
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
58<br />
x<br />
Da I RICORDI DEL VECCHIO VALLEMMANO<br />
La coperta di nebbia che si dipingeva agli occhi straniti di Francesco era germogliata dalla terra stessa. La strada di ghiaia che scendeva al<br />
ponte spariva dopo la svolta nella palude impalpabile, da dove tronchi brulli di umidore protendevano braccia rinsecchite come a chiedere<br />
aiuto e non affondare del tutto nel soffice piano di letargo. Il senso di essere levato da terra investì il giovane nei pochi passi che lo<br />
separavano dall'auto: lui sopra, sul poggio verde mangiato dal fango che dominava il corso invisibile, e là sotto la nebbia che aveva<br />
inghiottito la strada e il ponte e la sua acqua nell’incanto novembrino, il solito e sempre diverso, come solita e sempre diversa è la<br />
Vallemme. Poi lo schiaffo del motore rovinò in quel sonno a riavvolgere la marcia, persino la nebbia, fitta e sicura a mirarla dal poggio e ora<br />
si disfaceva di fronte all’auto per ricomporsi poco più in là.<br />
Ma era qualcosa di nuovo in quel mattino: la valle fermata nell’abbraccio di un nulla, al cenno di quell’autunno maturo, Francesco<br />
l’aveva subito colto nel cricchiare sommesso della ghiaia ai primi passi fuori di casa, in cortile. Gli dava sempre un effetto inatteso una festa<br />
a mezzo della settimana; era un bicchiere troppo rapido e non aveva il tempo di berlo per intero, ma almeno spezzava la frenesia delle date<br />
e apriva una pausa, un vuoto così dissimile dalla vacanza d’uso, e se non era per qualche lontano scampanio che forava la scialba coltre di<br />
stagione, l’avresti detta una delle tante mattine sonnacchiose della Vallemme, dove nei giorni di cenere, o quando un sole di gelo posa i<br />
suoi raggi tentennanti sulle pietre spoglie e incinte d'acqua, la vita ricalca la meditata inerzia del fiume; una goccia di avara saggezza ben<br />
compresa dalla carpa che con accidia gironzola sul fondo della sua pozza, cercando il ristoro della melma.<br />
Sbucare con il muso dell’auto sullo stradone fu come evadere; la striscia d’asfalto con chiazze di bagnato era una parte a sé nella valle,<br />
neanche la nebbia la voleva. E non era come passare dai ciottoli terrosi giù dalla Castagneta all’asfalto del ponte, che rifatto dopo la piena<br />
aveva sortito la sua fetta di modernità, mentre non ne erano state tocche la stradaccia tutta pietre verso la cascina e le altre, compagne al<br />
corso del Lemme, che confluivano al suo imbocco. L’ultima parte, la più dolce, della discesa era già nebbia, così che la fine dei sobbalzi<br />
mutò di poco nella matassa grigia che si scioglieva sotto i fari e rinasceva subito dietro di lui, immemore del suo passaggio. Anche lo<br />
stradone appariva deserto in quel mattino, partecipe del silenzio che era planato sulla valle con la pazienza dell’acqua viva sotto la crosta<br />
del ghiaccio, approfittando di quella feria per prendersi la sua rivincita. Aveva arrestato l’auto sul ciglio benché non vi fosse bisogno, e<br />
subito il gesto dell’abitudine fu sopraffatto dall'aspetto della provinciale, che non dava segno di vita fin dove la nebbia accorciava lo<br />
sguardo e tornava a trionfare, anche sull’asfalto.<br />
Era di quelle volte che Francesco avvertiva il pulsare nascosto della valle. Di solito la passava inosservata, le mattine che prendeva la<br />
direzione del lavoro, verso Alessandria, e tanto più di sera, quando non concepiva altro che il suo piede sull’acceleratore. Allora era<br />
soltanto un tramite necessario, il ponte verso casa e il resto; ma oggi vi respirava dentro, viveva la sua Vallemme con il greto, gli alberi radi,<br />
le sterpaglie morte che si sottraevano a lui, ferme nel loro solito palmare mistero. Forse era perché oggi voltava dall’altra parte, e in effetti<br />
ebbe da rifletterci un po’ su per sterzare in senso opposto e correre nella direzione della domenica. Francesco si immaginava come l’unica<br />
cosa in moto dentro il sopore del mattino vallemmano e quasi gli pareva di violare l’incanto della bruma, ordinata a chiazze sulle coste e le<br />
colline che sorgevano dal fiume, con il verde che spariva e si riaffacciava ancora più lucido nel contrasto: ma solo in quei giorni senza data<br />
poteva concedersi la visita a Mastro Genio, ricorrenze comparse dal nulla nel calendario o pomeriggi bagnati nel sole dell’ultima estate,<br />
quando si godeva scampoli moribondi di ferie rivestendo poco a poco la pelle dell’ufficio.
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
59<br />
x<br />
Mastro Genio, misantropo per elezione, non era della natura di un giorno qualunque. Abitava in un casolare fuori mano sopra Gavi, in<br />
mezzo a un bosco di castagni che saliva in costa subito dopo il Lemme; il nome era forse diminutivo di Eugenio e sulla sua origine regnava<br />
un’annosa questione: per certo si aveva solo ch’era della Vallemme, tanto gli era entrata nelle ossa da non distinguersi più, dove la<br />
Vallemme finiva e iniziava Mastro Genio. Anche del titolo di Mastro era lecito dubitare fino a che segno fosse legittimo: non indicava un<br />
mestiere, né si sapeva che cosa avesse fatto nella vita e se l’avesse mai avuto, un mestiere. C’era chi lo voleva materassaio, chi ciabattino a<br />
Francavilla, chi contadino dalle parti della Castagneta, in una cascina dissoltasi assieme al terreno dove sorgeva, una sporgenza a picco sul<br />
Lemme che in una notte infernale di piena era sparita nelle acque, alte come mai prima o dopo d’allora; e c'era chi lo voleva vissuto sempre<br />
lì nel suo eremo, campando non si sa di cosa, più per senso innato della solitudine che per noia del genere umano, come invece sentenziava<br />
Beppe Turchino, che asseriva di averlo frequentato, infinito tempo prima, tra un mazzo di carte e un bianchetto. Insomma, pretendevano<br />
di averlo visto un po’ dappertutto in Vallemme, e poco mancava che se lo rivendicassero, mentre i più gli negavano un’esistenza oppure<br />
parlavano di una leggenda, di superstizione; Francesco nelle sue passeggiate in costa indagava ancora il cascinale dove avesse potuto<br />
ergersi e ogni volta credeva di aver trovato una nuova traccia. Ma i pochi che ne dispensavano notizia lo davano per solitario abitatore della<br />
bicocca semidiruta nel bosco di castagni e nessuno l’aveva mai visto altrove; il resto, i suoi mestieri e le sue dimore su e giù per la<br />
Vallemme, erano un sentito dire. Persino il vecchio Beppe, lui che doveva essere il più addentro a quell’individuo dai contorni di nebbia,<br />
non lo ricordava altrimenti: come se fosse stato sempre lì, dove la memoria di quei pochi lo piazzava, e non avesse mai cambiato età né<br />
aspetto.<br />
Francesco aveva incontrato Mastro Genio una domenica d’autunno di qualche anno addietro, mentre andava in cerca nel suo bosco. Chi<br />
sa come gli era venuto in mente, quel mattino presto, di scambiare l’asfalto maestro con il guado malsicuro e poi con lo sterrato ben<br />
sconnesso che si infilava in un gomitolo di alberi buio più del solito e avviluppato in un puro silenzio. Quand’ebbe abbandonato l’auto, dove<br />
lo sterrato si assottigliava a un viottolo di terra pesta, dal bruno intenso, ebbe l’idea che il bosco fosse nato lì per lui, sul momento – eppure<br />
arrivava ancora qualche ronzio dello stradone, invisibile dalla pista tappezzata di buche come una groviera; dal suolo morbido di fogliame<br />
cresceva un profumo indeciso, di altri autunni. Il covo di un folletto, gli era stato naturale pensare. Ma non assomigliava davvero a un<br />
folletto il vecchio che gli si fece incontro poco dopo, mentre sedeva sulla base di un tronco tagliato, con gli occhi infissi nella borsa di<br />
plastica a contare le poche castagne e un presunto porcino. Non ricordava di aver trasalito all’apparire della sua figura trasandata e insieme<br />
composta, come se quel disordine obbedisse a una regola interna, i capelli grigi arruffati e un sorriso a pochi denti gialli incorniciato da una<br />
barba lunga ma non proprio incolta. Portava la giacca e i pantaloni scuri di una festa remota, sparsi di strappi e buchi senza toppe e immuni<br />
dalla minima macchia, al pari della camicia bianca sporgente dal colletto liso; non una traccia di fango intaccava le scarpe dove le suole<br />
erano lì per spalancarsi sul davanti, mostrando a mo’ di denti i chiodi che le avevano tenute insieme. Col bastone scacciava le foglie<br />
ammonticchiate al suolo, più per vezzo che per la speranza di scovare un riccio o altro. La sua persona impediva di appiccicargli un qualsiasi<br />
numero d’anni; solo poteva suggerire l’epiteto di venerando, appropriato, se mai altre volte, a quel vecchio dal nobile abbandono, e<br />
venerando fu il gesto di togliersi il cappello e tenerlo sulle mani giunte appoggiate al bastone, mentre attaccò a parlare. Come si era<br />
formato davanti agli occhi del giovane, così gli discorreva del tempo e dei rari frutti che la natura elargiva quell’autunno, dei consigli sui<br />
posti migliori per trovarne, quelli che più nessuno, oltre a lui, conosceva. Francesco non provò alcuna paura né fastidio, e stette subito ad<br />
ascoltare attonito e incuriosito l’uomo generato dal bosco, la voce dalla venatura roca che l’età aveva deposto senza offuscarne l’antica<br />
limpidezza.<br />
Poi il vecchio
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
60<br />
x<br />
Poi il vecchio lo invitò più addentro al bosco, nella sua dimora: una casupola dai muri sbrecciati che pareva spuntata da sé come filo<br />
d'erba o fungo, travi pietre e coppi tornati a essere alberi e foglie, zolle d’umido e roccia. Al tocco del padrone la porticina di legno nero,<br />
segnata per tutta la lunghezza da tante stagioni, si ritirò senza alcun rumore e li ammise a uno stanzone molto più ampio che a<br />
immaginarlo da fuori, col fondo di piastrelle indistinte dalla terra fresca, i muri inceneriti dagli inverni, la stufa decrepita all’angolo con la<br />
pignatta nera quasi a soprammobile; Francesco non avrebbe creduto che la finestrella spessa da collo di damigiana, che prima non gli aveva<br />
concesso di sbirciare attraverso, potesse dilatare di luce lo spazio annullandovi l’asse rozza inchiodata a quattro gambe malferme e le due<br />
sedie di paglia sfilacciata - una povertà pregna di bosco, che trasudava un decoro arcano. Offrì all’ospite castagne arrosto, era lecito<br />
scorgerne un bel mucchio da una porta socchiusa che dava in una specie di ripostiglio, e vinello rosso che faceva lui, aveva detto con un<br />
accenno di soddisfazione porgendogli un gotto dal vetro giallognolo; non c’erano vigne lì intorno, protestava tra sé Francesco, ma non era<br />
plausibile che qualcuno gli portasse della roba, a quel misantropo. No, la bottiglia su cui la polvere aveva fatto le incrostazioni non poteva<br />
essere che vino suo; così Francesco lo aveva ingollato senza troppi problemi e mangiava di gusto le castagne. In fondo, un po’ genio il<br />
vecchio lo era davvero.<br />
Intanto continuava a parlargli, beandosi di avere anzi tutto un ospite, di potergli trasfondere i suoi ricordi che subito si facevano storie.<br />
Non certo storie di sé, di una qualche sua vita dentro quei luoghi; la sua lingua andava a ingolfarsi in un’altra Vallemme, improbabile e vera<br />
come il poggio a vigneto che scoppia di sole nel tardo agosto, o il plocco d’argento dell’acqua sui sassi sinuosi, o il verde dilavato dei campi<br />
dopo la pioggia amorosa dell’aprile – una malia facile a tutti, chi avesse gli occhi per capirla. Il silenzio che aveva coltivato per anni doveva<br />
trovare sfogo e frutto nel retaggio di un tempo che a stringerlo scappava via dalle dita, e sarebbe valso empietà metterne in discussione i<br />
lacerti che affioravano alle sue labbra. Per Francesco erano naturali come il loro artefice, o forse dipendeva dalla casupola: nel tragitto di<br />
ritorno, chiuso nell’abitacolo dell’auto, gli era capitato di lasciar andare lo sguardo e sorridere tra sé per come i luoghi tanto usuali avessero<br />
potuto trasmutarsi nelle parole di Mastro Genio; ma seduto sulla sedia sgangherata dalla paglia loffia, davanti al vinello rosso con le<br />
castagne o un bianchetto con gli amaretti - di simili non ne aveva mai visti, faceva da sé anche quelli?, in mezzo allo stanzone umido, la<br />
pignatta piena d’acqua che traballava sulla stufa rugginosa, doveva convenire sulla serietà delle storie che uscivano dal suo vivo volto di<br />
brace: erano il passato di un uomo nato tale, senza mai avere avuto un’età. Così, dopo quel primo incontro dal quale era uscito con la testa<br />
un po’ confusa come da una forte scossa di tuono, la promessa di tornare a trovarlo non era rimasta nell’aria del bosco, ed erano seguite<br />
altre visite e altre storie, divenute per una tacita convenzione la materia del loro incontro; dopo i doni ospitali di cibo e di bevanda,<br />
naturalmente.<br />
Anche allora, mentre l’auto obbediva alle molli curve che spezzavano il rettifilo oltre il bivio per San Cristoforo, Francesco si sentiva<br />
addosso l’odore di quelle parole dalla cadenza di risacca, pregustava i saluti dopo tanto, l’accomodarsi sulla stessa sediola davanti alla<br />
bottiglia polverosa e al bicchiere giallognolo, e poi il momento che il vecchio sarebbe passato brusco a riavvolgere il filo della sua memoria<br />
diafana; e un’altra voce, un altro timbro sarebbe di nuovo sgorgato da quella bocca d’argento un po’ opaco, con la forza dell’acqua tersa<br />
che balzava di certo da una fonte, in qualche luogo del bosco, e ad ogni visita luccicava da un orcio screpolato vicino alla stufa. Gli riusciva<br />
quindi meraviglioso, della meraviglia più ingenua ascoltarlo; altrimenti come avrebbe accolto la favola dei tonni di fiume? Era la prima che<br />
aveva imparato dal suo labbro, e come prima gli era rimasta la più impressa. Mastro Genio si era scusato del suo povero desco,<br />
aggiungendo di non potergli offrire di più perché erano lontani i giorni in cui i tonni sguazzavano nel Lemme; alla faccia sbalordita del<br />
giovane precisò che esisteva un tempo una specie di tonno d’acqua dolce che trovava ricetto nel torrente, e solo in esso. Ogni pianta, ogni<br />
fiore giovane
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
61<br />
x<br />
fiore, ogni animale della valle, anche il più piccolo stelo d’erba aveva avuto all’origine un carattere suo proprio, che lo notava rispetto alle<br />
stesse specie presenti altrove; così era stato per il tonno di fiume, di cui si era estinta persino la memoria. Che cosa avesse di diverso dai<br />
cugini abitatori del mare, come fosse pescato e mangiato, Mastro Genio non diceva; nel suo ricordo i tonni mulinavano pigramente nelle<br />
anse del Lemme, per lanciarsi all’improvviso in guizzi frenetici fuor d'acqua andando a posarsi da sé, per la gioia stupita dei pescatori, sui<br />
sassi del greto o all’ombra bassa e primitiva dei lenti arbusti, e quando le piene ne sbattevano un gran numero sulle sponde dove più forte<br />
ruggiva la corrente era una festa cuocerli nelle piazze e nei cortili per propiziarsi il sereno.<br />
Ma la storia che sopra tutte Francesco amava farsi ripetere era quella del Marchese Pallino e di Santa Monalda: una storia del più buio<br />
Medioevo, quando imperava nella valle un oscuro feudatario, il marchese Guido de’ Pallini abbreviato in Pallino, che esercitava sui suoi<br />
sottoposti l’autorità concessagli dall’epoca e dal suo rango, fuor che in un punto, quello che massimamente gli sarebbe piaciuto di<br />
esercitare; perché non si sa per quale vizio di natura, o quale sortilegio, da non escludere in una tale epoca, il Marchese non poteva esigere<br />
dal suo corpo quel diritto che gli dava l’accesso alla virtù delle novelle spose. Per la verità Pallino, piccino e rotondetto come il nome<br />
suggeriva, non ricusava di chiedere al suo castello le giovani appena maritate, ma sempre le rimandava tali quali gli arrivavano. Il meschino<br />
intendimento di lucchettare il loro labbro con qualche regaluccio fallì: le immacolate mogli, in quanto mogli non tardavano a dotarsi di<br />
copiosa favella, e chi prima chi dopo divulgarono il difetto, come e perché le avesse restituite intatte al contado; e se Pallino confidava nella<br />
fama di una presunta liberalità, questa fu senz’altro presa per debolezza. Per dirla in breve, la cosa riecheggiò in tutta la valle e destò<br />
reazioni non improntate a gratitudine. L’argomento si prestava di per sé a essere oggetto di risa e motteggi, ma un signore incapace di<br />
regnare anche nell’esercizio del suo sopruso non meritava la signoria di cui era stato investito, soprattutto se non si procurava gloria nel<br />
pacifico campo di battaglia dove massimamente sarebbe dovuta rifulgere la sua virtù di nobile guerriero; quel volgo più che aduso a subire<br />
amava una tirannia assoluta su di sé, purché il tiranno infondesse la sicurezza della prepotenza. Insomma, il passo dall’irrisione alla rivolta<br />
fu breve: i villani inferociti per la mancata violazione delle loro donne presero d’assedio il castello, e quel ch’è più la truppa del Marchese<br />
fece causa comune con il volgo. I rivoltosi erano infiammati dal desiderio di avere una più degna autorità sopra le loro schiene, un vero<br />
feudatario quale era stato Pier Ugo, il padre di Pallino, additato in quel momento ad esempio di virile tirannia: lui sì che sapeva avvalersi di<br />
tutto il suo potere e andava di persona a compiere il suo diritto sulle donne, senza attendere che venissero recate a lui quando la legge<br />
degli avi lo prescriveva. Non era del tutto chiaro che cosa avrebbero fatto del Marchese; ma pare che sotto le grida di esilio, prigione e<br />
morte si insinuasse il proposito di un’esauriente lezione di virilità all’imbelle feudatario.<br />
Per la prima volta nella vita Pallino provò il vero terrore: all’improvviso solo, caduto dal suo fastigio in balia di una turba infiammata di<br />
sangue, il castello stesso pareva rovesciarglisi addosso mentre imboccava il cunicolo segreto che l’avrebbe portato in salvo, dietro lo<br />
sperone di roccia dov’era l’inutile baluardo del potere ereditario. Fuggiasco e inerme vagava per le vigne e i campi del suo feudo, che<br />
presto lasciò per tentare declivi agri e spelati, senza una meta ma il più lontano possibile da quelle furie assetate di una vittima che<br />
placasse secoli di servaggio. Corse Pallino, e corse ancora, finché verso il tramonto le forze lo condussero esausto a una gola profonda e<br />
minacciosa; in fondo un torrentello ignoto, o piuttosto un sottile rigagnolo che a tratti si allargava in pozze d’acqua. Il discendere le rocce<br />
brulle per un malagevole sentiero di sassi e terriccio calò in lui un po’ di pace, come un rifugio dal mare in una baia selvaggia ma sicura.<br />
Accolto dal fondo della gola, ormai densa delle ombre dei monti, i fremiti della paura diedero pian piano luogo alla dolcezza, istillandogli<br />
l’ansia di una preghiera; inginocchiatosi, senza nemmeno averlo deciso, giunse le mani e con parole sincere invocò Santa Monalda. Questa,<br />
continuò il vecchio di rimando ai due occhi ammutoliti di Francesco, era un’antichissima protettrice della Vallemme, dimenticata al pari<br />
deldel tonno di fiume negli anni continuò il
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
62<br />
x<br />
del tonno di fiume o degli altri animali che le facevano corona; granelli scivolati giù per la china del tempo, mentre il Lemme restava, a<br />
rosicchiare con calma vorace il suo letto. Nominò il fagiano muschiato e il furetto glabro, e anch’essi rivivevano assieme alla santa quando<br />
Mastro Genio si estraniava da lui e dalla stanza e il suo volto si incendiava per spandersi su tutta la valle, raccogliendo parole vecchissime<br />
che l’acqua e le pietre gli avevano tramandato. E Francesco, assorto dal canto, correva la discesa di Pallino verso l’alveo del torrente,<br />
sentiva nella strozza il respiro ansante del nobile che vedeva davanti a sé l’orda dei passi e delle grida assassine, si acquietava al suo ristare<br />
su un masso, di sbalzo sopra il rivo, confortato dalla piccola corrente che gorgheggiava nell’ombra, si univa alle suppliche del fuggitivo, in<br />
ginocchio verso l’azzurro luminoso del cielo che lentamente si spegneva nel crepuscolo, un velo di lacrime ritrovate sugli occhi. Pallino<br />
implorava la santa di concedergli salva la vita, ma anche di ridargli la virtù, così necessaria per la nobiltà nel corpo e nell’animo, la cui<br />
mancanza era stata la causa di tutti i suoi mali.<br />
La preghiera fu tanto ingenua che accadde il miracolo: su una roccia di rimpetto a lui, appena poco più in alto, apparve Santa Monalda.<br />
Prima fu un biancore nell’aria, poi si rivelò la molle cascata dei capelli biondi sulle spalle nude e sul petto rigoglioso, le braccia e le gambe<br />
come panna lasciate scoperte da un succinto abito bianco, stretto in vita da un balteo d’oro, il sorriso immacolato che si irradiava nella gola<br />
fugando la sera. Con gli occhi ardenti di lacrime feconde Pallino la implorò di nuovo, e già sentiva il suo corpo pizzicare di vita. Santa<br />
Monalda lo esaudì: con un gesto grazioso della mano gli indicò una pozza poco più a monte, formata da una cascatella che suonava di<br />
mirifica limpidezza e costretta su tre lati dalle pareti di roccia, sì da rassomigliare a una conca; altri, soggiunse il vecchio, raccontavano che<br />
la santa fece scaturire la pozza sull’istante con il suo sorriso, dalla roccia sotto i suoi piedi. Pieno di fervore Pallino si spogliò e vi si immerse,<br />
mentre in un alone latteo la santa scompariva così com’era venuta. L'acqua gli diede subito un nuovo vigore, che tiepidamente scorreva per<br />
le membra infondendovi una tensione da lungo non provata; pieno di forze si alzò dalla polla, si rivestì e con passo sicuro imprese la via del<br />
ritorno, fidando nell’aiuto di Santa Monalda. Il miracolo chiesto era stato dato e Pallino l’aveva scoperto, appena emerso dalla fonte, sul<br />
suo corpo madido d’acqua e di energia; non restava che testimoniarlo al popolo, per ribadire a chi spettava il comando.<br />
Come riuscì a rientrare nel suo feudo, solo e disarmato, Mastro Genio non disse: enumerò gli effetti del suo ritorno, che furono<br />
devastanti. Le bocche, annali d’allora, riferivano di un torrente secco e infido ingrossatosi per le piogge improvvise, che rovina a valle<br />
travolgendo ogni cosa e l’impeto dell’acqua non resta, ma sembra trovare alimento dalla stessa distruzione che apporta. Naturalmente non<br />
limitò il proprio diritto alle giovani spose destinate a sciogliere il cinto, ma pulzelle e maritate indistintamente lo sperimentarono, né alcuna<br />
si lamentò; corse anche fama che Pallino, nel placare il suo ardimento, volle persino fare vendetta dell’affronto subito punendo alcuni<br />
villani nella stessa maniera che adoperò con le loro donne. Notti e giorni passarono prima che la furia pugnace del Marchese trovasse<br />
requie; e intanto il popolo, chi lo direbbe?, lo stesso popolo che non capacitandosi della vacanza di un diritto secolare l’aveva dileggiato,<br />
tratto nella polvere e costretto alla fuga, ora esaltava il tiranno ritrovato, si adunava nelle strade e nelle piazze inneggiando al miracolo e<br />
all’ariete che viola la più casta fortezza, lo proclamava l’unico signore, il vero figlio del prode Pier Ugo, degno in tutto della stirpe degli avi.<br />
[…]
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
63<br />
x<br />
LA VALLEMME DENTRO<br />
Sono tornato. Lo attestano gli alberi spogli dal fiume, tra sassi e nebbia, lo canta qualche verso animale lontano, lo ripete il gomitolo<br />
grigio dell'aria sui vetri appannati, che sono qui. È ancora un poco di strada straniera, ma in breve, se non mi sfugge la memoria, mi<br />
accoglierà il suo margine disadorno e freddo e in quel punto sarà Vallemme, di nuovo Vallemme. Tutto ha termine in questo margine, e<br />
non è solo aver trovato il mio ritorno, o almeno non l'ho trovato veramente, in fondo; qui era la mira dell'errare per autostrade e tunnel,<br />
lungo alpi e laghi, qui aderivo con le dita naufraghe rapprese sul volante: all'albero spolpato dell'autunno dove vedevo rifiorire umori di<br />
nebbia, al greto di ossi per cui saltellavo indagando gli umili arbusti, alla melma che nella calura terrosa diceva il trascorrere di poca vita<br />
verdastra.<br />
Ecco il paese. Il quadrivio con la sua cappelletta, il rettifilo che lo sega e quasi non so di esserci, come non sapevo della valle, di<br />
trapassarla e viverla intanto. Il paese sembra la strada e pure c'è, le poche case abbrancate al castello o diluite nel piano davanti al fiume mi<br />
scappano, ma le rifaccio tutte mie ora, appena depongo l'auto e le cerco, una per una, nei loro anfratti. Il paese scivola sotto le mani,<br />
cavedano come la valle: anche lei non si è fatta prendere quando volevo, anche lei mi indicava la strada e il passaggio, intentata. Così l'ho<br />
dovuta stanare lentamente, e allora mi ha rivelato l'acqua che mugugnava parca ai miei piedi, il fastidio di uccelli disturbati che si<br />
rintanavano nel silenzio della sterpaglia; bisognava che la scoprissi tutta intera prima di andare, prima di cedere alla strada dove alludevano<br />
le case che avevo creduto troppo poche, toccarla pezzo per pezzo e portarne con me anche nella città dal cielo spiovente, la città delle<br />
fontane gioiello incastonate alle vie e alle piazze del centro. Il paese muore subito nel fiume, alcune case fuori del bordo ed è già la breve<br />
striscia del piano e oltre il piano è ghiaia e Lemme, vigile nell'ombra sulla presenza umana mai accolta a pieno. Si muove attento, esplora<br />
con la calma sua propria il tempo propizio, il tempo tanto sperato, quando evaderà dai sassi e tutto ridiventerà suo.<br />
La memoria mi si attorce con la coscienza gelida dell'aria che sboccia dalla valle a grigio del giorno. Poteva non essere? Ha aspettato<br />
anche troppo, voleva sapermi arrivato per spianare i suoi indizi: il parcheggio sconnesso di terra dove ho poggiato l'auto, l'insegna del<br />
telefono inusato, le salite che preludono al castello. Temevo che non mi aspettasse più, che forse non lo riconoscesse, il mio ritorno; e tutto<br />
è pieno di indizi. Di essere partito per scambiare la valle con un autocarro che tragittava cose, in bilico tra alpi e alpi. Del mattino colloso<br />
che fuggii e schernebbiava, tutte goccioline di valle che si attaccavano e mi accompagnavano anche là fuori, nel vuoto. Ottobre, novembre<br />
come ora, e come ora gocciava la Vallemme; non c'era che lei alla corriera, ad assistere che mi facevo trasportare via con gli occhi<br />
schiacciati al sedile davanti: gli altri, Cesco, Fren, i Genovesi, li avevo lasciati la sera prima tra il riso fumoso delle birre, già perduti dietro le<br />
spalle. Barcollando verso la villa, le mani incespicavano nella maniglia del cancello in cerca di una presa e tentavo un piede dopo l'altro,<br />
apparve lo sguardo nudo del ciliegio nel cielo nuvolo, a dirmi che così l'avrei salutata, la Vallemme. E invece non l'avevo oppressa in quel<br />
saluto, come forse pretendevo allora, lo intravidi al secondo o al terzo viaggio dalla Germania, sotto il Gottardo, sotto il buio della galleria<br />
infinita per cui rimordevo metro per metro il mio luogo; me lo prevenne di prepotenza il sole, forzando la curva all'uscita in discesa verso il<br />
Ticino. Del resto non valeva ricordare, se mescolavo i saluti alla memoria; ora sì, ho liberato la memoria da me o piuttosto sono divenuto io<br />
dentro di lei, io stesso memoria. È inutile andarli a trovare, Cesco e gli altri, e non certo perché saranno a un qualche lavoro, in questo<br />
mattino. Non è di loro che cerco: loro sì, sono rimasti in birreria da quella sera, dopo le sconcezze salate come lacrime e la fila a scaricare<br />
fuori, contro il muro e contro gli alberi, dopo l'addio di Fren che ridendo all'angolo della bocca mi ha stretto con forza la sinistra, a dispetto<br />
delle cartoline che ci saremmo mandati di norma, nell'illusione di sfotterci ancora alle mie sortite per le ferie; l'avrei capito dopo, che non<br />
potevo
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
64<br />
x<br />
potevo più tornare per loro, ma da loro, da come li avevo lasciati, se mai. Cesco lavora ad Alessandria, in ufficio: di lui si dice che certe<br />
domeniche di nuvole, dove l'aria stocca come in questo mattino prende su con la macchina e sale a Voltaggio, poi discende fino al confine,<br />
al ponte poco prima dell'Iride, e da lì rigira per la strada dei Fascioli. Anche a Cesco prude il paese, evidentemente; ha strappato con<br />
Claudia e da un pezzo abdica dalle vasche in giù per Novi, il sabato pomeriggio. La gente è sempre uguale, ripeteva alla mia ultima<br />
scappata, o piuttosto non sono gli stessi perché quelli della nostra età non vanno più, per la nostra età è finita con le vasche. Fren invece si<br />
è placato e non smania più per un qualsiasi altrove, i suoi nervi torrenziali hanno esaurito la piena arenandosi nel sedime della<br />
soddisfazione; si fa vedere molto meno e certe sere i buschetti del Lemme ospitano volentieri la sua macchina.<br />
Non mi è stato mai detto di Sandra: so che è impegnata, ma anche lei è rimasta alla sera delle birre, al rimprovero inciso nel luccichio<br />
sofferto degli occhi che mi studiavano e nella bocca che si conteneva dal ridere. Poi venne il saluto contro ogni attesa, la carezza delle<br />
labbra sulla guancia e il sussurro atono, ci mancherai; ma si è girata subito dagli altri, non curando la mia uscita. Ho avuto più volte l'idea,<br />
che potevo esserci e dare un seguito; e ne sono sempre rifuggito, preferendo il comodo di braccia straniere che mi facevo piacere a forza,<br />
secondo la lotta di due voglie. Così ho ottenuto Inge, scontrosamente tedesca con la sua voce baritonale non da donna, come i capelli neri<br />
sembravano negare l'origine che poi rinvenivo tutta nella lama sorridente dello sguardo e nel camminare sciatto. Forse per questo mi ha<br />
degnato: per quell'essere sospeso come lei, incerto da che parte venissi. E poi sudavo un po' di cultura, strana cosa per chi guida autocarri;<br />
mi aveva anche trascinato a teatro, qualche sera, e mi bastava. Ma ben altra è la traccia che mi ha arato sulla pelle Maria, un segno lento<br />
come un salice che solo nel tempo, verso questo ritorno, ho fatto pienamente mio. Lavorava in una Gasthof su una delle strade che mi<br />
portavano d'abitudine per la Germania. C'erano camere sempre libere ed ero certo di poter fissare lì la mia dimora per una notte, se non<br />
volevo proseguire; tanto il rendiconto avviene sempre al mattino, l'ho capito presto. Accoglieva i miei ingressi col ritegno di chi non si<br />
sbilancia anzi tutto, trattandomi uguale a ogni altro ospite del suo lavoro, come anch'io rientrassi senza meraviglia nelle probabilità che<br />
aveva circoscritto lavando e risciacquando, piatto per piatto, bicchiere per bicchiere. Mi faceva un po' di cucina italiana e senza quasi<br />
volerlo ci attardavamo a parlare, dopo la chiusura o quando i clienti erano radi. Una ritrosia primitiva annidava nei capelli corvini, nelle<br />
sopracciglia spesse e nella peluria appena accennata del mento; gli occhi di nocciola scuro amavano appuntarsi al tavolino o alle mie mani<br />
nervose che fremevano sulla tela cerata, a volte invece si aprivano ridendo di una diffidenza animale. Stupiva della mia eresia, di come un<br />
tipo con un diploma che doveva condurlo ad altri pezzi di carta avesse deciso di fare semplicemente quel mestiere.<br />
- Ma non è proprio camionista, - spiegavo. - Quelli vanno con i TIR. Io giro parecchio per le spedizioni, Milano, Zurigo, Stoccarda, ma<br />
porto solo un autocarro.<br />
In realtà mi rispondevo che stavo a mezzo anche in quello, anche nel cercare inquieto di lei, nell'osare con paura la mano, la bocca, il<br />
corpo tutto; così era stato piuttosto un lasciarsi guidare alla sua stanza, un visitare la sua pelle in un abbraccio di carne. Non chiedeva oltre<br />
se mi vedeva sazio, con la mano tra le sue gambe che all'improvviso si stringevano dolcemente a tenaglia, sancendo il contatto. Una volta<br />
non sembrava contenta e fece la prova di negarsi, di chiedere più di quanto era stato.<br />
- A che serve, se le altre sere dormo da sola?, - protestava. Ma poi rinnovò il patto e mi riammise alla sua intimità schiva, che mai avrei<br />
scelto per intera. Perché qui era la ragione di Maria e delle mie soste alla Gasthof, fuori rotta dalla solita Autobahn: era la facoltà di<br />
prendersi, lasciarsi senza pegno e ugualmente riprendersi, solo per guadagnarne un piacere proprio e farne parte, solo perché un caso ci<br />
consentiva uniti. Secondo il rito sdegnavo la camera in cui era posato il mio borsone non disfatto, poca roba, e salivo per le scale lucide, di<br />
legno pulito, fin sotto il tetto, fino al buco che le concedeva Herr Obermayer, il padrone obeso di birra e con pizzetto infido, decurtandolo<br />
dal mese;
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
65<br />
x<br />
dal mese; per questo si arrogava di ammiccarmi con sopportazione avara, se indugiavo uno Schnaps al bancone. Appena lei avvertiva i miei<br />
piedi sul legno mi apriva il buco invaso da un letto di una piazza e mezza, col lavabo eroso all'angolo libero e la finestra sulla statale che a<br />
intervalli filtrava i raggi delle auto; noi li guardavamo un po' incantati e col soffitto sui nostri corpi ci volgevamo uno nell'altro, nel letto<br />
poco per noi e troppo per lei sola, a stringere tutto quello spazio.<br />
Al mattino mi svegliavano i rumori da sotto; il letto già vuoto dalla sua parte, filavo via a togliere la roba dalla mia camera intatta, scarico<br />
da ogni cura. Certe sere si rintanava in cucina o stornava fingendo andirivieni di fretta tra i tavoli; solo all'ultimo concedeva a sedersi, con<br />
domande scarne e distratte sulla mia casa laggiù e sul lavoro. Allora davo le risposte che voleva e senza salire in camera recuperavo la<br />
notte, la mia strada. Tanto ci saremmo ripresi, in qualche altra volta. Anche Maria se lo faceva bastare, penso, e dev'esserle bastato da che<br />
non mi ha più visto; era nel conto di ogni mattino, lo sapeva. Lo stesso conto che avrei chiesto a Sandra, alla Vallemme: passare un'altra<br />
volta e ritrovarla, senza che nulla fosse stato intanto. Come qui non è stato che la nebbia, che il divorare alberi e fiume e infondersi goccia a<br />
goccia nelle ossa, con il suo silenzio. Non serve nascondere le mani nei guanti, nelle tasche, mi ha vinto dappertutto e devo camminare per<br />
conciliarla e respirarla, che sia fiato della valle questo che mando dalle labbra semichiuse.<br />
I passi mi portano al fiume, necessariamente. Devo scovarlo, è nascosto da qualche parte nella nebbia fatta cielo, nella nebbia appresa al<br />
corpo che mi spinge verso di lui, verso il mio ritorno. Ho imboccato la discesa del ponte e costeggio i cortili che danno sull'asfalto. Un cane<br />
mi si abbriva contro da una cancellata senza colore, accenna un abbaio e subito rientra che sono già via; da una pila di piastrelle, al riparo<br />
del portico, un gatto solleva con indolenza la testa e la sprofonda di nuovo nel suo pelo. È la casa del matto, perché ci dev'essere un matto<br />
per ogni luogo; è caduto per sorte in questa casa, il figlio eletto a intrecciare parole sue con l'aria, a non essere degli altri e vivere del fiume,<br />
lontano. Ci vuole della follia, per stare a rive d'acqua e gesticolare sassi al cielo, e anch'io rabbrividivo a incontrarlo sui blocchi di cemento<br />
dell'argine, o se mi appariva dalla strada del ponte disegnando un cammino sghembo, quasi a mezzo cerchio, con la gamba sinistra: ridere a<br />
sé, i sassi regalati alla melma giungevano troppo addentro alle cose del Lemme.<br />
Terminate le case i campi si allargano dai due lati mostrando chiazze di verde ingravidato del grigio che ha ridotto la valle al suo<br />
sconfinato dominio. Un rumore noioso si fa largo nella nebbia: è Loretta col suo motorino, coperta fino agli occhi in una sciarpa. Mi dedica<br />
un'occhiata insipida mentre il motorino strema di giri alla salitella e fugge via senza riconoscermi. L'ho saputo una sola volta da Fren, tempo<br />
dopo, in birreria: lei aveva sì e no quindici anni, io ero andato via da pochi mesi. Un sorpasso isterico, la macchina di quel balordo contro la<br />
barriera del ponte che l'aveva ributtata in strada e Loretta era volata fuori dal finestrino, atterrando sull'erba accanto al Lemme. Ne uscì<br />
con le due gambe rotte, e ci vollero parecchi mesi perché le usasse di nuovo come prima; Fren diceva che a farci caso le si notava un passo<br />
appena strascicato, il segno del prodigio. Il fiume, benigno, l'aveva salvata. Magari l'avrà imparato, magari nella valle di questo mattino; o<br />
penserà soltanto che se l'è cavata bene e imprecherà al tempo cattivo, ancora ignara dell'errore, del fondo di ogni errore, mio e suo<br />
comune.<br />
Devio repentino per i campi alla mia sinistra e scendo al fiume, che ormai è chiaro, mi ha atteso con la sua pazienza ristoratrice. L'erba<br />
molliccia scivola sotto i piedi e quasi corro al nostro incontro; un verso di uccello risuona salutare da qualche parte nella nebbia. Ecco, sono<br />
arrivato. È questa la mia Vallemme, la Vallemme dell'acqua che tenta un letto tra le pietre, dei pochi stecchi di alberi decisi a esistere in<br />
questo lembo che non è fiume né terra, delle stradine ingombre da tronchi che orlano il corso in lotta con l'autunno; non le case addosso a<br />
una strada che è subito oltre, quell'oltre cui sono partito credendo di non avere più luogo e non sapevo che il mio luogo restava, al di là di<br />
ogni alpe e di ogni autostrada, e non era l'irritarsi di nostalgia per i marciapiedi di piombo, tedeschi, non era la Gasthof con la stanza<br />
asempre libera
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
66<br />
x<br />
sempre libera a metà dei miei viaggi e Maria che la riempiva per un momento. Qui è veramente ordine, dopo essermi illuso della forma<br />
d'ordine che mi soffocava nella città gioiello, nell'incastro dei palazzi dentro piazze fontane e ciottoli, illuso del verde atra bile dei boschi<br />
puliti quando a giorni mi facevo schiacciare dal desiderio di perdermi; ordine è il poco impasto di acqua e terra e pietra e ancora acqua,<br />
latità indivisa prima d'ogni forma, che non si può ordinare. Ora comprendo questa coltre di nebbia, che cos'è l'adagiarsi in lei. Ora sono<br />
dentro la valle e la inghiotto a pieni sorsi e mi devo fermare sull'argine, tanta l'aria che mi ubriaca il petto, tanta la scossa che mi investe<br />
da ogni parte e mi butta a sedere sui pietroni, stremato dalla gioia paurosa della vertigine, bagnato del freddo di fiume che mi ha fatto<br />
albero, sasso, gemma di nebbia. L'ho respirata dentro e mi sono bagnato di lei nelle ossa, sotto i vestiti, nelle mani che ho levate dalle<br />
tasche inutili; le palme si distendono non sazie a prendere ancora di questo mattino, a sorbirlo tutto nelle sue punture d'umido, di vita<br />
che urge. Mi si fa manifesto il fine degli autunni che andavo al fiume per i campi e mi perdevo nei vapori del suo corso, e dei pomeriggi<br />
nell'anno appena nuovo, quando pregavo un sole tardo che arridesse alle reliquie del giorno; allora dovevo fare premura alle ginocchia, e<br />
seguitare i passi fino a scoppiare di freddo e di nebbia, fino a un gelso, un salice dove potessi aggrapparmi e nell'abbraccio sentirla<br />
veramente dentro, la Vallemme dentro. Fossi dall'altra riva come quell'airone, nato dall'aria con un grido roco e un volo superiore al<br />
fastidio dell'uomo; invece devo risalire al ponte, e mirare grado a grado l'eternità dell'acqua nella muta del suo alveo. In breve i campi<br />
geleranno, in breve sarà il tempo d'abbandono ma l'acqua resterà intatta là sotto, serberà la vita dagli ultimi rigurgiti fangosi di<br />
novembre. Accade qui, in questa sottile ferita di elementi primi che genera la valle; lo ripeteva quello strano amico di Fren, che tutto<br />
accade presso i fiumi, dove nessuno passa e il tempo stesso è un'ansa pigra. E presso il fiume mi è accaduto di essere, lento, inesorabile<br />
tremore di essere finalmente qui, nella striscia che con eterna fatica si apre la via tra i sassi e la fanghiglia. Ora non è più storia: la<br />
partenza e il ritorno, la stanza alla Gasthof, la donna presa qua e là per non ricordare, non ha più storia, nulla.<br />
Non mi resta che svoltare lo sterrato che dà all'altra riva, la riva che più volevo di amore. Controcorrente, a passi melmosi, guadagno<br />
l'altro ponte, confluenza di stradine perdute tra gli sterpi e il fango di questo mattino senza termine. Un'ombra si addensa verso di me.<br />
Ha la faccia impeciata del suo cappottone nero e cavalca il suo arrosto di bicicletta, ma non mi si cela: Beppe Turchino sta imboccando il<br />
ponte verso il paese, come ho visto da sempre. Appesa al manubrio sta la vetusta borsa di pelle catrame, coi manici rosi sul punto di<br />
saltare e il bottiglione di vino sporgente, il vino che fa lui allungandolo del Lemme, tramandano in paese. Tempo addietro doveva<br />
propinarlo ai Genovesi, che tanto quelli bevono di tutto, poi la voce si era sparsa e ne vendeva più di rado, e a poco; forse ci si è<br />
impuntato e ormai gli preme solo di ricantare che è la sua uva e che è tutta invidia, si sa nei paesi come sono fatti. Ma il vino annacquato<br />
senz’arte non basta a giustificarlo delinquente; troppo impegnativo l'epiteto che gli hanno inflitto, e l'uomo che caracolla i suoi<br />
settant'anni sulla bicicletta di ruggine lo porta piuttosto male.<br />
- Ehilà, buongiorno! Siamo tornati, eh? Siamo venuti a farci una passeggiatina, per rivedere i luoghi?<br />
Non ho neanche da rispondergli, se non mezze parole di stento; l'uomo e la bicicletta sono già saliti traballando su per il ponte. Beppe<br />
Turchino è stato il primo a venirmi incontro e non ha mostrato meraviglia, solo la naturale ironia di chi ha inteso che cos'è, ritornare<br />
presso la propria ansa pigra. Lo guardo ancora un po' di spalle prima che scompaia nella nebbia, nel fiume.
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
67<br />
x<br />
UNO SQUARCIO NEL CIELO<br />
Non c’era di vento, eppure un'aria maligna trovava ogni varco traverso gli abiti per attaccarsi alla pelle. Il cielo violaceo scendeva sul<br />
mare con la sua calma di piombo, e nel mezzo il traghetto filava sicuro, rinchiuso in un’enorme gabbia senza sbarre dove l’immenso livore<br />
del vuoto si era disteso a cancellare il segno di ogni terra: anche lì, sulla vernice lattiginosa del ponte, saliva col freddo a prendersi, senza<br />
premura, quell’ultimo puntino di bianco che andava nel nulla. Ma proprio in un tratto sgombro vicino alla poppa gli occhi puntavano ciò che<br />
mi teneva sdraiato spalle all’acqua, sul fascio di corde che aveva il taglio stesso dell'aria, perché non scorgessi dentro tanto nulla il principio<br />
del disegno che prendeva forma sul ponte: lenta, poco più in là dei miei piedi avvampava una macchia, all’inizio vaga, come una finta, un<br />
fantasma nato da qualche pensiero, ma poi si allargava più netta e ritagliava i propri contorni nel bianco di nave impastato del mare, fino a<br />
spiccare d’un arancio scialbo, ma vivo in quel correre verso chi sa quale porto. E insieme l’impulso del gesto, la tentazione di alzarsi dal<br />
cordame e torcere il capo verso lo squarcio di luce che doveva esistere dentro tutto quel cielo, da qualche parte dietro di me.<br />
- Lo sai che non devi guardare.<br />
La voce di Georghios mi colse nel fallo, mi forzava a buttare di nuovo gli occhi oltre i miei piedi, al riflesso di quella luce che non sapevo<br />
mirare all’origine. Ero impedito dalle sue parole e non osavo alzarmi dalle corde un tempo bisunte. Me l’ero trovato vicino, intanto che<br />
godevo di bermi il freddo del ponte; non c’era sospetto di altro, all’infuori del taglio uniforme che muoveva tutti quei giorni da una<br />
partenza poco reale, quando mi ero sdraiato spalle al cielo e avevo chiuso gli occhi al livore. Un suono leggero sul legno alla mia sinistra e li<br />
avevo riaperti: Georghios mi stava fissando e aveva iniziato a lanciarmi mozziconi di frasi.<br />
Mi sporsi, di poco, verso di lui. La faccia lasciava intendere una giovane età già scavata dal sale. Anni, ormai, di traghetti e di onde<br />
avevano inciso la pelle abbronzata, gli occhi smorti e i capelli avevano preso il colore della spuma. Teneva anche lui lo sguardo in avanti, le<br />
dita ingiallite di fumo si intrecciavano attorno alle gambe. Aveva detto poche parole, quanto bastava. Le ultime erano state solo un<br />
richiamo, un monito per non dire ancora.<br />
- Però hai lasciato sospesa quella storia, - cercai di riprendere. - La storia di Haghios. C’entrava con la luce dietro di noi, vero?<br />
Georghios provò a sorridere, ma era un sorriso di sale come il suo corpo.<br />
- Ti ho detto di non guardare. Non c’è bisogno di altro. Contentati del suo riflesso: è bello, in quest’acqua e in questo cielo di nuvole, di<br />
uguale acqua. Ma forse il suo bello sta nell’essere solo un riflesso, che ha perso di vita e di forza dalla luce vera. Quella sarebbe troppo per<br />
te, e ti porterebbe via.<br />
Nonostante tutto Georghios era tentato di dire, ma sperava che io mi facessi bastare quel poco; le sue pretendevano di essere parole<br />
scarne come la debole copia di luce discesa sul ponte, da contemplare senza paura. Seguendola avevo lentamente osservato che non era<br />
ferma, danzava ora più larga, ora più stretta per sfuggire a una presa, ma non voleva andarsene via. O non era piuttosto la sua danza un<br />
gioco, un invito a voltarsi, a congiungersi alla luce più vera? Mi tirai un po’ su con la schiena.<br />
- Ora mi alzo, e la guardo.<br />
- Io non ho conosciuto Haghios. È una storia trasmessa dal mare.<br />
Georghios mi aveva afferrato il braccio e la sua voce si stava sciogliendo. Anche il suo alito odorava di sale asciugato dal tempo.<br />
- È la prima storia che ho appreso quando mi sono imbarcato qui. Me l’ha raccontata Oscar, il cuoco. Ero andato in cucina a prendere un<br />
po’ di colazione e lui, come fosse la cosa più naturale, esordisce: “Te l’hanno detto della luce d’arancio nel cielo? Lo sai che non devi mai<br />
guardarla?”
Da La Vallemme dentro, 2000<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
68<br />
x<br />
guardarla?” Poi ha sghignazzato del mio silenzio. “Possibile che non ti abbiano detto di Haghios?” Allora ha tratto un sospiro, e senza più<br />
ridere me l’ha insegnata lui, con pazienza. Anche Haghios era marinaio, su un traghetto che tentava una rotta uguale a tutte le altre.<br />
Nessuno sa di preciso dove è successo, né quando, né su quale nave; potrebbe essere anche su questa, ma non importa saperlo. Haghios,<br />
come me e come te, come tutti, era stato avvertito del pericolo: in questi giorni, quando tutto d’intorno è un colore di viola e di cenere che<br />
non lascia confini e ti sembra di navigarvi sospeso, può accadere che in un attimo, in un angolo nel fondo del cielo, si squarci, e appaia un<br />
chiarore, prima ancora confuso di cenere, poi sempre più netto. Un chiarore d’arancio, una macchia che muta continui i contorni per<br />
assumere le forme più varie: un cerchio, una striscia lunga e sottile come una ferita del cielo che sanguina. Non dà calore e non rischiara,<br />
capisci subito che non è il sole e non ha la vita, o forse reca altra luce e altra vita. Quel chiarore non lo devi guardare: spicca troppo diverso<br />
dal viola e se lo guardi ti affascina, troppo ti affascina e ti attira a sé; e allora non puoi distrarre gli occhi, puoi guardare solo là e devi<br />
guardare là, finché i sensi non si placano e tu ti stacchi da terra, e voli a quel chiarore. Così successe ad Haghios: stava salendo, per un<br />
qualunque motivo, su per una scaletta esterna della sua nave, che in un giorno come questo trascorreva senza fine l’irosa mescolanza<br />
concessa dal cielo. All’improvviso si bloccò, come fulminato dal disegno più chiaro che aveva colpito il fianco della nave, poco sopra di lui. E<br />
si voltò a guardare. Un angolo dell’orizzonte si era aperto per fare posto alla luce che cresceva pian piano, fin quasi a parere l’incendio del<br />
sole al tramonto, o la tinta indecisa che fora le nuvole della burrasca. Haghios sapeva di certo la storia; non di meno guardò alla luce e restò<br />
lì impietrito, sulla scaletta, col viso che trascolorava beato mentre lo squarcio gli batteva sul corpo, avvinghiandolo tutto. Un marinaio, di<br />
sopra, se ne avvide, e dalla bocca coperta col braccio uscì un grido rauco: “Haghios, non farlo! Ascoltami, Haghios! Voltati, fin che sei in<br />
tempo!” Ma Haghios non era più a tempo e non lo sentiva, continuava a sorridere alla luce che era divenuta il suo stesso corpo d’arancio;<br />
poi le sue mani e i suoi piedi lasciarono la presa di ferro della scaletta. Subito diede l’idea di cadere, ma in breve fu manifesto che si levava<br />
nel vuoto, anzi volava, volava trascinato alla luce senza un grido, né un lamento; nell’aria fu udito soltanto un suono leggero, come una<br />
cantilena monotona che subito si perse lontana. Così almeno parve a quelli dell’equipaggio che accorsero, con ogni cautela, alle grida del<br />
compagno sul ponte. Comunque Haghios non fu più visto e tutti si dissero che era inevitabile, chi guarda alla luce non può che finire verso<br />
di essa.<br />
Faceva ormai troppo freddo per stare fuori. Era stata una storia del mare, nient’altro che un deposito amaro sulla bocca di uomini senza<br />
più scogli, e l’alone d'arancio che trasformava i suoi contorni davanti a me non scaldava; era sempre meno distinto ora, come se la fonte si<br />
fosse stancata di mandare giù la sua forza. Le parole di Georghios non potevano più legarmi sdraiato al cordame.<br />
- Ho freddo. Vado sotto coperta a leggere qualcosa.<br />
Mi alzai senza indugio, badando bene a tenere lo sguardo in avanti. Non concessi più neanche un’occhiata alla luce bastarda sul ponte.<br />
Georghios non mi rispose e restò con le mani intrecciate attorno alle gambe; la testa sprofondò tra le ginocchia e i suoi pensieri ripresero a<br />
correre sentieri perduti di sale. Feci pochi passi sicuri verso la porta che conduceva sotto coperta. Prima della soglia diedi un guizzo<br />
all’indietro e la rubai, quel tanto da poter intuire lo strappo là in fondo, nel regno di cenere e viola dove acqua e cielo si erano uniti in<br />
eterno: una ferita stretta e lunga che si spandeva in un cerchio simile a un’arancia sanguigna, e già da una parte riguadagnava spazio il<br />
livore.
Su La Vallemme dentro<br />
[…] Ciò che dobbiamo ammirare è il potere di comprensione e d’articolazione dell’iter diegetico che fonda l’argomento e lo colora. Il tessuto<br />
è intrecciato, nella maggioranza dei casi, di radi dialoghi interni al flusso narrativo […] con rapide vette di colloqui in atto. La parola si fa cioè in<br />
breve aura e non importa ceda a ritagli di memoria o a lacerti di leggenda. Il fascino è attivato dal meraviglioso, si vincola al fantastico, si insedia<br />
e cresce nella tipologia edenica: sono aree di un viaggio mentale ed emozionale intese al traguardo dell’innocente comunione. Nel luogo<br />
dell’apertura, ove è ospite l’intreccio, parlano nomi che sono ricamati tra storia e lingua, tra geografia e linguaggio, tra vita e letteratura. E i<br />
nomi informano un movimento continuo della frase. La stringa è mossa da guizzi adiectivali e verbali, in esercizio di sguardo, in purezza<br />
oggettuale. Tra termini culti e scelti, raffinato lessico, bizzarro conio, mentre l’universo sobriamente panico si ritira in adiacenza alla liricità<br />
quieta della prosa, risale dal fondo il senso della pace che embrica testo e autore. […]<br />
Alberto Cappi, Civiltà della parola (nota introduttiva a La Vallemme dentro).<br />
* * *<br />
Una valle è certamente un luogo, una via, piuttosto, che assieme al lento “sciogliersi” di un fiume unisce inconsapevolmente un principio ed<br />
una fine; un varco che attorno al perpetuo moto dell’acqua crea, senza sosta, consapevolezza ed improvviso oblio di sé.<br />
Nell’ultima raccolta di racconti di Gianni Caccia, la valle protagonista del suo narrare, la Vallemme, è anche e soprattutto una scena, un<br />
contenitore dai limiti dilatati intorno al quale gli avvenimenti si compiono e lontano dal quale, oggi come in passato, gli uomini vivono dentro<br />
un tempo che sfugge, correndo veloce (…tutto accade presso i fiumi, dove nessuno passa e il tempo stesso è un’ansa pigra.).<br />
La vita che lambisce il corso del Lemme ci è mostrata dall’autore come in bilico tra realtà e fiaba, tra personaggi narrati e narranti (su tutti,<br />
quelli del racconto I RICORDI DEL VECCHIO VALLEMMANO) che tracciano un sottile confine a dividere leggenda e quotidianità e che proprio su questo<br />
confine costruiscono come una misura di sogno che è dolce catarsi del vero. Se da un lato sono i personaggi ad essere protagonisti - così come<br />
si è appena detto - dall’altro sono il paesaggio e la natura a collocare il libro di Caccia dentro una dimensione di “vita senza uomini” che lascia<br />
flebilmente trasparire l’istinto di fuga dal contesto della società civile di oggi e dalle costrizioni che questa impone nei rapporti tra le persone<br />
(…non potevo più tornare per loro, ma da loro, da come li avevo lasciati, se mai... la facoltà di prendersi, lasciarsi senza pegno e ugualmente<br />
riprendersi, solo per guadagnarne un piacere proprio e farne parte…).<br />
Il testo LA PIENA, che chiude la prima parte del volume, dà il là - con l’immagine del fiume che si sta ripigliando tutto, violentemente - al<br />
secondo gruppo di racconti, al “momento” finale dell’opera. A partire da IL TESTAMENTO ed attraverso gli ultimi tre scritti, l’autore disegna un<br />
mondo sull’orlo del degrado ambientale (la minaccia dell’Oxygenia), un “universo” nel quale i protagonisti sono assaliti da paure (in L’USCITA) ed<br />
i sogni o i miti narrati sono inspiegabili, quasi principi di incubi (in UNO SQUARCIO NEL CIELO). In questo contesto si vive di una precarietà che incalza<br />
e di una natura che lentamente lascia spazio ad ambientazioni sfumate. Qui gli uomini sembrano sopravvivere ai margini dell’oblio (…uomini di<br />
nessuna città…), appaiono impotenti, desiderosi di solitudine (…quando ogni più piccola traccia dell’esterno sarà sfumata nella tenebra ed essa<br />
potrà essere mia, solo per sempre mia, nel mio cantuccio) e miseramente impegnati nella ricerca di colpevoli e di colpe che forse non esistono<br />
(in UOMINI DELLE RADURE).<br />
LA VALLEMME DENTRO è una raccolta di racconti in cui i principali registri narrativi - paesaggio e personaggi, differentemente concepiti nelle<br />
due parti del libro - sono come attratti dalle aree in cui gli stessi sono continuamente posti in sovrapposizione; sono come sospesi nel vuoto,<br />
galleggianti in quell’alone come di dormi-veglia, dove il tempo che trascorre sembra dover ancora giungere.<br />
Il risultato al quale l’autore approda è quello di un equilibrio mirabile, di una combinazione sapiente di atmosfere e contenuti che consente<br />
al lettore di avvicinarsi all’opera con cresce rapimo.<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
69
Su La Vallemme dentro<br />
al lettore di avvicinarsi all’opera con crescente rapimento.<br />
Danilo Mandolini, “Vico Acitillo - Poetry Wave”, 2001<br />
* * *<br />
[…]<br />
Senza specificamente voler parlare del volume di Caccia intitolato La Vallemme dentro, raccolta organica di racconti pubblicati presso le<br />
Edizioni Joker, o di altri racconti in particolare, vorrei fare qualche considerazione generale, ricavata più che altro da alcune prove narrative che<br />
mi hanno segnatamente coinvolto.<br />
Colpisce, già ad una prima lettura per così dire non “contenutistica”, il linguaggio. Un linguaggio ricco, complessivamente alto ma che sa<br />
piegarsi alle inflessioni più quotidiane e proprie del linguaggio parlato a seconda delle circostanze e situazioni, segnatamente nei dialoghi, dove<br />
si rinvengono frequentemente anche espressioni gergali; quindi un linguaggio – parlo non solo dell’aspetto lessicale, ma anche ad esempio di<br />
quello sintattico – che riflette una profonda padronanza e conoscenza della lingua ma che non è mai fine a sé stesso o ostentato in modo<br />
compiaciuto. Inoltre, una cosa che mi ha particolarmente colpito nello stile è il procedere nervoso, non di rado reso con un procedimento di<br />
variatio e brachilogico, cioè tendente alla brevità. Tutti procedimenti, sempre, funzionali come anzidetto al contenuto, all’esposizione e alle<br />
inflessioni di esso.<br />
Riguardo, appunto, al contenuto, mi pare che uno dei temi senza dubbio più importanti sia la giustizia. Emerge in molti racconti, infatti,<br />
un’ansia di giustizia e nello stesso tempo pare che ci si chieda se questa sia possibile a livello umano. La giustizia sembra anche guidata talora da<br />
un Fato (e si rammenti l’importanza del Fato nella concezione della civiltà greca, così cara a Caccia). Un Fato, dicevo, imperscrutabile e<br />
ineluttabile; e comunque, leggendo i racconti di Caccia, sembra che tra le righe sia continuamente sospesa una domanda, e cioè se ciò che è<br />
accaduto (specialmente ciò che di tragico e irrimediabile è accaduto) sia un caso oppure sia stato guidato da un destino che sta dietro le quinte,<br />
come un libro già tutto scritto di cui occorresse solo, nel tempo, sfogliare le pagine. La riflessione dell’autore tiene presente la natura<br />
dell’uomo, che è guardato con occhio disincantato. È un disincanto che porta ad uno sguardo oggettivo sulle cose, sugli eventi. L’uomo, pensa<br />
l’autore, è quel che è.<br />
Ma dietro questo sguardo oggettivo e questo disincanto stanno un uomo, un autore che non vogliono giudicare, perché – sembra dire<br />
l’autore – sarebbe troppo comodo; che guardano, scrutano nei recessi dell’animo umano per coglierne le più profonde motivazioni,<br />
giustificazioni o attenuanti, tutte cose che si possono solo incontrare nello spazio della coscienza individuale, umana, al fondo della quale è una<br />
radicata, inestirpabile – perché ad essa connaturata – dignitosissima ricerca etica. Ricerca etica, tra l’altro, che costituisce la cifra, così come di<br />
ogni autore degno di questo nome, anche di Gianni Caccia. […]<br />
Giovanni Giudice, da una presentazione pubblica, Imperia, 2004<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
70
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
71<br />
x<br />
ALBANESI TUTTI APPESI<br />
Ho sempre odiato i comunisti. Forse perché sono cresciuto tra loro, perché li ho visti sempre padroneggiare in municipio, perché un mio<br />
vicino di casa, untuoso con i miei e bavoso con mia sorella, era comunista e pontificava sul malgoverno o che ne sapevo io allora, o per<br />
quell’aria che hanno di credersi i soli onesti, i censori; fatto sta che li ho sempre odiati, che mi sono sempre detto e ridetto che se c’era<br />
gente da odiare quelli erano loro, che facevano le porcherie peggio degli altri, almeno gli altri avevano il coraggio di manifestarle mentre<br />
loro no, facevano tutto di nascosto e poi apparivano come se avessero l’anima netta, loro, che sotto sotto in Russia ne avevano ammazzati<br />
più loro di Hitler. Cerco di dirmelo anche ora, ora che ho il fiato che mi scoppia e devo ansare la mia disperazione col rischio che la sentano,<br />
non ce la faccio più a correre, a respirare e mi appoggio a questo muro, l’odore del muro, il tanfo della strada mi è dentro, mi è dentro<br />
questa sera che piomba nella notte in un urlo, buio e ombre più buie del buio che ormai non spero di uscirne; mi aggrappo a un punto del<br />
marciapiede, a quella cicca, a quella lattina schiacciata perché non mi giri la testa, la nausea non vinca, devo ripigliare il mio fiato e correre,<br />
non posso fermarmi ora che ho fatto, mi arrivano i loro passi, ecco le loro voci, no, è qualcuno che è sceso da una macchina, saluta e la<br />
macchina riparte prima che abbia pensato che dovevo fermarla, che poteva essere salvezza, ma fermarla a cosa dopo che ho fatto, i passi<br />
pesanti sono di una zoccola, sta attraversando la strada con i suoi stivaloni neri e la minigonna di pelle, torna da un cliente e nemmeno<br />
m’ha visto, altro che salvezza; loro non si fanno sentire, sono appeso a quest’angolo e loro già alle mie spalle. Devo ripetermelo con forza<br />
ora, che li ho sempre odiati; è per loro che ho fatto, anche questi qui erano comunisti.<br />
La pena migliore per i comunisti è il comunismo, Vlady rideva della mia uscita, compiaciuto che riflettesse così bene l’idea che era in lui,<br />
di lui; eravamo alla terza birra nella sua cantina, mentre sentivamo Back in black da un mangiacassette ch’era più solo fruscio, alla terza<br />
birra cominciavano i discorsi seri e allora godevamo a rafforzarci la nostra idea. Andassero in Russia a vedere come li trattavano i compagni,<br />
confermava Vlady, loro che cianciavano tanto dei lavoratori e l’avevano su col capitalismo e l’America e balle varie, quello sì che è un paese<br />
libero, s’infuocava Vlady sputacchiando birra cattiva, non sono mica molli come da noi coi delinquenti, là sanno come trattarli, là vanno per<br />
le spicce e per i delinquenti c’è la sedia elettrica, mica come da noi che tirano in lungo i processi per ingrassare avvocati e giudici e trovano<br />
sempre i cavilli per assolverli o mandarli subito fuori; l’America è un paese civile, la pena di morte è civiltà contro il crimine.<br />
A Vladimiro pesava il nome, da che aveva saputo che era di quello della rivoluzione russa, per la verità una delle poche cose che sapeva.<br />
Doveva aver speso tutta la vita a rimuovere quel nome che odorava d’odio, di nemico, era il riscatto dai suoi che l’avevano abbandonato<br />
con quel fardello addosso, il padre chi sa dove con qualcuna delle sue amichette, la madre che fattasene ragione aveva preso a badare a sé,<br />
canaste e bridge con le amiche e qualche avara beneficenza, a considerare il figlio come l’escrescenza ereditata dal marito; tanto il figlio<br />
era cresciuto, il diplomino pur con qualche anno di ritardo l’aveva preso e un lavoretto l’aveva rimediato, così lei poteva coronare il lento<br />
grigiore che l’accompagnava verso la pensione con qualche gita delle pentole o al più qualche viaggetto organizzato, Provenza, Costiera<br />
amalfitana o giù di lì. Con un nome del genere non poteva che essere nemico dei comunisti, Vlady raggiava quel pomeriggio gridandomi<br />
nelle orecchie che aveva fatto la scoperta, il suo nome era anche del conte Dracula, uno che aveva anche combattuto contro certi invasori, i<br />
comunisti di quel tempo; e lui si sentiva un uomo della notte, voleva affondare i denti nel collo dei comunisti, bisognerà cominciare a farlo<br />
prima o poi, proclamava come un ossesso quel giorno. Ma ora Vlady non c’è, ora sono solo, solo di fronte a loro che arriveranno, tra poco<br />
vedrò le loro ombre piombare sui marciapiedi, o arriveranno prima delle loro ombre, da dove meno me li aspetto, comunisti arriveranno.<br />
Vlady mi ha lasciato, li ha affondati nel collo a me i denti, sono segnato e mi riconosceranno, e saranno altri denti, altri morsi finché ci sarà<br />
fiato e sangue
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
72<br />
x<br />
fiato e sangue; ma mi devo ripetere che è stato per la causa, che non ho sbagliato, anche questi qui lo erano, tutti comunisti, se era gente<br />
che odiavo dovevano essere dei loro, non si chiamano così ma è lo stesso, quando il comunismo è finito si sono nascosti e ora riescono con<br />
altri nomi, me lo devo ripetere a forza, che sono sempre loro e ho fatto bene.<br />
O forse quella dei comunisti è una fantasia, me lo sono chiesto in questi ultimi tempi che loro non sono più vivi come prima, che stanno<br />
nascosti e si camuffano, forse nella realtà non esistono e li ho creati io; perché c’è bisogno di odiare, c’è bisogno di crearsi un nemico cui<br />
addebitare le proprie sconfitte, e io ne ho tante, il mio fardello è lungo, non solo un nome sbagliato, c’è bisogno di ridurre a una sola cosa,<br />
il male di tutto. E loro riassumono tutto quanto c’è di male, quanto mi è contro e mi fa schifo: i delinquenti che lo stato non è buono a<br />
togliere di mezzo, i tossici e i froci che ci hanno portato le loro malattie, e infine gli invasori, prima sono venuti su i meridionali con la loro<br />
mafia, che appena sento l’accento meridionale ho subito voglia di fare macello, negli uffici sono tutti di loro, ora invece abbiamo accolto<br />
questi qui, questa gente lurida che viene a rubarci spazio e lavoro; tutti comunisti. Una volta ho gridato comunista anche a uno che mi ha<br />
tagliato la strada col rosso, non mi veniva niente di peggio. Ma comunista o altro nome non fa differenza, certe fantasie sono pericolose, e<br />
io ho preferito accantonarle; Vlady poi non voleva sentirne parlare, s’imbufaliva se uno tentava il dubbio che forse il male di tutto non era<br />
solo comunismo. È meglio mettere da parte il dubbio, si sta meglio con la certezza d’avere qualcosa contro, che quel qualcosa ha la sua<br />
identità, un nome.<br />
Questo mi dà forza, erano i miei nemici e io ero nel giusto; perché ho paura, non me lo sono ancora confessato ma ho paura, non c’è<br />
Vlady né gli altri, non l’avevo valutato così bene nell’entusiasmo di fare finalmente, io solo, la pistola l’ho buttata chi sa più dove nella foga,<br />
dev’essere stato subito dopo, quando sono corso via alla cieca, non c’erano più strade, solo spazio da divorare, da metterne più che potevo<br />
tra me e loro, tra me e quello che ho fatto; finché lo stomaco mi è salito in gola, il fiato è stato un rantolio da moribondo, e io mi sono<br />
fermato dietro questo muro sconosciuto a rifiatare, ad aspettare che arrivino nel buio, mi sta prendendo la paura, la paura è il tanfo<br />
irrimediabile del muro, del piscio di un cane, dell’asfalto, la cicca e la lattina appiattita al suolo. Così devo darmi forza, ho fatto per me, per<br />
la causa, anche se poi qualcosa non ha retto e sono fuggito da me stesso, alla cieca, erano loro o altri come loro, devo crederlo.<br />
Ma non è più così facile odiare i comunisti, almeno come li ho odiati io: tutto si è complicato in questi anni, a prima vista sembrerebbe il<br />
contrario, ora che hanno fallito e si possono dire per bene i loro crimini, altro che la favola dei campi di concentramento; e poi non è più il<br />
tempo beato che si poteva essere niente, starsene rintanati nel proprio partitino e fregarsene del resto, ora o di qui o di là, finalmente si ha<br />
il coraggio di dirsi anticomunisti mentre prima era quasi bestemmia, ti davano subito del fascio, del nazi con quell’aria di sinistra che ti<br />
s’infiltrava dappertutto e dovevi stare attento a non assorbirli anche senza volerlo, i germi della mala pianta. Per questo che ho preso a<br />
odiarli anche se non sono mai stato di destra, non è cosa per me la politica, le sottigliezze, io odiavo i comunisti e basta, senza altre<br />
etichette. Ma ora che la mala pianta ha smesso di attecchire non è più così semplice, c’è meno gusto a odiarli come li odiavo io, troppo<br />
facile dare addosso ora, bisognava odiarli prima, come la rimpiango quell’aria, quando i compagni guastavano la città e pretendevano di<br />
passare per gli unici puri perché stavano altri al governo, quando s’inlordavano dell’opulenza dell’occidente anziché andare in Cina o in<br />
Russia, nel loro paradiso, e anche se non stavano al governo partecipavano pure loro al banchetto; allora sì che c’era il gusto di stare<br />
contro, allora bisognava avere il coraggio che ho avuto io, non come certa gente che la sinistra era tutto e ora non sa più neanche cos’è.<br />
Fortuna che sono arrivati altri in soccorso, se no restavo senza nemico per le mani. Altri come loro, o gli stessi sotto altro nome e altre<br />
spoglie; sempre loro. Prima sono stati i marocchini, ma non è la stessa cosa, sporchi e accattoni, ti si appiccicano con le loro cose da<br />
vendere, e anche ladri, ma non li si può odiare allo stesso modo, sono troppo poco. Poi però sono arrivati questi, dalle ceneri di quello che<br />
una volta
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
73<br />
x<br />
una volta era il comunismo sono arrivati finalmente i nuovi nemici: questi arroganti criminali venuti qui a farla da padroni, peggio che<br />
rubarci il lavoro, a colonizzarci con i loro traffici di clandestini e prostitute e droga, si vede subito dalla faccia che gente è, quando<br />
camminano a gruppi e ti sfidano con quell’aria sfrontata che ormai qui sono loro i padroni; tutto è in mano loro, sono loro i nuovi<br />
comunisti, se nei paesi da dove vengono c’era il regime avranno pur preso qualcosa, i comunisti si sono rinnovati in loro, i più schifosi, i più<br />
delinquenti, i più sfruttatori.<br />
E sono proprio loro che mi seguono, mi accerchiano, gli Albanesi, fogna dei Balcani, feccia della feccia dei clandestini; è contro di loro<br />
che ho fatto, so che non me lo perdoneranno, posso scamparli stanotte ma non sarà per sempre, magari sanno dove abito e me li trovo<br />
davanti a casa, pronti per me, loro sono dappertutto, controllano tutto e io non ho difese. Questa la verità, Vlady è solo uno smargiasso,<br />
Vlady e gli altri sono solo buoni a smargiassate e intanto hanno mandato avanti me, a fare da martire, troppo comodo imbottirsi la testa di<br />
slogan e starsene indietro, quando c’è l’ardito che fa l’opera per tutti. Ma perché andare a casa, cosa mi viene da pensare, là mi troveranno<br />
subito, ormai sono segnato e c’è da sperare che mi trovi la polizia prima di loro, avrei qualche possibilità in più di scampare; tutto quello<br />
che posso è fuggire in tondo, rasente i muri e pestare cicche e lattine appiattite al suolo, Vlady e gli altri non vorranno neanche saperne,<br />
ormai sono bruciato, hanno giocato con me, sbavavano per fare e cercavano solo un povero cristo per investirlo dell’opera e scaricargli<br />
tutto addosso, e ora sono solo, solo col buio senza più ombre, solo con gli Albanesi.<br />
Ce n’è voluto nonostante, perché li unificassi ai comunisti, col tempo gli spigoli si ottundono e non ero più tanto sicuro del mio odio;<br />
proprio per questo cercavo qualcosa per rinfocolarlo. L’occasione me l’ha offerta proprio Vlady. L’ho rincontrato un anno fa dopo tempo<br />
incalcolabile, era sparito così, nel nulla, con quella spilungona antipatica dai capelli che erano tanti spilli; mi salutava appena per via quando<br />
era abbracciato a lei, e io rispondevo appena rodendomi che fossi sempre da me coi miei passi, l’avrei voluta anch’io una cui aggrapparmi e<br />
perdermi in bacetti e smancerie. La cosa aveva scavato un solco tra noi, e neanche dopo che s’erano mollati, piuttosto male a quanto mi<br />
era giunto, avevamo ripreso a frequentarci; i nostri rapporti s’erano ridotti ai ciaocomè negli incontri occasionali, col contorno sporadico di<br />
poche chiacchiere portate avanti con imbarazzo affrettando il momento del distacco.<br />
Un giorno mi ha telefonato. Voleva vedermi, con una certa urgenza. In nome del nostro vecchio credo, vecchio ma mai morto, vero?, ha<br />
aggiunto. Il desiderio di riprendere il contatto, di mettere a posto un conto ingiustamente sospeso è stato superiore a tutto. La sera dopo,<br />
al pub, è andato subito al sodo. Ha tralasciato gli anni in mezzo come se non fossero stati e mi ha rammentato, fosse stato necessario, il<br />
tempo della nostra causa, i discorsi della cantina con la birra da muratori e le cassette che frusciavano. Ora si può riattaccare il filo, diceva.<br />
Non sono più gli anni dei comunisti, c’è di peggio ora, bei tempi allora che avevamo meno impedimenti a odiare e nessuno ti dava del<br />
razzista. Ora il nemico si chiama Albanesi, sputacchiava sulla mia maglia come quei giorni della cantina, sono loro che mettono a<br />
repentaglio la nostra razza, la delinquenza è esplosa in Italia da che sono sbucati dalle loro tane, rozzi laidi invasori della nostra identità. È<br />
inutile nascondersi dietro un dito, si accalorava Vlady dopo aver vuotato la seconda media, non sono come noi e qui non ci devono stare,<br />
già i meridionali sono di troppo e senza si starebbe meglio, ma ormai ce li dobbiamo tenere; figuriamoci questi qui che sono della stessa<br />
famiglia, anche gli Albanesi minano la nostra identità dalle fondamenta: dobbiamo far fronte per ricacciarli, cominciare a dare l’esempio.<br />
Mi ha dato l’appuntamento per qualche sera dopo con gli altri, stavano organizzando un gruppo, avevano già qualche piano. Io mi ero<br />
sistemato da usciere in comune passando per spazzino e bidello, proprio in comune dove comandavano i compagni, vendetta vigliacca della<br />
sorte, ma forse hanno il potere contato, alle prossime elezioni li manderanno a casa, mentre me chi mi mandava più via di lì; stavo ancora<br />
con mia madre, non mi riusciva d’indovinare la mira a uno straccio di donna, e il resto erano scarse frequentazioni di amici nel senso più<br />
largo della parola
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
74<br />
x<br />
largo della parola. Quello che mi mancava era lo scatto, la svolta che rimettesse tutto in gioco e non mi obbligasse a quell’assuefazione da<br />
tranquillità; giusto quello che mi offriva Vlady.<br />
E ora loro mi seguono, mi accerchiano, non l’ho compiuta l’opera, o se l’ho compiuta si sono già passati la voce e mi cercano, mi cercano<br />
qui nel loro buio; non dimenticano loro, hanno il senso della vendetta e mi seguiranno per sempre, sono spacciato, tanto vale che mi<br />
appiattisca a quest’angolo di muro, potessi sparire dentro!, ad aspettare. Una fitta percorre tutta la mia schiena: è il freddo di questo muro<br />
e non me n’ero accorto, m’era salita tutta una smania di calore quando facevo, e poi quando sono fuggito, ma ora il muro mi trapassa lo<br />
schifo della sua notte, è il freddo di questo buio, il freddo più vero che mi prepara alla fine.<br />
Quella sera eravamo in sei, con me. Il gruppo si vedeva da Milo, aveva la casa dietro il suo ristorantino di specialità locali, nel giorno di<br />
chiusura; non avevano un nome, ciò che li univa era la causa, la mia causa. All’inizio mi squadravano con diffidenza nell’aria che ristagnava<br />
di alcool e canne, anche se Vlady aveva subito provveduto a rassicurarli, è uno dei nostri, uno fidato, già vent’anni fa odiava i compagni<br />
peggio di voi. La tensione non si rompeva, un po’ non mi degnavano e intanto spiavano le mie reazioni ai discorsi, Vlady era il più agitato<br />
assieme a Rudolph, che era mezzo tedesco e andava in bestia se gli accorciavano il nome in Rudy; faticavano a contenersi anche se l’ordine<br />
era di parlare piano, i comunisti sono battuti ma stanno ancora dappertutto, ricordava pacato Milo, sono spie di natura e molti dei giudici<br />
sono dei loro, per questo stanno impuniti. Le mani lunghe e secche del mio amico gesticolavano nell’aria disegnando ombre bizzarre sulle<br />
pareti, la faccia asciutta e rugosa si arrossava e le labbra si coprivano di saliva; gli rispondeva la mascella larga e dura di Rudy, con la voce<br />
metallica e perentoria di un chiavistello. Gli altri due si limitavano per lo più ad annuire, Milo sedeva tranquillo sulla poltrona, per noi aveva<br />
apparecchiato sedie, e sorrideva di una contentezza maligna. Io li osservavo a mia volta: un ignorantotto con la testa fatta di slogan, un otre<br />
di birra dalla faccia quadrata e l’occhio di pesce lesso, uno stecchino di poco cervello e un ragazzetto lentigginoso che non avrei<br />
riconosciuto fuori il giorno dopo, e il padrone di casa, lubricamente elegante e cortese, mai una parolaccia: avevo scelto questi per amici,<br />
questi erano la causa. Ma la causa non ha persona, io dovevo pensare alla causa e non a chi la portava avanti.<br />
A un certo punto ho osato un intervento; poche parole dure per essere tenuto della partita. Io i comunisti sapevo cos’erano, rischiavi di<br />
beccarti insulti o anche botte a dirlo, a me non è toccata perché era meglio stare zitti; ma almeno non c’era l’accusa di razzismo, ora invece<br />
ci s’aggiunge anche questo, noi raccattiamo tutti i ladri e gli zingari e i delinquenti degli altri posti e se dici la verità sei subito un razzista. Gli<br />
sguardi di tutti si sono fissati con curiosità; mi sentivo finalmente considerato, al centro della riunione, era evidente che avevano<br />
apprezzato, persino il sorriso di Milo è cresciuto d’intensità e cattiveria e le labbra hanno preso un’espressione ancor più enigmatica, e per<br />
la prima volta ha preso la parola decretando la mia accettazione. Vlady mi ha rassicurato, con un bel sorriso che significava sei dei nostri.<br />
Dovevano ancora organizzarsi, spiegava, ma c’era già qualcosa che assomigliava a un piano per la causa; Milo poteva contare su certi<br />
finanziamenti, niente proclami e manifesti, c’era da agire, con quella gente bisognava agire e non serviva altro, gli appelli e le parole c’era<br />
già chi provvedeva, noi saremmo stati il braccio.<br />
Proprio quello che volevo per me: non mi è mai importato granché della letteratura e ho sempre preferito l’atto, qualche cosa ho<br />
masticato anch’io, dei gialli, quel libro di Hitler dal nome crucco che mi veniva rabbia solo a sentirlo nominare così metallicamente da Rudy,<br />
e una roba dello stesso tono, di uno che doveva essere un filosofo e diceva che l’uomo più forte è destinato a comandare e ha tutto il<br />
diritto di imporsi sul più piccolo; ma la pagina mi annoiava, io sono uno fatto per l’atto, e poi i libri inquinano col dubbio, la parola si può<br />
manipolare ma l’atto no, l’atto è quello, sai che devi fare quello e lo fai, l’atto viene prima di qualsiasi libro. Albanesi tutti appesi, ti piace?,<br />
mi ha chiesto Vlady quando la riunione era per sciogliersi, Milo che sorrideva impassibile sulla sua poltrona e noi già in piedi; come slogan è<br />
un po’ trito,
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
75<br />
x<br />
un po’ trito, non l’abbiamo inventato noi ma fa alla causa, è la causa che conta, diceva convincendosi sempre più, è di qui che bisogna<br />
partire, potrebbe essere anche il nome del gruppo, non ce l’abbiamo ancora e un nome dovremo pur darcelo. Niente nomi ufficiali da<br />
costringere in sigle, ma qualcosa di più diretto, qualcosa che si capisse subito la nostra idea. Com’ero euforico quando sono sceso dalla sua<br />
macchina; ho sbattuto la portiera e mi sono messo a saltellare fino al portone. Mi era stata offerta la svolta; potevo giocarmi tutto, avevo<br />
trovato l’azzardo dello scatto finalmente in avanti del mio tempo.<br />
Non l’avrei detto che finivo qui, dietro questo muro buio dove sedimenta piano il respiro della mia paura, senza l’appiglio di una fuga, di<br />
un ritorno. Albanesi tutti appesi: il mondo incasellato, diviso nettamente per categorie, ancora. Quant’era difficile, non me n’ero accorto ai<br />
tempi che rovesciavo tutto il male nella cloaca dei compagni, ora la causa cominciava a farsi più complessa, più sfuggente: che bella l’idea<br />
squadrata in cui ti ci riconosci tutto, in cui ritagli esattamente i confini e il resto è fuori, è contro; ma c’era sempre qualcosa che fuggiva lo<br />
schema, una maglia rotta e io a ricucire, a riparare con rabbia paziente perché lo schema tenesse, ne andava della causa.<br />
Se no, gli Albanesi correvano il rischio di non essere tutti uguali, era già successo con i comunisti, che lo schema non aveva tenuto.<br />
Perché al pensionato bavoso che faceva la posta a mia sorella, stazionava sempre giù da basso, al portone, aspettandola che uscisse o<br />
rientrasse e l’abbordava, o quell’altro vicino, il ferroviere che ci salutava appena perché andava superbo che era assessore, lo dicevano tutti<br />
che ci lucrava col suo assessorato, anche lui sempre a sparare sul malgoverno e poi faceva un cazzo tutto il giorno allo scalo merci, un<br />
rubastipendio come lui non poteva che essere un compagno, e toccava a noi mantenerlo; ecco, al conforto dei comunisti come quei due lì<br />
si opponeva il signor Manfredi, impeccabile anche se nella vita aveva fatto l’operaio, vestito di gusto, non con la cravatta posticcia e la<br />
saliva agli angoli delle labbra come il vicino porco, il signor Manfredi era un signore per davvero, di correttezza esemplare, mi salutava<br />
sempre con un sorriso aperto. Non ha mai saputo di me, è morto poco dopo la pensione per un tumore e mi è fin dispiaciuto, non mi sono<br />
neanche fatto pregare da mia madre per andare al funerale. Ma allora andavo dritto per la mia causa, c’era la cantina di Vlady ad<br />
aspettarmi e là tutto si rincasellava; ora è più difficile, sarà l’età che si matura come dicono ma io non voglio questo maturare, voglio la mia<br />
causa, la mia certezza e con essa affronterò anche loro, perché loro sono qui intorno, in agguato, approfitteranno se mi vedono cedere alla<br />
maturità.<br />
Già, è sempre più difficile odiare; più vedo che cresce l’odio, l’intolleranza quale che sia e meno mi ci ritrovo, va troppo di moda ora, è<br />
scomparso il piacere di essere contro odiando. Ho persino conosciuto una famiglia di Albanesi: lo sapessero Vlady e gli altri. Una famiglia<br />
per bene, della prima ondata, non di quelle dopo che hanno svuotato le loro prigioni e ci hanno mandato qui il peggio dei delinquenti;<br />
gente onesta, tiravano avanti in cinque col lavoro della figlia maggiore, traduttrice o qualcosa del genere. Abitavano in un alloggio delle<br />
case popolari qui vicine, anche questo fanno i comunisti, danno le case a loro venuti qui freschi freschi mentre la nostra gente aspetta una<br />
casa da una vita; il padre aveva anche provato a cercare lavoro, laggiù era barbiere, ma ha rinunciato quasi subito. Li ho conosciuti un<br />
pomeriggio che, rientrando, me li sono trovati davanti alla porta di casa mia; chiedevano abiti smessi, erano venuti in delegazione per<br />
impietosire: il padre, un uomo robusto dai capelli brizzolati, sguardo fiero e gentile, non aveva neanche la faccia scura degli Albanesi,<br />
sembrava dei nostri, la madre, lo sguardo curvo a terra sotto il risentimento di una vita di sconfitta, la seconda figlia, una giovinetta<br />
dall’aria sfrontata che ce l’hanno nel sangue, per quanto buoni sono di quella razza, e la bambina, la bambina della prima figlia, unica<br />
assente perché stava al lavoro, un amore di due o tre anni che pareva una bambola di porcellana, i capelli biondi come grano con tutti i<br />
boccoli e gli occhi celesti, non l’immaginavo che gli Albanesi potessero avere una bambina così bella, la teneva il padre nelle sue braccia<br />
salde, e lei sorrideva, ancora ignara sorrideva. Mi infastidiva che venissero a chiedere elemosina, anche di abiti smessi, mia madre ha la<br />
fissa
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
76<br />
x<br />
fissa della carità e si lascia convincere, arriverebbe a togliere i vestiti a me e a mia sorella per darli in carità, non mi piace questa elemosina<br />
data perché sono altri e come altri stanno sempre peggio di noi, è questo il vero razzismo, non il mio, il mio è difesa da chi non è come noi<br />
e ci minaccia; così, appena ho visto, ho capito subito come sarebbe andata a finire. Per educazione, quando mia madre è tornata dentro a<br />
raccattare roba, ho chiesto il nome della bambina. Il padre ha sciorinato una breve sequenza di suoni impronunciabili e non avevo voglia di<br />
richiederlo: peccato che fosse albanese e avesse un nome così. Parlavano un discreto italiano, erano qui da due anni, ma tutti gli Albanesi<br />
imparano l’italiano, fin troppo presto, fa parte dei loro piani. La bambina mi sorrideva ancora ignara, mi aveva preso in simpatia e ho<br />
ricambiato. Fossero qui a vedere come ho ricambiato; ma io sono bravo ad adattarmi, ho imparato a muovermi sul terreno dei compagni e<br />
camuffo bene l’odio.<br />
L’ho camuffato bene anche quel pomeriggio che mi sono imbattuto nel padre, portava a passeggio la bambina e io stavo tornando da<br />
casa di Vlady. Mi ha fermato e mi ha ringraziato cordialmente dei vestiti. Non ho mai provato tanto imbarazzo: mi avesse visto qualcuno dei<br />
nostri, io che mi prendevo sempre più spazio nelle riunioni, concionavo bene e poi ero amico degli Albanesi, il padre era maledettamente<br />
cordiale e la bambina sorrideva ogni volta che abbassavo lo sguardo a lei, non potevo trattenermi dal contemplare quell’ovale da pittore<br />
con i boccolini biondi tutti ben ordinati e gli occhi blu profondo che invitavano a tuffarsi nel loro luccichio e perdersi. Sono tornato a casa<br />
sconquassato, per ripigliare il controllo su di me ho dovuto rifugiarmi in qualcuna delle riviste che mi passava Milo, lui teneva contatti con<br />
altri gruppi. Da allora ho cercato di evitarli, di scantonare se li vedevo in distanza: quelle due perle azzurre e quei boccoli d’oro mi<br />
mettevano angoscia, paura. Fossero qui ora, magari perdonerebbero, mi aiuterebbero a capire le cose, o magari giustificherebbero che ho<br />
ragione io, siamo diversi e basta, ed è bene che restiamo separati. Perché è dalla paura che nasce il dubbio, solo con la mia paura sono<br />
perduto, non sono più sicuro che quello che ho fatto è bene, non sono neanche sicuro di aver fatto, forse me lo sono inventato, all’ultimo<br />
mi sono cagato sotto e ho buttato via la pistola e tutto, in quell’attimo mi sono rivelato, e non saranno neanche gli Albanesi che mi<br />
cercano, sono Vlady e gli altri, Milo li ha sguinzagliati contro di me, qualcuno di loro mi ha visto col nemico e mi hanno scelto per mettermi<br />
alla prova; e io ho offerto la prova, la prova di quello che valgo nel momento che non sono più le parole.<br />
Continuavo a frequentare la casa sul retro del ristorantino di specialità locali nel giorno di chiusura, con sempre più passione. Ormai ero<br />
io che incitavo, che proponevo le questioni e i rimedi; spesso mi davano sulla voce, più per dire anche loro che per confutarmi, ma io avevo<br />
più argomenti, ho coltivato poco i libri ma almeno io le cinque scuole le ho fatte in cinque anni, un po’ d’istruzione me l’hanno data. Milo<br />
sprofondava sempre in poltrona, annuiva col suo sorriso che non capivo se era perché ne sapeva di più, o si compiaceva della regia sempre<br />
meglio orchestrata a ogni riunione, di aver trovato uno che riusciva a dar parole giuste alla causa; annuiva e non mi interrompeva mai, alla<br />
fine mi porgeva le riviste dicendo di informarmi. Ma c’era poco da informarsi, ogni sera mi pareva che ripetessimo stancamente noi stessi,<br />
che cercassimo di illuderci a vicenda con la causa per non doverci confessare che non riuscivamo a darle uno sbocco; io non ero andato là<br />
per delle parole, ero stato chiamato per fare, ciò che l’odio reclamava.<br />
Una sera Vlady è venuto a prendermi con l’aria grave, vagamente misteriosa. C’è qualcosa di nuovo che bolle in pentola finalmente, si è<br />
limitato a dire; quando saremo là saprai. Tutti erano misteriosi alla riunione, c’era l’atmosfera forzata di un qualcosa che quasi temevano di<br />
palesare, ma prima o poi sarebbe saltato fuori; solo Milo giaceva impassibilmente sprofondato nella sua poltrona, col suo sorriso. Subito<br />
credevo che avessero scoperto con chi me la facevo, che volessero smascherare un mio tradimento della causa, ma nel peso dell’aria<br />
aleggiava anche una sorta di eccitazione repressa che indicava ben altro, e questo mi incoraggiava. È stato proprio Milo a dare la mossa,<br />
tocca a te Vlady, ha detto e il sorriso si è dileguato dalla faccia, si è retto sui braccioli mettendosi a sedere più composto; guardava fisso me,<br />
senza
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
77<br />
x<br />
senza più enigmi. Vlady mi ha informato. Avevano deciso il primo atto, giusto per far sentire che c’eravamo. Chi aveva deciso, ho azzardato.<br />
Contatti superiori, è intervenuto subito Milo, noi siamo solo una cellula, facciamo parte di una rete e non possiamo sottrarci al disegno che<br />
si sta spianando.<br />
Il primo e ultimo atto della guerra per ripulire il territorio dagli intrusi, dal male che in questo momento li accomuna, slavi, albanesi, froci<br />
e spacciatori, tossici e meridionali, tutti volevo ripulire, gli Albanesi prescelti avrebbero inaugurato. E invece sono io, il solo prescelto, la<br />
vittima abbandonata allo sbaraglio e la trappola si sta chiudendo, primo e ultimo atto della commedia giocata alle mie spalle, il muro mi<br />
trapassa il suo freddo, la notte si sta chiudendo su di me, verranno dalla notte a prendermi.<br />
Paura, eccitazione, voglia di fare: tutto si mescolava in me dopo che Vlady aveva proferito la sentenza con la voce che gli tremava,<br />
girando nervosamente la testa verso gli altri per non guardarmi. L’aveva mandata a memoria, te la senti, mi ha chiesto, di adeguare le tue<br />
parole ai fatti, la tua professione di fede all’atto in nome della causa. Gliel’avevano inculcata bene, Vlady non parla così di solito, stenta a<br />
mettere insieme una frase senza qualcuno dei suoi cazzocioediciamo. I loro sguardi mi devastavano, persino Milo aveva ripreso il sorriso da<br />
felino in agguato sulla sua preda, era la prova della mia fedeltà. Non potevo rifiutare, mi avevano prescelto. Una riunione, eccitato da Rudy<br />
che le cose di coraggio era buono a farle solo lui, mi ero vantato di saper sparare e che all’occorrenza non avrei esitato di fronte al bersaglio<br />
giusto; così mi sono ritrovato in mano la pistola. L’ho ricacciata subito nella tasca della giacca, senza guardarla. È per stasera stessa, vedrai<br />
che non è difficile, mi ha detto Milo; e mi ha indicato dove.<br />
Il prescelto, eccolo. Al muro ci mettono chi devono fucilare, questa è la mia esecuzione, la mia strada, non posso più scappare, l’unico<br />
posto dove potevo avere rifugio l’ho perduto, tendo l’orecchio ma non sento più rumori, solo qualche rara macchina che va via lontana,<br />
una sirena, mi cercano già o sono solo le autoambulanze che si precipitano a recuperare i corpi; ma poi è tutto silenzio, e allora vorrei i<br />
rumori, vorrei sentirli avvicinare perché almeno saprei quando, saprei che sono arrivati per donarmi pietosamente la fine, per placare<br />
questo silenzio che mi esplode dentro, quest’agonia che mi squassa al ritmo sempre più lento del mio fiato, sta misurando gli ultimi respiri<br />
prima dell’esecuzione.<br />
Ho scambiato il mio ruolo, o forse era già questo sin dall’inizio, io ero vittima come loro, mi sono lasciato scattare la trappola addosso<br />
poco a poco, riunione dopo riunione, Vlady e gli altri aspettavano il martire dalle belle idee che s’incastrasse da solo; ne ho avuto coscienza<br />
quando ero presso la porta, non ho avuto il coraggio di suonare giù, ho aspettato che uno uscisse e mi sono intrufolato nella tana, ho corso<br />
le scale per accorciare il tempo, avevo già il fiatone quando ho suonato, un caldo addosso da scoppiare, febbre di fare, di concludere al più<br />
presto, la mano nella tasca mi tremava e l’altra girava un bottone della giacca, l’aveva quasi staccato, la testa tentennava e non riuscivo a<br />
controllarla, ancora qualche secondo e se non aprivano me ne sarei andato, sentivo strascicare passi nel corridoio, dovevo scappare finché<br />
tutto era ancora intatto, ma la testa tentennava incontrollabilmente e la mano mordeva il grilletto, un dito aveva rimosso la sicura e ormai<br />
stavo lì, la porta si è aperta, è venuto lui ad aprire, mi dev’essere scappato un mezzo sorriso mentre tiravo fuori la mano ormai salda; e<br />
tutto ha taciuto in quel momento, li ho colti uno dopo l’altro senza più esitare, le gambe mi hanno portato da sole, la mano ha fatto da<br />
sola, io non avevo più colpa, il padre li avrà tranquillizzati vedendomi sulla porta, mi venivano le voci dalla cucina, ho calpestato il corpo e<br />
sono entrato, erano raccolti in cucina e così è stato più facile fare, la seconda figlia si era già precipitata in corridoio e con due botti l’ho<br />
sbattuta contro il muro, si è tenuta a una maniglia, la porta si è aperta ed è stramazzata nella stanza, la madre me la sono trovata sulla<br />
soglia della cucina e l’ho ributtata dentro, i colpi non cessavano ma tanto non potevo udire, tutto è diventato sordo tra le mie dita; e come<br />
potevo udire, come potevo vedere che nella mia mira c’erano i boccoli d’oro ben ordinati, i due occhi da tuffarcisi dentro e perdersi senza<br />
tornare
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
78<br />
x<br />
tornare più indietro, il faccino rotondo da pittore che la figlia maggiore schiacciava contro il petto per nascondermelo, instupidite che<br />
neanche urlavano, come potevo vedere e udire prima che finissi, prima che mi fermassi dritto in mezzo a tanto sangue, la testa non<br />
tentennava più, ora rombava, sempre più pesante fino a esplodere, e sono fuggito perché non lo resistevo, mi sono gettato per le scale<br />
senza vedere più niente, fuori nel buio dove tutto rombava ancora, mi ero illuso di lasciare tutto là ma era dentro, ormai parte di me.<br />
Forse è stato tutto un sogno, un’immaginazione di quello che non sono buono a fare, credo di aver fatto e invece sono scappato appena<br />
mi ha aperto la porta, magari la pistola gliel’ho gettata in faccia e sono corso via, via da Vlady, da Milo, dalle riunioni in cui ci gloriavamo di<br />
voler ristabilire l’ordine; e allora cos’è questo rosso sulla giacca, queste macchie più scure che sono rosso anche nel buio, ma devo essere<br />
caduto mentre rotolavo giù per le scale, lontano da ciò che stavo per fare e non sono stato buono, sono caduto e mi sono ferito, ho sfiorato<br />
qualche angolo di muro nella furia di scappare. Le macchie sono sulla giacca e sono rosse, per quanto sia buio vedo il loro rosso, non ho<br />
ferite sulle mani e sulla faccia; perché il buio rivela, mi rivela che ho fatto, nel buio spiccano i colori e non è più solo il rosso, l’esecuzione<br />
sono due occhi azzurri in un faccino tondo ornato di boccoli d’oro, e quegli occhi forano il buio, mi schiacciano contro il muro, a terra, mi<br />
accuccio, mi inginocchio a loro, sono carponi e finalmente arriva, finalmente libero tutta la notte che ho dentro.<br />
GLI ORDINI SONO CAMBIATI<br />
Le scale erano troppo strette per dare il braccio alla sua signora; soltanto questo dispiaceva, a Mr. Faithful, dell’albergo a due passi dal<br />
centro, dalle cose più importanti da vedere. E proprio questo gli faceva sostenere che lei scendesse un paio di gradini avanti, nella scala che<br />
si curvava come a chiocciola prima di sboccare nella hall.<br />
Buttò appena uno sguardo sui residui fili di biondo nella capigliatura di lei, ormai vinti dal grigio, poi i suoi occhi volarono oltre, a<br />
quell’oltre indistinto e sicuro di americano in vacanza. Non sarebbe stato il sopravvento della pioggia a fermare, o anche deviare il<br />
programma della giornata che aveva studiato in ogni punto, lui uso per gli affari a viaggiare con qualsiasi tempo da un capo all’altro del suo<br />
Paese, che era ben più di quella vacanzetta concessa alla moglie dopo l’insistere di tanti anni.<br />
Discesi nella hall George Faithful si riaffiancò alla sua signora e automaticamente le diede il braccio, quindi svoltarono a destra, nella sala<br />
da pranzo già apparata per la colazione. Un cameriere in divisa gialla e nera li salutò con turistica cordialità e poi che furono passati disse<br />
ridendo qualcosa a un collega che si lanciava di corsa per le scale. Mr. Faithful si voltò di scatto, ma il cameriere aveva ripreso la sua aria<br />
irreprensibile e salutava un’altra coppia di vacanzieri che terminata la colazione risaliva in camera.<br />
Mentre sedevano al loro tavolo Mr. Faithful considerò con disappunto la pioggia che batteva sulle ampie finestre della sala al<br />
pianterreno. Fuori la piazza era praticamente deserta: qualche passante filava via rintanato nell’ombrello, dal lato opposto stazionava una<br />
mezza dozzina d’uomini raccolti come a testuggine per ripararsi dal tempo. A un certo punto uno di loro emerse dal crocchio, e levò il<br />
braccio in direzione dell’albergo.<br />
Il Paese del sud guastato da un noioso accidente, pensava appena seccato Mr. Faithful versandosi il caffelatte e facendolo debordare un<br />
poco dalla tazza, mentre la sua signora imburrava meticolosamente due fette biscottate. Sembrava l’avesse combinato apposta per loro, il<br />
tempo si era girato male proprio al loro arrivo e da due giorni non faceva che piovere, con rade e ingannevoli schiarite. Nella sala da pranzo<br />
c’erano pochi altri tavoli occupati; in uno accanto al loro una coppia di giovani dialogava fitto senza quasi toccare della colazione.<br />
Con
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
79<br />
x<br />
Con tono abituale di comando Mr. Faithful chiamò il cameriere di prima, un ragazzo magro e pustoloso con una testa di riccioli, per un<br />
succo di frutta. Quando arrivò col bicchiere il ragazzo pesò la coppia con un sorrisetto, poi chiese nella lingua del luogo se uscivano<br />
nonostante il tempo.<br />
«Certo che usciamo», ridacchiò Mr. Faithful nel suo americano pastoso. «Non ci facciamo certo spaventare dalla vostra pioggia!»<br />
«Allora fareste bene ad andare via subito», insistette il ragazzo nella lingua del luogo. «Qui non siete più graditi».<br />
«Che cosa… come ti permetti», sbottò Mr. Faithful, più sorpreso che irato; ma il ragazzo gli aveva già girato le spalle e trotterellava via<br />
dalla sala.<br />
«Ora t’insegno io… », e stava per alzarsi, ma la sua signora lo invitò con calma a risedere.<br />
«Non ora, George. Finiamo la colazione».<br />
«Non siamo più graditi… che cosa vuol dire? Ma io vado dal direttore, gli insegno io a quel piccolo insolente… »<br />
«Calma, George», disse ancora la sua signora. «Ci stanno guardando».<br />
Mr. Faithful si accorse di aver alzato la voce e risedette, un po’ confuso.<br />
«Uhm, dopo», borbottò come a voler chiudere l’incidente.<br />
I due giovani del tavolo accanto si erano appena voltati, prima di ripigliare il loro dialogo con un’occhiata mutua d’intesa. Gli altri<br />
avventori erano chini sulle loro tazze e sembrava non avessero notato. Mr. Faithful disdegnò il resto della colazione, buttò ancora uno<br />
sguardo contrariato alla pioggia che rigava i vetri e formava ormai un velo leggero sulla piazza, poi fissò l’attenzione sulla coppia; avevano<br />
l’aria spregevole degli intellettuali, lei con i capelli biondi esili che tra qualche anno sarebbero finiti come la chioma della sua signora, lui<br />
con un impudente ciuffo ramato sulla testa abbondantemente calva e un’uguale peluria che picchiettava il mento e le guance. Nella sua<br />
conoscenza malsicura della lingua del luogo gli arrivavano pezzi di frasi.<br />
«… stanno cambiando».<br />
«Sono cambiati. Mica potevano fare i padroni in eterno».<br />
«Ma basterà? Non credi… »<br />
«È ancora poco… metterli a terra».<br />
Mr. Faithful si concentrò su quelle parole, scoprendo pian piano il dubbio che lo riguardassero. E più cercava di comporle, più il<br />
dispettoso avvertimento di esserne oggetto cresceva.<br />
«Ma allora… non sarà servito… »<br />
«Intanto non sono più i padroni dappertutto. Almeno non più qui».<br />
«Però non l’avresti detto… cani… »<br />
«C’è una parabola per tutte le cose».<br />
«… cani… stanno proprio cambiando».<br />
«… sono cambiati».<br />
Mr. Faithful si sentiva montare sempre più la sorpresa, e l’ira assieme. Prima il cameriere con la faccia butterata che li insolentiva<br />
marchiandoli per non più graditi, poi quei pezzi di dialogo sui padroni che non sarebbero stati più padroni. Infidi, altro che amici; sottomessi<br />
ma infidi. Con tutto quello che avevano fatto per loro. Era il prezzo da pagare per essere americani. Mr. Faithful cercò un conforto negli<br />
occhi della sua signora, che gli sorrise un invito a non muoversi, a lasciar correre; felice lei, che conosceva poco e niente della lingua del<br />
luogo.
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
80<br />
x<br />
Luogo.<br />
S’impose di calmarsi, ma stentava. Il prezzo da pagare per essere americani. Anche per lui che quella vacanza non la voleva, aveva<br />
accondisceso perché Linda non si sentisse da meno tra gli amici che vantavano le vacanze in Europa, nel Paese del sud soprattutto. Meglio<br />
girare il proprio Paese da un capo all’altro, che fare visita ai sottomessi infidi con la scusa della cultura, che cos’era tutta quella cultura da<br />
esibire di conoscere, di aver visitato; non l’aveva mai capito lui, americano anche quando dava il braccio alla sua signora o usava delle altre<br />
garbatezze. Infidi, l’avrebbe detto a Linda che per il futuro li avrebbe lasciati dove stavano, a macerare la loro rabbia di sottomessi, tra gli<br />
scarti della loro cultura. Sapeva bene che anche questo tornava nel conto di essere americani, che anche nel Paese del sud, nel Paese<br />
ufficialmente amico c’era tutta una propaganda contro, un’inimicizia non dichiarata, ma non l’avrebbe detto che covasse così forte: lo<br />
leggeva sempre più chiaro nelle facce dei due giovani ora intenti alla colazione, dei camerieri che si scambiavano occhiate o parlottavano<br />
con cenni verso il loro tavolo, e subito sparivano. Una propaganda sotto, un’inimicizia mielata cui preferiva la certezza di quei Paesi dov’era<br />
ben dichiarato, che non erano graditi.<br />
La pioggia batteva continua i vetri e il selciato della piazza; non c’era che quel diluviare grigio là fuori, quel consumare con la stessa<br />
forza, senza una posa. Non si vedevano più di passanti, anche il crocchio al lato opposto della piazza si era sciolto. Tempo infido, come il<br />
Paese che inutilmente pretendeva di lavare; con tutto quello che avevano fatto per loro e facevano tuttora, per la loro miserabile cultura,<br />
ecco come li accoglievano.<br />
Nella sala da pranzo era entrato un uomo sulla cinquantina, la faccia bruna e malinconica di barba lunga, che si diresse senza esitazione<br />
verso Mr. Faithful e signora. La pioggia aveva segnato l’orlo dei pantaloni e l’impermeabile beige.<br />
«Gli americani, giusto?»<br />
Allo sguardo interrogativo di Mr. Faithful e signora continuò nella lingua del luogo, senza aspettare risposta: «Devo pregarvi di venire<br />
con me. Qui non siete più graditi».<br />
«Che cosa? E perché dovrei venire… », rispose Mr. Faithful nel suo americano pastoso.<br />
«Non faccia scene. Tanto nessuno qui interverrà per voi». La voce, scavata e malinconica come la sua faccia, aveva il timbro grigio e<br />
regolare della pioggia. La coppia del tavolo vicino continuava la colazione; un leggero sorriso increspava le loro labbra. Non erano rimasti<br />
altri avventori nella sala, se n’erano usciti tutti poco prima, come a lasciar spazio al nuovo arrivato.<br />
Mr. Faithful si alzò in piedi, del tutto rabbioso. Di buona corporatura, ancora dritto sulle spalle, sovrastava l’uomo dalla faccia<br />
malinconica di due palmi.<br />
«Ma chi è lei?», eruppe Mr. Faithful nella lingua del luogo. «Noi due non abbiamo niente a che fare. Cameriere! Direttore!»<br />
«Non faccia scene. Gli ordini sono cambiati. Seguitemi, prego».<br />
«Forse non ho inteso bene. La pregherei di esprimersi… »<br />
«La vostra lingua non vale più. La vostra moneta non vale più», e cavò di tasca dei dollari accartocciati, gettandoli sul tavolo.<br />
«Seguitemi».<br />
Mrs. Faithful guardava con preoccupazione ora il marito ora l’uomo dalla faccia malinconica, con inutili richieste di spiegazione e inutili<br />
appelli a George che si calmasse.<br />
«Io non la seguo da nessuna parte! Tranquilla Linda, ora sistemo tutto».<br />
«Tutto è già sistemato. Non siete più i padroni qui, gli ordini sono cambiati».<br />
«Gli ordini sono cambiati»,
Da La stadera, 2005<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
81<br />
x<br />
«Gli ordini sono cambiati», ripeté a eco la coppia di giovani.<br />
«Quali ordini?», gridò Mr. Faithful sporgendosi in avanti a pochi centimetri dalla faccia malinconica.<br />
«Gli ordini», continuò la voce grigia di pioggia. «Non ci costringa a intervenire», e accennò ad altri due uomini che erano comparsi nella<br />
sala e stavano a braccia conserte presso l’uscita.<br />
Ora Mr. Faithful intendeva; l’inimicizia era scaturita finalmente, si era concretizzata in nuovi ordini dove loro erano gli esclusi, i colpevoli,<br />
le prede. Mr. Faithful intendeva, e indietreggiò abbassando la testa.<br />
«Andiamo Linda», disse con aria grave, cercando di infilarvi un ultimo accento di sicurezza. «Accontentiamo il signore, e vedrai che tra<br />
poco sarà tutto risolto».<br />
«Tutto è già stato risolto».<br />
Col pallore di chi aveva inteso più delle parole Mrs. Faithful si alzò e passò rasente al tavolo per aggrapparsi al braccio del marito.<br />
Mentre la sorreggeva Mr. Faithful scorse fuori, nella pioggia, due uomini in una divisa che sembrava della polizia; fermi a una decina di<br />
metri dalle finestre della sala da pranzo, parlottavano tranquilli e guardavano nella loro direzione. La pioggia sgrondava dalle visiere dei<br />
berretti e iscuriva le uniformi, ma non se ne davano pena. Sfidando l’uomo dalla faccia malinconica Mr. Faithful fece un gesto vistoso con la<br />
mano, sperando di richiamare l’attenzione; i due proseguirono come se non avessero visto e solo per caso, o per tutt’altro si fossero<br />
fermati un attimo all’altezza dell’albergo.<br />
I due presso la soglia fecero ala agli americani, stringendoli tra loro e l’uomo dalla faccia malinconica che li precedeva nella hall; la<br />
coppia si era alzata a chiudere la fila. Mrs. Faithful, a testa china, continuava a chiedere con smarrimento al marito che cosa significava,<br />
senza avere risposte, lui roteava gli occhi tutt’intorno, alla ragazza in divisa amaranto della reception, a una donna di servizio che si avviava<br />
a rifare le camere, al cameriere pustoloso che li aveva messi beffardamente in guardia, ad alcuni turisti seduti sulle poltrone, ma ottenne<br />
sguardi silenziosi, di indifferenza o dell’inimicizia ormai dichiarata.<br />
L’uomo dalla faccia malinconica aprì la porta a vetri dell’albergo e la lasciò subito andare; Mrs. Faithful afferrò con prestezza il<br />
maniglione dorato prima che si richiudesse. Uscirono affiancati, sulla soglia avvertirono una mano sulle loro schiene che li spingeva nella<br />
pioggia. Qui li aspettavano altri due uomini; Mr. Faithful impietrì, credette d’un colpo di riconoscere i berretti sgocciolanti e le divise che<br />
aveva intravisto dai vetri della sala. Ma erano stati solo pochi secondi, come poteva avere la certezza che fossero proprio loro, come<br />
pensare che anche loro avessero nutrito l’inimicizia, fossero passati ai nuovi ordini.<br />
La pioggia scemava. In fondo alla piazza due bambini senza ombrello giocavano a schizzarsi addosso l’acqua raccolta nelle irregolarità del<br />
selciato, e ridevano.
Su La stadera<br />
Per dire e per dirsi che esiste una via d’uscita per affrontare l’immaginario, anche quando la realtà cerca di sovvertire ogni divenire, il<br />
racconto cerca di proporsi con i mezzi più affilati che l’autore riesce a reperire.<br />
Questa alchimia costituisce un fenomeno assolutamente originale ed anche straordinario quando l’amarezza, che Gianni Caccia rende<br />
tangibile, si introduce subdola nelle storie, fra le trame dei singoli racconti, ricchi di riconoscibili colpi di scena. La solitudine del personaggio, la<br />
sfuggente ansia del proporsi sono punto di partenza e punto di arrivo della vicenda umana, che si intesse lungo tutte le pagine. Non è<br />
assolutamente riconoscibile la “tragedia”, ma in fondo ad ogni significazione appare un potenziale terreno fertile per l’elemento scatenante: un<br />
gesto, una frase, un evento improvviso, una tensione trattenuta a stento sostengono la prova di una ostinata tensione, ben registrata e quasi<br />
sempre variopinta.<br />
I destini non sono segnati dal fato ineluttabile, eppure le scelte vengono sottoposte a ingranaggi che fanno cambiare il cammino. […] La<br />
malinconia riesce ad entrare nell’idea del vissuto, a volte nebuloso, a volte splendidamente annullato nelle pieghe di un tempo nuovo e<br />
migliore, che valga la nostra storia sociale, l’architettura del segno, o l’ipotesi di una coscienza dello svuotamento dei principi, chiusi il più delle<br />
volte nei luoghi comuni dell’indistinto.<br />
Qui la prosa è ben diretta verso la ricerca di brani asciutti e sapientemente ponderati, ove l’atto del dire rispecchia quei riflessi della realtà<br />
che non si nasconde al nostro sguardo e alla nostra indagine, sia nei percorsi di una immediata osservazione sia nel ricadere del rapido sfoglio<br />
delle vicissitudini.<br />
Il desiderio della fiaba non è vagheggiato, abitato nell’attimo del suo apparire o variegato sulla retina del cuore, perché il senso amabile e<br />
sorridente della vita, spesa nel quotidiano affanno, diviene complice di un assoluto microcosmo in armonia con una lacerante metafora della<br />
suggestione.<br />
L’autore ci lascia tra cronaca concretamente significata e velluto di complicità, per la dimensione surreale di alcuni passaggi, nella sua<br />
capacità di offrire la forza della concretezza abbinata alla mitica fierezza dell’inventiva.<br />
Antonio Spagnuolo, “Vico Acitillo - Poetry Wave”, 2006<br />
* * *<br />
Dopo aver percorso i sentieri della memoria e dell’immaginazione tracciati da Gianni Caccia nella raccolta La Vallemme dentro (Edizioni<br />
Joker, Novi Ligure 2000), passo ora ad osservare, in qualità di lettore, le oscillazioni asincroniche de La stadera, il suo volume di racconti di<br />
recente uscita, pubblicato anche in questa occasione con le edizioni Joker, e accompagnato dalle significative e graffianti illustrazioni di Pietro<br />
Casarini. Le oscillazioni della bilancia, simbolo antico e a volte involontariamente autoironico, sono state prese dall’autore come emblema<br />
dominante per rappresentare storie che vertono tutte, seppure da punti di vista variegati e divergenti, sul tema della giustizia.<br />
L’argomento è quanto mai spinoso e suscettibile di discussioni e diatribe infinite. Persino una moderna bilancia elettronica avrebbe difficoltà<br />
in moltissimi casi a distinguere tra bianco e nero, giusto e sbagliato. Ma la giustizia, o ciò che chiamiamo per convenienza e necessità con tale<br />
nome, è affidata, Caccia lo sa e lo illustra bene, ad una stadera. Uno strumento di misurazione vecchio, quasi da medio evo, davvero poco<br />
moderno. Uno strumento con cui si va quasi ad occhio, o, comunque, che necessita di un’occhiata tra le due o più persone interessate alla<br />
pesatura. Uno sguardo d’intesa come a dirsi “tutti noi sappiamo bene che la misurazione è approssimativa, ma, visto che non si può fare di più,<br />
facciamo finta che sia precisa, o, almeno, che somigli in qualche modo all’idea della precisione”.<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
82
Su La stadera<br />
Questa alchimia di ironia salvifica e altrettanto ineluttabile amarezza, Caccia la rende tangibile nelle storie della raccolta. Non è opportuno<br />
che mi soffermi troppo sulle trame dei singoli racconti, anche perché molti contengono colpi di scena o sorprendenti ribaltamenti di visione. È<br />
auspicabile quindi che il lettore li scopra autonomamente. Posso però parlare del meccanismo generale, l’impostazione di base. Il punto di<br />
partenza è tanto sfuggente quanto imprescindibile: una vicenda umana, estrema, ma, in fondo, neppure troppo. Una delle infinite solitudini<br />
possibili che si rivestono di assurdità. Su questo terreno fertile di potenziali tragedie e sarcastiche commedie umane, si innesta l’elemento<br />
scatenante, un gesto, una parola, un evento, anche minimo e in apparenza “normale”, con una carica eversiva tuttavia, o perlomeno<br />
rivoluzionaria, in quanto foriera di mutamento. Il granello interrompe il moto dell’ingranaggio e lo blocca, oppure gli fa cambiare passo, lo<br />
trasforma in una potenziale macina di ossa e cervelli, un tritacarne di destini.<br />
Una delle qualità che a mio avviso spiccano in modo particolare in questo lavoro narrativo è la coerenza. Qualità tanto più preziosa quanto<br />
più rara. Coerenza con se stesso, innanzitutto. Con i testi scritti in precedenza, i punti fermi dello stile e del lessico che l’autore ha scelto come<br />
strumenti privilegiati per raccontare storie. Caccia continua a rifuggire le mode letterarie, quelle imposte dai best-seller. Si muove piuttosto<br />
passo dopo passo lungo una strada intrapresa e percorsa con tenacia, quella della ricerca di un suo linguaggio, un’impronta narrativa<br />
riconoscibile. I modelli ci sono, necessariamente, ma sono metabolizzati, resi propri e inseriti in un contesto personale, una voce autonoma. Sul<br />
piano strettamente stilistico, l’autore continua ad alternare, o meglio a miscelare, in dosi e con alchimie assolutamente originali, un linguaggio<br />
ricercato a espressioni crude, dirette, colloquiali. Si conferma colto, Caccia, ma non spocchiosamente cattedratico. Narra con forme e modi<br />
credibili, autentici, amalgamando l’elevato e il quotidiano. Mai banale tuttavia, quest’ultimo, mai becero. Prova a scrutare orizzonti di<br />
riflessioni, restando ancorato al suolo del concreto, del verosimile.<br />
Si estende, la coerenza di cui si è detto, anche al piano della costruzione dei racconti, il modo con cui viene veicolato il significato. Per dirla<br />
con le parole del Joseph Conrad di Cuore di tenebra, “il significato non si trova all'interno, nel gheriglio, ma all'esterno, in ciò che, avviluppando<br />
il racconto, finisce col rivelarlo, come la luce rivela la foschia, allo stesso modo in cui l'illuminazione spettrale del chiaro di luna rende a volte<br />
visibili gli aloni nebulosi”. Caccia continua a privilegiare l’implicito. Preferisce lasciare spazi aperti alle ipotesi, aggiungendo dubbi ai dubbi,<br />
piuttosto che pontificare. Ciò si verifica spesso anche nei finali, densi di verità che non vengono sigillate da una certezza, ma, piuttosto, aperte<br />
ulteriormente, come porte, cicatrici, ferite. Tutto questo accade, a mio avviso, non per il mero gusto dell’indeterminatezza. Direi, al contrario,<br />
in virtù del bisogno di aderire all’essenza del reale, fatalmente multiforme. Per fare gustare il sapore, l’essenza del vero, una stilla rapida e<br />
evanescente, che con identica velocità si perde e torna a rifluire nell’alveo dell’incerto, del probabile.<br />
Come rileva giustamente Mario Marchisio nella prefazione al libro, “Tale lavorio di contenuto non può non dettare la forma. La prosa è<br />
tutt’altro che piana e quotidiana. [...] Caccia sceglie di lavorare sul linguaggio quasi come un poeta, piegando spesso la frase a significato oltre<br />
che a significante”. Senza però, mi viene da aggiungere, togliere nulla al gusto del narrare, rievocando semmai, e ritrovando tra le pieghe del<br />
detto e del non detto, il gusto intenso del tessere parole raccontando tranches de vie. Ritrovando, come in certi film francesi in bianco e nero,<br />
poco commerciali e per nulla americaneggianti, il gusto del dettaglio, la pausa che evoca atmosfere, attimi di malinconica comprensione o di<br />
felice perdita della tramontana. L’idea che la vita, per quanto ci si pensi su e ci si danni, resta beatamente nebulosa, pregna di ombre e foschie.<br />
Gianni Caccia resta, anche in questo suo recente lavoro, serenamente e recisamente alieno alle facili simpatie, alle pagine edulcorate che si<br />
ingraziano agevoli plausi. Se c’è un sorriso, nella sua prosa, è agro. Sia quello diretto che quello riflesso, l’atto del dire e la reazione speculare<br />
del recepire. Domina le pagine della raccolta il cigolio della fatidica bilancia. Ghigna il lettore, viene invitato a collocarsi mentalmente su uno dei<br />
due versanti, quello che ritiene vincente. Ma è una posizione fragile. L’orrore dello specchio, ancora lui, incombe e prevale: emerge e si allarga<br />
a macchia d’olio l’ombra del dubbio, l’idea di aver visto e sentito tutto dal lato sbagliato. Il mondo capovolto, la vertigine che precede il salto.<br />
Ma solo<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
83
Su La stadera<br />
Ma solo attraverso tale stravolgente ebbrezza si può venire a patti con il vuoto, con l’abisso.<br />
Da lassù, dal luogo della vertigine, tutto è allo stesso tempo chiaro e sfumato. Gli angoli si smussano creandone altri, di diversa ampiezza,<br />
così come i colori mutano gamma e ridisegnano confini tra le tonalità. Questa visione d’insieme è tuttavia composta e resa possibile tramite<br />
una scelta accurata di singoli elementi, sia di sostegno che di demarcazione. Nulla appare casuale nei racconti de La stadera. A partire dai nomi<br />
dei personaggi, che paiono oscillare tra Cesare Pavese, Giovanni Guareschi e la cronaca minima e immancabilmente cupa di un qualsiasi<br />
telegiornale delle otto di sera. La cultura piemontese, già di per sé imbevuta, grazie a Pavese, di echi d’oltremare, migrazioni fisiche e oniriche<br />
verso l’America, si innesta ulteriormente sulla cultura contadina, le faide di paese, la politica vissuta e trangugiata assieme ai quartini di<br />
un’osteria, per poi ritornare alla visione attuale, la fuliggine senza tempo e senza anima della cronaca, quella dei serial killer all’italiana, le<br />
tragedie familiari per qualche lira o qualche euro in più, il far west di periferie urbane per nulla mitiche e per nulla lontane.<br />
Caccia si adegua, con un opportuno mimetismo, al clima e ai toni di tale realtà. Il suo modo di narrare è scabro, legittimamente angoloso.<br />
Anche i titoli sono secchi, parole singole, scagliate come i sassi dei famigerati cavalcavia, oppure lapidari, ineludibili come sentenze: Gli ordini<br />
sono cambiati, Confessione di un brigatista, Albanesi tutti appesi. Lontani anni luce da soffici e carezzevoli attrattive retoriche. Gli specchietti<br />
per le allodole qui vanno in frantumi, giustamente, sotto la pressione dell’urgenza del dire, dei conti che non tornano, l’equità che resta<br />
chimera. La nitidezza che Caccia ricerca è quella dell’onestà, nelle forme e nei temi. Scomoda, sempre. Ma del tutto consona al percorso e al<br />
progetto.<br />
Gli argomenti sono aspramente attuali. Ed esposti adottando il punto di vista dei protagonisti, chiunque essi siano. Spesso, dalla loro<br />
irriducibile assurdità, sboccia la coerenza dell’incoerente. Almeno per la visione comune, che, tuttavia, è composta di frammenti di<br />
innumerevoli visioni individuali. Il libro di Caccia conferma tramite storie bizzarre ed estreme, ma del tutto verosimili se non addirittura reali,<br />
quanto sia difficile da applicare la logica del diritto e il diritto della logica, all’interno di una qualsiasi società umana. Viene ancora in mente<br />
Conrad, che, come Kafka, come Sciascia, Pirandello, Dostojevskij e infiniti altri, alla vexata quaestio del giusto e del vero hanno dedicato pagine<br />
memorabili. Ognuno, in fin dei conti, è e rimane solo con la propria libertà condizionata dall’arbitrio e dai cancelli delle responsabilità. Si pensi<br />
all’eroe assai poco eroico ed estremamente umano di Lord Jim di Conrad. Solo con se stesso. Con un piede sulla terra ferma e uno sospeso nel<br />
baratro risucchiante delle scelte. Tra l’abitudine, la comodità della paura, la consuetudine e la necessità dell’azione. Ma ognuno nel suo<br />
profondo, come il brigatista che si confessa, oppure come il teorico dell’assassinio, o ancora il filosofo sui generis e pro domo sua, è convinto<br />
nel profondo di avere ragione, o almeno di avere una ragione anche lui. Una che vale. Fatta di ricordi, rancori, sogni. Ineluttabili, come la vita,<br />
come la pazzia. Improponibili nella loro nuda verità, eppure a loro modo reali, almeno dal lato della bilancia che è stato incautamente scelto o è<br />
capitato in sorte. Quello di chi regge lo strumento di misurazione, magari con mani rapide da prestigiatore, e quello di chi non può far altro che<br />
guardare e ascoltare, provando, quando, come e se gli è concesso a dire la sua.<br />
Tramite un efficace parallelo con Kafka, che successivamente si articola come contrasto, Marchisio nella prefazione sottolinea che “mentre il<br />
Praghese prendeva le mosse da un disgraziato quanto emblematico antefatto che gettava fin da subito il personaggio sulla più desolata delle<br />
ribalte, [nei racconti di Caccia] quello stesso enigma si manifesta invece progressivamente, devastando come una malattia degenerativa le<br />
capacità razionali dei protagonisti, fino a farli aderire, quasi, per una sorta di perversa conversione, alla logica distorta che li porta alla rovina<br />
fisica e mentale”. Lo spartiacque è ciò che allontana gli individui da sé, li chiama all’assurdo e li immerge ben sotto la superficie. Dopo, anche<br />
nell’ipotesi di un miracoloso salvataggio, un ritorno in extremis all’aria e alla luce, l’acqua è mutata. Il discrimine non è più individuabile, o non è<br />
più lo stesso.<br />
Il mondo cambia. Non concede di restare indietro. C’è l’intolleranza, c’è la sopraffazione. Ed accade che, per difendersi dall’odio, si finisca<br />
per essere<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
84
Su La stadera<br />
per essere costretti a odiare. Colpendo, di rimando, con armi fisiche e mentali. Anche se, nel profondo, si vorrebbe mostrare “odio per l’odio”,<br />
come recita il titolo di uno dei racconti più emblematici. La violenza maggiore è proprio questa: essere costretti a mutare, nel segno di un<br />
disprezzo che diventa inevitabile. La scelta è sempre tra due estremi: adattarsi o fuggire su sentieri ugualmente rovinosi. E qualunque sia<br />
l’opzione permane il dubbio dell’errore. La violenza, sugli altri o contro se stessi, è sempre orrifica, anche nel caso di una qualche forma<br />
sostanziale di “legittima difesa”.<br />
Il racconto Ate è uno dei più efficaci, a mio parere, anche in tal senso. Si colloca tra tensione e riflessione, azione brusca e dialogo quasi<br />
aristotelico. Contiene, forse, alcune chiavi di lettura di più ampio respiro. I bulletti che in un primo momento avevano deciso di malmenare un<br />
vecchio senza una vera ragione, chiedono, dopo essere stati attirati dalla potenziale vittima sul terreno aperto del dialogo verbale, del<br />
ragionamento: “Lei che cos’è? Un poeta, un ex giudice?”. La risposta è significativa: “Sono solo un dinosauro, che s’ostina a cercare il diritto<br />
scommettendolo da antiche storie”. Tutto ciò mi appare, seppure tramite adeguati ed efficaci filtri, come una proiezione dell’autore, e forse<br />
anche del lettore ideale di questo libro. Qualcuno che abbia ancora la voglia e la forza di scommettere sulla giustizia, nonostante tutto ciò che si<br />
sa, ed anche ciò che non è dato di sapere, a causa di puntuali insabbiamenti. Scommessa difficile come poche, ma, forse, come nel racconto, il<br />
passato, la memoria, la cultura, alla fine in qualche modo trovano una via di fuga e di sopravvivenza. Nulla cambia, certo. Ma rimane la<br />
soddisfazione di poter tornare, passata la bufera dell’arroganza e dell’ignoranza, a leggere, magari Eschilo, o qualche altra vicenda tra realtà e<br />
mito, continuando a coltivare il gusto del contrario, l’opposizione all’andazzo placidamente trionfante, quello che tollera, se non addirittura<br />
genera, l’idea che si possa, per noia, prendere a calci un vecchio che legge un libro su una panchina. Che tutto ciò sia possibile, legittimo o<br />
quasi, e, di sicuro, non grave.<br />
Ma, parafrasando il titolo di un altro racconto felicemente riuscito di questo libro, ad un certo punto ci si accorge che “gli ordini sono<br />
cambiati”, o, meglio, l’ordine è mutato, il modus vivendi. È cambiato o può cambiare, nonostante tutto. Il racconto appena citato è<br />
paradigmatico dell’intera raccolta, pur nella sua spiccata originalità. Innanzitutto, sotto il profilo stilistico, per la capacità di abbinare la<br />
stringatezza dell’espressione alla fluidità. Le frasi sono sintetiche, concentrate, e tuttavia corpose, ben tornite. La forma qui, ancora una volta,<br />
segue bene i contorni del contenuto, e, al contempo, li determina. La serena sinuosità lascia il posto ad un certo punto a un’aggressività tanto<br />
più incalzante quanto del tutto imprevedibile. Il racconto si colloca nella zona di confine tra cronaca minima e dimensione surreale, onirica, o<br />
meglio, da incubo che si riveste di realtà. Due tranquilli turisti d’oltreoceano, abituati ad essere trattati ovunque con i guanti di velluto, in virtù<br />
della loro potente valuta abbondantemente contenuta nei portafogli e nelle carte di credito, si ritrovano di punto in bianco in un luogo ostile,<br />
ferocemente contrario. Il racconto assume in sé il tema di fondo della giustizia per poi travalicarlo, facendolo slittare dal piano della<br />
responsabilità personale a quello più ampio dell’evolversi dei sistemi e delle gerarchie sociali e storiche. L’avvicendarsi dei destini dei popoli e<br />
delle nazioni, il mutare, lento ma inesorabile, di ciò che appare graniticamente consolidato. Tutto questo, chiaramente, ha ricadute sui singoli<br />
destini, sulle vite strangolate da meccanismi ancora una volta distanti e incontrollabili. Si parla di una Storia con la S maiuscola, futuribile<br />
scenario di amplissimo respiro, parlando di una mattina qualsiasi di una qualunque coppia di turisti, iniziata con una colazione che avrebbe<br />
dovuto e potuto essere ordinaria e rassicurante.<br />
Un racconto pregnante di significato, immaginato come un colpo fulmineo di pistola a cui fa da silenziatore un velo insistente di pioggia. Un<br />
racconto riuscito, Gli ordini sono cambiati, così come valida è la raccolta di Caccia nel suo complesso, grazie soprattutto al fatto che non è<br />
cambiato, il gioco di parole è invitante e consono, il modo di Caccia di fare narrativa: mantenendo sempre ben vivo il rispetto della lingua e del<br />
lettore, la coerenza, la volontà di raccontare storie non per un mero sfogo esteticheggiante ma per l’esigenza di confrontarsi con se stesso e<br />
con il gioco serissimo del falso e del vero, delle realtà e delle menzogne, di ciò che c’è e ciò che necessariamente si deve continuare a cercare.<br />
Un<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
85
Su La stadera<br />
Un libro sapido, di spessore, non facile, ma di certo, e per fortuna, non fatuo e volatile. Uno di quei libri che chiamano in causa il lettore,<br />
costringendolo a far corrispondere la propria bilancia mentale con quella di infiniti punti di vista e prospettive. Con i pesi e le misure di<br />
esistenze altre, aliene, eppure presenti, là fuori, sulle strade e nei vicoli, e nei sentieri mentali, i sogni e gli incubi di cui è composta quella cosa<br />
che ancora possiamo, dobbiamo e vogliamo chiamare vita.<br />
Ivano Mugnaini, “Poiein”, ottobre 2006<br />
* * *<br />
La stadera 1 è un volume di racconti, e come tale deve trovare un proprio territorio tra la narrazione pura, realistica se vogliamo, e il racconto<br />
a tesi. La stadera non è un libro di racconti a tesi perché l’autore non ha nulla da dimostrare: più che offrire soluzioni avanza infatti problemi,<br />
anzi li inventa per metterli sulla pagina: problemi etici, morali, filosofici attinenti al tema della Giustizia. Sono meccanismi narrativi in cui la<br />
narrazione dipana il problema, il suo sviluppo e la sua delineazione e, da questo punto di vista, è proficuo un accostamento ai problem plays di<br />
Shakespeare, con il loro tono amaro che ci dice che non vi sono soluzioni perché ad essere irriducibile è proprio la ricchezza umana; oppure, si<br />
rimanda alla labirintica lotta di Kafka, per cui la condizione umana, più che ricca, è paradossale e quindi una soluzione non c’è semplicemente<br />
perché non può esistere. Per restare in contiguità con il bagaglio culturale di Gianni Caccia, si può fare ancora riferimento al metodo socratico<br />
di continua interrogazione. Come dice Jerome Bruner “La grande narrativa è un invito a trovare i problemi, non una lezione su come risolverli!” 2 .<br />
Come che sia, siamo lontani anni luce dalla fiducia di un Voltaire nelle dimensioni logiche del Logos, cioè del linguaggio che rappresenta<br />
fedelmente la ragione: i racconti a tesi del filosofo francese, dal punto di vista narratologico, soffrono dal presentare personaggi che hanno<br />
l’unico scopo di illustrare il problema, e dall’avere meccanismi narrativi che quel problema soltanto espongono e risolvono. D’altro canto,<br />
Caccia è anche lontano dai narratori puri, tutti attratti dal fascino della storia e dei personaggi; certo, anche in loro, se siamo in presenza di<br />
autori veramente grandi, non possiamo non avvertire il premere di ben altro sotto la superficie della fabula, ma non è questo il loro intento<br />
principale.<br />
Il racconto breve di idee, a tema più che a tesi, che Caccia contiene qui entro le sedici facciate, deve essere una macchina perfetta: non<br />
sciupare energie, dare il massimo rendimento dal materiale ideazionale che sta bruciando, esibire assoluto controllo. Al termine, cioè, si deve<br />
avvertire il clic del meccanismo che è scattato. Il fine, e lo vediamo dagli esempi sommi di un genere spesso considerato a torto un<br />
sottoprodotto del romanzo, è quella perfezione che l’uomo può raggiungere solo in ambiti più ristretti del romanzo: in poesia, la stessa cosa<br />
può dirsi del sonetto contrapposto al poema.<br />
Se il Sé si costituisce sempre come racconto, se noi stessi non siamo che la congiunzione del racconto di noi fatto da noi stessi e dagli altri,<br />
allora è la continuità del romanzo ad essere debordante, inutile e falsa.<br />
*<br />
Un libro di racconti, se non è una semplice raccolta eterogenea ma ambisce a una superiore coesione e coerenza, deve esibire due<br />
caratteristiche distinte: la capacità di focalizzazione sul tema, o meglio sull’arci-tema, e una serie convincente di variazioni – detto altrimenti, e<br />
riecco i due poli della tensione tra narrazione pura e racconto a tesi: profondità della visione del tema e ricchezza delle soluzioni narrative, che<br />
non esauriscono comunque le (infinite) possibilità di dicibilità della vita. Gianni Caccia coniuga al più alto livello – e davvero sono in pochi a<br />
raggiungere questo risultato – questi elementi, e come prova anche la sua scrittura non è né un realista né un filosofo prestato alla narrativa,<br />
bensì uno scrittore che affronta un tema arduo e coinvolgente perché che ci tocca da vicino e lo fa con gli strumenti della narrativa: crea trame,<br />
inventa<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
86
Su La stadera<br />
inventa situazioni, personaggi, punti di vista. La gamma delle situazioni, ne La stadera, è amplissima, e davvero avrebbe poco senso riportare la<br />
trama dei singoli racconti, mentre è decisamente più utile scontornare quello che ho deciso di chiamare “problema”, il problema della Giustizia.<br />
Come visto, l’uomo non può conoscere, né quindi tantomeno applicare, una forma di giustizia oggettiva che sappia prima scindere colpa da<br />
responsabilità, e poi comminare la giusta punizione – perché la Giustizia è questa: non v’è riparazione al torto, come recita il verso di William<br />
Empson: “The waste remains, the waste remains and kills” (“Il torto resta, il torto resta e uccide”). Waste, in inglese, è sciupìo, torto, ma anche<br />
più concretamente lo scarico, ad esempio industriale. Il veleno, dice un altro verso empsoniano a conferma, lentamente riempie l’intera<br />
corrente sanguigna. Il giudice non può riportare in vita l’ucciso; ma neppure la ben più agevole restituzione del maltolto colma l’abisso che si è<br />
creato dopo l’errore, la colpa, il crimine.<br />
Il torto fatto è sempre inestinguibile, come sa bene lo Shakespeare di Measure for Measure, e nel mondo di Gianni Caccia non c’è<br />
appianamento del debito, e neppure soddisfazione: non possiamo infatti dire che i personaggi che “compiono giustizia da sé” sono poi convinti<br />
di avere rimesso le cose a posto, riequilibrando la stadera. Al massimo, si sono opposti per poco al naturale e tragico corso degli eventi; più<br />
spesso, hanno solo affermato il loro dissenso, guardandosi bene dall’aderire a una fede, come il protagonista di Confessione di un brigatista.<br />
Altre volte abbiamo invece di fronte l’idiota che viene eletto a capro espiatorio - idiota perché crede, ha fiducia nelle sue capacità logiche di<br />
comprendere la Giustizia: i due racconti abilmente messi in contiguità, Albanesi tutti appesi e Confessione di un brigatista ci danno l’ampiezza<br />
della gamma: il protagonista del primo, un “onesto” razzista, uno sconfitto privo di strumenti critici (si vedano le sue ossessioni politiche contro<br />
i comunisti, pp. 77, 82 e passim; il vero male nasce spesso dalla bêtise più che dall’intelligenza), si lascia coinvolgere in un gruppuscolo che,<br />
dominato dall’odio per i comunisti e gli albanesi, lo invia a massacrare una famiglia intera: cosa che lo sventurato, “il martire dalle belle idee” (p.<br />
87) fa, uccidendo anche una bambina che poco prima gli aveva toccato una corda di tenero affetto. Il brigatista della Confessione, invece, non<br />
aderisce tanto a un ideale, quanto a una spinta interiore, in fondo simile, alogica e acritica, che lo porta a ribellarsi, ma soprattutto a costruire<br />
una vita aberrante a partire da un singolo episodio che per lui fa paradigma: uguale l’acriticità, uguale la vocazione ad essere vittima, uguale la<br />
ferita interiore, ma diverso l’esito psicologico, perché il terrorista - che è ben più simpatico ed umano – non si pente: la sua Confessione,<br />
paradossalmente, non è penale perché non è basata sull’ammissione di una qualche colpa; è invece un tentativo di sviscerare il proprio Io, o<br />
forse persino l’autobiografia alla Sant’Agostino, ma di un nichilista.<br />
“Tempi cattivi hanno ancora da correre”: la sua pistola potrà ancora sparare, senz’altro quella del razzista no. Una differenza a monte: il<br />
primo dei due “giustizieri” (in fondo dei nichilisti inetti, come tanti personaggi in Caccia) è uno sconfitto e lo sa; il brigatista, prima della scelta<br />
improvvisa, è un tranquillo ingranaggio della macchina. Non è inopportuno sottolineare come il brigatista sia il personaggio più forte e riuscito<br />
del libro: emerge in tutta la sua problematicità attraverso un monologo che non solo crea un personaggio a tutto tondo, più che umano, ma<br />
che ricrea un periodo irrisolto della nostra storia recente, e lo fa con un insight originale e profondissimo.<br />
*<br />
Questi personaggi come altri sono stati colti da un meccanismo alieno, più grande di loro e incomprensibile, che in modo imperscrutabile li<br />
ha trasformati in vittime o in carnefici; o in giudici travestiti da carnefici, o viceversa. Una visione tragica e cosmica di stampo eschileo.<br />
I personaggi della Stadera quindi compiono spesso giustizia, o meglio si fanno giustizia da soli: c’è una ricca galleria di serial killer, psicopatici<br />
che “normalmente” riportano in equilibrio il fato, e che con la lucidità del folle si pongono tra “caso e necessità”, approfittando del primo e<br />
vivendo in piena schizofrenia la seconda: il furioso Kaspar Weininger di Autourghia, che massacra i colleghi di lavoro; il mite Oreste Nemi di<br />
Assassinio distributivo, che giustizia per antichi piccoli rancori solo perché caso e volontà si sono incontrati (“io ho raddrizzato la stadera”, p.<br />
49); il Ropa, che con “animo elementare” (p. 56, si veda il rimando al “martire dalle belle idee”, p. 87) concepisce una catena di delitti per<br />
tipologia;<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
87
Su La stadera<br />
tipologia; i due killer del Ragionamento del Bloody Mary, che in fondo uccidono perché “nessuno di noi può fuggire” (p. 71) e ammettono<br />
“pensa se, ad esempio, ci rifiutassimo” (p. 72); gli ex partigiani che proseguono anche dopo la fine della guerra una loro sete di giustizia ormai<br />
fuori tempo, quindi ingiusta; i teppisti di Ate, che in qualche modo non cadono – forse per ora – nella trappola.<br />
Pure, dice Caccia, questa è la norma, e questi personaggi, che davvero a caso si sono trovati davanti piuttosto che dietro la lama, hanno tutta<br />
la nostra simpatia, e solo in rari esempi – Alba Ostilio ne Il rovescio naturale – sono presentati come tanto antipatici da farci quasi gioire della<br />
loro sorte.<br />
In più punti, pur in presenza di un filo logico che congiunge i vari racconti, Caccia dimostra di non avere perso l’amore per il paradosso<br />
filosofico; vero, come si è visto tutto il libro è costruito sul paradosso della giustizia ingiusta, ma Il rovescio naturale va proprio citato per il suo<br />
gioco di equilibrio nel delineare una colpa senza responsabilità; una colpa che preesiste al personaggio e si incarna in lui; peccato originale,<br />
predestinazione, tragedia kafkiana... insomma, Il rovescio naturale è, con la Confessione di un brigatista, il punto più altro del libro; i due<br />
racconti, infine, costituiscono i due estremi del campo paradossale in cui si muove il libro, tra esigenza etica di una Giustizia superiore e<br />
inettitudine persino comica nel perseguirla – tragedia e commedia.<br />
I tre racconti finali presentano una novità, o meglio sembrano tirare le fila con una riflessione su un piano più alto che esorcizza la violenza e<br />
nel libro operano come un finale in tempo largo: i teppisti di Ate capiscono, o meglio vengono indotti a comprendere che c’è una giustizia<br />
superiore, quella che gli dèi hanno donato agli uomini con riferimento alla trilogia eschilea, specie alle Eumenidi; gli americani presuntuosi di Gli<br />
ordini sono cambiati vengono semplicemente dichiarati ospiti non più desiderabili nell’ex paese amico, e quindi ostracizzati; la Lettera dalla fine<br />
dell’impero, infine, chiude il libro su una nota pensosa, di grande spessore culturale ed etico che rimanda ai mala tempora currunt in apertura<br />
della Confessione di un brigatista: persino l’intellettuale del tardo impero romano, consapevole in qualche modo della direzione che sta<br />
prendendo la Storia, non può che vedere il futuro sotto forma di stereotipata corruzione e degenerazione, così da apparirci, al contempo e<br />
inscindibilmente, eroico e meschino.<br />
Un libro, insomma, che si spinge con coraggio e altissima perizia in territori inesplorati da tanto minimalismo mainstream. Senz’altro, dopo<br />
l’esordio originalissimo e per certi versi spiazzante di Aperture 3 e il deciso salto di qualità di La Vallemme dentro 4 , La stadera conferma Gianni<br />
Caccia come una delle voci più forti e originali della narrativa contemporanea.<br />
NOTE<br />
1 . Gianni Caccia, La stadera, Edizioni Joker, Novi Ligure 2006, pp. 176, € 14,00<br />
2 . Jerome Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 23.<br />
3 . Gianni Caccia, Aperture, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1994.<br />
4 . Gianni Caccia, La Vallemme dentro, Edizioni Joker, Novi Ligure 2000.<br />
Mauro Ferrari, Paradossi della giustizia (e della vita): La stadera di Gianni Caccia, da una presentazione pubblica, Novi Ligure, 2007<br />
fine<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
88
Da Anselmo, il locomotore color pompelmo, 2010<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
89<br />
x<br />
ANSELMO E L’ORA IN PIÙ<br />
Galeazzo non tardò a proporre Anselmo alla ferrovia di Carabattole come un gentile regalo, un locomotore in esemplare unico. Sulle<br />
prime i dirigenti erano restii ad adottare quella macchina dalla livrea così insolita, ma presto si ricredettero quando Galeazzo mostrò loro<br />
quanto Anselmo era capace: sarà stato pure di un colore poco adatto a un locomotore, ma non aveva uguali come accelerazione, velocità,<br />
tenuta in curva, capacità di trazione. Pertanto i dirigenti della ferrovia furono convinti ad accettare l’omaggio, dispiaciuti soltanto che il<br />
costruttore insistesse nel considerarlo una copia unica, irripetibile: sì, perché Galeazzo aveva mostrato solo le doti tecniche della sua<br />
creatura e aveva taciuto le altre, quelle particolari che in un locomotore, uno solo, aveva potuto infondere.<br />
Anselmo dunque incominciò il suo servizio presso la stazione di Carabattole e fin dal principio, data la sua unicità, fu impiegato per i<br />
compiti più diversi. Trainava treni locali, treni espressi, treni rapidi, treni merci, a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno, feriale e<br />
festivo, regolando le sue facoltà a seconda del viaggio che doveva compiere: lento e sornione con gli accelerati, più veloce con i treni<br />
diretti, un fulmine con i rapidi, potente e muscoloso con i pesanti convogli merci. E finito il suo dovere, si ritirava assieme ad altri<br />
locomotori nel deposito ai margini della stazione, dove riposava in attesa di un nuovo viaggio. Sempre regolare, sempre puntuale, mai un<br />
secondo di ritardo, si comportava egregiamente in tutte le situazioni, tanto che i macchinisti cominciarono ad apprezzarlo per le sue qualità<br />
e ad essere contenti se c’era lui in servizio. Talvolta sembrava loro che quel locomotore fosse un po’ speciale, non semplicemente un<br />
mezzo che andava su rotaie ma come dotato di sentimento, testa e cuore; e non sapevano quanto fossero vicini al vero.<br />
Un mattino, Anselmo doveva guidare un treno locale di lavoratori e studenti verso la città di Carabattole. L’arrivo era previsto per le otto<br />
in punto e già alla stazione di partenza tutte le carrozze si riempivano di passeggeri che si affrettavano a salire correndo lungo il<br />
marciapiede, per occupare i pochi posti a sedere ancora liberi. Era una bella giornata di primavera, il sole brillava ridente in un cielo azzurro<br />
sgombro di nuvole, ma nessuno sembrava guardarlo, tutti presi dai loro impegni giornalieri.<br />
Anselmo partì puntualissimo, uscì lentamente dall’intrico di binari della stazione, quindi prese velocità per la campagna tutta fiorita di<br />
alberi con il loro vestito di primavera, erba verde lucida, colori e profumi della nuova stagione. Ma ad un tratto accadde qualcosa di<br />
inspiegabile: Anselmo rallentò fino a fermarsi, dai carrelli spuntarono delle sbarre metalliche come delle zampette, e con quelle si allontanò<br />
dai binari per un bel prato di erba soffice, ancora bagnata, a lato della ferrovia, abbassò le sue antenne e andò a distendersi sotto un<br />
maestoso albero dalla grande ombra.<br />
I viaggiatori manifestarono sorpresa, stupore, ira.<br />
– Ma che cos’è questo? Un locomotore che molla il viaggio e se ne va per i fatti suoi?<br />
– Inaudito!<br />
– È una vergogna!<br />
– Che stranezza. Ma com’è possibile?<br />
– E ora? Come faccio ad essere al lavoro in orario?<br />
– E io devo andare a scuola! Come lo giustifico il ritardo?<br />
– E i macchinisti cosa fanno? E il capotreno?<br />
– Ehi, capotreno, fa’ ripartire!<br />
– L’avranno fatto apposta, per non lavorare. Ma mi sentiranno. Denuncerò la ferrovia!
Da Anselmo, il locomotore color pompelmo, 2010<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
90<br />
x<br />
Alcuni passeggeri cominciarono a inveire contro i macchinisti, i quali però non poterono che allargare le braccia e dire che non era colpa<br />
loro, ad un certo punto il locomotore non aveva più risposto ai comandi, si era fermato da solo e da solo si era staccato dalle rotaie ed era<br />
andato fin sotto quell’albero a sdraiarsi, e i loro tentativi di rimetterlo in moto erano stati inutili. Insomma, sembrava non ci fosse alcun<br />
modo per indurlo a ripartire.<br />
Vista la situazione, i passeggeri scesero un po’ alla volta dalle carrozze per sgranchirsi le gambe; videro finalmente la bella giornata, che<br />
prima non avevano considerato, il cielo azzurro senza nubi, il prato con i fiorellini e cominciarono a goderne. Qualcuno passeggiava,<br />
qualcuno coglieva i fiori, altri si distesero sull’erba o sotto gli alberi al limitare del prato dove riposava anche Anselmo, usando le giacche<br />
per cuscino; un bambino aveva una palla e improvvisò una partita di calcio, cui aderirono studenti e adulti in giacca e cravatta, gli zaini a<br />
terra come porte. Alcuni avevano con sé dei viveri, focaccia e biscotti e merendine, ne divisero con gli altri viaggiatori e organizzarono una<br />
gustosa colazione sul prato con le borse da lavoro come tovaglie.<br />
Passò così una parte della mattinata, quand’ecco Anselmo si drizzò sui bastoni metallici che fungevano da zampe, ritirò su le antenne e<br />
si riavviò saltellando verso la ferrovia; in breve si rimise sui binari, si riattaccò ai vagoni e lanciò un lungo fischio che segnava la fine<br />
dell’insperata vacanza. Era un fischio insolito, nel quale qualcuno credette di sentire come una nota di voce d’uomo. I viaggiatori si<br />
riscossero dalle passeggiate, dai picnic e dalle partite di calcio, e si affrettarono a raggiungere i loro posti sulle carrozze temendo che il<br />
treno partisse e li lasciasse a piedi lì, in piena campagna. Anche i macchinisti, che si erano distesi a riposare accanto ad Anselmo<br />
approfittando di quel piacevole fuori programma, balzarono su di scatto per raggiungere il locomotore; sarebbe stato buffo se a rimanere a<br />
terra fossero stati proprio loro! Il capotreno, che stava facendo capriole sull'erba con alcuni bambini, si rimise in fretta la giacca di servizio e<br />
con voce poco convinta gridò: – Tutti in carrozza! Si riparte! – E assieme agli ultimi passeggeri saltò al volo sul treno poco prima che questo<br />
riprendesse la sua corsa.<br />
Mentre il convoglio di lavoratori e studenti riacquistava velocità verso la stazione di arrivo, i viaggiatori tornavano alle loro normali<br />
abitudini.<br />
– È stato bello, sì, ma ora chissà che tardi!<br />
– E il tempo che abbiamo perso chi ce lo ripaga?<br />
– E che cosa racconto al lavoro? Che il locomotore se n’è andato per i fatti suoi a riposare? Mi prenderanno per matto!<br />
Ma quando guardarono l’orologio, tutti si accorsero con sorpresa e ammirazione che era esattamente l’ora in cui il treno si era fermato<br />
e il locomotore color pompelmo per qualche sua ragione aveva lasciato i binari: come se quel tempo nel mezzo non fosse trascorso, e fosse<br />
un di più regalato ai passeggeri perché si distendessero sull’erba e con calma passeggiassero, facessero colazione e giocassero con i<br />
bambini come bambini.<br />
– Che strano, non è passato neppure un minuto!<br />
– Forse abbiamo sognato.<br />
– Ma come! Sognato tutti insieme?<br />
– Comunque è stato piacevole. Ora vado al lavoro un po’ più contento.<br />
Mentre guidavano il locomotore, ora docile ai comandi, verso la città, i due macchinisti commentavano l’accaduto.<br />
– È davvero strano, non so spiegarmelo – diceva uno. – Ma sarebbe stato meglio non averlo avuto, il fuori programma. Questo<br />
locomotore può darci delle grane.
Da Anselmo, il locomotore color pompelmo, 2010<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
91<br />
x<br />
– Ma no, è stato divertente – diceva l’altro macchinista. – E poi, in fondo, non abbiamo perso nemmeno un minuto. Non è bello rilassarsi<br />
e ritrovare poi tutto il tempo intatto, come se non fosse passato? Questo locomotore ci ha fatto un bel regalo. È davvero speciale!<br />
Senza altre soste il treno arrivò puntualissimo alla città di Carabattole, dove i viaggiatori diffusero presto la notizia della fermata fuori dal<br />
tempo, ma per lo più non furono creduti, come di solito non si crede a un qualcosa di prodigioso e bello assieme. Il macchinista che aveva<br />
apprezzato il regalo di Anselmo non scese assieme al collega, ma rimase a scrutare i comandi come per scoprirvi un che di nascosto. Ad un<br />
tratto il locomotore lanciò un fischio simile a quello con cui aveva richiamato all’ordine dalla vacanza, quindi emise una vera voce d’uomo.<br />
– Ciao. Sono contento che la sosta sul prato ti sia piaciuta.<br />
– L’avevo capito, che non sei un locomotore come gli altri, ma non credevo tanto…<br />
– Io posso veramente molte cose, più di quanto tu creda. Perché possiedo lo spirito di bambino.<br />
– Lo spirito che cosa?<br />
– Imparerai. Chi mi ha costruito ha messo in me qualcosa di speciale, non solo di meccanico: lo spirito di bambino. Grazie ad esso mi<br />
adatto al treno che devo guidare e al viaggio che devo compiere, ma so anche parlare e ascoltare come voi uomini, capire e fare cose<br />
speciali come quella di oggi. Ho regalato un po’ di tempo a chi di tempo non sa più averne, e guarda sempre l’orologio come una<br />
maledizione. Io invece voglio reinsegnarvi a guardare un cielo azzurro di primavera senza nubi, l’erba verde trapunta di fiorellini, i campi<br />
dove rigermina la vita, e a divertirvi ogni tanto senza pensare che a divertirvi. Lo spirito di bambino è anche questo, e a te, che hai mostrato<br />
di apprezzare e capire, posso dirlo. Ma ricorda, non a tutti è concesso di conoscere il segreto del locomotore Anselmo. Solo a chi, come te,<br />
possiede un pizzico di quello spirito che è mio.<br />
– Non dubitare, Anselmo, terrò il segreto. E spero di avere altri fuori programma assieme a te.<br />
Il macchinista scese la scaletta del locomotore e si avviò per il marciapiede mani in tasca, soddisfatto: era sicuro di essere stato messo a<br />
parte di un grande segreto, e segretamente sperava di guidare tante altre volte quel meraviglioso locomotore color pompelmo.
Inediti<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
92<br />
x<br />
ALASKA RAILROAD<br />
Il mugghio dei motori saliva regolare, il fumo si attorceva in volute più nere contro il cielo che si faceva giorno, un ultimo spasimo come se fosse<br />
per scoppiare e infine la macchina gialla e blu mosse dal binario, districandosi tra la ragnatela degli scambi con il lungo treno di carri che la<br />
seguivano obbedienti, i carrelli tesi ad ogni scarto. Matthew Trotta anelava al tempo di essere fuori dal fumo attaccaticcio dello scalo, fuori dal<br />
grigiore basso dei capannoni, fuori dalla realtà, e prendere la via libera verso le foreste appena tagliate dalla ferrovia, verso le distese dove<br />
l’inverno si posava senza stagione, e poi più su, fino all’orizzonte inviolato dei monti che sagomavano il mattino.<br />
La neve insudiciata dell’uomo giaceva nera, ammonticchiata ai lati dei binari, ma piano piano la realtà si restringeva, si allentavano le maglie e<br />
finalmente Matthew Trotta poteva dare velocità sull’unico, interminabile binario; qualche stazioncina dove la rete si ramificava ancora un poco,<br />
forse doveva sostare per una precedenza, o incrociare qualche convoglio in manovra ma poi la ferrovia sarebbe stata di nuovo sua, fino all’ombra<br />
dei primi alberi che si avvicinavano, fino alle linee dei monti sempre più distinte nell’avanzare del giorno. Il piano di neve ai lati della ferita aperta<br />
dai binari pareva un cristallo sotto i primi, promettenti raggi del sole.<br />
Matthew Trotta godeva del borbottare sicuro dei motori che mangiucchiavano la strada senza premura, con la buona lentezza del treno merci<br />
che aveva eletto a sua vita. Il silenzio cupo degli alberi l’aveva accolto per un bel tratto e già intravedeva un’altra, profonda distesa di neve; un<br />
passaggio a livello con il tintinnio di monito che già lo inseguiva, un binario morto per pochi vagoni dimenticati nella ruggine e poi il candore di altri<br />
campi, altre foreste da trascorrere con la sua buona lentezza prima che fossero di nuovo uomini e merci, intrico di rotaie e neve infetta di<br />
fuliggine; non sapeva ancora, Matthew Trotta, che anche lì l’aspettava, nera come un’ombra dietro l’angolo, la realtà.<br />
Il rapinatore si era trovato la fuga sbarrata da quella maledetta fila di vagoni che procedevano irridenti, a passo di strazio, e solo un’inchiodata<br />
velenosa gli aveva evitato di finirci sotto; le sirene ululavano come cani famelici da qualche parte, tra poco potevano essere lì e quei vagoni non<br />
volevano più finire, vedeva le ruote scattare impercettibilmente in avanti come lancette che segnavano ore di condanna. Uscì di furia dall’auto<br />
lasciando la portiera aperta, alla sua sinistra il locomotore giallo e blu con la scritta cubitale sulla fiancata, poco avanti quel segnale rosso,<br />
irremovibile che sapeva di legge; e scelse.<br />
Matthew Trotta si preparava ad arrestare, appena seccato della fermata, quando la porta sbatté con violenza a fianco a lui e si vide puntata<br />
contro la realtà.<br />
– Non fiatare, quando ti danno il via guida come al solito. E non provare a giocarmi, ne ho già spedito uno all’inferno e ci metti niente a fargli da<br />
compagno.<br />
Le sirene si disperdevano, i cani famelici avevano smarrito le tracce e ululavano invano da qualche altra parte. Poco dopo venne il segnale<br />
verde.<br />
– Parti – ghignò il rapinatore accarezzandogli la faccia con la canna.<br />
Superato l’attimo iniziale di sorpresa, Matthew Trotta aveva recuperato in breve i soliti gesti e ripreso la marcia. Il locomotore sussultò appena<br />
sullo scambio, poi riguadagnò velocità nella pianura di neve che nessun sole avrebbe scaldato, la realtà a pochi centimetri da lui, aguzza come il<br />
freddo vitreo di fuori; i monti lontani incombevano senza conforto, nera la macchia di alberi che si profilava al termine del lungo rettilineo già<br />
leggera salita, dopo un accenno di curva. Dunque anche lì, dove meno l’aspettava poteva irrompere la realtà, mordere, braccare anche chi<br />
cercasse il tempo di esserne fuori; e ora la realtà aveva preso la forma oblunga e pestilente di un ghigno chiostrato di denti gialli e di una pistola<br />
che gli ripassava avidamente la guancia.<br />
– Te la fai sotto, eh?<br />
Spruzzi di saliva bagnavano il volto di Matthew Trotta, che fingeva completa attenzione ai comandi; sentiva su di sé tutto l’alito della realtà,<br />
quella realtà che era piombata a trovarlo proprio dove con buona lentezza aveva creduto di fuggirla, ma continuava a guardare alla via, a quel<br />
nero
Inediti<br />
Gianni<br />
Caccia<br />
93<br />
x<br />
nero di alberi che stava per inghiottire il treno, superato l’accenno di curva, ai contorni sempre più lontani dei monti.<br />
– Non l’avresti detto, vero?<br />
Il rapinatore inclinò bestialmente il suo ghigno, scivolandogli la canna dalla tempia al mento.<br />
– Tu fai il bravo, ma potrebbe non salvarti lo stesso.<br />
– Lo so – disse Matthew Trotta.<br />
– Ah, lo sai – ringhiava il rapinatore. – E allora saprai anche che sei in mio potere. In potere di questa – e indicò la realtà.<br />
Matthew Trotta torse il volto per fuggire l’alito di peste, scrutando il pannello dei comandi.<br />
– Pensa, è un attimo: io premo il grilletto e faccio saltare quella tua faccia di cazzo.<br />
– È lo stesso. Tanto non ho speranza – disse Matthew Trotta.<br />
– Può darsi che tu l’abbia, come no. Sono cose che non si possono sapere prima. Basta un dito tirato indietro, un attimo.<br />
– Non intendo questo – ribadì Matthew Trotta. – Io non ho mai avuto speranza.<br />
Il rapinatore raddrizzò un poco lo sguardo bovino.<br />
– Mai avuto speranza... forse vuoi cavartela con delle belle parole, ma non m’incanti. – Premette la canna della pistola sulla guancia. –<br />
Dovresti averlo capito, che non puoi fare il furbo con me. Basta un dito…<br />
– Intendo che quando uno non ha speranza mette in conto tutto, della realtà.<br />
– Anche che un colpo spappoli la tua faccia di cazzo?<br />
– Anche. Come qualsiasi altro imprevisto. Per esempio…<br />
– Per esempio cosa?<br />
– Una frenata brusca.<br />
Fu un attimo, come aveva detto il rapinatore. La mano di Matthew Trotta era già posata sul freno d’emergenza, e lo aprì del tutto. Le ruote<br />
stridettero mille scintille di rabbia sui binari, una mano gigantesca schiacciava tutto il treno sulla cabina di guida, come se tutti i vagoni volessero<br />
entrare, appiattirsi per una parte, anch’essi, di realtà. Matthew Trotta si aggrappò al mancorrente e si tenne in piedi, mentre il rapinatore finiva<br />
senza controllo sul quadro comandi.<br />
I motori borbottavano al minimo, tornati regolari e pronti alla marcia. Il rapinatore giaceva riverso sul pannello, doveva aver battuto nella<br />
frenata, non sapeva tutto l’imprevisto come Matthew Trotta, che se l’era cavata con un bel dolore al gomito; la faccia piegata innaturalmente di<br />
lato, gli occhi sbarrati su qualche strumento di bordo, un rigagnolo di sangue gli colava dalla bocca rimasta aperta nel suo ghigno, come un gatto<br />
finito sotto un’auto e toccato dal paraurti quanto bastasse.<br />
Matthew Trotta spalancò la porta del locomotore alla sua sinistra, sollevò la realtà dal quadro comandi e tenendola goffamente sotto le ascelle<br />
la spinse fuori. Il fantoccio inclinò di lato e rimase un attimo piegato in due sulla ringhiera, con le braccia e la testa ciondolanti nel vuoto, infine<br />
compì un mezzo giro su se stesso e rotolò per la massicciata, verso la bianchezza della neve che resisteva alla ferrovia; la realtà espulsa, eliminata<br />
dall’orizzonte che si rifaceva vicino.<br />
Con sapienza manovrò manopole e leve e ridiede pressione; qualche goccia di realtà bagnava ancora il quadro comandi, ma l’avrebbe rimossa<br />
presto con uno straccio. Il locomotore risalì di tono e buttò al cielo volute di fumo più spesse, poi la tensione si sciolse e ricominciò la sua marcia,<br />
tirandosi dietro la lunga scia di carri merci con la solita, tenace, buona lentezza.<br />
Matthew Trotta depose lo straccio appena imbevuto in un angolo del pannello; solo allora i suoi piedi toccarono la pistola. Si chinò a raccattarla<br />
e l’ultimo residuo di realtà volò fuori dal finestrino. Davanti a lui i monti, sempre più distinti nel sole, si facevano incontro a proteggerlo nel loro<br />
conforto inviolato.<br />
rimossa
Enzo Esposito. Senza titolo,<br />
tempera su carta
Massimo Gezzi<br />
94<br />
x<br />
È nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) nel 1976.<br />
È laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Bologna con una tesi sulla poesia di Bartolo Cattafi, vincitrice del<br />
Premio “Montale” 2002.<br />
Nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Pavia con una tesi sul diario in versi nella<br />
poesia del Novecento italiano.<br />
Come studioso si è occupato soprattutto di Bartolo Cattafi, Paolo Volponi, Giovanni Raboni, Antonio Porta, Eugenio<br />
Montale e le forme del diario nella poesia contemporanea.<br />
Tra i suoi saggi e scritti si ricordano, in volume: Porta marina. Viaggio a due nelle Marche dei poeti [peQuod, Ancona,<br />
2008 (con Adelelmo Ruggieri)], L’autocommento nella poesia del novecento: Italia e Svizzera italiana [Pacini Editore,<br />
Pisa, 2010 (con T. Stein)] ed il recente Eugenio Montale, Diario del ’71 e del ’72 (Mondadori, Milano, 2010).<br />
Collabora alle pagine culturali de “il manifesto” e a diverse riviste letterarie, tra le quali “Nuovi Argomenti”e “Poesia”.<br />
Come poeta ha pubblicato le raccolte Il mare a destra (Edizioni Atelier, Borgomanero, 2004) e L’attimo dopo (Luca<br />
Sossella Editore, Roma 2009, seconda edizione 2010, Premio “Metauro”, finalista Premio “Palmi”). È incluso nel Nono<br />
quaderno italiano, a cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, Milano, 2007) e nell’antologia Nuovi poeti italiani, curata<br />
da Paolo Zublena nel 2005 per la rivista “Nuova Corrente”.<br />
È recentemente stato pubblicato, per Transeuropa (Ancona), In altre forme (En d’autres formes/In andere formen):<br />
silloge di dieci poesie (otto edite e due inedite) in italiano, francese (a cura di Mathilde Vischer) e tedesco (a cura di<br />
Jaqueline Aerne).<br />
È tradotto in inglese (da Damiano Abeni, Moira Egan e Dave King), in spagnolo (da Emilio Coco), in francese (da<br />
Mathilde Vischer), in tedesco (da Jacqueline Aerne), in albanese e in croato. Nel 2009 ha vinto il Premio “Cetonaverde<br />
Poesia” (sezione giovani).<br />
Ha svolto l’attività di traduttore letterario dall’inglese per diverse case editrici.<br />
Nel 2006-2007, come poeta, è stato l’Italian Fellow in the Arts dell’American Academy in Rome. Nel 2010 è stato Fellow<br />
della Civitella Ranieri Foundation (CRF ’10).<br />
Nel 2007 ha organizzato la prima edizione della rassegna di poesia Feria d’agosto, e nel 2008 ha ideato e curato il ciclo<br />
di letture e incontri di poesia Venerdì poesia.<br />
Dopo aver vissuto e lavorato per diversi anni a Pavia e Roma, attualmente è assistente della cattedra di Letteratura<br />
Italiana dell’Università di Berna (Svizzera). Vive tra Sant’Elpidio a Mare e la Svizzera.<br />
Il blog di Massimo Gezzi: http://ilmareadestra.wordpress.com
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
95<br />
«Il miracolo è che il cielo<br />
non scivola di un dito, che il mare<br />
non trabocca nella conca<br />
su cui pende – questi colori,<br />
che in un piano segreto della mente<br />
sono cose, legano il nostro corso<br />
a uno stupore che continua:<br />
perciò dovete accorgervi<br />
che è tardi, che c’è da condividere<br />
il pane del linguaggio, la forza,<br />
la fatica – stiamo nel minimo<br />
tempo di un’eclisse: bisogna<br />
partire una volta per sempre».<br />
Da I<br />
C’è troppa notte quando<br />
il treno delle dodici e quaranta<br />
trascina i suoi bagliori sulla sabbia marchigiana,<br />
e Fano e Senigallia si illuminano<br />
appena, come per la lama<br />
di chiaro di una torcia: lontano<br />
le petroliere coltivano un brandello<br />
di luce, più netta di quella<br />
dei corridoi delle carrozze –<br />
noi scivoliamo nel sonno sordomuti,<br />
nella semioscurità siamo<br />
sagome di cose.<br />
La collina è una parentesi di steli,<br />
la luce del tardo pomeriggio<br />
anconetano la invita ad allungarsi<br />
negli occhi degli autisti, ad allagarne<br />
il respiro quando imboccano<br />
l’ultima curva della nuova superstrada –<br />
il grano è a quota venti, un giaciglio<br />
inespugnabile per gatti ed insetti, e spesso<br />
una festa di fiocchi di vento.<br />
Gli autisti la guardano, e nell’onda<br />
silenziosa ascoltano<br />
la terra rivolgersi e ruotare.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
96<br />
Il treno è visione laterale della vita<br />
(Marco Paolini)<br />
Il punto di svolta riposa<br />
sul primo gradino della scala: a terra hai l’aria<br />
soda e luminosa d’Adriatico nel naso,<br />
come poggi il primo piede sulla scala<br />
hai un sussulto. Le cose da fare<br />
allentano i lacci. Quelle all’altro capo dei binari<br />
sono bigie. Sul treno si rimane appollaiati<br />
sull’attesa. Si stringe una valigia<br />
ancora fresca di bucato.<br />
Poi la sfilata delle cose. Il conoscerle appena<br />
da uno sguardo tentato.<br />
Gli occhi si appigliano a un segnale autostradale,<br />
a un autobus, a un cespo d’oleandro.<br />
Tutto si allontana e lo sguardo<br />
pettina le colline, trascina via le nuvole<br />
dal punto di partenza verso quello d’arrivo.<br />
Lo stesso con il mare: a tratti siamo quasi<br />
a contatto con le onde. A tratti la luce<br />
scivola a battesimo degli occhi<br />
offuscati dal torpore. Li schiude alle scintille.<br />
Li muta in conchiglie<br />
dalle valve allentate.<br />
All’arrivo bisogna<br />
riprendere il bagaglio.<br />
Scendere un gradino è ricordarsi dello spazio:<br />
svegliarsi all’improvviso in una camera<br />
d’albergo oscurata a metà<br />
dagli avvolgibili abbassati.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
97<br />
Ancora un temporale stanotte,<br />
una giostra di baleni nel buio di prima estate –<br />
tutto è tranquillo di là: le spine staccate<br />
dalle prese di corrente, la tv<br />
ritornata in un silenzio minerale –<br />
le gocce bersagliano le siepi,<br />
scuotono un ventaglio di rami<br />
di oleandro, e sugli aghi<br />
dei pini si raccolgono in perle –<br />
io sono il solo a non temere<br />
il bagnato: lascio che il mio corpo<br />
affondi nel torpore, un piombo<br />
nell’acqua intessuta di ombre: nei giri<br />
del mio sonno la freschezza sarà<br />
la giusta ricompensa per la febbre del giorno.<br />
Piazza Carducci, una sera d’estate<br />
Un vento di risvegli dentro il treno,<br />
il faro della luce lampeggia<br />
ad ogni tunnel, e il gusto improvviso<br />
della gioia sulle dita, la mente che sfoglia<br />
la sua lenta processione di lampi, ognuno<br />
una stretta che tiene per i polsi:<br />
Bologna ieri sera<br />
cantava da sirena, le camicie<br />
sui balconi sollevavano le braccia,<br />
e dietro ogni persiana un bagliore<br />
diverso, una sagoma immobile o sparita<br />
al primo passo – ti ho chiesto di spiegarmi<br />
l’atlante di ritardi che ho cucito<br />
sul petto: mi hai mostrato<br />
un filo che tenevi nella borsa,<br />
l’hai riavvolto attorno all’indice, e prima<br />
che i lampioni si serrassero in un boccio<br />
sei sfuggita dalla presa, e la piazza<br />
ha richiuso il suo palmo di pietra.<br />
a Francesca F.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
98<br />
a Francesca S.<br />
Fuori dal finestrino del treno<br />
c’è quel fiume – non sappiamo<br />
quale fiume, io e Francesca:<br />
ci chiediamo cautamente<br />
se è il Po che scorre<br />
sotto il ponte di ferro nei pressi di Fidenza,<br />
più o meno, in direzione di Cremona –<br />
“È il fiume più grande d’Italia,<br />
è il Po”, trasale un’attenta<br />
compagna di viaggio:<br />
mi piace come ride Francesca<br />
di rimando – ha l’aria<br />
di averlo conosciuto da sempre<br />
quel nome, di dire «Che importa, guarda l’acqua<br />
come fila, come scattano gli uccelli<br />
annidati fra le canne al passaggio<br />
dei vagoni, come tutto procede<br />
in una sola direzione: il Po verso il mare,<br />
tu verso il nord, io qui di fronte<br />
verso te, verso il vento».<br />
Da II - Vinteuil<br />
[Daniele Groff, Daisy]<br />
Non era una città la cornice<br />
della voce finto-ruvido di Groff:<br />
Londra si stringeva<br />
in Sant’Elpidio a Mare, nella Punto<br />
immobile davanti<br />
al Bar della Stazione, ad attendere<br />
il passaggio di un’altra Punto bianca,<br />
misteriosa di sguardi –<br />
lo stampo intermittente<br />
delle luci di Natale, il parabrezza<br />
che sfilandovi al di sotto d’un tratto<br />
le deforma, nell’attimo in cui la radio<br />
manda l’ultimo affondo di concordia,<br />
e il tempo torna ad essere scandito<br />
dalla luce nel buio.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
99<br />
[Daft Punk, Around the world]<br />
«Ridicoli», diciamo, quasi<br />
in simultanea «gli omini mascherati<br />
da scheletro o da mummia» – l’epidermide<br />
di polvere dello schermo s’infittisce:<br />
il sole si incide sul tavolo<br />
più vivido, la casa poco a poco<br />
sta imparando il nostro odore –<br />
nella camera da letto i materassi<br />
riscoprono l’ingombro di due corpi:<br />
Elena mentre gode<br />
fa un rumore rabbioso –<br />
il quadro alla parete, papavero o che altro,<br />
custodisce la parentesi<br />
della nostra permanenza. Il lampo<br />
del televisore appena spento la cancella.<br />
[Angela Baraldi, Respiro]<br />
Io ti ho percorso più spesso di notte, Bologna<br />
che covi le tue strade alla luce di Settembre –<br />
e di notte schioccavano i tuoi portici<br />
al ritmo dei miei passi, o al respiro accelerato<br />
di un cane che trottava – poi veniva il silenzio<br />
(se gli strascichi degli autobus sparivano lontani),<br />
e il minimo clamore di un treno che andava<br />
a dividere l'aria ammantata di lenzuola.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
100<br />
In questa non so comprendere<br />
il movimento: la sera come il fiore<br />
abbandonato sul suo gambo eppure<br />
schiuso a corolla o a perimetro<br />
di bicchiere, dove passi le dita<br />
con moto regolare e fai<br />
accordi di ghiaccio teso –<br />
Trainspotting lo guardammo<br />
al cinema Rizzoli: usciti fingevamo<br />
di avercele anche noi le traveggole<br />
da drogati – invece sul tardi<br />
la notte non suonava di bicchieri<br />
o di chitarre: Bologna si avvitava<br />
su stessa, a malapena dava<br />
rochi rimbombi di barattolo.<br />
I suoni mascherati da passanti,<br />
da soffi d’aria fredda la mattina, o stillanti<br />
dalle punte dei tigli che in novembre<br />
gettavano le foglie per il transito<br />
dei merli, che adoravano acquattarsi<br />
in quei mucchi, nei cortili, mentre i nidi<br />
diventavano zavorre abbandonate,<br />
e i semafori dei treni tremolavano ma<br />
non avrebbero ceduto all’inverno<br />
come quelli.<br />
[Underworld, Born Slippy]<br />
[Deftones, Digital bath]<br />
E uno stupore di battimani,<br />
lancinato dal vapore che esalavano<br />
le bocche, uno stupore d’echi<br />
fini e sfrontati come lame<br />
di metallo – e la neve la neve<br />
la neve a confusione di profili<br />
e di sagome, a stringere<br />
le palpebre in fessure ed in grumi<br />
le dita – poche le istantanee del ricordo,<br />
e indelebili: come quella in cui passa<br />
Guido Guglielmi con le braccia<br />
conserte dietro la schiena, gli occhi obliqui<br />
di splendore al di là delle lenti, e un saluto<br />
di fiato a risalire verso il cielo.<br />
[Interno 17, Sottovoce]
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
101<br />
Da IV - Estinzione di una voce<br />
Il tempo dell’apprendere dal vento<br />
si calcola a ritroso, dal muoversi<br />
del ramo che spinge l’altro ramo si comprende<br />
che c’è stato un sorriso emerso dal tuo corpo,<br />
dalla stanza della casa in cui stipavi<br />
i coralli di gioia incrostati sugli oggetti –<br />
del passato rimane una sciabola di luce,<br />
una scia di trafitture sulla cornice<br />
di una foto, i fiori di metallo incastonati nel portone.<br />
Di sopra non vado, sono quello degli ingressi:<br />
preferisco gli odori che saranno sempre tuoi,<br />
il vapore dei capelli che asciugavi col fon –<br />
è un suono di estinzioni l’amarezza:<br />
il procedere dei passi sul pavimento<br />
della casa in direzione dell’uscita,<br />
soprattutto il riconoscerli<br />
fessure di schianti nel silenzio che si ricolma,<br />
unghiate dentro l’acqua inafferrabile e tutt’una.<br />
I cani moribondi si accostano<br />
ai muri che si stringono in strettoie,<br />
si appoggiano alle case in cui<br />
donne moribonde riposano inquiete,<br />
e cantano incuranti le note affrettate<br />
di Madama Dorè, e non vanno a tempo perché<br />
tutto il loro tempo si riduce a pochi metri<br />
del filo di un gomitolo nero –<br />
(e ne vedono il capo,<br />
ed avvolgono la matassa con pazienza<br />
e con lentezza, perché avvolgerla<br />
è cosa sicura, impegnativa).<br />
I cani<br />
hanno chiazze di malattia, o forse<br />
come rughe la pelle si deforma,<br />
gli occhi languiscono e diventano rossi,<br />
i latrati si mutano in grugniti disperati.<br />
Lo sanno di morire, lo sanno<br />
più degli uomini: per questo quando arriva<br />
il respiro che non possono ingoiare<br />
si rifugiano nei cespugli, o fra le ombre<br />
di un burrone.<br />
Rimane, della morte,<br />
un suono d’affanno: un canto<br />
strappato con impeto al silenzio<br />
duraturo. Anche la nonna cantava<br />
una romanza poco prima di morire:<br />
è la voce il ritratto più feroce<br />
da estinguere.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
102<br />
Su una musica, quasi un canto<br />
La cenere portata dal vento<br />
si fa sabbia, scivola lungo i vetri<br />
dei finestrini delle automobili,<br />
diventa chiarezza, si fa ultima<br />
chiarezza contro il buio che diluvia.<br />
Tu cosa pensi? Com’è nel tuo sguardo<br />
questa luce, questa perseveranza<br />
dei passi e dei mattini, delle cellule<br />
del corpo che si sfanno e poi rinascono?<br />
Non è facile mischiarsi con il vento,<br />
e nemmeno raccontarlo, questo vento<br />
che massacra e divide le impennate<br />
delle onde, che ti fa<br />
trasparire dall’assiduo andirivieni<br />
della luce sulle coste: stamani<br />
come esisti, come sbocci dall’estrema<br />
nitidezza dei suoni mattutini, come sei<br />
ritirata dentro il palmo della luce –<br />
io vado per i vicoli e le strade<br />
del porto, e mi chiedo se sei almeno<br />
questa nebbia di spume.<br />
un fischio, un segno di riconoscimento<br />
(Eugenio Montale)<br />
Non so se la tua voce sia già estinta,<br />
fra i muri intricati che il nostro<br />
consueto labirinto di giorni<br />
cuce intorno: so solo che mi resta<br />
come un suono familiare, l’identico<br />
rumore del portone di casa aperto<br />
dopo mesi passati lontano.<br />
Ma il tempo ormai si è rappreso<br />
in una sfera, lacerata da crepe<br />
più lunghe di noi, e non è<br />
la trama dei tuoi capelli quel rivolo<br />
di ombre: è l’ombra<br />
della mia mano che la distanza<br />
ha reso enorme.
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
103<br />
Da V - Scendere e cercare<br />
Cannone era il vecchio<br />
pescatore del Lido: aveva il dente d’oro<br />
e le rughe attorno agli occhi, che di sera mandavano<br />
lampi di chiaro – Cannone partiva<br />
ogni santa mattina, con la barca di legno<br />
e il motore venticinque – tornava soltanto<br />
col retino strapieno, mentre noi<br />
stentavamo a tirare due pesci.<br />
Morì in mezzo al mare, stroncato<br />
da un infarto. Lo trovarono appeso<br />
al fianco della barca, una mano<br />
aggrappata allo scalmo del remo<br />
ed il resto del corpo già teso, nell’acqua.<br />
Dicono che non c’erano ombre<br />
di sorriso sul suo volto. Infatti nel retino<br />
non trovarono pesci.<br />
Un attimo di calma: lasciare<br />
che la ventola del computer<br />
sospiri il suo rantolo nel vuoto<br />
della stanza – uscirsene fuori,<br />
guardare il vicino che spala<br />
la neve, sentire<br />
il rumore metallico del ferro<br />
sul cemento. Due passeri in volo<br />
confondono l’aria.<br />
Io penso: se non ci fosse gravità<br />
sarebbe tutto tormenta.<br />
Il sedile della macchina apprende<br />
il profilo della schiena –<br />
sul tasto alzacristalli si compone<br />
una nuova ragnatela di impronte digitali.<br />
Da qualche tempo anche il mio corpo<br />
si diverte a somigliarti: porto la tua musica<br />
di respiri nel sonno insieme a me,<br />
il calore del tuo palmo contratto che si schiude<br />
come un fiore, mentre tu ti addormenti.<br />
A Daniela
Da Il mare a destra, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
104<br />
...ma<br />
nella mia casa c’è un sollievo di pellicola,<br />
il vuoto aggalla come il tondo<br />
fluorescente sopra l’amo, il vuoto,<br />
il silenzio di sasso che non si dirada –<br />
(fossimo piante per lo meno<br />
tratterremmo nel profondo il gocciolio della linfa,<br />
non il solido ossario delle cose, il marmo<br />
dei pavimenti) –<br />
A volte la sera sembra incline a spalancarsi.<br />
Poi lo schiaffo dei treni lungomare,<br />
le palpebre sfrangiate dei pipistrelli sui lampioni.<br />
Le cose che tornano a covare le cricche<br />
che improvvisamente le schiantano in due.<br />
Congedo da riva e orizzonte<br />
And out of the swing of the sea<br />
(G. M. Hopkins)<br />
Ma a che cosa potranno servire questi segni?<br />
I muri non salgono, non ci sono<br />
nemmeno i mattoni. Il treno ogni volta<br />
aspetta alla stazione, ma il viaggio<br />
si è fatto meccanico, percorso prevedibile<br />
da ripetere a mente. Il carillon delle stagioni<br />
riporta le sue musiche autunnali: ieri notte,<br />
mentre ci amavamo, una ipnotica grandine<br />
di gocce ripeteva i nostri nomi,<br />
e una vampa di pioggia colorava<br />
di spessore l’arancione dei fanali.<br />
Anche per la pioggia meraviglia. Anche<br />
per la quiete momentanea di una stanza,<br />
prima che il mare a destra ritorni<br />
a tracciare sul vetro le sue ostinate<br />
due righe di saluto.<br />
NOTA. VINTEUIL.<br />
La riemersione mentale di un cronotopo dettagliato durante l’ascolto (a distanza di qualche tempo) di brani musicali che hanno accompagnato spezzoni più o meno lunghi della<br />
nostra esistenza è la molla che ha generato questa sezione. Il fenomeno richiama immediatamente alla memoria molte pagine di Proust. I brani indicati a margine (quasi<br />
andassero on air nel mentre che l’autore scrive e il lettore legge) sono alcune delle canzoni che duranti i miei anni universitari bolognesi le tv musicali, su cui troppo spesso ci si<br />
sintonizzava nelle pause o durante i pasti, diffondevano ossessivamente per brevi periodi, per poi cedere il posto alla cadenza altrettanto coattiva di un’altra hit.. Altre, magari<br />
orribili (come Luna di Togni per il Tondelli di Pao Pao…), ebbero la ventura di capitarmi nelle orecchie (o davanti agli occhi, nella forma d’arte sempre più arguta che è il videoclip)<br />
in alcuni momenti particolari, rimasti impigliati nella memoria e nei testi che le danno voce. Talvolta (Oh, eravamo in riga…; «Ridicoli», diciamo, quasi…) i versi si riferiscono<br />
esplicitamente alle scene dei videoclip delle canzoni richiamate in esergo.
Su Il mare a destra<br />
[…] In un ritmo esatto e misurato, carico di una tradizione metrica persuasiva, egli sa come offrirci tracce liriche immerse in una semplice ed<br />
effettiva condizione “pop”, incarnandosi - temporalmente - in un dettato poetico geneticamente generazionale. […]<br />
Stefano Raimondi, “Pulp”, 51, Settembre/Ottobre 2004<br />
* * *<br />
[…] L’atteggiamento predominante di questo giovane poeta e critico originario di Sant’Elpidio a Mare, che per ragioni di studio è vissuto a<br />
Bologna ed attualmente risiede a Pavia, è quello dello “stupore” e “meraviglia” nei confronti del reale che, montalianamente, si manifesta per<br />
“lampi”, “baleni”, “brandelli di luce”. Il paesaggio di colline digradanti sul mare, filtrato dal finestrino d’un treno in corsa o dall’interno d’una<br />
stanza, nel “silenzio minerale” prima del sonno, oppure Bologna, città della prima giovinezza, percorsa di notte, tra clamori lontani dei treni e<br />
“rochi rimbombi di barattolo”, sono attraversati da una luce intermittente che staglia le cose nel buio, le deforma, le rende incandescenti. “A<br />
tratti la luce / scivola a battesimo degli occhi / offuscati dal torpore. Li schiude alle scintille. / Li muta in conchiglie / dalle valve allentate”: è<br />
questo “chiarore che addormenta”, questo stato di dormi-veglia (parafrasando il titolo della raccolta d’esordio e d’una sua sezione) ad acuire la<br />
disposizione percettiva di Gezzi, a determinare quello stato di sospensivo distacco nel quale può rivelarsi il “miracolo” della vita nella sua<br />
essenza. Ad un tratto lo sguardo ritrova l’innocenza infantile per cui le cose stupiscono per quello che sono: il cielo che “non scivola di un dito”,<br />
il mare che “non trabocca nella conca”. Qualcosa di simile al disvelamento montaliano dell’”inganno consueto” che però in Gezzi determina una<br />
sorta di inebriamento e d’incondizionata adesione alla vita. Di fronte ad un mondo che esiste davvero e che rischiara con i suoi abbagli, “uno<br />
stupore che continua” muove Gezzi alla ricerca di un ponte con l’altro nel tentativo di risvegliare le coscienze e d’avvicinarle al “miracolo”.<br />
L’invito è a “partire una volta per sempre” da sé, dai propri limiti e ad adoperarsi con forza e con fatica: sarà la capacità di condividere il “pane<br />
del linguaggio” a decidere della possibilità d’accedere alla “festa” dell’esistenza, di cogliere il “minimo tempo di un’eclisse”. […]<br />
Il mare a destra è unito attorno alla metafora del transito, dell’essere in partenza: da un luogo originario in cui non è dato risiedere se non per<br />
istanti, in una distanza anche impercettibile (“la mente che sfoglia / la sua lenta processione di lampi”; “sono quello degli ingressi”), dal tempo<br />
della giovinezza, dalla Bologna notturna che “schiocca i portici al ritmo dei passi”. Nella seconda sezione, Vinteuil, è il tentativo di recuperare il<br />
proprio mondo perduto, sul flusso di brani musicali di quegli anni, nel torpore ipnotico dei videoclip.<br />
Il passato remoto o l’imperfetto, il presente dilatato e scisso dall’attesa, sono il tempo di questa poesia, a conferma d’un tremito d’ansia, d’una<br />
paura che forse la disposizione cordiale e la forza di volontà possono soltanto allontanare. “perché non è immobile ciò che non si muove / ma<br />
cova, è pronto allo scatto”: ma fin dove è radicato il “sì” di Gezzi? Perché poi il vuoto “aggalla” “fluorescente” “come un’esca nella notte” e le<br />
cose, per quanto le solleciti lo sguardo, “covano” “le cricche / che improvvisamente le schiantano in due”. A cosa dunque può servire la poesia?<br />
L’interrogativo apre l’ultima lirica del libro, e la sua risposta Gezzi la dà nei versi conclusivi: “Anche per la pioggia meraviglia. Anche / per la<br />
quiete momentanea di una stanza, / prima che il mare a destra ritorni / a tracciare sul vetro le sue ostinate / due righe di saluto”. Forse la<br />
strada più promettente in cui incamminarsi oltre il Novecento è nell’abbandono dello sguardo alla sequenza della vita, al suo miracolo, per<br />
ritrovare “il segreto entusiasmo di chi parte”.<br />
Franca Mancinelli, Uno stupore che continua, “Pelagos”, VIII, 10, 2004<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
105
Su Il mare a destra<br />
[…] Leggendo Il mare a destra si sente, con forza, l’appartenenza di Gezzi ad una koinè poetica alta ed internazionale. Si tratta di quel connubio<br />
di accumulazione, finezza metrica (con punte di understatement che non sono sciatte, ma rappresentano, montalianamente, il rovescio della<br />
medaglia) e allusività (anche nella narratività) che, in generale, può appartenere a Raboni come a Miłosz. Il libro ha pochissimo dell’opera prima<br />
e, di conseguenza, pochissime tracce di una gioventù standard (né di giovanilismo) […]<br />
Massimo Sannelli, Provincia e koinè, “microcritica”, 04/02/2005<br />
* * *<br />
[…] …ad ogni ripresa di lettura, scorgo, in queste intense poesie dell’autore marchigiano, un volto e una forgiatura diversi, come se, da un<br />
avvicinamento all’altro, nottetempo mi verrebbe da dire, qualcosa mutasse nei testi letti la volta precedente. Io credo che questo accada<br />
perché Gezzi, avendo dalla sua una forte personalità narrante, riesce a germinare nel lettore i diversi piani di una identica contingenza. […] Le<br />
caratteristiche di Gezzi sono almeno due. Una, sul versante della personalità, è quella che consiste nello scendere negli angoli più riposti della<br />
coscienza e della sua auscultazione: egli è decifrabile nel proprio rilevare i grumi esistenziali, proprio come farebbe un contabile di partita<br />
doppia, oppure il chimico che pone sul tavolo del laboratorio i minimi lacerti delle rare sostanze dell’animo umano. […] La seconda peculiarità<br />
del nostro autore in questione viene decifrata sul versante della struttura ed è l’accumulo - vuoi di particelle grammaticali (le numerose<br />
preposizioni, semplici e articolate, che evitano una più fitta aggettivazione), vuoi di luoghi, di pensieri e di tutta un’oggettistica quanto mai<br />
interessante -. […]<br />
Gianfranco Fabbri, Una poesia senza steccati generazionali, “la costruzione del verso & altre cose”, 24/02/2005<br />
* * *<br />
[…] Pagina dopo pagina, mi sono confermato nell’idea che dall’affermazione di Gezzi sul “peso” dei luoghi si potesse risalire a quella presenza<br />
[Sereni] tra i suoi punti di riferimento. Basti dire che la trafila isotopica che governa il libro è quella del viaggio (fin dal titolo, per cui si veda la<br />
poesia che conclude), e che la modalità di pronuncia fondamentale è l’interlocuzione (il libretto pone in limine il discorso virgolettato di una<br />
seconda persona): esemplare la bella poesia che sigilla la prima sezione, dove è messo in scena un dialogo (anche di sguardi) a tre in uno<br />
scompartimento ferroviario [...] Ma si dovrà specificare che il viaggio conta qui in quanto modalità dello sguardo, come si ricava dalla gnome di<br />
Marco Paolini – “Il treno è visione laterale della vita” - collocata in epigrafe di Il punto di svolta riposa ma idealmente riposizionabile ad insegna<br />
del libro [...].<br />
Rodolfo Zucco, “Poesia”, 191, Febbraio 2005<br />
* * *<br />
[…] Uno dei caratteri salienti della poesia di Gezzi è il sapersi tenere in una bolla di emotività tenue e riflessiva, in cui i fatti, spesso della più<br />
ordinaria, e per questo stupefacente, normalità si librano in un’ariosità lirica. Da ricordare in modo particolare la seconda sezione del libro,<br />
Vinteuil, per il tentativo, spesso decisamente centrato, di fare poesia con i miti d’oggi, qua certi gruppi della pop-music degli anni ‘90. […]<br />
Flavio Santi, “Pordenonelegge.it”, 04/03/2005<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
106
Su Il mare a destra<br />
[…] È un esordio notevole, questo del marchigiano men che trentenne Massimo Gezzi: […] ciò che precipuamente colpisce nel suo Mare a<br />
destra (prospettiva per così dire ontologica per un marchigiano che in treno si muova verso nord), è la necessità della strutturazione interna e<br />
l’essenzialità selettiva dell’insieme, ripartito in cinque parti, per un computo complessivo di trentotto testi […]. Il libro prende un felicissimo<br />
colpo d’ala con il suo secondo capitolo (dal bel titolo di omaggio a Proust, Vinteuil), quando entra in scena Bologna in quanto sede del<br />
formativo e dell’umano, in chiave dialogica e musicale, visto che ogni testo reca l’intestazione di una canzone e dei suoi interpreti. Ed è questa<br />
innanzi tutto la soglia oltrepassando la quale l’io poetante comincia a (ri)costruire la propria realtà intesa anche come esistenza vissuta dentro<br />
una contemporaneità propria, dunque come presenza e come percezione finalmente in atto, vitale, dotata di spazi e di tempi commensurabili,<br />
rapportabili, definibili per nome. Vale a dire che è la soglia obbligata per cominciare davvero a percorrerlo, in carne e ossa, con la propria storia,<br />
i propri fantasmi e i loro frammenti di voce, quell’inferno da cui alla fine scaturisce la conquista di un noi che suona anche liberatorio, tutt’altro<br />
che nichilista, assieme amoroso e generazionale (il “noi” è davvero il pronome più difficile da pronunciare credibilmente in poesia e Gezzi riesce<br />
a farlo in modo per una volta autentico): “Neanche un sogno avevamo, neanche / un progetto per cambiare le cose. / Da allora tutti i giorni<br />
custodiamo / con amore il nostro comune / cimitero di abbagli”. […]<br />
Alberto Bertoni, “Atelier”, 37, Marzo 2005<br />
* * *<br />
[…] Innanzitutto, Gezzi ha la mano sicura nella frase predicativa, come nell’attacco “La collina è una parentesi di steli”, o “Il punto di svolta<br />
riposa / sul primo gradino della scala”. Poi ha un forte senso della “cosalità” del mondo, se ci si passa il prestito dal vocabolario filosofico. Non<br />
solo perché pare affascinato dalla parola “cose” […], ma perché la sua poesia è fortemente oggettuale, sostantivale, piena di res extensa, che<br />
sia fatta di elettrodomestici (come la televisione spenta che rientra in un “silenzio minerale”), treni, navi, elementi del tempo atmosferico,<br />
piante e animali (come le api che rimangono “rattrappite nelle celle”), e città (Milano, Cremona o Bologna), che Gezzi riesce a cogliere con una<br />
punta di stupore, di senso del meraviglioso, come quando le strade milanesi in movimento gli si trasformano in un bastimento dove uno<br />
sterminato equipaggio si mette ad un tratto a sciogliere tutte le funi possibili. Gezzi ha la capacità di far alzare i suoi versi, di metterci sotto quel<br />
tanto di vento che basta ad alleggerire la pagina sulla quale sono stampati. Anche certi dettagli minori di vita quotidiana (una macchina<br />
parcheggiata davanti alla stazione, una serata in discoteca, un’istantanea di Guido Guglielmi che passa in una via di Bologna “con le braccia<br />
conserte dietro la schiena”) sono sottoposti alla torsione di un piccolo vortice di vento sufficiente a trascendere la loro mera presenza. […]<br />
Alessandro Carrera, “Gradiva. International Journal of Italian Poetry”, 29, Spring 2006<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
107
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
108<br />
Poi ci fu una scossa repentina,<br />
e i muri cominciarono a frantumarsi<br />
e a spaventare gli insetti che ci vivevano dentro.<br />
Non c’è più lavoro, ci dicevano<br />
sorridendo, non ci sono più affetti<br />
capaci di farci amare queste sedie, queste mura,<br />
il silenzio che si ascolta parlare solo quando<br />
percepisci il tempo scorrere, o ricordi qualcuno.<br />
Bisognava replicare,<br />
fare in fretta le valigie stipandoci<br />
i lampi della piattaforma, il profilo delle colline,<br />
la camera a tre muri attraversata dai rintocchi,<br />
la città sconfinata e le stanze di neve.<br />
Viene ogni volta come un vento di mare,<br />
perdono o condanna,<br />
che ci fa salde le spalle e ci infiamma<br />
di dolore, a cui bisogna obbedire, dire ancora sì,<br />
mentre strappa i nostri volti sopra i muri che salpano.<br />
Da L’attimo dopo - I<br />
Perché nel sottinteso<br />
della nota che scandisce<br />
il tempo quotidiano c’è un enorme<br />
rumore di battiti, una schiera<br />
di persone che a quel suono<br />
hanno spento i fornelli, inchiavato<br />
un lucchetto, pigiato i nove numeri<br />
che compongono un recapito –<br />
questo ripetono<br />
i colpi di campane: che il tempo<br />
sono occhi e mani che si stringono,<br />
voci di lontano che dicono<br />
un saluto, il duplice flusso<br />
del sangue nel corpo…
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
109<br />
Reperti<br />
Nella terra si leggono moltissime<br />
vicende, mi accorgo mentre faccio<br />
un sentiero di campagna che non avevo<br />
più percorso: i tronchi segati al pari<br />
del terreno resistono per secoli;<br />
qualche volta riaffiora un oggetto<br />
che pare extraterrestre, tanta è la distanza<br />
che lo separa dal presente. Un giorno, per esempio,<br />
ho trovato nel piccolo giardino<br />
antistante la mia casa una macchina<br />
per cucire in miniatura, ciarpame o giocattolo,<br />
nera e scrostata ma del tutto<br />
conservata, che a pulirla avrebbe dato<br />
un’eleganza démodé ad un mobile<br />
antico. Più di rado si rinvengono<br />
coriandoli di carta, a volte di giornali pornografici,<br />
altre di firme e scritture impronunciabili,<br />
slavati dalle bave o rifilati<br />
da chissà che mandibola paziente.<br />
Io so anche dire<br />
dove sono tumulati i miei due cani, bianchi<br />
e poderosi, seppelliti da mio padre<br />
dopo anni di passeggi serali<br />
e di carezze. Chissà cosa resiste, adesso,<br />
di quei corpi, se i lunghi filamenti del pelo<br />
o le zanne dei canini, oppure se è come<br />
se non fossero affatto transitati<br />
in quella terra, stinti del tutto, divorati da insetti<br />
che magari avrò schiacciato senza troppa<br />
attenzione, non capendo che nel cric<br />
di quegli scheletri echeggiava il guaito<br />
familiare dei miei cani, la saliva che lasciava<br />
minuscoli globi più scuri del cemento,<br />
brevi costellazioni evaporate<br />
in un secondo, subito sparite in altre forme<br />
anche loro.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
110<br />
Sul molo di Civitanova<br />
La propaggine del molo finisce<br />
con cubi di cemento ammassati<br />
e sconnessi. Camminarci viene male,<br />
bisogna proseguire per oblique<br />
pedane, attenti a mantenersi<br />
in equilibrio ad ogni salto –<br />
dietro il mare cerchia<br />
tre punti cardinali di un azzurro<br />
abbagliante, più lucido del cielo<br />
bucato dalle nubi – siamo ancora quelli<br />
che camminano a fianco, attenti a capire<br />
quali esche si impiegano<br />
per prendere le mormore, quali per i gronchi,<br />
che appena rovesciati nei secchi<br />
si contorcono – questa estremità<br />
non smette di insegnarci a guardare<br />
sempre meglio: un giorno la maretta<br />
intorbida le acque, il giorno dopo<br />
riesci a indovinare il cormorano<br />
mentre caccia e si appuntisce<br />
sfrecciando sotto il pelo.<br />
Non è mai finita, penso mentre guardo<br />
i tuoi capelli rovistati dal grecale:<br />
finché non muore tutto<br />
c’è speranza di risolverlo il dilemma<br />
che mette il segno uguale tra vita<br />
e non vita, in quest’angolo di porto occidentale<br />
che ogni volta è se stesso ma insieme<br />
è anche altrove, e per caso non coincide<br />
con il luogo dove gli uomini vendono<br />
tutto per fame, e i bambini si divertono<br />
a scavare le macerie – ci è dato questo spazio,<br />
questo minimo orizzonte<br />
di cose quotidiane: il lavoro,<br />
la visita agli amici che diventano<br />
più seri e fanno figli, la fede<br />
nel frenetico farsi delle foglie<br />
appena apparse – non credere in noi<br />
sarebbe il crimine maggiore,<br />
mi dico mentre godo il primo sole<br />
sugli occhi: come perdonarsi<br />
dell’altro è il rovello<br />
che il rauco saluto del mare non calma.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
111<br />
Il seme del tiglio<br />
Mentre aspettavo l’autobus guardavo<br />
le ondate di semi dei tigli<br />
piovere sull’asfalto dopo un volo<br />
di pochi metri: non attecchiranno,<br />
le ruote delle auto li schiacceranno<br />
in polvere finissima che la terra<br />
assorbirà, con le piogge di settembre.<br />
Mi stupivo del loro ingegno, del piccolo<br />
velivolo naturale che li sovrasta<br />
e li accompagna, nella discesa verso un tempo<br />
che non vedranno mai.<br />
La sera rincasando in automobile<br />
ho sentito qualcosa scivolarmi<br />
dai capelli: e su un braccio mi è atterrato<br />
uno di questi semi, con le ali<br />
acciaccate e il peduncolo piegato.<br />
Peccato che non fossi<br />
un bisonte di prateria, o un’antilope<br />
che a balzi attraversa le montagne:<br />
in uno scatto della corsa avrei deposto<br />
il seme annidato nel mio pelo<br />
in terra fertile. Invece sono un uomo<br />
di città, e a poco è servita<br />
la sua breve traversata, se adesso<br />
abbandono quel chicco sul terrazzo,<br />
sperando in qualcosa di più utile<br />
di me, in un vento.<br />
Da Mattoni – II<br />
Direzioni<br />
Certe direzioni sono modi<br />
improvvisati di restare in equilibrio<br />
gesti istintivi comandati da un niente.<br />
Per questo le traiettorie precise<br />
sono cose da aeroplani, da stormi in migrazione<br />
che capiscono il vento. Gli uomini onesti<br />
non dicono io vado: cantano pianissimo<br />
se una strada li porta, se una curva spalanca<br />
un mare abbagliante.<br />
Domande<br />
Piove da due giorni: la tenda degli scrosci<br />
si infittisce e si dirada,<br />
ma ininterrottamente si propaga<br />
la sua nuvola d’acqua. La ragazza<br />
stringe una tazza bianca, da cui sale<br />
un fumo chiaro. Sorseggia lentamente,<br />
tiene il sorso nella bocca prima di spingerlo<br />
in gola. Si chiede se la pioggia<br />
rappresenti un nuovo stato, se tirando<br />
le radici di un luogo le scopriamo<br />
infinite. Si abita così, credendosi per sempre.<br />
Lei beve a sorsi brevi, nel pensiero raccoglie<br />
i frammenti dei volti, si domanda<br />
perché mai con la pioggia<br />
rifioriscano i ricordi.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
112<br />
Marco Polo, 32 anni dopo<br />
Le linee verticali della grata,<br />
le linee orizzontali della tenda<br />
di alluminio: tutto qui<br />
la cornice di una cronaca<br />
che porta non so dove, nel fiume della storia<br />
o nelle secche dei sogni. Calvino scriveva<br />
che la sfida al labirinto è un lavoro<br />
da cartografi – io mi trovo qui:<br />
è tutto quel che vedo,<br />
nel baratro di un tempo<br />
che gioca con la carne e pone a zero<br />
la dignità delle persone, barattando<br />
torture per decapitazioni –<br />
non credere a nessuno: il fatto<br />
è che l’orrore è il solo prezzo<br />
quotidiano da pagare perché il mondo<br />
continui. Il bene è annidato<br />
in isole invisibili – ma se scavi e riscavi<br />
non trovi che altro inferno: niente<br />
sotto il niente quadrato dello scacco.<br />
NOTA<br />
In un saggio sull’autocommento, Fabio Pusterla racconta le<br />
difficoltà incontrate dai suoi studenti dell’Università di Ginevra nel<br />
decifrare il titolo e le circostanze alle quali si allude in questa<br />
poesia. Uno degli studenti, aggiunge Pusterla, si dimostrò<br />
abbastanza seccato dal fatto che ci si dovesse lambiccare il<br />
cervello per capire che il titolo fa riferimento al protagonista de<br />
Le città invisibili di Italo Calvino, uscito in prima edizione nel 1972,<br />
ovvero 32 anni prima della composizione della poesia. Chi parla,<br />
infatti, è un Marco Polo precario, disincantato e allibito<br />
dall’inferno in cui sventatamente si trasforma l’Iraq tra l’aprile e il<br />
maggio 2004, quando internet e tv diffusero al mondo, tra le altre<br />
cose, le immagini delle torture inflitte dai militari americani ai<br />
detenuti iracheni del carcere di Abu Ghraib, e il video della<br />
decapitazione dell’americano Nick Berg. A Fabio Pusterla (e ai suoi<br />
studenti) questo testo è dedicato: “Nulla è sicuro, ma scrivi”.<br />
Ovvero continua, continuiamo a scavare
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
113<br />
Rendere ragione<br />
Quello che girandoti di scatto, senza alcuna<br />
intenzione,<br />
un attimo fa è sparito dall’angolo della finestra,<br />
volto, mano, coda di gazza oppure nulla<br />
di reale, ombra di pensiero evaporata dalla vista,<br />
che se corri e ti affacci non vedi<br />
mai più, persa, volatilizzata, andata in frantumi<br />
di memoria: quello è quanto posso in questi versi<br />
riconoscere e scriverti, sapendo<br />
che è poco, che ci vuole altra forza e altra<br />
investitura per non credere ai miraggi<br />
e per dirigere la storia.<br />
Componile tu queste formule di boria:<br />
all’angolo del vetro poco fa<br />
c’era qualcosa.<br />
Mattoni<br />
Se volessi un mattone dovresti prendere<br />
un mattone, per rabberciare una muraglia<br />
o per tappare una buca<br />
in un pavimento a lisca di pesce.<br />
Un mattone: un solido che vive dentro tre<br />
dimensioni, pesa, al tatto sembra<br />
ruvido o poroso, e lasciato ammucchiato<br />
assieme ad altri per lungo tempo fa<br />
da nido a millepiedi, ragni e forbicine.<br />
Un mattone che esiste, che spaccato col martello<br />
fa tac una volta sola, un suono bello,<br />
di mattone, secco, preciso.<br />
Un mattone conta più delle parole<br />
che lo imitano appoggiandosi<br />
una sopra l’altra.<br />
Io con la poesia vorrei fare mattoni.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
114<br />
Da Materies aeterna - III<br />
Mi alleno così: imparo a numerare<br />
le ombre che mi passano fra palpebra<br />
e pupilla mentre dormo, e quando mi sveglio<br />
devo solo limitarmi a ripetere<br />
l’identico gesto con i vivi –<br />
se le cose fossero le cose<br />
non potrebbero cambiare di valore<br />
in poco tempo: al muro stamattina una bici<br />
che solo u giorno fa era un mezzo<br />
con due ruote è cavalcata da un fantasma –<br />
se le cose restassero cose per sempre,<br />
se non decidessero di saltare sulle dita,<br />
di smaterializzarsi (una notte di lavaggi<br />
ho impiegato per togliermi dal pollice<br />
il puzzo dell’aglio) – invece le cornacchie<br />
tossiscono sui coppi,<br />
e non se ne avvedono, e il suono<br />
passa vetri e guarnizioni e salta dentro<br />
una persona, conformandosi<br />
alla storia precisa di nevrosi<br />
di ognuno – se le cose restassero le cose,<br />
se fossero forme coerenti e ripetibili<br />
e non si rovinassero le sagome del tempo:<br />
ora una stessa carne sarebbe il mio guanciale,<br />
e i chiodi sul muro racconterebbero<br />
la storia del mio corpo,<br />
ficcàti bene dentro da bambino,<br />
lasciati a metà quando sai<br />
che poi col martello non riesci a sradicarli,<br />
nisi materies aeterna teneret<br />
Lucrezio<br />
se non resta uno spazio.<br />
Niente più capelli<br />
nello scarico del bagno, il bolo scende giù<br />
nella rete fognaria, si trasforma in poltiglia<br />
che nutre non so cosa. Avrei desiderato<br />
un tappeto di capelli, per dormire: stenderlo per terra,<br />
rigirarmi quattro volte su me stesso<br />
fino a sentire la tensione delle spire dipendere<br />
da un minimo scatto della testa. Invece,<br />
i capelli sono andati a finire<br />
nei tombini, sono persi come persa<br />
è la foglia che si sbriciola e diventa<br />
frantume che non ricorda più nulla<br />
della gemma.<br />
I cancelli dell’università<br />
diventano più freddi con il freddo,<br />
ogni sera fanno il solito<br />
strido di chiusura quando viene<br />
il custode a inchiavarli – per anni<br />
resteranno ancora lì, fino a che<br />
in un giorno come tanti un altro uomo<br />
batterà con il martello sui cardini<br />
per estrarli dal cemento – la ruggine<br />
che rode la vernice farà un’ombra<br />
sulla pietra – saranno trasportati<br />
su un furgone, abbandonati in un deposito<br />
o buttati in un fosso – dove rimarranno<br />
in incognito cancelli, appiglio<br />
di convolvoli, pettine di erbe: nessuno saprà<br />
che aprendosi sui perni gemevano<br />
di attriti – le lumache passeranno<br />
tra le sbarre agilmente.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
115<br />
Da Stanze alla deriva - IV<br />
Loro<br />
I<br />
Lei che lo tiene dentro il buio,<br />
che rialza le doghe del letto o socchiude<br />
la tenda per farlo svegliare in piena luce,<br />
perché vedere la luce del sole, al mattino…<br />
E dopo gli prepara il caffè, dosa calma<br />
e irrequietezza come l’aquila<br />
con la preda, evade dal suo corpo poco a poco<br />
perché dentro qualcosa non funziona<br />
più a dovere: anche loro resistono, forse,<br />
anche loro qui, su questa lama<br />
di metropoli sconfiggono il passato,<br />
e al male della crepa nel terreno<br />
oppongono il rimedio dell’acqua.<br />
I figli abiteranno<br />
le loro fattezze, troveranno nel profilo<br />
di un pollice o nel sebo della pelle<br />
la piccola storia di una multa<br />
non pagata, del mobile assemblato<br />
insieme una notte. Sapranno ogni cosa<br />
in questo punto esatto: quando uno di loro<br />
li vedrà nel suo riflesso e dirà grazie<br />
a chiunque, a qualunque cianfrusaglia<br />
accumulata nelle stanze della casa<br />
per esistere.<br />
II<br />
A questa insorgenza di luce<br />
nessuno fa più caso: le ombre delle piante<br />
che impercettibilmente si allungano<br />
sul pavimento, mentre tirano in alto<br />
i germogli, in obbedienza –<br />
e poi oltre, dalla soglia fino al letto,<br />
dove dormono insieme da un mese<br />
o poco più. Qualche volta si temono,<br />
quando lui si rovescia<br />
sul corpo e la colpisce,<br />
incapace di distinguere amore<br />
da rabbia. Invece lei capisce:<br />
qualcuno che urta il bicchiere sul tavolo,<br />
un castello mobilissimo di onde<br />
che affiora e dopo due o tre minuti<br />
collassa nel pieno: gli eventi ritornano,<br />
le parole si ripetono, anche questo abbraccio<br />
tra poco verrà sciolto, mentre il mondo là fuori<br />
ricomincia i suoi rumori, e nessuno si accorge<br />
dell’ombra delle piante che attraversa<br />
la soglia e le arrampica sul volto.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
116<br />
Rotonda di notte<br />
Costeggiando la rotonda attraversi<br />
il buio temporaneo di un’aiuola<br />
gigante, poi di nuovo luci, lampioni,<br />
le zampe di locusta del tram<br />
sui fili elettrici. Intorno le automobili,<br />
i grembi appannati in cui tre,<br />
quattro persone si scambiano sollievo.<br />
Sopra, tutto intorno, le infinite<br />
caselle di cemento e di vetro,<br />
le case di cui si esce di soppiatto,<br />
a testa bassa, come se ciascuno<br />
di questi appartamenti, abitacoli,<br />
avesse più importanza e dignità<br />
di quello a fianco, potesse promettere<br />
un briciolo di luce oltre il buio profondo<br />
che resta attraversata la rotonda,<br />
assicurate le persiane.<br />
Insonnia<br />
Una notte spesa male è poca cosa:<br />
se la guardi in filigrana è solo un punto<br />
tra tanti e un punto<br />
perde di consistenza sullo sfondo<br />
del tempo. Perciò sarebbe bello<br />
ingoiare una pastiglia per spezzare<br />
la stanchezza del lavoro e stare<br />
fissi sul terrazzo a dividere il vento,<br />
che sbatte le persiane non fermate<br />
della casa dirimpetto –<br />
e sbirciandoci attraverso contemplare<br />
l’equilibrio di quiete della sala,<br />
le spie degli standby che bruciano<br />
il buio – ma capire specialmente<br />
cosa dice una rondine<br />
che passa e garrisce alle tre<br />
del mattino: che fine del mondo<br />
c’è in quel grido, e l’attimo dopo<br />
che silenzio.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
117<br />
Da Poco prima – V<br />
Tuesday Wonderland<br />
Settembre, si direbbe. O forse una mattina<br />
di metà maggio: il treno, il paesaggio<br />
assopito dell’Oberland, contro il fumo<br />
rallentato delle fabbriche, sullo sfondo –<br />
era il solito percorso<br />
da casa alla stazione, cinque minuti<br />
(poco meno), prima di prendere la rampa<br />
di scale mobili che ascende<br />
al cielo grigioazzurro di Längasse.<br />
Una musica ripetitiva scardinava<br />
la catena degli eventi: la signora<br />
diretta al suo lavoro, come sempre,<br />
il folle barbuto che aguzzava gli occhietti<br />
sbirciando il contenuto delle tasche:<br />
un giorno come tanti, probabilmente martedì.<br />
Il treno rallentò, le porte si aprirono,<br />
le scale mobili ripresero a salire<br />
al primo tocco di piede.<br />
Le cose restarono tutte quel che erano<br />
l’attimo precedente: la luce fu luce,<br />
gli autobus autobus,<br />
gli aceri gli stessi, con qualche foglia in più.<br />
Eppure sembrava lo sapessero tutti,<br />
mentre tranquilli aspettavano al semaforo<br />
o carichi di spesa, a piedi o in bicicletta,<br />
svoltavano un angolo, e non c’erano mai stati.<br />
NOTA<br />
TUESDAY Wonderland è il titolo del terzultimo album (e del<br />
brano eponimo) degli Esbjörn Svensson Trio. Nel luglio 2008,<br />
mentre cercavo di acquistare un biglietto per un loro<br />
concerto a Fano, seppi che il pianista Esbjörn Svensson era<br />
improvvisamente morto per acqua pochi giorni prima, il 14<br />
giugno. La poesia, omaggio alla sua memoria, nacque a caldo.<br />
L’Oberland bernese è la parte meridionale e alpina del<br />
canton Berna. La capita svizzera si trova invece nel<br />
Mittelland. La Längasse è il quartiere dell’Università.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
118<br />
Invece di diventare padre<br />
E poi quando sarete arrivati alla sponda,<br />
tirato in secco le barche<br />
e ripartiti, ognuno nella luce<br />
e nell’odore che gli dice che c’è un luogo<br />
abitabile nel mondo, dopo,<br />
quando è notte e le luci scompaiono<br />
una dopo l’altra: poi cosa fate per dormire<br />
come se fosse niente, se non fosse<br />
uno scandalo feroce lo strato d’asfalto<br />
che ogni volta avete visto sovrapporsi a quelli sotto<br />
e fare spessa una strada?<br />
Come potete amare i vostri figli,<br />
i profondi misteri che gli si annidano<br />
negli occhi, il lampo di riso<br />
che si accende quando girano<br />
il volto verso il vostro e voi sapete<br />
che se un giorno andrete via<br />
non importa, non importa più di molto,<br />
perché loro resteranno e vedranno<br />
un’altra volta la luce che solleva<br />
le antenne e si dirama per i vicoli?<br />
Come fate ad amarli, se sapete<br />
che la sponda poi arriva, e il pane che dividete<br />
sulla tavola con loro tra poco sarà<br />
un’altra notte, un altro sogno<br />
(ed è grazia, questo, per voi, questo è tutto)?<br />
Dietro una finestra<br />
L. behind the window<br />
Tutti dentro i pini, gli storni addormentati –<br />
e là dietro, una fiamma di candela esterrefatta,<br />
provvisoria, riprodotta<br />
a distanza di chilometri e di anni<br />
da una memoria che non si sgretola –<br />
e oltre la finestra, in quella stanza popolata<br />
che fa della notte una cornice, una nuvola,<br />
lei che stende i suoi panni<br />
ballando su una musica di cui si sentono<br />
solo i quarti, lei in quella luce di candela<br />
esterrefatta, ignara degli storni,<br />
poco prima della consegna delle chiavi<br />
e della scheggia di intonaco che cade<br />
e si annida nella fuga del pavimento.<br />
Partono da qui le parole<br />
che percorrono la ronda dei corridoi<br />
e si abbattono sulle porte, mentre fuori<br />
il respiro collettivo degli uomini ronza,<br />
e l’ultimo riflesso dello specchio<br />
sprofonda fuori campo, tradisce la vista<br />
che l’aveva originato, rimanda<br />
l’invisibile a un corpo,<br />
a un ritmo di luci e di penombre l’aria chiara.
Da L’attimo dopo, 2010<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
119<br />
Adesso<br />
Adesso che cominciano tutte le ricerche,<br />
che mi guardo le mani e le scopro<br />
inutilmente contratte nella smorfia<br />
di prendere qualcosa che non c’è<br />
e non ci sarà – avverto come un’alba<br />
la tua tenerezza, il gusto di sentire<br />
l’incastro delle dita, il profumo di te<br />
che il mio asciugamano trattiene.<br />
E il miracolo di vederti,<br />
di essere veduto, ancorati sul cemento<br />
con ancore invisibili, proiezioni di ancore,<br />
cose che ci diciamo per svegliarci domattina<br />
ed avercene ancora.<br />
Adesso sono questo: un radar<br />
per la luce, una pelle che reagisce<br />
ai primi venti di settembre.<br />
Adesso siamo questa scenografia provvisoria:<br />
delle parole, dei rumori<br />
che le stanze della casa si dovranno inventare<br />
per non sentirsi troppo vuote,<br />
per non rimbombare.<br />
Poco prima<br />
Le braci degli sms che si spengono,<br />
la stanza inerme sprangata<br />
in cui tutte le notti affiora una polla<br />
d’acqua e luce, che chiede di sedersi<br />
sul cuscino, a contemplare.<br />
Il sonno atomico che marchia<br />
il materasso delle doghe,<br />
il fondale plasmato della notte<br />
a piccole dune. E l’esistenza quotidiana,<br />
fatta di carne e vetri sporchi,<br />
la cenere sottile dell’alba<br />
che scavalca le colline e pronuncia<br />
sulle labbra di ognuno la parola<br />
misteriosa, quella che fa sfilare dalle porte<br />
le sagome instabili dei corpi, poco prima<br />
che scocchi il rintocco sul quadrante<br />
e si popolino di altri le stanze<br />
che occupavamo noi.
Su L’attimo dopo<br />
La vita, le cose e il divenire. Spunti e riflessioni per una lettura<br />
È uscita la raccolta poetica di Massimo Gezzi “L’attimo dopo”, pubblicata dall’editore Luca Sossella nel 2009 e poi ristampata nel 2010 (da<br />
questa ristampa citeremo). Si tratta di un’opera che ha un baricentro soprattutto esistenziale (ci sono infatti anche momenti di carattere<br />
morale): i testi in effetti sondano specialmente la dimensione della vita privata e quotidiana, ne misurano i confini, le situazioni, soprattutto il<br />
senso, i vuoti, il peso. Non è una cronaca, non è un diario puro e semplice, perché la scrittura quando racconta o descrive lo fa con un filtro, un<br />
approccio, una declinazione selettiva e orientante, che propone in modo indiretto (lirico) e insieme esprime specialmente un’interpretazione<br />
dell’esistenza. E il sentimento dell’esistere per l’autore passa attraverso l’idea chiave della precarietà, della fluida potenza del divenire, del<br />
partire, del lasciare. Nella struggente consapevolezza di tutto questo e quindi nell’attesa che “si popolino di altri le stanze/ che occupavamo<br />
noi” (p. 91). Non è un libro vuoto di cose o persone o luoghi; anzi, la parola di Gezzi si dedica con attenzione e fervore lucido a fermare,<br />
trattenere, dipingere oggetti e realtà quotidiane, secondo una scrittura che afferma l’esigenza del quotidiano. Non a caso si potrebbe dire in<br />
effetti un libro in parte neo-crepuscolare, anche se sulla scia di un neo-crepuscolarismo riletto sia mediante la moderna percezione della vita<br />
incerta, mutevole e precaria, sia con gli occhi di certo Montale, attento al negativo, a tenere quindi le distanze da facili entusiasmi o da canti<br />
consolatori e ingannevoli; si veda un testo vicino a precise direzioni e vie montaliane come “Rendere ragione”, per esempio. Gezzi però fonde<br />
tale esigenza del quotidiano con la forma di una scrittura che mantiene uno stile discorsivo, ma in genere misurato e classicamente controllato,<br />
equilibrato. Una sorta di classicismo moderno, dal basso, con forti contaminazioni appunto che vengono dalla sfera domestica e dal registro<br />
confidenziale, discorsivo, che viene però sedimentato e stilizzato. Inoltre, per una fertile contraddizione, a causa comunque di un movimento<br />
lacerante e generatore, aderire alle cose anche banali o dimesse di tutti i giorni significa sentire, scontare la loro fragilità, la loro precaria,<br />
mobile, dolorosa presenza. La vita si smaglia, si rompe, lasciando vuoti e residui, insieme al senso del nulla; il mondo in questi versi scivola, si<br />
incrina di continuo, ha un peso instabile, fluido, incerto, che la parola poetica vuole e può almeno sulla carta fermare. Un mondo, un tempo<br />
“liquidi”, ci verrebbe da dire citando Bauman.<br />
Accanto a questa coscienza del negativo (la precarietà, il tempo che passa e smaglia, il nomadismo moderno, l’incomunicabilità, la fatica e la<br />
stanchezza esistenziali) c’è un polo positivo, più esiguo in verità del polo tematico negativo: ciò che può aprire un guado, una riscatto felice, un<br />
salto esistenziale nelle trame ripetute dei giorni può essere la “meraviglia” (p. 71). Anche se la direzione più forte e poeticamente incisiva ci<br />
appare quella del sentimento del negativo, espresso senza scatti urlati, senza scomposti e agitati toni, o tratti.<br />
Un’altra riflessione, quindi. La declinazione lirica, privata dell’esistenza e della poesia va contestualizzata nell’ambito della questione critica se<br />
oggi nella produzione in versi in Italia la lirica sia morta o resista. Questa raccolta poetica dimostra come il lirismo tenga, come sia anzi ancora<br />
pulsante, vivo e dinamico. Certo, utilizza forme e mappe nuove, stili e temi rinnovati; per questo libro di Gezzi si potrebbe parlare di lirismo<br />
colloquiale e quotidiano, dove l’io non è più la presenza fondante, il perno assoluto, ma uno dei tanti punti di riferimento o dei temi affrontati<br />
sulla pagina. Va anche detto, però, che resta un forte ed elegiaco filtro soggettivo, anche quando i testi sono popolati da oggetti, persone,<br />
circostanze che possiamo incontrare tutti i giorni: si veda la intensa e calibrata poesia “Quattordici foglie”. Perché in effetti quasi sempre,<br />
almeno nella migliore e più larga corrente poetica di questo significativo libro, perfino le cose, perfino “i rami cuciranno/ i loro vuoti in silenzio,<br />
non impiegheranno/ troppo tempo per capire” (p. 22).<br />
Luciano Benini Sforza<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
120
Su L’attimo dopo<br />
[…] La misura del dolore diventa concreta fatica di costruzione, ne L’attimo dopo di Massimo Gezzi, poeta volutamente lirico, che alle influenze<br />
di Fortini, Saba o Cattafi – segnalate da Guido Mazzoni – aggiunge forse una traccia di Raymond Carver. In questa poesia umanistica, o<br />
sottilmente animistica, in cui l’uomo non è più misura di tutte le cose, l’epifania è svuotata del sacro, ma ugualmente accade, e può non essere<br />
infrequente. […]<br />
Laura Pugno, Nei versi sensibili della giovane poesia italiana, “il manifesto”, 5 lug. 2007 [recensione al Nono quaderno italiano]<br />
* * *<br />
[…] Guido Mazzoni, …, ha colto nella prefazione ai testi di Massimo Gezzi (L’attimo dopo, si intitola la silloge) un aspetto determinante:<br />
“All’immediatezza esistenziale è subentrato uno sguardo mediato e interpretante; alla registrazione dell’esperienza, lo sforzo di cogliere i livelli<br />
di realtà che si aprono sopra, sotto e intorno alla vita individuale”. Gezzi è un interprete dell’oggi che sembra sempre sull’orlo di un punto<br />
limite, di una svolta assoluta dalla terra marchigiana, così locale e così universale. Un lampione, una pozzanghera, una macchina per cucire, i<br />
cubi di cemento sono cose che circoscrivono e allargano la visuale del mondo, le abitudini quotidiane, la riflessione indotta dal luogo, da una<br />
coscienza mobile nel recinto della mente e del luogo. […] Gezzi propaga un’esperienza anche come apertura sensuale, scrive Guido Mazzoni<br />
nell’introduzione al poeta di S. Elpidio a Mare. Le vicende abbagliano le distanze tra mare e cielo, in un posto “dove gli uomini vendono tutto<br />
per fame”. Nel segno di una residenzialità ancora presente e ribadita (e che nasce con Franco Scataglini, Francesco Scarabicchi e Gianni D’Elia<br />
negli anni Ottanta), Massimo Gezzi sembra porsi quella domanda dalla quale è scaturito il significato intrinseco del vivere “qui e non altrove”.<br />
[…]<br />
Alessandro Moscé, I nuovi poeti italiani tra i quali il marchigiano Massimo Gezzi, “prospettiva-L’Azione”, 13, 29 marzo 2008 [recensione al<br />
Nono quaderno italiano]<br />
* * *<br />
[…] È un libro solido, i testi discendono come discende la sorpresa di una scoperta nello stato della coscienza, i versi sono riflessivi, la voce del<br />
Gezzi è ferma e mai artefatta. Si coglie a tratti quasi una sommessa capacità di chiudere i quadri con un movimento aforistico dove sebbene<br />
tutto sia mutevole, niente è lasciato in sospeso.<br />
Se la prima sezione intitola infatti “L’attimo dopo”, l’ultima è intitolata “Poco prima”: non solo paradosso sintattico ma congedo e inizio,<br />
restauro temporale della ciclicità e della materia (anche morale, sentimentale) contro la fuggevolezza: non tutto è perduto sembra affermare in<br />
ogni testo l’autore, nonostante la fatica, l’incapacità di dire con esattezza quando arriva la scintilla; quando la scintilla non arriverà e si cerca di<br />
dire, capire. Quando la scintilla è la forma stessa dell’incendio. Ed i versi del Gezzi sono moti ondosi, andate e ritorni, permanenze. I versi del<br />
Gezzi sono soglie aperte. […]<br />
Fabiano Alborghetti, “alleo.it”, maggio 2010<br />
* * *<br />
[…] È un libro completo “L’attimo dopo”, di rara intensità. Mi piace che non ci sia il “sussulto” immediato, non compaia così spesso il verso che<br />
ti strappi il “però”. Questo succede quando è tutto il libro ad essere una scossa costante, un accordo, andirivieni quasi perfetto fra la parola<br />
scritta<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
121
Su L’attimo dopo<br />
scritta e il sentire dell’autore. Sentire che diventa il nostro, usiamo i versi del poeta a nostro piacimento. Immaginiamo noi stessi, ricordiamo,<br />
riviviamo, ne prendiamo possesso. Questo quando accade? Soltanto quando leggiamo poesia alta, poesia ben scritta. Quando l’autore possiede<br />
la leggerezza dell’ispirazione immediata e l’equilibrio, la cura costante per ogni verso. Ogni parola. Ci sono libri “da seduti” e libri “da in piedi”, il<br />
libro di Gezzi appartiene alla seconda categoria. Il tipo di libro con il quale te ne puoi andare dal salotto (per chi c’è l’ha) alla camera leggendo<br />
ad alta voce. Non è possibile farlo con tutti i libri, quando ci si riesce è una bella cosa però. […]<br />
Gianni Montieri “Poetarum Silva”<br />
* * *<br />
[…] … L’attimo dopo (…) è un libro assai bello, che merita attenzione. Ma questo è anche un libro che, per la sua maturità, per il controllo<br />
ritmico e formale che esibisce sommessamente, per la varietà dei temi, situazioni e sfondi che propone, e soprattutto per l’intensità inquieta<br />
dello sguardo che l’orienta, risulta tanto più notevole considerando la giovane età dell’autore. Si potrebbe pensare che Gezzi abbia scelto di<br />
ripartire dalla complessità splendida e nel contempo vertiginosa, affascinante ma anche paralizzante, definita da Vittorio Sereni nei primi anni<br />
settanta del secolo passato, nel movimento conclusivo del poemetto Un posto di vacanza: “Un sasso, ci spiegano / non è così semplice come<br />
pare. / Tanto meno un fiore. / L’uno dirama in sé una cattedrale. / L’altro un paradiso di terra. / Svetta su entrambi un Himalaya / di vite in<br />
movimento.”. Ogni elemento, da qui in avanti, è strettamente correlato con ciò che lo circonda, lo precede e lo segue; e in mezzo a questo<br />
vortice di “vite in movimento” l’esperienza del singolo diviene contemporaneamente più avventurosa e più smarrita, più conscia della propria<br />
precarietà eppure, paradossalmente, anche più cosciente della bellezza drammatica, sfuggente, del flusso che ci porta e che ci chiama.<br />
Il disorientamento, in Gezzi, è la conseguenza di tale ormai acquisita complessità; ma non comporta il rimpianto di un ordine perduto, semmai<br />
la consapevolezza di una situazione nuova, di un’avvenuta catastrofe individuale e collettiva. Sarà a questo, alla cosa che non viene detta e che<br />
pure orienta la scrittura, che si riferisce il titolo del libro, che è anche il titolo della sua prima sezione? L’attimo dopo sarebbe allora appunto la<br />
condizione in cui si trova la parola poetica e la figura inevitabilmente dilaniata dell’io che la pronuncia; e del resto l’ultima parte del volume ha<br />
di nuovo un titolo che richiama lo stesso concetto, ma come rovesciando lo sguardo: Poco prima. Tra questi due punti d’inizio e di fine, si<br />
sgranano le cinque sezioni della raccolta, e quella centrale, dominata da un unico testo più lungo degli altri e particolarmente rilevato, offre di<br />
nuovo un suggerimento di natura temporale: Materies aeterna, la “sostanza delle cose” di Lucrezio (e il termine, di un antichissimo latino<br />
rustico, indica infatti la materia più dura e durevole del tronco, in opposizione alla scorza e alle foglie; ciò che persiste quando il resto svanisce)<br />
e la sua durata, rispetto alla quale svetta con evidenza anche maggiore la fugacità delle vicende umane… Così la dimensione del tempo nella<br />
poesia di Gezzi si complica e si dilata: esiste il tempo individuale, dominato dalla brevità e dal desiderio, dalla speranza, dallo scoramento e<br />
talvolta dal vuoto; esiste quello storico, vastissimo, di cui il paesaggio (…) può serbare l’impronta, la traccia commovente; e poi esiste una<br />
misura ancora più vasta, biologica o addirittura geologica, il fondale più immenso, e solo a tratti per un istante ravvisabile, dei nostri poveri<br />
gesti di vita o di morte. Ma proprio di fronte alla lucida coscienza di una simile vertigine Gezzi trova lo scatto umile e fiero, il baleno della<br />
bellezza che comunque esiste e va difesa; proprio di fronte al baratro, alla scomparsa di un Ultimo trasloco: “Allora il nostro dovere di uomini<br />
liberi / è di contare le finestre illuminate / nel buio. Perché sul confine / tra il paese e la campagna una donna / si è svegliata a ruminare la sua<br />
angoscia / (disoccupazione, amore inconfessabile che svelle / la serratura della porta, malattia) / Perché un uomo abbandona / la sua casa una<br />
notte e tutti pensano / che è vita, in fondo, quella, è bellezza”. D’altro canto, la complessità dei tempi e degli spazi, che riconducono<br />
inevitabilmente a Leopardi, un Leopardi riletto, filtrato attraverso il grande asse novecentesco e forse soprattutto attraverso Montale, e<br />
finalmente<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
122
Su L’attimo dopo<br />
finalmente trasferito nel nostro oggi, non fanno mai dimenticare all’autore la necessità di indagare il presente, a sua volta complicato e<br />
tormentoso, contraddittorio e terribile. Una poesia da questo punto di vista assolutamente centrale in tutto il libro è senza dubbio Marco polo,<br />
32 anni dopo. (…) Gezzi (…) non è affatto insensibile alla dimensione politica, che spesso traspare nei suoi testi, e in qualche caso può persino<br />
occuparne il proscenio; ma come l’autore riesce a sfuggire alle maglie della melanconia soggettiva (“il suo modo di guardare fugge alla<br />
melanconia”, annotava giustamente Mazzoni), così non può neppure lasciarsi intrappolare da un pessimismo storico tanto radicale quanto<br />
insufficiente, perché sterile.<br />
E forse questa appunto è una delle novità più significative su cui L’attimo dopo induce a riflettere: l’autore, proprio come il soggetto emotivo<br />
che assume la responsabilità delle parole di questo libro, non è affatto un ingenuo, non si fa nessuna illusione sulla miseria del presente, sulla<br />
sua crudeltà, sul suo cinismo; conosce perfettamente tutti i limiti della condizione umana, e non intende nascondere nulla o affidarsi a qualche<br />
miraggio orfico. E tuttavia la lucidità dello sguardo non contrasta con una fiducia di fondo: fiducia in cosa, ci si può chiedere? Difficile rispondere<br />
senza scadere nella retorica più infelice. Ma fiducia, comunque, che nasce paradossalmente dall’incontro di disillusione e speranza; (…) è … per<br />
questo che Massimo Gezzi affida la sua riflessione sulla poesia a un paragone quasi allegorico con i Mattoni: “Un mattone conta più delle parole<br />
/ che lo imitano appoggiandosi / una sopra l’altra. // Io con la poesia vorrei fare mattoni”. (…)<br />
Le poesie di questa raccolta offrono dunque poche risposte nette e molte domande, come sempre i libri dovrebbero fare; interrogano se stesse<br />
e i loro lettori, aprono orizzonti che attirano e che inquietano. E chiedono di non arrendersi alla disperazione e allo smarrimento; è questa forse<br />
la sola risposta che Gezzi può trovare sul cammino (…).<br />
Una conseguenza stilistica di tutto ciò è, come già osservava Mazzoni, il prevalere della figura dell’elenco, che senza dubbio rappresenta uno<br />
dei tratti espressivi più visibili nel libro. Lo sguardo osserva, annota ed elenca, certo, i minuti elementi della realtà. Ma in questo processo<br />
enumerativo non si ravvisa né passività né mera contabilità materiale. Il mondo è complesso, a volte incomprensibile, quasi sempre lancinante,<br />
forse insensato; ma elencarne a bassa voce le componenti significa per Gezzi tentare strenuamente di coglierne un riflesso di luce, un sussulto<br />
di vita, unico e irripetibile; di nuovo, nel farsi stesso dell’elenco si sente l’eco dell’opposizione tra istante e durata, precarietà e infinito. Così le<br />
enumerazioni di Gezzi sono una forma di riconoscenza nei confronti di ciò che, malgrado tutto, esiste, si sforza di esserci e chiede di essere<br />
riconosciuto e nominato; sono forse anche, se questo si potesse dire con un po’ di leggerezza, una forma di preghiera laica e razionalissima. […]<br />
Fabio Pusterla, “Lo straniero”, 119, maggio 2010.<br />
* * *<br />
[…] Gezzi dà voce forse come nessun altro, per maledizione o forse privilegio autobiografico, allo stato di precarietà e di pendolarismo coatto<br />
che caratterizza la vita o più spesso la sopravvivenza dei suoi coetanei, cioè dà conto di una condizione di deriva così reiterata da apparire<br />
oramai naturale e persino fatale.<br />
In effetti, c’è nella sua poesia una fissità di sguardo, anzi un equilibrio percettivo paradossalmente contraddetto dal continuo mutare dei fondali<br />
geografici e delle occasioni esistenziali: ora alle sue spalle c’è la costa adriatica, un invaso colmo di vento e di luce radente, la tana occupata dai<br />
reperti di una giovinezza trascorsa in poco d’ora e poi via via faticosamente smaltita, ora invece c’è davanti a lui la nebbia e la neve di una<br />
qualunque città della mitteleuropa, anonima e greve di rapidi crepuscoli, tenuta a bada da un sentimento in cui convivono stupore e disincanto.<br />
[…]<br />
Massimo Raffaeli, Massimo Gezzi, versi scanditi esatti nel grigio, in “alias – il manifesto”, 22 maggio 2010.<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
123
Su L’attimo dopo<br />
[…]…in che cosa consiste essenzialmente la compiuta bellezza di questo “L’attimo dopo” di Massimo Gezzi? Innanzitutto, nella cadenza ritmicosintattica<br />
che l’autore imprime al suo dettato poetico: i suoi versi hanno un empito, un respiro che si direbbe ‘classico’, frutto anche della<br />
notevole padronanza ritmico-formale che viene esibita quasi sommessamente dal poeta; eppure, al tempo stesso, queste liriche paiono tanto<br />
sincroniche ai tempi nostri, come se fossero incrostate da una fulgida patina di contemporaneità. Gezzi ostenta senza timore il suo debito di<br />
riconoscenza verso grandi nomi della lirica del ‘900 la cui importante lezione sembra tanto nitidamente rivista e riletta in queste liriche: mi<br />
riferisco a nomi come quelli di Sereni e Montale, di Fortini e di Giudici. Ma Gezzi non si accontenta di cifrati richiami o di vaghe citazioni, ma<br />
arriva addirittura all’omaggio esplicito che diventa quasi un calco dichiarato, un prestito esibito. Due esempi fra tutti: “Ho sceso le scale del<br />
condominio” (da la poesia “Una parola non detta”) che recupera l’incipit di un celebre xenia montaliano “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un<br />
milione di scale”; oppure nella poesia “Sul molo di Civitanova” l’allitterante enjambement “la fede/ nel frenetico farsi delle foglie” che non può<br />
non riportare la memoria al D’Annunzio de “La sera fiesolana”: “Fresche le mie parole ne la sera ti sien come il fruscío che fan le foglie”. Ma<br />
questo attraversamento della tradizione non è inerte o sterile: Gezzi infatti, ribadendo i suoi legami con essa, ne attesta quasi la demolizione, la<br />
distruzione, lo sbriciolamento perché le contaminazioni e le combinazioni che subiscono questi innesti all’interno del suo dettato poetico<br />
conducono le sue liriche verso un luogo irrimediabilmente altro, differente, radicalmente diverso dalla tradizione del nostro 900: un sorta di<br />
oltraggio, di parricidio (poetico, beninteso) che nasce però da un atto di riconoscenza. […] …la poesia di Gezzi è poesia anche eminentemente<br />
corporale e materica: corporale pensando all’attenzione quasi ossessiva che il poeta riserva a ciò che viene cancellato, abraso via dal corpo<br />
umano, gli scarti e le deiezioni la cui esistenza caduca ed effimera sussume quasi una valenza allegorica (i capelli sul cuscino o nello scarico del<br />
bagno, la puzza d’aglio che non si riesce a mandar via dalle mani, un taglio sulla pancia, il bolo che scende nella rete fognaria,…)<br />
Ma anche materica (nisi materies aeterna teneret - se non le tenesse insieme una materia eterna-come recita il frammento lucreziano<br />
espressamente citato dall’autore) . Del resto è lo stesso Gezzi ad annunciarlo esplicitamente quando nella poesia “Venere davanti al sole”<br />
afferma: “la materialità dell’esistenza è cosa certa”. Una materialità che s’incista ed insiste ostinata anche in oggetti spuri o banali, del tutto<br />
inosservati e precari, ma che, trattati e riscattati dalla sensibilità del poeta, assumono una straordinaria incisività, un sovrasenso morale, una<br />
dimensione quasi epifanica. […] Sorprende poi in questa raccolta la puntuale trasposizione semantica che subiscono gli oggetti, provocata<br />
essenzialmente dalla presenza trasformatrice del tempo che ne muta aspetto e significato, assegnando loro un’orbita imprevista, una<br />
destinazione bizzarra, inattesa: i fari di una vecchia auto reclamata dalle radici del convolvolo, che ospitano nidi di vespe, i cancelli<br />
dell’università, che diventano passaggio e dimora di lumache. Questa vertigine metamorfica investe tutti questi oggetti di una altro significato,<br />
li scaraventa in una specie di universo altro e parallelo, che ne prefigura il destino, la paziente attesa di un disegno imperscrutabile e necessario<br />
a cui essi sembrano condotti. Oggetti spesso minimi e quasi impercepibili quelli che calamitano l’interesse del poeta, tanto trasparente ed<br />
eterea, fino ai limiti dell’inconsistenza, la loro natura. In realtà, proprio questa precarietà fenomenologica, li rende depositari di un mistero<br />
quasi ineffabile. […]<br />
Linnio Accorroni, testo letto il 18 giugno 2010 a Portonovo (An), in occasione della V edizione de La Punta della Lingua 2010 Poesia Festival,<br />
durante la serata dedicata alla poesia di Massimo Gezzi e Adelelmo Ruggieri<br />
* * *<br />
Le immagini e il bestiario della nuova raccolta di Massimo Gezzi sono rappresentati da una lingua come pochi sanno costruirsi, nell’attualità<br />
della recente poesia italiana e nelle vie strette dell’immaginario antropologico. Il libro ci dà una scossa repentina, anche se sappiamo che ci<br />
sono voluti diversi anni di difficile cammino, soprattutto per la sua natura di oggetto montaliano per eccellenza: e questo non è certo riduttivo<br />
nei<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
124
Su L’attimo dopo<br />
nei confronti di una ricerca che rispecchia finalmente qualità epiche e rigori sintattici, vedute dell’origine delle cose e fermezza di rotta.<br />
L’identità di Gezzi trova qui purezza d’intenti e mature energie, tutte messe in campo ad esplorare la piattaforma delle cose, il profilo delle sue<br />
terre d’origine e l’esaurimento dell’uomo in un esilio senza fine. Lo sguardo spesso dirige verso il basso, dove si consumano resti d’ogni genere<br />
schiacciati dai nodi epocali. Maggiore la fragilità della situazione del vivere, tanto più grande e attento il rigore delle forme, in una serie di<br />
“botta e risposta” che proseguono lungo le pagine concentrate e in controtempo. (…) Anche in questa raccolta (…) si parte da una Riviera<br />
adriatica tratteggiata con toni dimessi, quasi fosse consumata da un eccesso di seconde esistenze, per poi rivolgersi verso viaggi variegati, lungo<br />
tragitti che portano a nord, attraverso l’Europa. Per il poeta ligure [Montale] questo significò un livello percettivo più ampio, quasi dantesco;<br />
per il giovane poeta marchigiano è la sintesi di un fare razionale, dentro le cose (e qui si potrebbe intravedere un tratto della determinata<br />
azione di Antonio Porta), dentro tutti i movimenti che una poesia può permettersi, snodandosi e riavvolgendosi nei singoli testi… […] I<br />
frammenti, le “occasioni”, diventano luminosi come una mattina sul mare, si disegnano con precisione anche quando un po’ di malinconia<br />
emerge fra le virgole. Sono le ombre che Gezzi richiama come a voler sottolineare una corrente che altrimenti risulterebbe troppo<br />
disorientante, che male farebbe alla sua lingua viva ma non per questo esclusiva… […]<br />
Elio Grasso, “Poesia”, 250, giugno 2010<br />
* * *<br />
[…] Quella di Gezzi è poesia che interroga la materia: per il nostro bisogno di ancorarla a noi, o noi di ancorarci a lei, viene stabilizzata, fissata in<br />
immagini apparentemente immobili, quasi in bianco e nero per metterne a nudo le luci e le ombre, dense di senso e di vita. Tra i materiali che<br />
insieme e attraverso le parole “fanno” L'attimo dopo , c'è il vento, “costante come un vizio” (La meraviglia , p. 70), torna regolarmente nei<br />
componimenti<br />
componimenti che compongono la raccolta, così come il sangue presente sin dalla prima poesia della prima sezione, due elementi che<br />
costituiscono ognuno a suo modo un flusso. Esso è accompagnato dal ritmo, a volte dato dal suono della parola, ma anche dai rintocchi di<br />
campane, di ore scandite, ripreso dal motivo del tempo musicale diviso in quarti – d'ora (p. 63) e tempo di musica, (p.19, p. 86) –. Il battito che<br />
sostiene il flusso degli eventi sembra essere la manifestazione sonora di un richiamo alla consuetudine, alle azioni quotidiane, quasi obbligate,<br />
reiterate, su cui poi sono possibili le infinite variazioni: “questo ripetono / i colpi di campane: che il tempo / sono occhi e mani che si stringono,<br />
/ voci di lontano che dicono / un saluto, il duplice flusso / del sangue nel corpo...”, ([Perché nel sottinteso], p. 11).<br />
Ci sono poi i segni che testimoniano un pezzo di esistenza, l'essere passato, il loro essere minimo però rinforza appunto il sentimento di<br />
precarietà. Non solo manifestazioni imponenti, come albe, tempeste, panorami, ma anche solo un gesto, un resto – il filo di bava di un animale<br />
(Reperti , p. 12), il segno di un palmo della mano sul vetro (I ricordi della prima neve , p. 40) –. Doghe del letto, chiodi, capelli, cancelli, porte e<br />
muri, stanze e mobili, ciò di cui l'uomo si circonda per creare uno spazio proprio, eretto a difesa dalla solitudine, dall'esilio. Fino alle<br />
cianfrusaglie in Loro (p. 59), ai dettagli, alla riduzione del segno a poca cosa, ad un barlume minimo: la luce del tasto random (p. 38), il puntino<br />
rosso fuoco del laser (p. 43) il led (p. 61), la spia dello stand by (p. 64), gli sms (p. 91). […]<br />
Roberta Deambrosi, “Culturactif.ch”, settembre 2010<br />
* * *<br />
[…] Di Gezzi si può dire – e in questo senso se ne scrive giustamente da diversi anni ormai – che nella sua generazione è tra gli autori definibili di<br />
sintassi.<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
125
Su L’attimo dopo<br />
sintassi. È cioè tra i più coscienti nella ridefinizione di un percorso lirico che passa per la strada non facile di una metrica in sostanza classica<br />
(fondata sull’endecasillabo), non nemica di attenti e non artati enjambements e spezzature, nella continuità-fluidità del discorso. Il flusso delle<br />
frasi è formato dalle o scomponibile nelle unità metriche note, in accordo con una sintassi salda che tiene la linea portante del significato senza<br />
dissipare subordinazioni, senza tentare – in questo senso – azzardi di ulteriori frantumazioni, fossero pure sotto l’ombrello non spiazzante della<br />
reticenza e dell’anacoluto.<br />
Detto ciò, va aggiunto che, al livello delle unità superiori, ossia delle poesie, dei testi compiuti e dell’uso e modulazione che questi fanno delle<br />
caratteristiche appena elencate, esistono vari registri nel libro L’attimo dopo, ma che due sembrano tenere con maggior evidenza degli altri il<br />
campo: uno narrativo-allegorico, e uno – più indefinibile – che sembra, spiccando sempre su uno sfondo allegorico, attenuare le evidenze<br />
strette del narrato (e dell’io come asse portante) per affidarsi a una parziale indefinizione delle occasioni e situazioni di vita date. […] Cosa<br />
succede nell’“attimo dopo”? Il peso – fenomenologico – che la coscienza avverte, patisce e accerta, è quello delle cose, delle costrizioni, delle<br />
mancanze da cui pure nasce azione, una necessità (“partire”, “contare le finestre illuminate / nel buio”). Se di indefinizione nell’osservazione si<br />
tratta, è attivamente conoscitiva. Disegna ciò che prima del verso non esisteva. Il testo che apre la raccolta è, in questo, decifrabile sì nel senso<br />
dei disastri (tellurici e politici) che attraversano da sempre l’Italia, ma anche e precisamente nella direzione di una non scontata cognizione del<br />
dolore: “Poi ci fu una scossa repentina, / e i muri cominciarono a frantumarsi / e a spaventare gli insetti che ci vivevano dentro. / Non c’è più<br />
lavoro, ci dicevano / sorridendo, non ci sono più affetti / capaci di farci amare queste sedie, queste mura, / il silenzio che si ascolta parlare solo<br />
quando / percepisci il tempo scorrere, o ricordi qualcuno”.<br />
Marco Giovenale, “slowforward”, 5 novembre 2010<br />
* * *<br />
[…] Mosso dall’impegno (etico oltre che estetico) “a guardare sempre meglio”, Gezzi compone nei suoi testi un intreccio perfettamente<br />
calibrato (anche in questo caso per via prosodica: l’unica che rende davvero necessaria la versificazione, per chi legge non meno che per chi<br />
scrive) tra sapienza letteraria e passione figurativa, impulso esistenziale e ricchezza istintivamente cromatica della propria tavolozza espressiva,<br />
dentro un istinto diari stico temperato sempre dall’impulso a trasformare la cronaca in storia, il dato impressivo in epifania. E L’attimo dopo,<br />
derivato dall’epigrafe di Virginia Wolf then the hour, irrevocabile, è titolo per una volta non suggestivo ma esplicativo dell’intenzione poetica,<br />
tesa a raggrumare nei fotogrammi testuali che si susseguono entro le cinque sezioni del libro una gamma percettiva efficacemente compiuta.<br />
Così, l’io che parla integra l’ansietà del soggetto sensibile con una “prima resistenza da imparare grazie alla virtù primaria della meraviglia”… […]<br />
Alberto Bertoni, “Il Mulino”, 2, 2011<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
126
Da In altre forme (En d’autres formes/In andere formen), 2011<br />
Massimo<br />
Gezzi<br />
127<br />
Un congedo<br />
Si fermò ad osservare gli ultimi bagliori<br />
di luce che affondavano dietro i monti.<br />
"Non mentono di niente, i bambini,<br />
quando fanno il sole rosso o le nuvole<br />
rosa su uno sfondo blu cobalto. Forse sono<br />
gli unici che guardano ancora qualcosa".<br />
Posò il bicchiere sul tavolo,<br />
soffiò il fumo contro il vetro e quello<br />
si allargò come un lago di aria grigia.<br />
"Ho pensato che la mia vita fosse mia.<br />
Anche tu lo stai pensando, adesso,<br />
che tu sei ciò che scegli, ciò che vuoi,<br />
quello che dici". Gli rispondevano i libri,<br />
le cornici, le piante tese al tuffo nel buio,<br />
non io. "Anche quello che non dici",<br />
sorrise, mentre il rantolo di catarro<br />
gli si faceva più scuro. "Invece adesso<br />
tu, su quella sedia, che mi guardi le spalle<br />
e vorresti annodarti le mani o essere muto,<br />
tu adesso sei importante, e non lo credi, e non lo sai".<br />
La nuvola più lontana sbiadì all'improvviso.<br />
Nel giro di pochi minuti perse il rosa, poi il viola.<br />
Era ormai un ammasso grigio quando lui,<br />
picchiettando due dita al ritmo contro i vetri,<br />
diede un colpo di tosse e intonò Yesterday,<br />
poi smise.<br />
Quelle qui riprodotte sono le due poesie inedite della<br />
raccolta.<br />
Tutti i testi della silloge sono tradotti in francese, da<br />
Mathilde Vischer, e in tedesco, da Jaqueline Aerne.<br />
Promemoria<br />
Quello strappo di fumo, quella frangia<br />
che il vento apre a ventaglio<br />
mentre piega verso monte;<br />
quelle foglie di platano ormai moribonde,<br />
pronte a farsi umido e poltiglia<br />
ma ancora appese al loro ramo,<br />
mentre il sole ne accende i gialli<br />
ed i marroni; e il palazzo lì di fronte,<br />
che doppia quella scena e la rifrange<br />
in macchie di colori antichi<br />
e non per questo meno veri –<br />
ora che il trapezio di luce<br />
che li investiva sta sparendo,<br />
ora che torna grigio il fumo<br />
e giallo opaco il platano spogliato<br />
dall'autunno, adesso che non c'è più<br />
devi dire che c'è stato, che non pesa<br />
più di un lampo immotivato di allegria<br />
e non cambia nulla. Ma c'è stato, e fra decenni<br />
tutti questi giorni, questi anni<br />
di muri e di distanze per te saranno quello.
Enzo Esposito. Senza titolo,<br />
tecnica mista su tela
Franca Mancinelli<br />
128<br />
x<br />
È nata a Fano (PU) nel 1981.<br />
Ha pubblicato il libro di versi Mala kruna (Manni, San Cesario di Lecce 2007; Premio opera prima “L’Aquila” e<br />
“Giuseppe Giusti”).<br />
È inclusa nell’antologia nodo sottile 4 (Crocetti, Milano 2004) e nodo sottile 5 (Le lettere, Firenze 2008),<br />
entrambe a cura di Vittorio Biagini e Andrea Sirotti, ne Il miele del silenzio. Antologia della giovane poesia<br />
italiana, a cura di Giancarlo Pontiggia (interlinea, Novara 2009) e nel Registro di poesia 3 (d’if, Napoli 2010).<br />
Sue poesie sono state tradotte in spagnolo (in Emilio Coco, Jardines secretos. Joven poesía italiana: antología,<br />
Sial, Madrid 2009).<br />
Ha vinto, con gli inediti, i premi “Castelfiorentino” e “Senigallia-Valerio Volpini”.<br />
Un’ampia silloge dei suoi versi è apparsa su “Poesia” nel marzo 2006.<br />
Suoi testi sono usciti su varie riviste cartacee e online, tra cui “Nazione Indiana”, “l’immaginazione”, “nostro<br />
lunedì”, “graphie”, “Ali”, e “Versodove”.<br />
Collabora come critica con “Poesia” e con altre riviste e periodici letterari.<br />
In una intervista curata da Lorenzo Franceschini (“La forma dell’acqua”. Conversazione con Franca Mancinelli,<br />
“Scirocco”, 22, aprile – giugno 2008) ha avuto modo di dichiarare, parlando della sua poesia: […] «…molte<br />
cose che ci accadono tornano con la regolarità di un’onda a batterci, a frantumarci. Noi non ne siamo<br />
responsabili (almeno apparentemente); registriamo soltanto l’accaduto come l’ennesimo incidente,<br />
l’ennesima ferita. È poi soltanto la consapevolezza che, quando avviene, ci permette di guardare<br />
indietro il ripetersi di certe vicende, di scoprire il “tempo conficcato come seme rotto”, come qualcosa<br />
che non nasce, non va avanti, resta nella sua lacerazione.» […]
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
129<br />
all’orizzonte un mare diverso<br />
fermava il sangue sotto le unghie;<br />
madre nera nell’isola<br />
ti venne a fianco e ti disse del vento,<br />
un cattivo tempo che non faceva<br />
partire le barche;<br />
poi fissò un punto sul muro<br />
lungo la strada iniziava una festa<br />
mala kruna, disse<br />
piccola corona di spine.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
130<br />
Da I – OLTRE LA GIOSTRA<br />
dal giorno che non rispondi allo sguardo<br />
cresce ruga sul gomito il ricordo,<br />
sui tavoli dell’asilo non segui<br />
l’impronta non pensi<br />
che oltre la giostra<br />
c’è ancora lui che dorme in fondo,<br />
e non lo puoi svegliare.<br />
smetto di piangere solo<br />
quando il motore è acceso:<br />
le immagini scorrono, chiudo gli occhi<br />
nel sedile dietro mentre guidi<br />
sulle strade in collina dove il cielo<br />
traspare dalle foglie.<br />
Non farti accorgere, non dirmelo<br />
che la fuga s’è chiusa in un cerchio,<br />
non darmi questo mondo fermo<br />
di cose intonacate e appese<br />
se mi abbracci non posso<br />
dare la guancia al buio, ti chiedo<br />
lasciami come un gatto lontano<br />
alla svolta, sul ciglio di una strada<br />
dove s’aprono valli<br />
di viti e ulivi e non trovo la casa.<br />
*<br />
quanto paziente ostinato amore<br />
nel gesto che fai di muovere passi<br />
avanti e indietro nella sala, mentre<br />
col braccio e un ginocchio fingi<br />
di addolcire una cuna sulla sterrata<br />
come dondola il mondo e le cose<br />
di nuovo tremano, anch’io<br />
sarò nel buio.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
131<br />
scendo le scale in bilico<br />
aggrappata alla ringhiera;<br />
è tornata la mamma e la gioia<br />
parla forte, lui nella luce<br />
davanti alla porta ha un guscio<br />
e lo appoggia sul tavolo dove<br />
qualcosa ora piange<br />
«è un gatto per me?»<br />
iniziata la lotta:<br />
chi raggiunge prima<br />
la cucina, deglutisce più veloce,<br />
chi ha la vera ragione di piangere<br />
intuisce l’istante per spingere<br />
sott’acqua l’altra testa.<br />
Certezza<br />
lui ancora veglia ogni vena sul viso<br />
cauto che il pianto di smorfia o febbre<br />
tacesse custodito<br />
nell’abbraccio che è il vestito<br />
macchiato di ogni giorno.<br />
Da II – IL MARE NELLE TEMPIE<br />
costruzioni subito crollavano,<br />
l’onda entrava nel costume verde.<br />
Quando m’alzai sapevo<br />
cos’accade a una donna<br />
dopo che il sole è sceso nelle spire<br />
come di sale solidificato<br />
e altri gusci morti.<br />
hai baciato il mio osso sporgente<br />
l’anca ramo ricurvo:<br />
svanisce il filo di sassi sulla schiena<br />
e ti siedo di fronte<br />
a radici aperte.<br />
È un’immagine chiara, a lungo<br />
devo sfogliare prima che combaci<br />
ma ora che ricordo sono io:<br />
i lobi luccicanti appena incisi,<br />
un sorriso di fortuna<br />
dalla sua mano un fiore s’avvicina,<br />
apro gli occhi al lampo, e il taglio<br />
della luce è mio.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
132<br />
scandite al buio le parole sono un cerchio<br />
fino all’argento, al filo che taglia<br />
vieni negli anni muti, mani premute<br />
sulle labbra, il corpo perso.<br />
Sempre una favola da raccontare<br />
il mare quieto batte nelle tempie<br />
e m’addormenta.<br />
nella notte un estuario le tue braccia<br />
sono rami di quercia<br />
setaccio senza fondo<br />
sasso chiaro che precipita<br />
un granulo di terra che si scioglie<br />
sono sempre stata qui<br />
all’inizio della vita<br />
guardando queste cose<br />
muoversi nei tuoi occhi.<br />
con la marea che scopre le coperte<br />
spuntano dalla pelle gli aghi:<br />
partire per tempo<br />
accompagnarsi in gita.<br />
E chi m’avrebbe mai piegato un lembo<br />
della giacca e trattenuto, chiedi,<br />
sul guanciale dell’Ardizio segui<br />
pescatori di vongole chinarsi<br />
a rimboccare il sole.<br />
Da III – NEL TRENO DEL MIO SANGUE<br />
precipitando il mondo<br />
la notte camminavo tra le zolle<br />
su una collina che non puoi sapere<br />
se lenta cresce fino alla montagna<br />
o se t’inghiotte dentro la sua buca<br />
ora solleva una luce la terra<br />
o è il vortice appena il piede tocca<br />
il rullo di granelli dentro il buio.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
133<br />
t’ha fatto il nero più buio degli occhi<br />
il posto che è la casa vuota di me<br />
l’unghia che ritorna e spacca<br />
la carne. Da piccole macerie<br />
d’anno in anno t’ho raccolto<br />
ed ora che potrei<br />
stringermi all’incubo che ho gridato<br />
chiudo le arterie e torno<br />
monca alla vita.<br />
non è questa l’ora del treno, resta<br />
apri gli occhi all’ombra ondulata d’oro<br />
i rami del glicine, le persiane<br />
e ora chiudili di nuovo<br />
è una ferita accorgersi che siamo<br />
due dita di una stessa mano<br />
siamo un ponte sull’acqua e il suo riflesso<br />
cerchio intero di una falce di luna.<br />
vorrei con le parole aprirti<br />
questa vita come una mano<br />
che sul tavolo capovolta<br />
aspetta d’essere riempita<br />
stretta nella tua. Vorrei la lingua<br />
a chiudere ogni foro, a intonaco<br />
di questo intreccio di sterpi bruciati.<br />
Saremo due camicie<br />
appese l’una dentro l’altra<br />
per una stagione intera<br />
dove la penombra ha immerso<br />
l’amo negli inverni.<br />
quando mi dormi in mente<br />
la stanza ha il tuo profilo<br />
ed ogni cosa un posto<br />
come le vene.<br />
Sei il figlio, e il piccolo animale<br />
fermo sulla terra<br />
annusata cercando la radice<br />
la traccia, la coda di una promessa<br />
che trattengo, fino a che è rotto<br />
questo bavaglio, e il pensiero<br />
si disegna nella linea<br />
aperta delle nostre mani.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
134<br />
se oggi avessimo la febbre insieme<br />
staremmo come due cucchiai riposti<br />
asciutti nel cassetto,<br />
c’inventeremmo i piedi<br />
avanti e indietro come stracci<br />
per le carezze ai pavimenti,<br />
o resteremmo nudi come chiodi<br />
dimenticati in mezzo alla parete.<br />
che qualcosa finisca<br />
e non resti l’affetto<br />
come una spina in bocca.<br />
Così sciolgo la veste che le labbra<br />
fanno col buio punto dopo punto;<br />
sono in strada, tra le spalle non trovo<br />
un davanzale dove si respiri<br />
intreccio le mani sul ventre e sono<br />
creta sul letto di un fiume di passi.<br />
anche quando è la scure che ci abbatte<br />
l’uno sull’altro per la sua catasta<br />
o quando in una piazza ci sfioriamo<br />
le lingue come gambi senza fiore<br />
siamo uniti e intrecciati con pazienza,<br />
un canestro che dondola alle dita.<br />
Da IV – UN RUDERE LA CASA<br />
Leggo stesa, il libro sul torace<br />
è il mio terzo polmone<br />
che s’apre e si richiude.<br />
Stavo sognando la mia muta,<br />
avevo lettere tatuate<br />
come un anfibio stavo sulla sponda.
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
135<br />
e la diresti pronta per il viaggio<br />
la ragazza che ha lasciato, o forse<br />
perso le valigie ad una sosta<br />
e poi è trascorsa<br />
picchiettando sui colori<br />
della città: ho la forma<br />
dell’acqua e un suono<br />
come ogni animale un verso.<br />
il passo sui binari del suicida<br />
svuota le bocche e spezza<br />
le redini di affetti incontrollati.<br />
Ora l’infante potrà camminare<br />
con l’equilibrio che porta le braccia<br />
a sollevarsi inermi dalla terra.<br />
È un giorno strabico, e le persone<br />
s’affacciano sul proprio sangue fermo<br />
chiedendo dove sbuca la corrente<br />
che spinge rossa e perfora gli occhi.<br />
L’obitorio è un lago calmo: le barche<br />
ovali come il seme di una donna,<br />
la carne dove dorme sempre un figlio.<br />
un solo viaggio eterno, questa luce<br />
torna mia con un gesto dell’indice,<br />
e dentro gli occhi un davanzale ampio<br />
ultimo piano dove sono sporto<br />
da una casa vuota con la chiglia<br />
vedo gli istanti che sembrano fermi,<br />
uomini andare incontro al mare<br />
aperto, i cieli flessi,<br />
ponti minati e uccelli<br />
come archi all’orizzonte.<br />
Ora ogni cosa prima<br />
di sciogliersi o partire<br />
ha preso posto nella mia iride<br />
vagone di seconda in quante città<br />
sovraffollato, la gente in piedi scossa<br />
dalla stanchezza lungo i corridoi<br />
fino a che il buio e la provincia<br />
disseminano ognuno in un suo luogo.<br />
a Mario Dondero
Da Mala Kruna, 2007<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
136<br />
come l’interruttore nella notte<br />
che trovo accarezzando la parete<br />
del mio vivere so dov’è l’amore<br />
a tentoni ritorno a sedici anni.<br />
E tu sempre resti cara<br />
amica che mancavi<br />
a quel mattino mio di figlio<br />
bagnato dal suo latte.<br />
Accadde allora che un lenzuolo<br />
tenero m’avvolse dalla nuca<br />
imprimendo i contorni che ora vedi,<br />
l’immagine che sono.<br />
più neanche chiedo un laccio o un gancio<br />
a te che mi svapori come un segno<br />
d’alito sul vetro. Sorridi o è il flauto<br />
suonato con i bordi del bicchiere?<br />
Per le carezze devo<br />
rivolgermi alla pioggia, al suo<br />
tocco di acini caduti.<br />
Mentre voltandoti guardavi<br />
il cielo scuro come un pergolato<br />
aperte le braccia perdevo le mani<br />
come stringendo un tronco centenario.<br />
Un altro tuo respiro trattenuto<br />
e l’incavo racchiude la corteccia:<br />
rimango in piedi sola<br />
a formare una croce<br />
piantata su una vetta.<br />
guardo il buio con queste<br />
corde che si muovono, e ascolto<br />
la nave luminosa che si ferma.<br />
Prenoto e annuncio ancora il mio partire:<br />
oltre la grata della porta il vuoto<br />
s’alza come una torre; e un altro<br />
vicino a me è ancorato<br />
e si sbriciola in passi sulla strada. E io non so<br />
se salgano o scendano le corde<br />
da questo pianerottolo, ma vedo:<br />
l’immagine di me che si spazienta<br />
entrare con i piedi su una terra<br />
morbida e pestata molte volte.
Su Mala Kruna<br />
[...] Si muove per oscure volute, per lampi improvvisi e perentori, richiamando incunaboli surrealisti, la silloge Mala kruna della fanese Franca<br />
Mancinelli. La deflagrazione del sotterraneo fuoco lirico che ne alimenta il fiato scardina la sintassi logica, rompe la tenuta prosodica, instaura<br />
un codice figurale imprevedibile e tagliente. L’esperienza di un vissuto femminile pulsivo e dinamico si viene così a proiettare (e trova echi) in<br />
un frammentato universo che restituisce, a chi vorrà e saprà raccoglierli, pezzi schegge ed emblemi di una irrelata ventura creaturale. Prima del<br />
senso, l’ardua decifrazione percepisce la giustezza, si direbbe la giustizia, dei minimi testi che punteggiano la sinopia del percorso. […]<br />
Pasquale Maffeo, Premio “Senigallia – Valerio Volpini” 2005, motivazione<br />
* * *<br />
[…] In un paesaggio marchigiano di provincia e treni regionali, questi versi di Franca Mancinelli esprimono il dolore di un’unione che non giunge,<br />
di un’unità colta solo nel miracolo, di un amore intravisto e immensamente voluto. Versi essenziali e scavati che dicono il nostro essere<br />
prigionieri del male e il nostro essere sospinti verso una difficile gioia. […]<br />
Milo De Angelis, Premio “DeltaPOesia”, 2006, motivazione<br />
* * *<br />
[…] L’intonacatura come intonazione: potrebbe essere questa una possibile etichetta, per quanto odiose siano tutte le marche applicate alla<br />
poesia, per poter dire qualcosa intorno ai testi di Franca Mancinelli. Sì, attorno, perché questa poesia, apparentemente sottile e leggera, in<br />
realtà nasconde una forza di chiusura tenacissima, quasi maschile, e un’altrettanta crudeltà nei confronti di chi legge e di chi la avvicina.<br />
Chiusura e crudeltà, beninteso, patite in maniera molto forte dallo stesso poeta, quasi per assecondare una radice profondissima e inscalfibile,<br />
tragica. E sappiamo bene, del resto, che questa involontaria strategia, da non confondersi con più o meno programmatici trobar clus, si verifica<br />
solitamente laddove la ferita e l’emorragia è più copiosa e sanguinante. […]<br />
Andrea Ponso, Un rudere la casa, “Pelagos”, 11, settembre 2007<br />
* * *<br />
[…] Mala kruna è un libro pieno di spine, intrecciato a grumi di consonanti. L’assente si disperde nel giro dei tempi e dei luoghi, per una sorta di<br />
fato da scontare. Talvolta “chiusa” fino all’impenetrabilità, la lingua di Franca Mancinelli cela un’attesa, che si ammanta di aculei e così, forse, si<br />
fortifica. […]<br />
Daniele Piccini, Dietro le spine un’attesa, “Famiglia Cristiana”, 41, 14 ottobre 2007<br />
* * *<br />
[…] Mala kruna, questa “piccola corona di spine”, è una poesia di risposte negate. Di trafitture o piuttosto di aghi. Di ruderi e perciò<br />
disfacimenti. Di sangue e di acque. Questi i geroglifici fondamentali dell’intima tetralogia (Oltre la giostra; Il mare nelle tempie; Nel treno del<br />
mio sangue; Un rudere la casa) di Franca Mancinelli.<br />
La rovina, i frammenti, sono quelli degli affetti familiari, amorosi o amicali che segnano la persona e persino il paesaggio: quello marino e<br />
collinare<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
137
Su Mala Kruna<br />
collinare del marchigiano, non nominato mai, quanto piuttosto mappato emozionalmente; così che dall’ampia distesa del mare, dalla mole dei<br />
colli, ci si trova in un battito cardiaco a tenere fra le mani “un tulipano” o “animali addormentati nella tana”. Il buio cala presto sulle rive, sugli<br />
“sterpi bruciati”; ci si “scuce” e si “frana”. Ma sono trafitture inesorabili, ineluttabili, necessarie. A volti senza nome che svaniscono nelle<br />
stagioni, alle ferite senza risposta del tempo, l’autrice oppone sensazioni e memorie: d’infanzia e d’adolescenza, on libri aperti sul petto “come<br />
un terzo polmone”, e giovinezza “d’appartamenti barricati”. Ma soprattutto oppone la “lingua”. Un verso che si spera possa “chiudere ogni<br />
foro”, stendere “un intonaco”, ricomporre la frana. Non però sostituendo una metrica, e luoghi e corpi nuovi al ritmo del mondo; non è una<br />
lingua fisica, onomatopeica, che imita la consistenza oggettiva delle cose. È una lingua che si rimescola nel “sangue”, e dà nomi più ferini e più<br />
crudeli al sentire. Che dice che “con la marea che scopre le coperte / spuntano dalla pelle gli aghi”.<br />
Il valore della poesia di Franca Mancinelli sta nel non maturare alcuna egotistica weltanschauung, nell’accogliere l’avventura dell’esistenza<br />
lasciandosi, docilmente persino nel soffrire, incidere e attraversare. Poiché, come avvertono i versi di Dante in epigrafe alla raccolta (Inferno,<br />
XXVI, 94-95), “né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio padre, né ’l debito amore” possono trattenerci dal percorrere il vivere. […]<br />
Alessandro Forlani, “clanDestino”, 3-4, autunno/inverno 2007<br />
* * *<br />
[…] La poesia di Franca Mancinelli è in quel dito, in quel gesto che fisso punta una stagione che non potrà tornare più. Le mani allora diventano<br />
la culla dell’adolescenza, premute sulle labbra sono il luogo eterno dove si avvicina un fiore o si imprime il pensiero. In Mala kruna è forte l’idea<br />
di un’unione indissolubile: “siamo uniti e intrecciati con pazienza”, “camicie appese l’una dentro l’altra”, “staremmo come due cucchiai riposti<br />
asciutti nel cassetto” o come “chiodi dimenticati in mezzo alla parete”. L’allontanarsi di una certezza si profila intensamente nella seconda<br />
parte dell’opera Il mare nelle tempie, qui la donna torna nella sua stretta carnalità, nel suo essere sempre attaccata a un scoglio come un<br />
anfibio sulla sponda o un’alga bruna sempre investita da una luce obliqua che taglia e divide. Il mare è vissuto come uno spasimo, distribuito<br />
sotto i colli, un mare “che batte nelle tempie e addormenta”. E poi un’infinita dolcezza che fa di questi abbandoni una trama fitta e presente: il<br />
mare lascerà spazio a quel “partire per tempo, l’accompagnarsi in gita”. Nel trapasso dei giorni, nell’odore di una terra morbida e pestata molte<br />
volte, la poesia di Franca Mancinelli resta sospesa da una spinta: una presenza costante che imprigiona il tempo, una presa, un’arteria spezzata,<br />
un’ombra sorretta dietro una culla: all’inizio della vita e forse anche della morte.<br />
Alessandro Puglia, Una piccola corona di spine per una delle migliori giovani poetesse italiane, “La voce di romagna”, 3 marzo 2008, poi con il<br />
titolo La corona di spine della Mancinelli, “Il sottoscritto”, 1, aprile 2008<br />
* * *<br />
Franca Mancinelli è al suo primo libro di poesie e ha scelto come viatico un frammento dell’Ulisse dantesco, tra l’altro per indicare l’inizio del<br />
viaggio, uno scioglimento dei legami familiari, la maturità che intende affrontare dopo aver ripercorso in Mala Kruna (Manni 2007) “tre età<br />
della vita”, questo almeno viene affermato in quarta di copertina; quindi suppongo che si trovi – nella sua privata partizione temporale – in una<br />
sua terza età. Insisto sull’aggettivo possessivo perché implica anche una notazione di linguaggio: utilizzando una intuizione di Pier Vincenzo<br />
Mengaldo che era rivolta a una delle poetesse più inventive e inquietanti nel nostro panorama novecentesco, si potrebbe dire che Franca<br />
Mancinelli cerca di far coincidere una sua lingua privata con la lingua della poesia. Ora, mentre la lingua poetica di Amelia Rosselli è molto<br />
complessa e variegata, così come lo erano la condizione psicologica e lo stato gassoso delle sue angosce, quella alterazione fortemente<br />
dinamica<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
138
Su Mala Kruna<br />
dinamica e patologica della sensibilità che, diceva appunto Mengaldo, “lascia agire la lingua”; in Franca non sembra esserci nulla di patologico<br />
ma la sua poesia instaura un linguaggio parallelo, a volte reticente per riduzione rispetto al vissuto che riemerge, a volte gelosamente afasico<br />
quasi a salvaguardare l’unicità del proprio passato e l’anonimato delle figure che agiscono come sparring partner nel suo percorso poetico di<br />
formazione.<br />
Non sappiamo chi è il lui delle poesie di Oltre la giostra e delle altre sezioni del libro, e probabilmente questo pronome indica più persone<br />
maschili di diversa età e ruolo che recitano come comparse affettive nella dinamica dei ricordi, forse per questo il lettore si trova incerto tra<br />
indicatori di linguaggio ambigui e riferimenti privati ancora caldi di sensibilità ma lasciati in un loro stato nascente, frammentari e genuini:<br />
“restano i suoi occhi lontano, / oltre la linea mobile del grano”.<br />
C’è questo rapporto contraddittorio tra una voce che “ditta dentro” però rispettando una deontologia della privacy e un mostrare e mostrarsi<br />
di una affettività sincera, germinale, che vorrebbe diventare linguaggio condiviso, umanità condivisa: credo che la ricchezza del libro sia proprio<br />
qui, nello stupore di una coscienza che colleziona amorosamente i propri frammenti più cari o più vividi, senza collocarli razionalmente<br />
nell’album degli schizzi che i viaggiatori portavano con sé mentre facevano le loro esperienze di vita. “Nel treno del mio sangue / salite”.<br />
Marco Ferri, Mala Kruna, linizio del viaggio, “Scirocco”, 22, aprile / giugno 2008<br />
* * *<br />
Talmente è ricorrente in Mala kruna, opera prima di Franca Mancinelli, Manni 2007, la presenza della dicotomia buio/luce, che l’impressione, a<br />
lettura ultimata, è quella di essere entrati, e usciti, dal Tempio di Delfi, abitato da Apollo durante le estati calde e inondate di luce, e da Dioniso<br />
durante gli inverni, naturalmente scuri, bui.<br />
Il fatto è che, durante il breve soggiorno tra le pagine di Mala kruna, le divinità sono entrambe presenti e, attribuire all’una (Apollo, la<br />
coscienza) o all’altra (Dioniso, l’inconscio), le proprietà del buio e della luce, elementi presenti innumerevoli volte nel libro, è impresa ardua<br />
quanto inutile, dal momento che, tra l’uno e l’altra, Franca Mancinelli è costantemente “in bilico” (p. 16).<br />
L’accezione, inoltre, varia, e il buio è visto tanto nella sua valenza negativa: “non posso / dare la guancia al buio” (p. 14); “t’ha fatto il nero più<br />
buio degli occhi” (p. 34); “il rullo di granelli destinati al buio” (p.33), quanto, a ben vedere, positiva: “nella notte un estuario tra le tue braccia”<br />
(p. 28); “la notte camminavo tra le zolle” (p.33). Notti, queste, che rimandano a un altro conosciutissimo mito: Psiche era felice, al buio, con<br />
Eros.<br />
E dunque, in Mala kruna, il rimpianto di un tempo (o meglio, di una sosta) trascorso, non più esistente, ma non per un atto della propria<br />
volontà, è tanto più amaro proprio in quanto subito. L’abbandono si attesta non come l’ovvio buio, ma proprio come luce. È “la luce” che<br />
interrompe l’amore: “ora solleva una luce la terra” (p.33). La luce stessa, dunque, è metafora certo del bene, quanto del male. Lo dimostra<br />
anche “la luce” di invidierai l’aria che rimane (p. 61), una luce asfittica, pesante. […]<br />
Il rifiuto di un “mondo fermo / di cose intonacate e appese” (p. 14) si realizza dunque in una personale via crucis [si motiva la definizione: lo<br />
stesso titolo, in croato, significa piccola corona di spine; il termine “stazione” (p. 49); il trovarsi “a formare una croce / piantata su una vetta” (p.<br />
60)]. Ma le resta ancora un nuovo “partire” (p. 62), una nuova aderenza alla vita: “entrare con i piedi su una terra / morbida e pestata molte<br />
volte” (p. 62). Una terra che piace pensare non come vuoto, terreno familiare della morte (cfr. p. 29, con la marea che scopre le coperte), non<br />
come un passo nel vano buio di un ascensore, ma appunto come riconquista di un cammino nuovamente illuminato, recuperato il proprio sé,<br />
forse ancora ferito e lacero, ma comunque indipendente e autonomo, padrone unico del proprio corpo. Riprende insomma, Franca Mancinelli,<br />
per<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
139
Su Mala Kruna<br />
per svilupparlo originalmente, il topos del “viandante” che al di fuori di sé ed in sé, pur subendo perdite e dolori, ritorna, e si riconosce.<br />
Norma Stramucci, Mala Kruna: osservazioni sul buio e sulla luce, “La Gru” (www.lagru.org), 9, aprile 2008, poi “La Gru”, 5, giugno 2008<br />
* * *<br />
Piccola corona di spine è la traduzione – dal croato – di Mala kruna, titolo del primo libro della poetessa Franca Mancinelli (marchigiana, classe<br />
1981). Quelle parole hanno il sapore di un presagio, avvertito nella poesia che apre la raccolta, dove una madre nera interpreta il messaggio<br />
contenuto nell’aria: “ti venne a fianco e ti disse del vento / un cattivo tempo che non faceva / partire le barche”. Da subito si nomina il viaggio<br />
che accompagnerà, come una costante, tutta l’opera: dal passato si arriva a scrutare l’orizzonte, con momenti di dolore anche fisico, perché si<br />
viaggia attraverso il corpo. […]<br />
In questo passaggio dall’infanzia all’età matura non è difficile trovare un parallelo col dipinto di Gustav Klimt, Le tre età della donna (1905): un<br />
percorso nelle fasi decisive della vita femminile, interpretato come un rinnovamento, anche se nel quadro questo processo va letto in modo<br />
inverso (dalla vecchiaia si passa all’infanzia).<br />
Viaggiare – come metafora del processo di maturazione - significa anche perdere piccole parti di sé, sbriciolandosi verso una disintegrazione<br />
che si ripete nelle poesie della terza sezione: “sono seduta in briciole” (p.44), “è la scure che ci abbatte” (p.45), “l’amore in petali sul<br />
pavimento”, “mentre mi scucio e frano” (p.38), “da piccole macerie / d’anno in anno t’ho raccolto” (p.34). Il soggetto si frantuma, ma<br />
contemporaneamente si riorganizza in una geografia del corpo evidente nelle molteplici tracce: dito - lingua - costole - bocca - piedi - gambe -<br />
voce - corpo - pollice, tutti compresi in un unico testo; e ancora: piaga - saliva - petto - occhi - sangue, in un altro. Per arrivare al titolo, centrale,<br />
della terza sezione: Nel treno del mio sangue, dove trasporto, dolore, organismo si fondono.<br />
La scrittura di Mancinelli ha il pregio di avvicinare gli estremi, quando le “costellazioni” convivono con una “busta della spesa” (p.36), o quando<br />
si passa dai “non generati” al momento della nascita, col “grido che ha rotto ora le acque” e infine alla morte (p.30). Questa percezione è<br />
rafforzata da alcuni elementi strutturali del libro: spesso il titolo delle sezioni risuona come un’eco di qualcosa già udito altrove, di espressioni<br />
ripetute nelle pagine precedenti (o successive). Così l’opera è suddivisa da momenti / titoli che sono di apertura ma anche di chiusura, in un<br />
movimento tutto circolare: “scandite al buio le parole sono un cerchio” (p.26). E allora, la morte si ricongiunge con la vita in modo esplicito e<br />
straordinario in questi versi: “L’obitorio è un lago calmo: le barche / ovali come il seme di una donna, / la carne dove dorme sempre un figlio.”<br />
(p.52).<br />
Rossella Renzi, “land”, 1, 2008<br />
* * *<br />
[…] Questo libro è […] un rosario pungente per preghiere terrestri, corporali. Del rosario ha la mancanza di una vera e propria soluzione di<br />
continuità: ogni testo comincia con la minuscola quasi fosse la continuazione di un borbottìo interiore. Non c’è però un Dio a cui il poeta si<br />
rivolge, l’interlocutore è una presenza/assenza fisica: “se oggi avessimo la febbre insieme / staremmo come due cucchiai riposti / asciutti nel<br />
cassetto, / c’inventeremmo i piedi / avanti e indietro come stracci / per le carezze ai pavimenti”. Della spina ha la capacità di penetrare: la<br />
ferita, il taglio, la puntura sono immagini centrali del libro. Con questo fare tagliente il poeta scava dentro i corpi, gli elementi naturali e<br />
artificiali del mondo circostante, che al suo sguardo e al suo soffio si trasformano in strumenti musicali: “qua dove ogni parola è ramo rotto /<br />
albero<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
140
Su Mala Kruna<br />
albero di musica in riva al mare”; “ho la forma dell’acqua e un suono / come ogni animale un verso” ; “guardo il buio con queste / corde che si<br />
muovono, e ascolto / la nave luminosa che si ferma”. Ne risulta una musica creaturale, panica e metamorfica… […]<br />
Valerio Cuccaroni, “Poesia”, 226, aprile 2008<br />
* * *<br />
[…] si sviluppa come una sorta di romanzo familiare dove la poesia percorre e scandisce i tempi e la vita della protagonista, un’esistenza fatta di<br />
molte figure che nel tempo scorrono e si avvicendano con le poche certezze che i rapporti umani possono definire. In questa vita così precaria,<br />
continuamente modificata, il paesaggio poetico è preso nella propria interezza dalla figura narrante che, nonostante l’esile struttura, sembra in<br />
grado di reggere tutto il peso del vivere, tutti i cambiamenti, tutti gli addii.<br />
Cambia in un certo senso la figura femminile rispetto ai “corpi forti”, cui le ultimissime poetesse italiane ci hanno abituato: non più insomma il<br />
segno con la pietra dura tracciato ad esempio da Elisa Biagini, Tiziana Cera Rosco, Laura Pugno o Sara Ventroni, quel segno che con il suo<br />
essere forte si porta dietro anche una disperata fragilità, quanto piuttosto una condizione in qualche modo almeno ultimamente “nuova” che<br />
oggi vede autrici come Franca Mancinelli o Isabella Leardini salire alla ribalta con un’idea di corpo come “albero sottile” in grado comunque,<br />
nonostante manchi completamente una muscolatura possente di sorreggere il mondo (“hai baciato il mio osso sporgente / l’anca ramo ricurvo:<br />
/ svanisce il filo di sassi sulla schiena / e ti siedo di fronte / a radici aperte”, p. 25), dove l’amore stesso sembra così grande da potere<br />
attraversare tutto (sia quando è presente, sia quando è assente) come fa il chiodo attaccato alla parete: “se oggi avessimo la febbre insieme /<br />
staremmo come due cucchiai riposti / asciutti nel cassetto, / c’inventeremmo i piedi / avanti e indietro come stracci / per le carezze ai<br />
pavimenti, / o resteremmo nudi come chiodi / dimenticati in mezzo alla parete” (p. 41). […]<br />
L’epopea familiare, che a suo modo la Mancinelli racconta, propone anche un sorprendente attaccamento alla vita, anche quando questa è<br />
minima e le sofferenze non sono “sovraumane”, ma “quotidiane”, “popolari”: anche in questo senso la svolta generazionale è importante,<br />
tornano insomma temi e modi che negli ultimi anni le nuove autrici sembravano non volere più affrontare, troppo concentrate a ripercorrere le<br />
strade care alle poetesse degli anni Settanta e delle Avanguardie, troppo coinvolte e troppo innamorate, per esempio, da una poesia come<br />
quella di Amelia Rosselli.<br />
Nei corsi e ricorsi storici invece la poesia di Franca Mancinelli si riconduce a un discorso intimo, più vicino se vogliamo al lavoro di Patrizia Cavalli<br />
di cui nelle molte differenze ripercorre “il respiro” (“leggo stesa, il libro sul torace / è il mio terzo polmone / che s’apre e si richiude”, p. 50) e<br />
così il verso, anch’esso mai barocco, quanto piuttosto essenziale, efficace, diretto, asciutto. […]<br />
Matteo Fantuzzi, “Atelier,” 49, marzo 2008<br />
* * *<br />
[…] Mala kruna è un libro dove le metafore della Mancinelli sorprendono per la loro incisività e precisione. L’idea del viaggio in treno è concreta<br />
e al tempo stesso ideale. Progressive perdite e abbandoni, come riportato nella quarta di copertina, accompagnano la poetessa nel suo sostare<br />
e nel suo andare. Un romanzo poetico di formazione, senz’altro, questo Mala kruna (che vuol dire, in croato, “piccola corona di spine”). Si pensi<br />
ai versi d’apertura, ariosi e struggenti, lineari e significanti nel loro afflato esistenziale: “all’orizzonte un mare diverso / fermava il sangue sotto<br />
le unghie; / madre nera nell’isola / ti venne a fianco e ti disse del vento…”.<br />
C’è un altro aspetto saliente che cattura in questi versi, e cioè il rigore e la misura, senza sussulti, senza sfasature, sul piano strutturale. La<br />
parola<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
141
Su Mala Kruna<br />
parola stessa è perentoria, testimonianza di una vicenda autobiografica, di una ferita da chiudere nella vita e riversata nello scrivere. L’autrice si fa<br />
interprete di una domanda sul senso della perdita intesa anche come fine di qualcosa che non tornerà più. Una volontà, la sua, manifestata nel<br />
bisogno d’amore che risulta una richiesta garbata, una considerazione che va oltre il presente, oltre il contingente: “dal giorno che non rispondi<br />
allo sguardo / cresce ruga sul gomito il ricordo, / sui tavoli dell’asilo non segui / l’impronta non pensi / che oltre la giostra / c’è ancora lui che<br />
dorme in fondo, / e non lo puoi svegliare” […]<br />
Anni consueti e anni riguardati con “nostalgia creatrice,” con un bisogno d’abbandono che “reperisce” le cose e le riesamina attentamente. E<br />
ancora attimi che restano indelebili, abitudini, pensieri che affollano la mente specie nella sezione Un rudere la casa, probabilmente la più bella.<br />
Franca Mancinelli nomina “la forma dell’acqua” come qualcosa che le appartiene. Ed è proprio questo il lato più riuscito di Mala kruna nel<br />
progetto intenzionale: cogliere una percezione che transita nella propria esistenza, che si fa radice, sostanza, verità propria. Il dialogo inscenato<br />
include smarrimento e ritrovamento, fuggevolezza, il peso di interrogativi per lo più impliciti. Le associazioni mentali e l’affiorare spontaneo di<br />
un’attesa corroborano i versi senza cadute di tono. La parola asciutta risulta spesso fulminea, esatta, insostituibile. E con essa l’incedere in un<br />
viaggio che è soprattutto di conoscenza nella complessità del reale.<br />
Alessandro Moscè, Mala Kruna: un viaggio d’amore reale e ideale, “La clessidra”, 1, 2009<br />
* * *<br />
[…] preme sottolineare lo stile alto di Mala kruna […] levigato per successive passate, essenziale al fine di sfogliare il superfluo dal midollo del<br />
problema, che, per Franca Mancinelli, mi pare coincida con la ricerca di un senso unitario da attribuire alla propria esistenza giunta alla fine di un<br />
ciclo, con la necessità di ricucirne le tessere. Non a caso, “ago” è altra parola chiave del libro, che sposta sintomaticamente l’attenzione dall’eroe<br />
navigatore Ulisse (cui l’esergo riferisce), alla stanziale Penelope, a colei che tiene insieme e scuce di continuo il tessuto del viaggio, colei che di<br />
notte si toglie dal tempo della successione, per abitare l’intimità del tempo privato, che va verso il profondo di sé anziché più in là, nel mondo.<br />
Mala kruna, a ben vedere, corre su questo duplice binario: il tempo maschile del viaggio, della crescita come adattamento all’ambiente, della<br />
morsa con cui aderire alle cose, alle persone, per sopravvivere; e l’immobilità, il tempo femminile, che fugge dalle dita come sabbia (“la foglia che<br />
si volta non si salva”), tondo come un ventre, dilatato anche dall’uso frequente del presente indicativo per nominare il passato, così da<br />
trasformarlo in un eterno accadere, che si perpetua nel cuore delle tenebre. Il primo movimento, tuttavia, corre in superficie, porta la croce della<br />
narrazione biografica, del racconto con testimone. Ad esso spetta il carico emotivo, la funzione comunicativa e fàtica insieme, che lega il lettore al<br />
secondo momento, di carattere conoscitivo. Come nel romanzo di Conrad, Mancinelli cerca infatti la propria ombra sepolta nel tempo, quel Kurtz<br />
stanziale in un indefinibile altrove, simbolico fanciullo nell’amnio africano, adorato e morente, che la abita da sempre. A cercare di rifondare il<br />
cordone ombelicale che li lega, è Mancinelli-Penelope nel segreto della scrittura-tessitura, femmina che, per il resto del giorno, vive in una casa<br />
assediata, in “un rudere” abitato da malattia e morte, come lascia intendere l’ultima sezione del libro. Due sono dunque i poli archetipici entro cui<br />
il dialogo esistenziale matura, sottotraccia al clamore del mondo, reso invece operoso dal viaggio: la madre e il figlio, entrambe figure<br />
dell’immobilità, chiuse nella bolla d’un tempo familiare ma gelido, vicine “come chiodi / dimenticati in mezzo alla parete”. La scena è mortuaria, e<br />
trova il suo stemma nella clausola a il passo sui binari del suicida: “L'obitorio è un lago calmo: le barche / ovali come il seme di una donna, / la<br />
carne dove dorme sempre un figlio”.<br />
Il fanciullino della poetessa fanese attraversa invero l’intera cultura occidentale, da Platone a Pasolini, passando per Rousseau e per il dialogo<br />
mortale che Bonnefoy tesse con Douve, in un testo cardine del secondo Novecento. Mentre tuttavia là il matrimonio fra gli opposti si realizza<br />
(“Luce segreta è lei che arde i nostri gesti, / Così camminiamo rischiarati”), Mancinelli, anche per ovvie ragioni anagrafiche, fa i conti ancora con la<br />
nominazione delle parti, con il mistero che l’interiorità, scopertasi fonte, custodisce. […]<br />
Stefano Guglielmin, Mala Kruna ovvero come recitare l’abisso, “Tratti”, 86, febbraio 2011<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
142
Un verso è una vasca e altri appunti sulla poesia<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
143<br />
Quando percorro avanti e indietro le vasche di una piscina, alla ricerca di quello stato di narcosi che mi coglie<br />
poco tempo dopo il ritorno all’asciutto, mi seguono inizialmente alcuni pensieri. Scorrono leggeri sulla<br />
superficie insieme alla mia chiglia, fluttuano appena sulla linea nera che guardo per non deviare. Per un’ora<br />
circa avrò soltanto alcuni gesti, con le braccia che a volte sembrano tagliare l’acqua in un modo esatto,<br />
disegnare un arco deciso, oppure oscillare e cedere all’informe; ripeterò gli stessi gesti fino a quando sentirò<br />
le spalle muoversi in un celeste che lentamente si solidifica. Allora risalirò dalla scaletta, ascolterò la doccia e il<br />
phon, e tornata a casa lentamente verrò richiamata nel fondo, dove si depone il governo delle mie forze.<br />
Alle prime bracciate, quando ancora l’acqua non è stata dissodata e i miei archi procedono incerti, mi sembra<br />
di continuare a scrivere, su un foglio limpido, con tutto il corpo. Penso che si arrivi alla fine di un verso, come<br />
di una vasca, muovendosi all’interno di una misura. Una serie di gesti si ripete fino a che si raggiunge una<br />
sorta di equilibrio per cui sembra di non muoversi, ma di essere portati. Chi infrange il codice di movimenti e<br />
si dibatte oltre la forma stabilita, affatica il suo corpo e alla lunga lo addolora. I suoi schizzi suonano stonati,<br />
non necessari. Sbaglia per incapacità o per ignoranza. Ne vedo diversi avanzare sul dorso battendo le gambe<br />
con i ginocchi piegati, oppure andare di continuo ad urtare con il gomito i galleggianti delle corsie; danno<br />
l’impressione di animali finiti in acqua per errore, o di nuove specie lacustri, disarmoniche, sorte in seguito a<br />
qualche modificazione chimica. Conservo con gratitudine le frasi dei miei insegnanti di nuoto; ricordo ancora<br />
quando uno mi disse che l’acqua non fa del male, ed appena lo sentii e mi abbandonai a lei, trovai la<br />
leggerezza che serve per nuotare sul dorso, senza temere di bere dal naso. Il fatto è che i movimenti sono già<br />
tutti scritti. L’unico pensiero è quello di aderire, di eliminare ogni intenzione che fuoriesce dal tracciato.<br />
Anche se si arriva al bordo della vasca con un turbinio di rabbie e di rancori, nello stesso istante in cui ci si<br />
affida all’acqua le passioni come scorie tendono verso il fondo, liberano i propri riflessi nel gioco della<br />
superficie. Con il roteare delle braccia e il battere delle gambe, poi sembrano del tutto dissipate. In realtà<br />
hanno obbedito a leggi più grandi dell’istinto, e all’interno di quel rito di obbedienza si sono placate. Allo<br />
stesso modo, quando ci si affaccia alle soglie di un verso, non si arriva alla sua fine senza che lo stato emotivo<br />
che ci portava, non sia stato in qualche modo addomesticato. Si scrive con la stessa cieca consapevolezza con<br />
cui si nuota: ogni intenzione o slancio deve essere sorretto da tutto il corpo, approvato dalle sue forze e dalle<br />
sue riserve. Ogni gesto deve confrontarsi con la necessità di resistere fino a toccare almeno il bordo della<br />
vasca.
Un verso è una vasca e altri appunti sulla poesia<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
144<br />
Non si sovverte la tradizione in un attimo, in un sussulto di immaginazione eccedente. Se mai nascerà un<br />
nuovo stile, o una variante all’interno di quello codificato, sarà per un progressivo e lento distacco dai<br />
movimenti precedenti, attraverso prove calibrate, minime infrazioni accolte.<br />
Lo stile libero non esiste, non si è mai liberi se si vuole nuotare.<br />
*<br />
Le uova ci sono e l’oca le cova. Forse è passato un mese, forse tre. Un vecchio che viene a potare la siepe dice<br />
che il tempo della cova è terminato, che là sotto, se c’è qualcosa, è tutto morto, e che se non si tolgono le<br />
uova l’oca continuerà ad avvolgerle nel ventre, fino a perdere le forze e ad ammalarsi. Il vecchio allora si china<br />
sul nido, prende le uova una ad una, le avvicina all’orecchio e le scuote. Quelle che fanno un rumore sordo le<br />
spacca contro una pietra. Sulle zolle si apre un liquido rosso e marrone, gelatinoso e maleodorante. La<br />
maggior parte delle uova viene aperta, poche vengono rimesse nel nido. Assistiamo a questo rito consapevoli<br />
che una minima imperizia decide la vita.<br />
Anche nello scrivere c’è un tempo oltre il quale ogni più premurosa costanza e dedizione non valgono a nulla:<br />
da quel testo non nascerà una poesia. Un lettore attento e con esperienza può aiutarci a riconoscere quale<br />
testo può avere ancora speranze. Forse con il tempo impareremo a distinguere da soli il suono della fissità e<br />
quello da cui può nascere la vita. Ma facilmente chi ha fatto le uova è portato ad aspettare oltre ogni limite, a<br />
riversare nella possibilità tutto se stesso. Certe cose invece non dipendono neanche del tutto da noi. A volte<br />
bisogna semplicemente alzarsi dal foglio, abbandonare il nido, e continuare a muovere passi nell’erba.<br />
*<br />
Senza una minimo di amore per se stessi non si parla, né tantomeno si scrive. Posso dirlo perché ho<br />
combattuto contro la mia statua di pietra, le ho lanciato calci e pugni. Forse, nella furia, l’ho appena scalfita.<br />
Poi dev’essere accaduto che ho smesso di fissarla con gli occhi bianchi, ho smesso l’ostinazione. E lei si deve<br />
essere lentamente ammorbidita, fino a riprendere consistenza umana.<br />
*<br />
Contro noi stessi si può fare molto. Io ho desiderato e immaginato molto. Ma non avevo armi: la lametta<br />
scivolava sul polso come burro e la linea gialla non si faceva oltrepassare. Contro di me ho fallito, non ho
Un verso è una vasca e altri appunti sulla poesia<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
145<br />
non ho portato a termine o concluso. Poi ho impugnato la penna ed ho iniziato ad aprire lunghi tagli sulle<br />
braccia. Ho squarciato il ventre e l’ho visto sorridere. Più era profondo e esatto il colpo, più stillava gioia.<br />
*<br />
È come quando si giocava da soli con il pallone contro la parete. È dal modo in cui torna il pallone che ti<br />
accorgi se hai tirato bene. Solo che il tempo del rimbalzo è allungato a dismisura; e poi non sai più se fidarti di<br />
te stesso, vorresti che a ricevere il pallone fosse un altro. I momenti più difficili poi sono quando tiri e non<br />
riesci a prendere, quando scrivi e non riesci ad ascoltarti: il gioco diventa sordo, i rimbalzi senza ritmo, fino a<br />
che arriva il momento di smettere tutto e di sedersi. Nel gioco c’è un meccanismo congenito che segna il<br />
limite tra la vita e l’autodistruzione.<br />
*<br />
I versi sono i voli di un insetto imprigionato. Non si sa che cosa abbia portato l’insetto attraverso la fessura (un<br />
istinto innaturale forse, una bussola infranta). Una volta nella casa, si accorge presto che non è il suo luogo.<br />
Un verso nasce quando l’insetto cerca la via d’uscita dirigendosi dove vede più luce. La fine di un verso è lo<br />
sbattere dell’insetto contro la parete invisibile del vetro. Voli e versi si ripetono, ad una cadenza che si fa più<br />
ossessiva con l’aumentare della consapevolezza che la vita continua fuori, da dove si è venuti. Voli e versi sono<br />
fallimenti.<br />
La maggior parte degli insetti si consuma dentro la casa: si afflosciano alla fine arresi, si posano inebetiti<br />
dall’urto continuato.<br />
*<br />
Il lavoro del cameriere è fatto di sguardo, distanza, immaginazione. Il suo compito è fare in modo che nessuno<br />
chieda di lui. Invisibile compagno, mastica nel pensiero quello che i clienti hanno in bocca. È come se fosse<br />
seduto accanto ad ognuno e invece è sempre in piedi, alle loro spalle, in qualche luogo imprecisato.<br />
In genere ogni cameriere ha un suo ruolo e un suo settore della sala: alcuni prendono soltanto le ordinazioni,<br />
altri si occupano dall’inizio alla fine di qualche tavolo, i primi arrivati portano l’acqua e il pane. Ma<br />
sostanzialmente si lavora tutti assieme, soprattutto quando c’è più afflusso, o quando c’è del personale nuovo,<br />
e gli equilibri e i confini non sono ancora del tutto marcati. Allora li vedi aiutarsi con uno sguardo, scambiarsi
Un verso è una vasca e altri appunti sulla poesia<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
146<br />
sorrisi silenziosi nei momenti di fatica. Vedi come con un gesto fanno capire ai colleghi che porteranno loro<br />
un’altra bottiglia su quel tavolo. E così ogni tragitto che fanno dalla cucina alla sala è utile, non va perso.<br />
Nei fine settimana di qualche anno trascorso, sono stata una cameriera mite e quasi muta; lavoravo<br />
religiosamente chiusa in me stessa, riponendo la stanchezza in un mio luogo remoto. Quando mi sono accorta<br />
dei segnali luminosi che si lanciavano gli altri con gli occhi, della tela che li teneva uniti e ogni tanto li faceva<br />
persino divertire, il mio tempo era già quasi terminato.<br />
Mi è bastato a comprendere che allo stesso modo si dovrebbe scrivere. Se non si guardano gli altri, se non si<br />
sa che cosa hanno fatto e che cosa hanno intenzione di fare, accade facilmente di scrivere pagine che<br />
resteranno chiuse, come bottiglie d’acqua arrivate sul tavolo in cui ne serviva soltanto una. Quelle che<br />
avanzano sono uno spreco di risorse e di lavoro. Quanti libri si accumulano di fronte agli occhi di lettori che<br />
non avevano bisogno di nulla? Quanti scrivono come lavora un cameriere attento? Quanti spartiscono con gli<br />
altri la fatica?<br />
*<br />
Cessate le fatiche e i ripensamenti, ci si ritrova con il proprio libro in mano. Anche quei versi che continuano<br />
ad emanare un sottile stato di allarme, come non avessimo fatto il possibile per farli funzionare, tacciono<br />
come i grandi pilastri della corrente elettrica: più ci si avvicina, più si sente l’aria vibrare come per un’enorme<br />
arnia.<br />
In “clanDestino”, 4, 2008
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
147<br />
quello che sono è una finestra<br />
il peso che avevo l’ha raccolto<br />
in sacchi scuri l’alba.<br />
Anche l’asfalto spazzolato<br />
e umido si è aperto,<br />
con l’albero del parco che comincia<br />
a tradurre le nuvole alla terra.<br />
Ora ogni movimento oltre la stanza<br />
può trasportarti<br />
e luminoso il traffico rallenta<br />
perché il cappello rovesciato<br />
contenga una moneta.<br />
«ho lavorato con la morte<br />
nel cuore per un mese».<br />
E gli occhi le strabordano al pensiero<br />
delle notti quando all’altro lato<br />
del letto un fiume s’ostruiva<br />
lento di rifiuti. Poi nel sonno<br />
profondo un gran cantiere<br />
riallacciava la vita a quattro ponti.<br />
Sono vent’anni che dormiamo<br />
insieme e solo ora<br />
so che il sangue<br />
il corpo è un cucchiaio nel sonno<br />
va dal mio atrio al suo.<br />
raccoglie la notte. S’alzano farfalle<br />
sepolte nel petto, stendono ali.<br />
Quanti animali migrano in noi<br />
passandoci il cuore, sostando<br />
nella piega dell’anca, sul ramo<br />
di una costola; quanti<br />
vorrebbero non essere noi,<br />
non restare impigliati tra i nostri<br />
contorni di umani.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
148<br />
da una sponda all’altra<br />
le lenzuola erano garze<br />
ma non potevano bendarmi,<br />
tiravo e non coprivano<br />
e non potevo morire,<br />
aspettavo tremando che crescesse<br />
fino a qui, che un orlo<br />
azzurro s’allungasse<br />
a toccare l’orizzonte, la punta<br />
dell’ultima montagna.<br />
sono tornati nomadi i quadri<br />
scorrono come lampi rotti<br />
sulle pareti dove un ritmo batte<br />
chiodi insicuri, incerti semi, e tu<br />
dalla mattina presto<br />
in piedi sulla sedia<br />
a cercare l’angolatura esatta<br />
il punto a cui restare appesi.<br />
mute si sono addensate<br />
e come bende mi hanno avvolto<br />
in un sudario d’alghe secche<br />
e fieno. Si contano già i giorni<br />
dal deposito nel fondo, strappi<br />
e piccoli rinvii, prima che sorga<br />
abbandonando i succhi luminosi<br />
e i fili di bava sul cuscino.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
149<br />
è il carnefice che ti alza presto<br />
ti spella via dal buio, ti scuoia<br />
le coperte, ti scorta in corridoi<br />
scavati dentro il ghiaccio<br />
dove altri corrono levando<br />
un segno di saluto, uno specchietto.<br />
ci sono secchi sparsi nella stanza,<br />
quaderni vuoti.<br />
Lo sai che torneranno<br />
a frantumare come infiltrazioni<br />
ma piangi pure e impara<br />
dalle grondaie colme<br />
acquasantiere<br />
sulla porta dove ognuno<br />
si medica le mani.<br />
vecchi televisori<br />
si spengono la sera,<br />
un ultimo lampo<br />
di fosforo negli occhi<br />
e abbandonare tutto<br />
al formicolio che porta<br />
e toglie scorie, e gesti<br />
dal letto alla cucina,<br />
un gorgo che si chiude<br />
girandoci sui fianchi<br />
insonni, visi<br />
appoggiati e sfumati via.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
150<br />
sugli occhi rinserrati le formiche<br />
al posto delle ciglia. Intorno tutti<br />
composti nelle cifre<br />
di un telegramma; questo<br />
leggibile nel modo di restare<br />
mani annodate mentre<br />
passa la fiamma e una<br />
per una le viti girate. Contare<br />
per tre volte figlio, una nipote,<br />
quattro parenti, ripetere questo<br />
anello che non è tolto.<br />
ridono anche senza figli<br />
selvatici come alberi che danno<br />
frutti agli uccelli, con gli occhi buchi<br />
umidi nella terra:<br />
abbiamo già cresciuto molti semi<br />
la notte guardando<br />
le vene illuminate della valle.<br />
dopo la mietitura<br />
si affacciano allo specchio<br />
con i nodi e le doppie<br />
strade sforbiciate, e molta luce<br />
entrata a mulinare<br />
nel petto come<br />
tra i raggi di una bici.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
151<br />
un’esca guidi dentro<br />
le luci dell’estate. Uno spillo<br />
ci regga le pupille, ci fissi<br />
a una parete, decisi finalmente<br />
ad appartenere a una qualsiasi<br />
collezione della specie.<br />
ci porteremo i muri<br />
come calchi di gesso<br />
finché non sarà stato rimpastato<br />
nella saliva l’ultimo granello<br />
allora la casa colma<br />
d’acqua lentamente<br />
scenderà nell’ombra, gonfiandosi<br />
come un sacchetto vuoto.<br />
ho scritto quello che volevo dirti<br />
sotto le palpebre. Domani<br />
appena le riapro leggerai.<br />
Ma guardami soltanto e non dovrò<br />
portare tutto il bianco tra le ciglia.<br />
Dammi i tuoi occhi e sarò salvata.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
152<br />
come formiche rosse velenose<br />
discendevano in te salivano<br />
per una cupa crepa della terra<br />
trovandoti nel viso<br />
una ciotola buona.<br />
la coinquilina di sventrati<br />
casolari torna oggi<br />
come un rovo a consolarti.<br />
Cani sulla schiena<br />
in attesa di carezze,<br />
cimici sbandate,<br />
le zampe in aria a camminare<br />
cercando terra.<br />
nel circo dove addestrano gli affetti<br />
entriamo solo in due, con tutti gli altri<br />
svaniti in una doccia, fuoriusciti<br />
dal principio di non contraddizione.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
153<br />
darò minimi baci di sutura<br />
medicherò le crepe con saliva<br />
sarò sbucciata e dolce ai denti.<br />
Ogni mattino ti coglierò un pugno<br />
di fiori dal selciato.<br />
Per te avrò aghi sempreverdi<br />
e sboccerò ogni inverno per<br />
bruciarmi.<br />
torni ad affondare qui, a colpi<br />
di reni gettare fondamenta<br />
nella melma dove è infinito<br />
ogni tuo gesto, come all’inizio.<br />
anche queste mani che apro<br />
colmandole d’ombra come dovessi<br />
lavarmi gli occhi nel mattino<br />
sanno dove sorgeva<br />
un viso, una profonda<br />
e chiara insenatura.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
154<br />
Maria come mi chiamo<br />
nel profondo e più nascosto<br />
viso, in sotterranei<br />
cinti e altri<br />
luoghi di ricovero<br />
dove rasoterra odoro<br />
bruna come la viola e il mosto.<br />
un dito scorre la schiena, la apre<br />
come togliendo la spina più lunga<br />
deciso a rendere innocua la carne<br />
s’introduce cogliendo<br />
gli organi amari; un istante mi volto<br />
a vedere quel furto con le fattezze<br />
di un figlio, di un pugno portato<br />
dentro fino a svanire.<br />
l’acqua toglie il dolore, l’odore<br />
di selvaggina, sapone<br />
per non essere più<br />
carne predata, inumidita<br />
nella saliva d’altri: assottigliarsi<br />
e sempre più nel rito<br />
fino ad avere bianca<br />
la pelle come un’ostia.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
155<br />
quanto tempo contieni<br />
ora che sei d’ambra<br />
e lo vorresti, forse<br />
insetto fisso, caduto<br />
in te, immerso<br />
nel tuo corpo di luce:<br />
«presto tutto si verserà,<br />
non avrò specchi».<br />
con le tue carezze ai piedi<br />
secche foglie, aspetto nuda<br />
le ossa oltre la carne,<br />
gemme nell’inverno<br />
mia armatura.<br />
torno a immergermi nel corpo<br />
azzurro e buono di una domenica<br />
mattina, con muchi e umori<br />
affraternati a quelli di altri<br />
senza capelli e occhi, muti<br />
come in un giorno di lavoro<br />
per corridoi<br />
con altre ombre accanto.<br />
Ma in questo chiaro di saliva<br />
cloro e seme, abbandonata ognuno<br />
la sua scorza, gesto dopo gesto entriamo<br />
bambini con un segno d’acqua in chiesa.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
156<br />
dove mi dirigono le vene<br />
questi condotti gelati<br />
che vanno esauditi<br />
fino all’ultima goccia<br />
scendendo allo specchio<br />
offuscato del mare<br />
mercurio che sempre si muove<br />
al contrario di noi,<br />
ammainati in un atto<br />
di andata e ritorno<br />
a sfiorare la riva<br />
come figli prodigi.<br />
con i piedi punta di matita<br />
sul bianco del lenzuolo a fare il<br />
caldo<br />
a bruciare a gambe giunte<br />
nella notte che impugna<br />
i fianchi, spinge<br />
alla sua goccia che s’allarga nera<br />
e guarda.<br />
dormivo su una pagina ogni notte<br />
bianca. Il mattino<br />
un’ombra del mio peso, alcune pieghe<br />
e subito voltava: proseguire<br />
è questo a capo del principio,<br />
bocca che passa calore<br />
all’aria come potesse svegliarsi<br />
essere ancora salvata.<br />
quando una bocca legge<br />
nel tuo silenzio d’acqua<br />
pescandoti fuori intatta<br />
con gli occhi che vorrebbero<br />
tornare nel profondo, vivi<br />
confusa dentro il sangue di qualcuno.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
157<br />
vivevi rattrappita<br />
in un sottoscala della sua mente.<br />
Ogni tanto tornava a guardare<br />
chiedendo se stavi bene<br />
nei contorni in cui ti aveva<br />
portato per il sonno<br />
e prima per l’amore, o invece se<br />
avrebbe dovuto stringerti di più<br />
fino alla posizione<br />
perfetta, all’incastro<br />
per l’ultimo trasloco<br />
femori sulle tempie<br />
prima di sfarinarti.<br />
Si sono spogliati, sono tornati<br />
un groviglio nell’aria tersa<br />
aperte le confuse direzioni<br />
opposte e coincidenti<br />
dita che avrebbero voluto<br />
allungarsi come un’unghia, incarnirsi<br />
nell’altro che scompare<br />
che muore senza cielo<br />
o inizia a respirare<br />
attraverso rami che non sono<br />
della sua linfa. Così si sono<br />
spogliati, sono tornati<br />
ossa stagliate sul bordo<br />
di un tepore convulso, tirato<br />
da una parte o dall’altra,<br />
mentre avrebbero potuto<br />
custodire l’oscuro.<br />
oltre la buccia intatta<br />
un verme ti ha percorso<br />
scavando al buio una tana<br />
tra pareti di zucchero. Resta<br />
un incavo che abita<br />
ogni notte la bestia.
Da Pasta madre (inediti)<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
158<br />
ho la bocca nera,<br />
inchiostro che ramifica nel petto.<br />
Ho incontrato persone come un tronco<br />
tagliato, stringendo ceneri<br />
tra le braccia che ho perso, che porto<br />
nel petto di anatra sporca.<br />
sempre voltata indietro, guardi da poppa<br />
il torrente che sgorga e si fa quieto<br />
come ogni volta, quando ti allontani<br />
e riconosci il peso che affonda<br />
nello sguardo finalmente aperto<br />
nemmeno una linea<br />
nominabile, soltanto<br />
gioia per ogni terra cancellata.<br />
la gabbia del torace s’è allargata<br />
per lo sbattere d’ali sulla riva<br />
e un piangere che ha fatto baie.<br />
con gli occhi a salutare i<br />
viaggiatori<br />
solitari sul treno della sera<br />
puoi rincasare ora, se lo porti<br />
il mare è un uccello che zittisce.<br />
con la fronte sull’acqua sogna<br />
foglie che tornano verdi<br />
e guizzano alle radici<br />
prima di germogliare,<br />
l’albero capovolto che rinasce<br />
tra piccole luci<br />
che si sono accese.
Sulla più recente poesia di Franca Mancinelli<br />
[…] Come ha annotato Pontiggia, in quello che, fino ad ora, è il più acuto ritratto della Mancinelli, il movimento di questa poesia si affida a<br />
figure di significazione, a tropi, in prevalenza metafore, che ne denotano l’alto tasso di reticenza e figuralità, come pure alle figure di pensiero,<br />
similitudini … di originaria matrice sacroscritturale: come dire, un elemento connaturato e remoto, radice che rinvia a una pratica di oralità e<br />
pure di preghiera, o a una sua non confessata predisposizione. […]<br />
La lettura del testo singolo, come del lavoro di Franca Mancinelli nel suo complesso, rivela una fitta trama di coordinate fondamentali, e<br />
invarianti, tali da rendere concreta l’ipotesi dell’edificazione di un particolare canzoniere: movimenti reiterati o ritornanti, come “strappi e<br />
piccoli rinvii”, da un dentro a un fuori, o nella proiezione di rapporti interpersonali, nella disputa pronominale (io, tu, noi). Una poesia che ha<br />
per stigma il confino e lo sconfinamento fisico e ontologico (tra i lemmi, frequenti: custodia, guardia, porta, dogana, confini): le pareti della<br />
stanza, come dell’opera, e come del corpo, vivono simbioticamente con l’esterno, con la percezione corporale, fisica, e panica del paesaggio,<br />
pure in una pratica ustoria di rispecchiamento (specchio, è lemma ricorrente) e relativa registrazione di elementi di microcosmo: in questo<br />
senso, alcune parole chiave, wortmotiv, assurgono a correlativi oggettivi di una condizione: acqua, mare, luce, seme, arco, ago, formica,<br />
riverberando un destino nel transito, nel moto […]<br />
Manuel Cohen, Note in margine alle poesie di Franca Mancinelli, “graphie”, 46, 2009<br />
* * *<br />
[…] Il percorso indicato da Mala Kruna, locuzione udita pronunziare dall’autrice nel corso di un viaggio in Croazia - con un che di sibillino, di<br />
oracolare quasi, a stigmatizzare un episodio che assume una valenza emblematica e assurge a configurazione di un destino - … muove da un io<br />
lirico riflettente su di sé, o alla cui presenza rinvia per rispecchiamento l’acqua del mare, come in un andirivieni di maree, o lo specchio di un<br />
vetro. Ma è da subito evidente che Mala Kruna, suddiviso in quattro sezioni, come tappe perimetrali di un percorso di certificazione o<br />
disvelamento, è, come i versi pubblicati negli anni successivi su riviste e quaderni collettivi (Nodo sottile 5, Le Lettere, Firenze 2008), una<br />
ricognizione sulla sfera dei rapporti tout court. Dove l’esperienza dell’amore di coppia, ma anche allargata ai legami famigliari e all’amicizia, si fa<br />
sonar di un condizione di diffusa difficoltà, e radar che ne capti segnali di superamento. Nei lavori più recenti, l’accensione analogica - che è uno<br />
dei tratti distintivi dell’autrice assieme al riferimento a un mondo feriale variamente descritto nei suoi dati di quotidianità domestica … con un<br />
uso parsimonioso e strategico di metafore e similitudini attinenti a un mondo di natura, viene confermata anche dalla osservazione della realtà<br />
creaturale e animale, che variabilmente riallude, specifica e riverbera su stati d’animo e condizioni condivise con l’uomo. […] Tutto un mondo<br />
animale in cui si inscenano comportamenti umani. Strumenti di questo viaggio di Franca Mancinelli sono le parole che seguono l’esperienza<br />
dell’osservazione ricognitiva (vedo, guardo, leggo sono più che verbi ricorrenti, vere parole chiave), la sua indagine sul corpo (umano, e<br />
testuale) e sulla dimora (case abitate e stanze della poesia). Parole raccolte intorno ad alcuni motivi ricorrenti e a elementi di raffinata figuralità<br />
semantica, in versi brevi di partiture strofiche rastremate, legate da concatenazioni di suoni, allitterazioni, in cui si muove l’elemento prosodico<br />
ritmico testuale. Alle parole della poesia, Franca Mancinelli affida ogni fiducia, nella laica inquietudine del percepire l’esistenza […]<br />
Manuel Cohen, Nota, in La poesia è di casa. Festa della poesia nelle Case della Cultura, a cura di Stefania Fabri e Maddalena Fallucchi,<br />
Illustrazioni di Costanza Maria Mongini, Zètema, Roma 2010<br />
Franca<br />
Mancinelli<br />
159
Enzo Esposito. Senza titolo,<br />
tecnica mista su tela
Liliana Ugolini<br />
160<br />
x<br />
È nata nel 1934 a Firenze, dove risiede.<br />
Nel 1980 ha pubblicato in proprio la raccolta di poesie Il Punto e nel 1993, per le edizioni Gazebo, il volume di versi La baldanza scolorata.<br />
Sempre per le edizioni Gazebo sono usciti i seguenti volumi: Flores (1994); Bestiario (1995), entrambi illustrati con disegni di Giovanna Ugolini;<br />
Fiapoebesie/Vagazioni (1996), quest’ultimo con opere di grafica al computer di Marco Zoli.<br />
Gli altri volumi di poesia pubblicati sono:<br />
• Il corpo-Gli elementi (Masso delle Fate, 1996), con opere di grafica al computer di Marco Zoli;<br />
• L’ultima madre e gli aquiloni (Polistampa, 1998), da cui è stata tratta una lettura scenica con musica nell’ambito di una serie di spettacoli sul<br />
corpo e la malattia curati da Gianni Marrani;<br />
• Celluloide (libretto d’arte edito da Stelle Cadenti, 1998, con interventi di G. Coppola, G. Fiume, V. Finocchiaro, F. Arigoni, G. Ugolini);<br />
• Una storia semplice (Morgana edizioni libri d’arte, 1999, con intervento di Rebecca Hayward);<br />
• Marionetteemiti (Esuvia, 1999), con riproduzioni di collages di Giovanna Ugolini. Da questo testo è stata tratta una messa in scena per teatro;<br />
• Pellegrinaggio con eco (Gazebo, 2001). Dal testo è stata tratta una mise en espace teatrale;<br />
• Imperdonate, con foto della scenografa Laura Viliani (Morgana Edizioni libri d’Arte, 2002), da cui è stato tratto lo spettacolo omonimo già<br />
andato in scena;<br />
• La Pissera, con Rosaria Lo Russo e Maria Pia Moschini per l’Archivio e la memoria della scrittura delle donne, a cura di Ernestina Pellegrini<br />
(Ripostes, 2003);<br />
• Spettacolo e Palcoscenico (Campanotto, 2003), dal quale è stata tratta l’opera teatrale Palcoscenico e La Favola dello Spettacolo (già andate<br />
ripetutamente in scena);<br />
• Delle Marionette, dei Burattini e del Burattinaio. Rilettura fantastica del Teatrino (Genesi editrice, 2007), con opere visive di Giovanna Ugolini,<br />
tradotto in francese per la prossima pubblicazione in Belgio. Un’appendice di 7 capitoli è stata inoltre pubblicata su “Italian Poetry Review” della<br />
Columbia University N.Y., Vol. IV;<br />
• Tuttoteatro (Joker, 2008), 11 pieces teatrali in poesia, a cura di Sandro Montalto;<br />
• A nera (Morgana Edizioni libri d’Arte, 2009), con Gianni Dorigo e Roberto R. Corsi;<br />
• Gioco d’ombre sul sipario (Gierre Grafica - Anterem edizioni, 2010);<br />
• La pasta con l’anima (Quaderni di Pianeta Poesia , 2010 – Tradotto in romeno), con Mihaela e Speranza Cernitu e Giovanna Ugolini;<br />
• Mito e Contagio (Morgana Edizioni libri d’arte, 2010 - Tradotto in inglese), con il Gruppo “Cerimonie crudeli” che ha dato vita a 4 performance;<br />
• Il Confessionale e l’Apostolato – (I luoghi, le signorine, le bambine) (e-book, La Recherche, 2011).<br />
Cura da 18 anni - per “Pianeta Poesia” diretto da Franco Manescalchi ed in collaborazione con il Comune di Firenze, la poesia multimediale e la<br />
scrittura in scena. Ha curato, con Franco Manescalchi, l’antologia di poesia contemporanea Carteggio (Polistampa, 1999), “Pianeta Poesia”<br />
documenti (Comune di Firenze, 2005) e Pianeta Poesia Documenti 2 (Polistampa, 2009). Collabora con “Multimedia91” per l’Archivio delle Voci<br />
dei Poeti e per il Gruppo performativo “Cerimonie crudeli”.<br />
Sul lavoro di scrittura e teatro di Liliana Ugolini è uscito un saggio/antologia curato da Sandro Gros-Pietro: Liliana Ugolini: poesia teatro e<br />
raffigurazione del mondo (Genesi, 2005).<br />
I suoi libri sono stati introdotti da: Mariella Bettarini, Gabriella Maleti, Franco Manescalchi, Paolo Pettinari, Anna Ventura, Carmelo Mezzasalma,<br />
Stefano Lanuzza, Sandro Montalto, Gio Ferri, Roberto R. Corsi, Paolo Vannini, Gianni Broi, Sandro Gros-Pietro, Maria Pia Moschini. Carlo Lapucci<br />
e Alessandra Borsetti Venier. http://www.lilianaugolini.it/
Da Il punto, 1980<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
161<br />
Il Punto<br />
Un punto di vita.<br />
Il bimbo mai nato,<br />
il padre inventato,<br />
la madre tenera<br />
in confidenze proibite.<br />
Il Dio lontano<br />
racchiuso nel papavero<br />
morto. Il Dio risorto<br />
a primavera. La sussistenza<br />
in ore sprecate. Le parole<br />
svociate come semi di inferno.<br />
La calma d'eterno, un riso<br />
frenato nel pianto mai dato.<br />
Il disimpegno attorcigliato<br />
al legno di croce. Una medaglia<br />
per un disegno a due facce.<br />
La boa<br />
In queste acque<br />
tenere, la boa<br />
fu scambiata<br />
per un cervello<br />
e tutti le fummo<br />
intorno.<br />
Fu la sola<br />
che ci insegnò col silenzio<br />
a salvarci da soli<br />
Senza eroi<br />
Storia come favola<br />
su bocche incantate<br />
sprazzi alimenta<br />
rivolte infantili.<br />
A cavallo del manico<br />
di scopa, schioccano<br />
lingue mute<br />
e fischi s'accordano<br />
a dita in picchiata.<br />
Frastuoni di guerra<br />
preludono gli eroi attoniti<br />
e granello è visione<br />
immaginata contro<br />
deserti d'orrore.<br />
Senza eroi scriviamo la storia.<br />
Accettano (e il vuoto resta tra le righe)<br />
vittime reali, storie nuove<br />
Rododendro<br />
neppur lontanamente<br />
somigli alla parola<br />
misteriosa,<br />
che, pronunciata,<br />
d'echi s'imbottisce.<br />
La rosa sì.<br />
Carnosa quanto<br />
l'impeto che getta<br />
stupite labbra<br />
a dirne il breve nome<br />
La Goccia<br />
Stride la goccia<br />
che si spezza<br />
come il grido del passero perduto.<br />
Il cedro muto<br />
gronda freddo<br />
mentre s'accosta il buio distaccato.<br />
Scalza l'elemento<br />
oscuri suoni<br />
e mai giunge l'impotenza del silenzio.<br />
Spostarsi<br />
di larghe forme<br />
in stralci di sole<br />
e odori freschi<br />
di buono.<br />
Sotto le dita<br />
lievita la sfoglia<br />
preziosa.<br />
Elettrizzato<br />
annuncio di godimento<br />
in fretta<br />
ordina,<br />
allinea,<br />
raccoglie<br />
un ooooohh!<br />
di bocche piene.
Da La baldanza scolorata, 1993<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
162<br />
Troppo precoce prato<br />
a largo effetto<br />
serra rosati ciclamini<br />
petali schiacciati<br />
e fioriscono giacche<br />
ai ragazzotti<br />
con bisacce firmate.<br />
Colore secco mischia<br />
girandola di sbocci.<br />
Corpi dormono<br />
fiore su fiore<br />
Bo, bo, bambini, Boboli.<br />
Non guardo il guado con pesci<br />
morti.<br />
Monche, mancano statue cieche.<br />
Afosa camiciola sbraccia<br />
cascanti pelli e tentennano<br />
canute le rimaste sole.<br />
Vinto, l'azzurro è musica<br />
sui ferri e gira la girandola<br />
dei putti. Alla televisione<br />
sci d'acqua ai giovani<br />
ch'eravamo.<br />
(Shopping)<br />
Occhi perle s'accendono ai colori<br />
del particolare camuffato<br />
sciama denaro che smemoria<br />
l'urgente cogliere<br />
l'assurdo indispensabile<br />
come pagliuzze azzurre al becco<br />
Lettura attenta<br />
in ombra ticchiolata<br />
nutre all'unisono la mente<br />
(comunione spazio-pagina)<br />
Il tempo dilatato<br />
cede tatto prezioso<br />
dato alle parole.<br />
Una porta sbatte<br />
senza interlocutore.<br />
Consorteria al desco<br />
serra lo schivo tartassato<br />
in briciole palpate<br />
a bicchieri di silenzi<br />
e l'impotenza a penetrarsi<br />
gratta se stessa nel piatto<br />
cambiato<br />
e niente succede nel candore della schiuma<br />
che cancella<br />
gli avanzi e le ragioni<br />
Ciaccole bosco<br />
suoni code fogliame<br />
punti d'occhi a fuggire<br />
studiati in movimento<br />
cuccioli germogliati<br />
corale pentagramma<br />
tempo aperto<br />
Nel carillon del tempo<br />
esiste un luogo<br />
dove lancette fermano<br />
ricordi tangibili.<br />
Dai cassetti bottiglie preziose<br />
lambiscono i volti ai candelabri<br />
e sommesso convivio<br />
corre ai merletti.<br />
La polvere copre d'antico<br />
il rituale del menu<br />
gli orologi segnano<br />
l'ora ripetuta<br />
Sette donne<br />
allusive ridenti<br />
allo sgomento sfugge<br />
col sorriso "son troppe"<br />
il cameriere gelato<br />
d'amarena ventaglio<br />
e di sera<br />
sette ventagli nascondono<br />
lo schizzo d'amarena<br />
sulla coppa gelata.
Su Il punto e La baldanza scolorata<br />
[...] Il Punto pubblicato come auto edizione nel 1980, i cui testi sono palesemente interessati alla disposizione sulla pagina, al ritmo del verso che<br />
ovviamente non coincide con quello della lettura e si basano anche su allitterazioni e assonanze distanti alcuni versi e dunque fatalmente volatili<br />
alla lettura a voce alta … Eppure già in quei testi si registra una attenzione al parlato: “Elettrizzato / annuncio di godimento / in fretta / ordina /<br />
allinea / raccoglie / un oooohh! / di bocche piene”. I temi, poi, sono già quelli che diverranno preponderanti: gli affetti (soprattutto la madre), il<br />
viaggio con riflessioni sul paesaggio come specchio dello stato d’animo, la denuncia della guerra e l’interagire delle forme di espressione. […]<br />
Sandro Montalto, dalla postfazione a Tuttoteatro, Joker , 2008<br />
* * *<br />
[…] Il tema della sinestesia tra poesia, musica e pittura, con particolari riferimenti a Mozart e Shagall, il tema della testimonianza civile e<br />
dell’orrore per la violenza e la guerra. Il verseggiare è libero con scansioni versali tendenzialmente brevi, quinari, senari, settenari, sovente però si<br />
tratta di emistichi, magari ottenuti da un endecasillabo scomposto sulla cesura di due versi distinti ma sono anche ottenuti col raddoppio del<br />
senario. La poetica svolta assume una tensione simbolista e surrealista, con ampio sviluppo di metafore. […]<br />
Sandro Gros-Pietro, Liliana Ugolini: poesia teatro raffigurazione del mondo, Genesi, 2005.<br />
* * *<br />
[…] Interessante la movenza ritmica dei versi e la proposta di un linguaggio accattivante, ricco di immagini del quotidiano trasfigurate e di<br />
immagini, invece, desuete che prorompono, con sorpresa, nel parlato familiare. […]<br />
Rosaria Lo Russo , "Semicerchio”, 9, 1993<br />
* * *<br />
[…] La Ugolini possiede uno stile limpido e sicuro, una notevole sobrietà di linguaggio accompagnata da una tematica complessa e ricca di<br />
sfumature. Non manca tra le tante qualità del libro, un misurato approccio riflessivo e concettuale, forse il frutto meritato di un esperienza<br />
appartata. […]<br />
Roberto Carifi, “Poesia”, 66, 1993<br />
* * *<br />
[…] È qui che la penetrazione psicologica e sociale, indice dominante della presente raccolta, arriva ad evocare altre cadenze e altre arti come la<br />
pittura deformata e mordace del M. Ernst di Le vetement de l'epouse o il cinema del W. Borowczyk, salace e iconoclasta, di Thérèse philosophe.<br />
Segno che nell'impostazione paradigmatica sono ben enunciate, con sapienti e rivoluzionari sincretismi espressivi, l'ironia surreale e la radicalità<br />
oppositiva "gettate" nella grottesca tortuosità del vivere. In questa chiave La baldanza scolorata (si noti l'eloquente sinestesia) apre scenari che,<br />
se da un lato si caratterizzano per l'inconsueta libertà delle figurazioni rispetto ai dati concreti della realtà esterna, dall'altro sigla, in virtù anche di<br />
ameni dinamismi, un'interrelazione della condotta, la cui espressività, non poche volte di stampo picaresco, è dipanata attraverso una<br />
concitazione dai risvolti fortemente emblematici, oppure scabra senza prudenza e senza censure. […]<br />
Gaetano Pampalona, "Il Cristallo", 3, Dicembre 1996<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
163
Da Flores, 1994<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
164<br />
Bocche di Leone<br />
Velluto e polparancio, la grandiosa<br />
visione dell'impulso. La macula carminio<br />
sgoccia labbra, la forma è lo stupore<br />
dell'O, l'aprirsi del muto.<br />
Un ingollarsi d'occhi in attesa<br />
della voce, un ripetersi in mutazione<br />
d'emettere silenzi (l'urlo taciuto in ciocche)<br />
la gamma del violaceo<br />
tenersi tutto in gola<br />
Bella di notte (Mirabilis Jalapa)<br />
Il pietrisco s'accende.<br />
Ramifiche spontanee di possesso<br />
splendono rugiadose<br />
in afose stellate<br />
le belle di carminio.<br />
L'ibrido mostrarsi dell'inverso<br />
il circonflesso pudore del pistillo<br />
che riveste i suoi petali.<br />
La luce nel contrarsi del rifiuto<br />
s'illivida.<br />
Conosce il turgido sapore del buio.<br />
Papavero<br />
Un lievito di quattro tocchi<br />
ali sgusciate al nero, flettersi<br />
di soffi d'aliti scarlatti,<br />
la carezza della fragilità.<br />
Sgorgia il colore nel mare<br />
delle dimesse messi arrossate<br />
Oleandro<br />
Le oscure ciocche di sapida ragione<br />
s'aprono rugiadose,<br />
l'estrema capacità d'incanto<br />
trema vis velenosa, la rugosa<br />
venerea sembianza della maga<br />
lame-foglie. Crepita lo stormire<br />
(lo si fugge) si trafigge di gocce<br />
truculente. La stravolta visione<br />
è l'abbraccio dell'ultimo saluto.<br />
Azalea<br />
Calatidi carnose, le vetuste novelle,<br />
l'incandescente albore di papille,<br />
le scintille degli occhi, le mantelle<br />
irridenti, lo sfrangersi della cadenza.<br />
Un sovrapporsi di ripetizioni d'effimero,<br />
un involgere di sviluppi (le conche<br />
s'abbelliscono agli archi) la distesa<br />
è l'indicazione, la prescelta osservanza<br />
di rimestare un Rinascimento.<br />
Mughetto<br />
Il capolino ormeggiato,<br />
l'occhieggiarsi del trillo<br />
la scansione si pigola dirotta<br />
e sgoccia, al minimo lucore<br />
d'un difetto, l'onor di perfezione<br />
Margherita<br />
Miriade la curva groppa,<br />
centro del pensiero.<br />
Una totale assenza d'olfatto,<br />
lo sfatarsi del neo. La brina<br />
lascia scie, la luce s'è rifratta.<br />
Ritratta al sole la faccia,<br />
la rubiconda giostra sfreccia petali.<br />
La regina si regge sulle dita<br />
d'un travaglio di zolle<br />
le ridora, le serra,<br />
le dipinge screziate di solletico<br />
Gelsomino<br />
Evanescente a dileguarsi in nari,<br />
avvitarsi in appigli, riccioli<br />
uncinati seguiti dalle voglie<br />
del minimo sbocciarsi, ridondare<br />
la groppa permanente in sottile<br />
svenimento del buio, solfeggio<br />
di carnosa esuberante.<br />
Si raccolgono a ondate<br />
le soglie dello sforzo,<br />
sfarzo di miniature.
Da Bestiario, 1995<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
165<br />
Scimmia<br />
Per il pelo, per la presa<br />
(un cervello ridotto)<br />
il belzebù primate<br />
si rispecchia.<br />
Noi di razze e corazze<br />
emarginati, in sottecchio<br />
d’immagini diramo<br />
siamo eretti (la magia<br />
degli eventi) in riflesso<br />
d'un doppio consapevole<br />
Formica<br />
Formicolar complesso<br />
(sul sesso la corona<br />
del volo morituro)<br />
sta nel nascosto<br />
caso della larva,<br />
una beffarda scelta<br />
concepita fuori,<br />
un presagito segno<br />
una traccia di ruoli,<br />
un incontrarsi nel compito<br />
(di noi) concepito nel tempo<br />
una sorte da scuoter col fuscello<br />
in fuggi fuggi<br />
del globo-formicaio<br />
Pipistrello<br />
Padagio nell'arco<br />
divorante ultrasuono di spazio,<br />
s'emette all’ inudibile<br />
gocciare d'alcove raccontate.<br />
Pare del raccapriccio<br />
l'invenzione specchiante,<br />
imitazione del mantello di Hyde.<br />
Sirene<br />
Per certo il mare.<br />
Di piumaggio o di pesce<br />
l'altra donna c'incanta<br />
di risacche violacee di sconquasso,<br />
di lucori in fremiti di groppe,<br />
nel tuffo d'un aspetto,<br />
in attesa di specchi<br />
scontro imprendibile.<br />
A noi di cera, inutile<br />
l'udito assorda cantilene<br />
Drago<br />
Alato sputafuoco che s'arrende<br />
all'incetta dei simili,<br />
sforza la scatenata mole del serpente<br />
in rassegne d'eroi.<br />
Cade trafitto<br />
in fitte ricadute fino a spostarsi<br />
dove ora si tuona, in grinta<br />
d'un evento incontrollato<br />
Serpente<br />
Muta nell'occhio fisso<br />
il suono solido,<br />
l’ofido perfido<br />
che cambia la sua pelle<br />
di crescenza enfiata<br />
da mandibole.<br />
Il soppiatto della mela,<br />
e l'intrecciarsi<br />
d'una scala d’azzardi,<br />
da schiantarsi<br />
Gatto<br />
Occhio che s'impossessa<br />
del riflesso felis, s'inizia<br />
al pathos dell’immobilità,<br />
la contrazione intercetta<br />
l'attenta caducità dell'attimo<br />
carnivoro, una stregata<br />
rapida parvenza tattile<br />
del polpastrello quatto.<br />
L'allungarsi in atto<br />
di sfumarsi è il procedere<br />
le sette volte sette<br />
nell'ipnotico mistico<br />
coatto fascino<br />
delle duplicazioni<br />
Sfinge<br />
La soluzione dell'infinita<br />
incognita, la sottile ironia,<br />
sta d'eterno una soglia
Su Flores e Bestiario<br />
[...] Sulla base di alcune corolle già spontaneamente assurte a parola poetica in una vegetazione conscienziale più oscuramente galattica,<br />
l'autrice ha dato vita ad una sua serra o, etimologicamente, ad un "florilegio" di grande suggestione e - rispetto alle opere precedenti - di<br />
minore inquietudine formale e di maggior spessore ed evidenza con testi che appaiono veri e propri monotipi verbali, ovverosia "opere uniche"<br />
affidate alla propria abilità di cesello. […]<br />
"Ut pictura poesis", affermò Orazio, ed infatti la sorella di Liliana, Giovanna Ugolini, ha tratteggiato con mano duttile e particolarmente felice<br />
nel ricavare ed evocare dal bianco le immagini, i Flores di quest'opera. Scaturiscono dal suo impegno figure sempre diverse, come a segnare il<br />
"carattere" di ogni fiore, integrando magistralmente il messaggio del testo letterario: tanto ideo-grafica è la scrittrice, quanto liricamente<br />
impostata in un omaggio "al vero" è la pittrice. […]<br />
Franco Manescalchi, dalla prefazione a Flores<br />
* * *<br />
[...] È difficile in effetti trovare in questi testi congiunzioni, avverbi e in genere tutti quei connettivi che permettono di strutturare le frasi in<br />
periodi e di argomentare un pensiero e un messaggio. Questa riduzione e questo prosciugamento, però, producono dei testi estremamente<br />
ricchi sotto il profilo retorico, con una prolusione di figure sintattiche, semantiche ma anche fonetiche, che catturano e turbano come uno<br />
specchio in cui si rifletta il caos apparente della vita reale. […] Un mondo concretamente onirico in cui l’io è invisibile e che ha l’iconicità di certi<br />
emblemi seicenteschi, magari rielaborati da un pittore cubista, in cui ogni elemento rimanda a qualcos'altro. […] L'aspetto manieristico e poi<br />
accentuato dalla presenza di un apparato illustrativo, dovuto a Giovanna Ugolini, che è parte integrante del progetto complessivo del volume.<br />
Come nei codici medioevali le miniature venivano ad essere talvolta essenziali alla comprensione dei testi, specie laddove l'animale era meno<br />
noto, così in questa riscrittura contemporanea le illustrazioni ci aiutano a interpretare il senso dell'operazione: un percorso figurale e figurativo<br />
fatto con tocco lieve e anch'esso giocoso, che predilige il manifestarsi dei fenomeni senza escludere una misurata presenza simbolica. […]<br />
Paolo Pettinari, dalla prefazione a Bestiario<br />
* * *<br />
[…] Notevole ci è parso Bestiario di Liliana Ugolini, una silloge costruita in modo complesso, con un linguaggio tutt'altro che elementare dove un<br />
posto di rilievo occupano la riflessione e il pensiero. Si potrebbe parlare di uno stile fortemente controllato, razionale, a tratti perfino<br />
geometrico ma non privo di incrinature, di inquietudini che dalla realtà animale si proiettano sulla condizione umana. […]<br />
Roberto Carifi, "Poesia”, sett. 1994<br />
* * *<br />
[…] Nello stesso tempo la parola, in tutta la sua lucentezza, può divaricare la necessità del ri-chiamarsi, tramutando le lacerazioni nel riflesso di<br />
un'eco degli assoluti memoriali.<br />
La fabula esalta il significante poetico che affiora dall'inconscio archetipico e svela, attraverso il linguaggio stemperato della percezione, la<br />
nitidezza di un'aurorale saggezza che richiama canzoni medievali. Gli aforismi, ed in essi il pensiero poetante che scopre il racconto in fieri del<br />
Bestiario, ci appartengono in una strategia per la quale il pensare il mondo in un progetto rielaborato dagli animali confronta la nostra infanzia<br />
alla sopravvivenza inevitabile del presente. […]<br />
Antonio Spagnuolo, "Pietraserena“, 26/27, 1996<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
166
Da Fiapoebesie/Vagazioni, 1996<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
167<br />
FIAPOEBESIE<br />
Nell'involucro culla della fiction<br />
sto per saltare.<br />
Mi spoglio dimensione<br />
e nel cavo mi spazia<br />
la tenzone dei netti.<br />
Valicata, l'avventura<br />
si sfoglia a chiarirmi il nemico<br />
Hansel e Gretel (F.lli Grimm)<br />
Senza pane per denti,<br />
denti addenti di madre,<br />
l'allocco di padre fu scelta<br />
saccente lasciare due figli nel losco.<br />
Imparare, importante, portare<br />
disegni di segni biancastri<br />
nel doppio ricevere d'altro<br />
un pensiero, che lupi d'uncino<br />
allagano il seno del tetto.<br />
L'affido è nel bosco (l'amore<br />
fraterno) l'astuzia sapere,<br />
vedere di senso e scoprire<br />
il melenso d'inganno ferire,<br />
lo scotto che paga a noi dato<br />
scoprire in bocca di bocca<br />
sul forno a chi tocca perire<br />
La partita d'erte spine<br />
di clop e clop<br />
finissimo dorato<br />
al manto si dilunga<br />
e fiocca di gesta<br />
l'invenzione.<br />
Saetta dello scudo<br />
(vibrazioni)<br />
l'alzarsi del suo vero al quotidiano<br />
Cappuccetto rosso (di Ch. Perrault)<br />
Fauce sottile d'un logos<br />
che strada facendo di fiori<br />
catturi rimorsi.<br />
L'addentro stupore di bosco<br />
s'inizia al candore trastullo<br />
d'imberbe vagare e svagarsi<br />
in bocca di bocche. Lampanti<br />
di zampe latenti, l'eterna<br />
sognata giustizia sommaria<br />
s'accampa di pancia squarciata<br />
felici e contente. Cappuccio<br />
che rosso più rosso cruente<br />
spaventi l'effetto sorpresa<br />
per colpa d'un colpo si sdramma<br />
alla fame di lupo che indossa<br />
degli altri (l'errore) la pelle<br />
La pagina arroventa silenzi<br />
e le parole sospendono il risalto<br />
della rivelazione.<br />
Mi bisogna un corrimano<br />
di ruzzole, il riconoscimento<br />
nei frammenti lanciati da magie<br />
VAGAZIONI<br />
Segno metafisico<br />
l'incipit musicale<br />
copula di sostanze<br />
velario di diaspore<br />
elegiache, tintillo<br />
di devastazione<br />
e spazio tempo<br />
Sogno di una notte di mezza estate<br />
(Ouv. di F. Mendelssohn)<br />
Le trame d'un tessuto<br />
che s'infittisce nelle letterature<br />
ordisce l'infinito scandaglio<br />
(due flauti, due oboi)<br />
che si dilata cosmico sonoro.<br />
Il velo (due clarinetti)<br />
lo sparito segreto si racconta<br />
nel congiunto mistero<br />
(due fagotti, due corni)<br />
in occhieggiar d'un cenno<br />
d'assoluto (due trombe, un oficleide)<br />
germe del mi maggiore (archi)<br />
silenzio oltre la porta d'un ventaglio,<br />
sipario (timpani) del fantastico<br />
La vie parisienne (Ouv. di J. Offenbach)<br />
Paris Paris splendore<br />
l'ottocentosessantasei<br />
Palais Royale, l'euforia<br />
sarabanda d'alchimia<br />
(il terzo Napoleone) e l'invenzione<br />
d'elisir "vita di vin<br />
gioite in compagnia"<br />
scanzonata boutade, l'armonia<br />
resta l'arma lampante.<br />
Ambrosia in goccia sterile<br />
la farsa dei timpani alle marce<br />
e l'eco del non ritorno<br />
visivamente diacronico.<br />
Cappio esaustivo<br />
l'allarmante<br />
assunto a melodia
Da Il corpo-Gli elementi, 1996<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
168<br />
Acqua-caso<br />
Acqua alta, acqua di giacimento<br />
Acqua morta, acqua di cava.<br />
Di fusione e selvaggia, fossile,<br />
giovanile, incanalata, ipogeica.<br />
Litosferica acqua, la valdosa,<br />
marina, meteorica, l’acqua<br />
minerale, la termale, gocce<br />
cellule, concatenazioni. S’esalta<br />
e salta cavalloni d’infranto,<br />
geo (caso?) perché.<br />
Cervello<br />
L’enigma verticizza<br />
l’evolversi complesso<br />
pentagramma volume<br />
di supporto.<br />
Milletrecento grammi<br />
d’encefalo compresso<br />
esploso in due emisferi,<br />
(m/isterocosmo)<br />
avvento in divenire<br />
dell’attimo successo<br />
motivo telegrafico fili<br />
d’un messaggio.<br />
Linguaggio<br />
Velazione di suoni,<br />
vocalità, emozioni,<br />
che non muta al mutismo.<br />
Lingua di mano,<br />
altra comunicanza, ad oltranza<br />
si batte dove duole e linguaggio<br />
miriade che percuote tam-tam<br />
soffia di tromba corda di violino<br />
e si rimuove nell’onda che richiama<br />
dialettiche e allusioni (alluvioni)<br />
di doppi. La verità<br />
del perdersi.<br />
Pelle<br />
Il tessuto che separa l’ambiente<br />
dai suoi liquidi, che si tinge<br />
cangiabile al brivido mimetico<br />
mostra la morte in solchi conoscibili.<br />
L’iper di forme,<br />
evidenza dell’essere esterno<br />
interato al suo sembrare carezza<br />
rezze di punte d’estasi al sommo<br />
d’un inizio di culmini sfiorati.<br />
La pelle che in faville s’accende<br />
è tunica su forma contenuta<br />
d’accordo introvertibile<br />
Terra-terrea<br />
Pluviale tropicale<br />
l’altezza effetto notte<br />
intricata orchidee<br />
che sazia di sé gli stacchi<br />
dalle liane<br />
e<br />
sabbie senza tracce,<br />
dune, occhi di vento, lamento<br />
di gobbe filastrocche,<br />
fissità, infinità di rosa<br />
in cattura dell’oasi<br />
e<br />
praterie, veld sudafricano,<br />
pampas, steppe, le supine<br />
terrigne, le percorse di grida<br />
in orizzonte di ciuffi come grana<br />
e<br />
taighe conifere<br />
androni prospettive di varianti,<br />
le decidue di larici e betulle<br />
son<br />
terrapieno di roccia incrostature<br />
fossile cartasuga che si spettra<br />
in sovramettiture,<br />
la scoperta che imbeve<br />
l’ultima foglia terrea,<br />
sull’ameba
Su Fiapoebesie/Vagazioni e Il corpo-Gli elementi<br />
[…] Siamo ormai abituati a chiamarlo "slash": è il segno (/) che separa i versi quando vengono riportati di seguito, è un elemento divisorio per<br />
gli indirizzi telematici, è un simbolo di e/o. Così intenderei Fiapoebesie/Vagazioni, che è un volumetto ben congegnato: poesie associate a fiabe<br />
e poesie associate a ouvertures d'opera. Tutti dunque, rigorosamente, prodotti squisiti della grande cultura europea del secolo scorso (dai<br />
Grimm a Perrault, da Beethoven a Tchaikovsky per intendersi), perché la poesia è (anche) questo: è memoria, macchina del tempo e modo per<br />
ricordare le cose passate, le grandi cose, le vette dell'arte. Mentre il CD-ROM immagazzina bilioni di dati e li conserva disanimati dentro di sé<br />
(ma lo si può sempre interrogare) la poesia centripeta pochi dati ma li preserva in una forma memorabile, diciamo "poco ma buono". È questa<br />
la continuità della cultura, lo status sempre ante - e sempre post - della poesia; e la farcitura della raccolta è composta da disegni sintetici in b/n<br />
che verrebbe voglia di colorare (una mela, un ghirigoro, un albero, delle letterine ecc.). […]<br />
Massimiliano Chiamenti, "Semicerchio“, 14, 1996<br />
* * *<br />
[…] La mescidanza di fiabe-poesia-musica, fa ragione dell'introduzione. Citazioni, piccoli incantesimi, fluenti note, memorie fantasmatiche,<br />
ouvertures, ritmi, segreti accadimenti, dolci loquele vengono accolti dall'aria che li accorda e loro dà voce e ne gratifica la lettura. […]<br />
Alberto Cappi, “La Voce di Mantova“, 1996<br />
* * *<br />
[…] …Liliana Ugolini, in questo libro di poesia così originale e accattivante, sottolinea la stretta connessione che intercorre tra il corpo umano e i<br />
principali elementi della natura /acqua, fuoco, aria, terra) seguendo l'impulso di una ispirazione fiabesca e arguta, lessicalmente personalissima,<br />
la stessa che ha mosso i precedenti Flores e Bestiario, capace di annullare la distanza che esiste tra l'uomo e le altre creature, l'uomo e le forze<br />
primordiali che alitano nei boschi e nei torrenti, nelle nebbie e tra le fiamme del camino. La silloge è, pertanto, quadripartita secondo l'ordine<br />
dei quattro elementi e a ciascuno di essi si connettono momenti e aspetti del corpo umano, del suo passaggio, unico e irripetibile, sulla scena<br />
del mondo. […]<br />
Anna Ventura, dalla prefazione a Il corpo-Gli elementi<br />
* * *<br />
[…] Poesia "Elementale", materica, laicamente sapienziale quella di Liliana Ugolini. Il corpo-Gli elementi, con opere di grafica al computer di<br />
Marco Zoli, ricorda a tratti certa produzione di Zanzotto (Il Galateo in Bosco e Fosfeni) con una tensione linguistica ripartita tra fuga concettuale<br />
e parlato, tradizione colta e popolare. […]<br />
Antonello Satta Centanin, "Poesia“, 1996<br />
* * *<br />
[…] Il Corpo-Gli Elementi è un libro di poesia orientato alla sonorità, ricco di omoteleuti, dissonanze, distridori tra parola e immagine. È una<br />
raccolta che coniuga lucidamente usi metaforici e concreti del linguaggio, usi comunicativi e salti semantici, di significato. Versi che accostano il<br />
fatto al concetto, l'oggetto fisico, sensibile, all'idea, il concreto all'astratto. […]<br />
Cecilia Bello, dalla presentazione de Il corpo-Gli elementi<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
169
Da L’ultima madre e gli aquiloni, 1998<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
170<br />
A<br />
Quale<br />
Universo<br />
Invita<br />
L'aquilone<br />
Ondeggiando<br />
Nell'<br />
Incerto?<br />
Addolorata e bianca la notte.<br />
L'innocente agguarda la presenza<br />
tangibile, l'altro da sé potenza<br />
fattuale. L'incontinenza svilisce<br />
nei silenzi (carezza del suo groppo)<br />
e una manciata di riso non diviene.<br />
La coppa del suo buco straborda<br />
le giunture e qui nel gran rovello<br />
sto nel pensiero a domandarmi Rilke<br />
(elucubrazione) e denso di liquami<br />
al giorno lo stravolto conforto<br />
è lontanissimo<br />
Anche<br />
Questa<br />
Unicità è<br />
Immagine.<br />
L'incontro<br />
Ondeggia al<br />
Nostro<br />
Impallidire<br />
L'altro antro dove il dolore<br />
scarna scolorito, dove blocca<br />
stupore, dove più stronca pallore<br />
il passo dell'immobile, lì sei deposta<br />
diafano sorriso, appesa agli aquiloni<br />
fioriti in furori di fiamma.<br />
Cosi si stacca in corse di respiri<br />
l'ala d'amore memore di te<br />
che ondeggi nei tiranti d' uno strappo<br />
fuga frugata di cenere invisibile, nell'aria<br />
e posso pensarti in trascorsi di carni,<br />
in teneri calori d'effusioni<br />
in fila, nel tuo filo<br />
Un titano grande ripiegato<br />
è il nostro sentimento, madre d'assenza<br />
che un moto, un suono, un palpito<br />
accennato distende tramortito.<br />
Ma resta gigante indissoluto (senza suoni)<br />
immenso, come un monte cocciuto<br />
che t'aspetta in un cenno, in un tepore<br />
Abbattersi<br />
Quieto sull'<br />
Ultima<br />
Illuminata<br />
Landa<br />
O<br />
Navigare<br />
Infinito?
Da Celluloide, 1998<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
171<br />
Vecchio Frankestein<br />
Svuota l'ampolla il cervello<br />
del buono (nel film del '31)<br />
che si frantuma e nell'alcova<br />
suona disuguale. È ancestrale<br />
(livido) un contrappunto<br />
e un basso di tonale senza l'occulto,<br />
a immagini di sosia. Quando pesante<br />
il passo, spazia il pulsare, urge<br />
la scoperta. Insita all'uomo - Golem<br />
innumerevolmente senza fine<br />
*<br />
Sento il mio silenzio impugnar<br />
parole. Un bianco e nero assurto<br />
al cambiamento veloce, a sicurezze<br />
pugne d'un globale mistero e mentre<br />
lorde barbare (fosse d'origini<br />
piene alla natura) si muovono di storie<br />
ne riconosco come centro l'uomo<br />
nell'armeggiar l'annuncio d'organini<br />
d'Ovadia. La musica riprende e la pietas<br />
più vasta si colma infrangibile.<br />
Il seppia e il grigio stampano sul retro<br />
il negativo (rosso) in stanza oscura<br />
e viene dentro al clima il pulsar<br />
formicaio. Si avverte lo sgancio<br />
(un pizzicor d'imprese) che ancora<br />
c’imballa in vagoni piombati<br />
FILMS<br />
M'incanta in bianco e nero<br />
l'ombra dei divi e il loro<br />
movimento. Figure scatti<br />
umori in fascini di gesti<br />
vivi nei trapassati.<br />
Son pellicole diafane<br />
le pelli, le mode dei vestiti<br />
celluloide. Così primi e secondi<br />
ancora si ritorna truccati<br />
d'altri tempi<br />
Oh quanto muto venga<br />
dentro ai films che il tempo<br />
nella piaga porta voci<br />
a più voci e si rinnova<br />
d'abbondanze stonate!<br />
Torna nel bianco e nero<br />
il grigio assordante di parole.<br />
Nell'emozione il tempo non ha luogo.<br />
La Havilland, la Garbo, la Bette Davis<br />
(le certezze) tutto torna al finale.<br />
Abbinate nei gesti le purezze,<br />
strabordano nel foro delle stelle<br />
e noi, da spettatori, le malizie<br />
di spazi consumiamo<br />
Le comiche affrettate<br />
nel giro di manovella<br />
contrastano d'ossimori.<br />
Nei tempi accelerati<br />
di sgambetti, le torte<br />
più eccellenti son disastri.<br />
Quanto ci occorre ridere<br />
ai momenti è fuori<br />
da schermo, fuori da parole
Su L’ultima madre e gli aquiloni e Celluloide<br />
[…] Ciò che più colpisce della introspezione letterale della Ugolini è questa straordinaria linea inventiva, misurata o scandita su timbri di una<br />
forte musicalità, che va di pari passo con cert'aurea metafisica, nella quale lo spazio si stinge nel lucore del "ticchettio dei tetti" si mescola all’<br />
"odore degli ontani" o culmina ne "la corda del tuo soffio". Non bisogna però pensare che la Ugolini accentri tutta la sua poetica attorno e per<br />
la scrittura, pur essendo evidente la predilezione per tale aspetto, perché si cadrebbe nell'ipotesi di un suo isolamento, il che non corrisponde<br />
affatto al vero. […]<br />
Angelo Lippo, “Il Giornale della Puglia”, 1998<br />
* * *<br />
[…] La traccia sinusoidale di una coda di carta colorata è una felice metafora per descrivere l'andamento de L'ultima madre e gli aquiloni di<br />
Liliana Ugolini. Testi tesi a inglobare ogni possibile stimolo esterno, producono un quadro di percorsi e di vissuti interiori caratterizzati<br />
dall'importanza della figura e della sensibilità della madre in rapporto con l’"altro", il figlio. Madre reale, descritta in prima persona, o madre<br />
assoluta, archetipo.<br />
Fabio Simonelli, “Poesia”, 1998<br />
* * *<br />
[…] Questo intenso e inteso racconto in versi [L’ultima madre e gli aquiloni] è colmo come nessun libro precedente dell'autrice d'una calda<br />
affettività, umanità profferta al dovere di vivere, alla vocazione ad amare, per cosi dire in una sorta di mobilità mimetica, che canta e tace<br />
insieme. C'è una forza magnanima e implacabile nello sguardo e nella parola di Liliana, eppure nulla di quanto la parola esprime risente di peso<br />
o di sforzo: tutto si dipana in meditata, coinvolgente presenza di tale sguardo, in una resa verbale straordinaria. […]<br />
Giovanna Fozzer , Città di Vita<br />
* * *<br />
[…] Al di là e al di sopra della "bellezza" del racconto, che prende per aver saputo affondare fino alle radici della pietas quest'ultimo libro<br />
[L’ultima madre e gli aquiloni] si evidenzia, secondo me, proprio perché rivela, nella Ugolini, la capacità di rompere gli steccati che sempre si<br />
crea attorno chi si chiude in un modello espressivo, per evadere in territori prima sconosciuti, pur mantenendo con quel modello legami<br />
infrangibili, anzi allargandone gli orizzonti senza porre alcun limite alla propria sperimentazione, che non deve mai implodere, perché altrimenti<br />
rischia di annullarsi, ma deflagrare all'esterno per illuminare oltre qualsiasi confine.<br />
Walter Nesti, “Pietra Serena”, 1998<br />
* * *<br />
[…] Una plaquette anomala con inserti "cinematografici" e il mondo del cinema visivo per eccellenza, ha suscitato nella poetessa immagini, rime<br />
concatenate, rimandi fonici, progressioni per sincope quali "allarga e allaga" e "schermi e schemi". Né "il mostro Stein" affiora una femminilità<br />
figurativa: il linguaggio poetico della Ugolini è un continuo rivolgersi al segno di una creatività mai corriva. […]<br />
Luciano Nanni, “Punto di Vista”, 1998<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
172
Da Marionetteemiti, 1999<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
173<br />
Cassandra e il silenzio<br />
Cassandra:<br />
Parlai di venefiche congiure,<br />
di calure di piombi e terrapieni,<br />
di moti, di sostanze, d'alieni e di veleni,<br />
l'enigma delle voci (imponenti frastuoni)<br />
e menti del mentire e la veste del fuoco<br />
m'è responso che seppi senza bocca l'irrisione.<br />
Io sola l'ecatombe vidi del baratro do noi<br />
Il silenzio:<br />
Son stabilito piatto e sui conteggi algebrici<br />
mi ruotano pianeti. Sommuovo il tuono<br />
e il fulmine lo ignoro.<br />
Cassandra:<br />
Dal grembo mi nasce viscerale<br />
lo strido che m'aggiunge<br />
ai gridi che qui sento.<br />
E s'alza quel dito sui bottoni.<br />
Lo avverto alle calcagna dei titoli,<br />
dall'entrapieno del sogno,<br />
dall'orda dei rivoli e da menzogne<br />
d'ascisse verità, dal giocarsi<br />
il pathos dello scempio (la sicurezza<br />
eccelsa dell'impaccio) dall'oscillar<br />
d'incognite spicosi (immagini dell'input)<br />
Il silenzio:<br />
Conosco le fasi degli avelli,<br />
il frale struggimento delle tibie<br />
e le galassie domo dentro al blip.<br />
Resto su rette e gli angoli li aggiogo.<br />
Copro e consono e dico non dicendo.<br />
Cassandra:<br />
Voce perdo e divengo silenzio dentro al tono<br />
che non creduta urlante sono muta e m'agito<br />
negli occhi e sulle dita ho un gioco di morse.<br />
Devo attizzar di mura almeno la paura<br />
Il silenzio:<br />
Glaciale brillo alieno in solitudine,<br />
rimbalzo nei dirupi la certezza,<br />
ciò che non può accadere.<br />
Sono sull'erte, la svolta, il cambiamento<br />
Cassandra:<br />
La voce che grida l'attenzione del vuoto<br />
ti traduce ed io quel vuoto sono dove l'oscuro<br />
è nuovamente suono e la tua voce assorda<br />
la mia assenza che l'incomunicanza<br />
è nella retta che passa l'orizzonte,<br />
che s'alza in esplosione di pietre<br />
dentro al moto, che spezza del valico<br />
l'immoto al successivo incombere<br />
e l'urgere del tonfo è il terrapieno<br />
zeppo del vecchio nel rinnovo, immutabile<br />
stilla del suo comportamento.<br />
Il silenzio:<br />
Ed io son tu che gridi non udita,<br />
son la tua bocca attonita,<br />
lo svanire del vano nel concreto.<br />
Io solo resto, in fondo ad ogni suono.<br />
Io solo, oltre ogni dire.<br />
Colombina<br />
Ciarliera che spiuma<br />
di polvere le frange<br />
sulla diretta punta<br />
della lingua, s’accampa<br />
nel candore del grembiule<br />
e licenziosa in grazia<br />
d’empatia combina<br />
e riscombina. Confetti<br />
sono l’epilogo e i concetti<br />
son parenti del sale<br />
nel regno delle teste di legno.<br />
Arlecchino<br />
Getto di petto, spigolo dell’anca<br />
piroetta lo sparlar d’angolo<br />
sul salato forbirsi dei tranelli.<br />
La marionetta scapita ragioni<br />
nel lato del sapere o non sapere<br />
gli avvenimenti delle conclusioni.<br />
Par olè parole<br />
in vece paro le<br />
orlape lorape praole<br />
praleo prolae praole<br />
orapel plaroe che così<br />
disfatte e fatte<br />
ne divengon rappe di chine<br />
smonti di trambotte<br />
vessilli e batticuore<br />
sopra, più alte, (sole)<br />
al fattonar dei…fatti!
Su Marionetteemiti<br />
La “Poesia scenica” di Liliana Ugolini<br />
È nel Teatro, nella crepitante sonorità della voce e nell’intreccio psicofisico dei gesti, che meglio s’esprime la trama lessicale di un libro come<br />
Marionetteemiti. Il Neologismo, significante fortemente impressivo, mutua nel suono e il cenno interagisce con la parola: in un concorde gioco di analogie<br />
dove il ritmo intona l’immagine e la parola evoca le segrete realtà del mito. Ogni tema muove da un’idea di “scena” dominata dalla ricerca di espressioni<br />
inedite, di percezioni e suggestioni tradotte in pure, sorprendenti epifanie. Aperto spazio teatrale, il testo, pluriespressivo e multicolore quanto i costumi,<br />
le posture, i soprassalti emotivi – modulatissimi – degli attori che lo interpretano, assume un plastico valore d’uso ai fini della sperimentazione d’una<br />
pecularie “poesia scenica”.<br />
Come il sonno della ragione genera paranoici mostri (cfr. Goya, un referente immediato della massa scenografia suggerita dalla scrittura di Liliana Ugolni),<br />
“l’anima burattina” – quella governata dal “supremo manipolatore, detto in sanscritto “ Colui che regge tutti i fili” (cfr. Ceronetti), il Grande Marionettista<br />
occultatore dei propri fili … e fini – produce i cangianti travestimenti dell’Io: le plurime identità d’una marionetta metamorfica che è tante cose per gli altri<br />
e per sé stessa è niente. È una prodigiosa recita di creature emblematiche rivitalizzante da un’alacre mitografia, di cerimonie arcane, di aure umbratili, di<br />
gerghi astratti e combinatorie foniche, quella messa in versi dalla Ugolini. L’affollano rapinosamente un’imparruccato Gianduia, maschera piemontese<br />
creata nel 1808 dal burattinaio Sales, e il bislacco, avvinazzato Sandrone, rivoluzionario contadino da opera buffa, la figuretta della commedia italiana<br />
dell’arte Colombina, garrula e loica, e il pervasivo intrigante Brighella, il trasformistico Arlecchino e l’ingualdrappato Cavaliere Nero, figli della Tristezza<br />
saturnina. Compaiono Saffo sublime indolenza, una Top model come una Baccante “deificata” statue – idoli stagliate in metafisiche penombre, un Edipo<br />
madido di dolore e Didone, l’appassionata regina di Tiro morta d’amore per Enea. Non mancano la danzante, languida Salomè che pretese da Erode<br />
Antipa la testa di Giovanni il Battista, Il biancovestito Pulcinella, gobbo, col naso a becco e mascherato, ciarliero e molesto; la maschera veneziana di<br />
Pantalone in zimarra nera, il Paladino in tunica ferrigna e i Capitani – guerrieri Sputaferro, Escabombardon, Fracassa, Matamoros, Rodomonte. Coi pupazzi<br />
di una truce Opera dei burattini, un mendicante timido e schivo, un clown patetico e gentile e alfine la Morte secca, schioccante con tutto il proprio<br />
scheletro sacrificale. […] Malinconia delle magiche, guizzanti marionette, dei ricordi evanescenti, della nostalgia di poveri teatrini parodianti lo scibile<br />
mitico del classicismo antico … In questo spazio virtuale e atemporale che ricorda il ceronettiano “Teatro dei Sensibili”, presso cui la sensibilità è<br />
prerogativa esclusiva delle marionette “ideofore”, dialogano Filemone e la sua sposa Bauci: parlano della povertà e della loro modesta casa trasformata in<br />
tempio dagli Dei, loro che seppero offrire il piu dolce degli asili al sommo Zeus e a suo figlio Ermete, guida dei morti nell’Ade e protettore dei mariuoli. È<br />
invece sola, fervidamente votata a parlare con una Verità che è Silenzio, la figlia di Priamo e di Ecuba, Cassandra. La profezia è il suo dono maledetto,<br />
datole da Apollo innamorato. Cassandra non accettò le profferte del dio e questi si vendicò decretando che nessuno avrebbe creduto alle parole della<br />
donna, poi violentata da Aiace nel tempio di Atena, data quale bottino di guerra ad Agamennone e infine, giunta in Grecia, uccisa da Clittennestra.<br />
Marionetta di un dio deluso è Cassandra, conoscitrice di tutte le congiure e veleni d’ogni sorta: Cassandra che dice sempre la verità, qualcosa che,<br />
similmente alla libertà, tutti nominano e nessuno vuole veramente. Irrisa da nemmeno l’ascolta, grida non udita e poi si consegna al divino silenzio che,<br />
mentre parla “oltre ogni dire” asseconda beffardo i movimenti di noi tutti dispersi sul palcoscenico del mondo: noi che “siamo marionette, ma dobbiamo,<br />
disperatamente fingere di non esserlo o come uomini siamo perduti” (cfr. Ceronetti).<br />
Flessibile scrittura di scena in versi per un teatro di poesia “fatto in casa” o girovagante per strada – quel “teatro portatile” che, secondo Artaud, è il<br />
teatro libero, scevro d’ogni condizionamento istituzionale -, Marionetteemiti opera di trasformazione alchemica della parola in voce, si fa umile copione<br />
nella versatile recitazione degli attori Rosanna Gentili e Gianni Marrani prima di elevarsi a vero e proprio poemetto sulla condizione umana.<br />
Ne consegue, a mo’ di suggello iconografico, un’ideale scenografia, ben rappresentata dalla pittrice Giovanna Ugolini, in otto pannelli collages. Ambigui<br />
coboldi, angeli sofferenti, un Einstein sberleffante, polsi sbracciatati e mani e dita di odalisca prestidigitatrici, stemmi e fregi enucleati dai loro contesti<br />
originari, ritagli di stampa incartapecoriti e cartigli con corsivi antiquariati, icone spaesate oppure spezzoni della natura violata; con visi umani trepidi,<br />
assorti o terrifici …: ecco una mimesi dell’universale entropia che tutti ci aduggia, della confusione dei linguaggi, del “vuoto a perdere” connotante una<br />
realtà disgregata e ridotta “spazzatura della storia”.<br />
Stefano Lanuzza, dalla prefazione a Marionetteemiti<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
174
Da Pellegrinaggio con eco, 2001<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
175<br />
Firenze radicata<br />
sottovoce<br />
ha un' eco che non suona<br />
eppur la suona<br />
Piazza del Carmine (Sala Vanni) (Steve Reich - Clappin' Music)<br />
Fuori dal Carmine<br />
suonava la piazza di campane<br />
al tocco dell'Ensamble.<br />
(Restano mani in grembo<br />
e gli strumenti al basso<br />
del silenzio).<br />
Sei musicanti<br />
senza lo strumento, batterono<br />
le mani su spartiti.<br />
D'ataviche memorie BATTERONO<br />
la clappin' music come nei graffiti<br />
scolpiva dentro al battito i suoi ritmi<br />
in stucco al musicar di corpo.<br />
GRAFFITI Come del nascituro è l'applaudir<br />
già l'atto del finale così<br />
divenne colpo e brivido sonoro<br />
IN STUCCO il palpeggiare di note,<br />
primordiale.<br />
Restar fuori dal canto non ha voce.<br />
Nel gruppo dissordante, frastuoni.<br />
Nell'intermezzo, a mezzo, le canzoni d'o'core.<br />
Al numero dei corpi (morti)<br />
Salta JAZZ il jazz<br />
Via della Pergola<br />
Vicino al Tiratoio, la pergola<br />
dell’uva fra Via degli Orti<br />
e Via dell'Orbatello.<br />
Asprigna<br />
in succhi di nettare celiava<br />
il proprio nome.<br />
Ci venimmo le volte del teatro.<br />
"Re Lear" da Ricci, TEATRO "Il Giardino"<br />
di Cechov, "Le tre sorelle",<br />
la compagnia dei Giovani, De Lullo,<br />
la Falk, Valli, l'Albani. Veniva<br />
uno scrosciar delirio.<br />
Ora d‘Ovadia<br />
non più ghetto, il detto resta livido, DELIRIO<br />
la denuncia, la voce.<br />
RESTA LIVIDO Accolto per un tempo<br />
(l'indicibile) d'un grido.<br />
Tace il pubblico mono/tono, UN GRIDO a batter<br />
mani nel suo cerchio, voce<br />
senza parole, gruppo muto. Dove<br />
il messaggio cade?<br />
L'istrione<br />
calca pezzi di noi e l’atto è fine<br />
CADE? in sgretolar certezze. Fuori un piccolo bar,<br />
in corsa di spettacolo,<br />
il caffè,<br />
e l'Ospedale, NOI accanto, per una scena a colpo,<br />
dietro l'angolo<br />
IN SGRETOLAR CERTEZZE
Su Pellegrinaggio con eco<br />
PER PELLEGRINAGGIO CON ECO (ACROSTICO) / Pellegrinaggio, Liliana con Eco Eco Eco Eco Eco - / Eccoci qua: questo Pellegrinaggio per luoghi di<br />
pietra / e verde – per / Latébe e per luci - per cervelli da boccascena – questo / Lanzichenecco sacral pellegrin - aggio di parole e parole / Eh sì,<br />
Liliana / cara, ora m'appare un'arca (d) ica eco di / Galassia/Città (il monolito? Boboli? piazza delle Pallottole?) - / Rude/molle galassia la Città<br />
che / (diciamo) "forse è nostra“ / Invece è tutta loro - tutto l'oro del mondo è una città - / No: solamente Fiorenza - solo Florence che tu /<br />
Allùmini di / tuo giostrando in giostre caleidoscopi - / Giostre sì macroscopiche di vita/morte (Vita e Morte) / Generosa tu - per questi lastrici di<br />
/ Storia/storie / (Io calcante ben più magre evenienze – convinzioni / O calzante - chi sa - un alterno corale monologo ...) / "Certi della perdita<br />
della foce", scrivi. "Dopo l'angolo ho casa“ / O "qua la parola cambierà la storia": nulle certezze - / Nulla nulla euforia "la vita che si sfoglia": /<br />
soloECO d'un Eco d'un / Eco d'un Eco d'una parvenza che si (s) fa - / Calda ossuta pietà - estraniamento - poderosa in-essenza / O<br />
rappresentazione d'una splendida Assenza (che si nòma Fiorenza)<br />
Mariella Bettarini<br />
* * *<br />
Di Pellegrinaggio con eco vorrei svelare almeno due significati, ovvero il suo senso di mappa, il riferimento su carta per compiere<br />
attraversamenti e sopralluoghi, e le sue congiunture musicali che sono come folate di vento, ondate di uscite e di ritorni, di echi appunto densi<br />
di musica.<br />
Mappa perché il pellegrinaggio può non averne una predefinita ma ne costruisce una strada facendo, man mano che si avvicina alla meta<br />
prefissa. Chi viaggia conserva almeno negli occhi dei luoghi e, nei ricordi, degli incontri. Questa raccolta di versi è come un diario di viaggio e il<br />
viaggio è la vita stessa dell'autrice e tutto ciò che l'ha preceduta. C'è l'eco in questo libro di una storia collettiva, del sentimento corale di tutti<br />
quegli individui che hanno abitato prima di oggi le strade di Firenze e che, pure se estinti, sopravvivono nel sapere che qualcuno di vivo e<br />
pulsante ha preceduto il nostro venire al mondo e respirare.<br />
L'architettura muraria che offre la città ci dona tracce del passato in una miriade di segni, di targhe di nomi di lapidi e tabernacoli, o di aneddoti<br />
che ancora rimbalzano nelle botteghe artigiane dei quartieri più antichi. C'è l'Arco di San Piero con i suoi tumulti e le uccisioni nella “fragranza<br />
del tempo accavallato”. E poi ci sono le torri le basiliche e i teatri e ogni luogo ha i suoi elementi e i suoi perché: l'incanto della cattedrale di<br />
Piazza Duomo per la “tela leggera” del suo marmo (“La mole che mi schiaccia è la purezza / del lieve”); il teatro de “La Pergola” un tempo<br />
circondato di orti e d'uva asprigna che “in succhi di nettare celiava / il proprio nome”. Ci sono i luoghi del fuori e i luoghi interni, quando si varca<br />
una soglia reale come in Badia Fiorentina (“Aprii in Badia la porta / e stetti lì di botto”) o quand'anche è discesa intima. Molte le chiese visitate<br />
e poi trasposte in versi ma l'autrice dichiara di non professare alcun credo religioso. L'eco della preghiera come canto la travolge spesso,<br />
pellegrina, e l'avvolge in riflessioni scaltre o fiduciose sul senso dell'esistere. Da Preghiera, la quartina finale: “Libertà LIBERTA' / così vorremmo<br />
sicurezze /forti di inondazioni / certi della caduta nella foce”.<br />
Simona Maionchi, “Il Ponte“, 2, 2001<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
176
Da Imperdonate, 2002<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
177<br />
Medea<br />
Figli...<br />
... che il sonno vi venga dentro la storia del Tempo...<br />
... Addormentati in favole di sogno<br />
così compongo il giaciglio della Storia.<br />
Le membra rilasciate dentro il sonno,<br />
una goccia d'Eliso mentre più volte<br />
evento la mia furia distruggo<br />
nel composto delirio:<br />
non uccisi i miei figli per Giasone.<br />
Raccontarono in cronaca sterminio,<br />
del diritto di sposa e di persona. Io so<br />
di madre in madre, dentro al crematorio,<br />
l'immenso del terrore. Dalla strage<br />
d'innocenti dell'Erode, ai campi<br />
delle docce dentro al gas, chi da l'ordine<br />
è specie, un umano, nel comando.<br />
Vasto più vasto è il lutto ma della<br />
crudeltà produco la sua Stirpe.<br />
Io son Colei che salva il Gene<br />
oltre quel tutto che rifà la storia.<br />
Seppi d'un tempo ancora nel futuro,<br />
che è qua giaciglio inerme dentro al sonno.<br />
Velatamente, senza farvi male,<br />
figli d'un figlio immane,<br />
allungo il sonno, portandovi sul Carro<br />
verso il Sole, nel tentativo,<br />
l'ultimo,<br />
che resta<br />
di fermare<br />
l'Orrore.<br />
Antigone<br />
È sogno quel gesto pietoso<br />
che non è sogno ma possibilità<br />
di sogno non nostro, universalità<br />
di sogno che radica nel comune,<br />
che brivida nei corpi indifesi a difesa.<br />
È il superamento, nel sogno,<br />
dell'umana pietas per l'umana<br />
sventura, il combattuto sogno<br />
che ci accomuna al fulgore di vittime<br />
ingiustamente vittime d'un sogno.<br />
Ed è per quel sogno, per quel non potersi<br />
disgiungere dal sogno che è la forza,<br />
il mistero che ci unisce<br />
fino all'estremo del sogno.<br />
E non c'è più morte ma superamento<br />
nel sogno il far della vita una coerenza<br />
al sogno, pietas del sogno pietas sognata<br />
pietas vincente nel sogno, nell'idea<br />
d’un sogno nostro che non viene<br />
se non dall'universalità d'un sogno<br />
fatto nostro.<br />
*<br />
(Il suono, vibrazione di noi,<br />
di tutti i corpi è in ascolto.)<br />
È il nostro profondo fraterno sogno<br />
liberato, per il raggiungimento nel presente<br />
d'un futuro (sempre futuro) sogno.
Da Spettacolo e Palcoscenico, 2003<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
178<br />
Da SPETTACOLO<br />
La passione<br />
Mezz'ora, mezz'ora durava lo spettacolo<br />
ridotto. A Torino. In due luoghi.<br />
Si partiva lontano quattrocento Kilometri.<br />
L'attrice, il suo bambino, un carrettino,<br />
la mamma baby-sitter, pannolini, tutine,<br />
due valigie-costumi, il bastone, un tutù,<br />
la ballerina, l'autrice. L'avventura<br />
partì. L'albergo, il ristorante, lo spettacolo,<br />
le prove, un mercatino e il teatro.<br />
La Barraca al completo senza il carro partì.<br />
Aveva senso? Sì, aveva senso.<br />
Il sogno<br />
Non potremo certo dire all'uomo<br />
che in cielo e in terra non ha proporzioni<br />
e non potremo dirgli che nonostante<br />
lui lo creda non c'è da credere<br />
se non nel sogno che lo tiene in vita<br />
e neppure sogno lo compete ma possibilità<br />
di sogno. Anche la volontà che nasce<br />
fuori e dentro le sue cellule non potremo<br />
dire all'uomo che non viene da lui e che la fede<br />
è percezione, solo un canale del sogno.<br />
E che non somiglia a nessuno ma di animali<br />
alberi e pietre è specchio e loro espressione.<br />
Non potremo certo dirgli la sua piccolezza<br />
e il suo (la sua) fine per una trasformazione<br />
d'un sogno non suo.<br />
Il burattino<br />
Lì, nella stanza delle marionette,<br />
il desco apparecchiato in desideri<br />
di buono, si fece bricco e versò atmosfere.<br />
Ebbri di senso e approvazione, i corpi<br />
alleggerivano spaziali e le parole in riso<br />
intelligentemente bollicine alzavano.<br />
Furon danze di vortici, elevazione,<br />
senso di vita sorta dal dolore rimosso.<br />
Fu la frecciata piena d'un trascorso<br />
affiorato nella dichiarazione:<br />
"Così sarei stato, canto, suono, danza<br />
e non son stato. Che altro..." E un soffio<br />
cadenzò un batter d'osso-legno<br />
un batter burattino...<br />
Concretizzo l'immaginario nel teatro<br />
invece di sognare una realtà<br />
che è cosa ben diversa nel molteplice.<br />
Invento nel teatro verità e lì<br />
son libera lucertola
Da Spettacolo e Palcoscenico, 2003<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
179<br />
Da PALCOSCENICO<br />
Coro<br />
Onda anomala, oggi, la guerra.<br />
Questo, noi, l'abbiamo capito.<br />
Dopo tante tempeste, vascelli<br />
e detriti in riflessione, dall'onda<br />
vedevamo la marea della gente<br />
acqua d'acqua in cammino.<br />
Ed ora il muro di schiuma<br />
con uguale cecità, viola le coste.<br />
Siamo incapaci di cambiare<br />
il filo dell'onda, noi, in cicli<br />
distruttivi contro la vastità<br />
della diversitudine?<br />
Quali crolli di coscienza<br />
procurano la massa d'acqua?<br />
Onda anomala, oggi, la guerra;<br />
era il grido dei delfini il filo indagatore,<br />
la nostra voce opaca d'ultra-suoni.<br />
Sulla spiaggia di stragi, ci siamo<br />
anche noi da tutto il mondo<br />
su piattaforme di fermezza.<br />
Onda anomala, oggi, la guerra.<br />
Questo, noi, lo abbiamo capito.
Su Imperdonate e Spettacolo e Palcoscenico<br />
[…] (Imperdonate) Per l'esattezza si tratta di "testi poetici-teatrali" con intercalate opere visive di Laura Viliani. In effetti la poesia si presta a<br />
varie dimensioni, persino alla coreografia, poiché la parola riesce a suscitare risonanze non di rado a carattere puramente fonico: in questo<br />
dialogo fra scrittura e arte figurativa si assiste un feeling che trova la ragion d'essere in elementi (il tratto e la versificazione) coincidenti, per<br />
esempio il tartiniano "Trillo del Diavolo" - e qui è ispiratrice la mu(sic)a - scatena un'originale fantasia linguistica.<br />
Luciano Nanni, “Punto di vista”, 2003<br />
* * *<br />
[…] (Imperconate) Un tema abissale avvicinato e insieme messo a distanza da angolazioni caleidoscopiche. Il suo testo mi è parso forte quanto<br />
originale e autentico. […]<br />
Giuseppe Pontiggia, corrispondenza privata<br />
* * *<br />
[…] …la prima parte: "Spettacolo", è interamente filmica.<br />
Le sequenze, come fotogrammi vengono sospinte da un vento tellurico, oscillante. Muovono e sommuovono i vari piani di azione. Le presenze,<br />
al femminile, perdono le connotazione: il tutto legato dal filo violetto del dramma implicito, catenella che porta in sé il respiro della<br />
speculazione. "Invento nel Teatro verità“.<br />
[…] …nel testo "Palcoscenico", il Teatro assume il viaggio come percorso mentale, introspettivo. Il monologo è un canto che a sua volta è<br />
richiamo e intima verità. Il dramma descritto diviene elemento purificatore, oggetto della Passio.<br />
[…] L'eroe combatte, l'eroe donna scava con la forza della sua fede nella vita e nella morte un pozzo profondissimo da cui sgorgherà l'acqua<br />
della rigenerazione<br />
Maria Pia Moschini, dalla postfazione a Spettacolo e Palcoscenico<br />
* * *<br />
La vita che dà spettacolo di sé, nell’apprendere le costanti del quotidiano “diverso” e sempre uguale della liturgia preparatoria, dal testo, alla<br />
scena, alla regia, ai costumi e via dicendo, misura la scelta, procede per sezioni, per personaggi, per scansioni di scena “endecasillabica”, nel<br />
finale tra “cronaca di una storia vera” e l’utopia del sogno e il suo possibile (infinito se si accoglie la tesi di Musil). Ogni azione genera sequenze<br />
e analogie, conseguenziali ipotesi che la vita spettacolarizza e lo spettacolo rivitalizza. Liliana Ugolini licenzia alle stampe prima che alla ribalta i<br />
suoi versi teatrali quasi che “americane e cantinelle” diventano le linee guida della scrittura su tavola, in un crescendo a suo dire asettico nella<br />
regia di pagina per aprirsi alle invenzioni ricreative della regia in scena. La poesia che si fa teatro, non solo come teatro di poesia ma come<br />
parola drammaturgica di alta levatura, di profilo lirico, di meta scrittura in un contesto che sulla lezione di Carmelo Bene, abbia bandita la<br />
rappresentazione e giochi a mettere fuori scena la poesia-spettacolo, evidenzia e nasconde l’autore, coinvolto nella operazione dinamica<br />
dell’intera azione e si prepari alla seconda parte, su quel “palcoscenico” che ne accolga la lettura e l’evento nel corpo dell’attore (come sostiene<br />
giustamente Sanguineti). Qui i personaggi orchestrati drammaturgicamente tra mito e letteratura, nel dominio della ribalta si incontrano, quali<br />
prototiti universali di misteri legati alla vita ed assurgono ad emblema… […]<br />
Giovanni Amodio, “Arte Cultura”, settembre 2004<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
180
Da Delle marionette, dei Burattini e del Burattinaio. Rilettura fantastica del Teatrino, 2007<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
181<br />
XVII<br />
Marionette, burattini e lo stupore<br />
Nella bella stagione, di notte, capita alle Marionette e ai<br />
Burattini di alzare gli occhi al cielo e l’organismo stellare<br />
appare loro in tutta la sua immensità e bellezza. Così ad<br />
occhio nudo sanno che vedono pochissimi mondi in<br />
confronto a quelli che potrebbero vedere col telescopio o<br />
da una sonda spaziale. Sono ugualmente così fitti che la via<br />
lattea sembra un velo. Luccicano i mondi di luce propria e<br />
luce riflessa e le marionette e i burattini sono incantati. E<br />
vedono gli occhi, il naso e la bocca della luna o i suoi crateri,<br />
s’immaginano l’orma del loro piede e la possibilità di<br />
trasloco, vedono la luce e il nero trasparente e sanno di un<br />
universo parallelo o di tanti altri. Immaginano gli astronauti<br />
e gli argonauti percependo l’immenso. Batte loro il cuore<br />
che pulsa scandendo il flusso del sangue allo stesso ritmo<br />
del bagliore d’una stella. Le marionette e i burattini stanno<br />
muti e il loro pensiero corre alla loro misura e anche alla<br />
possibilità di pensare gli spazi e anche ad una lucciola che lì<br />
non c’è più. Stupefacente è il silenzio lontano della città<br />
illuminata. Le proporzioni dei mille e più universi non si può<br />
misurare ma anche loro sanno di essere uno dei tanti<br />
universi uguali nel caso d’un insondabile perché. Finalmente<br />
si sentono grandi e piccini e la gioia di essere in quel<br />
momento è l’abbraccio della mano con il filo che cuce il<br />
sogno del Burattinaio troppo grande per loro e<br />
comprendono che per questo nessuna marionetta potrà<br />
essere altro che quella, in questa percezione. Questa le fa<br />
grandi tanto da dare loro la possibilità di sondare<br />
quell’universo, di rallentare il tempo e di scoprire ancora e<br />
ancora il gioco giocato dentro di loro, in espansione.<br />
Vi godo impenetrabile distanza<br />
e quasi tocco lo spicco del mio volo.<br />
Il vuoto mi trattiene ora che perdo coscienza di volare<br />
come falla o molla di certezze.<br />
Eppure so la fede tangibile marea<br />
del mio im-possibile.<br />
La bellezza è dell’altro salire di me<br />
e vedermi più piccolo centro d’un vasto.<br />
Scorrendo da groppi di pianto (candori candori)<br />
vedere gli errori. In petali stupori di vita e di morte<br />
bellezza complessa. Cannoni schiodati<br />
in un foglio di storie volato in canzoni canzoni<br />
e nel rosso di rosa.<br />
La marionetta è il corsivo di me<br />
fra righe, in luoghi.<br />
Il mio sogno ha un’altra storia.
Su Delle marionette, dei Burattini e del Burattinaio. Rilettura fantastica del Teatrino<br />
LE MARIONETTE E I BURATTINI NELLA METAFORA DEL GESTO E DELLA VOCE<br />
Nel terso clima di questo libro, anzi Fiabola di irsuto pudore toscano (in versi, prosa, illustrazioni secondo le leggi e le umorosità narrative) si<br />
riscontra un assoluto e ininterrotto segno di vocazione a quel genere di teatro che privilegia “maschere e burattini” secondo una felice e<br />
feconda “irrealtà quotidiana” per dirla con Ottiero Ottieri, peraltro inconfondibile fra le diverse scritture contemporanee in fatto di mimesi<br />
fantastica e dialettica visuale. Liliana Ugolini collabora all’iniziativa considerando gli effetti interiori dei personaggi in questione: lingua fervida,<br />
osservazioni concettuali, trasparenze di corpi e di gesti elevati oltre ogni polvere; Giovanna dipinge mimesi e illusioni retoriche, spazi vincolati al<br />
bene e al male dei fatti, elevando lo spirito della pantomima a configurazione critica, emotiva, sociale del conflitto iconografico. In ogni<br />
simulazione c’è un accento di poeticità divertita, una sorgiva ilaro-tragica (come direbbe Giorgio Manganelli), una riscoperta ironizzata,<br />
automatica, libera, pagana e sacra, concreta e oggettiva. L’opera finge un proprio cromatismo letterario e grafico, lascia riferimenti<br />
appassionati ad ogni lettera e segno. La stessa prosa è speculare così come la serie di disegni che l’attraversano e salva sia l’aspetto<br />
convenzionale del dire e del disdire dei “manichini” e dei “burattini” sia l’interrelazione che carica di significati la loro non efferata biologia. Il<br />
gioco, l’alienazione che presiedono alla vicenda un po’ assorta, un po’ problematica, (un po’ il riordino dei temi che, dal fondo della tradizione,<br />
si portano fino a noi, comunicando essenze labili e colte denuncie per verificarsi), continuano in ogni caso la memoria e insieme lo spettacolo<br />
che le Autrice e la tensione attiva svolgono, rifondando i sensi di umanità e la veloce prospettiva delle questioni. I personaggi (chissà quanto<br />
egocentrici e utopici, moralisti e civili, con voci torve o chiocce, cacofoniche e modulate per la consapevolezza rappresentativa) perdurano in<br />
questa accademia, grazie alle sorelle in causa e ricominciano le linee mimetiche del processo di apparenza, di conflitti, in una recitazione<br />
temporale, aperta, anzi a lettura molteplice di sensi e di disputa. E, relazione sottile, qua e là audace, adattata ad una modernità i cui riverberi<br />
di ogni fiaba sono spesso stravolti, non senza angoscia e significato. L’analisi della pagina è puntuale occasione per destinare alla scuola un<br />
rapporto del genere, i cui codici dell’evento così come quelli del dibattito culturale non sono fine a sé stessi ma progettano e prevedono<br />
soluzioni inventive sempre più duttili e inedite. Senza negare al testo l’“a priori” del suo teatro assiduamente annunciato nel riscontro, qui<br />
comunque ripercorso come dono, non come esperienza scabra o delirante bensì polarità percettiva del medesimo destino della materia a cui la<br />
tesi si affida e in cui s’insinua il desiderio esteso di un lieto piacere di incontrarsi con l’arte, su lesta identità inventata. Senza dire quanta storia<br />
si è enucleata e scritta o dipinta tra questi fili che ascoltano il mondo, l’impatto forma-energia che li ha caratterizzati, cogliendo la psicologia<br />
delle mani, le epifanie linde e intense del loro ricominciamento efficace, comico, presto decifrabile e amato, non frivolo né eccentrico o lezioso.<br />
Con gli stessi controlli del “ Burattinaio” direttore, ormai guida dell’intreccio, dell’enfasi e delle pause (che non arrossa mai il loro viso lucido,<br />
vestito elegante) per testimoniare al pubblico e in pubblico la natura della loro esistenza, della divergenza espressiva, che è in ogni caso<br />
metafora del presente, contingenza che non soffre per comunicazione o recita doc, la cui percezione morale diviene verifica e sentimento<br />
operativo non logoro.<br />
La natura ludica di codesti valori ha dunque una coesistenza non soltanto effusiva e verbale ma d’incontro e passo deciso verso<br />
un’interpretazione della verità riassunta in dettagli irrinunciabili, tra incanti e disincanti, tra impazienti e affaticate, violente, incancellabili,<br />
riabilitate da un equilibrio che Liliana ravvisa ineliminabilmente. Di tutto punto le marionette e i burattini sono figure attive e visibili, con una<br />
loro efficace aneddotica, mai sconfitta o ridotta a mera imitazione di riletture pulcinellesche; in effetti riscoprono sé stessi rianimando le<br />
medesime esplosioni della vita comune, il viaggio che in essa si compie, le funzioni elementari nel brusio che sale dal vocio della gente, che in<br />
ogni caso lascia ai burattini il discorso che può proteggere lo spettatore di ogni categoria, rappresentato (sopportabilmente) più che dal<br />
politico, dalla persona di pezza: secca, liscia, vellutata, appesa e sospesa non soltanto all’apparato della scena, ma alle contingenze più<br />
immediate<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
182<br />
x
Su Delle marionette, dei Burattini e del Burattinaio. Rilettura fantastica del Teatrino<br />
immediate, più aneddotico che uomo sicuro, più compagno di giochi che serioso pedagogo. Questa è una sensibile devozione che merita<br />
durata; non si rivela soltanto in periferia o in una zona del mercato settimanale che ha bisogno di riempire il vuoto di uno spazio per venditori di<br />
cose. L’interesse non sorveglia alcuna ambiguità, né destina a dissidenti filosofie popolari anacronistiche<br />
anzi cita per loro il movimento obbligato, scioglie con rapidità i nodi posti dagli assidui interrogativi sulla vita e la non vita delle persone che<br />
lottano adoprando la voce cruda e il magnetofono, la pubblicità assillante, la lingua della ricerca che fonda (e sogna) un sempre più diretto<br />
capire nel mare magnum dell’attualità. Per più orizzonti ancella d’una modernità lucida che resta più spesso vezzo assente e maniera di farsi<br />
progressivi o docili a quello che morde o s’aggira tra noi secondo le immagini correnti sapidamente coinvolte. Liliana Ugolini intende per più<br />
necessità questo genere di teatro, definisce, inscrive le istanze (peraltro praticate in fonti e fondi diversi di poeticità incancellabile)<br />
rivendicando la passione della sua scelta e proiettando essenze, accessi, ebbre cause (non auliche o arse ) per motivare il coraggio e il volo della<br />
fantasia, la denuncia, il garbo che diviene attrazione sempre meglio riaccesa, elemento del cosmo a cui si affida, che dal teatro giunge ad un<br />
Oltre che diventa ductus di entusiasmo scritto (e orale) ripartendo di là, vincendo qualsiasi rumore e senso proibito. Armonie e disarmonie<br />
(evidenti o recondite) sono esplicitate nel testo cartaceo (prosa-verso, avallo disegnato) e sono guida al lettore di questo volume prezioso la cui<br />
didattica s’ inscrive nella nozione mentale ( e pragmatica) che lo ha generato e che senz’altro non va eluso per altre seduzioni illette perché non<br />
deduttive su ciò che nell’ esistenza di ognuno accade. Nell’attraversamento di questa transizione ormai datata e pur insidiosa è riconoscibile la<br />
qualità (non dogmatica) del contributo indirizzato all’argomento e qui si offrono le spiegazioni talora sorprendenti e icastiche, inseparabili da<br />
una specie di allegoria, non solo formale delle cognizioni insinuate nella fisica delle espressioni. Esse in tutto rileggono le fantasie di quel<br />
“teatrino” che ormai riassume l’elan vital e la fortuna della ricerca che le sorelle Ugolini hanno imposto come un neo-idillio agli stessi tragitti<br />
della poesia dei nostri anni. Senza appoggiarsi affatto ad altro transfert per caratterizzarli “ da qui all’eternità”, proprio perché il teatro è vita e<br />
ogni viaggio verso di esso, travaso universale.<br />
Domenico Cara, “Vernice”, 36, 2007<br />
* * *<br />
[…] Un’ atmosfera festosa e in continuo movimento incornicia l’incontro ben riuscito di prosa, poesia e immagine in Delle Marionette, dei<br />
Burattini e del Burattinaio, all’insegna di un fatato surrealismo in chiave storica e psicanalitica, che si rende favola per metafore del destino<br />
umano rappresentato sulla scena del mondo: l’immenso teatro senza confini determinati e senza un fondo scena conclusivo. Liliana lavora sulla<br />
parola in modo più etereo e meno laboratoriale rispetto al passato, ma anche con più profondi intenti cognitivi ed esplicativi; mentre Giovanna<br />
inventa un fantastico mondo di figurine seducenti e maliziose, cariche di nostalgia e di bellezza: le due sorelle Ugolini ancora una volta<br />
conquistano il lettore per la grazia e la ricchezza delle loro alluse corrispondenze di significati e di emozioni. […]<br />
Sandro Gros-Pietro, “Punto d’incontro”, 3 – 4, 2007<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
183<br />
x
Da A nera, 2009<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
184<br />
(Abitare il nero)<br />
Antenna<br />
M’annienta nero<br />
l’Antenna dell’insetto<br />
cenno di cappio inconscio<br />
e macigno del no.<br />
Gettarsi nel rifiuto<br />
e rivoltare il guscio<br />
della tartaruga<br />
in metamorfosi d’estremo<br />
rallentarsi del suo sì<br />
sibilo spiro.<br />
Ospiti del breve incanto<br />
incauti e incanutiti<br />
danziamo il ballo della mosca.<br />
Il ragno non sappiamo dove sia<br />
tanto è sepolta in noi la sua zampata.<br />
(Abitare il nero)<br />
Apuleio<br />
È un cerchio di concetti<br />
(narrazioni) sulla pagina<br />
annerita di parole<br />
d’Apuleio favole a filo<br />
(stringere le fila),. Poetica<br />
scovata di mani<br />
le canzoni spaziano<br />
in mutazione di pelle.<br />
Emergere dall’edere sui tronchi<br />
dai tagli dell’avene. Le pietraie<br />
ordinate tappezzano d’ortensie di soft<br />
( lo struggimento) e nel cammino pieno<br />
l’angolo è scosceso. L’incanto del terribile<br />
respinge un cosmo d’origine nei voli<br />
e m’attaccano mosche di Zefiro.<br />
Gli sconosciuti luoghi mancano<br />
alle mie mani e le zolle sconosco nella coltre di cenere.<br />
Spira l’ira di Venere e le percosse percorrono<br />
Cupido dalle ruote impennate.<br />
Gronda Psiche in corolle.
Da Gioco d’ombre sul sipario, 2010<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
185<br />
Il mimo:<br />
Fugace notte pulsa di bagliori<br />
nell’apparente immenso dello sguardo<br />
che abbraccia la galassia.<br />
Lontano in tempi sto alla meraviglia<br />
delle stelle al centro d’universo<br />
e dall’inimmaginabile infinito<br />
sparisco sovrastato<br />
(quanti passi su pietre assorbiti in silenzio<br />
sono trascorsi e tra spacchi ricordi germogliano<br />
di noi che ritorniamo bendati all’avvenire.<br />
Mia sicurezza è il magma che si muove<br />
delle nostre storie pietra o meteora)<br />
C’era una volta e c’è<br />
L’abbraccio è fino a l’aria degli abissi<br />
oltre vette rovesciate bollenti<br />
in pelle di corolle<br />
smagliate agli occhi d’amore<br />
Il Circo<br />
Il Clown bianco duplicato interviene con grazia ma non c’è.<br />
Intorno in un’apoteosi di perfezione di pochi minuti, le figure incorporee<br />
svaniscono in forme come nuvole. Hanno volti coperte da un trucco<br />
indistinguibile dalla maschera, condensati alle bocche rosse. La paura e<br />
l’esaltazione sono dilatate in espressioni e sostituiscono le parole. Intorno corpi<br />
flessuosi, fasciati da costumi raffinati, raggiungono tutti i colori con la gamma in<br />
natura. Piccoli ed eccelsi gli uomini volano sui trapezi o appesi a drappi d’ali o in<br />
bilico sulle corde. Volteggiano dicendo la certezza matematica d’un calcolo e la<br />
caducità e l’imperfezione restano negli occhi stupefatti degli spettatori. Gli<br />
oggetti volano lanciati sfruttando la forza centrifuga e ricadono perfetti al centro<br />
della gravità. Una figura rossa, morbida e soffice, rotea mostrando un corpo<br />
flessibile pronto a cogliere ogni bagliore e la sua bellezza colpisce intrigando<br />
l’ombra. I Clown sgargianti salgono come astronauti e combinano guai in<br />
sperimentazioni togliendosi stranamente la calotta per respirare. Tre piccole<br />
donne-bambine dimostrano nel lancio e nella ripresa d’un rocchetto, la fede nella<br />
realizzazione dell’idea che tutto sia possibile insita in ogni alba della gioventù<br />
riuscendo a dimostrarlo in una compiutezza di tempi che non tiene conto<br />
dell’imprevedibilità. Vola azzurro in pose statiche un corpo, o meglio, l’essenza<br />
d’un corpo di uomo che ha già vinto le leggi scoperte dalla scienza mentre una<br />
ballerina, diafana, sottolinea in passi di danza che appena toccano il pavimento, la<br />
trascendenza dell’anima dell’Arte che aleggia tutt’intorno. Un bagliore terrifico<br />
ad un tratto ferma l’esattezza dell’insieme poi, lentamente integrandosi, lascia<br />
che l’effetto dirompente si sciolga in uno specchio opaco. Tutto torna di nuovo a<br />
muoversi in euforia e leggerezza in un estratto che qui, dura un’ora e mezzo e un<br />
niente nell’orologio dell’età della terra.
Da Gioco d’ombre sul sipario, 2010<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
186<br />
L’opera svela la psiche<br />
la torbida verità multiforme<br />
e il volto morente del cuscino<br />
è una conchiglia. Il teatro<br />
è la dimensione del colmo<br />
e soffia indicibile. La morte<br />
è marionetta metro di suoni<br />
e il nastro di Mobius<br />
l’urlo della risata.<br />
(Sarei del mondo cittadina<br />
se quel giorno non fossi partita per restare<br />
e avrei incontrato chi non ho conosciuto<br />
né avrei parlato con chi parlo.<br />
Qui cittadina del mondo partita<br />
avrei casa dove non sto<br />
e non sarei chi sono<br />
se quel giorno non fossi partita per restare).<br />
Tutti i personaggi (Il mimo, C’era una volta e c’è, il Re, il Cavallo, il Ritorno, il<br />
Mare,i Fiori, gli Occhi, i Bambini e la Luna, il Bosco, la Scena, i Numeri, il Circo, i<br />
Vecchi, la Parola e il Silenzio, i Colori, l’Opera, la Musica, il Soprano) si alzarono<br />
di nuovo in piedi. L’Artefice doveva comparire, la regia doveva esserci. In una<br />
fumata la voce dalla montagna sparì fra le nevi lasciando gli interpreti a bocca<br />
aperta. Il sipario rosso chiuse l’Era e fu di nuovo sera quella sera.<br />
“La terra che contiene i mimi<br />
della globalità e tante altre splendide creature<br />
nell’universo dà luce riflessa.<br />
Così le creature illuminate sappiano questo<br />
e il buio che girando poi avviene”…<br />
…così disse il bianco mimo come una nuvola con i buchi negli occhi mentre al<br />
buio toglieva i fili dalla terra nera in attesa della nuova luce che di certo sarebbe<br />
arrivata dall’alba dagli occhi d’un bambino…
Su Gioco d’ombre sul sipario<br />
Il processo creativo di Liliana Ugolini si sviluppa propriamente, in questo Gioco d’ombre sul Sipario (ma anche in tutta la sua produzione), fra<br />
parola, spazio, interiore gestualità, in questa uscita dall’angolo per farsi Artefice-regista di una rappresentazione della parte nascosta (ombrosa)<br />
della vita, propria e nostra, vaticinante in particolare in quell’incipit poeticamente folgorante:<br />
“Fugace notte pulsa di bagliori nell’apparente immenso dello sguardo<br />
che abbraccia la galassia”<br />
in cui, con sicurezza profetica, apparente è ciò che appare, e non ciò che può sembrare. L’intera rappresentazione non è attraversata dal<br />
dubbio, bensì vive nella naturale certezza delle cose, ancorché non conosciute. Perché la poesia non è ciò che può, forse, apparire bensì ciò che<br />
è.<br />
Ma ancora il Mimo s’appresta a rivelare quel germe della sua casa (da una solitudine a una scoperta spaziale):<br />
“La casa dove bacio la soglia<br />
mi riconosce amica di presenze…”<br />
D’altro canto lo stesso processo è esplicitamente dichiarato nella memoria della propria epifania, in cui l’autrice, o il Mimo (per grazia del Dio?<br />
della Poesia?), ritrova se stessa (che cosa mi spinge alla soglia dell’essere me), e la propria voce nell’indicibile:<br />
“Memoria e tempo formarono la scena<br />
dove imparo la parte mai imparata.<br />
Sgambetto dal mio filo e il palco si fa scuro.<br />
Di parole ho mente e bocca piena<br />
e non mi serviranno per capire.<br />
L’inchino è riservato a quel Supremo<br />
che il sipario m’apri per la Commedia.”<br />
Ed ecco che si rivelano all’annuncio (“quando tutti i Personaggi si alzarono in piedi”) la nascita e la morte, l’aria e gli abissi, i tempi della vita e<br />
della musica e dell’eterno, la partenza dalla casa e il ritorno, la bufera mugghiante e le acque prolifiche, le colpe e le paure, la luce negli occhi<br />
dell’innocenza, i misteriosi aromi del bosco, terre e cieli, i profetici numeri cabalistici, l’immobilità dei silenzi e i corpi flessibili, le germinazioni e<br />
le geologie, i colori, gli accordi, le splendide universali creature… […]<br />
Quel tutto, biologico e cosmologico, che è colto dalla parola e dal silenzio.<br />
Ma non si tratta di generiche, indistinte dismisure, poiché, in questa rappresentazione la natura stessa e ogni personaggio in essa hanno la loro<br />
storia, ogni evento ha la sua particolare apparenza, visibilità, scandita di verso in verso, ora da un flusso di parola, ora da una proposizione di<br />
pause fra gli asintattismi, ora da una individuale e collettiva, progressiva, presa di coscienza. […]<br />
Gio Ferri, dalla postfazione a Gioco d’ombre sul sipario<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
187
Su Tuttoteatro<br />
TUITTOTEATRO è il volume, edito nel 2008 da Joker, che raccoglie la produzione teatrale di Liliana Ugolini, Si tratta di<br />
lavori poetici messi nello spazio alla ricerca di una teatralità del verso poetico.<br />
[…] Quello di Liliana Ugolini è un nome noto a chi si occupa del territorio di ricerca tra poesia e teatro, quella zona affascinante che coltiva il<br />
potere multiforme e svelante dell’oralità senza tuttavia investire i versi di un potere che non hanno, senza cioè snaturarli e violentarli. Il<br />
problema dell’oralità è vasto e complesso, e non è questa la sede per approfondirlo. Occorre però lanciare un grido d’allarme di fronte al<br />
proliferare di reading di poesia nei quali il verso è assoggettato all’istrionismo del lettore, o al palato spesso del pubblico, mentre la musicalità<br />
interna e peculiare del testo poetico (quando c’è) viene del tutto stravolta, e passa l’idea di una poesia come stampella per non si sa bene quale<br />
“espressione” umana compromessa in realtà con la spettacolarizzazione.<br />
Fortunatamente vi sono scrittori interessati a qualcosa di ben diverso: alla parola che in sinergia con altre arti ed espressioni si fa teatro, alla<br />
parola non spettacolarizzata ma che concorre allo spettacolo. Il tutto in testi che non sono canovacci ma opere compiute, spesso cucite su<br />
figure del mito (materiali con i quali costruire una rappresentazione del mondo e del sé, la quale è sempre e per forza una interpretazione). E<br />
soprattutto, con alle spalle una concezione di poesia non come vaga poeticità, espressione puerile di sensazioni illanguidite o edulcorate (come<br />
è in molta poesia, dobbiamo purtroppo dirlo, soprattutto femminile), ma come espressione a suo modo civile, partecipe, sociale, consapevole<br />
della storia, ancora una volta ancorata all’idea della poesia classica, per sua natura legata all’oralità e dunque teatrale in un modo sideralmente<br />
lontano dagli istrionismi contemporanei.<br />
Tutto questo, beninteso, non significa che la Ugolini non sia una poetessa, anzi: nasce poeta e scrive opere che vivono sulla pagina, dotate dei<br />
caratteri tipici della poesia scritta… […]<br />
Sandro Montalto, dalla postfazione a Tuttoteatro<br />
* * *<br />
[…] In allusiva dialettica con la stabilizzata forma mentis della poesia come scrittura o codice autonomo, sono votati alla performance scenica i<br />
versi di Liliana Ugolini costantemente pervasi da una volontà di relazione sociale - di comunicazione o ‘conversazione’ - che li fa metamorfosare<br />
in commedia ludica, danzante teatro puparo, farsa surreale dai risvolti psicodrammatici.<br />
Vitalizzato da una mite quanto inalterabile ironia, il discorso dell’autrice vuole affermare le valenze primarie della phoné, cioè del ‘suono’ che,<br />
concretizzato in armoniche parole-azione, dà luogo al rito collettivo dell’evento teatrale. Un evento che rinnova la fiducia nella poesia come<br />
occasione d’incontro, esperienza ‘recitante’ o atto partecipativo; e vorrebbe riaffermare la primogenitura o il primato ‘storico’ dell’oralità sulla<br />
vincolante forma gutenberghiana.<br />
Trasposto dallo spazio ‘chiuso’ e tutto soggettivo della pagina scritta verso l’emozionale contesto pubblico, il copione poetico punta, in un<br />
crescente fluire sonoro, ad affrancarsi dal modulo tipografico-letterario e si apre, si dissemina e frammenta in una più vasta gamma di<br />
possibilità espressive.<br />
S’apre il sipario ed ecco - sul palcoscenico d’un teatro prima ‘da camera’ e dopo itinerante a tutto campo - la “marionetta”: un “pupo”<br />
pirandelliano che, a coprire il vuoto d’identità, indossa la ‘maschera’ della propria “anima burattina” talora errante per i luoghi ricchi di<br />
memorie d’una Firenze alfine fantasmatica e sognante. […]<br />
Stefano Lanuzza, “Edison Square”, 2008<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
188
Da Il Confessionale e l’Apostolato – (I luoghi, le signorine, le bambine), 2011<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
189<br />
L’Apostolato<br />
(La Via, il cancello, il leone di terracotta)<br />
I passi per la mano sono l’infinito<br />
d’una sola storia. È lo sgomento<br />
di scorgersi nei tempi col variato dell’iride<br />
l’intatto scorso lampo dell’attesa.<br />
Il ritrovarsi (parole rimaste nell’appiglio<br />
d’un tramite) del giungere all’Arrivo.<br />
Il perso chiudersi del ferro<br />
l’esempio del cautelarsi<br />
in occasione del campanello alla scoperta<br />
dell’aria a braccia aperte<br />
Di cotto stupito si scusa il leone<br />
impavido piglio e s’alloga il diritto<br />
d’esser ritratto in foto di Comunione.<br />
Sugli scalini impettito sul Giglio<br />
uno scompiglio di salti. Il cultore (del simbolo)<br />
è tutto un tremore che incute.<br />
Confessionale III<br />
Un peso enorme come quel respiro<br />
che non sale la colpa.<br />
Era lì fissata ai forellini della grata<br />
presente all’incauta condizione.<br />
S’abbandonava all’oltre<br />
che batteva sul volto sconosciuto<br />
fino all’ansia d’un dono.<br />
La formula fu detta in penitenza<br />
e tutto fu di nuovo sollevato nel legno.<br />
Restò sopra la grata un sangue che colava<br />
e le spine in eterno.<br />
Le finestre<br />
Passa il nuvoloso riprodursi a specchio<br />
il ceruleo colletto del sole rifrazione<br />
di tempo tintinnato. I vetri captano lo stupore<br />
il passaggio del sorriso, le corse.<br />
Lo svolgersi non copia le trasparenze sonore<br />
contiene lo strumento dell’ora (s’affacciano le storie)<br />
si chiude il riposo d’un suono d’ombra.<br />
Nel fremito - passaggio le bambine - le Signorine.<br />
Confessionale X<br />
Stava in disparte il confessionale<br />
con l’accesso accostato e la tendina aperta.<br />
La luce si colava intravedendo<br />
la possibilità. C’era un mistero antico<br />
e dentro al vuoto il recupero accedeva<br />
accendendo. Restava l’accostarsi<br />
al bisogno di dire e l’assillo dell’inizio<br />
fu sciogliere l’errore dei perché<br />
vivi nel fuori luogo. Umano lenire<br />
la speranza dell’oltre.<br />
L’enigma è<br />
nella ripetizione dell’insaturo<br />
in consapevolezze dominanti<br />
sulle mani giunte delle bambine.
Su Il Confessionale e l’Apostolato – (I luoghi, le signorine, le bambine)<br />
CONO D’OMBRA<br />
Le chiese, e si pensi in specie alle grandi cattedrali gotiche, sono in sostanza dei libri tridimensionali dove ogni spazio architettonico o<br />
elemento pittorico assume un valore di simbolo e si presenta come tassello di un sistema di segni che, decifrato, aiuta il fedele a porsi con<br />
maggior consapevolezza in rapporto con il Divino: ogni chiesa è dunque un libro nelle cui “pagine” è possibile fisicamente aggirarsi.<br />
Ora Liliana Ugolini si serve degli elementi di una chiesa (quasi edificandola pietra su pietra davanti ai nostri occhi) per dare avvio e in un certo<br />
senso inscrivervi questo suo nuovo libro di versi, delicato, pulito e profondo, che richiama fin dal titolo il lessico religioso, ma che (pur<br />
prendendo le mosse dagli spazi di una chiesa immaginaria) si allarga, come un cerchio nell’acqua, via via inglobando frammenti memoriali e<br />
atmosfere di più ampia e indeterminata contestualizzazione. La chiesa a un certo punto si apre, si scoperchia, per accogliere al suo interno una<br />
massa e una messe nebulosa di ricordi o altri frammenti di una quotidianità trasversale: “luoghi”, “signorine”, “bambine”.<br />
Il punto di partenza di questo cammino ramificato è una sorta di scatola nera, un ricettacolo di misteriosi e inquietanti colloqui la cui eco si<br />
replica nei secoli: il confessionale, che accoglie “vertici e parole” e diventa una sorta di minimo “Spoon River”, luogo dove si esplicita la<br />
denuncia dell’oscuro (“di strappi e stupri l’accaduto potente…”). Intorno a questo “cono d’ombra” si sedimenta un lessico legato agli arredi<br />
sacri, a iconografie cariche di mistero come paraventi, inginocchiatoi consunti, cripte, colonne… Ma la chiesa è anche altro: luogo di luce, di<br />
speranze, aperture. E, quasi a funzionare da interfaccia fra i due piani, un leone di terracotta è inciso nei versi nel momento in cui viene<br />
fotografato durante la cerimonia di una Prima Comunione…<br />
Così il testo è scandito da una sorta di controcanto, una zona esterna al cono d’ombra, e in parallelo sono evocati cancelli, altalene, orti,<br />
scavallate di bambini / grida di lucori”: forse ricordi infantili, sicuramente luoghi del cuore, nuclei polivalenti che fungono da trama per la messa<br />
in atto di un’idea di poesia che caratterizza l’intera produzione in versi di Liliana Ugolini, una produzione prolungata negli anni, ma coerente e<br />
lineare nel suo sviluppo, fondata com’è sull’idea che la poesia non è pensiero né assenza di pensiero, ma – come nota Franc Ducros nella<br />
citazione posta in esergo di questa raccolta – “intervallo o interstizio-vuoto (…) tra una cosa nominabile e la sua assenza, tra una cosa e un’altra,<br />
tra una cosa e nulla che si sappia o si possa dire”. Di qui le continue sfocature di senso che a folate attraversano le pagine, sorrette però da<br />
raffinate tramature sonore, ingegnosi accostamenti analogici, slittamenti di piani concettuali. Queste sfocature, tipiche della poesia della nostra<br />
autrice, nella presente raccolta richiamano tuttavia anche un altro livello dell’indeterminazione: l’incerto confine che separa il bene dal male e<br />
per questo il “confessionale” diventa un elemento ricorrente, una sorta di fisico refrain, “cono d’ombra” in opposizione all’“aria aperta” (e<br />
dunque anche all’Apostolato, luogo delle buone intenzioni): ne emerge così, con naturalezza ed efficacia, una rappresentazione della bipolarità<br />
in cui si trova sospesa la condizione umana.<br />
E qui, in questa complessa alternanza, davvero il suono si fa eco del senso, richiama a unità perdute sulle cui tracce, in azzardo, la lingua<br />
poetica di Liliana Ugolini si è messa da tempo in cammino con gli esiti di splendida evidenza che questa nuova raccolta documenta.<br />
Alfonso Lentini, dalla nota introduttiva a Il Confessionale e l’Apostolato – (I luoghi, le signorine, le bambine)<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
190<br />
187
Inediti<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
191<br />
DA REMBRANDT<br />
Da Rembrandt, dice la Szymborska<br />
sono usciti padre e madre.<br />
I miei da uno schizzo di Boldini.<br />
Figurine con tanto di cappello, zeppe alla moda<br />
in sobrietà, con gusto. Qualcosa<br />
che doveva assomigliare all’idea<br />
d’eleganze mentre bombe scotevano<br />
il rifugio. Fragili per un troppo<br />
in quinta fila, sommessamente in nervi<br />
stile al sghimbescio. Spersi al sorriso ovale<br />
storie di me che affaccio al tabernacolo<br />
icone incastonate nel mio lago.<br />
Un figurino con mazza ed occhialino<br />
in posa foto quando io non c’ero.<br />
Lungo l’abito avvinto, la veletta.<br />
Un gioco serio per non darla vinta<br />
alla durezza, al soglio dilavato in sorriso<br />
d’espressione. Care persone in piena<br />
d’un insolito vuoto.<br />
Occhi prima del fare che del fare fanno<br />
gioia d’iniziativa precedenza premura.<br />
Occhi chiusi che vedono oltre il mio marmo accanto.<br />
Bastava uno sguardo una parola tesa<br />
l’intesa brillava come squarcio.<br />
Ora è l’intatto piatto di convenevoli<br />
la mancanza.<br />
POESIE PER GILBERTO<br />
L’alito della candela<br />
non passava nel corpo.<br />
La luce nel taglio delle pieghe<br />
si spegneva e l’ombra bianca<br />
proiettava il fumo della cera.<br />
Fu pallore di legno<br />
e le mani le mani negli oggetti<br />
che volavano.<br />
Stupore e l’oltre è.<br />
Non basta il raso al vuoto<br />
né la cenere né la fiamma.<br />
né che l’alba s’alzi<br />
d’invisibili motivi<br />
C’è un abisso<br />
tra l’apparire statua<br />
ed il passaggio. Di qua<br />
solo l’involucro di là<br />
oltre la cenere<br />
un sentire di fronde<br />
dà la misura.<br />
Ritorna ai luoghi<br />
in veste nuova l’ombra<br />
e gli occhi gli occhi<br />
la voce l’argentino trillìo<br />
come il canto promesso<br />
mattutino<br />
d’ogni mattino alto più in alto.
Inediti<br />
Liliana<br />
Ugolini<br />
192<br />
LISISTRATA<br />
(Monologo)<br />
Trilla nel cardellino e l’usignolo<br />
l’ultimo canto mentre cova nell’uovo<br />
il passeggiar domani<br />
Nel mio nome Lisistrata (“colei che scioglie gli eserciti”)<br />
un destino…<br />
Voci,voci, nella città svuotata. Bisbigli e suoni<br />
fra l’erbe leggere dove i corpi non sono.<br />
Come un muro le trine, i nastri.<br />
Dietro solo un profumo e un’attesa vibrata.<br />
Imperanti gli ordini, al vento.<br />
Le alcove sbarrate e i colpi d’ariete non scalfiscono i veli.<br />
Noi, conduttrici del ciclo inseminato,<br />
abbiamo voce nella negazione.<br />
Un potere ripetibile<br />
(profumo di tigli, un battere di mare,<br />
fragilità d’un petalo)<br />
e irresistibile. Resta immensa<br />
la sospensione dal sesso, se vogliamo.<br />
Il cambiamento parte dal muro di gomma dei manichini<br />
e noi, a braccia protese,<br />
possiamo lamentare un canto di vittoria.<br />
Poi, conciliate, provare<br />
la negazione dei figli come scudo svuotato dalle generazioni<br />
ed essere artefici della forza inarrestabile d’un gene<br />
mentre vi resta un clone..<br />
Teneramente<br />
cede la ripetizione di noi<br />
ma quale forza immensa quel possibile!<br />
E l’avremmo, nel caso<br />
fossimo tutte insieme, contro ogni guerra!<br />
Di quei chicchi<br />
(pagine perdute in altro luogo)<br />
un plasmato binario e di perché<br />
una zavorra al collo<br />
o uno scudo<br />
dove vogliamo voce
Alfredo Malferrari. Cattedrali,<br />
serigrafia con ritocco manuale
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
193<br />
Avvenire<br />
firma di pubertà<br />
sotto rovine.<br />
(Nanni Cagnone)<br />
1.<br />
è qui l’altrove del rantolo di fame<br />
questo statuto che sa di Colosseo<br />
verso i cani bastardi, randagi quanto<br />
un dì del mese scorso. scorribanda<br />
di eclissi starti accanto io che ti amo<br />
oca di mamma guardarti nel passo.<br />
dove ti ammacchi io so che mi ami<br />
ugualmente lo stesso e senza ansia<br />
bambina darsena col cerchio senza avaria di salto.<br />
viadotto della cometa chiedere asilo<br />
ai quartieri proletari dove i tarli ammucchiano<br />
e le madonne scempiano. io spendo dio<br />
per dirti del canile abbandonato al dolo.<br />
i comatosi stanno zitti e i morenti urlano<br />
come mio padre erto sulla fronte ubriache le guance<br />
gli occhi spicchi di coltelli per la bramosia di pace<br />
2.<br />
adesso vorrei piangere un pochino<br />
sulle assurdità che scrivo per liberare<br />
la panchina che mi aspetta vecchia.<br />
stralunare l’ulivo in una reggia<br />
il cipresso in una lancia di voto<br />
per raggiungere la gerarchia del cielo.<br />
è invece limpido solo il sudario<br />
per le strofe che piangono poema<br />
dentro le giare dell’eclisse.<br />
un dolore d’orgoglio m’infetta tutta<br />
dalla mattina alla sera voglio il giglio<br />
di poter volare. la cenerentola del bavero<br />
è il mio ossigeno bacato dalla genia del no.<br />
3.<br />
tutti piangono da vicini di casa<br />
con la canicola sul collo della colpa<br />
per l’arrivo del gerarca ch sentenzia<br />
gerundio a tutto campo per le pene.<br />
in pace con lucertole già rincorse<br />
si salvano i bambini puritani<br />
innocenti senza rane nei barattoli.<br />
qui il plurale delle nebbie sono anime<br />
a capofitto linciate dagli stenti<br />
per rendere cicalate le vendemmie.<br />
tante le penne che non servono più a niente:<br />
scrivo al computer con voracità d’impotenza<br />
l’ebbrezza del servo che si senta libero<br />
solo perché la faccenda è multipla.<br />
4.<br />
in posizione fetale questo rattristarsi<br />
buio al fuoco della soluzione<br />
altrettanto lutto della stanga<br />
del passaggio a livello.<br />
in mano a Cristo ho letto la valanga<br />
della stazione ennesima risacca
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
194<br />
rimango immune al basto dell’estate<br />
calura tragica feto d’eclisse<br />
dove si sparge l’odissea di dio<br />
la cavezza rumina l’inferno.<br />
di te Celeste ricordo le caviglie<br />
la nullità furiosa dello zaino<br />
quando si tratta di trattare amore.<br />
paese triste il raggio della ronda<br />
quando si tratta di raccattare il fango<br />
la borraccia affoga nei buchi.<br />
in America si saltano i fossi<br />
per la bravura dell’atrio di casa.<br />
non credo alle preghiere di chiodi<br />
alle speranze che reggono le funi<br />
dove è malato l’apice del tutto.<br />
lungo la commedia del giorno mistico<br />
inventi il sapore della madia d’Ercole<br />
con le fandonie paniche del vero.<br />
in corda a Cristo immagino vergogna<br />
una ragione d’asma senza scrupoli<br />
né ventre di promessa la vecchiaia.<br />
5.<br />
cuore di fuga raggio di malessere<br />
questa bravata d’ansia che rincorre<br />
le cicatrici ataviche del giusto.<br />
in palio al gerundio di resistenza<br />
sta la parata d’ascia che vuole uccidere<br />
financo le gestanze del deserto.<br />
attrice di vendetta la cometa<br />
simula dio con la vestale accanto<br />
così per murare l’ossatura<br />
della finestra fiduciosa amante.<br />
in rotta con le genie delle bellezze<br />
si rompe il sangue che fraziona guerra<br />
la zona sempre apolide del senso.<br />
sì ho voglia di pulire il cielo<br />
dalla vaghezza tragica del verbo<br />
nella giunzione con l’altare fatuo.<br />
6.<br />
un giorno finisce il tragico s’inerpica<br />
nella palude sciatta del mio corpo.<br />
in realtà il tempo è un forsennato addio<br />
una credenza con le formiche e le briciole<br />
di quando c’era la spesa di una vita.<br />
oggi mi appoggio all’eremo del buio<br />
alla marina sirena delle regie del sale<br />
perché la pendola è ferma da un mare d’anni<br />
la noia piena di salute senza resistenze.<br />
si stenta invece verso la fenice d’alba<br />
questo abituro che assassina il futuro<br />
dentro le scosse di singhiozzi e ceppi.<br />
la terra è chiusa da sicari sicuri<br />
nessuna pietà ospita la lena<br />
di captare oasi la merenda infante.<br />
così clemente è l’ora di guardarti<br />
dentro la darsena della luna piena<br />
alambicco di cristallo il tuo respiro.<br />
piango assai quando qualunque impegno<br />
mi precipita nel legno della cassa<br />
appena morta forse. se ieri volli la regia del sasso
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
195<br />
oggi il canestro è il desiderio più lungo.<br />
7.<br />
nessun domani ignori se stesso<br />
è il passato il dubbio. la quarantena<br />
vizza del rondinino storpio<br />
dentro il nido piissimo delle cimase<br />
chissà qualora uno stridio benefattore.<br />
8.<br />
non farò caso alla malia del timbro vuoto<br />
la possibilità di essere chiunque<br />
lo stallo di un ergastolo<br />
la baraonda di un amante<br />
oggi mi basta il fischio della fionda<br />
la dura prova di chiudere a chiave<br />
le inferriate delle lanterne vizze.<br />
in coda all’alamaro della rotta<br />
perdo la spugna per asciugare il sangue<br />
acquisto le nomee di golfi senza attracco.<br />
9.<br />
la luna vuota sotto il sudario d’inganno<br />
quasi a trasalire per una stoppia in cortile<br />
dove si evince morte ben sicura<br />
e tagli all’avaria del disamore.<br />
questo si ritaglia dalla gaiezza del mare olimpico<br />
quando si staglia la penombra della giovinezza<br />
nell’equoreo barcone di guardarti<br />
tenue balbettio del tic di non averti.<br />
salutò la rima in riva al mare<br />
senza amorazzi di lutto per sopravvivere<br />
al cielo troppo alto da toccare.<br />
in calamità di genesi e verdetto<br />
offro la mira di guardare oltre<br />
almeno oltre la feritoia della rondine.<br />
appena assaggerò il sale ammesso<br />
sarà fatale dimorare il cerchio<br />
verso la falla della palla sgonfia.<br />
il simbolo del cerchio è la bravura<br />
della clausura libera la perfezione d’aria<br />
nonostante il ritorno del medesimo.<br />
alla marea di scarto voglio sottendere<br />
genialità la nuca del bambino<br />
che se ne va in apice di nido.<br />
10.<br />
ho visto un bell’albore quando da piccolo<br />
s’insinuava l’arringa della vita<br />
una vacanza con gli alamari aperti<br />
verso la gioia la corsa anti muraglia.<br />
in trono la lucertola immobile<br />
verso lo scavo di trovar pepite<br />
nel limitar di un’agenda vergine.<br />
oggi nella ciotola che m’imbeve amore<br />
racconto quale fu la mia mattanza<br />
la polvere del rantolo e l’eclisse.<br />
scampato sono stato un bambino d’epoca<br />
con la ciotola del riso e la mitraglia<br />
tra eremi di fanghi e ghiri di ricchi.<br />
calamite di mosche soqquadrano il mio corpo<br />
ora che avvengo da bambino offeso
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
196<br />
dentro la darsena che mi soffre madre.<br />
qui mi dannano una marea di lacrime<br />
nel crimine del fasto in cima ad altri<br />
continenti cattivi di ricchezza.<br />
11.<br />
il museo del giorno comune<br />
quando dal fatuo del rimedio<br />
si pinza la foto ad asciugare<br />
a ricordo d’eccezione<br />
svaghi mistici il sollecito dell’abaco.<br />
12.<br />
gli anni passano una radice nera<br />
una miniera di aghi<br />
una tempia suicida.<br />
uno straccio di rondini si rannicchia<br />
sotto cimasa in balìa del vento.<br />
una crudele soglia intasca il cuore<br />
nei valori del serpente che sibila<br />
perpetue le sentenze dell’occaso.<br />
13.<br />
un eremo m’infesta la salute<br />
mordo il crisantemo che mi sceglie<br />
con scaglie ridanciane per uccidermi<br />
contro la festa d’asilo di bambini<br />
felici illetterati. con il filo spinato per bracciale<br />
ingorgo la mia vita traumatica<br />
mentore il sangue che non mi vuole bene.<br />
tra treccine di braci vado a lungo<br />
lungo il fiume per salvarmi l’anima<br />
l’acqua migliore non saprà lavarmi<br />
dai chiodi stonati delle labbra.<br />
la lezione del vicolo se la ride<br />
di me da sempre intenzionata al lutto<br />
alla frode di strapparmi il cuore.<br />
invece di coriandoli lamento<br />
la lira che canzona la mia pace<br />
sotto il circuito di lavarmi il viso<br />
con il colera degli altri che sono tragici.<br />
sbatte la persiana sulla collina fatua<br />
vendetta che da anni si ripete<br />
appena giungono le rondini di pace.<br />
sono martirio e avanzo di me stessa<br />
la resina del miele che non sa sedurmi<br />
nel tramestio del mitico fantasma.<br />
la rendita del fianco è stata arresa<br />
dallo scontro illiberale della fune<br />
dal cipresso che mi aspetta sempre.<br />
14.<br />
scottature di calce questa manfrina<br />
che gioca con i verginei sassi<br />
a ribassare il suolo per far giocare<br />
i bambini. in bilico sul manuale d’ascia<br />
so imparare a fendere il palazzo<br />
sotto le membra che scaldano i papaveri<br />
do diluire un pugno da una carezza.<br />
la forza del messere signore assente<br />
comunichi col brano della preghiera<br />
dica se può magnificare la rendita
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
197<br />
dica se può magnificare la rendita<br />
della fortuna. con poche eclissi ci<br />
sarà riguardo verso lo scempio<br />
di perdere il viso.<br />
15.<br />
da tempo sta morendo la mia diaspora<br />
quel fannullone intrigo che mi perseguita<br />
in guisa di nullaggine giornata<br />
sotto il gingillo della luce pavida<br />
per un vernacolo d’inedia in far di spada.<br />
D’Annunzio rabbrividisce perché guerriero<br />
Pascoli mi ama perché usignolo<br />
Pasolini m’incoda nel dolore.<br />
la fame è sedata sugli scalini del metrò<br />
dove chi corre è un manipolo d’ascia<br />
un polo di preda per chi è vile<br />
e mozza la cometa della malinconia.<br />
un sudario di madonne l’idroscalo<br />
dove finì la madre Pasolini<br />
e la vergogna è un inguine di tram.<br />
l’ultima uccisa è una bambina bionda<br />
cipresso di se stessa per la felicità<br />
di nascere appresso ancora appresso<br />
una venia per la forca di rinascere.<br />
poi si vedrà chi ha cervello d’anima<br />
per accovacciare i morti resi bambini<br />
in un brevetto di chissà qual senso.<br />
16.<br />
in vaghe acque trascino ciò che avvisto<br />
la nomenclatura delle stelle blasfeme<br />
queste cicale orride ripetenti<br />
con le rovine dense di fanghiglia.<br />
io genero la viltà che mi troneggia<br />
da dietro lo zuccherino del sonnifero<br />
che mi dà la cheta del risparmio di luce.<br />
martirio di conchiglie il brecciolino<br />
quando si gioca a divorare l’antro<br />
con risultati blasfemi financo i miti.<br />
l’arringa della voce è dar di frottole<br />
sotto ponti che non reggono le volte<br />
né le cautele che si dicono bambinaie.<br />
17.<br />
ho finito col domare il mio panico<br />
a forza di bestemmie. in mano ad Alice<br />
non ho visto nessuna meraviglia. semmai<br />
la caviglia è sporca di fango a forza<br />
di cammino. in straccio alla diaspora<br />
la spora non porta fiore. vorrei<br />
piangere la foga della vergine<br />
quando quaggiù si giunge alla ventosa<br />
altalena e si smorza l’amore ben comunque<br />
futile. l’altalena l’andare fa conquiste<br />
con le nuvole. in mano alla filandra credo<br />
avvenga l’odissea del filo pagato<br />
dallo sguardo. Domodossola la città<br />
della villa di Contini. i grandi critici<br />
si contano in un abaco di coma. è
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
198<br />
finita la norma di credere al futuro<br />
è tutto una blasfemia di torri in esuli<br />
mattini. qui si accorcia la vita in una<br />
mattonella di morgue. il sasso occiduo<br />
non basta a giustificare la morte una nel<br />
simbolo del semaforo verde.<br />
qui l’acuta fandonia della stirpe<br />
solitudine cruenta sulle spalle.<br />
18.<br />
il fiabesco delle rondini si fa cicatrice<br />
crepa di scompiglio panico.<br />
il fiasco della cimasa scompiglia<br />
verdetto in masso d’uccisione.<br />
me ne andrò con far di stagno<br />
sotto la nuca delle epoche.<br />
mansione d’epitaffio la coda delle balene<br />
quando la targa è gomito di schiaffo<br />
sotto le genti delle rime stanche.<br />
per la bambina che gioca con la brina<br />
la faccenduola del sale da scappare<br />
per felicità una doglia da scassare.<br />
19.<br />
nulla sarà questo vanto acerbo<br />
questo dispaccio d’era in fondo al mare<br />
si andò così che la vita tacque<br />
per l’elemosina di copiare il sole.<br />
nessun patema ingaggi l’anfiteatro<br />
ma resistenza al quanto nonostante<br />
sia di panico l’orizzonte e l’afa.<br />
così in silenzio la genia dell’uomo<br />
per la condanna di servire zolle<br />
nomee di ieri che uccisero le vette.<br />
20.<br />
a ridosso del muro la farfalla<br />
non esce più. gli angeli dell’afflato stanno inerti<br />
verso le tattiche di perdere la vita<br />
nei gironi del plasma. immune solo resta<br />
un cancelletto di siepe che Leopardi<br />
prescrisse da maestro e fanciullo sommo.<br />
in mano alla maestria del sillabario<br />
nessuno è randagio ma domestico colto<br />
dai vespri di capire la crisalide<br />
che si ostina nel fantasma di farsi.<br />
con il periglio di perdere staffetta<br />
questa lunatica fiamma di sterpaglie<br />
impigliate all’addendo di capire<br />
perché giammai la fionda è così perfida<br />
da uccidere uccellini da nido o appena evasi.<br />
i cercatori nella mondezza hanno uncini<br />
da far paura a chiunque si avvicini.<br />
chissà che tempo intralcia il mio destino<br />
sorpassato da eventi di costrutto<br />
esule comunque nella pigrizia.<br />
già tomba la nenia di capire<br />
perché così sia valso il mio destino<br />
stinco di atleta anima di grinze.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
199<br />
21.<br />
il museo del perdere impenna le maree<br />
così è tenuto all’ipogeo il tuo nome<br />
quaresima la finestra che non si apre.<br />
parente momentaneo starti a guardare<br />
simulacro di resine il tuo gelo<br />
dovuto alla culla che fu picchiata.<br />
finì la pena e il rischio della ruggine<br />
da quando da ieri ci sfiorò la giara<br />
colma di salsedine benigna.<br />
la grondaia della rondine fu affezionata<br />
al mio quadretto lugubre. come si fa a<br />
morire ogni attimo senza il quartiere<br />
del breve velo. ogni contuso anemone<br />
marino sfiorò lo squalo senza esplodere<br />
la moina dolcissima corolla.<br />
22.<br />
mi piacerebbe perdere il detrito<br />
del mio dolore e invece un calcolatore<br />
implacabile mordicchia l’attrito<br />
nella carne. alterno ridanciane aquile<br />
con muschi teneri e licheni morbidi.<br />
la schiera delle bambole maschili<br />
non mi aiuta a sorridere, la paura<br />
mi stanzia regina tenebrosa abrasa<br />
stanza d’agonia. il velo che mi straccia<br />
l’esistenza è una bravata da ragazzi<br />
senza rimedio. discendo dal volgo al suolo<br />
solo per vivere senza dio o il permesso del santo.<br />
una birra rancida mi volteggia in gola<br />
dove l’alunno impara che la madre è mortale<br />
più del dubbio del tale padre. avvengo con<br />
le creme della plebe per fingere giovinezza<br />
o la farfalla vanessa che trovo al ciglio<br />
miracoloso nesso di amore per i divieti<br />
innumeri. funebri fiori con le corolle<br />
nobili attendono di essere buttati via. miliardi<br />
di spore non possono una vita.<br />
23.<br />
censore rauco perdere la vita<br />
immacolata concezione vieta.<br />
di te ho un’azzurra matricola di fango<br />
morta laddove vivesti<br />
brevetto di commiato già da piccola.<br />
goliardia del seno quando innamorata<br />
crollavi tra le braccia di un lui magnifico<br />
saluto alla cometa entrambi voi.<br />
la gioia che vociava cucciola<br />
tramortiva di sé una balena<br />
con l’apice dell’est che era l’anello<br />
non maturando per nessun agguato.<br />
moriste a distanza di un mese<br />
il crepacuore atavico degli amanti<br />
quando crepare è raggiungervi.<br />
ci voleva la cattiva stagione per strofinarvi<br />
i polsi.<br />
24.<br />
la poesia del solo incendio<br />
dove l’acropoli dell’anello crede in dio
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
200<br />
e simula nei popoli la bontà<br />
tumefatta sul collo di ruggine.<br />
questa quartina senza senso<br />
si aggira nei viali dell’occaso<br />
per simulare un agguato d’amore<br />
un rigurgito di pianto d’elemosina.<br />
aggiungo che così non c’è girandola<br />
per far impazzire il gatto,<br />
sotto controllo il razzo del vento<br />
la scimmiesca ilarità del sole.<br />
ieri ho avuto la perennità dell’acqua<br />
per lavarmi la faccia<br />
il cigolio del bavero contro il vento<br />
per godermi la frottola dell’indice.<br />
qui sommessamente l’altare è colmo<br />
di fiori per la messa esponenziale al cielo.<br />
25.<br />
l’agguato sulla fronte<br />
quando vederti è scialbo<br />
bosco di animule cortesi<br />
sillabario anche<br />
nel credulo alambicco della favola.<br />
dolo di sabbia il credo degli occhi<br />
quando s’impone la fugace via<br />
di perdere la vita. anemia del mare<br />
questa realtà zoppa restia all’audace<br />
celibe comunque con le nuvole.<br />
nel vuoto che troneggia ciuffi di cardi<br />
la malia è vedova di sé<br />
burattino d’elemosina soltanto.<br />
veste d’addobbo etnia del male<br />
questo crocicchio di rovi vilissimi<br />
dove la nenia ricompone l’alba<br />
flebile la luce d’ombra.<br />
baci del pane la liturgia del secolo<br />
dove si ammalia la regina d’arpe<br />
nella frenetica giuria del tempo.<br />
26.<br />
ho un figlio che mi accudisce il seno<br />
il senso atavico di perdermi comunque<br />
sotto la muta del cancello sempre<br />
provato di non aprirsi. il fato nudo<br />
della risacca comprime la funzione<br />
della nuca che è bambina ripetente.<br />
dove si oscura il fato del mio fato<br />
sono in credito di vita. muore il mio<br />
costato cristologico. l’addobbo<br />
dell’ultimo faro fa il mio natale<br />
buio povero. le eresie labiali della mente<br />
mandano a monte la speranza. il dubbio<br />
mercificato come sabbia sale allo<br />
sguardo. il medico di turno permetta<br />
l’addio e la forbice non faccia più<br />
paura.<br />
27.<br />
nell’oasi che frantuma il dettato<br />
sono partigiana. gioisco con il sì<br />
della farfalla. le baraccopoli dell’ombra<br />
attivano le coccole del vano.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
201<br />
in vena di cantuccio e molta nenia<br />
le sillabe che fioccano la cantica<br />
per dire le bravure del vulcano.<br />
in casa della sciabola retratta<br />
sta l’erba voglio si fa prendere da tutti<br />
i giocolieri intrisi di vaghezza.<br />
meringa la sorpresa della gioia<br />
quando t’inchini all’impresa della gara<br />
nell’ultima finestretta della torre.<br />
28.<br />
certi abusi stringono le ossa<br />
verso il sudario degli asfodeli<br />
le unghie intrise solo di vecchiume<br />
verso la zattera del malcontento.<br />
in verità vorrò stringere baracca<br />
con l’unguento di dio il più bonario<br />
così da ergermi felice. sono un rattoppo<br />
con rischio di guasto appena la miniera<br />
delle povere cose urta il mio gomito.<br />
meringa del diaframma poter respirare<br />
bene. culla di perigli l’andatura del pupo<br />
che gioca a ballare. in tutta la sfinge<br />
che riparte il mio zero sono elemosina<br />
moria comunque uno stridio di crepe.<br />
29.<br />
con un dolore in petto vado contromarcia<br />
ricordo la città che fu lasciata<br />
al pingue disprezzo del gioco dei dadi.<br />
mi lamento dei baci che non ebbi<br />
tra aciduli denti di mostruosi cannibali<br />
il baule pronto di mia madre per l’ospedale.<br />
tra dividendi e addendi ho perso la gioia<br />
di consacrare i vent’anni quando fui<br />
figliastra di ciotole piene.<br />
oggi le gite le fanno i camionisti<br />
con la malinconia nei muscoli<br />
l’acerbo gioco di scalare curve.<br />
nemmeno un’astronave potrà il mio arbitrio<br />
docile feticcio, pupazzo per le perle che non<br />
consolano. in un casolare di lana amai<br />
il mio albore fatto di madre ragazza.<br />
invece adesso sono una stima di misteri<br />
di tabule rase lungo il sodalizio<br />
in assenza di angeli. ora purtroppo<br />
la strada si rimorchia in un bagliore<br />
di sterpi. in un buio di caligine<br />
voglio guardarti albino gemello della luna.<br />
30.<br />
come si sta a rincuorare il presente<br />
con la noia che giunge dovunque<br />
e fa da crisantemo all’ore<br />
alle perlustrazioni del maniaco.<br />
qui c’è il lago che annoia chiunque<br />
questo smarrimento d’acque<br />
il talismano inutile al verbo<br />
la sfortuna che non si tarla giammai.<br />
nessuno chiamerà l’orto della musa<br />
questo tristissimo campiello di Venezia<br />
dove si azzera il vero in uno zigomo di sale.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
202<br />
qui è bello sparire nelle stelle<br />
nelle gimcane che crepano le madri<br />
estranee finalmente al far di vita.<br />
ho buttato i soldi per eresia di vita<br />
una calura che mi stemma il sonno<br />
dentro le braci degli alunni vinti.<br />
31.<br />
Madre, eccelso caso<br />
di perdita, madre d’occaso<br />
del romanzo spento dove s’incontrano<br />
la litania del verbo e la bisaccia del santo.<br />
i venti vanno a zonzo per ipocriti<br />
velieri dove la fata è stata decapitata<br />
e i mozzi sono gli assassini di creature<br />
senza nidi di vespe. dove lo scalpello<br />
del marmo è solo vuoto indice<br />
esonero di statua. il profugo del vento<br />
è un ragazzone alato ma non per<br />
questo felice. le dimore del sudario<br />
accessi per appieno morire<br />
dopo la resina del sangue che trattiene.<br />
dizionario d’età stare smunte<br />
agavi di sensi dolorosi. hai la voce<br />
mortale di chi muore già zitta<br />
stanti le cilecche delle parole.<br />
Madre assoluta veglia del mio vivere<br />
torna da me nel lutto la mia mamma<br />
regina favolistica chissà.<br />
32.<br />
un giorno passerò a dirti addio<br />
sotto il plagio delle forze<br />
la foga oscura del pagliaccio vuoto.<br />
dal gorgo della notte che m’impaura<br />
guardo le stoffe degl’indovinelli<br />
le villanie a segugio del mio angelo.<br />
latrano i cani le infamie del dì<br />
quando schiantati lungo i binari<br />
chissà se finiscono il tunnel.<br />
sotto scacco i bastoni dei vecchi<br />
hanno il patema delle lettighe<br />
le mani smunte di chiunque siano.<br />
sotto le ore di guardarti attorno<br />
sprechi la vita di non darti<br />
né al redentore né al solitario.<br />
attori desti comandano salite<br />
verso le giostre delle cornucopie<br />
che invitano giovinezze le defunte<br />
furenti di tetano le morte.<br />
oggi mi attesto in un convento di cicale<br />
dove l’avvento delle belle storie<br />
l’allegrezza del vento mi romanza<br />
per domenica l’ammanco di letizia.<br />
33.<br />
qui ti fa gola il sillabario smunto<br />
questo canuto antefatto del dado<br />
quando lo tiri in aria soffia il numero<br />
del tirassegno bieco. in meno di una nascita<br />
ti volgi zitto pavone che non sa insegnare
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
203<br />
la bella aureola di starsene guardato<br />
da tutti gli astanti torno torno.<br />
in mano alla domenica è strafare<br />
finissimo ricamo di nonna analfabeta<br />
dove non ride il gelo di cometa.<br />
tu non piangi che fegati di cimasa<br />
lassù le case eruttano bontà<br />
per le rondini che girano in pericolo<br />
di botto. così il paese è un sudario<br />
smilzo. sotto il sudario che trabocca<br />
libri per scarafaggi. ormai la casa di Pascoli<br />
predice solo tarli. la tesi di Pasolini è andata<br />
dispersa. così l’alunno spaccato dalle ruote<br />
del cimelio di esistere la morte.<br />
34.<br />
una vita difficile sul letto di morte<br />
quando si abbevera la resina del sale<br />
e le scialuppe non servono a nessuno.<br />
di te ho visto l’acre cerimonia<br />
il lutto acerbo di morire all’alba<br />
quando le bare non chiudono bene.<br />
il brio della rondine continua naturale<br />
nessuno impiglia le vocali in cardi<br />
nessuna consonante sembra vagare.<br />
qui di te io volsi l’aneddoto<br />
così per imparare la castagna glabra<br />
quando nessuno più rosicchia il muro.<br />
le lentiggini che giocano le guance<br />
ammettono ginestre di prestigio<br />
verso i natali delle siepi ginniche.<br />
qui mi manca la canzone per defraudare<br />
la darsena banchiera. vado al mare per morir<br />
di gigli delle dune dove la gente è più<br />
vagamente cattiva e calpesta. questo lutto<br />
che trabocca un airone impazzito sa di<br />
petrolio che impazza sicumere multinazionali.<br />
35.<br />
pietà del sole alto quando si allaga la via<br />
tutto sembra un addio agli occhi<br />
che cresima bestemmia per rivolta.<br />
amor gentile dammi un attimo di tregua<br />
dove si spoglia l’eresia del bacio<br />
con la gestione in apice di perdita.<br />
in bocca alla rimonta della luce<br />
si parla di cicogne ancora attive<br />
buone davvero per lucciole congenite.<br />
in urlo al viottolo del sale<br />
sale la rena con i gigli di sabbia<br />
la bambinaia che accudisce l’eco<br />
delle conchiglie. nei cassetti delle donne<br />
si parla di vendette contro la libertà negata<br />
perché la truffa di starsene a casa<br />
ancora pende sulle spalle vive.<br />
verrà l’occaso che tutto accaserà<br />
nei loculi di sfinge. in mano all’ottica<br />
del sale il giardino dei ricordi si trafela<br />
verso un cipresso padre di coccarda.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Soqquadri<br />
del pane<br />
Vieto<br />
di<br />
Marina Pizzi<br />
204<br />
36.<br />
maretta e contumacia questa estasi<br />
stato di cose in parco di consiglio.<br />
percorso calunnioso lutto vivo<br />
soccorso immenso senza apice.<br />
nell’ammanco che dà croce questa furia<br />
di dolore al sempre, sempre presente<br />
quanto un ammasso di doglie senza figlio<br />
o lusinga di luce voce di conchiglia.<br />
resta atavico il mosto dell’aceto<br />
nulla disseta. quale un anello spezzato<br />
nella carne moribonda. la porta tombale<br />
si umanizza ancora d’àncora. qui il gemellaggio<br />
col tuono non basta a vagheggiare quiete.<br />
voglio staccare la catena del sudario<br />
dalla linguaccia dei mostri accanto<br />
questo stradario senza nomi di vie.<br />
mira di fosso lo stato del rito<br />
intonacato d’arpe per pulsazioni d’altro.<br />
*…+<br />
Marina Pizzi è nata a Roma, dove vive, nel 1955.<br />
Ha pubblicato i libri di versi: Il giornale dell’esule (Milano, Crocetti, 1986), Gli angioli patrioti (Milano, Crocetti, 1988), Acquerugiole (Milano,<br />
Crocetti, 1990), Darsene il respiro (Milano, Fondazione Corrente, 1993), La devozione di stare (Verona, Anterem, 1994), Le arsure (Faloppio,<br />
CO, Lieto Colle, 2004), L’acciuga della sera i fuochi della tara (Lecce, Luca Pensa, 2006), Dallo stesso altrove (Roma, La camera verde, 2008),<br />
L’inchino del predone (Piacenza, Blu di Prussia, 2009), Il solicello del basto (Roma, Fermenti, 2010).<br />
Ha inoltre dato alle stampe le plaquettes L'impresario reo (Tam Tam 1985), Un cartone per la notte (edizione fuori commercio a cura di Fabrizio<br />
Mugnaini, 1998) e Le giostre del delta (foglio fuori commercio a cura di Elio Grasso nella collezione “Sagittario” 2004).<br />
Sue poesie sono state tradotte in Persiano, in Inglese e in Tedesco.<br />
Numerosi e-book e collaborazioni si possono leggere on line. Ha vinto tre premi di poesia.<br />
Sul web cura i seguenti blog di poesia: “Sconforti di consorte”, “Brindisi e cipressi” e “Sorprese del pane nero”.<br />
È membro del comitato di redazione della rivista “Poesia”.
Giordano Perelli. per S. T., acquaforte/fotoresist.
Collage Charles Baudelaire<br />
205<br />
Spleen<br />
Quando il cielo basso e greve pesa come un coperchio<br />
sullo spirito che geme in preda a lunghi affanni,<br />
e versa, abbracciando l'intero giro dell'orizzonte,<br />
una luce diurna più triste della notte;<br />
quando la terra è trasformata in umida prigione<br />
dove, come un pipistrello, la Speranza<br />
sbatte contro i muri con la sua timida ala<br />
picchiando la testa sui soffitti marcescenti;<br />
Spleen<br />
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle<br />
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,<br />
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle<br />
II nous verse un jour noir plus triste que les nuits;<br />
Quand la terre est changée en un cachot humide,<br />
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,<br />
S'en va battant les murs de son aile timide<br />
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;<br />
quando la pioggia, distendendo le sue immense strisce,<br />
imita le sbarre d'un grande carcere,<br />
e un popolo muto d'infami ragni<br />
tende le sue reti in fondo ai nostri cervelli,<br />
improvvisamente delle campane sbattono con furia<br />
e lanciano verso il cielo un urlo orrendo,<br />
simili a spiriti vaganti, senza patria,<br />
che si mettono a gemere, ostinati.<br />
- E lunghi trasporti funebri, senza tamburi né bande,<br />
sfilano lentamente nella mia anima, vinta;<br />
la Speranza, piange, e l'atroce Angoscia, dispotica,<br />
pianta sul mio cranio dilaniato chinato il suo nero vessillo.<br />
trad. di A. Bertolucci<br />
Quand la pluie étalant ses immenses traînées<br />
D'une vaste prison imite les barreaux,<br />
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées<br />
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,<br />
Des cloches tout à coup sautent avec furie<br />
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,<br />
Ainsi que des esprits errants et sans patrie<br />
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.<br />
— Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,<br />
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,<br />
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,<br />
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
ARCIPELAGO itaca prima apparizione. Giovanni Commare su Gianfranco Ciabatti, Adriàn Bravi, Maria Lenti, Nicola Romano e<br />
Norma Stramucci. Collage Dino Campana. Riproduzioni di opere di Giorgio Bertelli e Lorenza Alba.<br />
ARCIPELAGO itaca seconda apparizione. Danilo Mandolini su Attilio Zanichelli, Lucetta Frisa, Ivano Mugnaini, Adelelmo<br />
Ruggieri e Luigi Socci. Collage Guido Gozzano. Riproduzioni di immagini di Michele Rogani e di un’opera di Pietro Spica.<br />
ARCIPELAGO itaca terza apparizione. Contributi da interventi di Maria Lenti e Gianfranco Lauretano su Tolmino Baldassari,<br />
Danilo Mandolini su Renata Morresi, Maria Grazia Calandrone, Mauro Ferrari, Daniele Garbuglia, Massimo Morasso e Enzo<br />
Filosa. Collage Vladimir Majakovskij. Riproduzioni di opere di Silvana Russo e Lucia Marcucci.<br />
ARCIPELAGO itaca quarta apparizione. Un ricordo di <strong>Leonardo</strong> <strong>Mancino</strong>, Danilo Mandolini su Anna Elisa De Gregorio, Gianni<br />
Caccia, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, Liliana Ugolini e Marina Pizzi. Collage Charles Baudelaire. Riproduzioni di opere di<br />
Enzo Esposito, Giovanna Ugolini, Cosimo Budetta, Alfredo Malferrari e Giordano Perelli.<br />
Per effettuare il download delle ultime tre apparizioni di ARCIPELAGO itaca: www.arcipelagoitaca.it/download.<br />
Per ricevere, a ½ e-mail, tutte le apparizioni di ARCIPELAGO itaca, inoltrare relativa richiesta a info@arcipelagoitaca.it o<br />
arcipelagoitaca@libero.it.
Quando ti metterai in viaggio per <strong>Itaca</strong><br />
devi augurarti che la strada sia lunga<br />
fertile in avventure e in esperienze.<br />
Costantino Kavafis, <strong>Itaca</strong>
La piccola immagine in basso a destra nella seconda di copertina e in alto a sinistra nella terza di copertina raffigura la<br />
sagoma dell’isola di <strong>Itaca</strong>.<br />
Le note di Giovanni Giudice (70) e di Mauro Ferrari [Paradossi della giustizia (e della vita): La stadera di Gianni Caccia<br />
(86-88)] su Gianni Caccia e di Luciano Benini Sforza [La vita, le cose e il divenire. Spunti e riflessioni per una lettura<br />
(120)] su Massimo Gezzi sono, fino ad oggi, rimaste inedite.<br />
Caccia<br />
Ugolini<br />
Pizzi <strong>Mancino</strong><br />
Mandolini Gezzi<br />
De Gregorio<br />
Mancinelli<br />
ARCIPELAGO itaca: Danilo Mandolini – Via Mons. D. Brizi, 4 – 60027 Osimo (AN).<br />
www.arcipelagoitaca.it<br />
info@arcipelagoitaca.it; arcipelagoitaca@libero.it