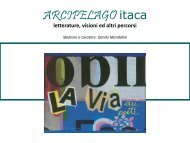Arcipelago Itaca 7
Arcipelago Itaca 7
Arcipelago Itaca 7
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARCIPELAGO itaca<br />
letterature, visioni ed altri percorsi<br />
ideatore e curatore: Danilo Mandolini<br />
Inserire disegno di Luigi Bartolini
[…]<br />
Ma ei non brama che veder dai tetti<br />
sbalzar della sua dolce <strong>Itaca</strong> il fumo,<br />
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi.<br />
Omero, Odissea - Libro I<br />
AVVERTENZA.<br />
ARCIPELAGO itaca è un’iniziativa realizzata senza fini di lucro, resa disponibile nel solo formato digitale e distribuita gratuitamente, via e-mail e tramite<br />
internet (www.arcipelagoitaca.it), a circa 800 tra associazioni ed operatori culturali, riviste di letteratura e non, critici, scrittori ed estimatori.<br />
ARCIPELAGO itaca non è da considerarsi una testata giornalistica in quanto non ha periodicità e non può pertanto essere ritenuta un prodotto<br />
editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001.<br />
Testi ed immagini contenuti in ARCIPELAGO itaca sono riprodotti, quando possibile e per lo più, previo espresso consenso dei relativi autori (sono<br />
sempre e in ogni caso citati gli autori e/o le fonti di reperimento).<br />
ARCIPELAGO itaca è un marchio registrato.
Le riproduzioni di dieci immagini fotografiche di<br />
Mario Giacomelli<br />
commentano questa settima apparizione di ARCIPELAGO itaca.<br />
In copertina: da La buona terra di Mario Giacomelli -<br />
Fotografie realizzate tra il 1964 e il 1966 nella campagna marchigiana<br />
L’ordine di presentazione degli autori di VOCI - eccezion fatta per le rubriche VETRINA,<br />
che è in apertura, e SOLO INEDITI, che è in chiusura - è alfabetico.<br />
Echi<br />
Un ricordo di Giovanni Giudici<br />
Brani da una nota commemorativa di Goffredo Fofi<br />
Testi da La vita in versi<br />
e Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
Voci<br />
VETRINA<br />
Il talento della malattia di Alessandro Moscè<br />
con una nota di Danilo Mandolini<br />
Marco Ercolani<br />
Fabio Franzin<br />
Mariangela Guàtteri<br />
Annalisa Teodorani<br />
SOLO INEDITI<br />
Da Tutto il tempo di Giovanni Commare<br />
Collage William Butler Yeats<br />
1 - 26<br />
27 - 36<br />
37 - 80<br />
81 - 120<br />
121 - 156<br />
157 - 181<br />
182 - 191<br />
192<br />
Echi<br />
Settima apparizione<br />
Un ricordo di Giovanni Giudici<br />
Brani da una nota commemorativa di Goffredo Fofi<br />
Testi da La vita in versi<br />
e Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
Voci<br />
VETRINA<br />
Il talento della malattia di Alessandro Moscè<br />
con una nota di Danilo Mandolini<br />
Marco Ercolani<br />
Fabio Franzin<br />
Mariangela Guàtteri<br />
Annalisa Teodorani<br />
SOLO INEDITI<br />
Da Tutto il tempo di Giovanni Commare<br />
Collage William Butler Yeats
www.mariogiacomelli.it<br />
Qui dove vivo, ad Osimo, c’era (forse c’è ancora) un circolo fotografico intitolato a Mario Giacomelli.<br />
Appena adolescente, mentre mi divertivo a scattare foto e a stamparle nella camera oscura della scuola, ebbi modo di conoscere la sua arte.<br />
Una piccola mostra a lui dedicata ed alcune sue foto esposte nella bacheca del suddetto circolo mi portarono a nutrire una forte curiosità<br />
verso l’opera di questo conterraneo. Lo scoprii così straordinariamente capace di scorgere ed “inchiodare” ogni minimo, indecifrabile<br />
(doloroso o felice) anelito del vivere nell’intervallo risibile di uno scatto, già molto conosciuto nel mondo e, inoltre, appassionato di poesia<br />
(lui stesso aveva scritto versi; il suo fotografare traeva spesso ispirazione dalle poesie che leggeva<br />
e diverse delle serie di immagini da lui realizzate e composte hanno il titolo di testi poetici più meno noti o riferimenti espliciti a questi stessi).<br />
Nel febbraio del 1997 mi ritrovai - insieme ad altri, trai quali anche Simone Giacomelli, figlio di Mario - a leggere dei miei versi<br />
nell’ambito di una rassegna intitolata C’è vita su marte. Eravamo a Senigallia, al Centro Sociale Molinello 2 e tra il pubblico,<br />
- lo riconobbi subito, con la sua folta capigliatura bianchissima - c’era anche lui: Mario Giacomelli. Al termine della serata mi avvicinai.<br />
Mi disse che gli era piaciuto ciò che aveva ascoltato. Ci stringemmo la mano e ci scambiammo un sorriso. Non fui capace di altro.<br />
Nel dicembre del 2000 venni a sapere della sua scomparsa. Nel corso del 2001 mi persi, letteralmente, nelle varie esposizioni<br />
della retrospettiva completa della sua opera che diversi comuni marchigiani avevano organizzato a pochi mesi dalla morte.<br />
«Io non credo che la morte chiuda certe storie, perché, se c'è tanto di strano in questi occhi che vedono e in queste orecchie che sentono,<br />
vi è posto per altre cose strane che non capisco.». È così, caro Mario; è proprio così come hai, semplicemente, affermato tu.<br />
Grazie a Simone Giacomelli per aver autorizzato l’utilizzo delle immagini e consentito, quindi, la realizzazione di questo piccolo tributo.<br />
Danilo Mandolini<br />
Mario Giacomelli<br />
Mario Giacomelli<br />
www.mariogiacomelli.it
Nasce a Senigallia (Ancona) nel 1925. È il maggiore di tre fratelli e all’età di 9 anni perde il padre. In<br />
questo periodo comincia a dipingere e a scrivere poesie. La madre trova lavoro come lavandaia<br />
presso il locale ospizio. Qualche anno più tardi, nel 1954, ritornerà in quel luogo e realizzerà le<br />
immagini della serie Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, titolo ripreso da Cesare Pavese. Avrà modo di<br />
dire in seguito che tra tutte le immagini da lui prodotte, quelle dell’ospizio di Senigallia gli hanno<br />
procurato le più grandi emozioni.<br />
La prematura perdita del padre lo costringe ad iniziare presto a lavorare come garzone in una<br />
tipografia di cui diventerà poi proprietario. Il tempo della scuola viene sovente impegnato in<br />
tipografia, la magia della stampa lo cattura e a tredici anni decide di fare il tipografo.<br />
La Tipografia Marchigiana affacciata sulla piazza che, nel centro di Senigallia, celebra con un<br />
monumento Papa Mastai Ferretti (Pio IX), ha cessato le sue attività soltanto nel dicembre del 1999.<br />
Il 1953 segna la svolta nella sua vita. Acquista infatti, per 800 lire, una macchina fotografica e il<br />
giorno<br />
giorno di Natale si reca sulla spiaggia. È solo di fronte al mare, scatta e muovendo la macchina ottiene la sua prima fotografia:<br />
L’approdo, un’immagine della battigia carezzata da un’onda come con un colpo di pennello.<br />
Vicino alla tipografia abita una persona che tanto peso ha avuto nell’inserimento delle Marche nel dibattito che, a livello<br />
nazionale e in quegli anni, si stava sviluppando attorno all’arte fotografica. Quest’uomo è Giuseppe Cavalli. Avvocato, uomo di<br />
lettere, profondo conoscitore di Croce, ma anche esperto di tecnica e storia della fotografia, fondatore nel 1947 con Leiss,<br />
Finazzi, Vender e Veronesi de “La Bussola”: storico circolo le cui idee crociane furono espresse nel Manifesto pubblicato da<br />
“Ferrania” nel maggio del 1947. Dopo alcuni anni il successo iniziale riscosso da “La Bussola” comincia a venir offuscato dal<br />
progressivo affermarsi di un altro gruppo storico, “La Gondola”, guidato da Paolo Monti e alle cui immagini molti giovani si<br />
avvicinano, colpiti dal grande vigore espressivo di queste. È forse proprio per contrastare l’ascesa de “La Gondola” che, nel<br />
1953, Giuseppe Cavalli fonda, proprio a Senigallia, il gruppo “Misa”, di cui Giacomelli e Piergiorgio Branzi rappresentano le<br />
“giovani speranze”. Nel “Misa” non si ravvisa la presenza egemone delle idee di Cavalli come ne “La Bussola”; si tratta, piuttosto,<br />
di un gruppo aperto dove ognuno è libero di condurre le ricerche che vuole; sono così inevitabili gli scontri, soprattutto tra<br />
Giacomelli e Cavalli stesso. Nel corso delle discussioni all’interno del “Misa”, Giacomelli conosce le opere di Paolo Monti,<br />
apprezzandole al punto di arrivare a dichiarare «Cavalli diceva che era il nemico pubblico numero uno, ma a me Monti faceva<br />
morire!». Sarà proprio Paolo Monti (in giuria con Roiter e Comisso, tra gli altri) a dargli la soddisfazione del premio al miglior<br />
complesso di opere al Concorso di Castelfranco Veneto nel 1955. «Apparizione è la parola più propria alla nostra gioia ed<br />
emozione, perché la presenza di queste immagini ci convinse che un nuovo e grande fotografo era nato» avrà modo di<br />
affermare in seguito lo stesso Monti.<br />
Del 1957-59 è la serie di immagini riprese a Scanno (acquisite dal MoMA di New York nel 1963) e che hanno, come titolo, il<br />
nome dello stesso paese. Giacomelli rimane affascinato dall’atmosfera fiabesca del luogo che aveva già colpito altri grandi<br />
fotografi,
fotografi, tra cui Henri Cartier Bresson. Sempre del 1957 è la serie Lourdes seguita, nel 1958, da Zingari, Puglia e, nel 1959<br />
(ripresa poi nel 1995), Loreto. Del 1960 sono le immagini di Mattatoio e l’anno successivo inizia a lavorare alla serie Io non ho<br />
mani che mi accarezzino il volto, titolo mutuato da uno scritto di David Maria Turoldo. Le immagini sono riprese nel Seminario<br />
Vescovile di Senigallia, che Giacomelli frequenta per un anno prima di dar forma alle foto vere e proprie. In questo ambiente i<br />
giovani seminaristi sono ripresi in momenti di ricreazione, le foto restituiscono l’incanto di uno spazio umano, ma al tempo<br />
stesso sospeso in una sorta di astrazione temporale.<br />
Nel 1963 inizia la grande stagione di mostre che porteranno le sue immagini nei più grandi spazi espositivi del mondo, dalla<br />
Photokina di Colonia (nello stesso anno) al MoMA di New York (nel 1964), dal Metropolitan, sempre di New York (nel 1967), alla<br />
Bibliothèque Nationale di Parigi (nel 1972), dal Victoria & Albert Museum di Londra (nel 1975) al Visual Studies Workshop di<br />
Rochester (nel 1979) e poi Venezia, Providence, Parma, ancora New York, di nuovo Colonia, Mosca, Arles, Amsterdam, Tolosa,<br />
Bologna, Londra, Rivoli e fino alle più recenti antologiche di Empoli, Losanna e Roma (postuma).<br />
La serie La buona terra risale agli anni 1964-66. Questa è seguita da Caroline Branson (1971-73), lavoro ispirato all’Antologia di<br />
Spoon River di Edgar Lee Masters.<br />
Su testi del poeta Permunian si fonda Il Teatro della neve (1984-86, che recupera anche scatti ben più datati), seguita da Ninna<br />
Nanna e A Silvia, lavoro - quest’ultimo - pensato in origine per un programma televisivo. Nel 1986 muore la madre, alla quale<br />
aveva dedicato, nel 1955, un intenso ritratto. A Presa di coscienza sulla natura, la grande serie di paesaggi realizzata nelle<br />
campagne marchigiane, lavora parallelamente, dal 1954 al 2000, a tutte le altre opere.<br />
Tra i molti lavori degli ultimi anni si ricordano: Io sono nessuno (1992-94), su testi di Emily Dickinson, La notte lava la mente<br />
(1994-95), Questo ricordo lo vorrei raccontare (1999-2000) e Bando (1997-99), ciclo di immagini in serie di quattro, ispirate ad<br />
una poesia di Sergio Corazzini e presentato nel 1999 alla XXIV Biennale d’Arte contemporanea di Alatri.<br />
Il 25 novembre 2000, all’età di 75 anni, si spegne nella sua casa di Senigallia.<br />
«L'immagine è spirito, materia, tempo, spazio, occasione per lo sguardo. Tracce che sono prove di noi<br />
stessi e il segno di una cultura che vive incessantemente i ritmi che reggono la memoria, la storia, le<br />
norme del sapere.»<br />
«…parlo di segni. Li potrei fare anche sulla carta, nel mare, ma sarebbero tutti voluti, quindi tutti falsi.<br />
A me interessano i segni che fa l'uomo senza saperlo… Solo allora hanno un significato per me,<br />
diventano emozione.<br />
In fondo fotografare è come scrivere: il paesaggio è pieno di segni, di simboli, di ferite, di cose<br />
nascoste. È un linguaggio sconosciuto che si comincia a leggere, a conoscere nel momento in cui si<br />
comincia ad amarlo, a fotografarlo. Così il segno viene a essere voce…»
«I giovani come Giacomelli, nutriti da uno stile asciutto e castigato, hanno inteso immediatamente la caducità, la<br />
friabilità, di questo orecchiato Neo-realismo (…) hanno voluto approfondire il loro linguaggio espressivo, allo scopo di<br />
esulare dal campo - così schematico e convenzionale - della realtà, per toccare quello della verità. Una verità loro, però,<br />
non imposta da mode, da maniere altrui (…) Giacomelli non è un formalista (…) Il fotografo di Senigallia ha uno stile, il<br />
che significa che ha un proprio linguaggio e dunque un messaggio da comunicare al pubblico. Tale messaggio è tutt'altro<br />
che sradicato dalla realtà, dalla verità umana. Si pensi al magnifico reportage Vita d'ospizio: il più crudo, il più lancinante<br />
messaggio di pietà che la nostra fotografia ci abbia mai dato. Si pensi ai suoi nudi, non edonistici, non decorativi, non<br />
estetizzanti a quella maniera paesana e volgare che tanto disprezziamo: nudi che entrano nel mistero e nell'angoscia del<br />
sesso e comunicano una verità universale, insopprimibile: quella della tristezza, della gioiosa tristezza della carne. Si<br />
pensi, infine, alla purezza delle sue nature morte, al fulgido incanto dei suoi paesaggi. Questo è formalismo? Signori qui<br />
si vede male, anzi non si vede addirittura. Forse perché si è incapaci di cogliere la poesia di queste immagini. Poesia che<br />
esula anche dai confini - così tecnicistici, talora - della fotografia. Lo diceva (…) un collaboratore (…) su queste colonne:<br />
Giacomelli è un "caso" che poco ha da spartire con la fotografia. Un autore che penetra nel campo dell'espressione<br />
artistica, diremmo, in piena regola, con uno stile suo, inconfondibile, lirico (…) Giacomelli ha la stoffa del fotografo<br />
classico; il documento è trascurato per assumere classico; poi un senso profondo, vastissimo. Egli è pure uno dei pochi fotografi che abbia qualcosa da esprimere e che<br />
l'esprima con sentimenti suoi, e con uno stile personale (…) ecco dunque un vero artista della fotografia, le cui immagini non invecchieranno e figureranno benissimo<br />
in un volume - ancora da scrivere, purtroppo - dell'espressione fotografica, in Italia e all'estero.».<br />
Giuseppe Turroni, "Photo Magazin“, per la mostra alla biblioteca comunale di Milano, 1959.<br />
* * *<br />
«Vita d'ospizio. Ecco senza dubbio il vertice dell'esposizione. Questo servizio su uno ospizio di vecchi mette in valore tutto il genio di Mario Giacomelli. È per mezzo<br />
della poesia che il fotografo ha scavato il muro della desolazione e della solitudine, è per mezzo della comunicazione e un filo di delirio che egli ha penetrato questi<br />
esseri strappati alla vita attiva, alle speranze, all'avvenire (… ) ed è per questo che occorre ricordare l'esposizione di Giacomelli, il realismo reinventato dagli italiani<br />
verso l'anno 1944, si è a poco a poco, trasformato, grazie a dei cineasti come Rossellini o Visconti e a certi fotografi, in una conquista del reale.».<br />
S. Manbel, “Giovane fotografia”, per la mostra allo studio 28 di Parigi, 1962.<br />
* * *<br />
«L'intervento del suo occhio, del suo occhio-obbiettivo, scompone tutte le pianificazioni dell'abitudine, procede ad una rilettura del reale rivelandone una insospettata<br />
pregnanza di sensi riposti (…) infinite possibilità di trasformazione che sono insite negli oggetti quando essi sono veramente "visti", cioè focalizzati come fenomeni<br />
puri, insieme di facoltà sensoriali, al di là del loro uso pragmatico, della loro capacità di orientare i nostri comportamenti (…) l'obbiettivo (…) non più strumento per<br />
restituire una realtà esatta, addomesticata per i nostri bisogni, ma strumento per "obbiettare" autenticamente la realtà, gettarla di fronte, distanziarla e riceverla<br />
come sensibilità assoluta. Proviamo a fare un piccolo inventario delle metamorfosi, attingendole a quel grande tema-chiave di Giacomelli che si potrebbe definire della<br />
"terra desolata": le righe tracciate dalle spighe di un campo di grano diventano fili di una strana sostanza lanosa; la terra diventa un’insospettata materia lavica,<br />
pumicea o di altro indefinibile tessuto corroso e spumoso; un disegno nella neve diventa una improbabile radiografia della terra, la struttura di una foglia, o altro<br />
ancora. Questo potere d'intervenire sulla natura è così drastico e dittatoriale da mettere persino in discussione la natura stessa della fotografia, quello che si dice il suo<br />
specifico e che ha i suoi parametri nella lezione dei grandi reporter come Capa e Cartier-Bresson; i quali potrebbero apparire persino deludenti nel loro progetto di<br />
bloccare l'esistente dentro il tempo; mentre per un fotografo come Giacomelli, col suo prepotente istinto figurativo, si tratta di bloccare forme assolute fuori dal<br />
tempo.»<br />
Sandro Genovali, Un artista senigalliese: Mario Giacomelli, “Controvento”, 1978.
«Mario Giacomelli, marchigiano, affettuoso "allievo" di Cavalli, si è costruito, nel panorama della fotografia mondiale, un'area di originalità e di indiscusso valore. Nella<br />
vastissima letteratura fotografica molti critici hanno autorevolmente voluto vedere nelle sue opere riflessi di "espressionismo figurativo”; hanno parlato di visione<br />
panteistica del reale o addirittura di autoanalisi in una sorta di rapporto freudiano terra madre-matrigna. Ritengo però che il miglior approccio alle fotografie che<br />
vengono proposte in questa mostra sia sgombrare la mente da schematismi intellettualistici e, dall'altra parte, guardarsi dal facile inganno della prima impressioneemozione.<br />
Vedere nelle vecchine dell'ospizio una denuncia sociale, lasciarsi impressionare dalle inquadrature del Sud, troppo spesso sacrario della retorica, o fermarsi<br />
alla suggestione visiva delle interpretazioni di Spoon River, significa tradire Giacomelli. Bisogna lasciar parlare l'immagine nella sua purezza; e allora i temi di quel<br />
mondo (che sono i temi della nostra storia: la natura, i malati, i pretini, i vecchi e gli innamorati) diranno la partecipazione appassionata dell'artista al dolore universale<br />
della vita. Ciò avviene ad esempio, in modo privilegiato nel paesaggio, dove la violenza del linguaggio degli alberi si tramuta in infinita tristezza. Lo stesso Giacomelli<br />
suggerisce una lettura del proprio rapporto con la natura, quando parla di quel paesaggio che ad ogni primavera rinasce, mentre l'uomo inesorabilmente muore ogni<br />
giorno. Ma anche quello che può apparire come il più spietato documentarismo si sposa, in una fusione perfetta, con la limpidezza dello stile, senza sbavature, senza<br />
sadismi, senza sentimentalismi. (…)».<br />
Mina Cavalli, invito alla mostra Mario Giacomelli, Lucera, 1982.<br />
* * *<br />
«Il fotografo di paesaggi ruvidi e puri, spogli di accenti naturalistici, con le loro incantate geometrie, la loro matericità così tipica dell'informale, il libero scoccare<br />
dell'energia, ma anche dell'angoscia nello spazio (…) senso fortissimo del livello sintattico della composizione (…) esigenza a far ricorso ad elementi puri, (…)<br />
conseguente vagheggiamento dell'Esprit de geometrie (…) bisogno di massima economicità. Tutte le fotografie di Giacomelli sono metafore, ariose, ma anche violente,<br />
di un racconto interiore. Come tali vanno lette: grafico di un paesaggio dell'anima, tormentato e appassionato. Nelle scabre campiture dei paesaggi illuminate da una<br />
forte accentuazione chiaroscurale è la stessa inquietudine interna, la stessa sottile disperazione ma anche la profonda "pietas" che rinveniamo nel bue scannato, nel<br />
volto rugoso di un vecchio, come nella solitudine di tre monachelle in riva al mare, e la struggente intimità di due innamorati. (…)».<br />
Michela Vanon, Mario Giacomelli. Sogni e incubi di un poeta, “Photo Italia”, 1984.<br />
* * *<br />
«Le fotografie vivono nel rapporto reciproco, nel loro ritmarsi in sequenza, con tensioni e torsioni che sono, per analogia, quelle del verso poetico. L’evocazione è<br />
l'altra dimensione di queste opere nelle quali qualsiasi immagine, con forza, denuncia il suo non esistere in quanto tale ma essere rimando ad altro, che è musicalità ed<br />
emozione. emozione. Giacomelli, in un certo senso, ha ottenuto il silenzio dell'immagine, ne ha distrutto la perentorietà, l'imporsi con<br />
la sua fisicità per trasformarla in allusione dinamica, denunciarne il suo carattere fenomenico. Diventando così, le sue<br />
immagini, eidetiche nel senso definito da Husserl di ciò che è al di là della percezione sensibile in quanto relativo alle<br />
essenze. Le fotografie non riprendono mai immagini provocate o presenti nelle poesie. Anche in questo caso le<br />
reinventano. Come non esistono immagini/simbolo, ma solo immagini/segno. La paratassi è ottenuta non con la ripetizione<br />
di un immagine chiave, ma ancora una volta per evocazione, per allusione.»<br />
Mario Giacomelli racconta: L'Infinito; Passato; Ninna Nanna, cat. Mostra Comune di Sorbolo e Associazione Camera Works,<br />
1991.<br />
* * *<br />
«…le fotografie di Giacomelli sono però lungi dall'essere semplici documenti. Egli fotografa e stampa con gran senso<br />
d'avventura, usando alto contrasto, composizioni inaspettate e altri espedienti per trasformare le sue immagini da semplici<br />
documenti in opere d'arte ricche ed evocative. A volte appare come se avesse gettato un velo magico sopra i suoi soggetti,<br />
producendo immagini che sembrano mescolare descrizione, memoria e sogno in parti uguali…».<br />
Charles Hagen, “The New York Times“, per la mostra alla James Danziger Gallery, 1993.
Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi -<br />
Fotografie realizzate tra il 1954 e il 1983<br />
all’ospizio di Senigallia
echi
Da Scanno -<br />
Fotografie realizzate nel 1957 e nel 1959<br />
a Scanno, Abruzzo
Giovanni Giudici<br />
Giovanni Giudici è stato poeta, prosatore, saggista, traduttore e giornalista. Letterato, insomma, a “tutto tondo”, personalità intellettuale<br />
davvero particolare che si è concretamente palesata anche attraverso l’impegno lavorativo svolto per decenni all’interno della Olivetti (tra<br />
Ivrea, Torino e Milano e sempre occupandosi di comunicazione). Probabilmente esaustiva della sua esperienza di uomo (e, aggiungeremmo, di<br />
“uomo di lettere”) è la breve definizione che di lui viene data nel risvolto di copertina del libro Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
[Grafiche Fioroni, Casette d’Ete (AP), 2004]: «In ogni ambito, Giudici ha portato il suo raro stigma di civiltà, come se l’impegno della vita<br />
trovasse il suo giusto nella parola e l’amore della propria lingua ne contenesse la salvezza…».<br />
Si propone, a seguire e introdotta dalla quasi totalità di una bella ed appassionata nota di Goffredo Fofi, una scelta di testi da La vita in<br />
versi, il libro che - uscito da Mondadori nel 1965 - impose definitivamente Giudici all’attenzione dei critici e dei lettori, e dal già citato, e poco<br />
noto ai più, Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002, il volume che ha preceduto il silenzio degli ultimi anni della sua vita e che ci<br />
dona una produzione in versi, in prosa e nel campo della traduzione parallela a quella ufficiale e fino a quel momento in buona parte inedita.<br />
Si tratta di una selezione che è sì polarizzata su due estremi temporali distanti tra loro, ma che appaiono come di assoluto rilievo nella vicenda<br />
artistica del poeta de Le Grazie. D’altronde, non si può non testimoniare - qui - anche tutta l’oggettiva difficoltà nel dar conto in maniera<br />
completa, in un qualsiasi spazio che non sia un’antologia appositamente pensata, di un’opera così vasta come quella che Giudici ci ha lasciato.<br />
A guidarci nella redazione delle pagine successive è stato comunque, in primis, il grande desiderio di voler dedicare un sentito omaggio a<br />
quell’autore che, forse più originalmente di altri nel novecento italiano, ha saputo avvicinare la poesia al quotidiano “atto” del vivere.<br />
Giovanni Giudici
Giovanni Giudici<br />
1<br />
Nacque a Le Grazie (La Spezia) il 26 giugno del 1924.<br />
Dal 1933 al 1955 è vissuto a Roma, dove si è laureato in Lettere; poi, assunto alla<br />
Olivetti, ha lavorato ad Ivrea, a Torino, quindi a Milano fino al 1980. In quella<br />
fucina di cultura e di intellettuali che fu in quegli anni la Olivetti ebbe occasione<br />
di conoscere, tra gli altri, Paolo Volponi, Nello Ajello, Giovanni, Arpino, Beppe<br />
Fenoglio, Riccardo Musatti e Franco Fortini.<br />
Vastissima è stata la sua attività letteraria. Si è infatti cimentato nella scrittura in<br />
versi, in prosa, nella saggistica, nella traduzione e, marginalmente, nella<br />
drammaturgia.<br />
La sua produzione poetica è raccolta nel Meridiano I versi della vita (cura e<br />
commento di Rodolfo Zucco, introduzione di Carlo Ossola, cronologia<br />
biobibliografica di Carlo Di Alesio, Mondadori, 2000); le sue prose sono<br />
pubblicate in Frau Doktor (Mondadori, 1989); le sue opere saggistiche sono<br />
riunite nei volumi La letteratura verso Hiroshima (Editori Riuniti, 1976), La dama<br />
non cercata (Mondadori, 1985), Andare in Cina a piedi (e/o, 1992) e Per forza e<br />
per amore (Garzanti, 1996).<br />
In veste di traduttore ha trasposto in italiano, tra gli altri, Pound, Frost, Sylvia<br />
Plath e Puškin.<br />
Tra i molti riconoscimenti che hanno accompagnato le sue opere si ricordano i<br />
premi: Viareggio (1969), Librex-Montale (1986), Puškin (1986), Bagutta (1992) e<br />
Feltrinelli (1997).<br />
Ha collaborato con “Comunità Rinascita”, il “Corriere della sera” e, con<br />
continuità ventennale, con “L’Espresso” e “L’Unità”. Negli anni Ottanta è anche<br />
stato editorialista del “Secolo XIX”.<br />
Nel 1989 è tornato a risiedere in Liguria: prima a La Serra di Lerici e infine nel<br />
suo paese natale.<br />
È scomparso all’ospedale della Spezia la notte del 24 maggio 2011.
Giovanni Giudici<br />
2<br />
LE OPERE<br />
Poesia<br />
• Fiorì d'improvviso (Edizioni del Canzoniere, Roma, 1953)<br />
• La stazione di Pisa (Istituto Statale d'Arte di Urbino, Urbino, 1955)<br />
• L'intelligenza col nemico (All'insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1957)<br />
• L'educazione cattolica (All'insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1963)<br />
• La vita in versi (Mondadori, Milano, 1965)<br />
• Omaggio a Praga (All'insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1968)<br />
• Autobiologia (Mondadori, Milano, 1969)<br />
• O beatrice (Mondadori, Milano, 1972)<br />
• Il male dei creditori (Mondadori, Milano, 1977)<br />
• Il ristorante dei morti (Mondadori, Milano, 1981)<br />
• Lume dei tuoi misteri (Mondadori, Milano, 1984)<br />
• Salutz (Einaudi, Torino, 1986)<br />
• Prove del teatro (1953-1988) (Einaudi, Torino, 1989)<br />
• Fortezza (Mondadori, Milano, 1990)<br />
• Poesie. 1953-1990 (Garzanti, Milano, 1991)<br />
• Quanto spera di campare Giovanni (Garzanti, Milano, 1993)<br />
• Empie stelle (Garzanti, Milano, 1996)<br />
• Eresia della sera (Garzanti, Milano, 1999)<br />
• I versi della vita (Mondadori, Milano, 2000)<br />
• Da una soglia infinita [Grafiche Fioroni, Casette d’Ete (AP), 2004]<br />
Antologie<br />
• Poesie scelte 1957-1974 (a cura di F. Bandini, Mondadori, Milano, 1975)<br />
• Un poeta del golfo. Versi e prose (Longanesi, Milano, 1995)
Giovanni Giudici<br />
3<br />
LE OPERE<br />
Narrativa<br />
• Frau Doktor (Mondadori, Milano, 1989)<br />
Saggistica<br />
• La letteratura verso Hiroshima (Editori Riuniti, Roma, 1976)<br />
• La dama non cercata (Mondadori, Milano, 1985)<br />
• Andare in Cina a piedi (e/o, Roma, 1992)<br />
• Per forza e per amore (Garzanti, Milano, 1996)<br />
Traduzioni<br />
• Addio, proibito piangere (Einaudi, Torino, 1982)<br />
• Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola (Mondadori, Milano, 1984)<br />
• A una casa non sua (Mondadori, Milano, 1997)<br />
• Eugenio Onieghin di Aleksandr S. Puškin in versi italiani<br />
(Nuova edizione riveduta, Garzanti, Milano, 1999)<br />
• Vaga lingua strana (Garzanti, Milano, 2003)<br />
Per ragazzi<br />
• Scarabattole (Mondadori, Milano, 1989)<br />
Teatro<br />
• Il Paradiso. Perché mi vinse il lume d'esta stella - Satura drammatica<br />
(Costa & Nolan, Genova, 1991)
Da Ricordo di Giovanni Giudici<br />
Di Goffredo Fofi<br />
«Benigno o no, lettore mio, / Come o quale tu sia stato, / Da amico voglio dirti addio. / Qualunque cosa abbia<br />
cercato / In queste strofe buttate là, / O di memorie un’ansietà, / O sollievo dalle fatiche, /Quadri vivi, parole<br />
ardite, / Qualche grammaticale errore, / Dio voglia che in questo libretto, / Per i tuoi sogni, per diletto, / Per<br />
recensioni, per il cuore, / Un granello abbia rinvenuto. / E qui ti lascio e ti saluto!».<br />
Sono i versi che compaiono alla fine dell’Eugenio Onieghin di Puškin, quelli con i quali Puškin si congedava dal suo<br />
lettore. La traduzione (del 1990, per Garzanti) è di Giovanni Giudici, il poeta ligure-milanese da poco scomparso,<br />
una traduzione che secondo Folena andava giudicata «come una poesia sua», di Giudici. E in effetti il colloquio di<br />
Giudici con Puškin ha dato origine a un’esperienza che sembrò, a chi leggeva l’Onieghin conoscendo la precedente<br />
versione di Lo Gatto in endecasillabi, una musica nuova, una riappropriazione della bellezza del verso grazie alla<br />
sua musicalità: cantabile era la poesia di Giudici, e cantabile quella originale di Puškin. Cantabile, ironica e<br />
autoironica, “facile” e “democratica” come facili e democratici sono i classici se riportati alla lingua comune<br />
quando questo è possibile, comune come lo era quando essi scrivevano, in una leggibilità liberata dalla pesante<br />
polvere del tempo.<br />
Giovanni Giudici è stato uno dei nostri maggiori poeti, di una stagione grande […]. La generazione è quella dei<br />
Sereni, dei Fortini, cresciuta tra Montale e Noventa, e nel caso di Giudici più Noventa che Montale. È la<br />
generazione che personalmente ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare da quando, richiamato in Italia da<br />
Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi per fare con loro i “Quaderni piacentini”, ho trovato tra i collaboratori più<br />
assidui della rivista Fortini e Sereni, Giudici e Zanzotto, Bandini, Raboni e Majorino. Con alterne vicende ne sono<br />
nate amicizie durature, fatte anche - per lo scalpitare della gioventù (arrivavo da Parigi forte di nouvelle vague e di<br />
nascente situazionismo, e mia base era la Torino dei “Quaderni rossi” e degli immigrati) - di occasionali scontri<br />
(soprattutto con Fortini, ovvio, e quasi sempre con grandi riaccostamenti) e di progressivi distacchi (da Raboni, il<br />
meno “aperto” di quel gruppo). Il poeta che più avevo amato prima di conoscerli era stato Sereni, concentrazione<br />
densa, non pacificata, ma quello di cui diventai più facilmente amico fu Giudici che, per aiutarmi nel mio<br />
inserimento milanese, mi faceva tradurre testi pubblicitari dal francese all’italiano e viceversa per l’Olivetti, per cui<br />
lavorava. Giudici mi voleva come suo collaboratore fisso, perché, nello stesso ufficio, avremmo potuto alternarci e<br />
prendere il nostro tempo, parlare di tutto, ma per farmi assumere dovevo prima passare da Ivrea. Un’amica mi ci<br />
accompagnò in macchina da Torino costringendomi a mettere giacca e cravatta del marito, e lì due simpatici<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
4
Da Ricordo di Giovanni Giudici<br />
laureati di Harvard mi fecero un colloquio al quale, credo, risposi con un candore per loro inatteso («Perché<br />
l’Olivetti?» «Perché sono disoccupato»). Dopo il colloquio, mi dissero che Volponi, direttore del personale, voleva<br />
conoscermi e mi accompagnarono da lui, che mi accolse espansivo, contento perché, essendo lui di Urbino e io di<br />
Gubbio, antica colonia dei Montefeltro, parlavamo un dialetto vicino ed eravamo cresciuti sullo stesso sfondo<br />
appenninico e contadino (ed entrambi, scoprimmo, conoscevamo assai bene per motivi di famiglia il mondo<br />
operaio delle fornaci di laterizi). Tornato a Milano, seppi da Giovanni che Volponi mi voleva a Ivrea, «per annoiarsi<br />
di meno a fare il dirigente» aggiunse Giovanni, ma io proprio non me la sentii: ero tornato in Italia da poco, ero<br />
infervorato dal progetto dei “Quaderni” e preferii il precariato milanese alla sicurezza eporediese, ma intanto<br />
l’amicizia con Giovanni si era consolidata, ed è continuata fino a quando la malattia non lo ha chiuso<br />
nell’incoscienza già molti anni fa, mentre quella con Paolo e sua moglie Giovina nacque più tardi, quando anche<br />
loro si fecero milanesi, una volta chiusa per sempre la grande stagione olivettiana.<br />
Giovanni amava la sincerità, e non nascondeva a nessuno degli amici i propri dilemmi e le scoperte, pubbliche e<br />
private. C’era in lui una forma di narcisismo sottile, che cercava complicità e condivisione, e la sua capacità di<br />
auto-ironia lo portava fin quasi all’auto-denigrazione su quelli che riteneva suoi difetti (da confessione cattolica e<br />
però pubblica, di chi tollera e si tollera nella comune coscienza dei limiti dell’umano, dell’imperfezione di tutti).<br />
Questa era una caratteristica del tutto insolita nell’ambiente culturale del tempo, che lo faceva resistere assai<br />
bene all’austerità fortiniana e che mi servì forse di modello per resistervi anch’io.<br />
Era infatti Fortini («sant’uomo, ma che pazienza!» diceva Grazia, citando Manzoni) un punto di riferimento per<br />
tutti, tra poesia e politica, di cui mi rendo conto oggi perché ci fosse così indispensabile. Giovanni era il contrario<br />
di Fortini (e che io chiami per nome l’uno e per cognome l’altro, anche se ho forse frequentato di più il secondo,<br />
vuol dire qualcosa...) ma a me sembrava che Giovanni fosse il più forte, perché sapeva andar d’accordo col suo<br />
super-io, accettando (ancora una volta, cattolicamente) i propri limiti, fidando nelle possibilità dell’uomo di<br />
cambiare qualcosa, perlomeno in quella precisa epoca storica che prometteva grandi cambiamenti, ma non<br />
trovandosi affatto spaesato e sconcertato più tardi di fronte al fallimento di quella promessa. Erano stati entrambi<br />
molto toccati, per esempio, e non solo loro, da Esperienze pastorali e da Lettera a una professoressa.<br />
Collaborò assiduamente con poesie, testi e consigli al lavoro di “Linea d’ombra”, negli infelici e ottusi anni ottanta<br />
della sconfitta, gli anni di Craxi e del nascente berlusconismo, e più tardi fu tra i sostenitori di “La Terra vista dalla<br />
Luna” (nel primo numero vi comparvero le poesie bene auguranti degli amici Zanzotto, Bandini, Giudici, Carmelo<br />
Bene e Amelia Rosselli, probabilmente l’ultima che ella scrisse) e quando fece 79 anni ci donò, per “Lo straniero”,<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
5
Da Ricordo di Giovanni Giudici<br />
delle bellissime traduzioni da Frost, Pound, Orten, Plath, con la stessa generosità e la stessa semplicità<br />
dimostrata al tempo di “Linea d’ombra”. Perché oltre che grande poeta Giudici è stato anche un grande<br />
traduttore da più lingue (spesso con l’aiuto di amiche che ne erano esperte).<br />
La sua ultima raccolta garzantiana venne a presentarla a Roma in un pomeriggio di pioggia dirotta che<br />
allontanò molti ammiratori. Si era in pochi, e si stabilì un dialogo allegro tra lui e noi pochi venuti a<br />
festeggiarlo. Leggeva versi dedicati al suo passato giovanile del tempo di guerra e di dopoguerra (l’anteprima<br />
di Roma città aperta, la fiducia politica nella nascente Repubblica...), anche qui con simpatia e ironia verso<br />
tutti e verso se stesso. Ma l’ironia nascondeva stavolta - come nelle sue poesie più belle - anche la nostalgia<br />
per uno ieri di speranza e una più dolente coscienza delle contraddizioni tra le aspirazioni private e le<br />
collettive, tra le aspirazioni collettive e la Storia. La leggibilità dei suoi versi gli ha forse nuociuto presso molti<br />
critici “iper” e ’63, ma ha fatto di lui e continuerà a farne un amico per i suoi lettori, un Poeta grande e vicino,<br />
di alta morale e di eccezionale sensibilità per l’humus profondo della nostra cultura, anche antropologica, e<br />
per la necessità e dignità di una Poesia che fosse anche, come in lui è stata, al contempo civile e religiosa. Con<br />
ironia. […]<br />
Testo apparso, nel luglio del 2011, in “LO STRANIERO - ARTE CULTURA SCIENZA SOCIETA’”<br />
http://lostraniero.net/archivio-2011/130-luglio-2011-n133/678-ricordo-di-giovanni-giudici.html<br />
La scelta dei testi che segue è stata curata da Danilo Mandolini<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
6
Da La vita in versi<br />
Con tutta semplicità<br />
Con tutta semplicità devo dire<br />
che un tempo sembrava lontano<br />
il tempo in cui morire.<br />
Ora non è più un pensiero strano.<br />
Ora è sempre lontano (almeno spero) ma<br />
posso già prefigurarmelo. Ho l'età<br />
in cui dovrei fare ciò che volevo<br />
fare da grande e ancora non l'ho deciso.<br />
Faccio quel che faccio, altra scelta non ci sarà:<br />
leggo di miei coetanei che muoiono all'improvviso.<br />
Il benessere<br />
Quanti hanno avuto ciò che non avevano:<br />
un lavoro, una casa - ma poi<br />
che l’ebbero ottenuto vi si chiusero.<br />
Ancora per poco sarò tra voi.<br />
*<br />
Dal cuore del miracolo<br />
Parlo di me, dal cuore del miracolo:<br />
la mia colpa sociale è di non ridere,<br />
di non commuovermi al momento giusto.<br />
E intanto muoio, per aspettare a vivere.<br />
Il rancore è di chi non ha speranza:<br />
dunque è pietà di me che mi fa credere<br />
essere altrove una vita più vera?<br />
Già piegato, presumo di non cedere.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
7
Da La vita in versi<br />
Le ore migliori<br />
I<br />
Le tue ore migliori… ma non sono per me:<br />
sono le ore del lavoro domestico,<br />
che è troppo trascurabile realtà<br />
per essere degno di storia. Progredisce<br />
la storia, infatti, ma il tuo lavoro<br />
semplicemente ricomincia e finisce.<br />
Le tue ore migliori sono della mattina,<br />
quando ti lascio e tento per vie diverse<br />
variare l’obbligato itinerario<br />
che sempre da un punto parte e ad uno arriva.<br />
Batte il sole al balcone di cucina,<br />
prima di cominciare tu guardi in strada.<br />
Io guardo invece nel fondo del mio cortile,<br />
mentalmente bisbiglio Dirigere<br />
et sanctificare, la breve preghiera,<br />
mia virtuosa abitudine prima di lavorare:<br />
lucida è la mente al quotidiano servizio<br />
e la stanchezza impossibile appare.<br />
Intanto passano le tue ore migliori,<br />
quando potresti parlarmi e sorridere.<br />
Tali bruciavano gli anni di gioventù<br />
nell’aspettare più sereni giorni:<br />
e tu riassetti, rigoverni, spolveri, sola<br />
(i figli sono a scuola) e aspetti che torni.<br />
II<br />
Dice decoro la tavola apparecchiata,<br />
possiamo avere tutto quel che vogliamo:<br />
all’opulenza mancano forse i fiori.<br />
Il buon cibo conforta dopo l’onesta fatica.<br />
Ma già si ammucchiano stoviglie mentre mangiamo<br />
troppo avidamente, per fare presto.<br />
E ricominci: i necessari rifiuti<br />
in un sol piatto raccogli, riempi<br />
il lavandino ove galleggiano sughi,<br />
affondano fili di pasta, bucce. Adempi<br />
la tua virtù necessaria, riordini<br />
ancora una volta la casa. Io ad altro<br />
lavoro attendo, al mio ufficio, sperando<br />
di fornir l’opra e non me, anzi che giunga la sera,<br />
per godermi la luce residua e, di me<br />
stesso padrone, qualche ora d’avanzo.<br />
Ma non sarà quella la vita vera:<br />
sono queste ore migliori e non ci appartengono.<br />
Eccoci ancora intorno alla mensa serale,<br />
tra le risse dei figli allegramente spietate:<br />
e nuovamente si guasta la linda cucina,<br />
la tovaglia è chiazzata di vino. «Lascia<br />
così - suggerisco - penserai domattina<br />
a tutto. Adesso resta un poco con me».<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
8
Da La vita in versi<br />
III<br />
Nessuno ci corre dietro. Ma tu<br />
macchinalmente solitaria persisti<br />
nel ritmo ordinario in cui ogni ora<br />
ha la sua norma: sai già che il mattino avrà stanze<br />
disfatte e l’odore del sonno e l’aria<br />
che un brivido nebbioso vi porta o il sole<br />
nella bella stagione. Bisogna dunque concludere<br />
tutto perché tutto ricominci,<br />
dopo un riposo di affrante bestiole,<br />
col primo atto del domani:<br />
vivrà la vita per chi non ha tempo<br />
di vivere. Così anche ora da me ti allontani,<br />
spingi cassetti, fai scattare sportelli,<br />
ammàini l’avvolgibile con fragore:<br />
e siamo soli con tutte le storie<br />
dei libri che promettevano<br />
in cambio di virtù felicità.<br />
Così finiscono le tue ore migliori,<br />
quando da un capo all’altro della città<br />
si chiudono i portoni dei casamenti:<br />
e in buie menti un comune pensiero<br />
apre un barlume del meglio a venire…<br />
così non riconosci l’inganno<br />
di chi ci ha fatti a servire.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
9
Da La vita in versi<br />
Quando piega al termine<br />
Quando piega al termine l’età,<br />
la nostra età, l’età del mondo, quando<br />
aspettare il nulla che accadrà<br />
è chiaramente un inganno - si mette al bando<br />
volontario colui che il sorriso rifiuta<br />
e non sopporta di essere vile<br />
più, non chiede più complici e muta<br />
persona diventa, facile preda ostile.<br />
Guarderò indietro<br />
Guarderò indietro, non avrò più paura.<br />
Dimenticare amici, dimenticare sventura<br />
o ventura, non serve, cambiare accento,<br />
sapere tutte le giuste notizie,<br />
dunque non serve. Se è da rifare il mondo,<br />
datemi la mia parte, fissatemi il tempo,<br />
controllatemi, lavorerò… Ma qui un po’ di vento<br />
già mi sbalestra, mi scopre se mi nascondo,<br />
mi coglie in fallo: basta un niente a tradirti,<br />
e sbagliare da soli non dà esperienza.<br />
Cominceremo daccapo, ma qui è già sabato sera,<br />
credo che il diavolo esiste, volevo dirti.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
10
Da La vita in versi<br />
Una sera come tante<br />
Una sera come tante, e nuovamente<br />
noi qui, chissà per quanto ancora, al nostro<br />
settimo piano, dopo i soliti urli<br />
i bambini si sono addormentati,<br />
e dorme anche il cucciolo i cui escrementi<br />
un’altra volta nello studio abbiamo trovati.<br />
Lo batti col giornale, i suoi guaiti commenti.<br />
Una sera come tante, e i miei proponimenti<br />
intatti, in apparenza, come anni<br />
or sono, anzi più chiari, più concreti:<br />
scrivere versi cristiani in cui si mostri<br />
che mi distrusse ragazzo l’educazione dei preti;<br />
due ore almeno ogni giorno per me;<br />
basta con la bontà, qualche volta mentire.<br />
Una sera come tante (quante ne resta a morire<br />
di sere come questa?) e non tentato da nulla,<br />
dico dal sonno, dalla voglia di bere,<br />
o dall’angoscia futile che mi prendeva alle spalle,<br />
né dalle mie impiegatizie frustrazioni:<br />
mi ridomando, vorrei sapere,<br />
se un giorno sarò meno stanco, se illusioni<br />
siano le antiche speranze della salvezza;<br />
o se il mio corpo vile io soffra naturalmente<br />
la sorte di ogni altro, non volgare<br />
letteratura ma vita che si piega al suo vertice,<br />
senza né più virtù né giovinezza.<br />
Potremo avere domani una vita più semplice?<br />
Ha un fine il nostro subire il presente?<br />
Ma che si viva o si muoia è indifferente,<br />
se private persone senza storia<br />
siamo, lettori di giornali, spettatori<br />
televisivi, utenti di servizi:<br />
dovremmo essere in molti, sbagliare in molti,<br />
in compagnia di molti sommare i nostri vizi,<br />
non questa grigia innocenza che inermi ci tiene<br />
qui, dove il male è facile e inarrivabile il bene.<br />
È nostalgia di futuro che mi estenua,<br />
ma poi d’un sorriso si appaga o di un come-se-fosse!<br />
Da quanti anni non vedo un fiume in piena?<br />
Da quanto in questa viltà ci assicura<br />
la nostra disciplina senza percosse?<br />
Da quanto ha nome bontà la paura?<br />
Una sera come tante, ed è la mia vecchia impostura<br />
che dice: domani, domani… pur sapendo<br />
che il nostro domani era già ieri da sempre.<br />
La verità chiedeva assai più semplici tempre.<br />
Ride il tranquillo despota che lo sa:<br />
mi numera fra i suoi lungo la strada che scendo.<br />
C’è più onore in tradire che in esser fedeli a metà.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
11
Da La vita in versi<br />
Da L’educazione cattolica<br />
I<br />
Nelle sole parole che ricordo<br />
di mia madre - che «Dio<br />
- diceva - è in cielo in terra<br />
e in ogni luogo» - la gutturale gh<br />
disinvolta intaccava il luò d’un l’uovo<br />
contro il bordo d’un piatto<br />
- serenamente dopo il cielo in terra<br />
dal guscio separato in due metà<br />
scodellava sul fondo il tuorlo intatto<br />
- la madre sconosciuta parlava<br />
religione entrava<br />
nella mia tenera età.<br />
III - Il catechismo illustrato<br />
L’ira era chiara nel catechismo illustrato:<br />
uno mostrava il pugno, sembrava gridasse.<br />
Il superbo passava diritto, il goloso mangiava,<br />
l’avaro ricontava le sue monete d’oro,<br />
l’accidioso era scalzo e contro un muro dormiva,<br />
un bieco era l’invidia che a due felici guardava.<br />
Ma non altrettanto chiaro il vizio della lussuria:<br />
accanto a una finestra - TRISTI EFFETTI<br />
una nota ammoniva<br />
- di caffellatte o di brodo fumante porgeva la tazza<br />
la donna curva all’uomo adagiato in poltrona.<br />
Erano, soli in casa, due vecchietti<br />
e oltre quei vetri - probabilmente - una piazza.<br />
*<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
12
Da La vita in versi<br />
*<br />
VI - Piazza Saint-Bon<br />
Sbràita decoro il creditore, infierisce<br />
sull’insolvente, gli minaccia galera,<br />
fa adunare la gente del passeggio serale:<br />
il giusto chiede giustizia al procuratore del re.<br />
Gli è contro solo il bambino che trema<br />
di paura e vergogna, ma che finge<br />
di appartenere ad altri - non si stringe<br />
al genitore maltrattato.<br />
Il figlio del debitore - io<br />
sono stato.<br />
Per il mio padre pregavo il mio Dio<br />
una preghiera dal senso strano:<br />
rimetti a noi i nostri debiti<br />
come noi li rimettiamo.<br />
*<br />
VII<br />
Vivranno per sempre?<br />
Sempre, sì - mi dicevo<br />
e le vedevo<br />
alla distanza del tempo rimpicciolire<br />
lontanissime, in piedi, a braccia conserte<br />
su quelle stesse soglie, o leggendo gli stessi giornali<br />
crollando il capo, scuotendo gli stessi grembiali,<br />
di nero e di grigio vestite e decisamente<br />
fuori di moda come diventerà<br />
ogni persona vivente<br />
- ovunque e su quella stessa<br />
strada fra il mare e una fila di platani<br />
dove quieta ubbidiente e dimessa passò<br />
la mia età infantile<br />
- quelle persone viventi<br />
che passarono poi come l’età<br />
rispondendo di no alla domanda<br />
che avevo dimenticata: no (dicendo)<br />
non vivremo per sempre<br />
- senza notizia alcuna, senza coscienza<br />
di storia o di giustizia, senza il minimo dubbio<br />
che un’altra vita sarebbe stata a venire<br />
più vera, con più intelligenza:<br />
e dunque senza viltà consegnate alla sorte<br />
- alcune con stupore della morte,<br />
con desiderio altre, con sofferenza.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
13
Da La vita in versi<br />
*<br />
XIII<br />
Trotski lattaio in maglia di flanella<br />
ruggine o, secondo la stagione,<br />
con uno sbottonato gilè<br />
- o alle feste in giacchetta con un bel fiocco nero:<br />
solo, occhiali a stanghetta in luogo del pince-nez<br />
egli portava - e un cognome che traducevo nel gesto<br />
di due dita infilate nel taschino.<br />
Era un contrario al fascio, era un onesto.<br />
Scendeva ogni mattina dal suo domicilio<br />
coatto, sbarbato di fresco, faceva il suo giro,<br />
poi si sedeva al caffè, tranquillo leggeva il giornale.<br />
«Nessun governo può durare in eterno»<br />
diceva - e quasi un giorno in paese ma senza<br />
il bidone del latte<br />
lo videro - e in camicia nera.<br />
Così per uno sbaglio una vita intera<br />
d’opere buone va in fumo per un peccato mortale.<br />
Sì, qualcuno pensò che la mente non fosse più stabile<br />
o soffrisse quel vecchio d’un brutto male…<br />
la verità è piuttosto che la virtù è insopportabile,<br />
sta addosso come una rogna<br />
- e non te ne puoi liberare<br />
che con infamia e vergogna.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
14
Da La vita in versi<br />
Mimesi<br />
Attento, ci rimani, passa l’Angelo!<br />
- mi ammonivano quando per divertirmi fingevo<br />
d’essere muto o strabico, o facevo<br />
la bocca da idiota col labbro pendente e bavoso,<br />
o zoppicavo imitando…<br />
Invece no,<br />
ben altro aveva da fare che non passare di lì<br />
dove io ero - e fu un vero peccato<br />
che non mi riuscisse lo scherzo di rovesciare le palpebre:<br />
l’Angelo non sarebbe passato.<br />
Tranquillamente allora fu imitato<br />
il nonno che fischiando e volto in su<br />
dalla strada serrava i pugni e in aria<br />
troncava una manciata immaginaria<br />
di spaghetti per ordinare: giù<br />
in pentola! - o il chinarsi contrito<br />
del padre, le sue manìe<br />
a tavola d’incartare quando si era servito<br />
coppa o salame senza far caso di noi…<br />
A questo giuoco quanto i miei figli hanno riso.<br />
Un po’ meno per giuoco - e utilmente<br />
spesso per me, per smuovere un sorriso,<br />
ho specchiato i pensieri della gente:<br />
certo non senza ironia - ma troppo<br />
celata non serve - ho parlato<br />
di ordine col reazionario,<br />
di borsa col possidente,<br />
di calcio col tifoso - e raramente<br />
me stesso ho scoperto com’ero<br />
nella dovuta misura:<br />
l’amaro spino del vero ho temuto<br />
- non l’impostura.<br />
Un tempo di vita ho perduto<br />
a travestirmi a scherzare<br />
sicuro che dietro ogni maschera<br />
l’altro che ero restasse<br />
paziente ad aspettare:<br />
al momento opportuno per essere pronto,<br />
con uno scatto di reni<br />
riemergere dal fondo…<br />
……………………………………………………………………………<br />
È artrite o artrosi che mi fa torcere il collo?<br />
Ma di chi sono queste parole che dico?<br />
Già forse ho una mia smorfia abituale?<br />
E niente più da nascondere?<br />
Solo me da imitare?<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
15
Da La vita in versi<br />
La vita in versi<br />
Metti in versi la vita, trascrivi<br />
fedelmente, senza tacere<br />
particolare alcuno, l’evidenza dei vivi.<br />
Ma non dimenticare che vedere non è<br />
sapere, né potere, bensì ridicolo<br />
un altro voler essere che te.<br />
Nel sotto e nel sopramondo s’allacciano<br />
complicità di visceri, saettano occhiate<br />
d’accordi. E gli astanti s’affacciano<br />
al limbo delle intermedie balaustre:<br />
applaudono, compiangono entrambi i sensi<br />
del sublime - l’infame, l’illustre.<br />
Inoltre metti in versi che morire<br />
è possibile a tutti più che nascere<br />
e in ogni caso l’essere è più del dire.<br />
Finis fabulae<br />
1965<br />
Come una scia si richiude la favola<br />
sugli sbruffi dell’elica lussureggiante di schiuma.<br />
Guardala a poppavia che s’appiattisce<br />
levigata da diavoli mulinelli.<br />
L’essere è più del dire - siamo d’accordo.<br />
Ma non dire è talvolta anche non essere.<br />
Ah discreta più del dovere fu l’incoscienza.<br />
Presto tutte le acque saranno uguali o lisce.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
16
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
A cura di Evelina De Signoribus. Introduzione di Carlo Di Alesio e nota ai testi di Rodolfo Zucco.<br />
Illustrazioni di Sandro Pazzi.<br />
Da I. PROVE E POESIE 1983-1999<br />
MADRIGALE<br />
………………………………………………..<br />
Quando non fosse la vera pietà<br />
Parole finis mundi prigioniere<br />
Rischiarvi oltre il corpo con tremore<br />
E sopra voi cadere<br />
Mai si scoprisse lievemente il cuore<br />
Con voi volando nel vostro aldilà<br />
Spine del giusto affanno<br />
Spine del mio tacere<br />
Egli si udì parlare - scriveranno<br />
E della sua virtù fece il suo danno<br />
Gennaio 1984<br />
A FERNANDO BANDINI<br />
Mi fa difetto, Fernando, il latino<br />
E arduo mi sarà salire al soglio<br />
Dove il pastore barbaro d’orgoglio<br />
Medita il NO spietato e tridentino<br />
Vengo da te semmai su bianco foglio<br />
Tu mi segnassi un pur nero cammino<br />
O rosso, o verde - apologia, germoglio<br />
Di nuova teologia cui m’indottrino<br />
Qui non soccorre Ignazio (o così pare)<br />
Distratto alla difesa di Pamplona<br />
O pur lui stesso prostrato alle scale<br />
Del palazzo di Pietro - a impetrare<br />
Grazie da chi malvolentier perdona<br />
Un troppo solo peccato mortale<br />
2 febbraio 1984<br />
Ricopiata il 22 febbraio 1987 con qualche variante<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
17
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
HYDRA<br />
Inghiotti ròdimi ripuliscìti<br />
Idra e fauce<br />
Zannuta di sangue<br />
E raschiati ossi prelibati<br />
Da altri più urbani ossi<br />
E le briciole<br />
Residui di beccaio alla bocca<br />
Ti insistono<br />
Da mitissimi corpi<br />
Tali e quali le mie che qui… Ma no<br />
Ché veruna importanza e diciamo piuttosto le tue<br />
Inclitamente più che vive<br />
Briciole del tuo umore irrorate -<br />
Idra e fauce che mai<br />
Del misero me non colmerò<br />
Valore e lagrime<br />
Tale è sì la tua fame<br />
Che a ammansirla non basti<br />
Te nemmeno tuo corpo a brani<br />
E scricchiolìo osso a osso<br />
Da te se potessi medesima e come fai<br />
Briciola te sola a mangiarti<br />
8 febbraio 1987<br />
QUARTINA<br />
Io te mi spalmo del diverso miele<br />
Onde stillasti, amara vita mia:<br />
Da spietate ferita e aguzze chele,<br />
Nuda madre - Nostalgia…<br />
Estate (?) 1987<br />
Sì, perdonate<br />
Al faticato attore:<br />
Con tremante tremore ei se ne va<br />
Tra le quinte si rotola via<br />
Perché al patire luogo più non sia<br />
Segreto del segreto<br />
E quel che al suo tacere insiste dietro<br />
Meno del meno fu la verità<br />
Come mi graffiano questi panni<br />
Inganni di scena<br />
Consumata mia sempre duplicità:<br />
Ut unum sint - cuore intero<br />
Pancia del perfetto zero<br />
22 novembre - 2 dicembre 1987<br />
*<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
18
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
SUÈBICA IV<br />
Alla discreta forse amica lo<br />
Chiede come si dica<br />
Senza che lei però<br />
Possa in faccia frugarlo e del perché<br />
Protetto dal telefono inquisire<br />
Come nell’ora vagheggiata lingua<br />
Della speciosa austera sunamita<br />
Mentale nudità tepore al freddo<br />
Estremo della vita<br />
Si dica vieux cochon vecchio maiale<br />
Quasi finger si voglia<br />
L’eco se mai saprà<br />
Che lui gli fa poesie quanto suo ridere -<br />
Intanto la risposta è: Tale e quale<br />
Tranne che Schwein è neutro e deve scrivere<br />
Altes con es finale<br />
29 maggio 1988<br />
Trascritta con minime varianti il 2 settembre 1999<br />
DA UNA SOGLIA INFINITA<br />
Apparivi e sparivi che a disfarti<br />
Bastò la tenue offesa di uno sguardo<br />
Carpirti un volto nella mente un nome:<br />
Scendevi da una soglia infinita<br />
I secoli che attraversando<br />
Da tanto avaro averti insisti in vita<br />
Gennaio 1991 - gennaio 1993<br />
*<br />
SINE MURMURE<br />
Quando ma in segreto onde non possano<br />
Impeccabili labbra<br />
Trafiggerlo - tu come osi<br />
Giuda e sentina del vizio?<br />
O affannato bisbiglio e spiraglio estremo!<br />
KING TO-MORROW<br />
Improbabili arcani<br />
Messaggeri del mondo<br />
Che dal gaio domani<br />
A noi movete incontro<br />
Spenti i miei paradisi<br />
Chiudo finestre e porte<br />
Prima la vostra visita<br />
Aspetto e poi la morte<br />
4 novembre 1998<br />
*<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
19
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
Da II. ALTRE POESIE<br />
AUGURI<br />
A FRANCESCA C. PER IL SUO BATTESIMO<br />
(nell’accompagnarle il dono di una sterlina<br />
con l’effigie della regina Vittoria)<br />
Francesca la buona fortuna<br />
Ti giungerà da una stellina<br />
Nel cielo assai più che la luna<br />
Lontana e come te bambina<br />
Ma oggi di grazia e decoro<br />
Promessa adorni la tua storia<br />
Di una di nome Victoria<br />
Vecchia bambina il vecchio oro<br />
Lerici, 4 ottobre 1999<br />
SVETLANA<br />
O cameretta che già fosti un porto…<br />
Petrarca<br />
Quale il sussurro di Arletty:<br />
Une chambre?! - nel buio delle scale<br />
Fuori grondando il temporale<br />
In «Les enfants du Paradis»<br />
Tale la tenera bugia<br />
Che bisbigliata come in fretta:<br />
Nella mia (disse) cameretta<br />
C’è sul muro la Sua poesia<br />
Febbraio-maggio-agosto 2001<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
20
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
IL FIGLIO DI DIO<br />
Presentato da un certo Gianni brera<br />
A conoscerla ho fatto in tempo anch’io<br />
Nato nel ‘24 Sua bella primavera<br />
De Pra Giovanni alias il Figlio-di-Dio<br />
«Siamo finiti in mano ai capimastri<br />
Caro signore se ripenso ai miei<br />
Tempi che al Genoa c’erano gli Inglesi<br />
E davano a tutti del Lei…»<br />
(Esatte parole Sue<br />
Nel foot-ball dei disastri)<br />
IO E TE CHE SORRIDIAMO DALLA FOTO DI DONDERO<br />
Io e te che sorridiamo dalla foto di Dondero<br />
Fu in Milano un remoto pomeriggio<br />
Nella casa che più non abitiamo<br />
E adesso al buio o tutt’al più in penombra<br />
Per quel filo di luce dal cortile<br />
Ma è come se vivessimo e viviamo<br />
In un paese ormai molto lontano<br />
Però dal temporale inaspettato<br />
Qui riparando esploro<br />
La stanza come non più mia, gli oggetti<br />
Un tempo vagheggiati -<br />
Il lampadario bianco e lilla di Venini<br />
Il tavolo a tre gambe Louis-Philippe<br />
E alle pareti Baj Greco Kolář…<br />
Io e te che sorridiamo l’un l’altra sottobraccio<br />
Due stagionati sposi di Ben Shahn<br />
Da pie preci sepolti innanzi tempo<br />
Dunque al riparo, fuori piove, e qui<br />
Benché tu non ci sei noi due contemplo<br />
In domestici panni ossia dal vero<br />
Nel giorno stesso che passò Dondero<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
21
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
DEDICATO AI POMPIERI DI NEW YORK<br />
Bambini in trecento son morti<br />
Bambini che prima di ieri<br />
Erano giovani e forti<br />
A loro nei vostri pensieri<br />
Tenetevi stretti un minuto<br />
Quando giocate ai pompieri<br />
Il vostro gentile saluto<br />
UNA COPIA DEL MAUBERLEY<br />
Quest’anno - il mio<br />
78° e primo che a quanto mi ricordo<br />
Mai non mi fossi bagnato nel mare -<br />
Ora ripenso di quanta meraviglia<br />
Mi fece e son più di quarant’anni<br />
Udire che Ezra Pound allora meno vecchio<br />
Di me adesso nuotava tornato a Rapallo<br />
Che strano nell’apprenderlo da Vanni<br />
Io pensavo l’averne ancora voglia:<br />
Con la vita che aveva alle sue spalle<br />
Dall’Idaho a Venezia e poi a Parigi<br />
E a Roma e le sue prediche alla radio sull’usura<br />
Per finire poi in braccio all’RSI<br />
E dieci anni interi al Saint Elizabeth’s<br />
Io lo conobbi appunto rétour d’Amérique<br />
Non spiccicava verbo - era un suo modo<br />
Di protestare… «A G. il risponsabile»<br />
Scrissi su quella copia che gli porsi<br />
Della mia traduzione di H.S. Mauberley -<br />
Poi donata a qualcuno<br />
Che più non ricordo<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
22
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
Da III. ARLETTY<br />
Potrebbe essere la regina di babilonia, ma nel film è Garance: nome che fa inevitabilmente rima con<br />
France e che rimanderebbe a un fiore, a un alcunché di rosso. Nei primi fotogrammi, appare poco più che una<br />
figurante. Con l’eloquenza, però, di chi non ha bisogno di parole.<br />
Nude le spalle e le braccia, emerge dalla tinozza che ruota all’imboccatura di un finto pozzo di scena e<br />
sempre immobile (si muovono per lei soltanto le cose che “la” muovono) tiene impugnato uno specchio da<br />
toeletta. I tumultuanti spettatori che si accalcano ad ammirarla anche soltanto di spalle incontrano<br />
comunque il suo volto riflesso. È un volto senza tristezza né gioia, potrebbe esprimere (o celare) qualsiasi<br />
sentimento e disegno; è un volto che esegue unicamente se stesso, in nome di quella che alcuni critici<br />
definiranno una sua «religione d’indipendenza morale».<br />
Un lievissimo, intermittente indizio (un rien!) di strabismo di Venere all’occhio destro non fa che esaltarne<br />
il fascinoso enigma.<br />
Al cinema è arrivata non più giovanissima da qualche atelier di moda dove l’hanno ribattezzata col suo<br />
nome d’arte. Di taglia sottile, statura che non eccede la media dell’epoca e un peso (a diciassette anni) di<br />
quarantanove chili, è passata anche per il cabaret, ma specialmente per il teatro… Così è diventata anche<br />
un’intellettuale: ma non inclina a sinistra e a Proust preferisce Céline, col quale ha avuto una sincera amicizia.<br />
Scriverà in seguito un libro di memorie, quasi un’apologia là dove tocca certe sue personali vicissitudini. Il<br />
titolo, La Défense, è però anche il nome del quartiere parigino dove è cresciuta e ha avuto un suo primo<br />
amore, partito per la guerra nel 1914 e subito morto. Di lei scrivo come da diva, al presente virtuale del più<br />
famoso dei suoi film che (per la cortesia del Centro culturale francese di Milano) mi trovo insperatamente<br />
sotto gli occhi, visto dal sofà di casa mia. Se non fosse morta sette anni fa, in solitudine e quasi cieca, sarebbe<br />
oggi ultracentenaria.<br />
* * *<br />
Vivevo anch’io, anzi pativo, da almeno tre anni un primo amore: ma discontinuo e infelice: tutto un<br />
esasperante prendi-e-lascia. E il tempo che altri miei coetanei dedicavano alle loro ragazze, io lo dissipavo al<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
23
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
al cinema: le più spesse volte nel deserto semibuio del primo spettacolo pomeridiano, unica distrazione che<br />
potevo concedermi senza spendere nulla: come cronista mi avevano dato una tessera di libero ingresso.<br />
E fu così che ebbi a imbattermi nell’edizione in lingua originale del film-fiume di tre ore e mezzo in cui, a<br />
oltre mezzo secolo di distanza, credo di poter ravvisare, meglio tardi che mai, una qualche analogia con la mia<br />
travagliata inquietudine di quel tempo.<br />
Come fosse incominciata lo rileggo da un vecchio appunto: «Otto maggio (1945) e armistizio in Europa, la<br />
mia privata melanconia di ventenne e proprio quella sera la ragazzina in gonna nera a pieghe e camicetta<br />
bianca con una curiosa scollatura quadrata, capelli neri e altresì gli occhi che mi sembravano inarrivabili e il<br />
gentile reclinarsi del collo appena abbronzato nel domandarmi: “ma perché è così triste, non è contento che è<br />
finita la guerra?”».<br />
Quasi come un treno (ma no: una carrozza!) che ti passasse vicino al piccolo trotto: un salto e ci sei sopra.<br />
E invece la mia piccolo-borghese, forse meschina, manìa di definire, classificare, formalizzare. Quella manìa<br />
che finisce per castrare tutto: come, in poesia, certi endecasillabi spalmati di burro. E dunque, già nel fondato<br />
presentimento di perderla, l’ansia di codificare da subito un’innominabile, fragilissima, serena felicità, nome<br />
di Dio pronunziato non invano, un esser nudo nell’Eden da non dover goffamente eludere o coprire… E<br />
tuttavia l’impenitente mostrum degli atti impuri minacciosamente rappresentato nel vecchio catechismo di<br />
Pio X: una minuscola figura di donna bionda lambita e avvolta da infernali lingue di fuoco. Per gli atti impuri,<br />
ammonivano i buoni sentimenti, c’era semmai il remedium concupiscentiae del casino. Mentre ecco noi due<br />
quel giorno di Corpus Domini distesi su un prato che più non esiste e il mio trasalire alla paradisiaca<br />
bianchezza, miracolo che dai suoi ginocchi in su mi si offre alla vista per un venticello malandrino che fa<br />
svolazzare quella gonna nera a pieghe. «Du bist so schön! Fermati, sei bello!», aveva gridato all’attimo<br />
fuggente l’antico distillatore di elisir. Io no: «Stretto fra il tuo pudore e la mia angoscia» sarei solo riuscito<br />
amaramente a scrivere di me stesso. E dire che non erano mancati consigli di più esperti: per esempio<br />
«metterglielo in mano»… o altre espressioni a cui inorridivo, pensando che lei avrebbe potuto non volermi<br />
nemmeno più vedere.<br />
[…]<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
24
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
Da IV. 14 X 14. DAI SONETTI DI SHAKESPEARE<br />
Così il mio amore dice quel che è detto<br />
22.<br />
Lo specchio non dirà che sono vecchio<br />
Finché tu e giovinezza insieme state;<br />
Ma se ai solchi del tempo in te rifletto<br />
Sento che morte espia le mie giornate.<br />
Perché questa beltà che ti ricopre<br />
No n è che bella veste del mio cuore,<br />
Che è nel tuo petto come il tuo nel mio.<br />
E come posso avere più anni di te?<br />
Oh, dunque, amore, usa per te ugual cura<br />
Qual io non per me stesso e per te avrò,<br />
Custodendo il tuo cuore che dal male<br />
Proteggerò come il suo bebè una tata.<br />
Se il mio cuore è disfatto di lui non ti fidare;<br />
Tu che mi hai dato il tuo, da non ridare.<br />
76.<br />
Perché il mio verso così poco aspira<br />
A varietà di forme e a cambiamenti?<br />
Perché col tempo non tengo di mira<br />
Sistemi nuovi e inediti ingredienti?<br />
Perché sempre lo stesso e sempre uguale<br />
Scrivo inventando quel che è già inventato,<br />
Così che ogni parola la mia firma<br />
Quasi porti con sé marchio d’origine?<br />
Oh tu lo sai, scrivo sempre di te,<br />
Dolcezza mia, solo di te e d’amore,<br />
Di nuova veste le antiche parole<br />
Vesto spendendo ciò che fu già speso:<br />
E come il sole è sempre nuovo e vecchio<br />
Così il mio amore dice quel che è detto.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
25
Da Da una soglia infinita. Prove e poesie 1983-2002<br />
81.<br />
O io vivrò per dettare il tuo epitaffio,<br />
O sarai viva tu e io sottoterra:<br />
Dunque non morirà la tua memoria<br />
Benché di me ogni parte sia disfatta.<br />
Quindi il tuo nome avrà vita immortale,<br />
Pur dovendo io morire a tutto il mondo:<br />
La terra mi avrà dato solo una fossa comune<br />
E tu sarai sepolta negli occhi della gente.<br />
Tuo monumento saranno i miei bei versi<br />
Che occhi ancora non nati scorreranno;<br />
Lingue future diranno di te<br />
Quando qui sarà morto chiunque ora respiri;<br />
(Tanto può la mia penna) tu ancora sarai viva<br />
Dove su labbra d’uomo un fiato sopravviva.<br />
121.<br />
Meglio essere in colpa che incolpato<br />
Quando a chi non lo è lo si rimproveri<br />
Ed il giusto piacere egli ne perda,<br />
Non per noi stessi, ma al giudizio altrui.<br />
Perché infatti dovrebbero falsati sguardi estranei<br />
Rendere omaggio alla mia allegra vena?<br />
O c’è dei miei difetti qualche indizio<br />
Che sia male quel che io ritengo buono?<br />
No, io son quel che sono; e loro che censurano<br />
Le mie magagne guardino alle proprie:<br />
Magari io sono in regola ed essi invece in fallo;<br />
A meno che non credano in questa sciagura generale -<br />
Tutti gli uomini sono malvagi e regnano sul proprio male.<br />
Giovanni<br />
Giudici<br />
26
voci
Da Zingari -<br />
Fotografie realizzate nel 1958 a Senigallia<br />
in un campo nomadi
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
27<br />
La rappresentazione del desiderio di vivere. Di Danilo Mandolini<br />
(nel ricordo di Giorgio Chinaglia, che proprio in questi giorni ci ha lasciati)<br />
La modalità utilizzata da Alessandro Moscè, nel suo recentissimo Il talento della malattia, per introdurre il<br />
tema della sofferenza, esteso - poi - a quello ben più arduo da rendere della paura della morte, richiama da<br />
vicino il cambio di scena che Michael Cimino mette in atto nel bel mezzo del suo sontuoso ed indimenticabile<br />
Il cacciatore (The Deer Hunter, 1978, tratto dall’omonimo romanzo di E. M. Corder).<br />
Nel film appena citato si passa bruscamente dal matrimonio dei protagonisti, dalla vita tranquilla e ripetitiva<br />
di questi e dal rito della caccia di gruppo al cervo alla guerra in Vietnam, alle atrocità consumate e vissute su<br />
quei campi di battaglia. Allo stesso modo, nel romanzo dello scrittore e critico fabrianese lo scenario muta<br />
repentino, praticamente senza preavviso, dalla narrazione di eventi risalenti all’infanzia e alla preadolescenza,<br />
dal ricordo (ne deriva «…un vivido spaccato sulla provincia italiana e un ritratto dell’Italia dell’epoca.», si<br />
dichiara nel risvolto di copertina), dalla passione sportiva per la squadra della Lazio e per alcuni suoi calciatori<br />
(Giorgio Chinaglia in primis) alle avvisaglie della malattia, ai primi sottesi timori da questa indotti e, nell’arco di<br />
poche pagine, al pudore che si scioglie nella richiesta di aiuto: «Irrompeva un’ultima intrusione del silenzio,<br />
dell’eccitazione vacillante. / - Non ce la faccio a dirlo. / Una barriera diffondeva pietà, una propaggine crudele.<br />
/ - Avanti. Cos’è quella faccia? / - Mamma, ho una ciste sulla pancia.».<br />
Il tono della scrittura cambia, si adegua al nuovo tema del racconto, il ritmo si fa a tratti incalzante portando il<br />
lettore, progressivamente ma inesorabilmente, a vivere dal di dentro tutte le ansie del protagonista: «E se<br />
fossi morto? Come mi sarei accorto di morire, di lasciare tutto? Avevo lampade enormi sopra l’addome e una<br />
luce accecante che emanava calore. Arrivò un’altra dottoressa con gli occhiali bianchi, perlati. Ostentavo<br />
sicurezza, mentre piangevo.». Ora si tratta del lungo e difficile intervento chirurgico, del successivo decorso,<br />
del dolore dei genitori, delle lettere “spaventate” mai spedite ad Anna Rita, delle visite di controllo e dei molti<br />
compagni di ospedale che compongono un freddo e straziante elenco di giovani vite prematuramente<br />
spezzate.<br />
Non si è ancora detto, ma è oltremodo utile svelare che l’“avventura” al centro de Il talento della malattia è<br />
stata vissuta proprio da Alessandro Moscè; è lui che, a soli tredici anni, ha scoperto di essere affetto da una<br />
rara ed implacabile neoplasia denominata Osteosarcoma di Ewing; è lui che ha deciso di incontrare<br />
nuovamente quel periodo della sua vita e di donarlo ai suoi lettori di oggi, insieme alla felicità non
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
28<br />
pronunciata - forse perché inaspettata, benché sperata, al punto di essere fonte di assoluto sbigottimento<br />
essa stessa - della guarigione.<br />
Immaginiamo non sia stato facile ripercorrere le tappe di un calvario che ha visto il nostro divenire un caso (fin<br />
anche negli Stati Uniti) di ritorno miracoloso alla vita senza il male spietato, le infinite e tribolate resistenze<br />
nell’accettare l’idea di raccontare un “io passato” così ingombrante. Sappiamo, anche, delle difficoltà<br />
incontrate nel trovare un editore disposto a sostenere il progetto del libro; un “partner” che fosse in grado di<br />
cogliere e capire, condividendone gli assunti ed oltre la forte componente di commozione che inevitabilmente<br />
sprigiona, come questo lavoro sia, di fatto e soprattutto, la rappresentazione, esaltata dai caratteri diremmo<br />
estremi della storia, del desiderio (anche disperato) di vita che muove il nostro divenire e che è capace di<br />
aiutarci ad annientare anche la più aggressiva delle malattie.<br />
Nel caso dell’esperienza di Alessandro Moscè, però (ed è l’autore a suggerircelo in più di un’occasione), il<br />
desiderio di vivere ha avuto, oltre e chiaramente al sostegno dei propri cari, un preziosissimo alleato nella<br />
guerra contro l’osteosarcoma di Ewing, un irrinunciabile sostegno quotidiano nella palude delle tante nuove<br />
ed estenuanti sfide da affrontare. Quella passione sportiva per la squadra di calcio della Lazio e per il suo<br />
osannato protagonista dell’anno dello scudetto - quel Giorgio Chinaglia di cui si è solo accennato in apertura -<br />
hanno probabilmente svolto il difficile ma indispensabile compito di ancorare il giovanissimo protagonista ad<br />
uno dei pochi elementi sicuramente positivi nella realtà dolorosa di quei giorni di grande prostrazione.<br />
In un flash-back degno della migliore tecnica cinematografica, Giorgio Chinaglia appare sul palcoscenico de Il<br />
talento della malattia durante il ritiro della Lazio a Gubbio, nel luglio del 1984. Chinaglia ed il piccolo<br />
Alessandro si incontrano. Poche semplici parole ancora oggi impresse nella memoria. Semplicemente una<br />
grandissima emozione.<br />
D’altronde, come afferma l’autore: «Lo sport (e noi aggiungiamo: “alla stessa stregua della vita”) si può<br />
raccontare […] con gli occhi di chi si stupisce e incamera i ricordi primordiali, emozioni.».<br />
Il talento della malattia, Alessandro Moscè, Avagliano Editore, Roma, 2012<br />
La scelta dei testi che segue è stata curata da Danilo Mandolini.
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
29<br />
[…]<br />
A scuola ero muto, disinteressato. Non credevo alle preghiere, non avevo religioni, se non quella che mi<br />
riconduceva a un assillo personale. Se Dio c’era, perché non si poteva vedere? Perché non veniva a trovarci in<br />
classe? Lo chiesi ad Angelo, il primo della classe.<br />
- Dio c’è e non si vede perché sta in alto, troppo in alto per noi.<br />
- Ma è sospeso?<br />
- Sì, perché vola, perché guarda tutti da lassù e scende solo qualche volta. A Natale e a Pasqua.<br />
- E a Natale e a Pasqua chi lo vede?<br />
- Non lo so, ma qualcuno lo ha visto, perché nei dipinti della chiese è raffigurato. Ha la barba bianca, ma<br />
senza bastone. Mio nonno lo sognava, ma anche lui non l’ha mai visto.<br />
- E Gesù?<br />
- Gesù è il figlio di Dio, ma è morto giovane. Siede alla destra del padre.<br />
- Con la Madonna?<br />
- No, con lo Spirito Santo.<br />
- E chi è lo Spirito Santo?<br />
- Questo non l’ho capito. Ma secondo me non lo sa neanche suor Melania. Non tutto si può sapere.<br />
- Sarà…<br />
- Non diciamo nulla, altrimenti la suora si arrabbia. Questi discorsi li fanno solo i grandi.<br />
- Ma perché restare muti come pesci?<br />
Un giorno mi decisi a chiederlo appena finita la ricreazione. Alzai la mano e presi la parola tra lo sgomento<br />
della classe.<br />
- Suora, io mi chiedo perché Dio non si fa mai vedere. Vorrei una spiegazione, se possibile.<br />
Suor Melania prima arrossì, dentro quel viso tondo e liscio, poi disse con tono dolce ma deciso, che non si<br />
poteva credere solo alle cose che si vedono.<br />
- Ma Dio fa anche le magie? insistetti.<br />
- Non fa alcuna magia.
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
30<br />
- E chi le fa le magie?<br />
- I ciarlatani. Pensa a pregare, a recitare l’Ave Maria - mi disse spazientita. E capii che non ammetteva più<br />
domande.<br />
Angelo e Chiara ridacchiavano, Luca mi disse che ero stato bravo perché gli sembrava avessi sfidato la<br />
maestra.<br />
[…]<br />
*<br />
[…]<br />
L’ultima volta che sono salito al duomo di San Ciriaco è stato con Marta. Sulla stessa via aveva lo studio il<br />
grande poeta anconetano Franco Scataglini, uno dei maggiori dialettali del secondo Novecento italiano. Ma io,<br />
all’epoca, ero troppo piccolo e non lo potevo sapere.<br />
Ancona, una città di scoglio con la spiaggia del Passetto a costa alta: così veniva descritta nel libro di geografia<br />
delle elementari. Ancona, città che qualcuno sostiene si guardi meglio dal mare che non da altre postazioni<br />
come il Colle dei Cappuccini, il Colle Guasco, la Piana degli Orti. Ancona protesa verso oriente con il<br />
suo odore di catrame, con uno strano clima, con i venti di bora che portano il nevischio in inverno, una<br />
nebbiolina che non si dirada e che è simile a quella della costa romagnola ed emiliana. Una nebbia stirata,<br />
dentro la quale il mare si vede e non si vede. D’estate soffia il libeccio che può far salire la temperatura fino a<br />
40°.<br />
- Lì c’era lo studio di Scataglini - dico a Marta che ha i capelli mossi dal vento e sembra un’aliena.<br />
Mi appoggiavo alla ringhiera. Ancona sembrava Tunisi: i tetti bassi tra i fumi di un tardo pomeriggio e le luci<br />
come punti che si incrociavano tra gli aloni delle lampare. La città era vuota, furtiva.<br />
Ora non mi dice più nulla, non mi suggerisce alcun ricordo, vista da quassù. Eppure in quello spazio davanti<br />
la scalinata del duomo ci correvo con il monopattino. Dietro la facciata del duomo c’era una parete laterale<br />
che sembrava di tufo. Mio padre ci ha inciso le iniziali del suo nome e quelle di mia madre, quando erano<br />
ancora fidanzati, nel ’57. Quelle scritte sono ancora lì.<br />
Arrivò la notte. Ancona non era più la città di Scataglini, né il duomo le dava una cornice classica, né la casa<br />
dei nonni, né i natali, avevano più un senso assoluto. Era Marta con lo spolverino nero che fumava guardando<br />
verso il porto, il mio fulcro. Non riuscivo a farla parlare. Nascondeva un turbamento lieve, come sempre. Ma
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
31<br />
era bella. Alta, slanciata, le calze nere e le scarpe con il tacco. Riesce a essere improvvisamente ironica dopo<br />
un interminabile silenzio. O malinconica e distratta, prima di sprofondare ancora in una coltre di ombrosità.<br />
Quell’essere fantasmatica è il suo fascino inconsapevole.<br />
- Porto Recanati è dall’altra parte, a sud. Andavamo al mare a Porto Recanati, quando ero bambino. Vincenzo,<br />
il bagnino, aveva un moscone bianco con i remi verde acqua che si confondevano con il colore del mare<br />
e delle alghe. Era il 1976, il 1977, durante il mese di luglio.<br />
- Ancora quei due anni. Ancora il 1976 e il 1977. È una fisima la tua. Ogni volta che mi parli escono dal<br />
cilindro i due anni. Gioca i numeri al lotto, vincerai.<br />
- Lo sai che mia nonna aveva un carillon di legno con al centro un tavolino dove ai lati, seduti su delle<br />
panche, stavano dei giocatori di carte le cui teste era nodi sughero? Dando la carica, la ballerina si muoveva al<br />
ritmo di una musica lenta, interminabile.<br />
- Perché non mi abbracci, visto che fa così freddo?<br />
- Non riesco a resistere ai miei gesti infantili, oltre che ai racconti dell’infanzia.<br />
- E quali sarebbero questi gesti irresistibili?<br />
- Eccone uno.<br />
La baciai. Marta si ritrasse e mi sorrise, scosse la testa, l’abbassò appena, timidamente.<br />
- Malinconico come a ottant’anni. Sei più unico che raro.<br />
Al secondo tentativo la sua bocca si unì alla mia. Erano anni che volevo baciare Marta passeggiando per via<br />
Pizzecolli. Mi riuscì al duomo. Scendemmo mano nella mano e mi fermai ancora davanti al palazzo dei nonni.<br />
Guardai in alto, verso la prima finestra, quella della cucina. Nonna Irma si affacciava sempre. La luce era<br />
accesa, fui tentato di suonare.<br />
- Andiamo, andiamo, siamo nel 2008, non più nel 1977 - mi suggerì Marta tirandomi per un braccio.<br />
Mi prese una stretta allo stomaco.<br />
[…]<br />
*<br />
[…]<br />
I bambini sanno tutto, quando presagiscono. Non sanno nulla quando vivono l’abitudine, che è un tempo<br />
smemorato. Ma può succedere che la crescita venga bloccata, che qualcosa non vada per il verso giusto. Al-
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
32<br />
lora i bambini si sentono crudelmente assaliti. Succede che il gatto acchiappa il topo, e la favola di Tom e di<br />
Jerry ha un altro epilogo. Il fumetto o il cartone animato appare insensato, indisponente. Ci si sente divorati e<br />
con la testa all’ingiù. Erano finiti gli esami, ma sotto il lenzuolo, quando ero a letto, non scoprivo la frescura<br />
della notte, il sogno del calciatore. La testa era sul cuscino, le braccia si univano e le mani si incrociavano sul<br />
ventre. L’avrebbero chiamata tumefazione, ma io, semplicemente, sentivo una montagna sotto l’ombelico.<br />
Provavo un sussulto, anche perché il corpo estraneo mi comprimeva e mi costringeva a orinare spesso. Dal<br />
mio stesso fisico nasceva una deriva. Stavolta non era un incontro con la naturalezza della crescita, ma<br />
un’oppressione. Mi svegliavo e mi riaddormentavo. Fino al giorno prima la montagna sulla pancia non c’era. La<br />
toccavo, la spingevo. Dura, gonfia, specie nel mezzo. Ai lati erano le ossa del pube che la fermavano. Aveva<br />
una forma rotonda, come un bombolone, ma non poteva essere piena di crema. Tre settimane prima correvo<br />
e avevo attitudine per la velocità, avevano scritto sulla scheda della scuola dove ero stato promosso sotto la<br />
voce “distinto”. Se ne accorse l’insegnante di educazione fisica, il signor Paolucci. Mi faceva fare le ripetute.<br />
- Sei nato con le fibre a contrazione rapida - diceva elettrizzato.<br />
La forza esplosiva nelle gambe mi aveva introdotto in un reality. Ecco il campione: lo ero anch’io, finalmente.<br />
Il più veloce della scuola, tra i trecento alunni della media “Marco Polo” di Fabriano. In palestra l’insegnante<br />
mi dava i consigli. La velocità è un’attitudine, ma ci volevano allenamenti costanti per migliorarla.<br />
- Chiudi la bocca e stringi i denti - innanzitutto.<br />
- Non è la stessa cosa se apro la bocca? - chiesi con fare impertinente.<br />
- Zitto coglione, e sprinta in linea retta. Devi aumentare la potenza anaerobica. Ogni quattro secondi<br />
accelera.<br />
Se dovevo cambiare direzione, come nella curva dello stadio, mi sbilanciavo.<br />
- Cambio di direzione, cambio di direzione - urlava l’insegnante.<br />
- Come vado?<br />
- Il tempo è buono, ma non magnifico. In linea retta sei bravissimo. Per la velocità ci vogliono i nervi, per la<br />
maratona la calma. Sarai un centometrista.<br />
Il bombolone era cresciuto in una notte, a scuola, forse in pochi minuti. Dove sarei finito? Da una pista<br />
d’atletica a un ospedale?
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
33<br />
Lo strappo non era solo nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Cambiava la voce, che divenne rauca,e il<br />
corpo, con la prima peluria addosso. Le ascelle sudate emanavano una puzza di acido. A un’età critica si<br />
aggiungeva l’imprevisto, arrogante come la voce del signor Paolucci che mi costringeva a fare le ripetute per<br />
un’ora. Entrai a far parte di un disordine che nasceva dentro di me. Non sempre bastava chiudere gli occhi e<br />
pensare ad altro. Mi aggrappavo alla sponda del letto, mi alzavo appena il sole sorgeva. Infilavo le ciabatte e<br />
andavo in bagno. Il bombolone si vedeva a occhio nudo. Orinavo, sperando che l’uscita del liquido sgonfiasse<br />
la pancia. Ma dopo aver finito, dopo aver tirato lo sciacquone, giungeva l’ennesima delusione. Sentivo delle<br />
fitte all’addome, come se non riuscissi più a contenere quell’involucro che diventava sempre più duro. In<br />
punta di piedi camminavo sul pavimento e tornavo a letto avvolto da una vibrazione irregolare.<br />
Un pomeriggio, mentre mio padre e mia madre erano usciti per prendere un po’ d’aria, li spiavo dalla<br />
finestra. Sul marciapiede li vedevo piccoli e sentivo il loro vociare attutito. Lungo il marciapiede diventavano<br />
minuscoli, fino a che scomparivano dietro le fronde di un ippocastano mosso dal vento ombroso. Forse li stavo<br />
perdendo. Tacevo del bombolone sulla pancia, non potevo rattristarli. Dentro casa rimanevano i suoni dello<br />
speaker televisivo come tonfi, mentre lungo il corridoio le pareti sembravano guardarmi all’altezza del ventre.<br />
Non poteva essere la crescita ad aver fatto ingrossare quella strana protuberanza. Vagavo tra la sala e il<br />
soggiorno, toccavo la pancia, ritraevo le mani, come in un vortice senza fine, risucchiato da un mesto timore.<br />
Stavo mentendo ai miei genitori e non dovevo. Li divoravo con gli occhi senza vergogna, ma quando ero sul<br />
punto di confessare che sulla pancia era cresciuta una ciste, rinunciavo, scappavo. Un sottile velo arrossiva le<br />
guance, mi stringeva la gola e serrava le labbra. Le parole venivano annientate, dovevo respirare a pieni<br />
polmoni. Mi riempivo il naso dell’odore della casa, mi scostavo come un gatto dalla cucina, riconoscevo<br />
l’errore e implodevo nella quiete.<br />
[…]<br />
*<br />
[…]<br />
Gennaro, di Napoli, subì l’amputazione della gamba destra. Quando tornò a casa, l’ultima volta, arrotolò il<br />
pantalone dei jeans fin sotto l’anca e lasciò una scarpa nell’armadio.<br />
- Tanto non mi serve più - diceva facendo spallucce e saltellando con le stampelle in mano.<br />
Renzo morì. Aveva il male alla colonna vertebrale. Era grassottello, rosso di capelli. Nel giro di due
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
34<br />
settimane dimagrì e finì per essere asciugato dal sarcoma. Dal bacino l’infezione aveva contaminato<br />
fulmineamente i polmoni. Se ne andò strozzato nell’impossibilità di respirare. Una morte atroce.<br />
Franco era uno sciatore di Udine. Anche a lui avevano amputato una gamba. Ricordo che lo trasferirono a<br />
Budrio per provare una protesi. Lo rividi un mese dopo e camminava speditamente. Se l’amputazione partiva<br />
da sotto il ginocchio, la deambulazione non destava particolari problemi. Se invece il male colpiva il femore, e<br />
l’amputazione partiva da sopra il ginocchio, le protesi non permettevano il piegamento dell’arto e si rimaneva<br />
claudicanti.<br />
Stefania era una ragazza di Foggia, bellissima. Aveva il sarcoma al ginocchio. Subì l’amputazione dell’arto.<br />
Sapemmo che il male era salito al cervello. Visse due mesi.<br />
Manlio faceva l’elettrauto a Peschiera del Garda. Il male dal bacino era passato alle parti molli, alla vescica.<br />
Morì prestissimo.<br />
Serena aveva compromessa una spalla. Non riuscirono a evitare che venisse compromesso anche un<br />
polmone. Morì a novembre.<br />
Andrea giocava nelle giovanili della Virtus Bologna di pallacanestro. Era alto, bello. Subì l’amputazione della<br />
gamba. Il male colpì il cervello. Gli si notava un taglio che divideva la testa in due. Il padre faceva il generale<br />
dell’esercito. Aveva perso la moglie un anno prima. Fece togliere tutti i crocifissi dalle caserme. Non ho più<br />
saputo nulla di lui.<br />
Gianni era marchigiano, di Porto Sant’Elpidio. Tifava per l’Inter. Aveva un osteosarcoma al ginocchio. Non<br />
accettò l’amputazione, si getto dal quarto piano della sua abitazione.<br />
Norberto, trentenne che faceva l’elettricista a Mantova, sapeva di morire. Era convinto che il suo destino<br />
fosse stato imposto.<br />
- Muoio e lascio una figlia che deve ancora nascere.<br />
La moglie era incinta di sei mesi. Il sarcoma era penetrato nella vescica dell’orina, ma Norberto scherzava<br />
con la morte.<br />
- Adieu, et voilà. Il tempo mi ha preso. Arrivederci a tutti. Vado via.<br />
- E dove vai? - chiedevo.<br />
- A morire, e chi se ne frega.<br />
- No - esclamavo seccamente.
VETRINA<br />
Il talento<br />
della<br />
malattia<br />
di<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
35<br />
- Vado, io vado. Time out.<br />
Più di ogni altro mi colpì Sergio, un quindicenne siciliano, di Catania. Aveva dolori persistenti a un’anca. La<br />
tumefazione si era allargata fino alla coscia. La sua gamba gonfia sembrava quella di un lanciatore di<br />
giavellotto. Ma non erano muscoli i suoi, bensì una metastasi che gonfiava l’arto. Sergio era bruciato dalla<br />
febbre. La gamba spesso si scuriva, gli dava prurito. Quando il dolore si acutizzava, stringeva i pugni e<br />
imprecava.<br />
[…]<br />
Ricordo quell’ammasso di carne e ossa sotto il lenzuolo. Sergio giaceva inerte. Ancora la morte in faccia,<br />
dopo quella dell’anziano all’ospedale di Ancona. Ma questa era più vicina, era già arrivata. La morte si faceva<br />
vedere una seconda volta, senza pietà. Sergio dormiva, non si era accorto, non aveva sentito nulla. Ho<br />
respirato la sua morte mentre riposava. Quel lenzuolo sulla testa copriva tutto, ma non toglieva niente. Mi<br />
girai ed ero lì, attonito. Sergio non imprecava più. I suoi piedi sporgevano come una vetta e le sue mani<br />
uscivano dalla sponda del letto. Arrivò un medico, misero un telone sopra un trabiccolo. Sergio era stato<br />
separato dalla madre, dal mondo.<br />
[…]
VETRINA<br />
Alessandro<br />
Moscè<br />
36<br />
È nato ad Ancona nel 1969 e vive a Fabriano.<br />
Ha pubblicato l’antologia di poeti italiani contemporanei<br />
Lirici e visionari (2003); i saggi Luoghi del Novecento (2004)<br />
e Tra due secoli (2007); l’antologia di poeti italiani del<br />
secondo Novecento, tradotta negli Stati Uniti, The new<br />
italian poetry (2006).<br />
Ha dato alle stampe le raccolte poetiche L’odore dei vicoli<br />
(2004) e Stanze all’aperto (2008).<br />
Ha pubblicato il saggio narrato Il viaggiatore residente<br />
(2009).<br />
Si occupa di critica letteraria e di filologia su riviste e<br />
giornali.<br />
Ha ideato e dirige il Premio Nazionale di Narrativa e Poesia<br />
“Città di Fabriano”.<br />
Inserire immagine<br />
copertina libro
Da Io non ho mani che mi accarezzino il volto -<br />
Serie composta tra il 1961 e il 1963<br />
con fotografie realizzate a Senigallia
Marco Ercolani<br />
37<br />
È nato a Genova nel 1954, dove vive e lavora come psichiatra. La scrittura apocrifa e il nodo arte/follia sono le sue<br />
ossessioni dominanti.<br />
Suoi testi sono stati pubblicati in riviste: “Con ciò sia cosa che”, “Nuova Corrente”, “Anterem”, “Pietre”, “Resine”, “Steve”,<br />
“Alfabeta”, “Riga”, “Poesia”, “Il gallo silvestre”, “Ipso Facto”, “LG Argomenti”, “Bloc Notes”, “Il Cobold”, “Istmi”, “Hebenon”,<br />
“Origini”, “La Corte”, “Ciminiera”, “La clessidra”, “Nuova prosa”, “Icaro” e “La mosca di Milano”. In antologie: Poeti in<br />
Liguria (Ipotesi, 1981), Poesia in Liguria (Forum/Quinta generazione, 1985), Viceverso. Antologia di prosa poetica (Corpo 10,<br />
1989); Altramarea. Poesia come cosa viva (Campanotto, 2006). In volumi collettivi: Le trame parallele. Letteratura e arti<br />
visive (Graphos, 1996), Genovantasei (Costa & Nolan, 1996), I popoli del sonno (Caramanica, 2001), Viaggio nelle città<br />
sognate (Neos, 2005), Sotto la superficie (Bocca, 2005), Nuove declinazioni (Joker, 2005); Genovantasei (Costa & Nolan<br />
2006); Convergenze 3. I nomi della trasformazione (Moretti & Vitali, 2006), Dizionario degli scrittori liguri 1861-2007 (De<br />
Ferrari, 2007), Fotografia europea (Damiani, 2008), La poesia e la carne (La Vita Felice, 2008), Convergenze 5. In nome della<br />
Grande Madre (Moretti & Vitali, 2008), AA.VV. Genovainedita 2007-2008 (De Ferrari, 2008), Ali, 5 (Edizioni del Bradipo,<br />
2010), Quaderni di Dedalus, 1 (Puntoacapo, 2011), Camille Claudel: scultore (Nicomp, 2012).<br />
Con Luisella Carretta ha inventato la collezione di arte e scrittura Scriptions ed ha partecipato a vari eventi: “Lettera<br />
d’amore”, “I taccuini”, “Deserto e silenzio”, “Lettere”.<br />
Ha curato un libro di saggi di Paul Klee: Filosofia della creazione (Pirella, 1992).<br />
Ha partecipato a “Milano Poesia” (1984), “Genovantasei - Festival internazionale di poesia” (1996), “Biennale di<br />
Alessandria” XI edizione (2004), “Genova inedita” (2007).<br />
Ha pubblicato il volume collettivo L’arte come evento: tra follia e salute (Graphos, 2002), che raccoglie le relazioni del<br />
convegno omonimo, svoltosi a Genova-S. Olcese nel 2000.<br />
È stato invitato a un’importante manifestazione sull’opera dello scrittore polacco Bruno Schulz [Trieste, novembre 2000gennaio<br />
2001, i cui atti sono nel volume Bruno Schulz: il profeta sommerso, a cura di Pietro Marchesani (Libri Scheiwiller,<br />
2000)].<br />
Suoi saggi sono apparsi per le Edizioni Via del Vento in: Alberto Giacometti, Un personaggio vago, 2005; Bruno Schulz,<br />
L’epoca geniale, 2006.<br />
Ha scritto due plaquettes per Alberto Casiraghy: Io scrivo di notte, con un disegno di Jgor Ravel, Osnago, Edizioni<br />
Pulcinoelefante, 1999, e Superfici, con un frammento di Enzo Fabbrucci, ivi, 2002.<br />
È stato redattore della rivista di cultura psicoanalitica “Fanes” (1989-1991), di “Arca” (1992-1997) e “Arca. Quaderni di<br />
scrittura” (1997-2004): tra le opere pubblicate, inediti di Artaud, Barthes, Beckett, Blok, Bonnefoy, Mallarmé, Šalamov,<br />
Walser.<br />
Ha scritto testi e prefazioni per poeti, critici letterari e artisti visivi contemporanei.
Marco Ercolani<br />
38<br />
Collabora ai siti web: “La dimora del tempo sospeso”, “Zibaldoni”, “Fili d’aquilone”, “Biblioego”, “Doppio zero”, “Poesia<br />
2.0”.<br />
Nel 2010 ha vinto il Premio “Lorenzo Montano” per la prosa inedita con Turno di guardia.<br />
Ha dato alle stampe diversi libri di narrativa, trai quali: Le mani e la follia (Il Torchio, 1979), Studi della paura (ivi, 1982), Col<br />
favore delle tenebre (Coliseum, 1987), Visioni della natura (Corpo 10, 1991), Praga (Ripostes, 1990), Il ritardo della caduta<br />
(ivi, 1990), Taccuini di Blok. 1902-1921 (ivi, 1992), Vite dettate (Liber, 1994), Lezioni di eresia (Graphos, 1996), Sindarusa<br />
(Solfanelli, 1997), Il mese dopo l’ultimo (Graphos, 1999), Carte false (Hestia, 1999), Il demone accanto (L’Obliquo, 2002), Il<br />
tempo di Perseo (Joker, 2004), Taala (Greco & Greco, 2004), Discorso contro la morte (ivi, 2008) e A schermo nero (QuiEdit,<br />
2010).<br />
Per la critica poetica ha pubblicato: Fuoricanto (Campanotto, 2000) e Vertigine e misura (La Vita Felice, 2008); intorno al<br />
nodo arte/follia: L’opera non perfetta (Nicomp, 2010).<br />
Una plaquette di prose e aforismi, Sentinella (Carta bianca, 2011) e un volume di “racconti psichiatrici”, Turno di guardia (Il<br />
Canneto editore, 2011), sono i suoi lavori più recenti.<br />
Con Lucetta Frisa ha scritto L’atelier e altri racconti (Pirella, 1987), Nodi del cuore (Greco & Greco, 2000), Contrappunto<br />
(Lietocolle, 2000), Anime strane (Greco & Greco, 2006; Âmes inquiètes, tr. fr. di Sylvie Durbec, Éditions des états civils,<br />
2011) e Sento le voci (La Vita Felice, 2008; J’entends les voix, tr. fr. di Sylvie Durbec, Éditions des états civils, 2011), e dirige<br />
la collana I libri dell’Arca per le edizioni Joker (fra gli autori tradotti Maurice Blanchot, Alain Borne, Bernard Noël, Dieter<br />
Schlesak).<br />
In versi ha pubblicato Il diritto di essere opachi (La Vita Felice, 2010).<br />
Moltissimi i critici che si sono occupati della sua produzione. Si segnalano, tra questi, Giuseppe Zuccarino e Sandro<br />
Montalto; il primo: per essersi con “insistenza” interessato della sua opera; il secondo: per la vasta ed approfondita<br />
indagine svolta nel saggio Marco Ercolani: il veggente notturno (in Forme concrete della poesia contemporanea, Joker, Novi<br />
Ligure, 2008, pp. 269-274).
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
39<br />
Da Le mani e la follia, 1979<br />
Le mie mani sono perfettamente tese.<br />
Già da un’ora sto guardandole: con le palme rivolte verso il viso, bianche. A volte le sento piegarsi con strappi<br />
fulminei, per un attimo tempo che possano colpirmi: allora le premo rapidamente sulle gambe; resto immobile<br />
uno o due minuti, attendo. Da molti mesi mi inquietano, da quando caddi su di esse senza spezzarle. I primi che<br />
mi soccorsero guardarono con stupore quelle dita magrissime, integre, bianche. Avevo le braccia e le spalle<br />
spaccate, sanguinavo in ogni punto del corpo, ma mi dissero che continuavo a sorridere e a guardare le mie mani,<br />
come fossi caduto in un delirio…<br />
Da Studi della paura, 1982<br />
* * *<br />
Quando la città viene devastata dal vento furibondo e inspiegabile, quando i pali e le antenne sono piegati dalle<br />
sue raffiche senza suono, le porte delle case diventano così sottili che i prigionieri, forzandole, rivelano attraverso<br />
il legno le forme tese dei loro corpi. A volte capita di scambiare con vele lontane, brune nella luce lunare, ombre<br />
di uomini che tentano di fuggire. Nei gesti delle famiglie che raccolgono la valigia e si preparano a lasciare la città<br />
si coglie una straordinaria stanchezza, come se i loro movimenti fossero già velati dall’acqua.<br />
Le campane della chiesa, lontane, oscillano senza mandare un suono.<br />
Dominati da un pensiero sconosciuto, uomini soli percorrono delle vie che i loro corpi sembrano rendere<br />
tristemente marine; il cielo è azzurro come gli abissi nei mattini estivi.<br />
Un uomo, camminando con elasticità sui marciapiedi di cemento, comincia ad abituarsi al pensiero della morte<br />
per acqua quando, sollevando la testa, vede sopra di lui le chiglie delle barche e i corpi che nuotano, mentre le<br />
stelle, velate dal mare, splendono lontane, irraggiungibili. Guarda a lungo, poi si trova, stordito, sulla terraferma.<br />
«Respira profondamente - sussurra un bambino - finché l’aria è intorno a noi».<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
40<br />
Da Visioni della natura, 1990<br />
[…] Se ho dipinto la stanza di Arles, Theo, lo devo a te. Guardala: è gialla. È lì che vivo. Non condivi la mia<br />
inquietudine, la sensazione che da qui emerga qualcosa di strano? Eppure tutto è a posto: la caraffa d’acqua, il<br />
libro, il cappello, l’asciugamano appeso. Solo i colori troppo vivi - il blu, il giallo, il verde - insinuano il sospetto di<br />
una passione sgretolata, di un’emozione incontrollabile. Guarda bene, a destra. Vedi le piccole tele appese al<br />
muro dipinto? Appaiono protese verso il letto, piegate contro il punto sul quale, di solito, appoggio la testa per<br />
dormire. È impossibile guardare la parete e resistere alla paura […]. Stretta da forze naturali che la corrugano, la<br />
stanza è chiusa in una morsa, pronta a spaccarsi. Guarda il pavimento - non lo trovi in leggera salita? Quando<br />
sono premute, le cose si allungano e si deformano; quando la pressione cala, i contorni si rifanno normali e la<br />
deformità sparisce […]. Io, Théo, dormo in un luogo dove dormire è impossibile. Da un momento all’altro uno dei<br />
quadri appesi potrebbe cadere e il muro curvarsi di più, toccarmi la mano, la spalla, la guancia - crollare con un<br />
boato…<br />
Vincent<br />
Da Praga, 1990<br />
* * *<br />
Con corpi eleganti e sorrisi compiaciuti mi avete ascoltato senza capire. Udendo poesie che dovevano bruciare le<br />
vostre orecchie e stravolgere le vostre vite, avete osato applaudirmi senza fervore e senza ironia. E ora, spogliata<br />
la parola del suo potere, vi apprestate a uscire da questa sala per tornare nella vostra casa; dove, accaldati e<br />
commossi, dopo una cena abbondante e la consueta scopata, vi addormenterete deponendo la nuca sullo stesso<br />
punto del cuscino, sereni.<br />
Mi fate ribrezzo.<br />
Ma oggi vi sorprenderò.<br />
Forse non ve ne siete accorti, ma, mentre declamavo Ouvalu Klinu, Praga è cambiata. Non mi credete? Scuotete la<br />
testa e ridete?<br />
Eppure io non ho l’intenzione di scherzare.<br />
Guardate fuori. Guardate attentamente.
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
41<br />
Ognuno di voi, uscendo di qui, vedrà cose diverse. Chi piazza Venceslao affondata nella nebbia. Chi il Ponte Carlo<br />
ostruito dalla carcassa di un cavallo assiderato. Chi confonderà la Drevna alla Bozdechòva, la Vlasska alla Zelezna:<br />
le vie sono mescolate, irriconoscibili. Chi udrà colpi sordi, chi tonfi di vanghe, chi violini stridenti.<br />
«E la bocca socchiusa dove luccicano i denti» - ricordate i versi di Màcha? La mia parola, che credevate innocua,<br />
ha fuso vicoli e tetti. Le fondamenta si sono abbassate. Il fiume si è spostato a sinistra. Mentre vi raccontavo che<br />
Màcha cancellò e riscrisse Maggio sette volte, Praga si trasformava settantasette volte.<br />
Non potrete, luridi porci, riprendere la vita di tutti i giorni. Sarete costretti ad adattarvi a piazze ignote, a entrare<br />
in case che non c’erano prima, a vedere università chiese taverne ospedali dove non siete mai stati. Urlerete,<br />
finalmente. Annientati dallo stupore, urlerete. E tornerete qui, nella sala, costernati e furiosi, pretendendo che io<br />
vi restituisca la vecchia realtà - che spazzi via, per voi, questa sgradevole confusione.<br />
Ma io non sarò più qui.<br />
Dovrete arrangiarvi senza di me.<br />
In una sala vuota - senza tavoli né libri né sedie.<br />
Forse - chissà - non era Màcha il poeta che avete ascoltato. Io non l’ho mai letto. La mia voce, vegliando la<br />
metamorfosi di Praga, aveva intonato - non ricordate? - l’ultima terzina dell’Inferno.<br />
Da Il ritardo della caduta, 1990<br />
* * *<br />
[…] La poesia ruota attorno a questo nodo che è fuori dalla parola: immagine non verbale ma sonora, in parte<br />
visiva, segreta alla parola. La poesia è il segno visibile della miniera di suoni e visioni dove la lingua scava e taglia,<br />
inventando prospettive. La poesia è riferire in forme adeguate questa prima forma cin cui la lingua entra sempre<br />
in contatto, per la prima e l’ultima volta. La poesia è il pathos del fuori di sé, la ricerca del non-nato, dell’altro da<br />
noi. La lucida demenza del sonnambulo. Volare attorno a ciò che non avremo, al segno-nulla di cui non siamo né<br />
custodi né garanti. E in questo folle volo trascrivere, testimoni adeguati e non virtuosi semantici. Le parole sono lo<br />
strumento di questa intensità iniziale, di questa consapevole appropriatezza. Bisogna cercare la prossimità che ci<br />
appartiene. È questa la maturità per cui siamo nati […].<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
42<br />
Da Taccuini di Blok. 1902-1921, 1992<br />
Noi non abbiamo ascoltato Petrarca ma il vento nella steppa: la musica della nostra steppa crudele è echeggiata<br />
all’orecchio di Gogol’, Tolstoi, Dostoevski. È questo turbine che testimoniamo.<br />
Troppo facile, l’immagine. Gli occhi possono tradire, la scena ingannare. Ciò che non tradisce è l’udito, la forma<br />
che l’urlo assume nell’orecchio, nella testa, nella cavità dove è costretto a rimbombare. Il bambino che grida,<br />
l’adulto che grida, è qui dentro le tempie.<br />
Come tutti i grandi eventi la rivoluzione accentua il buio. Ma è giusto che accada così? Che la notte sia ancora più<br />
notte nel momento in cui la libertà esigerebbe una forma?<br />
Un colpo. La porta che sbatte. Un grido.<br />
Neve e vento. Salute pietosa.<br />
Pietroburgo è stretta nella morsa di un gelo polare. Non faceva così freddo da oltre vent’anni. Il pane è gelato, la<br />
verdura immangiabile. Tutti hanno fame, io no. Per me è tutto molto lontano, come se vedessi dalla cima di un<br />
campanile ciò che è accaduto e accadrà: la rivoluzione e l’occupazione del Palazzo, la sazietà e la fame, il crollo<br />
dello zar e i colori della folla. Non mi riconosco in questo corpo e nello squallido domicilio che occupa. Non mi<br />
vedo nella carne sofferente che è affidata alle cure di Ljuba. Sorrido del guscio nel quale mi sveglio, ogni giorno,<br />
con accresciuto stupore. Io sono altrove.<br />
Appunti di un romanzo, sussulti di frasi, si chiamano, mi chiamano, come tessere di un mosaico impossibile,<br />
tracce di una trama afferrata per allusioni. Ho in mente un libro-frammento, nella circolarità di una visione che<br />
intuisco completa. Ma è un libro dove vorrei andare non come si entra in una stanza chiusa, in una circonferenza<br />
magica, ma come si penetra in un corpo infelice, nodo di passioni e foresta di immagini.<br />
L’essere intatti è una qualità del vuoto che non appartiene alla nostra natura terrena. In un istante noi siamo<br />
sporcati, toccati, coinvolti, e solo il sonno, quando cessano di esistere sbarre, labirinti, progetti, ci restituisce la<br />
divina possibilità della fuga.<br />
Per ora sono invisibile a Pietroburgo. Conto di apparire domani.<br />
…e ti scrivo su un pezzetto di carta sbilenco, di notte e nella grigia nebbia.
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
43<br />
Da Vite dettate, 1994<br />
La febbre e il limite<br />
* * *<br />
Lezione inedita di Ingeborg Bachmann in difesa della scrittura apocrifa, 1960.<br />
Signore e signori,<br />
sono qui a parlarvi della scrittura. Non di commemorazioni, convegni, centenari, bicentenari, genetliaci,<br />
riscoperte postume, ma della scrittura. E allora comincerò a dirvi la verità: ogni scrittura è apocrifa. Ogni scrittore,<br />
in quanti opera nel segreto del suo spirito, è apokryphos, cioè segreto, e il suo apprendistato si esercita con una<br />
lingua scritta e consumata nei secoli da altri scrittori, vissuti prima di lui alla ricerca della loro anima. Che cosa<br />
significa tutto questo? Che lo scrittore, proprio perché autentico, si abbevera alla fonte a cui altri hanno già<br />
bevuto. Non vi sembra contraddittorio? Una sincerità dell’anima che si basa su una forma di vampirismo. A me<br />
sembra splendido. Dirò di più, inevitabile.<br />
La scrittura, quando si sgombra dei prodotti letterari, diventa quello che deve essere: un’etica del pensiero, una<br />
direzione del sentire, una forza che ci stringe lì, nel regno delle parole, a sperimentare, in modo scandaloso,<br />
l’inadeguatezza dei nostri strumenti. Ma ognuno canta con la sua voce, indossa la sua maschera, cammina con il<br />
suo passo. Ed è osando il proprio tono e non un altro, preso a prestito dalle tradizioni della letteratura, che la<br />
scrittura smette di essere inoffensiva e diventa energia pulsante e trasgressiva, diagramma spezzato di una<br />
febbre.<br />
[…] Ciò che in arte noi chiamiamo perfezione non fa che rimettere in moto ciò che perfetto non è. Una volta<br />
spenti i riflettori e ogni altra forma di illuminazione, la letteratura, lasciata in pace e al buio, risplende di luce<br />
propria, e le sue creature vere, commuovendoci ancora oggi, emanano bagliori. Le opere sono punti morti e punti<br />
di luce, frammenti in cui si avvera la speranza nella lingua intera che dirà i mutamenti dell’uomo e i mutamenti<br />
del mondo: questa lingua, questa koiné dell’arte nei secoli, è il frammento di confessione che non smette di<br />
agitare la lingua del morente per l’ultimo sospiro. E il morente è l’esegeta, il traduttore, il posseduto, il<br />
camaleonte di questo sospiro: abbandonato dai destini che lo avevano invaso, tace e torna a vegliare, in attesa<br />
che l’aria vibri ancora e torni questione di vita o di morte trascrivere voci…<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
44<br />
Da Lezioni di eresia, 1996<br />
Un caso clinico<br />
Lettera di Roberto Bazlen a Eugenio Montale (ottobre 60)<br />
Caro Eusebio,<br />
capisco che è ineducato scriverti, dopo tanti anni, e non per segnalare la geniale opera di Svevo o l’intollerabile poesia di<br />
Saba, ma sei l’unico amico a cui possa rivolgere questa singolare preghiera: scrivi un articolo, un saggio, un pezzo come vuoi<br />
- ormai sei celebre tutti ti ascoltano - e intima il silenzio su di me.<br />
Il sipario comincia appena ad aprirsi, ma già si discute troppo della mia persona e dei miei gusti. Si vocifera di quaderni,<br />
taccuini, romanzi, che terrei segreti. In parecchi fanno assurde fantasie sulla mia scrittura, di cui sorriderebbe lo stesso<br />
Freud. Se potessero, sognerebbero la mia opera omnia. E ne conosco, di imbecilli, che ricavano, da una mezza frase, da una<br />
mediocre letteruccia, un caso clinico, e frugano nelle carte alla ricerca di chissà quali tesori nascosti.<br />
Non lasciare che frughino, Eusebius. È un fatto di sciacallaggine: come si strappano i denti d’oro ai morti, così ai presunti<br />
scrittori… Non lasciare che si cerchi niente, visto che non c’è niente da trovare: ma si sa, se cercano in tanti finisce che<br />
qualche conto della lavandaia venie fuori, qualche mucchio di fregnacce che possono solo disonorarmi.<br />
Fra poco non sarò più vivo e non potrò oppormi alla stupidità degli altri. Cosa posso fare per essere difeso, se non scrivere<br />
ai vecchi amici?<br />
Proteggimi dalla letteratura, tu che sei sufficientemente cinico per farlo. Le tue quattro poesie poco angeliche e poco<br />
italiane le hai consegnate al mondo. Fa’ che io consegni il mio silenzio. Persuadili a lasciarmi in pace, a tenermi fuori. Fammi<br />
restare nascosto fino all’ultimo, Eusebius.<br />
Io sono un lettore. Uno che, nel treno, con la febbre a quaranta, legge il racconto di un persiano visionario, uno che giudica<br />
Musil e manda a quel paese Bataille e Blanchot. Una razza rara, incomprensibile - tipo quel contadino che si mette a<br />
guardare i raccolti e se ne infischia della semina.<br />
Fermali comunque, Leggo, fumo, vedo, film. Cuscini e poltrone mi conoscono meglio degli uomini. Cos’ho fatto di male per<br />
meritarmi che ficchino la loro lente sui mie i quaderni di scuola? Non voglio essere niente, neppure un caso. Non c’è un caso<br />
Bazlen, altrimenti non esisterei. Possibile che in questo paese non si riesca a leggere un libro in santa pace?<br />
«Poiché so, non dico».<br />
Tao?<br />
Tuo Bobi Bazlen<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
45<br />
Da Il mese dopo l’ultimo, 1999<br />
Drohobycz, 5 luglio 1940<br />
Cara Romana,<br />
lo sai da tempo: il mio stile si compone di immagini. Ma sono immagini che dissolvono la materia del reale. La mia arte usa<br />
le visioni per tendere a un'etica della mente. Quale? Mi chiederai tu. E qui mi ingarbuglio. Sto zitto, come non rispondo a<br />
chi mi chiede cosa provo quando ho visioni. Io non provo nulla: io vivo in uno stato di visione. Qualcuno mi disse, un giorno,<br />
che la mia scrittura è arborescente e acquitrinosa, come una vegetazione colma di putrefazioni e di rinascite. Chissà. Io ho<br />
sempre la sensazione di semplificare, di chiarire: non mi sento così torbido. Sono un uomo ingenuo e credo che le frasi più<br />
limpide siano sempre quelle che gelino il sangue.<br />
Ogni cosa, essere, pianta, oggetto, possiede la sua voce, e questa voce ha un ritmo in cui dirsi, un'energia sonora che ne<br />
determina la potenza magica. Se per noi la parola è solo l'atto che nomina le cose, per un poeta è il ritmo, l'inno, la danza -<br />
che permette alle cose di essere come sono. Quando questa parola non esiste più, resta solo il senso comune - un guscio<br />
vuoto, un fossile. Tu lo sai quanto detesto i significati della logica, la maturità del mondo adulto: per me tutto è suono e<br />
canto, come all'inizio.<br />
La mia voce circuisce il cielo, ma non si perde in esso: al contrario, vuole riferire la vertigine delle lontananze in cui si<br />
smarrisce. È come abitare i confini dello stesso suono, i segni della stessa nota. La musica non cambia melodia ma timbro. E<br />
il timbro è quel lampo che, prima o dopo, la scrittura addensa in parole. Ma sono oggetti reali, le parole, o nebbia da cui il<br />
lampo trapela con un chiarore diverso? Io mi sento reale solo quando sono il fantasma che le mie parole guidano chissà<br />
dove; e scrivo, lasciando sempre troppo spazio fra la prima frase e il margine sinistro del foglio. Qual è il mio vero<br />
desiderio? Che la parola scritta fermi l'emozione di una voce? che la sintassi diventi la sostanza di quella voce e sconfigga la<br />
morte a cui tutti i suoni del mondo - comprese le mie parole - sono condannati?<br />
Non posso aderire a questo sogno di immortalità. È troppo grande la sofferenza di reggerlo. Quando il mio corpo cesserà di<br />
esistere, l'aria tornerà a occupare lo spazio che occupava, e della mia vita resterà meno di un ricordo, un'eco che le parole<br />
restituiranno appena. Ogni soffio sgretola, da sempre, le scritture più sacre. È questo soffio, l'evento. Lui mi tiene in vita, mi<br />
chiede di star bene. E io cerco di star bene, cioè, di scrivere. Penso, da tempo, di raccontare una storia che riguardi il<br />
Messia.<br />
* * *<br />
Tuo Bruno
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
46<br />
Da Carte false, 1999<br />
Il buco nella terra<br />
Da una lettera di Gustave Courbet (1876).<br />
[…]<br />
Mi hanno rimproverato per quella grande zona nera, al centro della tela. Ne sono stati sconvolti. Ma perché?<br />
Quello è il quadro di un funerale, e chi circonda il corpo sono i volti dei familiari. Perché tanto stupore? Io,<br />
comunemente, metto scuro su scuro. Addenso e dipingo tutto come se tutto fosse pietra e bosco. Faccio<br />
pensare anche le pietre. Solo quando stendo un colore meno scuro, questo significa luce, perché la luce è<br />
solo un grado in meno dell’ombra. Millet ha lavorato nei campi e nelle rocce come me, ma ha fallito. I suoi<br />
grandi schizzi di contadini sono patetici superficiali: nei suoi quadri c’è sempre un orizzonte. Millet fa il<br />
pittore che rappresenta da lontano, non si immerge dentro le cose. Io ho vissuto nelle montagne del Giura e<br />
non ho mai saputo cosa fosse l’orizzonte. Sono cresciuto nel fitto dei crepacci e dei rovi. Non conosco il mare,<br />
non sono elegante, ho letto pochissimi libri. Ma dipingo tutto: esserti e cose. E gli esseri sono anche le cose.<br />
Quando inizio un uomo, una pietra, un bosco, una catasta di legna, comincio sempre nello stesso modo,<br />
senza sapere cosa sto facendo, andando avanti colore per colore, alla cieca. Quando, l’altro giorno, mi sono<br />
ritratto in compagnia del cane, ho dipinto il mantello scuro, il copricapo, il corpo dell’animale, con un masso<br />
nello sfondo; il volto e la mani erano dipinte dello stesso colore della pietra.<br />
Io sono così. E tutti sanno che Courbet non cambierà. Perché allora di stupiscono, se in questa tela lunga<br />
ventun metri, io raffiguro esattamente al centro la fossa nera dove seppelliranno il cadavere che stanno<br />
piangendo? O dovevo esprimere il compianto funebre come una bella parata di corpi addolorati da i quali<br />
cancellare il problema - il buco nella terra, il corpo che si corrompe? Nessuno vuole capirmi. Vadano a farsi<br />
fottere. Io dipingerò esattamente quello che sento e quello che vedo. E se per questo sarò arrestato o<br />
frainteso, facciano pure: patirò la prigione e il disprezzo ancora una volta.<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
47<br />
Da Il demone accanto, 2002<br />
10,5<br />
Sopra piazza Sarzano<br />
Sopra piazza Sarzano, oltre lo stradone di S. Agostino, vedi la parete, intatta, di una casa crollata. Davanti c’è<br />
una piccola scala, con il suo passamano di ferro. Per qualche misterioso effetto dei bombardamenti, delle<br />
devastazioni edilizie o del caso, la ringhiera termina dentro la pietra. Si infila nel muro con grande<br />
naturalezza, il muro è la sua meta necessaria. Senti, salendo i gradini coperti di polvere, che cammini dentro<br />
una casa fantasma, fra sale invisibili, alla ricerca del tuo sosia. Non lo trovi, lo cerchi, sali ancora. Entri nella<br />
pietra. Guardi Genova. Città, per te, di puro nulla. Vuoto che non consola, vuoto di nuvole, lampi, ombre,<br />
salite, venti, riflessi. Orizzonte discontinuo, che può cullare come inabissare. Lì, dentro la pietra, ci sei tu. Ma<br />
non tranquillamente. Il paesaggio non è mai dolce e curvo, armonioso come una casa. È proteso, in bilico,<br />
pronto a balzarti addosso, a franarti fra le dita. Guardi nella pietra. Guardi nel mare. Due fulminee epifanie e<br />
ti afferra la bellezza, hai il tempo di parlare solo per pochi istanti, come un condannato. Chiuso in una parete<br />
circondata d'aria, la parola che balbetti è precaria, sfuggente, rischiosa.<br />
Genova ti assomiglia. È questa parola, questa parete - esposta, vertiginosa, segreta. Fondale, prospettiva,<br />
prigione, torre, prua. Hai due alternative: tacere, chiuso dentro la pietra, o viaggiare su e giù, ricordando la<br />
nicchia che ti protegge le spalle. O silenzio o visione. Dove si possono avere più visioni? nelle città visitate da<br />
apparizioni diaboliche e spettri ammalianti, oppure qui, in un luogo più scontroso e meno segreto - qui, nella<br />
parete che ti ospita, muro di chiesa romanica, fortezza di carcere, porta di tugurio, portale di palazzo? In libri<br />
dimenticati hai scritto di Praga e di Pietroburgo, città poetiche e assolute, che hai ricreato con immagini nate<br />
da antiche leggende. Ma, se fossi vissuto a Praga o a Pietroburgo, avresti potuto parlarne o non saresti stato<br />
soffocato da quelle stesse leggende, la lingua mozzata dalla mancanza di distanza?<br />
Qui, chiuso nella roccia, sei più libero. Le notti, a Genova, non sono bianche, come a Pietroburgo, o favolose,<br />
come a Praga. Le notti genovesi sono mediocri. L'aria è bassa, umida. Non consola. Per chi vive in una parete<br />
sono ancora più cupe. Ma puoi voltarti. Ti giri avanti, ti giri indietro. Genova nega ogni paradiso: non ti puoi<br />
illudere di volare alto, come in certi luoghi dove rocce gialle di ginestre si librano contro abissi celesti. Genova<br />
è sconnessa come questo muro. Ma sulla pietra del muro batte l'aria salata, lo scirocco, il vento notturno. Un<br />
prigioniero, queste cose le avverte. In certe notti vivi una concentrazione che non potresti concepire in altri<br />
luoghi, un'astratta passione della mente che esalta le ossessioni più intime. Dalla pietra tu guardi: traversi le
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
48<br />
cose, erodi la materia, assorbi i colori. Vivi a Genova come il nomade che all'improvviso è diventato statua di<br />
pietra e, da pietra, canta l’impossibilità di continuare il suo viaggio. Una volta ti dissero: siamo tutti più<br />
trasparenti dopo l'esperienza sofferta, ma perché dobbiamo pagare un prezzo così alto per ottenere la<br />
leggerezza? Il tuo prezzo è la nicchia nel muro: leggera e instabile, la parete ti chiude dentro di sé ma ti<br />
permette di salire e scendere la scala impossibile per migliaia di volte. Le città sono psicotiche o nevrotiche:<br />
ad esempio, Siena è psicotica, segreta, curva, tortuosa, labirintica, ostile agli intrusi, chiusa nel suo ordine<br />
malioso e avvolgente, con quell'unico centro che risucchia come un vortice; Palermo è nevrotica, orizzontale,<br />
discontinua, frammentaria, visibile, rumorosa, silenziosa, monumentale.<br />
Ma Genova? Da questa postazione privilegiata - prigioniero del muro - la vivi come una città border-line,<br />
sospesa fra psicosi e nevrosi. Città gelosa, fortificata nelle sue difese, intima ma non inaccessibile, aperta al<br />
mare, aspra, ambigua, sonora, rischiosa. Città adatta ai nomadi e agli ossessivi. Nicchia per poeti, dove stare<br />
dentro pareti a sognare, ma pareti circondate dall'aria, che non formano una stanza chiusa ma un luogo<br />
forato dei venti. Città per chi cerca un'idea da nutrire in segreto, fingendo di essere solo. Ma i prigionieri delle<br />
pareti sanno che le pareti ospitano una moltitudine di vivi e di morti, che pensa e ripensa lo stesso sogno.<br />
Folle silenziose, ricordando la vita e presentendo la morte, regnano dentro i muri. All'alba e al tramonto,<br />
nella scala e nel muro, ospiti e abitanti, senza parlarsi, lasciano tracce nell'aria, simili a voci.<br />
Sempre lo stesso suono<br />
Sempre lo stesso suono, acuto e puerile. Quasi che annunci qualcuno. Ma chi doveva salire è già salito. Sono<br />
io. Ti ascolto, ti tengo stretto. Ti sento muovere e parlare, nel sonno, finché vado via. So quando resti solo.<br />
Un sibilo lieve, qualche luce dalla strada, un terrazzo che brucia. Ecco i segni. Non mi vedi più.<br />
Ma ogni volta ritorno. In autobus, quando esci, i ragazzi ti respirano addosso; ti sbriciolano il pane sui calzoni.<br />
Ho pietà di te. Chiacchierano, gridano, esistono. Un essere dagli occhi vuoti sfoglia il giornale. Ti rendi conto.<br />
Devi tornare a casa. Devi dormire. Senza di me le voci sono prevedibili, sono di tutti e di nessuno, sono una<br />
folla neutra che non odora di nulla, una folla anonima e consenziente, una massa senza ombre.<br />
L'aroma del caffè. Io lo sento con te. Io: i tuoi sensi, la tua lingua. Non puoi che berlo con me - è nero,<br />
profumato, caldo. Il caffè: le tenebre. Notte dopo notte sollevi la mano, ti tocchi il viso, ricomponi i lineamenti<br />
devastati dal giorno. Approfitti del buio per questa opera di pietà, che il giorno non ti consente, che io ti<br />
impongo. Stupendo nome Subrahmanian Chandrasekhar - lo leggi, in qualche libro, come una rivelazione. È il
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
49<br />
nome di un fisico indiano - Dio che ha la luna sulla testa. Sorseggi Veuve Cliquot, Johnny Depp agita le forbici<br />
delle sue mani. E se il nero calasse sullo schermo? Se non potessi più vedere quel film, nessun film? Fantasmi<br />
di scrittura, sogni di malati, taccuini fantastici. E ancora fantasmi e sempre sogni. Andrà in fiamme il roveto?<br />
Bruceranno le tende? Crollerà il soffitto?<br />
Praga, Pietroburgo, Genova. Come se esistesse una sola città, in qualsiasi parte del mondo. Un corpo, ma<br />
quale corpo? Un corpo fatto di appunti, di parole; un corpo che perde sudore, sperma, lacrime, sangue, e<br />
trasforma tutto in frasi... Fissi la casa vuota, gli occhi incantati dalla brace della sigaretta. La città brucia,<br />
manda fumo. C'è fumo ovunque, nelle strade, nelle scale, nelle chiese. Niente aria, solo soffi deboli, quasi<br />
inconsistenti, che non salgono e non scendono. Il cielo è basso.<br />
Notte dopo notte, sono con te. Salgo, gradino dopo gradino. Apro la porta. Mi siedo davanti a te. Ti siedi<br />
davanti a me. Mi guardi. Hai un foglio sotto le mani, di cui accarezzi il bordo superiore. I tuoi occhi vedono le<br />
mie visioni, il tuo cervello pensa i miei pensieri. Ti distingue solo quel tremito lieve, nella mano destra. Ansia<br />
umana, che ignoro. La mia è ferma, buia, e scrive con dita perfettamente uguali alle tue.<br />
Ti svegli e, nel torpore del sonno<br />
Ti svegli e, nel torpore del sonno, annoti quanto ti è stato svelato dalla notte. Ti sembra una rivelazione<br />
magnifica, un messaggio particolare, destinato a te solo, come le visioni agli eletti. Ti riaddormenti con un<br />
senso di beatitudine. Poi, al mattino dopo, con ansia, trattenendo il respiro, abbassi lo sguardo. Sul foglio è<br />
scritto, con caratteri fermi e chiari: «Io sono vivo». Ne sei stupito? Perché? Cerchi di salvarti con la scrittura.<br />
La carta ha viso, spalle, ventre, piedi: come un corpo umano. Non si può smettere di abitarla. Pensi che sia<br />
impossibile restare qui. Muovi gli occhi, le mani, cerchi di essere in un luogo diverso. Ma qui abito io. Vorresti<br />
dormire, per non udirmi. Ma i colpi che affondano sul cuscino quando dormi, ti convincono che non è facile<br />
restare sereni, gli occhi immobili sotto le palpebre chiuse, le mani tranquille sotto le lenzuola. Così, se sei<br />
sveglio, scrivi. Sorrido quando ti vedo curvo sulla carta, attento alla composizione di un libro. Povero illuso.<br />
Cerchi luce, armonia, quiete. Eccola, la luce: è dentro lo specchio. Guardati. Ma, mentre ti guarderai, la mano<br />
traccerà segni incomprensibili sul foglio. Solo se fisserai me, la scrittura nascerà. Quella scrittura che cerchi.<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
50<br />
Da Il tempo di Perseo, 2004<br />
10,5<br />
Talvolta, se la terra del sentiero è intatta, si accanisce, contro ogni prova di realtà, a inventare orme, sapendo che un<br />
giorno alla sua fantasia che un omicida si aggiri nel bosco risponderanno i piedi reali dell’assassino, calcati in quelle<br />
orme come guanti nelle dita.<br />
Ogni follia è un privato schema di verità a cui non si possono opporre alternative. Supporre un’analogia tra allucinazioni<br />
e immagini in libertà è ingenuo. Non è la libertà di immaginare che caratterizza il delirio ma tumori di immagini, che<br />
occupano spazio nella mente.<br />
L’esistenza umana si fonda sul bisogno di un forma plastica, vivente: nel momento della patologia o domina un rituale<br />
ossessivo, che irrigidisce, o un’idea delirante, che ne frantuma i confini.<br />
Un tempo voleva, con lo strumento della lingua, sperimentare le macerie del mondo. Poi capì che non aveva senso<br />
aggiungere violenza a violenza, che smembrare il tessuto fonetico per definire lo scempio di un corpo non era scandalo<br />
ma illustrazione. Allora comprese che ogni distruzione corrispondeva sempre, nel pensiero, una possibile ricreazione -<br />
parallela, obliqua, diversa.<br />
Come una gomma, la fantasia cancella il sogno precedente e aggiunge quello successivo. L’universo diventa di creta, di<br />
cera, si trasforma in un gioco che le dita possono plasmare, cambiare, distruggere. Ma la straordinaria leggerezza del<br />
gioco frana nel momento in cui una realtà inamovibile ci mette con le spalle al muro; e allora, delusi dalla nostra<br />
impotenza, desideriamo la morte. Non possiamo sostituire l’amico scomparso con un fantasma; né ricostruire libri e<br />
manoscritti che il fuoco ha incenerito; né reinventare le carezze che durante la notte ci facevano rabbrividire. Per cui, o<br />
cominciamo a vivere partendo da quelle macerie o ci togliamo la vita.<br />
Da Taala, 2004<br />
* * *<br />
Che cos'era Taala? È questo che mi chiedi? Era una città di cristallo e di pietra, di titanio e d'acciaio, fatta di leghe<br />
leggere, impensabili, mobili, sempre sul punto di slacciarsi, di vacillare, di afflosciarsi al suolo o di salire in volo,<br />
ondeggiare, farsi portar via dal vento. I muri delle case hanno angoli curvi. Non c'è riparo, a Taala, non un muro che<br />
difenda, una linea verticale, nessuna intimità. Tutto è scollato, aperto, eppure resta in piedi... La pietra, di notte, è un<br />
rifugio caldo. Ma, di giorno, è fredda, è uno specchio che paralizza... Qui cosa c'è? Delle sbarre? Una cella? Un ospedale?<br />
Ma se sapessi quante volte la città ci ha mostrato le facce più strane! Non è certo oggi la prima volta. Ricordo un
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
51<br />
carcere, un collegio, un posto di blocco, una caserma, dei templi, delle tende. Cosa vuoi che sia, adesso, questo misero<br />
ospedale e la tua faccia attonita? Meno di un cerchio di fumo. Forse sono sempre a Taala.<br />
A domani. Ma posso proprio dirti: a domani?<br />
Vuoi la verità, d'accordo. Eccola, in una riga. Sono venuti e hanno occupato la città. Non ho parole per descrivere la<br />
crudeltà con cui ci hanno seviziato e la meticolosità con cui hanno raso al suolo le case. Forse tu conosci un'altra<br />
versione dei fatti; forse tu credi che ci abbiano trovato per caso, mentre vagabondavamo nel deserto. Se è così, smetti di<br />
credere alle menzogne dei tuoi capi. D'altronde, non tutto il male vien per nuocere. Senza il loro drastico e definitivo<br />
intervento Taala sarebbe rimasta solo una città fantastica che, all'alba di ogni nuovo giorno, con regole sempre nuove,<br />
in un silenzio perfetto, avrebbe mutato forma alle case, volti agli abitanti, direzione alle strade, come un colore sfuma<br />
nell'ombra o un'ombra nel colore. Ma per fortuna sono arrivati loro: i tuoi amici, la tua specie. Hanno fatto scorrere il<br />
nostro sangue e il sogno è finito. Non c'è niente di virtuale, in tanti corpi massacrati. Noi, che siamo sopravvissuti,<br />
ringraziamo i nostri oppressori per la verità che siamo stati costretti a vedere.<br />
La cosa più sorprendente è che nessuno, adesso, a Taala, ricorda nulla di nulla. Loro potrebbero tornare, riassediare la<br />
città e ucciderci di nuovo. Ma quelli che la abitano ancora non hanno imparato niente: se ne vanno per le strade con la<br />
testa in aria e non pensano, non ricordano. Addirittura, continuano a vivere e dimenticano che loro sono stati là e li<br />
hanno depredati e ammazzati; dimenticano persino, con imbarazzante amnesia, di essere morti. No, non sono matto.<br />
Laggiù succede qualcosa di disgustoso e di ingiusto. Questa è la pura verità. Credi a un uomo che è vissuto per un tempo<br />
molto più lungo della vita media di un uomo. Credi a chi ha visto le comete apparire allo sguardo come massi opachi e le<br />
farfalle verdi assediare in pozzi scuri uomini giganteschi, incapaci di difendersi. Credi a chi ha visto i leoni addormentarsi<br />
e trasformarsi, da solenni animali del deserto, in mosche ronzanti.<br />
Già diversi anni fa, al calare della notte, i più anziani di noi cominciarono a parlare di assedi, di nemici, di date. Ci<br />
indicavano i momenti in cui si sarebbe alzata la polvere dal deserto. E noi, che non ci aspettavamo niente di minaccioso<br />
ma che credevamo alla loro saggezza, cominciammo a fissare l'orizzonte con la loro stessa titubanza, presagendo<br />
qualcosa di incontrollabile. Morirono senza vedere niente di quello che avevano temuto, ma noi abbiamo ereditato la<br />
loro paura, che si è trasformata in terrore. Per questo vi abbiamo accolti quasi con sollievo, mentre uccidevano anche i<br />
nostri bambini. Almeno, per un attimo, finiva la paura di attendere. Non siamo più, oggi, dei fantasmi terrorizzati, ma le<br />
vittime reali di un massacro.<br />
[…]<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
52<br />
Da Discorso contro la morte, 2008<br />
Discorso contro la morte<br />
Sermone pronunciato da John Donne la notte di Natale del 1630, nella chiesa di Saint Paul.<br />
Solo adesso arrivo a parlarvi, miei fedeli. Educato fra uomini abituati al disprezzo della vita e al culto dei morti, affamati di<br />
un immaginario martirio e di una tormentosa trascendenza, oppressi dal cilicio di una religione oscura come una tara<br />
inconfessabile, solo adesso arrivo a parlarvi, come dopo un lungo viaggio.<br />
Ora siamo nudi, qui, nella chiesa di Saint Paul, e non possiamo tacere. I nostri abiti sono quella piccola montagna di stracci<br />
ammucchiata davanti al portale. Ma non vergognatevi. Nessuno entrerà. La porta è stata sbarrata dall'interno con un trave<br />
di legno. È quasi mezzanotte e nessuno potrà vederci così come siamo. Dowland ha acceso questo grande fuoco al centro<br />
della chiesa, che ci scalda tutti. Non possiamo avere freddo. Dobbiamo restare in preghiera - noi, chiusi in questo silenzioso<br />
mausoleo con i nostri corpi nudi, nudi come lo furono alla nascita, senza lo straccio di una veste, senza l'orpello di un abito,<br />
scorticati da ogni lusso superfluo - con tutti i nostri corpi, giovani, vecchi, bambini, adulti, nel giorno della massima festività:<br />
il Natale del 1630, la nascita di Cristo, Nostro Signore.<br />
Il cuore mi si colma di commozione. Quasi non riesco a proferire parola. Come siete diversi tutti. Il tempo è leggero su<br />
quelle braccia, pesante su quella schiena, funesto su quel cranio, atroce su quelle gambe. Vi vedo tutti - non posso farne a<br />
meno. Vedo la vita in cammino, come il suo muto gemello, il Signore della Morte. Dio passa dentro di voi. Quell'addome<br />
magro, Katherine, ieri era florido e ha generato Anna Porter, vostra figlia. Quel braccio che ieri lavorava duramente nei<br />
campi, Summer, adesso è lì, raggrinzito sul volume di preghiere. Vi vedo con chiarezza, come un cartografo la mappa delle<br />
terre che esplorerà.<br />
Ma i vostri pensieri sono le cose più incredibili: affollano questo luogo da ogni parte, sono uno sciame di cose tranquille e<br />
atroci, chi vorrebbe ammazzare il vicino di campo, chi cullare la figlia, chi mangiare un arrosto di cervo, chi fare all'amore<br />
con la donna dell'amico. Voi che ora mi ascoltate e arate dei campi e nutrite delle famiglie, non avete mai sentito parlare,<br />
da bambini, di apostasie, anatemi, abiure, sentenze. Non siete stati allontanati, a sei anni, da un drappello di militari che<br />
conducevano l'eretico alla forca: non vi hanno coperto il viso, come fecero a me, obbligandomi a giurare di non fare parola<br />
di quello scandalo. Io, che sentii solo il rullo dei tamburi, non promisi però di non immaginare: così vidi me stesso, issato<br />
sulla forca, il cappuccio sulla testa, ma, nel momento in cui la botola avrebbe dovuto aprirsi, la terra tremò, franò la forca, e<br />
io ero là, nudo e ispirato, la morte negli occhi, che soggiogavo tutti con le parole e cambiavo il corso del mondo.<br />
Ognuno di voi, lo sapete, è nato da un luogo buio, lì ha preso forma: e, dentro il corpo della madre, è nato e si è nutrito, per<br />
nove mesi. Ma, se quel tempo non fosse stato rispettato, se il feto avesse avuto qualche malattia, la morte avrebbe ucciso<br />
le madri e i figli, e qui ci sarebbero dei posti vuoti e io non potrei guardare negli occhi persone che hanno vissuto una vita<br />
intera, di felicità o di stenti, perché non sarebbero mai esistite, perché un piccolo germe, quel giorno di primavera o di
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
53<br />
autunno, si sarebbe insediato nell'utero di qualche madre, un piccolissimo insetto, invisibile a occhio nudo, che anche<br />
adesso potrebbe benissimo stare sotto la cute del tuo braccio, John, o la pelle del tuo cranio, Jane, anticipando il vostro<br />
viaggio agli inferi. La vita è qualcosa di incongruo e di non ragionevole: dipende da un acaro o da un bacillo, a noi è capitato<br />
di viverla e siamo qui, insieme, come una mappa di cui è impossibile decifrare qualcosa. Siamo corpi che si espongono a<br />
Dio.<br />
[…] Atlante, libri, pianeti, sudore, fatiche, singulti – voi siete la mia mappa, la parabola accidentata della creazione. I libri<br />
sacri lo dicono: La creazione è il sommo bene, ecco l'opera di Dio, mirabile ai nostri occhi, e tu mi hai fatto e plasmato,<br />
Signore: ma queste meraviglie, se sono attaccate dalla peste e dilaniate dalle guerre, restano sempre delle meraviglie? A<br />
volte marciscono negli uteri, a volte marciscono nel mondo, e la vita è meno di una pezza da piedi, in cui il potente si<br />
asciuga lo stivale infangato o la lancia insanguinata. E tutto è così precario anche se ci copriamo di mille abiti e pellicce e<br />
corazze e armature, perché la puntura di un ago infetto potrebbe provocare dolori, febbri, bubboni, e non lasciarci più<br />
finché non abbiamo reso l'ultimo respiro.<br />
Credete a me - miei cari, miei nudi fedeli, miei vivi - è solo per caso che qui ci vediamo e parliamo. Nostro Signore è nato in<br />
quella capanna che le nostre storie dolcificano a nido edificante di un bambino meraviglioso ma lo sapete - voi! - che era<br />
una notte d'inverno e faceva un freddo atroce e il fuoco non bastava e, se Cristo non fosse stato il miracolo di se stesso, la<br />
febbre lo avrebbe assalito e lui sarebbe morto di freddo o di fame o per qualche agente maligno, e lo avrebbero pianto i<br />
suoi sventurati genitori, eletti da Dio?<br />
Certo, quando un uomo nasce, può scegliere le sue condizioni di vita. Può viaggiare o pensare, sposarsi o restare solo,<br />
leggere libri o conquistare città: ma non c'è nessuna differenza fra un eremita e un viaggiatore, entrambi si consumano,<br />
entrambi sono ben fragili fortezze. Uno preferisce farsi di pietra, l'altro di vento, ma alla fine devono tutti morire: e chi va<br />
sul Nilo a trovarsi oscure terzane e sopravvive, e chi non si sposta dal tugurio dove è nato e un piccolo verme lo possiede,<br />
distrugge il suo corpo, lo espropria dalla vita: questo è il dannato exitus a cui siamo tutti avviati, e i vostri corpi lo<br />
confermano, chi giovane, chi vecchio, chi malato. Nessuno di voi è immune dai segni del tempo e dai sintomi del male.<br />
Implorate al vostro corpo, che ora è qui, nudo, di tacere a lungo, di non portarvi le sue sorde pene; fatelo stare zitto; non<br />
forzatelo con lavori massacranti; non esibitelo come trofeo nelle guerre; non esponetelo in guerre di religione; non<br />
vituperatelo in risse da quattro soldi; non vi spaccate lo stomaco con la carne e i reni con la birra.<br />
Rispettiamoci: la morte verrà, anche se siamo prudenti. Ma forse, possiamo essere in armonia con lei, se cerchiamo di<br />
vivere un'ora d'ozio al giorno, di leggerezza assoluta, senza vestiti e senza rimorsi, disincantati e liberi. Eccoci qui, corpi e<br />
volti nudi, come non siamo mai stati prima, a mezzanotte. Qui non ci sono orge o scandali, ma solo la pace giusta. Non<br />
sento più il sussurro delle fontane, le armonie dei clavicordi, i cori delle campane, i corni di caccia, le marce funebri, i canti<br />
liturgici. Ho perso il lessico del teologo per essere qui, con voi, nel dubbio reale dei capelli intorno all'osso, della pelle viva<br />
contro lo scheletro. Voi siete la mia mappa planetaria e le mie strofe perfette: voi significate il mio abbandono di ogni
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
54<br />
perfezione. Io entro, con voi, nella presenza della vita e della morte.<br />
Anche se la chiesa, come abbiamo voluto, è sbarrata a chiave. Anche se non vogliamo che nessun vescovo o nessuna<br />
guardia entri qui, dove preghiamo, e inorridito dallo scandalo delle mie parole condanni me al rogo e voi ai lavori forzati.<br />
Ma sarebbe bello fosse così per ognuno di noi - nella sua comunità; che fosse esposto a tutti, docile e giusto. Certo è che<br />
l'uomo, così come voi lo vedete, ha bisogno di tutto. È l'essere più fragile. Se questo fuoco uscisse dai limiti in cui lo<br />
abbiamo confinato e si appiccasse ai vostri corpi, cosa potrei fare io, per voi? cercare di salvarvi? Ma come, se io sono<br />
debole e leggero quanto voi? E se questa chiesa fosse invasa dall'acqua e grandi onde frantumassero le vetrate e si<br />
impadronissero dei vostri corpi? E se il vento vi trascinasse via come fuscelli? e se la terra vi inghiottisse nei suoi crateri?<br />
Ecco, noi siamo qui, nudi e calmi, in questo Natale, solo perché la terra è tranquilla e non manda scosse e gli oceani non<br />
escono dai loro limiti. Noi esistiamo e i nostri padri e i padri dei padri e i figli dei figli e i figli dei nostri figli, magari per<br />
cinquecento anni, solo perché in questi cinquecento anni la terra è rimasta tranquilla. Quindi viviamo per caso: e intanto<br />
continuiamo a invecchiare e niente può arrestare il processo se non amare meno la vita e pensare con saggezza al possibile<br />
distacco.<br />
Guardate laggiù, i vostri abiti. Sono tutti fradici delle vostre fatiche, del sudore, della gioia che avete vissuto. Sanno di<br />
quando avete fatto all'amore o avete cagato i vostri escrementi. Sono una piccola montagna lurida. Ma racchiudono tutti i<br />
fatti che vi sono accaduti. Forse, in qualche brandello, ci sono rimasti anche i vostri pensieri. Forse un giorno li brucerete, li<br />
dimenticherete, li getterete via, parte della vostra storia resterà in quelle fibre di tessuto, e le fibre non andranno distrutte,<br />
magari saranno macinate o riassorbite dall'acqua e porteranno nel mondo, dove voi siete morti, l'eco di voi.<br />
Eccoci qui, nudi. Le maschere le abbiamo lasciate lì, addossate al portale della chiesa, e qui nessuno entrerà. Ma ricordiamo<br />
che quelle maschere sono anche la nostra storia. Non illudiamoci di essere sempre nudi. Santi o veggenti o folli - è un<br />
destino di cui ho appena intravisto l'orrore.<br />
Qualcuno di voi è malato. Qualcuno di voi mi dirà che, magari, desidera uccidersi. Non c'è niente di più naturale, per<br />
l'uomo, che togliersi la vita. Cosa si può imputare, al suicida? Egli corre, invece di camminare. Si affretta, invece di<br />
rallentare. Cade nel pozzo, invece di esserci a fatica buttato dentro. Siamo tutti mortali. Non ci sono peccati né nel vivere<br />
né nel morire. Siamo tutti la mappa di un disegno sacro, che ognuno di noi potrebbe anche turbare, chi ridendo, chi<br />
giocando, chi uccidendo, chi cominciando a danzare. Non c'è un fato già scritto: già scritto è solo il fatto che morremo.<br />
Ma qui, adesso che siamo nudi e spaventati, io vi dico: guardiamo con chiarezza il mistero. Nutriamoci della morte come<br />
gustiamo la carne degli animali o le piante della terra, è tutto un ciclo naturale, non pensiamo troppo a noi, alle nostre<br />
famiglie, ai nostri figli, non possediamo i nostri pensieri ma facciamo che loro traversino noi. Non viviamoci indispensabili,<br />
anche se siamo portati a pensarlo, ognuno con le sue eccellenti ragioni. Tutti andiamo e veniamo dalla stessa porta.<br />
Ognuno di noi ha il suo volto e il suo incubo: la paura non è neppure un sentimento, è uno stato. È sangue della nostra<br />
carne, prendiamola con noi, passiamo con lei le nostre ore. Viviamo o uccidiamoci o sopportiamo gli stenti: ogni giorno ci
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
55<br />
colerà vita dalle mani, è stupido poi piangere quando qualcuno muore, come se un fato crudele ce lo avesse strappato.<br />
Sarebbe come incolpare una bottiglia di essere vuota, dopo che è stata bevuta giorno per giorno. Piangere, lo possiamo<br />
fare a ogni secondo che scappa dalle dieci dita; ma, se non fossimo esistiti, potremmo gustare questa gioia di esserci, di<br />
gridare e battere i piedi, e gustare il vino e tenerci per mano? Non saremmo nulla e allora niente servirebbe, né cibo né<br />
vesti né carezze.<br />
Se uscite di qui, quando sarete di nuovo con le vostre vesti, non pensate a voi stessi. Ricordate di esservi visti e che domani<br />
potete ancora vedervi, se il caso lo concede. Non c'è speranza o disperazione: solo una stretta di mano, un bacio, uno<br />
sguardo. Si vive di nulla. Qui, a pelle nuda, col sangue che ci scorre nelle vene. Qualcuno leggerà la mappa dei nostri corpi<br />
anche quando essi saranno cenere e solo le ossa indicheranno la nostra permanenza sulla terra. Qualcuno ci sognerà o<br />
respirerà di noi e noi rivivremo nel sogno di un re o nel rimpianto di un soldato, nel dolore di un mendicante o nel sonno di<br />
un eremita, in qualche angolo del pianeta, e allora, verme o Shakespeare, cosa importa, resteranno sempre le ossa, fuori<br />
sarà primavera o inverno, o qualche altra stagione.<br />
Forse qualcuno di noi, presente oggi, potrebbe domani uccidere il vicino, per una questione di donne o di campi. Si uccide<br />
per difendersi da chi ci opprime o ci offende: è un impulso naturale. Un uomo deve uccidere, per essere vivo: ma se lo fa, lo<br />
circondano ingombranti cadaveri, cose da sotterrare. Deve essere più scaltro. Deve, se sarà necessario, annientare l'altro,<br />
privarlo delle armi, ridurlo alla condizione di morto, ma senza spargere sangue. Così l'essere umano ammazza il padre e la<br />
madre non se li elimina fisicamente ma quando sa distaccarsene. Essere vivi è sempre e solo un distacco. Tutta la vita è un<br />
raffinato vagare nelle strategie dell'addio. Ma durante queste fasi, durante il tempo che ci separa dalla morte o<br />
dall'assassinio, eccoci nudi, qui, nella chiesa di Saint Paul, a dichiarare che amiamo, a non potere non amare, nel modo più<br />
eretico e folle, personale e avventuroso, quanto vogliamo e possiamo. E, se ci sarà occasione di odiare, odieremo.<br />
Ma ora rivestiamoci. Il tempo della Messa è quasi finito e non voglio che nessuno sappia di quanto è accaduto. Questa<br />
notte è stata irripetibile: teniamola dentro la nostra memoria come un evento. Spegniamo il fuoco e torniamo a vivere e a<br />
morire nelle nostre case. Non cerchiamo mai di opprimere o di rassegnarci ma di essere liberi, innanzitutto. Di sorprendere<br />
e meravigliarci. Mai dormire in se stessi ma addormentarsi fuori di sé, per uscire dai nostri corpi, lasciando a chi resta<br />
l'insegnamento del sogno e qualche gesto da ricordare.<br />
Amen<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
56<br />
Da A schermo nero, 2010<br />
Faccia lunare<br />
Un uomo piccolo, dalla faccia folle, infantile, perturbante, che interpreta con perfetta intelligenza parti di traditore e di assassino: l’ungherese<br />
Ladislav Löwenstein, in arte Peter Lorre (1904-1964). Caratterista in Casablanca e Il mistero del falco. Protagonista in M., Delitto e castigo,<br />
Amore folle e Lo sconosciuto del terzo piano. Lorre, regista di un unico, tragico film sulla storia di un assassino nella Germania nazista, L’uomo<br />
perduto, invecchiando interpreta parti sempre più marginali in alcuni film dell’orrore. I suoi lineamenti sono deformati dalla pinguedine e<br />
dall’uso prolungato di morfina. Al suo funerale, Vincent Price disse di lui che era stato un “piccolo, grande, immenso attore”. Il testo seguente<br />
è un soliloquio-confessione dell’attore, ubriaco in una taverna messicana, nel 1951.<br />
Non so se, vedendomi, mi riconoscereste. Grasso, piccolo, sempre ubriaco, vivo per nove ore al giorno nel fondo di questa taverna,<br />
ad Escobar. Non ho più un volto per turbarvi. Ho perduto l'atterrita attenzione del mio pubblico. Non so più guardare con quegli occhi<br />
globosi e innocenti, da folle mite, da assassino silenzioso, da essere lunare. Non verso il latte nella ciotola, non accarezzo il gatto,<br />
non uso sciarpe bianche. Non mi innamoro di una statua. Non tradisco per nessun falco. Non uccido, non fuggo, non sono inseguito.<br />
Nessuno marchia la mia schiena con una M di gesso. Non fischio canzoni per ciechi, non compro palloncini per bimbi dolcissimi. Il<br />
subdolo criminale dalla voce flautata non abita più in me. Il processo è stato lento e inesorabile. Quando avevo un viso giovane e uno<br />
sguardo sfuggente, nessuno si accorgeva della mia statura: la mia insidiosa piccolezza aggiungeva ambiguità all'ambiguità. A<br />
cinquant'anni ingrassai e il mio collo ingrossò, la faccia divenne molle e larga - materia flaccida, da incubo, da danza macabra. Capii<br />
allora che si poteva solo ridere del piccolo attore dalla faccia cambiata, dall'ex-viso lunare. Adesso ero poco più alto di un nano.<br />
Non lasciai il cinema ma i ruoli che mi venivano assegnati erano sempre più secondari e bizzarri: la mia faccia, rammollita anche da<br />
un mediocre technicolor, non faceva più male a nessuno. Ecco la verità: ho consegnato il mio volto ai film che ho girato e ora non è<br />
più mio. È vostro. Non saprete mai quanto tutto questo sia atroce: sapere la propria faccia appesa, come un trofeo, in certi<br />
capolavori che non smetterete mai di rivedere, turbati da un viso glabro, lunare, folle, e io, che lo possedevo, mi trovo questa vescica<br />
grassa e irriconoscibile posata sul collo, una cosa molle e sudata che mi tortura per la sua ottusità.<br />
Quando voi, con il nome di Peter Lorre, vedrete sempre, in qualche vecchio cinema, il volto che ho perduto e rabbrividirete, io, in<br />
questa taverna di miserabili, ad Escobar, potrei essere schiaffeggiato da un barbone che non saprebbe mai di stare percuotendo lo<br />
stesso volto lunare che dalle penombre del cinema, con subdola grazia, continua a turbarvi da generazioni...<br />
Non sono più chi sono stato. Il cinema mi ha derubato di me.<br />
Gli idoli invecchiano, se sono fatti di pelle umana, e non c'è niente che, come la vecchiaia, spezzi l'incantesimo del cinema. Il cinema<br />
è giovinezza. Un certo sguardo o andatura o sorriso, colto in una certa età. Un attimo. Quell'attimo e nessun altro: un che di<br />
enigmatico e di insostituibile, di cui non si può tollerare la scomparsa; al punto che solo l'alcool, tracannato nelle taverne di Escobar<br />
o in sordidi seminterrati, con puttane o senza puttane, fra ex-attori o guitti o deboli di mente, può farci tollerare l'impressionante<br />
lunghezza della vita. E poi, questi dolori al fegato, la morfina…. Vorrei solo poter rivedere Un uomo perduto prima di morire: sono<br />
anni che non passa, in televisione, proprio quel film. Pensa di essere un genio soltanto lui, quel grassone di Laughton, con La morte<br />
che corre sul fiume?<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
57<br />
Da Sentinella, 2011<br />
Nelle ultime ore della notte può sempre apparire un “pensiero girovago”, come lo definiscono i monaci egiziani del IV secolo - un<br />
pensiero che conduce da una mente all’altra, senza nessun<br />
nesso logico, e genera eresie.<br />
Esiste una follia “bianca” dove non è visibile la cruenta emorragia del delirio o la violenza permanente del grido ma il silenzioso<br />
slittare dell’individuo verso i suoi intimi inferni.<br />
Ogni opera scritta, veramente scritta, è un silenzio che parla.<br />
P. Quignard<br />
Errante nella follia: scrittore.<br />
Stanziale nella follia: pazzo.<br />
Il muro bianchissimo dell’Acropoli, visto dagli occhi di Flaubert, non è più la rigorosa trama del Libro.<br />
Oggi il Libro è svuotato, graffiato, smascherato anche delle ultime parole, che restano rapidi arpeggi sulle macerie.<br />
Dondolano e dondolano, dal basso sembrano stracci bucati o vessilli pericolosi, ma visti dalla giusta prospettiva sono oracoli fatti<br />
di stoffa, con segni e scritture, disegni e alfabeti.<br />
I libri si rispecchiano uno nell’altro, soprattutto se sono scritti in tempi e in età diverse.<br />
Ponti che l’acqua subisce o forme create dalle correnti?<br />
L’artista rischia il richiamo imperioso della sproporzione.<br />
Gli stili sono strumenti accordati da interpreti diversi.<br />
La scrittura: un sogno da cui ci si sveglia scrivendo il libro che era necessario scrivere.<br />
Io, se scrivo, non posso avere rimpianti.<br />
Il fuoco che arde e insorge, senza incenerire.<br />
Come se in una casa che sta per essere distrutta dalle fiamme, ci si ponesse per la prima volta il problema della sua architettura.<br />
F. Kafka<br />
* * *
Dalle opere di narrativa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
58<br />
Da Turno di guardia, 2011<br />
[…]<br />
Oscillare senza cadere<br />
Quando ascolto un «matto» delirare, ogni sistema logico diventa instabile, come se io e lui fossimo su una passerella oscillante.<br />
Ma, nell’attimo stesso in cui io e lui ci mettiamo a parlare tutto ritorna stabile e c’è una via di scampo. Io vacillo e lui sprofonda.<br />
Ma, vedendomi vacillare con lui, sprofonda di meno. È felice che io barcolli, che io sia simile a lui. Sa che io, come psichiatra, non<br />
sprofonderò. Sa che, come matto, lui potrebbe farlo. Ma sente che, se ha una possibilità di salvarsi, deve imitare la mia strategia.<br />
Oscillare senza cadere.<br />
Ascolto il suo destino. Ha voluto sciogliersi dalla forma che lo imprigionava e ha fallito. Mi carico di quel fallimento per osservare<br />
nodi che appartengono a me e a lui. Conquisto una distanza che è già reciproca via di salvezza e di avvicinamento al mondo<br />
parallelo che, da quei nodi, potrebbe inventare universi.<br />
Se il mio compito, come lettore e interprete della malattia, è decifrarla e trasformarla in qualcosa di altro dal sintomo, il mio<br />
compito come scrittore è lavorare su una scrittura che renda impossibile e altro il linguaggio. Chi, come lo psicotico, non ha niente<br />
da perdere perché crede di possedere tutto, ha come suo doppio l’artista che non ha niente da perdere perché non ha e non<br />
vuole avere nulla.<br />
[…]<br />
Mulini a vento<br />
Un giorno cercai di persuadere un uomo di trentasei anni, in preda a un delirio megalomanico in cui credeva di essere Gesù,<br />
Budda o Gandhi, a raccontarmi ciò che provava, a scriverne su un taccuino. Lui mi guardò con sospetto, poi disse: Io non scrivo, io<br />
sono. Aveva già tracciato, per i giorni a venire, il suo programma: dimostrare di avere ragione contro chi gliela negava, e pagare il<br />
prezzo di questa lotta. Il segno più evidente della psicosi è che ogni parola pronunciata non appartiene alla sfera del linguaggio, e<br />
tantomeno all’universo della metafora, ma è verità rivelata. Chi si sente messaggero di questa verità guarderà con sospetto sia i<br />
funzionari di potere - poliziotti e psichiatri - che lo invitano a tradirsi, sia i compagni di follia che enunciano verità diverse dalla<br />
sua. L’uomo di cui parlo ha sofferto per mesi di un’infezione alla gamba sinistra che solo per caso non si è trasformata in<br />
cancrena. Per mesi, pur zoppicando, ha negato la realtà di quella ferita. Non lo considerava un problema. Lo avrebbe risolto<br />
quando avesse voluto. Poi il dolore è cresciuto; lo ha spinto, suo malgrado, a farsi curare.<br />
Il «matto» intraprende sempre una lotta ostinata contro le convenzioni della sofferenza, del pensiero, della percezione: una lotta<br />
grandiosa, destinata al fallimento. L’esagerazione, maniacale e donchisciottesca, è comune, in campi diversi ma contigui, anche<br />
all’arte. Se non si esagera lottando con i mulini a vento contro una uniforme pianura noiosa, se non si vive fino in fondo<br />
quell’«energia dislocante della poesia» di cui parla René Char, accettare le regole della vita e del linguaggio è solo un debole atto<br />
di sottomissione a codici già scritti, una sconfitta umiliante. La speranza nasce quando - parzialmente sani - cerchiamo di<br />
sfruttare, tra affanno e pazienza, l’energia vorticosa dei mulini.<br />
* * *
Dalle opere scritte con Lucetta Frisa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
59<br />
Da Nodi del cuore, 2000<br />
Guarigione<br />
Paul Celan e Nelly Sachs<br />
Parigi, gennaio 1970<br />
Nelly cara,<br />
gli ultimi disegni di Gisèle raffigurano bei corsi d'acqua, magnifici. L'acqua è qualcosa di molto buono: risolve, e dà<br />
senso. Lo sa bene chi, come e più di noi, ha visto tante morti per fumo e per fuoco, e ora vuole dimenticare la cenere e la polvere,<br />
non ricordare più. Noi, che ancora siamo vivi, abbiamo un privilegio: scegliere dove andare, quando è il momento di andare. Ora<br />
non parliamo più di terra promessa, ma di acqua - assegnata in dono a noi, perché ci si purifichi o si scompaia. I due atti sono<br />
paralleli: guariscono dal male, come dalla poesia che ci consuma. (Quel 5 settembre di dieci anni fa, perché non hai voluto<br />
riconoscermi?).<br />
***<br />
Tuo Paul<br />
Stoccolma, marzo 1970<br />
Lo dicevi anche tu, Paul. Scrivere poesie, stringere una mano, c'è differenza? In questo momento vorrei entrambe<br />
le cose. Sono debolissima e solo entrambe queste cose mi darebbero la forza di resistere alla malattia fisica. La parola è stata,<br />
forse, la cura intima e splendente che ci ha permesso, fino ad oggi, di restare in vita. Ma anche le cure hanno una fine. Si guarisce,<br />
si va altrove... Qualcosa, Paul, mi risucchia dentro - come un'acqua nera, che sento salire dentro di me. Ma non provo nessuna<br />
sofferenza. Davvero nessuna. Solo una grande, silenziosa felicità: mi sento pensata da te e non resistere significa, in un certo<br />
senso, abbandonarmi a questo pensiero, strappare la rete, essere insieme a te dove sappiamo che si può, in modo buono e<br />
chiaro, riconoscerci veramente, senza vergogne e senza ricordi. Forse, nella luce...<br />
Nel maggio del 1954 Paul Celan e Nelly Sachs cominciano a scriversi assiduamente. Fra la poetessa tedesca, nata a Berlino nel 1891, e il poeta<br />
rumeno, di ventinove anni più giovane, nasce una corrispondenza intensa, dove momenti di esaltazione lirica si alternano a periodi di<br />
malessere esistenziale, legati anche alla comune ascendenza ebraica. Nelly Sachs vive a Stoccolma, mentre Celan, con la moglie Gisèle,<br />
pittrice, e il figlio Eric, abita a Parigi. I due poeti si incontrano solo due volte: nel maggio del 1960 a Zurigo e nel settembre dello stesso anno a<br />
Stoccolma:<br />
Nelly
Dalle opere scritte con Lucetta Frisa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
60<br />
Stoccolma: in quella seconda occasione Nelly Sachs, prostrata da una grave crisi psichica, non può o non vuole riconosce il poeta che è venuto<br />
a trovarla. L'epistolario continua, sempre meno frequente, negli anni seguenti. Paul Celan muore suicida il 20 aprile del 1970, annegandosi<br />
nella Senna, e Nelly Sachs, già gravemente malata, il 12 maggio dello stesso anno.<br />
Da Anime strane, 2006<br />
* * *<br />
Pesce<br />
Fin dal primo giorno in cui ha letto vita e abitudini dei pesci, li ammira per la straordinaria prudenza con cui affrontano il nemico,<br />
per le tecniche sofisticate di difesa: si commuove alla notizia che le seppie intorbidano il mare con getti d’inchiostro, di modo che<br />
i predatori, storditi e macchiati, girino al largo. Dai pesci ha imparato il silenzio. La madre, quando lui compie dieci anni, comincia<br />
a preoccuparsi. Risalgono ad allora i primi colloqui psicologici. Ma lui, invece di parlare, muove appena le spalle e protende le<br />
labbra a muso. È considerato un «idiota sapiente». Internato e costretto ad assumere neurolettici, non si scompone. Trangugia i<br />
farmaci con grande calma e sa dentro di sé che non possono fargli né bene né male. I pesci sono insensibili alle terapie dell’uomo.<br />
Continua a ruotare le spalle, a protendere le labbra. Spesso scende da letto e nuota nel corridoio, pancia a terra; nuota nel buio,<br />
come se avesse le pinne, finché gli infermieri non lo notano e lo riportano nella sua stanza. Lui, obbediente, riprende la posizione<br />
eretta, barcolla un po’ e senza dire una parola si lascia rimettere a letto, a pancia in giù.<br />
Tentativi di nuvola<br />
Fa spesso i suoi «tentativi di nuvola», così li definisce. Si affaccia alla finestra, sollevandosi sulle punte dei piedi, allunga il collo,<br />
chiude gli occhi, poi, dolcemente, comincia ad oscillare la testa. Finché si dondola con tutto il corpo. Sua madre gli urla di tornare<br />
a studiare. Il patrigno si isola nella sua stanza. Il fratello sghignazza. Ma lui, ostinato, continua i suoi «tentativi di nuvola». Agli<br />
psicologi che lo interrogano sulla sua infanzia, risponde ridendo: «Io? Mai avuta infanzia. L'avranno quei due uomini e quella<br />
donna che mi perseguitano. Io no. Io sono leggero. Molto leggero».<br />
Bocca di rosa<br />
Tiene le spalle incassate. «L’aria mi pesa sul cranio, non riesco a scrollarla dalla testa! Mi annoio, dottore. A volte sento un fruscio<br />
sotto le spalle, che non capisco. Sto bene con il Risperdal, certo. Tranquillissimo. Lavoro in mensa al mattino, di pomeriggio porto<br />
a spasso Leòn (o è Leòn che porta a spasso me, mugolando e correndo?). Ma io, chi sono? Me lo dica. Un mese fa sentivo le voci,<br />
ora meno. Esistono davvero, sa. Una mi dice: stai fermo sui gradini. L’altra: il ponte suona se ci soffia il vento. L’altra: guarda che<br />
arriva lo tsunami. Si avvera tutto, dottore. Allora dovrò scegliere: sono matto e niente è vero, oppure non sono matto e tutto è<br />
vero. Ma, se tutto è vero, allora perché sto con mamma e papà e perché passo il tempo a fare ragù di carciofi e a ingoiare pillole?<br />
Devo andare su un monte a fare l’eremita, e basta.<br />
Si ricorda il mio sogno? La cascata, immensa in mezzo alla chiesa. E io, con quei lacci addosso, come una corazza, portato via da<br />
due
Dalle opere scritte con Lucetta Frisa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
61<br />
due ragazzini. Cosa significa? E io, perché vengo da lei? Se ci pensa bene, Bocca di rosa non l’ha scritta De André. Lui è venuto a<br />
trovarmi, un giorno che ero bambino, e l’ho scritta io, la canzone. Come, non ricordo. Ma so che lui l’ha copiata da me. Sì, sento<br />
sempre quel solletico sotto le spalle. È vero che mi nasceranno le ali?<br />
Da Sento le voci, 2008<br />
* * *<br />
Claudio L.<br />
Devo aggiungere una cosa, dottore. Per correttezza. Quando, la sera, buttavo la spazzatura nei cassonetti, ero io la spazzatura.<br />
Volevo dirglielo. Grazie per questi tre anni in cui mi ha curato bene. Ma chi semina vento raccoglie tempesta. Tutto è già stato<br />
scritto. Inutile lottare. LORO verranno a prendermi, domani, forse. Me lo dicono giorno e notte, che verranno a prendermi. Lo<br />
scandalo è stato troppo grande. Sono come un maiale, mangio e dormo come un maiale, e dei maiali si fa prosciutto e salsiccia.<br />
Lei ha voluto salvarmi ricoverandomi in ospedale. Grazie: ma io sono colpevole, e lei lo sa. Non merito neppure di stare in questo<br />
letto: c’è chi sta peggio di me. Chissà se sono proprio malato. Sono solo il figlio superstite: mio fratello, quello buono, è morto a<br />
dodici anni in ospedale. Sono rimasto io: la spazzatura. Lei mi dice che sono malato, che sono bipolare, ma tutto è scritto. Io ho<br />
peccato e devo pagare. Punto. Lei ha voluto salvarmi ricoverandomi e la ringrazio: lei è buono. Ma, stavolta, è davvero un casino<br />
e, se fossi scoperto, non potrei che uccidermi per lo scandalo. Alla fine, le colpe si pagano. Spieghi tutto lei a papà e mamma.<br />
Devono restare uniti, come sempre: stare uniti è l’unica cosa che conta.<br />
(spazzatura, 1)<br />
Giuseppe R.<br />
Lo vedi da te che non camminerò mai più. Eh già, mi sono cacciato giù dal ponte. Non volevo venire al servizio, non volevo andare<br />
in comunità, non volevo un cazzo. Sono salito sulla ringhiera, sono piccolo, sai, molto piccolo, e mi sono buttato. Niente dolore.<br />
Nemmeno una fitta. Ma il rumore delle ossa, quello sì. Un rumore lungo fino alla testa. Ma ero vivo. Ho chiamato aiuto col<br />
cellulare. Che vento, quel giorno! Soffiava dappertutto. E quello stupido elicottero,che girava e girava e non poteva atterrare! Io<br />
non sentivo i piedi. Fissavo il vuoto. Allora ho ricordato quanti chilometri facevo, tutti i giorni, dalla comunità a casa, da casa alla<br />
comunità, con una voce che mi martellava nella testa «scemo… scemo…», e mi sono messo a ridere. Mentre mi soccorrevano<br />
tenevo la bocca dentro le dita perché non mi vedessero. Non avrebbero capito uno che si butta nel vuoto, si rompe le gambe e<br />
ride.<br />
(risata)<br />
Miriam T.<br />
Lei lo sa, dottore, che corpo è anagramma di porco? Io sono chiusa dentro questo porco che non mi lascia libera. Non mi molla. E<br />
aspetto. Aspetto la morte, aspetto. Come passo il tempo? Io non passo il tempo perché è lui a non passare mai. Eppure ho già 50<br />
anni.
Dalle opere scritte con Lucetta Frisa<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
62<br />
anni. A Montségur non volevo aspettare, ho provato a uccidermi con le pastiglie. A Genova con la pistola, esercitandomi a<br />
tirassegno per non sbagliare il colpo. Ho fallito tutte e due le volte. Eppure la voglio, la fine, la imploro. Dopo morta, salirò nella<br />
grande Blue Family, nel Paradiso Azzurro della razza ebraica, riceverò finalmente la laurea ad honorem in matematica e sarò<br />
felice. Là brillerà, e per sempre, non la povera luce del giorno, non il sole fasullo di Sigfrido, di Dio padre, di Cristo figlio, ma il sole<br />
vero, il sole di mezzanotte. Lei lo sa, dottore, che Mezzogiorno di fuoco, con Gary Cooper, è una metafora della condizione<br />
umana? Lo sceriffo Cooper, in una cittadina del West, uccide la bestia che è dentro di sé. Arrivano quattro nemici, in pieno sole.<br />
Due li uccide lui. L’altro la sua sposa, Grace Kelly. Il quarto lo uccidono insieme, quando lei si scrolla in pieno sole. Due li uccide lui.<br />
L’altro la sua sposa, Grace Kelly. Il quarto lo uccidono insieme, quando lei si scrolla di dosso il capo dei banditi, piantandogli le<br />
unghie in faccia, e lui lo ammazza. Dopo, possono lasciare quel paese assolato e ingiusto ed entrare, da sposi, nel loro vero regno<br />
di tenebre. Fred Zinnemann, che ha diretto il film, lei lo sa, dottore? Era ebreo. Arrivederci al prossimo martedì. Noi li faremo<br />
sempre, i nostri colloqui, vero?<br />
(i nostri colloqui, 1)<br />
Maurizio F.<br />
La natura è natura, dottore. Vuole forse che io depositi mele e pesche dentro il frigorifero in modo che il ghiaccio le uccida e ne<br />
spenga la fragranza? Io non ammazzo la natura. E il fuoco, il sacro fuoco, lo accendo di notte, in cucina, perché i miei lari e penati<br />
mi custodiscano. Michela teme una stupida esplosione domestica, ma ha torto. Lavarmi? No, che sciocchezza! Io non mi lavo. Se<br />
mi lavassi ucciderei i batteri sparsi nei capelli, nella barba, nei denti. Uno sterminio. Sono loro il mondo, non noi; loro il grande,<br />
multiforme, invisibile universo del quale siamo deboli ospiti noi, con le nostre coscienze morte. La preoccupo, vero? Io sono la più<br />
grande risorsa e la più grande ansia per i miei simili. Adesso torno a casa. Sta per tramontare il sole e devo vederlo, l’astro, io che<br />
da sempre sono il suo custode. Curioso: con quella faccia da giovane sapiente lei è solo uno spietato assassino, come il resto degli<br />
uomini. Ma, più di loro, capisce l’enormità della mia vita spirituale, che mi rende vero ma mi riempie gli occhi di lacrime, che<br />
rende gracile e stretta la mia vita materiale. Permette? Le esprimerò il concetto con questi versi:<br />
Come la mano<br />
raccoglie la terra<br />
la terra cade<br />
il vento la porta<br />
qualcosa rimane<br />
La mente<br />
pensa<br />
un’altra cosa.<br />
(il sacro fuoco, 1)
Da Il diritto di essere opachi, 2010<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
63<br />
Gerico<br />
Da Gerico non si fugge mai<br />
perché intorno alle case cresce l'insidia dell'aria:<br />
una città fluida, oscura,<br />
dove i nomi delle strade sono segreti<br />
dove, se respiriamo,<br />
un uomo sarà ucciso mentre cammina nella nebbia.<br />
I nostri passi, cercando la terra, trovano il vento.<br />
Io socchiudo gli occhi, stanco di vedere<br />
pietre.<br />
Stringo un bicchiere vuoto<br />
e ascolto le voci dei ragazzi<br />
per non credere che l'uomo<br />
è un disegno staccato dal muro.<br />
Davanti alle porte di Gerico<br />
mani estranee lasciano il cibo.<br />
È buio. Rompendo il pane<br />
mangiamo lentamente, prigionieri di una rete.<br />
Sono ripide le fontane<br />
a cui vorremmo bere, vacillano<br />
le pietre su cui cadde la pioggia.<br />
Chiusi cancelli e giardini<br />
la mia mano trascrive il colore degli aranci.<br />
Ma il foglio è stretto, coperto<br />
da parole notturne.<br />
La luce muore, nella carta,<br />
come sulle mie dita, scomparsi gli amici,<br />
cade l'ombra dei rami.<br />
Quando anche io partirò nascerà il dubbio:<br />
saremo ricordati uomini o pietre?<br />
Ma una sentinella, tradita dal sonno,<br />
non vede quel cerchio di fumo<br />
dove, senza essere cavalcati,<br />
galoppano i puledri.<br />
Io sollevo il palo dalla porta<br />
perché i cavalli entrino a Gerico.<br />
Stanco di proteggere delle statue<br />
osserverò gli zoccoli polverosi<br />
rompere con un rumore cupo spalle di pietra.<br />
La fessura nell’idolo<br />
Qualcosa scivola in una materia senza futuro.<br />
Non precisare. Non disporre. Non sapere.<br />
Aspetta sotto la curva del cielo.<br />
Prometti sostanza alle cose.<br />
All’orizzonte quella nebbia, con la forma di noi.<br />
Le mani, meno forti, non trattengono<br />
il peso dell’acqua. L’anfora rotta,<br />
nessuno racconta come si sfracellò lentamente<br />
sui lunghissimi gradini, fra esseri<br />
senza nome e profilo.<br />
Le mani, meno forti,<br />
non sentono l’acqua che scivola via.<br />
Qualcosa dissolve la pietra. Inventa incubi, fiumi.<br />
La testa non appartiene più al corpo, né il corpo alla terra.<br />
Ora dovrai difenderti e dire […]
Da Il diritto di essere opachi, 2010<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
64<br />
Is Arutas<br />
Sempre, dopo che gli uccelli hanno cantato,<br />
arriva una notte incomprensibile,<br />
il buio come un incubo,<br />
e ti sorprendi a pensare la luce<br />
nelle ali che pulsano immobili -<br />
sonno senza cielo, perfetta assenza di sole.<br />
Poi ti addormenti.<br />
Saprai domani se le geometrie del pianeta<br />
resisteranno a un’altra notte.<br />
Dentro le cose sparite<br />
la notte scolpisce di nuovo i profili<br />
che rinasceranno.<br />
Rosso e oro. Rocce.<br />
Soffio presente di vita.<br />
Sottoterra, il fiato.<br />
Incantesimi deviati, inattesi.<br />
Is Arutas.<br />
Roccia a testa di lupo.<br />
Troppa, troppa luce. Non scrivo. Nessuna carta<br />
tratterrebbe le parole.<br />
Scie d’acqua sulla pietra.<br />
Lingua per muti.<br />
Non leggo. Aspetto la notte.<br />
Lascio che la luce scorra sui vetri<br />
in quel modo silenzioso e immortale<br />
che, una volta morti,<br />
piangeremmo. Lascio che la luce<br />
scorra. Vorrei accennare che. Ma le parole,<br />
sempre più opache, restano nelle dita<br />
come unghie staccate.<br />
Nella sua nuca, inverno dopo estate,<br />
la lunghezza degli sguardi, giorno dopo notte.<br />
L’infinito lo guardiamo<br />
dentro la sua testa come in uno specchio<br />
ma le cose restano troppo grandi<br />
molti guardiani non conoscono la casa<br />
e sanno tutto del buio,<br />
del mondo che cola via - acqua<br />
senza cose, strappata dal sisma.<br />
La sillaba di un vento solleva l’erba<br />
come secoli fa, quando respiravano<br />
tra questi fili verdi, sotto fortezze ora dissolte,<br />
uomini che mi assomigliavano.<br />
Il penultimo sole<br />
torna lentamente alla terra<br />
per difenderla dalle notti future<br />
racconta l’opera del respiro nel sonno<br />
che alla pelle riporta una giovinezza<br />
dove le dita si reimparano dita,<br />
nuove nel buio.<br />
L’uomo che fingo di essere<br />
accennando con la lingua parole<br />
sono io<br />
chiamatemi per nome<br />
Non serve la scrittura<br />
che ogni giorno ascolti.<br />
Diari, schegge, balbettii,
Da Il diritto di essere opachi, 2010<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
65<br />
voci infitte nella mente.<br />
La chiamano scrittura dei morti<br />
ma con matite, grida, fogli, pietre, mattoni sono,<br />
restano<br />
vivi.<br />
E tu? Parli<br />
di uomini che non sono stati guardàti.<br />
Di sabbia, non di mare.<br />
Non racconti fiabe ai bambini.<br />
Non ricordi le pietre piccole, di quarzo rosso -<br />
princìpi di speranza, di silenzio -<br />
scoperte fra alghe e rocce.<br />
Is Arutas. Is Arutas.<br />
Non fare, della terra che vedrai,<br />
un altro punto buio nella nuca.<br />
Per una volta. Senza visioni.<br />
Guarda.
Piccola antologia della critica<br />
In Le mani e la follia lo scontro drammatico fra protagonista e società sfocia nella discesa del personaggio maschile verso una follia ora<br />
visionaria ora delirante; simbolo del sociale è la “strada”, attraversata da arcangeli, demoni frenetici e loro imperfetti umani facsimili; simbolo<br />
del protagonista le sue “mani”, che egli sempre si guarda come esercizio corroborante. Questo libretto, diario di un pellegrino sula strada della<br />
propria disintegrazione attraverso stretti corridoi della follia, ci si presenta come supplemento della rivista quadrimestrale “Con ciò sia cosa<br />
che”, dove lo stesso Ercolani, in un articolo dedicato ad Antonin Artaud, L’opera perfetta come sepolcro, colloca la scelta della follia da parte del<br />
poeta “al punto estremo di un discorso sulla parola”, in quanto la follia può essere “mezzo di disintegrazione e di ricreazione di una parolacadavere,<br />
parola che è solo pietrificazione e suicidio dell’uomo”. La follia, dunque, come carica al contempo negativa e positiva, pozzo senza<br />
fondo in cui scagliare qualcosa e attingerne il diverso; in altre parole, il tema della follia come scelta trasgressiva: e ancora una volta viene alla<br />
memoria l’ideologia eversiva che sta dietro la celebrazione del follus e della festa follorum nel XII secolo.<br />
Maria Corti, in “Alfabeta”, 1979, anno 1, n. 5<br />
* * *<br />
…rileggo ancora una volta le serie di poesie di Marco Ercolani dedicate a Velemir Chlebnikov e oltre a trovare conferma delle doti visionarie di<br />
questo giovane poeta genovese (irresistibile il collegamento con Dino Campana e la sua poesia Genova, tra le più importanti del ‘900 italiano),<br />
mi viene il sospetto che l’attenzione a un poeta di “radici storiche come Chlebnikov (intendo radici storiche trovate nella lingua) segnali la<br />
volontà di ritrovare, in Liguria, il senso di una storia mitica e di trasformare questa categoria del mitico in segnale di verità storica e geografica<br />
incancellabile.<br />
Antonio Porta, dalla Prefazione a Poeti in Liguria, 1981<br />
* * *<br />
Marco Ercolani ha fatto di tutto per depistare e spiazzare i critici rubricatori. Da quasi quindici anni occupa uno spazio decisamente inconsueto:<br />
la sua scrittura prevalente è in prosa ma una prosa non tanto narrativa quanto intima, una sorta di molteplice e cangiante Journal o Zibaldone<br />
(con la variante della lettera, negli ultimi tempi sempre più frequente). Tuttavia la misura di tale prosa non è mai autobiografica; essa crea una<br />
serie di maschere dell’io, capaci di scatenare una narrazione visionaria, tributaria però di una singolare chiarezza, che si deposita sulla figuralità<br />
della lingua, capace di suggerire nitidi fotogrammi visivi (il cinema e la pittura sono alimenti continui).<br />
In un suo volume di saggi, Il ritardo della caduta, Ercolani sostiene che “usare la parola è dimenticare il linguaggio, scrivendo come sonnambuli”<br />
e precisa “La poesia ruota attorno a questo nodo che è fuori dalla parola: immagine non verbale ma sonora, in parte visiva, segreta alla parola”.<br />
La ricerca di Ercolani e la sua dimensione tipicamente poetica (al di là delle apparenze narrative o aforistiche) sta proprio qui: spogliare la parola<br />
della sua forza semantica, sviluppando le sue valenze musicali e figurative. È tale dinamica a garantire il senso e la novità di questa<br />
particolarissima scrittura della visione, che continua a risarcire la propria oltranza. Davvero la cifra del sonnambulismo è efficace: si vive un’altra<br />
vita, ma nella dolcezza e nell’oblìo del sonno, piuttosto che nella lacerazione della veglia.<br />
[…] La variazione è un po’ la realtà storica di quest’opera che ruota attorno a precisi motivi ossessivi, dentro una scelta radicale di scrittura<br />
notturna e della follia, ben chiara dall’ur-Ercolani di Le mani e la follia (1979). I temi ossessivi costituiscono un chiaro sistema articolato a tre<br />
livelli. Da un lato abbiamo gli elementi di relazione: le mani, per il corpo, e le porte per gli oggetti; dall’altro i luoghi: la città, di perpetuo<br />
attraversamento e nomadismo ed il suo opposto, la stanza, il cui legame con il personaggio e l’io è sempre duplice, all’insegna sia della<br />
claustrofilia che della claustrofobia; infine le regressioni reificanti, il freddo e la pietra soprattutto, che sono il segreto desiderio di chi vede il<br />
respiro<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
66
Piccola antologia della critica<br />
respiro (e con esso la vita) come continua perdita («Chi respira, in questa città, non riesce a ricordare»).<br />
[…] Il desiderio di reificazione credo sia motivato dal dominio della paura, che presiede all’opera di Ercolani. La paura si configura come paura di<br />
vivere con questo la paura di entrare nella dispersione; il desiderio di reificazione rappresenta il profondo desiderio di uscita dal vivente per<br />
rituffarsi nell’inorganico, che ha una duplice valenza di protezione e di immortalità<br />
[…] La svolta delle opere più recenti porta alla creazione di una letteratura apocrifa (I taccuini di Blok e le Vite dettate), il cui senso non sta in un<br />
labirintico raddoppiamento borgesiano, ma in una immedesimazione postuma che è, per ora, l’ultima declinazione del progetto reificante, che<br />
garantisce una maggior valenza comunicativa. L’apocrifo non è comunque l’unico presente di questa scrittura: essa si divide con il journal, che<br />
prosegue la voce demonica all’interno con oltranza imperativa, che ora non è più assoluta e infungibile; ha il suo contrappeso e contrappunto<br />
nella prosa saggistica dell’apocrifo, nel suo tono esterno e di supplica.<br />
Stefano Verdino, da Del sonnambulismo, in “Nuova Corrente”, Anno XL, 112, luglio-dicembre 1993<br />
* * *<br />
[…] …la singolarità di Ercolani resta indubbia, non soltanto per l’insistenza con cui egli si affida al procedimento dell’apocrifo - le Vite qui<br />
raccolte non sono che un’isola all’interno di un vasto arcipelago di testi analoghi, solo in piccola parte già editi in riviste o volumi -, sia per il<br />
carattere sostanzialmente «serio» del confronto che egli stabilisce con gli autori evocati. Basta leggere, in tal senso, la splendida difesa della<br />
scrittura apocrifa posta a conclusione del libro, ed attribuita a Ingeborg Bachmann, per vedere quanto impegnativa e vitale possa divenire<br />
questa pratica letteraria quando essa, attraverso «l’identificazione allucinatoria» con un personaggio vissuto, rappresenti la via per conseguire<br />
«una verità etica, un momento in cui il dire, simile al non-dire, espone con ardore il suo tormento» [2]. Questo approccio, che da un lettore<br />
distratto potrebbe essere tacciato di romanticismo, implica in realtà una riabilitazione della scrittura narrativa, che allontanandosi dalle forme<br />
correnti di vuoto calligrafismo o falsa naïveté (tenute artificialmente in vita da un’editoria sempre più miope e timorosa) torna a rivendicare la<br />
propria necessità e il proprio carattere vincolante.<br />
Una simile idea di letteratura, intesa non come ornamento ma come destino, funge anche da guida nella ricerca ercolaniana di quegli artisti del<br />
passato che, esplicitamente o implicitamente, sembrano averla condivisa. Di qui un rapporto con la tradizione che non ha nulla di compiaciuto<br />
o di museale, ma si dà come capace di ripensare, e dunque modificare, l’immagine del passato, negandone la compiutezza e riattualizzandone<br />
le possibilità inesperite. La scelta non cade dunque soltanto su quegli autori - da Kleist a Cézanne, da Artaud a Giacometti - la cui ossessione,<br />
lucida o folle, investe palesemente tanto la sfera dell’esistenza quanto quella dell’espressione artistica. Anche personaggi in apparenza ben più<br />
sobri e apollinei possono trovarsi chiamati a mostrare il loro volto più segreto: così Goethe acquista un reale interesse, per Ercolani, solo nel<br />
momento, ipotizzato, in cui allontana da sé la maschera «olimpica» e decide di dar voce ai propri dubbi sottaciuti e alle proprie predilezioni<br />
represse, mentre Hofmannsthal, posto di fronte ai quadri di Van Gogh, viene condotto ad abiurare la cristallina e rassicurante purezza della<br />
propria scrittura a favore di un’arte più coraggiosa e coinvolgente.<br />
Questi ultimi esempi si prestano ad evidenziare con particolare chiarezza il carattere costitutivamente anfibologico dell’apocrifia, la natura<br />
doppia e insidiosa di una tecnica che induce a «mettersi al posto dell’altro», per rendergli omaggio, per farlo rivivere, ma anche e<br />
contemporaneamente - lo si voglia o no - per espropriarne la parola, per annullarlo sostituendosi a lui. Chi pretendesse di imputare ciò allo<br />
scrittore di apocrifi avrebbe le sue ragioni, ma rischierebbe di dimenticare che un processo assai simile si ritrova, fra l’altro, in ogni atto critico.<br />
Inoltre il fatto di scrivere testi a nome di autori così numerosi e differenti non può non presupporre l’impulso a moltiplicare le occasioni di<br />
uscire da sé e dal proprio stile, a diffrangersi dunque idealmente in una pluralità di situazioni psicologiche e figure di linguaggio. Giacché<br />
Ercolani<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
[2] Marco Ercolani,<br />
Vite dettate, Pavia,<br />
Liber, 1994, pp. 160-<br />
161.<br />
67
Piccola antologia della critica<br />
Ercolani sottoscriverebbe senza esitare l’affermazione di Canetti secondo cui: «Nessuno resiste senza vite prestate, la nostra vita non ci basta»<br />
[3]. […]<br />
Giuseppe Zuccarino, da Destini d’artista, prefazione a Vite dettate<br />
* * *<br />
Tra Michaux, Duchamp, Borges (e un po’ di Canetti) si inserisce una tua particolare cifra che denota, oltre la fantastica acquisizione del testo<br />
come oggetto energeticamente esistente al di là, o al di qua, di ogni (non) necessaria testimonianza, una intensa proposta di analisi e<br />
conoscenza. Voglio dire che, dimostrandosi gli apocrifi introvabili per loro stessa natura, ma veri in quanto storicamente collocati nel tempo e<br />
nella vita di personaggi realmente esistiti, il piacere della loro invenzione si pone come proposta critica di acutissima rivelazione. Così si rivivono<br />
opere e giorni di grandi fantasmi, cogliendone (secondo la valenza di ogni pregnante operazione critica) una verità da vivere più vera della vita<br />
assoluta.<br />
Gio Ferri, da una corrispondenza privata dell’8 maggio 1995<br />
* * *<br />
Una serie di vite immaginarie, di artisti e scrittori, colti in un punto preciso della loro vita psichica e artistica, sulla soglia di un cambiamento, nel<br />
punto in cui l’esistenza sembra ricapitolarsi nel breve volgere di un attimo, e poi precipitare verso il nulla. Così si presenta questo originale libro<br />
narrativo di Marco Ercolani che mette in scena le voci narranti di artisti come Paolo Uccello, Leonardo, Cézanne, Giacometti, Melotti, Bacon, o<br />
scrittori e poeti come Baudelaire, Nerval, Goethe, Artaud, Bachmann. Il genere che Ercolani usa per recitare i frammenti di esistenza dei<br />
personaggi è assai differente: diario, lettera, conferenza, monologo interiore, racconto testimoniale, intervista, testo teorico: ne risulta un<br />
volume da leggersi come livre de chevet, una meditazione sul destino dell’uomo e lo scopo dell’arte.<br />
Marco Belpoliti, da Il sogno della realtà in voci di artisti, ne “Il Manifesto - Talpalibri”, 9/3/1995<br />
* * *<br />
Ogni scrittura è apocrifa nel senso che «la pagina nata dalla volontà dello scrittore parla della sua alienità alle norme sociali, parla del gettarsi<br />
con violenza verso il proprio destino». Il fondo non storicizzabile dell’opera sta qui. L’artista che rappresenta il mondo rappresenta se stesso nel<br />
mondo. Rappresenta la sua inoggettivabile soggettività in mezzo a cose altrettanto inoggettivabili. L’opera sfugge alla presa della<br />
storicizzazione o dell’estetica o del commento, perché mina le basi su cui queste pratiche fondano il loro agire: la separazione tra soggetto e<br />
oggetto, che ha «illuminato» e «ordinato» il mondo scorticandolo però della sua ombra, quella che si proietta dalla sconvolgente intimità<br />
dell’uomo.<br />
Franco Rella, da La vita e le opere, a proposito di Vite dettate, ne “L’Unità”, 27/3/1995<br />
* * *<br />
[…] Uno scritto apocrifo - più che essere tale - dovrebbe suo malgrado diventarlo, ma Ercolani rinuncia da principio: i suoi testi sono<br />
volontariamente apocrifi; lo sono in maniera congenita, e non per disavventura. Sono risolutamente anacronistici, deliberatamente erronei e<br />
apertamente furtivi, se è vero che giungono a noi nell’ombra del suo nome, e solo più tardi prendono il nome di coloro a cui sono attribuiti.<br />
Questi scritti sono definitivamente apocrifi perché il loro vero autore li sconfessa, dicendoli suoi proprio mentre li dice altrui. Perché questa<br />
procedura<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
[3] Elias Canetti, La<br />
tortura delle mosche,<br />
tr. it. Milano, Adelphi,<br />
1993, p. 131.<br />
68
Piccola antologia della critica<br />
procedura acrobatica? Cosa gli impedisce di sperare e insieme di mentire? Cosa trattiene il suo inganno? Cosa gli vieta di scrivere testi propri,<br />
invece che alieni?<br />
Forse Marco Ercolani deve farsi dire dagli altri: sono loro a scrivere la sua autobiografia - dovrei dire la sua vita, per quanto è assillata dalla<br />
scrittura.<br />
Nanni Cagnone, in “Poesia”, n. 118, 1997<br />
* * *<br />
[…]<br />
Etica e poetica<br />
Di norma, definire un testo come apocrifo equivale a considerarlo il prodotto di una falsificazione o di un’imitazione. Gli apocrifi ercolaniani,<br />
però, si sottraggono del tutto a questi stereotipi: non sono infatti l’opera di un falsario, poiché l’autore effettivo esibisce senza reticenze o<br />
infingimenti il proprio nome in copertina, né costituiscono l’esito di un procedimento imitativo. Il gioco che Ercolani conduce con gli autori cui<br />
attribuisce le sue pagine è ben più complesso, e per giocarlo non basta introdurre nell’apocrifo dei segnali (stilistici, storici, ideologici) che<br />
rimandino agli scritti autentici ai quali si fa riferimento, ma occorre anche riuscire a turbare e modificare l’immagine tradizionale di colui da cui<br />
si trae ispirazione.<br />
Nel caso specifico, ad esempio, lo Schulz ercolaniano non si limiterà a scrivere in una maniera che solo a tratti può dirsi simile a quella del vero<br />
Schulz, ma elaborerà contestualmente una poetica che renda ragione dei motivi che lo hanno indotto ad adottare uno stile diverso. Così, in una<br />
delle prime lettere a Romana Halpern incluse nel Mese dopo l’ultimo, si legge: «Forse ti sarai accorta, leggendo questi frammenti, che il tuo<br />
Bruno è meno ragazzo, meno innamorato di quella lingua variopinta con cui, un tempo, voleva entrare nei mondi sfavillanti dell’infanzia e<br />
descrivere tutto; meno colpevole di giocare con la sintassi delle frasi contro un mondo senza sogni. Ora scrivo in modo più severo. Sono<br />
invecchiato» [41]. E ancora, in un’altra missiva alla stessa destinataria: «Immolerò la mia musica senza un brivido di rimorso. Libererò il sangue<br />
troppo denso del canto. Allora la mia prosa sarà quello che voglio: uno stato di squilibrio, di tempesta. Meno fulminea della poesia, sosterà più<br />
a lungo dietro le quinte e si porrà domande sulle parole che narrano eventi. La vera scrittura viene fatalmente prima o dopo l’evento, con una<br />
tensione irrefrenabile a dire storie, mostrare racconti, svelare immagini. Non le è concesso né il gioco fantasmagorico della lingua né la quiete<br />
semplice di narrare. Deve esporsi - ardere e resistere» [42]. Si potrebbe ipotizzare che in queste e altre dichiarazioni d’intenti reperibili nel<br />
volume sia in causa semplicemente, per Ercolani, la volontà di sostituire la propria poetica a quella schulziana. Se così fosse, sarebbe già<br />
ammirevole il fatto che egli attui in maniera lucida e trasparente un’operazione che altri, al posto suo, avrebbero cercato di mimetizzare il più<br />
possibile. Parlare di un autore, non solo con le libertà concesse a chi si muova nello spazio della finzione ma anche seguendo le regole di un<br />
discorso che si voglia critico, comporta necessariamente una certa proiezione di sé nell’oggetto. Lo osservava, con formula efficace, Ripellino:<br />
«Ogni rievocazione trapassa in racconto, ogni discorso sugli altri è sempre un diario truccato» [43]. L’asserzione, in questo caso, è esatta<br />
persino alla lettera, visto che a volte gli appunti attribuiti a Schulz nel Mese dopo l’ultimo riprendono senza modifiche annotazioni diaristiche<br />
ercolaniane. Eppure l’idea che uno scrittore di oggi, per enunciare la propria concezione della letteratura, abbia bisogno di coinvolgere la figura<br />
e l’opera di un predecessore illustre si rivela, ad un esame più attento, ingenua e poco credibile. Le motivazioni da cui traggono origine gli<br />
apocrifi di Ercolani sono in effetti assai più profonde, e non tutte riconducibili ad una problematica di natura letteraria. Diceva Nietzsche: «Nella<br />
vita dei grandi artisti vi sono casi maligni, che per esempio costringono il pittore a schizzare solo come fuggevole pensiero il suo quadro più<br />
importante, e che per esempio costrinsero Beethoven a lasciarci in varie, grandi sonate (come nella grande sonata in si maggiore) solo<br />
l’insufficiente riduzione per pianoforte di una sinfonia.<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
[41] Il mese dopo<br />
l’ultimo, cit., p. 38.<br />
[42] Il mese dopo<br />
l’ultimo, cit., p. 46.<br />
[43] A. M. Ripellino, Il<br />
trucco e l’anima. I<br />
maestri della regia nel<br />
teatro russo del<br />
Novecento, Torino,<br />
Einaudi, 1965, p. 137.<br />
69
Piccola antologia della critica<br />
l’insufficiente riduzione per pianoforte di una sinfonia. Qui l’artista posteriore deve cercare di correggere successivamente la vita dei grandi:<br />
cosa che farebbe per esempio chi, come maestro di tutti gli effetti d’orchestra, suscitasse per noi alla vita quella sinfonia votata alla morte<br />
apparente del pianoforte» [44]. Scrivendo, sia pure solo in parte e per frammenti, quel Messia che Schulz non ha potuto far giungere fino a noi,<br />
Ercolani corregge la vita dello scrittore polacco, ripara - nell’unico modo concessogli, cioè con l’immaginazione - un’ingiustizia della sorte:<br />
perciò non può accontentarsi di vagheggiare una trama, ma deve tracciare le parole del testo assente, sostituire la propria mano a quella dello<br />
scrittore scomparso. Schulz, però, non è visto qui solo come un artista, ma anche come un uomo, un uomo barbaramente assassinato. A questa<br />
ferita, più profonda e irrimediabile di quella costituita dalla perdita di un capolavoro, la scrittura ha il dovere di opporsi: «Se un uomo è stato<br />
ucciso, bisogna trovare parole per lui. Raccontare la sua scomparsa significa non diventare complici del suo assassino» [45]. […]<br />
Giuseppe Zuccarino, Le notti del Messia, presentazione a Il mese dopo l’ultimo, 1999<br />
* * *<br />
[…] Nodi del cuore è un libro […] diviso in due parti circa della stessa consistenza: La seconda vista e Carte segrete. […] Tecnicamente è una<br />
raccolta di scambi di lettere: 34 scambi. Tra Gaspara Stampa e Collaltino di Collalto, Charles Baudelaire e sua mamma, Felice Bauer e Franz<br />
Kafka […] Le lettere sono inventate. Le hanno scritte Ercolani e Frisa (Frisa quasi tutte quelle delle donne; Ercolani quasi tutte quelle degli<br />
uomini). Ma non tutte sono inventate: qualcuna - poche - è vera […]. La storia che si racconta non è, non sono, le storie di queste sessantasette<br />
persone che Ercolani e Frisa si sono immaginati di essere, ma la storia di qualcosa che è accaduto tra […] un personaggio “prodotto” da Ercolani<br />
e un altro personaggio “prodotto” da Frisa, diciamo tra Egli ed Ella, che peraltro non si mostrano mai, ma continuamente si travestono, a volte<br />
perfino Egli si traveste da donna ed Ella si traveste da uomo … e tutto questo è affascinante; ecco: è bello. […]<br />
Giulio Mozzi, da I travestiti delle lettere, in “Il manifesto”, 28/9/2001<br />
* * *<br />
[…]<br />
Di fronte alla follia<br />
Ercolani … non è solo uno scrittore, ma anche uno psichiatra. Nella misura del possibile, egli cerca di far convergere questi due interessi, ad<br />
esempio dedicando grande attenzione all’arte dei folli: «I malati vibrano molto, hanno meno pelle, sono traversati da emozioni incontrollabili.<br />
Hanno un punto di partenza: sono invasi dal loro discorso, dal loro corpo. Ma ciò che conta, se sono artisti, è quanto trattengono. Se sono dei<br />
veggenti, non lo sono perché gridano fra le rovine ma perché reinventano le loro forme colmandole di maggiori emozioni, perché sono capaci<br />
di tornare nel nostro mondo con altre chiavi e l’indicazione di nuove porte» [17]. D’altronde, se l’arte costituisce per certi malati un modo per<br />
attenuare o trasfigurare la loro sofferenza, le opere che producono ci coinvolgono proprio perché riescono a trasmettercela, a farcela<br />
percepire.<br />
L’alternanza fra le due attività quotidianamente svolte non è pacifica, per Ercolani, anzi suscita in lui tensioni e dubbi: «Nell’afa di luglio, un<br />
matto vuole spaccare le mura di casa e chiamano te, lo psichiatra di zona; tu vai, lo infiali, lo carichi sull’ambulanza, lo rinchiudi in corsia<br />
psichiatrica; poi, tornato a casa, ti getti a capofitto nella scrittura della visione, evochi viuzze fatiscenti, case vacillanti, magari descrivi un folle<br />
che vuole spaccare le mura di casa. Guardati bene e vergognati. Indossi una maschera e metti il delirio in prigione; ne indossi un’altra e lo liberi<br />
nella carta» [18]. Può accadere così che la comprensione per l’altro, la fascinazione prodotta da certe forme quasi serene di delirio, lo induca a<br />
venir meno al proprio ruolo tradizionale. Chiamato in una caserma dei carabinieri per visitare un folle che dichiara di sentire le voci di Dio, che<br />
parla<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
[44] Friedrich<br />
Nietzsche, Umano,<br />
troppo umano, I, in<br />
Opere, vol. IV, tomo II,<br />
tr. it. Milano, Adelphi,<br />
1965; 1977, p. 136.<br />
[45] Il mese dopo<br />
l’ultimo, cit., p. 101.<br />
[17] Il demone<br />
accanto, cit., p. 72,<br />
Ercolani ha curato un<br />
volume collettivo dal<br />
titolo Tra follia e<br />
salute. L’arte come<br />
evento, Genova,<br />
Graphos, 2002. Nel<br />
testo introduttivo, egli<br />
precisa bene il proprio<br />
punto di vista su<br />
questi temi.<br />
[18] Il demone<br />
accanto, cit., p. 23.<br />
70
Piccola antologia della critica<br />
parla della sua intenzione di andare in Grecia per partecipare ad uno strano rito, egli si limita a prestargli ascolto: «Alla fine andasti via dalla<br />
caserma senza far nulla, senza ordinare ricoveri, senza prescrivere pillole, senza praticare punture, come un ospite esce dalla casa in cui è stato<br />
accolto» [19].<br />
Assai più frequente, però, è il contatto con un dolore che ha poco di poetico. Il libro ce ne offre immagini brevi ma incisive: una donna parla di<br />
suo figlio che in realtà non è mai nato, un’altra si lamenta dicendo di sentirsi il corpo pieno di morti, un vecchio va in giro trascinando valigie e<br />
borse che riempie con tutti i libri e giornali che riesce a trovare, un alcolista chiede farfugliando di essere ricoverato, due donne inebetite<br />
vivono in una casa entro cui la sporcizia si accumula da anni. Ricordare, anche solo per accenni, la storia di queste persone, può essere un modo<br />
per farle uscire dal buio, per rendere meno inutile e invisibile il dolore che provano, e tuttavia lo scrittore avverte la stortura, non evitabile,<br />
implicita in questo modo di operare: «Vivi all’ombra della malattie che gli altri ti riferiscono. Ogni sintomo descritto è un racconto possibile. Ma,<br />
se tu sai trasformarlo in racconto, chi lo soffre saprà farlo?» [20]. Il problema resta quello che Celan ha condensato in tre memorabili versi:<br />
«Nessuno / testimonia per il / testimone» [21]. […]<br />
Giuseppe Zuccarino, da In compagnia del demone, 2002<br />
* * *<br />
[…] Taala, la città perfetta poiché sognata: città dell’utopia, alla lettera, del nessun luogo, e città ugualmente celeste e infernale […] Ma Taala è<br />
un corpo sgusciante: è città ingannatrice, città dei desideri e delle lori immagini allo specchio. Ercolani […] ha dato forma al regno del’illusione,<br />
dei tanti incanti del desiderio, dell’inganno dei sensi e delle aspettative tradite […] Città comunque memorabile, Taala, dal momento che<br />
esclusivamente affidata alla memoria, al cuore (par coeur se pure sotto orma letteraria, la sta raccontando […]<br />
D’altra parte Taala è ricreata nella mente come una città indefinibile dai contorni geografici, ma comunque fortemente connotata da elementi<br />
d’ambiente mesopotamico. E proprio nelle culture della Mesopotamia sembra abbia prevalso la forza del segno invocativo rispetto alla langue,<br />
al linguaggio come sistema […].<br />
Da un punto di vita compositivo, il talento di Ercolani si dispiega qui, in Taala, nell’arte dell’accumulazione, della ripetizione sottilmente mossa<br />
di un tema obbligato. Ripetizione che è anche ripresa, ripetizione che dice altro, e che soprattutto lascia emergere il tema dell’Altro, di<br />
quell’alterità che è elemento irriducibile di ogni vera scrittura. Scrittura consapevole. Come una tessitura di ragno che prende forma e procede<br />
grazie a continue variazioni, di prospettiva o di sguardi, o a cambiamenti di ritmo interno, narrativo. E il ritmo è serrato, incalzante.<br />
Ogni immagine si impone, acquista subito evidenza, per poi demonicamente dileguare. Non si può fare a meno di pensare alle variazioni<br />
(trenta? trentuno?) di un tema musicale a quelle Variazioni Goldberg, ad esempio, di cui Marco Ercolani è assiduo ascoltatore. Con una<br />
differenza. Che qui, nel romanzo, l’aria iniziale, quella da cui tutto origina, da’ l’impressione di non avere mai raggiunto lo stato di vera<br />
partitura. Come se tutti gli interpreti l’avessero imparata a memoria, ciascuno a modo suo. E ora ne ripetessero solo le risonanze. O come non<br />
pensare, allo stesso modo, a trenta visioni - immagini allucinate della stessa macchia, tutte vorticanti attorno alla stessa pagina bianca. Questa<br />
idea di pagina bianca viene suggerita dal vuoto di quell’involucro, di quella trama di segni che compone il ricordo della città di Taala. Segni<br />
subito dissolti dal vento e dalla sabbia […]<br />
Dario Capello, da Il pulviscolo ballerino dell’esistere, nota su Taala, in “La clessidra”, n. 2, 2004<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
[19] Il demone<br />
accanto, cit., p. 128.<br />
[20] Il demone<br />
accanto, cit., p. 127.<br />
[21] Paul Celan,<br />
Aureola di cenere, in<br />
Svolta del respiro, in<br />
Poesie, tr. it. Milano,<br />
Mondadori, 1998, p.<br />
625.<br />
71
Piccola antologia della critica<br />
[…] I nostri giorni, scriveva Franz Kafka, sono un «essere abbagliati dalla verità». Abbagliati, mentre si arranca su una corda tesa che ha nome<br />
“vita” e, al pari di quella del funambolo nicciano, non offre alcuna via di fuga. «Paura della pazzia, paura della non-pazzia», tertium non datur.<br />
Ma di vero, in questa soglia che appare prossima alla “frontiera infernale” del vivere e della poesia, non rimane che la luce. Quella luce che -<br />
ancora Kafka - si intravede «sul volto di chi arretra, con una smorfia di dolore».<br />
Di questa luce, Marco Ercolani e Lucetta Frisa, corresponsabili e complici di una sfida caparbia e delicata, rendono a pieno l’essenza. Raccolgono<br />
storie di follia ormai troppo ordinaria, fatti che non fanno cronaca, cronache che non fanno Storia, e li rielaborano, li illuminano, li rivalorizzano<br />
nella sola scena entro la quale ogni contraddizione abbia davvero facoltà e diritto di estinguersi: la scrittura […].<br />
Marco Dotti, dalla prefazione ad Anime strane<br />
* * *<br />
Nel lavoro di scrittura … Ercolani e Frisa perseguono invece una semantica dell’abbandono. Le voci raccolte da Ercolani e trascritte e riscritte in<br />
questo libro insieme a Frisa provengono da un buio profondo, e riportano alla luce una antica dignità offuscata. Queste voci significano.<br />
Producono segni che si manifestano. […] Ercolani e Frisa hanno dovuto attraversare, inevitabilmente, il sublime poetico della follia, che in<br />
Anime strane reclamava i suoi diritti sottilmente e gentilmente. Ora il demone parla, non si limita più a suggerire. Le voci, e le voci di “coloro<br />
che sentono le voci”, questa volta parlano in prima persona. […]. Il loro non è né sciacallaggio letterario né documentarismo tecnico-scientifico<br />
con velleità letterarie. Si tratta … di una scrittura necessaria, di un atto dovuto e in risposta a un obbligo, non solo di testimonianza, quanto di<br />
un riconoscimento della potenza dirompente della vita e dell’arte che, come ormai sappiamo grazie a Dubuffet, è lì dove non sospetteremmo<br />
mai che sia. Il valore di quest’opera, in un’accezione molto più ampia, quindi, del suo senso letterario, è attestato dal pudore del terapeutascrittore<br />
e dal bisogno di ricorrere alla collaborazione di una poetessa per maneggiare questo materiale magmatico che non si raffredda mai,<br />
un pudore onestamente dichiarato e la cui soglia è necessario sia superata per compiere legittimamente un lavoro come quello che viene qui<br />
presentato. Storie eccentriche, inclassificabili, la cui divulgazione è resa possibile dalla certezza che, senza un narratore, sarebbero sprofondate<br />
nell’«oltraggio del silenzio», vengono così alla luce.<br />
In questo lavoro c’è la realtà. Quella vera. La realtà parla. Ma è una realtà consapevole, in qualche modo - e, soprattutto, in qualsiasi modo - dei<br />
propri confini. Ecco perché questo libro si può usare in diversi modi. Come l’I Ching, si può prendere a sorte una pagina, e quella pagina ci<br />
rimarrà appiccicata addosso. Ma la voce non ci dirà il futuro. Ci può dire di un presente dilatato sino all’estremo, a ricoprire passato e futuro in<br />
un abbraccio asfissiante, un presente che ci è comune, a tutti, nel quale, tutti, siamo. Oppure si può farne un uso alla Jodorowsky, come se<br />
fossero tarocchi - una pagina una carta - e chiedere agli arcani. Allora le voci parlerebbero, ancora una volta, di noi stessi, di un’umanità<br />
occupata a sbranare e divorare il tempo, a tracciare parabole nei cieli e aprire sentieri nel divenire. Ne andrebbe fatto un uso sociale, letto nei<br />
salotti … , di sera, al posto del rito catodico-plasmatico. Un uso rituale, sì, ormai quasi inesorabilmente perduto ogni respiro che possa dirsi tale,<br />
non mancando a queste pagine un certo arreton, né mistero, né una dimensione, se non mitica, per lo meno archetipica.<br />
E invece, piccole epifanie si manifestano al momento di voltare ogni pagina. Ogni voce che parla strappa il fondale del palco … […]. Gli squarci al<br />
fondale dipinto rivelano mattoni, cemento, ferro, e, al di là dell’inorganico, materia vivente e pulsante che per un istante si avvicina alla visione<br />
estrema della vita, e un attimo dopo ce ne allontana, di colpo. Barlumi. Lampi dal temporale nella notte della vita.<br />
Niente di queste parole proferite dalle voci raccolte con pietosa cura da Ercolani e Frisa ci è estraneo. Ne siamo coinvolti. Come spiegare<br />
altrimenti quello sbigottimento, quella sospensione a ogni pagina voltata, che ci impediscono di usare questo libro come una lettura lineare e<br />
letteraria? La ragione abita da un’altra parte. Abbiamo torto. Abbiamo tutti torto. Le voci ci abitano, pervadono tutti i recessi lasciati deserti da<br />
una<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
72
Piccola antologia della critica<br />
una ragione che è evaporata, svanita (se c’è, appunto, è, sempre, da qualche altra parte). Queste voci sono basso continuo, stream of<br />
consciousness, introspezione quotidiana, pensiero dialogico borbottato in silenzio. Eco delle nostre sensazioni e percezioni, materiale grezzo da<br />
annacquare in sentimenti. Le voci parlano, indipendentemente dal fatto che siamo in grado di ascoltarle o no, e la semantica dell’abbandono ci<br />
introduce sul sentiero dell’abbandono del senso. Il mondo, le cose, parlano; viviamo in un universo di segni; ed è ormai luogo comune: l’uomo<br />
dei nostri tempi è immerso nel rumore e nei suoni, incapace di silenzio. Quel silenzio da cui tutte le parole - suoni, rumori, segni, si originano.<br />
Non sentiamo più il silenzio, non sentiamo più le voci. Non è una contraddizione. Proprio perché siamo incapaci di silenzio, siamo anche<br />
incapaci di ascolto. Le voci a volte urlano, a volte sussurrano. L’orecchio della follia ascolta le voci, anche nel rumore più intenso. Sente quello<br />
che gli altri non sentono. Ciò che sarebbe, per natura umana, comune a tutti, ora è rimasto privilegio di pochi. Privilegio pagato a carissimo<br />
prezzo, ancor oggi, nonostante tutto. L’orecchio della follia ascolta, ragiona, trae conclusioni. Quelle conclusioni che noi non vogliamo trarre.<br />
Che ci porterebbero lontano, troppo lontano. Che ci obbligherebbero a fare cose che non possiamo fare e che infatti non facciamo, standocene<br />
protetti e al riparo dalla follia. […]<br />
Massimo Barbaro, da Dalle grinze del reale, postfazione a Sento le voci<br />
* * *<br />
Un insieme di sorpresa e piacere è ciò che ho provato leggendo Vertigine e misura - appunti sulla poesia contemporanea di Marco Ercolani … ,<br />
proprio come lo si potrebbe provare entrando in una dimora sconosciuta, enigmatica e affascinante. Quest’opera, infatti, è “un luogo” in cui la<br />
parola e il silenzio sono affiancati, i pensieri e le intuizioni vibrano in un’interrogazione appassionata e così, pagina dopo pagina, “spazi segreti”<br />
si mescolano a “luoghi conosciuti” in un viaggio articolato e complesso attraverso alcuni aspetti cruciali della poesia e del “fare poetico”, ma<br />
anche attorno all'Essere, al destino e al tragico che segnano la parola poetica nata da quel «soffrire di meraviglia» che, nota Ercolani, è di ogni<br />
grande poeta. Il cammino è qui svolto attorno alla parola poetica, ma anche attraverso la parola poetica stessa, costruito in precise<br />
architetture, sorrette dal paziente interrogare del nostro autore che non sovrappone mai la propria interpretazione ai versi dei poeti, ma lascia<br />
che essa emerga dalle parole della poesia. […] In Vertigine e misura non c’è assertività logica, né volontà di stabilire “una verità critica” che sveli<br />
il testo attraverso lo “smontaggio” dello stesso - come è stato fatto, invece, dalla corrente strutturalista del Novecento - ma ogni spunto di<br />
analisi è apertura dello sguardo e balzo del pensiero: rapide e vibranti affermazione aforismatiche si legano ad ampie divagazioni e<br />
approfondimenti sulla poesia e sul suo senso,; una breve citazione o alcuni versi di grandi autori vengono riportati sulla pagina senza alcuna<br />
pedanteria erudita, bensì con la forza di un cuneo, che apre varchi al pensiero o di una porta, che allarga lo spazio bianco dentro la pagina,<br />
dilatando la profondità del discorso e creando un intreccio tra le varie dell’opera. […] …la certezza che si ha alla fine della lettura di quest’opera<br />
è che la qualità della poesia non si misura in base alla visibilità di un autore o alla notorietà della casa editrice (grande-media-piccola) che lo ha<br />
pubblicato, bensì solo per la potenza della lingua usata, in cui vibra una visione del mondo “non addomesticata” e non artificiosa, ma potente e<br />
scabra, poiché dice Ercolani «ogni poesia autentica modifica la lingua in cui viene scritta e ogni esperienza poetica è fondamentalmente<br />
un'esperienza dell'impossibile, in quanto la poesia è una forma di allarme permanente contro i codici dell'interpretazione linguistica».[…]Chi<br />
leggerà questo libro si renderà conto che è un’opera che non si può dimenticare, non solo per ciò che Ercolani dice, ma anche per come viene<br />
detto: lo stile potente, mai ripetitivo, ci fa immergere in una scrittura critica che ha il ritmo del racconto gotico e, contemporaneamente,<br />
l’acutezza del pensiero di filosofi quali Blanchot, Agamben, Bachelard, Franco Rella e Maria Zambrano, pensatori che hanno fatto della<br />
narrazione non solo “la forma” del loro pensare, ma “la sostanza” dello stesso, radicando la riflessione nella potenza dell’immaginario<br />
letterario. Va detto che Marco Ercolani è anche autore di prose apocrife e romanzi, tra cui ricorderei l'acutissimo Taala, oltre che essere un fine<br />
traduttore<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
73
Piccola antologia della critica<br />
traduttore dal francese (e ci basti ricordare la sua dedizione per Artaud e Michaux), ma voglio citare anche, tra le opere più recenti, la prosa<br />
visionaria de Il demone accanto, dove Marco - attraverso un dialogo fitto, stralunato e acuminato con il suo daimon, di antica memoria<br />
socratica - si interroga sulla scrittura e sull’ispirazione. A mio parere è stato, questo “esercizio di intensità”, maturato nel tempo, coltivato<br />
attraverso le proprie diverse prove d'autore, oltre che nella vita e nella lettura degli autori amati, che ha “alimentato” la specifica scrittura<br />
critica di questo critico-funambolo che ci regala ora un libro che sa scendere dentro la parola poetica, andando oltre la parola stessa, tanto da<br />
farci scorgere come questa via di conoscenza, esperienza e scrittura che è la poesia sia tragica antitesi, spesso non condivisa, a qualsiasi forma<br />
di pienezza, a qualsiasi certezza o verità statica, poiché la poesia è un inesausto cercare di afferrare, torcere, modificare e testimoniare il<br />
mondo visto-percepito in quello «strabismo dello sguardo» che segna ogni artista, ogni poeta e, tuttavia, solo se la “vertigine” di fronte al reale<br />
si compone in “misura”, si fa “architettura” in un linguaggio che è ritmo, suono e senso, diventa poesia, altrimenti resta esperienza dello<br />
scacco, urlo senza forma, senza possibilità di ascolto.<br />
Gabriela Fantato, da Quando il pensiero fa un balzo, presentazione a Vertigine e misura<br />
* * *<br />
Il cinema è un mondo fatto di ombre. Una notte nella quale si muovono figure, corpi disegnati da una luce di cui non si riesce a comprendere<br />
l’origine, né la natura. È un mondo dalle dimensioni e dai ritmi fuori dall’ordinario: la mano, il volto di una donna occupano tutto lo spazio<br />
davanti a noi, i giorni e gli anni hanno la durata di una dissolvenza. È un luogo che diviene possibile solo nel buio che ci circonda, che costruisce<br />
trame, vite e destini a volte del tutto simili, altre volte nemmeno avvicinabili a quelli che definiamo “reali”. Per queste ragioni le sequenze<br />
proiettate sullo schermo sono state frequentemente paragonate al sogno, alle immagini prodotte dall’inconscio, come se là, in fondo alla sala,<br />
si mostrassero le pieghe, forse le piaghe di un’anima. Lo si ricorda anche qui, in A schermo nero, è una delle prime avvertenze che ci pone di<br />
fronte la scrittura di Ercolani: «Il meccanismo con cui si crea l’immagine, nel cinema, richiama il lavoro dello spirito durante il sonno. Il buio che<br />
invade a poco a poco la sala equivale all’azione di chiudere gli occhi. È allora che comincia sullo schermo l’incursione notturna dell’inconscio; le<br />
immagini, come nel sogno, appaiono e scompaiono».<br />
A schermo nero si presenta come una appassionata riflessione sul cinema, come un vero e proprio atto d’amore per le storie, i personaggi, gli<br />
attori e gli autori del mondo di celluloide. Si tratta di una raccolta di una cinquantina di testi: essi presentano una notevole varietà di forme,<br />
assumendo le caratteristiche di una confessione, di un’intervista, di una lettera, di un diario, di una manciata di pensieri, di riflessioni intime,<br />
oscillando tra la modalità dei frammenti o di appunti sparsi a quella più strutturata di un commento, o addirittura di un lessico. Pagine che si<br />
presentano come occasionali, recuperate tardivamente, casualmente riemerse. Quasi a volersi muovere ai margini delle storie e degli eventi<br />
raccontati sullo schermo, in una zona sotterranea, nascosta, ma proprio per questo imprevedibile e rivelatrice.<br />
Di chi sono le voci che raccontano, annotano osservazioni critiche, progettano nuove opere, ricordano una vita ormai alle spalle, come una<br />
storia a cui restano pochi metri di pellicola prima della parola fine? Sono quelle di registi, attori e attrici, controfigure, sceneggiatori, produttori,<br />
direttori della fotografia. Ciò che però unisce le parole che prendono forma in questi testi è il fatto di non essere mai state pronunciate - anche<br />
se non mancano, qua e là, delle eccezioni - dalle persone a cui sono attribuite, di non essere mai state scritte dalla loro mano. Ercolani infatti<br />
realizza, con A schermo nero, dopo Vite dettate, Lezioni di eresia, Carte false, Discorso contro la morte, dopo i volumi dedicati a Blok e a Bruno<br />
Schulz (ma l’elenco è incompleto), un nuovo libro di apocrifi, o meglio di testi che si presentano sotto la forma dell’effetto di apocrifo:<br />
sottoscritti da Abbas Kiarostami o da Maurice Kosinski, da William Daniels o da Dulton Trumbo, da Jean Renoir o Fritz Lang, ma di cui risulta poi<br />
del<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
74
Piccola antologia della critica<br />
del tutto chiara l’identità dell’autore. Lo scopo perseguito da Ercolani è quello di trovare, in uno spazio e in un tempo che non esistono, un<br />
punto di osservazione inedito che possa gettare luce su una poetica o un destino, sulla genesi o il senso di un’opera. […]<br />
Luigi Sasso, da Dietro lo schermo, postfazione a A schermo nero<br />
* * *<br />
[...]<br />
3. L’arte, una necessità di vita<br />
«Ogni individuo vivo, cercando di lasciare una traccia di sé, scava, giorno dopo giorno, nel muro che lo circonda; batte la testa contro le sue<br />
pareti, sempre troppo alte o troppo strette, crede di impazzire, cerca nuove fessure, immagina di uscire; poi vede nuove macchie, nuove forme<br />
nel muro, le ammira, si ferma; inappagato, riprende a scavare, guarda altre forme, le descrive, si rintana, scava ancora. Non vuole né fuggire né<br />
restare. Ma trovare la sua strada, sì».<br />
È un’idea sottesa a tutta l’opera di Ercolani e della quale ogni artista di cui egli ci parla si fa testimone. Non si percepisce mai, nella sua<br />
scrittura, il sospetto di un puro esercizio retorico, di una pagina presentata come maschera, come variazione fredda, come esperimento<br />
calligrafico. Ercolani preferisce stare dalla parte degli scorticati, di coloro che sbandano tra pathos e ansia di classificazione, tra vaneggiamento<br />
e meticolosa autocritica, dalla parte degli individui dallo sguardo introflesso, affacciato sul magma del loro io. Un’altra netta distinzione viene a<br />
cadere, quella tra etica ed estetica. Allora scrivere, dipingere, comporre una musica diventano gesti necessari, inevitabili, inseparabili dalla<br />
carne e dai sogni di chi li compie e le opere assumono la forma e l’intensa presenza di un corpo. Il tema del doppio, così caro alla narrativa<br />
fantastica, e così connesso al decorso della follia, è anche una metafora della creazione artistica, come se il libro fosse un sosia, le pagine<br />
altrettanti volti dispersi lungo le strade, simulacri di noi, capaci di osservarci mentre accanto a loro camminiamo.<br />
4. Una questione di identità<br />
«Come lo sgretolamento effettivo della pazzia è la perdita dell’identità personale, così la descrizione di questa perdita è il momento fragile e<br />
tenacissimo dell’arte». Di questo sgretolamento il segno più vistoso è il delirio, che Ercolani definisce «la costruzione di un antimondo senza<br />
ritorno, sigillato nel sintomo», rispetto al quale «l’arte è la costruzione dello stesso antimondo, ma nella libera ossessione delle immagini che lo<br />
rappresentano». Per quanto insomma l’arte sia contagiata dagli incubi della mente «da questi deve estrarre il suo quadro, il suo limite».<br />
Un io che si sbriciola, la costruzione delirante di un antimondo, l’ossessione, l’incubo. Abbiamo da tempo imparato a riconoscere in questi<br />
aspetti, che potremmo facilmente desumere da una cartella clinica, alcuni connotati fondamentali della creazione artistica degli ultimi due<br />
secoli. Gli autori che potrebbero essere chiamati a testimoniare, da Kafka a Musil, oltre a quelli direttamente interpellati da Ercolani, sono<br />
molti, e noti. C’è in Ercolani la convinzione che nessun artista, nessuno scrittore è un’ isola, ma un arcipelago («un arcipelago ramificato di<br />
identità»), una realtà plurale, fatta di pezzi che non collimano. Perché proprio là dove il soggetto perde, o vede sgretolarsi la propria identità,<br />
l’artista la ritrova («L’artista vive la sua identità mentre la perde»).<br />
La conseguenza più importante la si riscontra sul piano della costruzione e della struttura di un’opera, sull’andamento e sul ritmo della<br />
pagina: l’impossibilità di una forma chiusa, in armonia con le tendenze della tradizione o del proprio tempo. Al punto da non risparmiare …<br />
anche la natura, l’essenza stessa dell’arte.<br />
[…]<br />
Luigi Sasso, Sette movimenti tra arte e follia. A proposito de L’opera non perfetta. Il testo è apparso sul sito web “La dimora del tempo<br />
sospeso”, a cura di Francesco Marotta<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
75
Piccola antologia della critica<br />
All’inizio è la pagina bianca. Poi, quasi a precipizio, un’urgenza impone il suo ritmo, che è scandito in frammenti, schegge spesso fulminanti,<br />
lampi lapidari. Corteggia l’aforisma, ma non cede alla sua facilità; più ancora che l’aforisma l’obiettivo diventa il sigillo sapienziale. Una segreta<br />
conoscenza del nulla. Una “via segreta” del pensiero che, mentre cerca gli incontri col vocabolo, ne è aspirato. Occorre calcinare ogni scoria,<br />
non danzare sulla musica delle parole; qui è una corrente che trascina, come è detto nella poesia “Il folle volo”, e qui, ancora, non deve<br />
ingannare il senso, apparentemente paradossale, di quel verso decisivo «Il folle volo lo compiamo / nell’incantesimo dell’acqua ferma (…)».<br />
Gran parte, se non tutta, della scrittura di Marco Ercolani, anche quella che precede e affianca questi testi poetici, si può leggere nel senso di<br />
una brusca scossa all’apparenza delle cose del mondo, all’evidenza ordinaria. Cerco di sintetizzare così: come usare la finzione per dire la<br />
verità? I termini stessi di verità e finzione sono presi in un laccio inestricabile; interrogare questo koan, portarlo al limite è una passione del<br />
pensiero.<br />
E il centro di gravità di queste poesie si trova già nel titolo, in quell’opachi. Parola chiave, “opaco”, che voglio leggere come confine della luce,<br />
nostalgia della luce, quasi invocazione a un’idea di trasparenza. Nostalgia della luce. Già Gabriela Fantato, nella sua prefazione, parla (con più<br />
cautela) di «uno spiraglio di luce, una sorta di lievità (…)».<br />
La parola poetica di Ercolani recita, sapendo di recitare, il dramma della propria doppia natura, della trasparenza e della intrasparenza... Una<br />
parola che rompe la traccia facile, nasconde quel che vuol rivelare come una domanda che nasconde l’enigma. Il senso scivola, si perde, rinasce<br />
altro.<br />
Il diritto di essere opachi trascrive gli esiti di una discesa nella notte, ma di una notte che ha segreti e dunque pietà. Una discesa che ricorda il<br />
sogno lucido di una coscienza qui e là sonnambolica, testimone e spettatrice insieme di sortilegi, specchi inquietanti, turbamenti, cose<br />
notturne…<br />
Ma «il sogno / è già una sentenza», come ci ricorda Ercolani, così suggerendo un’altra chiave interpretativa della sua poetica.<br />
Il topos cruciale, il nodo di questa raccolta si può pensare nella figura di una clessidra, o meglio, nel suo punto di scorrimento, nella strozzatura<br />
(altra “via segreta”). Ai due lati, l’ombra e la luce, la forma e l’informe, lo scendere che è già salire. Da qui passa il singolare melos di questa<br />
poesia, dall’”armonia della vertigine”. Questo punto di capovolgimento è l’immagine ideale di una ricerca: non conta l’alto o il basso, quanto la<br />
profondità... Da un lato, il visibile, «questa luce verticale / dove tutti credono di muoversi», dall’altro, la cecità, il buio, la “finzione nella notte”<br />
che è finzione della notte. In fondo, per Ercolani, né l’uno né l’altro. L’ultimo imperativo che chiude la raccolta è potente: “Guarda”. È uno<br />
sguardo che oltrepassa la dimensione retinica, ha poco a che fare con l’ottica, piuttosto reclama una postura, una condizione, uno stato<br />
dell’essere.<br />
Dario Capello, nota su Il diritto di essere opachi<br />
* * *<br />
[…] Qui le visioni sono talmente vivide da domandarsi se non ci si trovi davanti un nuovo genere letterario, quello di una poesia nata nei mondi<br />
che altri autori su diversi versanti hanno dichiarato veri: Sturgeon, Van Vogt, Simak, il Ballard di Vermilion Sands. Avete capito a quale tipo di<br />
letteratura penso. Visioni cresciute direttamente nel lato sinistro dell’anima […] Ercolani ingaggia se stesso come se guardasse un altro, e lo<br />
seguisse nelle sue piste notturne, con forti e capaci affabulazioni. Non si sfugge alla sua ardua finitezza, e proprio nell’andare controcorrente<br />
scendiamo a capofitto e senza neppure pensare alla speranza […] Non lo vedo libro di speranza, questo - e chi ha detto che una raccolta poetica<br />
debba esserlo per forza? A me basta che un poeta, scrittore, creatore di mondi o pasticciere, mi diriga contro un dardo congegnato per farmi<br />
farmi<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
76
Piccola antologia della critica<br />
fuori. Sta a me decidere se scansarmi oppure no.<br />
Elio Grasso, Nota a Il diritto di essere opachi, in “Pulp”, novembre-dicembre 2010<br />
* * *<br />
Il diritto di essere opachi di Marco Ercolani racchiude in diciannove componimenti, articolati in due sezioni, trent’anni di attività poetica dello<br />
scrittore ligure. Ercolani arriva negli anni della piena maturità a questo primo convincente libro di versi. Ed è un caso singolare perché molte di<br />
queste poesie, già apparse in importanti riviste fin dall’inizio degli anni Ottanta, lasciavano presagire, per la qualità dei contenuti e per gli<br />
assetti prosodici, la pubblicazione di un’imminente silloge. Del resto è un caso singolare l’intera vicenda artistica di questo scrittore che,<br />
ignorato dai centri di consenso della critica, ha dato alle stampe un’opera imponente e sfaccettata in multiformi modalità di scrittura ma fitta di<br />
plurime connessioni intertestuali e intratestuali. Una scrittura debordante, spesso scomoda da affrontare…<br />
Francesco Maccio, Nota a Il diritto di essere opachi in Punto - Almanacco della poesia italiana, 1, 2011<br />
* * *<br />
Ben consapevole che la vita e la poesia costituiscono una sorta di doppio ossimoro, ad un tempo reciproco, interdipendente e specifico, Marco<br />
Ercolani manifesta - attraverso la metafora centrale della Sentinella - la necessità dell’una in rapporto all’altra (le riunisce l’atto primario del<br />
respiro), per un’alternanza tanto paradossale quanto nutriente di “vertigine e misura”, a ricordare il titolo del suo bel libro di “appunti”<br />
(«Appunti non come confessioni ma come cosmografie») sulla poesia contemporanea pubblicato per La Vita Felice nell’estate del 2008. E se<br />
questa Sentinella è il pendant creativo del lavoro saggistico, risulta subito evidente un presupposto fondativo per l’autore genovese: non ha da<br />
sussistere barriera tra ragionamento e invenzione, pensiero e pathos, così come tutte fallaci sono le frontiere, peraltro assai sedimentate entro<br />
un’idea diffusa ma solo passiva di tradizione, tra prosa e testo versificato, suono e immagine, espressione e teoria, oralità e scrittura.<br />
Parafrasando infatti uno dei momenti più cospicui del libro, dev’essere subito chiaro al lettore che il poeta vive di una sua “fantasia acustica”, il<br />
cui motore primo coincide sì con una condizione di estasi, ma che nondimeno si motiva nel rovello di un’inesausta tensione critica.<br />
La finzione suprema cui ambisce l’atto stesso di scrittura prodotto da Ercolani è un realismo radicale (tant’è che vi risuona perfettamente<br />
plausibile l’apoftegma ancora a fondamento ossimorico «Vivere in uno stato di finzione reale»), da riconoscere per esempio in un archetipo<br />
come Il capolavoro sconosciuto di Balzac: e dunque la Sentinella eponima è definita quale corpo in azione davanti a un foglio bianco sul quale<br />
trascorre la luce - una luce di evidente sostanza metafisica, alla Caravaggio - nella sua polarità compiuta, tra pienezza abbagliante e buio<br />
integrale. Su questo foglio, così, potrà compiersi l’atto a suo modo sacralmente (ma - si badi - non orficamente) conoscitivo della Scrittura, con<br />
echi evidenti di una cultura francese tardosecolare che riattualizza i nomi obbligati di Derrida e di Deleuze attraverso un’eco penetrante<br />
dell’esperienza inventiva di Char e - in particolare - di Jabès. Appartiene all’autore franco-egiziano, infatti, l’idea viva di un Libro che non è mero<br />
tramite di idee o di parole, tese a proiettare il lettore in un ipotetico mondo “fuori”, ma che è in sé - nella sua stessa materialità in fieri, in<br />
duello e dialogo continui con la morte - spazio vitale e atto dialogico.<br />
Ambizione di questa opera invero assai originale è di avvicinare fino a sovrapporli i domini della poesia e della filosofia (intesa non come facoltà<br />
astrattiva o teoretica, bensì come competenza storico-antropologica del genere umano), con un cortocircuito di verità e di invenzione che svela<br />
presto la sua natura sapienziale… […]<br />
Alberto Bertoni, Resistere nella parola, nota critica in Sentinella, 2011<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
77
Inediti 2010 - 2011<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
78<br />
Prose buie<br />
Prigionieri di Dionisio<br />
Perché urlare, battere le mani, parlare a voce alta? Non è l’eco che conta, dentro l’Orecchio di Dionisio, a Siracusa: è<br />
l’orecchio del tiranno, là sopra, capace di ascoltare il minimo bisbiglio. Per questo camminiamo nel buio dell’antro, suoi<br />
prigionieri; ci comunichiamo progetti di fuga con un cenno del capo, senza farci sentire; tracciamo sui palmi delle mani,<br />
come sordomuti, le vie che percorreremo per salvarci. La grotta in cui il re vorrebbe ascoltare le nostre voci è un grande<br />
antro pieno di silenzio da cui non verrà fuori nessun suono a smascherare i nostri sogni sotterranei. Sorridiamo appena.<br />
Perché urlare o battere le mani o parlare a voce alta? Uscire dall’antro: quello è il nostro solo progetto, racconta ai<br />
compagni di prigionia.<br />
Quando scende la notte<br />
Leggere quando scende la notte, mentre non si sa per quanto tempo saranno visibili le parole. I libri diventano allarmanti,<br />
imprecisi, oscuri, come certi vasi attici dove sono disegnati corpi neri di tuffatori e che, al mattino, col sorgere del sole,<br />
appaiono vuoti e bianchi, come se quei corpi non fossero mai esistiti. Si intravede, imprecisa e sinuosa nella ceramica scura,<br />
una crepa. Si continua a leggere il buio.<br />
Il bel colore bianco<br />
Una sete insopportabile. Deve arrivare a casa. Ecco sua moglie e suo figlio, così gli hanno detto. Sono immobili sulla soglia.<br />
Se almeno avesse ricordato i loro nomi! Se almeno ricordasse i loro nomi! Sa che sono loro e sorride. Ha visto subito i loro<br />
occhi allibiti. Un precipizio da cui fuggire. Fuggire subito. Ora è più calmo. Ora sa come liberarsi di se stesso senza l’orrore di<br />
farlo, senza mettere in piedi una scena spaventosa e ridicola. Non tollera il fracasso delle ossa, l’immagine penosa del corpo<br />
mutilato. Sangue ovunque, grumi neri, gente inorridita. Tornerà alla terra.<br />
Basterà scivolare nella neve, a notte alta, e sprofondare appena, non per caso ma con intenzione, una vaga intenzione<br />
animale. A trentasette anni immergere i piedi nella neve altissima, passo dopo passo, in stati sempre più profondi, finché<br />
diventerà impossibile sollevare la gamba destra e allora, gli aghi di ghiaccio sulla fronte, le mani congelate, i piedi assiderati,<br />
il torace chiuso, potrò rendere i pensieri più lenti, più vicini al loro centro, quello che rifiuta la presenza del corpo, le<br />
strategie della mente, il calore delle emozioni, quello che nega tutto ma non il bianco, non il bel colore bianco che si<br />
deposita adesso su di lui e lo rende inesistente, invisibile, fermo. Assoluto, come non poteva esserlo prima. E bere, bere<br />
tutta l’acqua contenuta nella neve.
Inediti 2010 - 2011<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
79<br />
Il falso catalogo<br />
Isidoro di Siviglia, il vescovo medioevale stregato dai segni del mondo e dalla magia delle parole, il vescovo che annotava il<br />
mondo medioevale in un catalogo interminabile di parole raccontava di uomini che credono, con miracolosa ingenuità, alla<br />
reale cartografia di tutti i punti del mondo; diceva che nessun segno, nessuna parola, può descrivere questo universo<br />
incontenibile dal linguaggio perché ogni linguaggio, nel descriverlo, creerebbe un falso catalogo a cui non sarebbe possibile<br />
credere perché il mondo, pur non essendo infinito, è troppo vasto per poter essere descritto e classificato, nell’ansia di<br />
perderlo; i cataloghi, i sistemi, le nomenclature, le enciclopedie, sono concepibili solo in un sogno limitato e perfetto come<br />
quello di Isidoro, vescovo di Siviglia, un sogno esatto, sapiente e impossibile che cancella il casuale pulviscolo in cui tutte le<br />
verità fluttuano simultanee e inafferrabili, un sogno buono per un’esistenza da idiota felice, quella del suo fedele discepolo,<br />
il quattordicenne Alonso che getta e rigetta lo spago sopra il cortile deserto, mangiucchiando torpido, gli occhi persi nel<br />
vuoto, un enorme pezzo di pane, e osservando i segni che le briciole lasciano nella polvere. Isidoro sa bene che tutta la sua<br />
sapienza è nata nel momento in cui vide, sul bordo del pozzo, i nodi che, sulla corda, avevano impresso sulla pietra, dopo<br />
mille discese e risalite, degli uomini.<br />
Chiamare per nome<br />
Ci sono forme che esistono sempre. Per lui è sufficiente guardare, pochi minuti prima del tramonto, mentre cominciano a<br />
scendere le ombre, la grande struttura della cattedrale; vedere i capitelli e le vetrate scivolare lentamente nel buio e<br />
continuare a ricordare tutti i dettagli proprio mentre diventano invisibili; poi immaginarli, nel corso della notte, per tutta la<br />
durata della notte, nel pieno dell’oscurità. Al risveglio, qualche ora prima dell’alba, qualche ora prima di vedere, ricostruirà<br />
la cattedrale a memoria, con i suoi sogni e i suoi ricordi mescolati insieme, nella prima nebbia del mattino, senza aprire gli<br />
occhi, chiamandola con il suo nome. Solo così sarà in grado di comprendere una cosa che esiste durante il giorno e che<br />
esiste durante la notte.<br />
Nome e cognome<br />
Di notte e di giorno, scrive lettere che non spedisce, che non arriveranno a destinazione e non saranno mai lette. Scrive a<br />
persone vive e ignote, a persone con nome e cognome. Nel momento in cui i suoi destinatari vedranno scritto il suo nome e<br />
cognome nel mittente della busta, non si sentirà più un fantasma ma un uomo reale, un essere battezzato, una creatura<br />
vera. Al contrario, in Ultimo tango a Parigi Marlon Brando e Marie Schneider, mentre si amano, si dicono i loro non-nomi,<br />
lui sillabando dei gemiti gutturali, lei improvvisando uno stridìo da uccello. Nel momento in cui si chiameranno con il loro<br />
nome vero, smetteranno di amarsi e lei finirà lui con un colpo di pistola. Prima di morire, Marlon guarda Parigi come per<br />
comprendere dentro di sé, un attimo prima della fine, tutta quella metropoli di persone senza nome.
Inediti 2010 - 2011<br />
Marco<br />
Ercolani<br />
80<br />
Cromatismi<br />
11 ottobre 1585. Da Carlo Gesualdo da Venosa a Torquato Tasso.<br />
Caro Torquato,<br />
comprendo il tuo tormento. Ho provato anch'io una pena simile alla tua, anche se non persi la ragione. Vivo a Ferrara fuggito da Napoli.<br />
Uccisi due esseri umani: mia moglie e il suo amante. Cosa aggiungere? Il mio secondo matrimonio con la figlia del principe è stato solo una<br />
maschera sociale, una garanzia di esistenza. Io sono ancora quelle due morti. Non ho altro di mio. Faccio madrigali per caso, perché nel<br />
mio ricordo c'è la profondissima tenebra di quel delitto. La musica è l'unico modo di svelare il mio crimine senza raccontare un solo<br />
particolare della scena, senza addentrarmi in ricordi proibiti, vertigini, incubi, oscurissime colpe. La musica, fitta di cromatismi ma<br />
astratta, me lo consente. Quando le note risuonano, rispondono al pianto, senza svelare l'oggetto del pianto; sono come sassi, se li tocca il<br />
vento.<br />
Perdonami. Dire di questo a te, che hai sofferto follia e mancanza di senno, è impudenza, e mi affanna. Ma solo il mio Torquato, poeta di<br />
travagli, mi comprenderà, se la sua vita, come la mia, è ombra che viene dall'ombra.<br />
Carlo Gesualdo principe di nulla<br />
Ground<br />
Lettera di Henry Purcell a un'amica ignota (1612).<br />
Neppure in questa occasione, in cui mi esorti a discutere i miei ground per clavicembalo, avrei molto da dire. Sono tanti i significati della<br />
parola ground: suolo, terra, fondamento, causa. Sul ground si edifica, si fonda, si insegna, si gettano àncore. È il fondo, il primo strato, il<br />
canovaccio: è l'istruzione. Per questo, a mio avviso, tutti i pezzi che nomino ground, tutte le composizioni che si fondano su qualcosa di<br />
solido e di terreno, sul basso ostinato da cui nasceranno passacaglie, ciaccone, variazioni, «follie», devono essere malinconiche. Istruzione<br />
fa sempre rima con distruzione. E la distruzione è proprio quel dolore che rende la vita inaccettabile come è e ce la mostra come dovrebbe<br />
essere.<br />
In questi giorni, casualmente, scrivo solo ground per clavicembalo. Lavoro accanitamente, senza provare nessun tipo di affetto. Considero<br />
pericolosi gli stati emotivi. La mia emozione è prodotta solo dalla potenzialità e dall'efficacia dello strumento che uso, o dalla lunghezza<br />
della composizione che scelgo: è un calcolo preciso di effetti, con cui adesso non ti voglio annoiare, ma che risponde a una necessità<br />
filosofica, a una matematica senza illusioni.<br />
Molti si stupiscono di non vedermi, come immaginano, perennemente malinconico, chiuso nella mia dimora a lamentarmi della più triste<br />
delle esistenze, inquieto e sospettoso, malcontento e invidioso, a girarmi e rigirarmi nel letto come morso da un'ape, vagabondando da un<br />
sentimento all'altro, impaziente e infelice, senza concludere mai nulla. Per fortuna non ho questa disgrazia. Non provo la tristezza e la<br />
nostalgia che affliggono di solito il genere umano: semmai, ne conosco altre, di cui non posso parlare. E tu, che mi ascolti, dovresti essere<br />
simile a me, se ami Didone ed Enea. Preparati dunque alla mia musica: un puro sentimento di dolore che, dalla ferma linea del basso,<br />
muove all'acuta intensità della melodia. Ground, come dicevo. E chi ignora i significati del termine, ne sia ugualmente turbato, come dalla<br />
risonanza di una corda che vibra nell'acqua o sottoterra.<br />
Tuo Purcell
Da Caroline Branson, da Spoon River -<br />
Serie composta tra il 1971 e il 1973<br />
con fotografie realizzate a Senigallia
Fabio Franzin<br />
81<br />
È nato nel 1963 a Milano. Vive a Motta di Livenza, in provincia di Treviso.<br />
Ha pubblicato le seguenti opere di poesia.<br />
Nel dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense:<br />
• El coeor dee paròe, Roma, Zone, 2000, prefazione di Achille Serrao.<br />
• Pare (padre), Spinea, Helvetia, 2006, introduzione di Bepi de Marzi.<br />
• Mus.cio e roe (Muschio e spine), Sasso Marconi, Le voci della luna, 2007, 2a ed. 2008, introduzione di Edoardo Zuccato,<br />
Premio “S. Pellegrino Terme 2007”, Superpremio “Insula Romana 2007”, Premio “Guido Gozzano 2008”, Premio speciale<br />
della giuria ”Antica Badia di S. Savino 2008”.<br />
• Fabrica, Borgomanero, Atelier, 2009, 2a ed. 2010, Premio “Pascoli 2009”, Premio “Baghetta 2010”.<br />
• Rosario de siénzhi (Rosario di silenzi - Rožni venec iz tišine), Postaja Topolove, 2010, edizione trilingue con traduzione in<br />
sloveno di Marko Kravos.<br />
• Siénzhio e orazhión (Silenzio e preghiera), prefazione di Franca Grisoni, Motta di Livenza, Edizioni Prioritarie, 2010.<br />
• Co’e man monche (Con le mani mozzate), Milano, Le voci della luna, 2011, con prefazione di Manuel Cohen, Premio<br />
“Achille Marazza 2011”, finalista Premio “Antonio Fogazzaro 2011”.<br />
In lingua:<br />
• Il groviglio delle virgole, Grottammare, Stamperia dell’arancio, 2005, premio “Sandro Penna” 2004 sezione inedito con<br />
introduzione di Elio Pecora.<br />
• Entità, in E-book, Biagio Cepollaro E-dizioni, 2007.<br />
• Canti dell’offesa, Cesena, Il Vicolo, 2011, con introduzione di Gianfranco Lauretano.<br />
Nel 2009, La rivista Atelier gli ha dedicato, monograficamente, il n°53.<br />
Nel 2010 ha vinto il premio “Giacomo Noventa - Romano Pascutto”.<br />
Sue poesie, accolte in molteplici riviste e antologie in Italia e all’estero, sono state tradotte in inglese, francese, cinese,<br />
arabo, tedesco, spagnolo, catalano e sloveno.<br />
Numerosi e di assoluta levatura i critici e i poeti che, in riviste, on-line, in saggi e in occasioni di interviste, si sono occupati<br />
della sua opera.
Da Il groviglio delle virgole, 2005<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
82<br />
Dire vita<br />
Dire vita. Come se fosse semplicemente<br />
pronunciare una parola qualsiasi;<br />
come se non si trattasse, invece<br />
di conquistarsela, in ogni istante,<br />
o cercare di trattenere con le unghie,<br />
strenuamente, ognuna di quelle quattro<br />
lettere dal bordo del nulla che le attrae.<br />
Come se fosse una condizione certa<br />
e non un precario equilibrismo sopra<br />
il cratere eruttante dell’urlo che sempre<br />
esplode dentro noi, o non, forse,<br />
una perenne corte alla luce, un canto<br />
solitario che si perde fra le stelle, dentro<br />
le nebbie della noia; un vagito innestato<br />
al dolore, alla gioia; un rancore che prude<br />
proprio quando la nostra storia rima<br />
con una delle folte assenze che dobbiamo<br />
per forza attraversare lungo l’irto sentiero dell’amore.<br />
Dire vita, però.<br />
Proprio, e perciò, come se fosse semplicemente<br />
una parola qualsiasi. Come se fosse un’oasi,<br />
e non un’ansia che consuma. Dire vita, comunque,<br />
quando la vita vizia lo sguardo, e la forma<br />
di una voce è già quella, perfetta, di una rosa.
Da Pare (Padre), 2006<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
83<br />
Fra i confini dea vita<br />
(In memoria di mio padre Antonio, in benvenuto a mio figlio Jacopo)<br />
‘Sti stanbi zorni de utùno, ora cussì caldi<br />
e ciari, ora cussì covèrti e afosi, cussì caìvosi.<br />
Un zhigo ‘l vent, ieri nòt, e ‘l scuro scuriàr de frasche<br />
contro ‘e finestre fuiscàdhe de l’ospedàl.<br />
E i nidi, pensée: se ghin ‘é, chi ‘o che metarà<br />
un téon sot’i albari? E po’ incòrderse pa‘a prima<br />
volta che ‘l zal dei setenbrini s.ciopà drio ‘e rive<br />
dea Livenza ‘l fa rima co’ quel dee fòjie dee piòpe<br />
piantàdhe longo i só àrdheni. ‘Sti stranbi zorni<br />
de utùno e i fòji del caendàrio che i me casca<br />
stonfi dae man disendo de ‘na vita che la ‘é squasi<br />
drio ‘rivar e de una che, massa sguèlta, ‘a scanpa via.<br />
Co’i stessi làvari che ‘ò basà ‘a front<br />
maeàdha de mé pàre, ‘dèss ‘scolte ‘sti<br />
colpéti lidhièri, ‘sti calcéti cèi, e bei,<br />
pudhàndoi tea panzha piena de mé fémena.<br />
Piove fòjie rosse ‘dèss, tii nizhiòi futignàdhi,<br />
drio i bianchi curidhòi sgrafàdhi dal doeór.<br />
E ‘dèss sò, co’a pì maedéta dee sicurezhe<br />
che quel che me ‘à dat ‘a vita e quel<br />
che da mì la ‘varà no’ i riussirà a incontrarse.<br />
So che mé pàre, nonostante tut el só ben,<br />
no ‘l me ‘assarà far festa pa ‘a nàssita<br />
de mé fiòl, e sò che ‘a nàssita de mé fiòl<br />
no ‘a me ‘assarà piàndher mé pare<br />
come che ‘l meritaràe.<br />
Fra i confini della vita<br />
Mi son qua, co’na man strenta<br />
pa’ provàr a tègner duro, e chealtra<br />
vèrta a spetàr, pronta a ninàr.<br />
No so co quàea dee dó èpie possù scriver ‘ste paròe.<br />
Questi strani giorni d’autunno, ora così caldi / e limpidi, ora così<br />
coperti e umidi, così nebbiosi. // Un urlo il vento, ieri notte, e il buio<br />
frustare di fronde / contro le finestre appannate dell’ospedale. // E<br />
i nidi, pensavo: se ce ne sono chi appronterà / un telone sotto gli<br />
alberi? E poi il primo notare / che il giallo dei toupinambùr esploso<br />
lungo le sponde / del Livenza rima con quello delle foglie dei pioppi<br />
/ che ne costeggiano i suoi argini. Questi strani giorni / d’autunno<br />
e i fogli del calendario che mi cadono / inzuppati dalle mani<br />
dicendo di un arrivo / e di un’altrettanto imminente partenza. /<br />
Con le stesse labbra con cui ho baciato la fronte / emaciata di mio<br />
padre ora ausculto questi / quasi impercettibili sussulti, questi cari<br />
calcetti / appoggiandole sul ventre teso di mia moglie. // Piovono<br />
foglie rosse ora, sulle lenzuola stropicciate, / lungo i candidi<br />
corridoi istoriati dal dolore. // Adesso so, con la più assoluta e<br />
crudele delle certezze / che colui a cui devo la mia vita e colui / a<br />
cui io la darò non riusciranno ad incontrarsi. / So che mio padre,<br />
nonostante tutto il suo bene, / non mi permetterà di gioire appieno<br />
per la nascita / di mio figlio e so che la nascita di mio figlio / non<br />
mi permetterà di piangere mio padre come merita. // Io sono qui,<br />
con una mano stretta / a cercare di trattenere e l’altra / aperta nel<br />
gesto di accogliere, di cullare. // Non so con quale delle due sia<br />
riuscito a scrivere queste parole.
Da Pare (Padre), 2006<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
84<br />
Òni volta che ciape in man ‘a pena<br />
Òni volta che ciape in man ‘a pena<br />
pense a mé Pare. Me par de stréndher<br />
fra i déi una dee só MS cussì come<br />
che le spizhighéa Lu pa’ studharle.<br />
Me ricorde ‘e só ponte dei déi zae<br />
e lisse, tel pòice e te l’indice.<br />
Parché Lu ‘e ciche le fuméa senpre<br />
in dó tenpi. Come ‘na partida de baeón,<br />
come òni bona zhena; come ‘sta poesia.<br />
Da quando che ‘l se ‘vea un fià pers<br />
el se desmenteghéa senpre pì de spess<br />
‘a mèdha messa via, cussì ‘l s’in inpizhéa<br />
‘n’antra, e àa sera ‘l vea ‘a scassèa<br />
dea jaca che ‘a paréa ‘na borséta colma<br />
de muzhigòti che ae volte ‘l studhéa cussì<br />
de prèssa e mal che capitéa de véderghe<br />
vègner fòra un fil de fun da chea sfesa<br />
tant che po’ l dovéa sorbirse i zhighi<br />
de mé mare straca de cusìr su<br />
tute chee fòdre sbusade, brusade<br />
e mì che ò ‘e scassèe dea me jaca<br />
‘ncora seradhe no’ so ‘ndo che pòsse<br />
meter via el muzhigòt mèdho inpizhà<br />
de ‘sta pena jàzha; no’ so co’ che paròe<br />
brincarlo, co’ quae sbusàr ‘a stofa<br />
frapadha e penda de ‘sta crudèe nostalgia.<br />
Ogni volta che prendo in mano la penna<br />
Ogni volta che prendo in mano la penna / penso a mio padre. Mi<br />
sembra di stringere / fra le dita una delle sue MS così come / le<br />
pizzicava lui per soffocarne la brace. // Ricordo le sue digiti ormai<br />
ingiallite / e cancellate, nel pollice e nell’indice. / Perché Lui le<br />
sigarette le fumava sempre / in due tempi. Come una partita di<br />
calcio, / come ogni cena decente; come questa poesia. // Negli<br />
ultimi suoi anni, da quando il male l’aveva colpito / si dimenticava<br />
sempre più spesso / della mezza messa via, così se ne accendeva /<br />
un’altra e alla fine della giornata aveva la tasca / della giacca che<br />
sembrava un sacchetto colmo / di mozziconi che a volte spegneva<br />
/ sbrigativamente e male che un filo di fumo / fuoriusciva non di<br />
rado da quella fessura / così che poi doveva sorbirsi le lagne / di<br />
mia madre stanca di rammendare / tutte quelle fodere bucate,<br />
bruciacchiate // ed io che ho le tasche dell’unica mia giacca /<br />
ancora sigillate non so dove riporre / il mozzicone fumante / di<br />
questa penna ghiacciata; non so con quali parole / raggiungerlo,<br />
con quali bucare la spessa e raggrinzita fodera / di questa crudele<br />
nostalgia.
Da Pare (Padre), 2006<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
85<br />
Deusión<br />
I cunìci i se sconde<br />
tii cantoni dea caponèra<br />
co’ passén; sen qua<br />
tel dadrìo dea casa<br />
dei nòni, e mì voéee<br />
mostràrtii, fiòl mio,<br />
e no’ so pì còssa dirte:<br />
tì cussì corioso e lori<br />
pì dispetósi dee sìmie<br />
sie volte romài<br />
‘ven fat fenta de ‘ndar<br />
via, e po’ muci-muci<br />
pì pin piàn, man par man,<br />
sol pa’ sintìr el sfurigàr dea fuga<br />
drento ’l scuro de l’onbrìa.<br />
E ‘dess che ‘nden via<br />
par davéro, so che i ‘é là,<br />
pudhadi aa retina, co’l nasét<br />
che ghe trema, e tì, e tì<br />
te ‘a tièn un fià pì fiapa<br />
‘a tó man, drento<br />
el sgranf sudhà dea mia.<br />
Delusione<br />
I conigli si nascondono / negli angoli della stia / quando<br />
passiamo; siamo qui / nel retro della casa / dei nonni, ed<br />
io volevo / farteli vedere, figlio mio / e non so più cosa<br />
dirti: / tu così curioso e loro / più dispettosi ancora delle<br />
scimmie // sei volte ormai / abbiamo fatto finta di<br />
andarcene, / e poi zitti - zitti / quatti quatti, mano nella<br />
mano, / solo per sentire il grattìo della fuga / dentro il<br />
buio dell’ombra. // Ed ora che ce ne andiamo / per<br />
davvero, so che sono lì, / appoggiati col muso alla<br />
retina, col nasetto / che gli trema, e tu, e tu / la tieni già<br />
un po’ più moscia / la tua mano, ora, dentro / il crampo<br />
sudaticcio della mia.
Da Pare (Padre), 2006<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
86<br />
Co’ na cufiéta, co’ chealtra recia<br />
Co’na cufiéta parón scoltén<br />
dee canzón de Zucchero...<br />
L’é cussì òni volta che te porte<br />
casa, da tó mare; mì, l’aràdio<br />
no’ l’ò mai bbu, tea machina,<br />
e ‘lora tì té te porta drio chel<br />
to stèrio cèo, rotondo, co’ te<br />
vièn da mì, pa’l fine setimana...<br />
Cussì, òni volta che cioén<br />
su ‘a machina, te me passa<br />
‘a cufiéta parché me ‘a frache<br />
te ‘a recia destra, tì té te fraca<br />
chealtra sua tua de zhanca,<br />
po’ te fa partir ‘e canzon...<br />
Cussì, tuti dó ‘ven un fil<br />
che ne pica, in banda, un fil<br />
che ne taca a un fià de musica<br />
e a un pòche de paròe; cussì,<br />
a tuti dó ne resta ‘na recia<br />
scovèrta; e so che pì l’é quea<br />
a tacarne, el siénzhio che continua<br />
a ingrumarse là drento...<br />
Co’na cufiéta parón sintìn,<br />
co’ chealtra recia, un sbrègo<br />
tea carne longo, e fondo<br />
pì de dièse àni, romài...<br />
Con un auricolare, con l’altro orecchio<br />
Con un auricolare ciascuno ascoltiamo / delle canzoni di<br />
Zucchero... // È così ogni volta che ti riporto / a casa, da tua<br />
madre; io l’autoradio / non l’ho mai avuto, come sai, / e allora<br />
tu ti porti dietro quel / tuo rotondo lettore CD portatile, quando<br />
/ vieni a passare il week-end da me... // Così, ogni volta che<br />
saliamo / in auto, mi passi / l’auricolare affinché me lo metta /<br />
nell’orecchio destro, tu ti metti / l’altro nel tuo sinistro, / e fai<br />
andare le canzoni... // Così, entrambi abbiamo un filo / che ci<br />
pende, lungo la guancia, un filo / che ci lega a qualche accordo<br />
musicale / e ad alcune parole; così, / ad entrambi rimane un<br />
orecchio / scoperto; e so che è più quello / a congiungerci, il<br />
silenzio che continua / a ronzare dentro ad esso... // Con un<br />
auricolare ciascuno udiamo, / con l’altro orecchio, uno squarcio<br />
che ci lacera le carni, lungo e profondo / più di un decennio,<br />
ormai...
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
87<br />
No l’é pecà a ragàr<br />
‘na rosa dal rosèr, se<br />
tì che te ’a spèta te ‘iuta<br />
‘a sera a fiorìr de un canto.<br />
Intanto ‘e pavéjie ‘e me saeùdha,<br />
e dal fondo de l’aria mòre<br />
el ciaro te ’a grazia de l’ort.<br />
‘Na zhiìga ‘a se pudha tea paeàdha.<br />
E mì son vestì da festa.<br />
‘Ò ‘na camisa bianca come<br />
un fòjio. La ‘ò messa su parché tì<br />
te ghe scrive sora un poema de carezhe.<br />
Là c’è la curva, e le siepi / arruffate. Là cresce / il luppolo<br />
brado e c’è l’erba / alta sullo stradone, e poi / c’è il cumulo di<br />
macerie, / api e papaveri, l’acacia / secca e il pozzo. Venti<br />
passi / oltre passano le auto, / è vero, e si sorpassano veloci /<br />
prima dello stop; ma noi / abbiamo imparato a non udirle /<br />
quando veniamo qui, qui dove resiste / un passato che sa<br />
ascoltare / il silenzio che gli portiamo / con devozione, e a<br />
volte / credetemi, questo scampolo di natura / che si ribella<br />
attorno alle travi e alle pietre / sembra di udirlo piangere / e<br />
chiamare tutti i nomi che conosce.<br />
Non è peccato recidere / una rosa del roseto, se / tu che la<br />
attendi aiuti / la sera a fiorire di un canto. // Intanto le<br />
farfalle mi salutano, / e dal fondo dell’aria muore / la luce<br />
nella grazia dell’orto. / Un passero cala sulla rete di<br />
recinzione. // Ed io ho messo il vestito buono. / Ho una<br />
camicia bianca come / un foglio. L’ho indossata perché tu / ci<br />
possa scrivere sopra un poema di carezze.<br />
Là l’é ‘a svòlta, i zhiesóni<br />
selvàreghi. Là cresse<br />
i bruscàndoi e l’é l’erba<br />
alta tel stradhón, e dopo<br />
l’é ‘l mucio de rovinàzhi,<br />
àve e papaveri, ‘a cassia<br />
seca e ‘l pozh. Vinti passi<br />
pì in là passa ‘e machine,<br />
l’é vero, e ‘e se sorpassa sguèlte<br />
prima del stop; ma noàntri<br />
‘ven inparà a no’ sintìrle<br />
co’ vignén qua, qua ‘ndo’ che resiste<br />
un passà che ‘l sà ‘scoltàr<br />
el siénzhio che ghe portén<br />
co’ devozhión, e dee volte,<br />
credéme, ‘sto cantonét de natura<br />
che ‘a se ribèa torno i travi e ‘e pière<br />
par de sintìrlo piàndher<br />
e ciamàr tuti i nomi che ‘l conósse.
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
88<br />
Trazhe<br />
Calcòssa. Come un muzhigòt<br />
de zhigareta schinzhà<br />
te un portaciche bianco,<br />
te l’unico tavoìn libero,<br />
fora da un cafè: el fil<br />
de fun che ‘ncora se lèva,<br />
sora el filtro macià de rosséto.<br />
O un sbrodegòt de zhiéra za dura<br />
zó daa pinzhéta, te ‘na cesa vòdha,<br />
‘na sera. Intant che dó posti pì in là<br />
mèdha candéa ‘ncora ‘a continua<br />
el ciaro dea só preghiera.<br />
Opura ‘a zhàpega de ‘na scarpa<br />
che par dispèt, par zogo, o par<br />
‘na perdita de caìbrio, un sburtòn,<br />
par senpre ‘a resterà fonda<br />
te ‘na getàdha de ciménto.<br />
PRESENZE. E za distanze.<br />
Trazhe che calcùn<br />
el ‘assa là, e che a noàntri<br />
ne fa pensàr, imajinàr:<br />
un viso, ‘na storia diversa<br />
daa nostra epùra cussì diversamente<br />
conpagna. El fato de ‘rivàr un fià<br />
dopo, el fato che calcùn’altro<br />
‘rivarà un fià dopo de noantri<br />
provando a pensàr chi che se ièra.<br />
Tracce<br />
Qualcosa. Come un mozzicone / di sigaretta schiacciato / in un<br />
posacenere bianco, / nell’unico tavolino libero, / fuori da un caffè:<br />
il filo / di fumo che ancora si libra, / sopra il filtro macchiato di<br />
rossetto. // O una colatura di cera rappresa / nel vassoio votivo, in<br />
una chiesa vuota, / una sera. Mentre due spazi oltre / mezza<br />
candela ancora continua / il chiarore della sua preghiera. //<br />
Oppure l’impronta di una scarpa / che per un dispetto, una burla, o<br />
per / una perdita d’equilibrio, una spinta, / per sempre rimarrà<br />
impressa / in una gettata di cemento. // PRESENZE. E già distanze.<br />
// Tracce che qualcuno / ha abbandonato lì, e che ci / fanno<br />
pensare, immaginare: / un viso, una storia diversa / dalla nostra<br />
eppure così diversamente / simile. Il fatto di arrivare un attimo /<br />
dopo, il fatto che qualcun altro / arriverà un attimo dopo di noi /<br />
tentando di immaginare chi eravamo.
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
89<br />
El mar. L’amór. E ‘a mare<br />
Còssa podaràeo mai dirghe al mar<br />
un òn che l’à remà senpre tea pianura,<br />
che l’à rumà tèra. Servo de l’erba.<br />
Un che no l’é mai stat bon de inparàr<br />
a nodhàr, a amàr. Parché l’é difizhie<br />
star a gaea anca tii òci de ‘na fémena,<br />
drento ‘e só onde, ‘e só corénti.<br />
El pol sol ‘ndar da Lu, entrar caminando<br />
fin che l’aqua ghe toca ‘a sbèssoea.<br />
Sintìr ‘a sabia soto i pie come che ‘a sie<br />
‘ncora ‘a tèra. ‘N’antra, pì smòrvedha. Pì bona.<br />
E star là. Co‘a testa fòra.<br />
Come un putèl, co‘l nasse.<br />
Come che ‘l mar deventésse ‘na mare.<br />
Fresca. Chièta. E za cuna.<br />
Soto ‘l sol, o ‘e stée<br />
che i ‘a incorona.<br />
Il mare. L’amore. E la madre<br />
Cosa potrà mai confidare al mare / un uomo che ha<br />
remato sempre in pianura, / che ha scavato la terra.<br />
Servo dell’erba. // Uno che non è mai riuscito a imparare<br />
/ a nuotare, ad amare. Perché è difficile / restare a galla<br />
anche negli occhi di una donna, / dentro le sue onde, le<br />
sue correnti. // Può solo andar da Lui, entrare<br />
camminando / sino a che l’acqua gli sfiori il mento. /<br />
Sentire la sabbia sotto i piedi come se fosse / ancora la<br />
terra. Un’altra, più morbida. Più buona. // E stare lì. Con<br />
la testa fuori. / Come un bambino, quando nasce. //<br />
Come se il mare si facesse madre. / Fresca. Quieta. E già<br />
culla. // Sotto il sole, o le stelle / che la incoronano.
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
90<br />
‘A bici<br />
No’ò mai capìo<br />
parché té te ‘a ‘vesse ciota<br />
chea bici. Te vedée passàr<br />
par de qua, tignéndoea pa’ à manòpoea<br />
caminando, e ‘ndar ‘vanti verso ‘l tó lavoro,<br />
verso l’ostarìa. Mai te ‘ò vist saltàrghe<br />
sora, mai te ‘ò vist fracàr chii pedhài<br />
che i giréa istéss. Po’ i ‘à tacà a giràr<br />
anca i pedhài dea mé vita, ‘ò scuminzhìa<br />
a córerghe drio ai sogni, a l’amór,<br />
e no’ò pì buu tenpo pa’ sentàrme fora<br />
a vardàr còss che passéa de qua,<br />
e i chi e i come che ‘ndea, che tornéa,<br />
a volte inbriàghi, a volte cantando,<br />
bestemàndo, saeudhàndo.<br />
No’ te sì mai stat, o mèjio,<br />
no’ te vée mai vist, spèta,<br />
com’eo che se dise... ah, sì : «pitoresco»,<br />
mai te sì tornà sbiègo, da l’ostarìa,<br />
a sparàr stranbòti come Guerino e Cochi<br />
e Rico, te chel dir baéngo<br />
che a noàntri bòce ne fea cussì tant da rider,<br />
che se imitéa, se simiotéa in mèdho ai nostri zòghi.<br />
Tì te passéa, òni tant, tut quà, te passéa<br />
co’a tó bici par man, co’l tó baschét blè<br />
e ‘l tó siénzhio. Cussì, sol dopo un bèl tòc,<br />
un àno forse, che no’ te vedée pì<br />
La bicicletta<br />
Non ho mai capito / perché te la comperasti / quella<br />
bicicletta. Ti vedevo passare / di qua, tenendola per<br />
la manopola del manubrio / e, camminando, andare<br />
verso il tuo lavoro, / verso il bar. Mai ti ho visto<br />
saltarci / sopra, mai ti ho visto spingere quei pedali /<br />
che giravano lo stesso. Poi hanno incominciato a<br />
girare / anche i pedali della mia vita, mi sono avviato<br />
/ verso i sogni, verso il richiamo dell’amore, / e non<br />
ho più avuto tempo da perdere per sedermi qui fuori<br />
/ a guardare cosa passava, / e i chi e i come che<br />
andavano, che tornavano / a volte ubriachi, a volte<br />
cantando, / bestemmiando, salutando. Non sei mai<br />
stato, o meglio, / non mi eri mai sembrato, aspetta, /<br />
com’è che si dice... ah, sì: «pittoresco», / mai sei<br />
tornato ciondolante dal bar, / a declamare<br />
stramberie come Guerrino e Cochi / ed Enrico, in quel<br />
dire bislacco / che a noi fanciulli / era così simpatico,<br />
/ che imitavamo, scimmiottavamo, insieme ai nostri<br />
giochi. / Tu passavi, ogni tanto, con il tuo baschetto<br />
blu / e il tuo silenzio. Così, solo dopo un bel pezzo, /<br />
un anno, forse, che non ti vedevo più /
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
91<br />
ghe ‘ò domandà a me mare - ma cussì, tant<br />
par dir calcòssa, nianca coriosità,<br />
come che se sé parla del tenpo, opùra<br />
se sé dise: «che ora eo?» - ghe ‘ò domandà<br />
tó notizie. «’A, Benito?, a l’é bèl che un àno<br />
squasi che l’é mort». Po’ a me ‘à dita<br />
che te jèra mul, senza fradhèi,<br />
e che ‘iutéa el latér a far formàji<br />
e butìro. Tuta qua ‘a jèra stadha ‘a tó vita.<br />
E ‘dèss mì pense che chea bici<br />
(che te tignéa senpre cussì lustra)<br />
‘a fusse stadha par tì squasi chea morosa<br />
che no’ te ‘à mai bbu, quea che se porta fora<br />
a spasso, ‘a sera, a brazhéto, o un fradhél,<br />
un amìgo, un fiòl, un can inmànco.<br />
E me piasaràe savér che fine<br />
che l’à fat, chea bici,<br />
se calcùn ghe ‘à mai montà parsora<br />
o se, a l’incontrario de tì, drento de mì,<br />
‘a se ‘à inrudhinìo pudhàdha a un calche<br />
muro del tenpo.<br />
ho chiesto a mia madre - ma così, tanto / per dire<br />
qualcosa, neanche curiosità, / come ci si parla del<br />
tempo, oppure ci si chiede: «che ore sono?» - gli ho<br />
chiesto / tue notizie. «Ah, Benito?, è ormai un anno /<br />
quasi che è morto». Poi ha aggiunto / che eri<br />
scapolo, senza fratelli, / e che aiutavi il lattaio a fare<br />
burro / e formaggi. Tutta qui era stata la tua vita. //<br />
Ed ora io immagino che quella bicicletta / (che tenevi<br />
sempre così linda e brillante) / fosse stata per te<br />
quasi quella fidanzata / che non hai avuto, quella che<br />
si porta / fuori a spasso, la sera, a braccetto, o un<br />
fratello, un figlio, / un amico, un cane, almeno. // E<br />
mi piacerebbe sapere che fine / abbia fatto, / se<br />
qualcuno gli sarà poi salito sopra // o se, non come<br />
te dentro me, / si sia arrugginita appoggiata a un<br />
qualche / muro del tempo.
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
92<br />
Presèpio. Diaèto<br />
Chea strabenedhéta bona vòjia<br />
che te ciapa de far su ‘l presèpio,<br />
òni àno, e òni àno pì grando,<br />
pì bèl; ‘a cura che te ghe mete,<br />
po’, ‘a passión. Là, cuzhàdha,<br />
par tèra, drio ‘l cantón dea sàea,<br />
tì, cussì maeandàdha, che se ‘o<br />
capìsse, sàtu? quant che te diòl<br />
i dhenòci, dopo, co’ te lèva su...<br />
là, a pontàr el cel pièn de stée<br />
co’e brochéte, tel muro, a pudhàr<br />
tute ‘e piègore tel mus.cio... e po’<br />
el fògo, co’e lucéte che baca soto<br />
‘a carta dee narànzhe...’e scorzhe<br />
del ró.ro pal tét, ‘e stradhèe de jerìn,<br />
el pozh, l’acqua che score te un lèt<br />
de stagnòea, e lù, el Gesù banbìn,<br />
co’i brazhéti vèrti, in fra ‘a pàjia<br />
e un nido de bachéti incrosàdhi...<br />
Pa’ i nevodhéti, lo so, capìsse...<br />
ma tì no’ te capìsse che no’é pì tenpi<br />
e reijión, che mì no’ò pì tenpo de ‘ndar<br />
in zherca del mus.cio che té ocóre,<br />
che no’sò pì ‘ndove ‘ndar a catàrlo...<br />
e che no’ i ghe crede pì, i bòce: l’é<br />
pì ‘l deghèio che i fa su... che dopo<br />
té sacramentéa, a tacàr co’l scòc<br />
‘a carta che i sbrèga pa’ tocàr co’<br />
i déi ‘e stée, a cavàr via dal mus.cio<br />
i sasséti dee stradhée sbaràdhe,<br />
a méter in pie ‘e statuéte rebaltàdhe...<br />
Presepe. Dialetto<br />
Quell’irrinunciabile desiderio / che ti prende di allestire il<br />
presepe, / ogni anno, e ogni anno più ampio, / più ricco; la<br />
cura, minuziosa, in ogni suo dettaglio, / la passione. Lì,<br />
accucciata / sui calcagni in un angolo della sala, / tu, così<br />
malandata che, lo / capisco, sai? quanto ti dolgano / le<br />
ginocchia, poi, mentre ti risollevi... // lì, a fermare il cielo<br />
stellato / con le puntine da disegno, nel muro, a sistemare /<br />
tutte le pecore nel muschio... e il fuoco, / poi, con le luci<br />
intermittenti sotto / un batuffolo di carta delle arance... le<br />
cortecce / grinzose del rovere per il tetto, le stradine di<br />
ghiaino, / il pozzo, l’acqua che scorre in un letto / di stagnola,<br />
e lui, il Gesù bambino, / con le braccine aperte, fra la paglia /<br />
e un nido di bastoncini incrociati... // per i nipotini, lo so,<br />
capisco... // ma tu non capisci che non è più tempo / che non<br />
c’è più sacralità, che io non ho più tempo per andare / a<br />
raccogliere il muschio che ti serve, / che non so neppure dove<br />
andare a cercarlo, poi!... / e che non ci credono più, i bambini:<br />
è più / il disastro che combinano... che poi / sbuffi, a<br />
riattaccare con il nastro adesivo / la carta che strappano per<br />
toccare le stelle / con le dita, a togliere dal muschio / i<br />
sassolini delle stradine sparpagliate, / a mettere in piedi<br />
statuine ribaltate... /
Da Mus.cio e roe (Muschio e spine), 2007<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
93<br />
che me vignaràe squasi vòjia de dirte<br />
basta, Mare, ‘àssea star ‘sta poesia,<br />
santa; e varda i nostri paesi, pitòst<br />
varda! che saràe da inpinìr el mus.cio<br />
(mus.cio che ‘sto àno ò vist parfìn<br />
tee scansìe de l’Ipercòp; che i ‘o<br />
vendéa, capissìtu? i vende anca<br />
quel romài! che saràe da inpinìrlo,<br />
chel mus.cio, co ‘e scàtoe dee scarpe<br />
e co quee dee tó medesìne, dee mé ciche,<br />
cussì, a somejiàr tuti ‘sti capanóni, i Centri<br />
Comerciài, che l’é quea, romài, ‘a realtà<br />
che i tó nevodhéti conósse... el tubo dea carta<br />
da cèsso a far ‘e ciminière... i Re Magi<br />
farli ‘rivàr sora ae machinéte de mé fiòl:<br />
al modheìn de un gipón, de ‘na Bièmewu,<br />
de ‘na Mercèdes, altro che camèi...<br />
che ‘l Gesù banbìn no‘l va in tivisión,<br />
tii reàliti, tii tolc-sciò, e ‘lora no’ l’esiste,<br />
capissìtu? no’ l’é un vip, no ‘l conta pì nient...<br />
Vàrdene, Mare: sen qua, mì e tì, tì co’e tó<br />
statuéte, el mus.cio, mì co’e mé pòre paròe,<br />
el diaèto; vàrdene: sen qua a provàr a tègner<br />
fermo un mondo che scanpa via senpre pì<br />
de prèssa, infagotàndoeo de sintimenti,<br />
popoeàndoeo de erba e pastori, de storie<br />
che ‘e sa da fen, da mufa. Fen pròpio da rider!<br />
però, ‘scólteme, Mare: ‘ndarò in zherca<br />
del tó mus.cio anca l’àno prossimo, te ‘o prométe<br />
continuarò a‘ndar in zherca de paròe<br />
vèce, òni dì, pa’a mé poesia, ‘l presèpio<br />
e pa’ i nevodhéti che mé rivarà, anca a mì...<br />
che mi verrebbe quasi voglia di dirti / basta, mamma, lasciala<br />
perdere questa poesia, / sacra; e guarda i nostri paesi,<br />
piuttosto // guardali! che sarebbe da riempire tutto il muschio<br />
/ (muschio che quest’anno ho persino visto / fra gli scaffali<br />
dell’Ipercoop; che era / in vendita, capisci? vendono anche<br />
quello / ormai! che sarebbe da disseminarlo, / quel muschio,<br />
di scatole di scarpe / e di quelle delle tue medicine, delle mie<br />
sigarette, / così, a figurare questi distretti di capannoni<br />
industriali, di Centri / Commerciali, che sono, ormai, il reale<br />
paesaggio / che i tuoi nipotini vivono, conoscono... il tubo<br />
della carta / igienica per mimare ciminiere... i Re Magi / farli<br />
arrivare su di una di quelle macchinine di mio figlio: / al<br />
modellino di un fuoristrada, di una Bmw, / di una Mercedes,<br />
altro che cammelli... / che Gesù bambino non appare in tivù, /<br />
non va ai reality, ai talk-show, e quindi non esiste, / capisci?<br />
non è un vip, non è più nessuno... // Guardaci, mamma: siamo<br />
qui, io e te, tu con le tue / statuine, il muschio, io con le mie<br />
povere parole, / con il dialetto; guardaci: cerchiamo,<br />
strenuamente, di trattenere / a noi un mondo che si allontana<br />
a una velocità / impressionante, avvolgendolo di valori, di<br />
sentimenti, / popolandolo di erba e pastori, di storie / che<br />
odorano di fieno, di muffa. Siamo proprio ridicoli! // però,<br />
ascoltami, mamma: andrò a raccogliere / il tuo muschio<br />
anche il prossimo anno, te lo prometto // continuerò a<br />
raccogliere parole / vecchie, ogni giorno, per la mia poesia,<br />
per il presepe / e per i nipotini che arriveranno anche a me...
Da Fabrica , 2009 e 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
94<br />
Varda chii operai, varda<br />
come che i se perde via<br />
fra i só pensieri intant che<br />
i se fuma ‘na cica sentàdhi<br />
contro ‘l muro dea fabrica<br />
co’ chee camise smarìdhe,<br />
‘e scarpe zhòzhe de còea<br />
o de ojàzh, zhéjie e cavéi<br />
zai de segadùra. I par squasi<br />
dei pajiàzhi scanpàdhi via<br />
vàrdii ‘dèss che i schinzha<br />
‘a cica soto i pie e a testa<br />
bassa i torna dae machine<br />
che spèta ‘ncora i só sèsti<br />
servi; i sogni soeàdhi lontani.<br />
vàrdii, stràchi e spàzhi,<br />
co’i gins che ‘na volta<br />
i ièra quei boni, e ‘dess<br />
i ‘é sol un pèr de bràghe<br />
màssa curte e taconàdhe<br />
da un circo, cussì, ridìcoi<br />
e maincònici come i comici<br />
del cinema mut, e muti i ‘é<br />
anca lori parché ‘a fadìga<br />
ghe ‘à portà via ‘a paròea<br />
Guarda quegli operai, nota / come sono assorti<br />
/ fra i loro pensieri mentre si / concedono una<br />
sigaretta seduti / contro il muro della fabbrica<br />
// guardali, stanchi e sporchi, / con i jeans che<br />
un tempo / erano alla moda, ed ora / sono solo<br />
un paio di brache / troppo corte e rattoppate //<br />
con quelle camicie sbiadite, / le scarpe lerce di<br />
colla / o di oliaccio, ciglia e capelli / gialli di<br />
segatura. Sembrano quasi / dei clown fuggiti //<br />
da un circo, così, ridicoli / e malinconici come i<br />
comici / del cinema muto, e muti sono / anche<br />
loro perché la fatica / gli ha estirpato la parola<br />
// guardali ora mentre schiacciano / la cicca<br />
sotto i piedi e a capo / chino ritornano dalle<br />
macchine / che attendono ancora i loro atti /<br />
servili; i sogni volati altrove.
Da Fabrica , 2009 e 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
95<br />
I sèsti i ‘é senpre ‘i stessi<br />
òni dì. E sempre pì sguèlti<br />
i deve èsser. ‘E man che<br />
‘e core, e corendo ‘e porta<br />
via co’ lore anca ‘l zhervèl<br />
co’e só zàne de fèro fin ‘ndo’<br />
che i sogni no’ i ‘à pì àe. Sèsti,<br />
i stessi, sempre, e senpre pì<br />
de prèssa ‘dèss, senpre prima<br />
‘e man in préstio, el stress<br />
tut a un trato, no’ i se ricorde<br />
‘ndo’ che i ‘é e che i parte via<br />
de scàto, fàzhie che pur savèndo<br />
‘ndo’ che i se trova no’ i pòsse<br />
pì controeàrse e i tache a tremàr.<br />
e ‘l sorìso de tó fiòl ròdhoea<br />
in mèdho ae rulière, ‘i òci<br />
de tó fémena se sconde drio<br />
i bancài, i muéti i diventa<br />
mamùt zai che i vòl levàrte<br />
òmini deventàdhi robò romài<br />
come farài, co’ i ‘riva casa?<br />
Come farài a far passàr pin-<br />
piàn ‘na carézha fra i rizhi<br />
de l’amór; fàzhie che i dei,<br />
I gesti sono sempre gli stessi / ogni giorno. E<br />
sempre più ossessivi / devono essere. Le mani<br />
che / corrono, e correndo trasportano / con<br />
loro anche la mente // il sorriso di tuo figlio<br />
rotola / in mezzo alle rulliere, gli occhi / di tua<br />
moglie si nascondono oltre / i bancali, i carrelli<br />
si mutano / in mammut giallastri che ti<br />
sollevano // con le loro zanne d’acciaio, sin<br />
dove / i sogni non hanno più ali. Gesti, / gli<br />
stessi, sempre, e sempre più / in ostaggio alla<br />
fretta, ora, sempre prima / le mani in prestito,<br />
lo stress // uomini trasformati in robot ormai /<br />
come faranno, quando ritornano a casa? /<br />
Come faranno a far scivolare lenta- / mente<br />
una carezza fra i riccioli / dell’amore; facile che<br />
le dita, // tutto d’un tratto, si scordino / di<br />
essere uscite da quella follia e partano / di<br />
scatto, facile che pur consce / di essere<br />
“rientrate” non riescano / comunque a<br />
controllarsi e inizino a tremare.
Da Fabrica , 2009 e 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
96<br />
Ma pì ‘ncora fa pecà<br />
‘e fémene operaie: vièn<br />
in ment, chissà parché,<br />
‘e formìghe, chee frégoe<br />
grande che ‘e se strassìna<br />
a l’asìo, lavatrice da svodhàr,<br />
‘a roba picàdha al stendìn<br />
‘a matìna, ‘ncora da stiràr,<br />
el magnàr da far; tut un afàno.<br />
Le vede co’ chee onge rote<br />
‘na vèrta de ganbe justa<br />
‘e ‘à incastrà ‘l mona che<br />
le mantièn, pa’e sgrimiéte<br />
dea tivisión, senpre tiràdhe,<br />
inprofumàdhe, ‘a serva in casa.<br />
drio alte fin tel formighèr.<br />
Le vede, senpre de corsa,<br />
cavéi ciapàdhi co’a moéta<br />
in fabrica, ciapà ‘l pensièr<br />
fra ‘l fiòl da ‘ndar a cior<br />
chee rughe in banda ai òci,<br />
sorìsi fiapi e ‘a feminiità persa<br />
sot ‘l traversón; ‘na invidia<br />
che vièn su, a volte, pa’ quee<br />
che co’na bea menàdha de cul,<br />
Ma più ancora provo pena / per le donne<br />
operaie: vengono / in mente, chissà perché, / le<br />
formiche, quelle briciole / giganti che si<br />
trascinano // dietro, sulla groppa, sino al<br />
formicaio. / Le vedo, sempre di corsa, / i capelli<br />
raccolti con mollette o forcine / in fabbrica,<br />
ostaggio il pensiero / fra il figlio da prelevare //<br />
all’asilo, la lavatrice da svuotare, / la biancheria<br />
appesa allo stendino / la mattina, ancora da<br />
stirare, / la cena da imbastire; tutto un affanno.<br />
/ Le vedo con quelle loro unghie spezzate //<br />
quelle rughe intorno agli occhi, / sorrisi mosci e<br />
la femminilità persa / sotto il grembiule;<br />
un’invidia / che monta, a volte, verso quelle /<br />
che con abile ancheggio, // uno scaltro<br />
allargamento di gambe / hanno saputo<br />
incastrare il babbeo che / le mantiene, verso le<br />
veline / della tivù, svestite sempre all’ultima<br />
moda, / profumate, la serva in casa.
Da Fabrica , 2009 e 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
97<br />
A Roberto no’ l’é che<br />
‘e ghe piase pì de tant<br />
‘e batùdhe e ‘e barzeéte<br />
che ‘l diretór el conta<br />
co’l passa fra i reparti<br />
che ridér no’ costa niént,<br />
visto che tuti i só coèghi<br />
i se sganàssa, lo fa ‘nca<br />
lu, parché ‘l sa che sì, che<br />
insóma convièn sempre<br />
che a ridér e a dir senpre<br />
de sì se fa pì strada, l’é pì<br />
fàzhie far carièra, e ‘lora,<br />
capìa ‘a règoea ‘l se ‘dàta,<br />
in coro. Manco duro ‘l lavoro.<br />
come pa’ dirghe «vedéo<br />
che simpatico che son,<br />
che òn bon» no’ le trova<br />
cussì comiche, zherte po’<br />
le conósse za, però, visto<br />
èsser un fià lechìn, che l’é<br />
sempre mèjio tègnersee<br />
bone zherte persone, i capi<br />
spèzhie, quei che comanda;<br />
là in fabrica, po’, l’à vist<br />
Roberto non le trova / così irresistibili / le<br />
barzellette e le battute / che il direttore<br />
racconta / quando sosta fra i reparti // come se<br />
volesse suggerire a quelle maestranze «vedete<br />
/ che simpatico sono, / che buon uomo» non le<br />
trova / così comiche, certe poi / sono anche<br />
vecchie, però, dato // che ridere non costa<br />
nulla, / dato che tutti i suoi colleghi / si<br />
scompisciano, lo fa anche / lui, perché sa che sì,<br />
che / insomma conviene sempre // essere un<br />
po’ yes-man, che è / sempre meglio tenersele /<br />
buone certe persone, i superiori / specialmente,<br />
quelli che comandano; / lì in fabbrica, poi, ha<br />
constatato // che a ridere e ad annuire /<br />
sempre si fa più strada, è più / semplice far<br />
carriera, e allora, / capìta quella regola vi si<br />
adatta, / in coro. Meno duro il lavoro.
Da Fabrica , 2009 e 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
98<br />
Marta l’à quarantatrè àni.<br />
Da vintizhinque ‘a grata<br />
cornìse co’a carta de véro,<br />
el tanpón, ‘a ghe russa via<br />
‘a vernìse dura dae curve<br />
un grop de spaghi stopósi<br />
che nissùna peruchièra pòl<br />
pì tornàr rizhàr. Co’a cata<br />
‘e só care amighe maestre<br />
o segretarie, ghe par che<br />
drio ‘e rece, i recìni. Le<br />
varda e spess ‘a pensa<br />
al só destìn: tuta ‘na vita<br />
persa a gratàr, a gratarse<br />
via dal corpo ‘a beézha.<br />
del ‘egno; e ghe ‘à restà<br />
come un segno tee man:<br />
carézhe che sgrafa, e onge<br />
curte, da òn. I só bèi cavéi<br />
biondi e bocoeósi i ‘é ‘dèss<br />
‘e sie tant pì zóvene de ea,<br />
‘a ghe invidia chee onge<br />
cussì rosse e longhe, i cavéi<br />
lissi e luminosi, chii déi<br />
ben curàdhi, co’ i sii pàra<br />
Marta ha quarantatre anni. / Da venticinque /<br />
leviga cornici col tampone, / la carta abrasiva,<br />
con questi umili strumenti frega / la vernice<br />
dura nelle modanature // del legno; e le è<br />
rimasto / come un segno nelle mani: / carezze<br />
che graffiano, e unghie / tozze, da uomo. I suoi<br />
bei capelli / biondi e ondulati sono ormai // un<br />
groviglio di spaghi stopposi / che nessuna<br />
parrucchiera potrà / più rimodellare. Quando<br />
incontra / le sue coetanee, maestre / o<br />
segretarie, le trova // tanto più giovani, / le<br />
invidia quelle unghie / così rosse e lunghe, i<br />
capelli / lisci e luminosi, quelle dita / ben<br />
curate, quando se li scostano // dietro le<br />
orecchie, gli orecchini. Le / osserva e spesso<br />
pensa / al suo destino: tutta una vita / persa a<br />
grattare, a fregarsi via dal corpo la bellezza.
Da Siénzhio e orazhión (Silenzio e preghiera), 2010<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
99<br />
Pan e paròe<br />
Pan e paròe<br />
l’é sempre stat ‘l mé past,<br />
‘a mé eucarestia; senpre<br />
l’é stat carestia de schèi<br />
tee mé scassèe, caro Dio<br />
tì te ‘o sa, e te sa che mai<br />
te ‘ò domandà un calcòssa<br />
de pì, che senpre quel che<br />
te me ‘à dat ‘l me ‘à bastà<br />
ma ‘e paròe che conzha<br />
chee dó fete de pan le ‘é<br />
senpre ‘e mie, quee che<br />
ghe ‘ò sgrafà via dal jazh,<br />
dal siénzhio, e ‘a fame che<br />
me cresse drento la ‘é quea<br />
dee tue, de una soea, inmanco.<br />
Fàme savér se te son caro,<br />
se te me tièn de cont, fàea<br />
anca tì ‘a tó part, saràe ora<br />
no, no’ te par? Fàme ‘rivar<br />
zo ‘na pàrticoea de pase,<br />
‘na vose fata sol de un rajo<br />
de ciaro; son qua co’e man<br />
vèrte che la spète, al scuro,<br />
co’e fete de chel pan. Za duro.<br />
(Come si mangia un pane<br />
non invocano il Nome)<br />
Bibbia, Salmi, libro primo, 14 [*]<br />
[*]: da I salmi, Einaudi, 1967, traduzione di Guido Ceronetti.<br />
Pane e parole<br />
Pane e parole // sono sempre state il mio<br />
pasto, / la mia eucaristia; sempre / è stata<br />
carestia di lusso / nella mia vita, caro Dio // tu<br />
lo sai, e sai che mai / ti ho chiesto qualcosa / in<br />
più, che sempre ciò che / mi hai donato mi è<br />
bastato // ma le parole che farciscono / quelle<br />
due fette di pane sono / ancora una volta le<br />
mie, quelle che / ho graffiato via dal ghiaccio,<br />
// dal silenzio, e la fame che / mi cresce dentro<br />
è quella / delle tue, di una sola, almeno. /<br />
Fammi sapere se ti sono caro, // se ti sono<br />
importante, falla / anche tu la tua parte,<br />
sarebbe ora / no, non ti sembra? Mandami /<br />
giù una particola di pace, // una voce fatta solo<br />
di un raggio / di luce; sono qui, fermo, con le<br />
mani / aperte che la attendo, al buio, / con le<br />
fette di quel pane. Ormai raffermo.
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
100<br />
Mòbii / Mobilità<br />
I<br />
Èco, vardéne: sen qua, tuti insieme<br />
sot’a tetòia de eternit e lamiera drio<br />
‘a segheria, un branco de pòri cristi<br />
a l’onbrìa del silo; vardéne, ‘dèss<br />
che quel del sindacato e ‘l diretór<br />
dea fabrica i ne ‘à ‘assà là da soi<br />
da soi òniun co’i só pensieri, ‘a só<br />
ansia, el rabiosón; ‘dèss che forse<br />
pa’a prima volta sen davéro tuti<br />
compagni, cussì, ligàdhi aa stessa<br />
sort. Vardéne: se ‘ven anca scanà<br />
fra de noàntri, e sbarufà, se ‘ven<br />
mandà a cagàr a volte, parché un<br />
ièra un fià lechìn, el fea ‘a spia su<br />
in ofìcio, o parché cheàltro tiréa<br />
el cul indrìo, no’l capìa un ostia.<br />
E ‘dess par squasi che se ‘vene<br />
senpre vussù ben, che sene tanti<br />
fradhèi ribandonàdhi da un pare.<br />
Calcùn l’à sgobà insieme par vinti<br />
àni, cómio co’ cómio, bestéma co’<br />
sudhór; calcùn no’l voéa pròpio<br />
savérghine de lavoràr in còpia co’<br />
cheàltro, altri i ‘à vist el só ben<br />
fiorìr drio ‘na fresa, basi robàdhi<br />
fra un toc e ‘n’antro, i fiòi crésser<br />
fra i turni e ‘l mutuo; un l’à vist<br />
un déo sparìrghe via daa man, tut<br />
a un trato, ‘n’antro se tièn duro ‘a<br />
schena, co‘l lèva su daa carègha.<br />
Mobilia / Mobilità<br />
I<br />
Ecco, guardateci: siamo qui, riuniti / sotto la tettoia di<br />
eternit e lamiera dietro / la segheria, un manipolo di poveri<br />
cristi / all’ombra del silo; guardateci, ora / che il<br />
rappresentante sindacale e il direttore / dell’azienda ci<br />
hanno lasciati soli, lì // soli ognuno con le sue<br />
preoccupazioni, la propria / ansia, il rancore; adesso che<br />
forse / siamo per la prima volta davvero / una classe, così,<br />
incatenati alla stessa / sorte. Guardateci: ci siamo anche<br />
scannati / fra di noi, e azzuffati, ci siamo // mandati a quel<br />
paese a volte, perché uno / era un po’ ruffiano, confidente /<br />
dei caporioni, o perché l’altro tirava / il culo indietro, non<br />
capiva un ostia. / E ora sembra quasi ci si sia / sempre<br />
voluti bene, tanti // fratelli abbandonati da un padre. /<br />
Qualcuno di noi ha sgobbato insieme per venti / anni,<br />
gomito a gomito, bestemmia a sudore; qualcuno non<br />
voleva assolutamente / saperne di lavorare in coppia con /<br />
l’altro, altri hanno visto il loro amore // fiorire accanto a<br />
una fresa, baci rubati / fra un pezzo e un altro, i figli<br />
crescere / fra i turni e il mutuo; uno ha visto / un dito<br />
sparirgli via dalla mano, tutto / a un tratto, un altro si<br />
tocca la / schiena, sollevando il suo corpo dalla sedia.
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
101<br />
II<br />
Ribandonàdhi, là, tel lasco scuro<br />
de chea paròea che ‘a sona dolzha,<br />
squasi gemèa de chii mòbii che ‘ven<br />
fat su, panèl dopo antina, asta dopo<br />
travèrs; chel nome pers drento ‘na<br />
storia altra, paréa, roba che capitéa<br />
sol tea Fiat, pa’ esenpio, tee fabriche<br />
massa grande, sgionfàdhe de operai,<br />
de lòte sindacài… qua pì che altro<br />
ièra sol da farse ‘l cul, a testa bassa,<br />
fra rumór e spolverón, reclamàr co’<br />
el contajozhe: ‘ché sbàtoea e dovér<br />
no’ i ‘à mai fat rima in fra de lori<br />
tel miràcoeo de ‘sto nostro nord<br />
est, croeà ‘dèss, al tenpo dea crisi.<br />
Ma vardéne, ve dise, vardéne intànt<br />
che noàntri se vardén ‘e man vòdhe,<br />
intànt che te ‘ste man, in fra i cài,<br />
‘nden in zherca de ‘sta scrita che<br />
‘é stat inpetà, co’ còea o spuàcio,<br />
no’ so, ‘sta paròea nòva che vol<br />
dir «a casa, a spasso» senza schèi<br />
chissà fin quando. Vardéne, parché<br />
sen quei che paga tuta l’ingordisia<br />
dei potenti, ‘e só barche bèe lustre,<br />
‘e só feste. Vardéne: un cuzhà drio<br />
un cantón a piàndher, un che romài<br />
le ‘à finìdhe tute quante ‘e bestéme,<br />
‘n’antro che par che l‘ te varde e<br />
invézhe l’à ‘i òci revessàdhi tel chissà.<br />
II<br />
Abbandonati, là, nel vuoto buio / di quella parola che<br />
suona dolce, / quasi gemella della mobilia che abbiamo /<br />
costruito, pannello dopo anta, asta dopo / traverso; quel<br />
nome perso dentro una / storia altra, credevamo, evento<br />
che capitava // solo alla Fiat, per intenderci, nelle aziende /<br />
troppo grandi, gonfiate di maestranze, / di lotte sindacali…<br />
qui più che altro / era solo da farsi il mazzo, a testa bassa, /<br />
fra clangore e polverone, rivendicare con / il contagocce:<br />
‘ché brontolio e dovere // non hanno mai fatto rima fra essi<br />
/ nel miracolo di questo nostro nord / est, crollato, ora,<br />
nell’epoca della crisi. / Ma guardateci, vi dico, guardateci<br />
mentre / ci osserviamo le mani vuote, / mentre fra le<br />
stesse, intorno ai calli, // cerchiamo di scorgere l’epigrafe<br />
che / ci è stata impressa, con colla o sputo, / non so, questa<br />
parola nuova che vuol / dire «a casa, a spasso » senza<br />
salario / chissà fino a quando. Guardateci, perché / siamo<br />
coloro che pagano l’ingordigia // dei potenti, i loro yacht<br />
luccicanti, / le loro feste. Guardateci: uno accasciato dietro<br />
/ un cantone a piangere, uno che ormai / le ha consumate<br />
tutte quante le bestemmie, / un altro che pare stia<br />
indagandoti e / invece ha lo sguardo rovesciato nel chissà.
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
102<br />
III<br />
Sen qua, imatonìdhi come dopo<br />
un funeràl, se sta, sfinìdhi come<br />
se se ‘vesse lavorà; po’ un se dà<br />
un sgorlón, e fando ciao co’a man<br />
para zó ‘l só magón; altri, vardéne,<br />
i dise de trovarse al bar, ‘na bira<br />
tant pa’ continuàr ‘e ciàcoe, forse,<br />
forse sol pa’ scanpàr via da là, pa’<br />
‘scondér ‘a paura, in compagnia…<br />
Vardéne ‘ncora, su, ‘ncora par poc:<br />
se se ‘brazha, se sparìsse dal piazhàl,<br />
sen in dièse, forse, ‘dèss, dei otanta<br />
che ieréssi ‘stamatina; l’é tristézha,<br />
sì, ma la ‘é ‘ncora massa fresca pa’<br />
spunciàr, e ‘lora, vardéne, a un ghe<br />
sbrissa fòra ‘na batùdha, la buta in<br />
vaca, sul scherzàr: chissà che bruta<br />
‘dèss ‘a vita, star coi cójoni in man<br />
e po’l va via, anca lu, e sen restàdhi<br />
sol in zhinque, ne vedhéo? sentàdhi<br />
sora ‘e tòe de scarto, drio ‘a muréta;<br />
altri dó i ne saeùdha, e sen restàdhi<br />
sol in tre: dó che parla e scrive l’aria<br />
co’e man, e cheàltro un fià pì in là.<br />
Quel son mì, vardéme, ve preghe,<br />
vardé co’là che a passi sòchi el se<br />
incamìna verso ‘a machina, la vèrde,<br />
el vòlta ‘a testa ‘n’antra volta parché<br />
el deve disegnàrseo tut in tea só testa<br />
‘sto momento, l’à da farlo testamento.<br />
III<br />
Siamo qui, sbigottiti, come dopo / un funerale, stiamo,<br />
sfiniti come / avessimo lavorato; poi uno si / riscuote, e<br />
salutando con la mano / inghiotte il suo magone; altri,<br />
guardateci, / si danno appuntamento al bar, una birra //<br />
tanto per lasciar proseguire i discorsi, forse, / forse solo per<br />
fuggire via da là, per / occultare la paura, in compagnia… /<br />
guardateci, ancora, dài, ancora per un poco: / ci si<br />
abbraccia, ci si eclissa dal piazzale, / siamo in dieci, forse,<br />
adesso, degli ottanta // che eravamo stamattina; c’è<br />
sconforto / sì, ma è ancora troppo fresco per / scavare, e<br />
allora, guardateci, ad uno / scappa fuori una battuta, la<br />
butta in / vacca, sdrammatizza: chissà che brutta / ora la<br />
vita, stare coi coglioni in mano // e poi si allontana, anche<br />
lui, e siamo rimasti / solo in cinque, ci scorgete? seduti /<br />
sulle tavole di scarto, lungo il muro; / altri due ci salutano,<br />
e ora siamo / solo in tre: due che parlano fra loro e scrivono<br />
l’aria / con le mani, e l’altro un po’ discosto. // Quello sono<br />
io, guardatemi, vi prego, / guardate quello lì che a passi<br />
mesti si / incammina verso l’auto, apre la portiera, / volge<br />
indietro lo sguardo un’altra volta perché / deve<br />
disegnarselo tutto nella testa / questo momento, deve<br />
farne testamento.
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
103<br />
Seràdha, ‘a fabrica, morta,<br />
romài. ‘Dèss la ‘é par davéro<br />
sol che ‘na scàtoea de cimento<br />
vòdha de vita e de fadhìghe.<br />
Drento l’é restà el fèro vècio<br />
dee machine e dee rulière, el<br />
poster dea mora co’l cul nudo<br />
che Lele ‘vea inpetà al piastro<br />
e quel del Milan tea bordatrice<br />
de Sandro, ‘i stivài e ‘a traversa<br />
de gòma che Caio uséa pa’ lavàr<br />
‘a spalmarina, el reòjio rotondo<br />
de Jijio tacà alt al muro; l’é restà<br />
‘a pólvera de osàdhe e bésteme<br />
sora i banchi, i cessi co’e porte<br />
che no’ se sèra, el brinc de fèro<br />
pa’ trar in qua i pachi de trucioeàre<br />
che un dì de barufa ‘Nando ghe ‘a<br />
moeà in testa al Ross. L’é restà tute<br />
‘e storie che là drento se ‘a frugà.<br />
Chiusa, la fabbrica, morta, / ormai. Ora è per davvero /<br />
solo una scatola di cemento / vuota di vita e di fatiche.<br />
// Dentro sono rimasti la ferraglia / dei macchinari e<br />
delle rulliere, il / poster della mora col culo nudo / che<br />
Manuele aveva attaccato al pilastro // e quello del<br />
Milan alla bordatrice / di Sandro, gli stivali e il<br />
grembiule / gommati che Claudio usava per lavare / la<br />
spalmatrice, l’orologio rotondo // di Luigi appeso alto<br />
al muro; è rimasta / la polvere di urla e bestemmie /<br />
sopra i banchi, i bagni con le porte / che non si<br />
chiudono, il gancio di ferro // per tirare a sé i pacchi di<br />
truciolato / che un giorno di baruffa Fernando / calò in<br />
testa al Rosso. Sono rimaste tutte / le storie che lì<br />
dentro si sono consumate.
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
104<br />
E cussì star qua, co’e man<br />
in man, ‘a testa scontrarse<br />
contro ‘a mura de ‘sto tenpo<br />
scuro, massa lasco, i pensieri<br />
far spiràe fra incùo e doman,<br />
‘torno un ieri che ‘l par za<br />
un passà senza ritorno romài.<br />
Star qua, co’e man restàdhe<br />
vòdhe, seràdhe su a pugno<br />
come te un sgranf de rabia,<br />
o a sofegàr l’aria che manca<br />
ai suspiri de l’ansia; operai<br />
sen, sì, quei che ‘e senpre stat<br />
carne da mazhèo, quei che ‘à<br />
da tàser, senpre, e basta, schèi<br />
che no’ basta mai, tea busta,<br />
sbassàr ‘a testa e ringrazhiàr<br />
istéss co’a ne casca tee man.<br />
Ma ‘dèss quant’eo che costa<br />
‘a desgrazhia de ‘ste ore vèrte<br />
e spòjie, de passi cussì, tant<br />
parché ‘e ore passe, un caffè<br />
al tavoìn del bar, el zhùchero<br />
da cior su, piàn, co’l cuciarìn?<br />
E così rimanere qui, con le mani / in mano, la testa<br />
sbattere / contro il muro di questo tempo / buio,<br />
troppo lasco, i pensieri // far spirale fra l’oggi e il<br />
futuro, / intorno a un ieri che sembra già / un passato<br />
senza ritorno ormai. / Stare qui, con le mani rimaste //<br />
vuote, chiuse a pugno / come in un crampo di rancore,<br />
/ o a soffocare l’aria mancante / ai sospiri dell’ansia;<br />
operai // siamo, sì, quelli che sono sempre stati<br />
considerati / carne da macello, quelli che debbono /<br />
tacere, sempre, e basta, soldi / che non bastano mai,<br />
nella busta, // abbassare la testa e ringraziare / lo<br />
stesso quando cade nelle mani. / Ma ora quanto costa<br />
/ lo spreco di queste ore aperte // e spoglie, di passi<br />
così, tanto / perché le ore passino, un caffè / al<br />
tavolino del bar, lo zucchero / da raccogliere,<br />
lentamente, col cucchiaino?
Da Co’e man monche (Con le mani mozzate), 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
105<br />
Incùo el mé fiòl pì pìcoeo<br />
l’é ‘rivà daa só camaréta<br />
co’ un pòche de machinete<br />
rote in man, rodhèe e tòchi<br />
de plastica che ghe caschéa<br />
fra ‘e piastrèe del pavimento<br />
- ‘a só voséta prima de lù, là,<br />
drio ‘l coridòio - «papà, se<br />
non riesci a trovare lavoro<br />
in una fabbrica potresti fare<br />
il meccanico che aggiusta le<br />
macchine intanto incomincia<br />
a giustare le ruote di queste<br />
mie che sono rotte». E ‘lora<br />
méterme là co’ un cazhavidhe<br />
cèo e ‘a pazhienza che no’ò<br />
mai bbu, a provàr, ‘na rodhéa<br />
cavàdha de qua e una ‘tacàdha<br />
de ‘à, a tornàr a far córer chee<br />
machinete. Chissà se ‘l destìn<br />
varà ‘a stessa pazhienza, co’<br />
mì, se ghe sarà un calcùn bon<br />
de tornàrme invidhàr i sèsti,<br />
tee man, parché ‘e pòsse tornàr<br />
a córer anca lore… pa’l pan.<br />
Oggi il mio figlio più piccolo / è arrivato dalla sua<br />
cameretta / con un mucchietto di macchinine / rotte<br />
fra le mani, ruote e pezzi // di plastica che gli cadevano<br />
/ sulle piastrelle del pavimento / - la sua vocina prima<br />
di lui, lì, / lungo il corridoio - «papà, se / non riesci a<br />
trovare lavoro // in una fabbrica potresti fare / il<br />
meccanico che aggiusta le / macchine intanto<br />
incomincia / ad aggiustare le ruote di queste // mie che<br />
sono rotte». E allora / mettermi lì con un cacciavite /<br />
da orologiaio e la pazienza che non ho / mai avuto, a<br />
cercare, una ruota // tolta di qua e una fissata / di là, a<br />
tornare a far correre quelle / macchinine. Chissà se il<br />
destino / avrà la stessa pazienza, con // me, se ci sarà<br />
qualcuno capace / di riavvitarmi i gesti, / nelle mani,<br />
affinché possano ritornare / a correre, anch’esse… per<br />
il pane.
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
Col precedente Mus.cio e roe (Muschio e spine) […] Franzin si è imposto come una deflagrazione nonostante un percorso già ben definito. Con<br />
l’attuale Fabrica […] il successo ripete ed amplia. Franzin, operaio nel profondo dell’industrioso Nord-Est italiano, analizza dall’interno (dal vero)<br />
il vivere la fabbrica, mestiere nel quale sopravvive innalzando non soltanto una bandiera della protesta civile ma restituendo la voce al popolo<br />
dei dimenticati quotidiani, quei fantasmi che appaiono nelle cronache solo in caso di morti bianche, di disastri clamorosi [...] offrendo con versi<br />
naturali e compiuti la forza possente di chi tira avanti giorno dopo giorno legato al giogo di un mestiere duro e cieco, incapace di non<br />
risucchiare dall’uomo ogni stilla di sogno o lasciare almeno intatta la dignità; la “Fabbrica” restituisce solo fatica e membra consunte,<br />
disincanto, sopraffazione, spesso un incidente, ogni tanto la morte. Franzin ci parla nello specifico di una possente segheria ed io figuravo al<br />
contempo un cementificio, con gli operai minacciati dalla silicosi; figuravo una fonderia, altro ancora, scenari mastodontici, andirivieni di cose<br />
meccaniche al servizio di cose costruite, grandi, imponenze materiali che soffocano la presenza dell’uomo, piccola comparsa il cui servigio è far<br />
funzionare la macchina, lavorare “con” la macchina e non viceversa; essere un ingranaggio aggiunto nell’ingranaggio poderoso delle macchine<br />
ma l’ingranaggio debole, quello che s’inceppa, si rompe ed al contempo è forte, è quello che resiste anche laddove la macchina non può: è<br />
l’uomo fatto di carne e caparbietà, di silenzio e straordinari, di ritorno a casa a fine giornata e domeniche in famiglia. Leggendo i testi, uno dopo<br />
l’altro, il quadro allarga: non di sé stesso parla (scrive) ma di chi come lui: gli altri attori che compongono il teatro crudo della vita operaia. Ecco<br />
le vite dei colleghi (chiamati per nome) e le disillusioni dei singoli. La scena è qui ma è anche nelle catene di montaggio nella Torino degli anni<br />
70, nelle fonderie tedesche che impiegavano operai turchi e curdi, è in una qualunque industria metalmeccanica italiana; non è solo la voce di<br />
Fabio Franzin ma la voce resa coro di un pane che per essere mangiato richiede la consumazione del corpo, richiede il sacrificio di una vita,<br />
senza scampo. Chi entra in Fabbrica (perché quello è il mestiere che offre la regione in cui si vive e niente altro è disponibile, niente altro)<br />
questo dovrà affrontare: essere divorato, lentamente nel corpo e nella mente, essiccato, reso sterile di sogni, speranze e cambiamenti, essere<br />
minacciato nel corpo se accade l’incidente, se ti viene strappata una mano o maciullato un piede; e resistere, con accanto la famiglia, con<br />
appresso il corollario invisibile di chi la vita spende senza rumore, senza grandi scene. Il volume è formato da una cinquantina di testi, ancora<br />
una volta scritti nel dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense con traduzione in lingua italiana a fronte (fatta dallo stesso autore).<br />
L’impianto sono 5 stanze composte da 5 versi e persino graficamente la composizione ricorda qualcosa della macchina: le stanze sono sfalsate<br />
in assetto, componendo i “denti” di un ingranaggio che incastra con le svasature dei testi/denti della pagina seguente. […]<br />
Fabiano Alborghetti, in www.alleo.it, luglio 2009<br />
* * *<br />
[…] …una lettura sorprendente, spiazzante, dura e assai illuminante. Si scoprirà che la poesia onesta, per adoperare la categoria stabilita da<br />
Saba che non ammetteva poesia bella o brutta ma solo onesta e disonesta, è una pianta anomala, capace, come quelle che attecchiscono sulle<br />
dune davanti al mare o nelle sabbie desertiche, di vegetare in situazioni proibitive, di annichilimento dello spirito e del corpo. […]<br />
Di questo suo ultimo libro […] il titolo enuncia seccamente la materia del dire: null’altro - ma quanto, invero - che il lavoro dentro le mura di<br />
uno stabilimento del Nord-Est, uno dei tanti capannoni grigi: «anca se / griso,’l capanon l’a ‘na / sò grazhia: squadrà,quatà / un fià scont drio ‘a<br />
zhièsa / de lauro che lo scontorna … tacà là in banda / a cheàltri, che insieme i par / squasi tanti cubeti de Lego…». Si intona presto ad un<br />
profondissimo sentimento di umanità, condivisione, fratellanza, questo canto che Franzin ha composto come un poema, articolato in due<br />
sezioni, la prima dedicata agli operai, la seconda a persone specifiche, nominate, ritratte nel dettaglio. E sullo sfondo di questo dialetto ritmico,<br />
franto, con frequenze monosillabiche che lo rendono estraneo, straniante, rispetto alla lingua nazionale - materia naturale dell’endecasillabo -<br />
si sente<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
106
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
si sente il basso continuo delle macchine, una maligna armonia che struttura e autorizza la melodia ruvida della voce poetica […]. Paradossale<br />
eppure tangibile la percezione fisica della macchina: minaccia e complicità si mescolano così come odio e gratitudine, alienazione e<br />
appartenenza. E quella voce che Franzin, con forza e coerenza, articola lungo tutto il canto è solista e coro in un solo respiro, capace, fuori delle<br />
(ormai, pare, annichilite) logiche di classe, di restituire un’anima ai gesti, un volto alle sagome, un senso alla parola: «Se resta operai anca / co’é<br />
festa, parchè no’ / basta un vistito, un bel / bagno pa’sconder via / ’na condizhion cussita / s.cèta: ‘a ‘è scrita tii cài, / tee man tute sgrafàdhe…».<br />
Isabella Panfido, da Franzin cerca l’uomo dentro i capannoni, in “Corriere del Veneto”, 25 agosto 2009<br />
* * *<br />
In alcuni manuali sindacali e nell’accordo del 5 agosto 1971, sostanzialmente ancora vigente negli stabilimenti Fiat, si apprende che i tempi di<br />
lavoro degli addetti alle linee di montaggio a trazione meccanizzata, comunemente definite catene di montaggio, sono divisi in Tempi Attivi (di<br />
attività manuale o assistenza al ciclo per la trasformazione di un prodotto), Fattore Fisiologico (computato per le necessità fisiologiche del<br />
lavoratore), Fattori di Riposo (percentuale di maggiorazione da assegnare ai tempi attivi in relazione a posture, difficoltà nell’uso dei mezzi o<br />
pesi, condizioni ambientali, stress psicofisico, ecc.). Ai tempi di lavoro si aggiungono le Pause che possono assorbire il Fattore Fisiologico e che<br />
vengono fruite collettivamente o individualmente a scorrimento, secondo le necessità produttive. Ciò che è rilevante in queste sommarie<br />
indicazioni è che l’attribuzione, lo svolgimento e la fruizione di tempi e pause sono stabilite a priori, rigidamente previste secondo tabelle,<br />
funzionali all’integrazione uomo-macchina a vantaggio della maggior efficienza di quest’ultima. In tale contesto il tempo per l’esecuzione di un<br />
lavoro è determinato e non direttamente influenzabile dal lavoratore. Tale scansione, meccanica e lineare, si ritrova nella costruzione della<br />
poesia di Fabrica … attraverso l’adozione di una serie continua di strofe di cinque versi, agganciate le une alle altre come una catena, composte<br />
in prevalenza di settenari e ottonari con tre accenti variati su altrettante sillabe. Scrive acutamente Roberto Cogo (recensione pubblicata su<br />
“Atelier” n. 55, Anno XIV, settembre 2009, pag. 122): «una struttura all’apparenza rigida, quasi meccanica, anche nel deciso effetto grafico<br />
complessivo, procede, foglio dopo foglio, sempre identica a se stessa, sfruttando gli spazi bianchi e i bordi di pagina con ampie rientranze tra<br />
strofa e strofa, fino ad assumere una valenza visiva che richiama alla mente un albero-motore o a camme, ma anche, quasi a dimostrazione<br />
della risoluta corrente provocatoria che apporta un forte impulso dinamico a tutto il libro, una specie di schiera allineata in cinque formazioni<br />
pronte ad avanzare sul campo». A contribuire al cadenzamento proprio di una macchina industriale, è una costruzione dei versi continuamente<br />
fratturata in enjambements, all’interno delle strofe e fra strofa e strofa, creando movimenti in sequenza sostenuti da rime e rime interne,<br />
apprezzabili in particolare nel dialetto usato da Franzin […]. Si tratta, dunque, di un testo a scorrimento che incatena i soggetti operai e i lettori<br />
come a un nastro trasportatore, non dissimile da quello della falegnameria industriale presso la quale Franzin lavora come operaio. Ogni<br />
palpito, emozione, ogni battere del senso di un singolo testo si lega a quello successivo, così come ogni operazione parcellizzata in una<br />
postazione di lavoro di una catena di montaggio è determinata da quella precedente e propedeutica a quella successiva. L’andamento della<br />
scrittura, nel ritmo come negli assetti narrativi, nel movimento del pensiero, nella compiutezza di un’emozione, segue dunque un Tempo Ciclo,<br />
ovverosia il tempo a disposizione di un operatore per completare tutte le operazioni assegnate alla sua postazione di lavoro. Analogamente<br />
ogni strofa, ogni testo si concludono in un tempo chiuso, legato e funzionale alla strofa e al testo successivi. Non si avverte in tal senso una<br />
cesura netta fra una poesia e l’altra, ma le due sezioni che compongono il libro, Pòri operai e Par nome, vengono lette come poemi, scanditi dai<br />
tempi netti della produzione […]. La vita, intesa come somma degli elementi che costituiscono l’individuo (vita familiare e sociale, amore,<br />
passioni, dolori) è dunque plasmata sugli assetti produttivi, sul cadenzamento dei turni e dei riposi; la fabbrica emana un effetto ‘alone’ che<br />
travolge<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
107
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
travolge ogni aspetto dell’esistenza del lavoratore, dove il tempo del lavoro «sembra fuoriuscire dai suoi confini cronometrici, invadere e<br />
asservire gli altri tempi, i quali devono ricollocarsi variabilmente seguendo l’andamento dell’orario di lavoro» (Giancarlo Cerruti in La fabbrica<br />
integrata e il tempo; a proposito dell'accordo di Termoli, Ires, Torino 1994). […] …la condizione operaia, per Franzin, è incardinata nell’individuo<br />
in tutte le sue espressioni, implacabile nella sua ineluttabilità: «Si rimane operai anche / la domenica, perché non / bastano un abito o un bel /<br />
bagno a celare / una condizione così.» Tale condizione coincide, almeno in parte, con quel processo di alienazione conseguente all’applicazione<br />
dei modelli di produzione tayloristici e fordisti che, attraverso la semplificazione e parcellizzazione di ogni operazione, rende riducibile il lavoro<br />
in singoli micromovimenti, e che si è impressa nella memoria collettiva attraverso le immagini di Tempi moderni, il famoso film di Charlie<br />
Chaplin. La misurazione e ottimizzazione di movimenti dell’operaio attraverso una tabellarizzazione in singole unità di tempo propongono un<br />
processo di disumanizzazione dell’essere umano, ridotto a elemento complementare della macchina alla quale è asservito […]. …il concetto di<br />
saturazione, cioè il rapporto percentuale tra il tempo di lavoro e il tempo di presenza in officina. Franzin sembra cogliere questo aspetto su due<br />
piani distinti. Vi si trova in prima battuta quello prettamente temporale relativo all’utilizzo del fattore lavoro, legato a quei momenti di pausa<br />
che gli operai possono concedersi. […] La pausa, l’allentamento della tensione che può provocare un difetto di fabbricazione o un incidente sul<br />
lavoro (vibranti i versi del poeta sul tema), sono visti in un’ottica di contrapposizione con i capi, i padroni, muti osservatori e giudici minacciosi<br />
delle risultanze della fatica quotidiana: «Ben lo sa il padrone quando passa / serio fra i reparti, quando si / ferma ora qua ora là / e li guarda, li<br />
fissa nelle mani». Si tratta di una continua forma di intimidazione, presente anche quando i capisquadra non si aggirano fisicamente nei reparti,<br />
che fa scricchiolare il meccanismo a scorrimento dei versi attraverso una palpabile tensione lirica, un movimento inconscio verso la paura che<br />
sfarfalla di fronte agli occhi del lettore. È appena il caso di rilevare come anche in questo caso la poesia tende a rifarsi a una dinamica<br />
prettamente industriale. […] Il concetto di saturazione del tempo nella vita di fabbrica è affrontata da Franzin anche in un’altra, e forse più<br />
rilevante, ottica. Lo spazio, incomprimibile e insostituibile, è quello del pensiero, del battito del cuore che va in direzione ostinata e contraria al<br />
movimento ripetitivo dei macchinari: «C’è spazio solo per i pensieri/ lì, in catena, perché/ non possono, non riescono / più a parlarsi fra di loro /<br />
questi operai. Ed anche se // potessero non saprebbero / cosa raccontarsi, cosa / cavar fuori dalla voce per / aiutarsi l’un l’altro, / stipati lì, tutti<br />
stretti // come schiavi ai remi / in questa moderna galea». Non è una prospettiva salvifica, è l’unica possibile nel campo d’azione del poeta. La<br />
stessa poesia non si pone come strumento di denuncia civile, almeno nella prospettiva dell’autore, ma come mezzo di contrasto capace di<br />
mostrare (e non dimostrare) l’ingranaggio alienante dell’officina. L’operaio, dunque, nella prospettiva del linguaggio non è più numero,<br />
matricola su libro paga, somma di tempi di produzione nell’organizzazione del lavoro; esso è preso come individuo, per nome, come recita il<br />
titolo della seconda sezione …: ecco comparire Renato, Luisa, Marta, Mirco, Joussouf, Roberto, Sergio, Lino, Pietro, con i loro desideri,<br />
aspirazioni, sofferenze; interagire con i Guanti, le Macchine, la Sega, il Frastuono, la Fabbrica, la Segatura, la Sirena, il Nastro trasportatore, la<br />
Lama circolare, elevati dal poeta a personaggi, anch’essi chiamati per nome. Ne emerge un quadro, carico di umanità e desolazione, che non è<br />
solo espressione della realtà industriale del Nord Est, dove Franzin vive e lavora, ma più in generale di un Paese, delle sue contraddizioni, delle<br />
precarie condizioni di lavoro, ma anche della sua inesausta fame di vita.<br />
Luca Benassi, in Rivi strozzati - poeti italiani negli anni 2000, Lepisma, Roma, 2010<br />
* * *<br />
Chi legge per la prima volta i versi di Fabio Franzin - soprattutto questi inediti tratti da una raccolta in via di pubblicazione presso Le Voci della<br />
Luna e intitolata Co'e man monche (Con le mani mozzate) - […] è un lettore privilegiato. Si ritrova davanti, senza che nessuno gli abbia aperto o<br />
distorto lo sguardo, un'evidenza nuda, incontrovertibile, priva di argomenti, il cui unico sostegno persuasivo è l'esserci stata e l'esserci, in quel<br />
momento<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
108
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
momento storico e in quei luoghi. Come davanti al diario di Simone Weil sulla condizione operaia, ma alla rovescia, in una salda e coerente<br />
inquadratura soggettiva: lo stato di mobilità di ottanta e più lavoratori dell'industria del mobile, oggi, nel Nordest in crisi. […]<br />
Le mani restano basse, o si raccolgono l'una nell'altra. Tutto partecipa dell'abbandono, in mobilità: gli operai che si ritrovano nel piazzale della<br />
fabbrica chiusa, come «fradhèi ribandonàdhi da un pare»; poi sbigottiti, «imatonìdhi come dopo / un funeràl», e stanchi, esausti come se<br />
avessero appena finito il turno. A un certo punto si allontanano, uno a uno. E dietro le fabbriche, nelle vie strette e spoglie che hanno i nomi<br />
delle regioni o delle scienze, in quelle zone industriali che si sono mangiate la terra di tutto il Nordest, anche i pezzi, gli scarti di lavorazione e i<br />
macchinari restano «ribandonàdhi», cominciano a arrugginirsi. Una sinfonia degli addii: «vardéne», «guardateci», è l'ultimo rintocco. Tenete gli<br />
occhi fissi sull'ultimo operaio che si sta allontanando, prima che sparisca. Suona così, questa appendice brutale del fordismo, per le piccole<br />
fabbriche con i turni a tamburo battente, senza tutele né prospettive, in un pezzo d'Europa che ancora non impara a crescere insieme al<br />
fatturato. E la perdita della manualità - un tema privilegiato nella storia della poesia operaia italiana - sostituisce ora il grande canto<br />
dell'orgoglio delle mani che si ascoltava in Fabrica. La realtà si è fatta obliqua, piena di salti e di curvature: l'ordine delle certezze è saltato, ed è<br />
cambiata la percezione del tempo, del paesaggio, dei rapporti familiari. Queste mani orfane dovranno imparare un modo nuovo di percepire, di<br />
accostarsi alle cose. La loro esperienza non è perduta, e dovrà agire sulle radici minuziose della meccanica della vita. Se ne avverte la<br />
percezione in forma di domanda, nel testo in cui il figlio chiede al padre operaio in mobilità di riparargli le macchinine: più che Ferruccio<br />
Brugnaro, l'altro grande poeta generazionale delle grandi fabbriche del Triveneto, si riascolta qui, contro ogni apparenza immediata, qualcosa<br />
di Zanzotto: soprattutto in quel modo di chiamare per nome la realtà, nelle sue minuzie e nei suoi frammenti devastati. […]<br />
Ciò che è stato fatto dell'esistenza degli operai - da parte di un manipolo di piccoli e medi industriali che un Gramsci di oggi non esiterebbe a<br />
chiamare parassitario - assomiglia al disastro sofferto, anno dopo anno, da quel paesaggio zanzottiano, che sempre più raramente ha potuto<br />
dare e ricevere conforto. Le mani raccontate ora da Franzin richiamano così le piante, i sentieri, i cippi del poeta del Galateo in Bosco, aprendosi<br />
alla realtà operaia come le radici alla terra. Così, la perdita del lavoro arriva come un secondo e più grave snaturamento: l'opera di una<br />
generazione lasciata in mezzo al guado, con le mani mozzate… […]<br />
Stefano Colangelo, Con le mani mozzate. La poesia operaia di Fabio Franzin, in “l’ernesto”, n. 3-4 2010<br />
* * *<br />
Un uomo senza lavoro … è «Co’e man monche», con le mani mozzate. Ci voleva questa immagine per dire la crisi, non quella dei numeri, delle<br />
banche, dei telegiornali, degli economisti, ma quella delle persone. Ci voleva questo titolo duro e le immagini, i dialoghi che vibrano nella serie<br />
delle poesie aspre, i precipizi di solitudine e di tempo vuoto a cui Fabio Franzin ha dato voce per far sentire di cosa siamo tutti corresponsabili.<br />
Non è poesia di denuncia sociale. Sarebbe poco. Perché la poesia fa denuncia totale. Non si ferma alle analisi e a cercare l’origine dei mali nella<br />
società. Perché la società la fanno gli uomini. È poesia di vita. Di tutte le dimensioni della vita. Non a caso, nelle poesie di Franzin, accanto ai<br />
testi dove sono in scena gli operai mandati in mobilità sotto la tettoia come «fratelli abbandonati da un padre», ci sono testi dove l’uomo è a<br />
casa, mentre fa lavori domestici, in giornate prive dell’impegno del lavoro, ci sono i figli, la compagna, pensieri su tutto. C’è un Nord-Est italiano<br />
duro, uomini che si trovano con le «mani inchiodate nel vuoto». Qui le persone sembrano prese in un ingranaggio più vasto dello stesso<br />
pensiero: «globalizzazione» è parola che indica un male oscuro, inafferrabile, lontano. Un fato. Così questa poesia attaccata alle ferite del<br />
presente è analoga all’eterno cantare il disagio della vita quando pare presa in un destino sovrastante. […]<br />
Davide Rondoni, in Denuncia sociale. Anzi: totale, “Domenica de Il Sole 24ore” n°6/2011, 6 febbraio 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
109
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
Se l'allegoria del quarto stato, alla vigilia delle grandi lotte operaie, mostra corpi fieri di uomini e donne che avanzano verso il futuro,<br />
provenendo dal buio del passato, Co’e man monche …, alla fine delle grandi lotte, ci dà l'immagine di indumenti bianchi stesi al vento, camicie<br />
«monche di mani, come in una richiesta di aiuto [...] in una guerra persa». Tristi come «bandiere bianche di resa». Tra questi due pilastri c'è la<br />
storia del movimento operaio del Novecento, un ponte gestito da sindacati e imprenditori, dove di rado gli operai hanno deciso per conto<br />
proprio. E ancor meno lo possono fare adesso, visti i ricatti del capitale per mantenere il lavoro nelle grandi aziende: riduzione della pausa,<br />
flessibilità, sospensione premi produzione eccetera. Fabio Franzin non ci racconta l'iter contrattuale di una sconfitta, ma la disperazione che ne<br />
segue, nei suoi momenti concreti: il sentimento di malessere di fronte ad una vita da cassaintegrati (tra passeggiate senza meta, bar, tv e<br />
inadeguatezza nei lavori domestici, liti familiari) e la tristezza per il degrado in cui sprofondano le zone industriali, con «capannoni spenti»,<br />
«ruggine» ovunque e silenzio cimiteriale, tanto da tratteggiare un morto reliquiario, non orto montaliano, ma reticolo della vita activa dove, un<br />
tempo, gli uomini hanno goduto e sofferto, per essere infine cacciati nell'inferno della vita inattiva, che è condizione priva di senso non soltanto<br />
per una cultura operosa come quella del nord-est, ma per tutta quella occidentale moderna. Restando legato alla propria esperienza, Franzin<br />
scrive "nord-est" spezzandolo, "nord / est", dando così evidenza all'irrimediabile rottura del fondamento che nutriva non soltanto i corpi, ma<br />
l'identità stessa di ciascuno, tramite i valori acquisiti (lavoro, virilità, denaro, sacrifici, famiglia, ruoli all'interno della stessa) ora venuti a<br />
mancare o a mutare. […] Più che classe … direi popolo destinato al martirio da un potere inavvicinabile, con quella vocazione cristiana che<br />
permea da sempre la parola di Fabio, stavolta però priva di speranza, perché l'unità non è nel progetto, ma - paradossalmente - nelle coscienze<br />
lacerate, ora che l'ideologia passa sopra le teste, che occorre fare i conti con la sopravvivenza concreta e che l'operaio, si sente orfano, lasciato<br />
solo e incompreso persino dalla moglie.<br />
Insieme a questa voce collettiva, testimone di uno sfacelo epocale, opera un secondo registro, in cui l'autore mostra le proprie piaghe e chiede<br />
che siano riconosciute nella loro autenticità. Entrambe le linee tracciano un disegno complessivo che non consola, non attenua la drammaticità<br />
della situazione, come in qualche modo succedeva in Fabrica. Per questa ragione condivido quanto mi scrive in privato Francesco Tomada,<br />
rilevando la superiorità di questo libro rispetto al precedente, in quanto è «capace di tracciare» non un manifesto della classe operaia, ma «la<br />
voce e il corpo della precarietà umana, che sempre più spesso affonda le radici in quella lavorativa». […]<br />
Stefano Guglielmin, in “blanc de ta nuque”, www.golfedombre.blogspot.com, 28 aprile 2011<br />
* * *<br />
…Fabio Franzin sembra aver ingaggiato, per il tramite della scrittura, una lotta corpo a corpo con un destino contrastato, iniziato con<br />
l’emigrazione dei suoi genitori a Milano, dov’egli stesso è nato nel 1963, proseguito col ritorno nel trevigiano nel 1970, inseguendo le<br />
fanfaluche del nascente miracolo del Nord Est, e concluso, per ora, con la tragica esperienza della perdita del lavoro. […] L’approdo alla poesia<br />
nei libri che lo hanno imposto all’attenzione della critica, con l’avallo prestigioso di figure come Serrao, Voce, Pecora, Piccini, Loi, Guglielmin e<br />
Ladolfi, pare per certi versi mosso dal bisogno di una sorta di risarcimento lirico a fronte di una vita messa a dura prova dall’allontanamento<br />
coatto dagli studi e dal precocissimo avviamento al lavoro operaio. […] …l’onda lunga della recessione, partita dalla spregiudicata provincia<br />
americana, si è abbattuta anche sulla più conservatrice provincia italiana, e allora la lingua di Franzin viene strappata alla calda sentimentalità<br />
della prima stagione e piegata (ma con più naturalezza che costrizione) al dovere di testimoniare un paesaggio violentato forse<br />
irreversibilmente da capannoni e strade improvvisamente inutili… ’Dietro il paesaggio’, dunque, la poesia pare ora richiamata all’urgenza di<br />
cercare non più il soggetto individuale, la sua coscienza o il mistero delle più intime risonanze, bensì la dimensione collettiva e persino<br />
sociologicamente determinata dell’operaio, doppiamente sconfitto: prima privato della propria coscienza di classe, depoliticizzato e spesso<br />
anche cercare<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
110
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
anche desindacalizzato, e poi tradito nella propria aspirazione dall’inserimento in un’informe e indifferenziata middle class con un destino e con<br />
un salario protetti. Fabrica … dà cittadinanza poetica ai lavoratori dell’industria, non alla loro classe, dunque, ma ai singoli ora costretti a<br />
misurarsi con l’impoverimento e la paura degli infortuni e del licenziamento, con l’aggravio della solitudine, frutto di una pluridecennale<br />
frattura dei vincoli di solidarietà e della conseguente cannibalizzazione dei luoghi di lavoro. […] …l’umiliazione del lavoratore, ripensato ora<br />
attraverso le categorie dell’alienazione così ben visitate nel secondo Novecento da Volponi, sovrapposte a quelle dell’incomunicabilità<br />
campionate in letteratura da Moravia e nel cinema da Antonioni, si moltiplica nella visione della fabrica come «tiatro» dove si recita «’na<br />
comèdia inbastìdha / co’ dò sèsti e tre bestème» («con due gesti e tre bestemmie»), nella quale per un fortunato che può giocare la parte del<br />
«parón», tanti altri devono accontentarsi di «dir sempre: servo suo, / comandi!», come fossero Arlecchini e Colombine in tuta blu… […] La<br />
bellezza di queste poesie sta nel coraggio con cui parole così poco poetiche come «oliaccio, segatura, macchine, reparto, lattice, chiave inglese»<br />
e infinite altre rivendicano il proprio diritto alla testimonianza e all’elaborazione della comunità industriale come piano di laboratorio per<br />
un’analisi acuminata e risentita delle dinamiche di sfruttamento ed esclusione proprie della società del capitalismo decadente: e un certo tono<br />
epico, di un’epica minore s’intende, non eroica e magniloquente, ma prosaica e dolente, è raggiunta nella seconda sezione … dove i nuovi<br />
Ulisse, Enea e Orlando si chiamano Renato, Joussouf e Marta e lottano contro «chii granèi de Segadhura» che graffiano le mani e penetrano fin<br />
dentro i calzini, contro le aste che scorrono troppo rapidamente «sora i rui» (sopra la «rulliera») e cascano a terra suscitando le «bestéme» del<br />
capo, e nel frattempo sperperano «’a beézha» («la bellezza») dei loro quarant’anni, grattandosela via «co’a carta de véro». E proprio perché la<br />
vita di questi individui deve contendere al nulla la propria identità e dignità, ecco che ai pochi che conservano un nome si affiancano i molti che<br />
invece non ce l’hanno più, quasi che in loro si sia compiuto il sortilegio della massificazione, opera di un apprendista stregone che, più perfido di<br />
quello di Goethe, conferisce, di contro, una volontà soggettiva (e con essa il privilegio dell’iniziale maiuscola) al Nastro trasportatore, alla<br />
Sirena, alla Lama circolare e agli altri demoni mostruosi del sabba industriale. … c’è ancora lo spettro del fallimento delle fabbrichette con la<br />
cassa integrazione e poi il licenziamento, com’è accaduto nell’ottobre 2009 allo stesso Franzin, dopo esattamente trent’anni trascorsi nel<br />
medesimo mobilificio; ed ecco pronta la ‘reazione’ poetica, la registrazione quasi in tempo reale di questa nuova e impreveduta lacerazione,<br />
grazie all’uscita, nel gennaio del 2011, di Co’e man monche (Con le mani mozzate), ventotto nuove liriche, impreziosite da tre prose nel<br />
medesimo dialetto trevigiano e da sei fotografie della giovane Anna Visini, che sa trasformare i capannoni industriali abbandonati, arrugginiti e<br />
fradici di umidità, in metafisici monumenti di un sogno di grandezza, fallito nelle miserande contraddizioni del capitalismo. …il tono ora si fa più<br />
struggente che in quello del libro precedente, come se Franzin ora volesse musicare il proprio requiem per le esequie non solo della sua<br />
regione, ma di un’intera massa di derelitti, vittime incolpevoli di calcoli sbagliati il cui conto finisce sulle bollette sbagliate… Parallelamente,<br />
anche la metrica - che è ritmo per l’orecchio e forma per l’occhio - assume la regolare gravità di un thrênos, qui fatto di quartine, che<br />
divengono sestine solo nella seconda sezione, che gioca sulla paronomasia delle parole «mòbii», quei mobili a cui l’autore aveva dedicato tutta<br />
la sua vita di lavoratore, e «mobiità», «paròea che ’a sona dolzha, / squasi gemèa» («parola che suona dolce, / quasi gemella») e invece<br />
nasconde la dura sentenza della precarizzazione dell’esistenza, una di quelle voci che il dialetto non conosceva, ma che è costretto a recepire<br />
pressoché immutato dall’algida lingua dell’economia. La somiglianza delle due parole svela con intelligenza il carattere proprio del processo<br />
omeopatico attraverso il quale il sistema anestetizza i conflitti potenziali: i contenuti opposti (in questo caso il lavoro e la sua assenza, in altri<br />
casi il diritto e la sua abrogazione) vengono avvicinati, assimilati sul piano del referente, attraverso una comunicazione paternalistica e<br />
tranquillizzante, disarmante in senso stretto. Questo nega evidenza alla drammaticità di una condizione collettiva e spezza i vincoli di<br />
solidarietà sociale e nazionale, lasciando ai singoli la scelta obbligata dell’assuefazione e della rassegnazione. […]<br />
Daniele Maria Pegorari, in www.poesia2punto0.com, maggio 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
111
Su Fabrica e Co’e man monche<br />
[…] Il disoccupato diventa l’immagine della “solitudine del cittadino globale”, vittima di poteri, di ragioni, di scopi a lui ignoti, dipendente, come<br />
i protagonisti dei romanzi di Kafka da un misterioso destino “non a misura d’uomo”, disperso su un pianeta, diventato improvvisamente opaco.<br />
Alla condizione di “sfruttato”, che pure conferiva identità, segue la condizione di “essere-per-il-nulla”, di individuo privo di progettualità, privo<br />
di valore umano, di capacità di incidere sulla produzione materiale e sulla relazione sentimentale, sfiduciato, inutile, inadeguato nei confronti<br />
del suo essere uomo, dell’essere padre, dell’essere marito, dell’essere cittadino, amico, parente … […] E il cittadino globale si sente, pertanto,<br />
straniero in patria, emigrante nella terra in cui è nato, «parché i ghe fa sparìr el domàn» («perché gli viene cancellato un futuro»). Questa è la<br />
vita, questa è la vera poesia. Si potrà discutere all’infinito di estetica, di poetica, di retorica, si potranno individuare le metafore evangeliche e le<br />
occorrenze lessicali, ma non si potrà mettere in dubbio che il lavoro di Franzin non nasce da elucubrazioni mentali, da progetti letterari; pulsa di<br />
tragedia; è poesia che nasce dal sangue, dalle lacrime, dal disfacimento di esistenze, dall’annullamento dell’individuo. Ci troviamo di fronte ad<br />
una lirica universale, perché non si lascia sedurre né da proclami politici e tanto meno da rivolte ideologiche; qui la tragedia germina sulla pelle<br />
di persone concrete, di luoghi reali, di situazioni palpabili. […]<br />
Giuliano Ladolfi, in “Atelier” n. 62, 2011<br />
* * *<br />
[…] Partiamo dunque dal titolo, ’E man, ‘Le mani’, che si presta a qualche ragionevole congettura sulla istintiva riarticolazione della tradizione<br />
letteraria della poetica di Franzin, che guarda, sì, senza nostalgie neometriciste, alle forme di una tradizione (da Giotti a Marin a Zanzotto…),<br />
com’è stato più volte appurato da altri attenti lettori (ricordo almeno Manuel Cohen e Edoardo Zuccato), e non perde i contatti con una lingua<br />
‘lirica’, che non significa patinata, se è vero che recupera, oltre le soglie di un immaginario standardizzato, una sua energia referenziale.<br />
Tornando al titolo, ne ’E man’ non è impossibile riascoltare la bella mano di Laura, trascorsa dal Canzoniere petrarchesco attraverso le ampie<br />
rotte della poesia cortigiana quattrocentesca (basti ricordare Giusto de’ Conti, che ne farà il nodo tematico della sua produzione di rime), lungo<br />
i molteplici rivoli del petrarchismo cinquecentesco. La bella mano dell’amata si riaffacciava, come l’elegante fantasma di un’epoca lontanissima,<br />
e non saprei quanto (e non mi pare sia necessario saperlo) casualmente, anche nel titolo rude intenso di Co’e man monche. Ma dal singolare al<br />
plurale, dalla sineddoche alla metafora, dalla ‘mano’ bianca e tersa di una donna irraggiungibile, persino intangibile, alle ‘mani’ sporche, sudate<br />
sulle presse, fra gli ingranaggi unti, offese e mutilate degli operai, insomma da un simbolismo smaterializzato a un realismo materialista, la<br />
poesia di Franzin mi sembra che realizzi pienamente un lungo percorso partito a Novecento inoltrato - per lo meno da Tre operai di Carlo<br />
Bernari - che legge nel nostro corpo non un destino ultraterreno, ma il segno di una distinzione di classe, di una condizione stigmatizzata dalla<br />
storia, come per esempio - si legga Na cica drio cheàlta pa - nei «calli» che hanno indurito la nostra sensibilità al mondo, o - pensiamo a Dopo<br />
dó mesi de cassa integrazhión - in quell’«eczema», in quel «prurito» che squama via la pelle, inchiodando le mani a un «vuoto» che trascende la<br />
diagnosi del dermatologo, la rassicurante esegesi degli effetti psicosomatici. Queste stesse mani che difendono il lavoro servono però a<br />
prendere l’eucarestia e a pregare un dio che non pare tanto trattenuto lontano dagli affari umani quanto perduto in qualche angolo<br />
dell’universo. È il dio del silenzio, scrive Franzin in Pan e paròe («Fàme saver se te son caro, / se te me tièn de cont, fàea / anca ti ’a tò part…»),<br />
che lascia il poeta in attesa, «co’e man / vèrte che la spète, al scuro, / co’e fete de chel pan. Za duro». Dal primo all’ultimo testo di questa<br />
silloge ci troviamo davanti a un personaggio che gesticola, afferra e lascia, cerca con le sue mani un modo per trattenere intorno a sé un mondo<br />
che sfugge, cambia direzione, ribalta le premesse, perde senso. Mani che lavorano e mollano pezzi … o grattano via dal corpo una bellezza …;<br />
mani che cercano di riavvolgere la fragile catena biologica delle generazioni, travolte, ovvero ‘stravolte’ da un succedersi slogato di esistenze<br />
che si incontrano solo nello spazio privato ma generoso di una pagina… […]<br />
Salvatore Ritrovato, in Guardando per terra - Voci della poesia contemporanea in dialetto, Lietocolle, 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
112
Da Canti dell’offesa, 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
113<br />
Povere statue. Mai state scolpite<br />
mai state toccate da arte o scalpello<br />
scaricate dalla stiva sull’asfalto<br />
bollente dell’estate stese e per le<br />
storte pose degli arti derise. Statue<br />
del gelo nell’algore che ci avvolge.<br />
Impresse nel display di qualche<br />
telefonino quale esotica immagine<br />
di viaggio da mostrare ai mostri amici<br />
le angurie fresche a fette nei tavoli<br />
il ghiaccio nei cocktails a cubetti<br />
quel ghiaccio triturato dai sorrisi.<br />
Il 14 luglio 2007, nell’area di servizio Bazzera, a Mestre,<br />
da un camion-frigo tedesco che trasportava angurie,<br />
furono estratti i corpi congelati di tre clandestini iracheni.<br />
I giornali raccontarono le risa divertite dei turisti di<br />
passaggio, le foto ricordo fatte coi telefonini.<br />
Perché è sempre sempre stato<br />
lo straniero il capro espiatorio<br />
di una società quando cieca si<br />
ammanta di un’aurea innocenza<br />
per il carnevale delle colpe ed è<br />
storto il dito che punta al troppo<br />
comodo torto di pelle e di razza<br />
è monco e indica spesso colui che<br />
non c’entra e l’altra mano quella<br />
che stringe la pietra del linciaggio<br />
è corrotta dalla convenienza neanche<br />
si accorge di indicare lo specchio.
Da Canti dell’offesa, 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
114<br />
Lo strazio di questi sgomberi forzati<br />
fra viadotti e incolti di periferia le ruspe<br />
in azione a spazzar via lamiere cartone<br />
far macedonia in fango e pozzanghere<br />
ciabatte colorate maglie arti di bambole<br />
donate dalla caritas; bonificare l’area<br />
è il gergo giuridico che indica diritto<br />
da una parte e offesa dall’altra l’offesa<br />
al genere umano costretto a vivere fra<br />
ratti e baracche il cinismo di chi si indigna<br />
perché quei ghetti turbano l’estetica del<br />
luogo non sono in sintonia con l’ordine<br />
le cancellate dei recinti civili. Triturare far<br />
macerie della miseria cancellarla dalla vista<br />
questa ora l’area dell’anima da bonificare.<br />
Senti anche il respiro come sospiro<br />
l’aria più pesante nonostante sia<br />
stata depredata di saluti e confidenze<br />
come suona di carta strappata il soffio<br />
che passa fra le cose intriso dell’acido<br />
polline di promesse e scongiuri. Senti<br />
come graffiano in gola le schegge della<br />
rovina pensa a quei sedimenti lo scoglio<br />
che si forma all’interno del costato.
Da Canti dell’offesa, 2011<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
115<br />
È che non è neanche più questione<br />
di come o di cosa uno si accontenti<br />
la miseria è sempre iena e la dignità<br />
il moncone che nessuno può esporre<br />
al mondo ormai senza vergogna. La<br />
matassa il reticolato irto e grigio là<br />
calcato sopra le ansie e le preghiere<br />
di mia madre: Testanera è una bella<br />
pubblicità che promette di ricoprire<br />
a lungo la ricrescita. «Sì, mi balla<br />
la dentiera, altro che parrucchiera»<br />
dice «mi fanno male le gengive»<br />
è solo il male a far rima con sociale<br />
oggi per chi si ostini a continuare<br />
a vivere oltre l’età contributiva.<br />
Ma siamo proprio noi quelli là<br />
quelli che compaiono così allegri<br />
e minchioni nei video fatti in casa<br />
col telefonino il pollice alzato alla<br />
Fonzie come in un autostop verso<br />
il nulla pronti a gridare Italia Uno?<br />
a urlare in coro dal video di fronte<br />
a qualcuno stravaccato sul divano<br />
col suo telecomando stretto in mano<br />
la mente come un sacco da riempire<br />
di sangue e spazzatura lo sguardo<br />
a catturare il capezzolo affiorante<br />
la spallina lasca ad arte la scena<br />
del mercato devastato dalla strage.<br />
Siamo noi? Chi? Chi siamo? Noi.
Su Canti dell’offesa<br />
Fabio Franzin tenta … di dare voce alla crisi economica che ci attanaglia …,pericolosa avvisaglia di una ben più profonda crisi antropologica […].<br />
Conosciuto finora come autore in dialetto veneto, lo fa stavolta con poesie in italiano, lingua che è più diffusa, ovviamente, ma forse più<br />
anonima, più veicolare che materna per un poeta abituato ad adoperare il dialetto. Forse la scelta sottolinea i tempi, dunque, e l’esigenza di<br />
una lingua che sia più vasta, com’è vasta la crisi … e più estranea ai suoi stessi parlanti, com’è il tipo umano che è insieme vittima e attore di<br />
questa crisi. […] Il dispositivo che fa scattare la poesia di Franzin è sempre sentimentale, in senso positivo, cioè di partecipazione dell’Io alle<br />
vicende sociali, che diventano anche vicende personali, sia per l’implicazione concreta ed esperienziale dello scrittore con la situazione di crisi,<br />
sia perché è questa partecipazione, si direbbe, lo scopo poetico stesso del suo operare. […] Intanto il sogno di giustizia sociale ed equità<br />
economica, che doveva portare ad una felicità ancor prima che ad un benessere, si è perduto in un’assenza di senso, tanto da far sorgere il<br />
reclamo: «Ma era proprio così il mondo / che sognavamo?»; domanda retorica perché, evidentemente, il sogno si è smarrito. Ciò che emerge è<br />
proprio il non senso, tanto che «ora è anche per noia che si violenta». Antiche paure di un continente un tempo centro della civiltà ed oggi<br />
sfigurato dal potere […] riemergono nel presente […]. Proprio quella civiltà che vedeva l’altro come valore si sta perdendo […]. Così la voce del<br />
poeta, che è a tratti intenerita o dura, che usa una discreta invettiva ma a volte si volge quasi alla preghiera, tentenna tra richiesta e mutismo,<br />
riconoscendo «l’assurda verità del suo invocare». Non si può far altro che ripartire descrivendo il poco che si sa, «le schegge / della rovina». Di<br />
tutto il resto, di tutto il profluvio di informazioni e di news con cui sembrano raccontarci la realtà, a ben guardare ci rimane poco, in termini di<br />
conoscenza. In fondo «cosa mai ne capivamo noi di borsa / economia»? Si tratta di un’ultima stoccata alla società dello spettacolo,<br />
clamorosamente decaduta anch’essa. L’apparenza ha preso il posto di ogni parvenza di verità; una finzione sciatta, assurda e stupida pretende<br />
di raccontarci il mondo. Basterebbe così poco per accorgersene, per provare la pena del poeta: «che pena / però vedere Platinette al posto di<br />
Pasolini». Lo spettacolo ingloba i suoi stessi spetta tori, nell’estrema menzogna di renderli protagonisti degli eventi […]. Basterebbe, sì, davvero<br />
poco per rendersene conto, basterebbe la parola fragile e, in verità, pericolosissima per il potere (a proposito di Pasolini…) della poesia. Si<br />
potrebbe tornare a compatire gli altri, cioè ad appassionarsi con loro del destino comune, ad adirarsi per la giustizia che non c’è, per il pane che<br />
manca, per lo sciatto e finto essere umano che stiamo generando.<br />
Gianfranco Lauretano, dalla Prefazione<br />
* * *<br />
A metà fra il Dylan delle canzoni di protesta e il Matteo Salvatore delle canzoni di denuncia sociale, a metà fra la poetica rabbiosa e sferzante di<br />
Trilussa e le parole amare di Pennacchi, Fabio Franzin lancia con questi Canti dell’offesa il suo urlo primordiale. Versi potenti, scarni, diretti,<br />
contro la tirannia dei potenti e contro l’impoverimento materiale, ma soprattutto culturale, del nostro tempo. Come non riconoscersi nei suoi<br />
versi, versi che non sono diretti a nessuno in particolare, eppure versi che appartengono a tutti noi. Versi monolitici, che non conosciamo ma<br />
RICONOSCIAMO, come le montagne, come il mare. Se, dopo la pubblicazione delle opere di Primo Levi, nessuno ha più potuto dire di non<br />
essere mai stato, seppur per un istante, ad Aushwitz, leggendo questi “canti” nessuno potrà più dire di non essere mai stato un operaio,<br />
nessuno potrà più dire di non sapere cosa significhi essere precario, sia economicamente che spiritualmente. Questo ci insegna Franzin: che la<br />
precarietà, più che una condizione di vita, è un sentimento, uno stato d’animo. Lo stesso stato d’animo delle celeberrime foglie autunnali<br />
cantate da Ungaretti, precariamente appese agli spogli rami, in balia delle raffiche di vento potenzialmente fatali.<br />
Un’opera matura quindi, forse una delle opere più compiute del poeta veneto che, conscio della sua maturità artistica ha giustamente optato<br />
per uno stile più asciutto, quasi telegrafico, eppure spietatamente efficace.<br />
Alessio Franzin, CANTI DELL’OFFESA, una recensione di parte<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
116
Inediti. Da Tape del calvario (Tappe del calvario)<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
117<br />
L’é stronzo co’là, e basta<br />
Anca incùo, tre de agosto domìe e undese,<br />
intànt che ‘e borse brusa mièri de miliardi<br />
e tuta l’economia del mondo ‘a ghe sbrissa<br />
via dae man sporche e sbusàdhe dei póitici,<br />
anca incùo son qua sot el sol che vae ‘torno<br />
fra capanóni vèrti e altri seràdhi opùra vòdhi,<br />
son qua che vae in zherca de ‘na fabrica che<br />
no’ son bon de catàr, Formaplast ‘a se ciama<br />
e core vose che ghe serve operai. Son qua pa’<br />
presentàr ‘a domanda, ‘a via la ‘é quea justa,<br />
‘ò controeà tre volte tea carta… l’unica ‘lora<br />
l’é provàr ‘ndo’ che i cancèi i ‘é spaeancàdhi<br />
e no’ l’é nome tel canpanèl, ‘ndo’ che no’ i ‘à<br />
‘ncora serà pa’e ferie. Me ‘vizhine a un de chii<br />
capanóni co’i portóni in sfesa, òce bobine e<br />
scafài, tasse de panèi, rulière e machinari…<br />
da in fonde un sora el muét me fa segno co’a<br />
man de fermarme, me varde indrìo, son ‘ncora<br />
sol tel piazhàl, no’ò passà nissùn confìn, nissùn<br />
accesso vietà, quel co’l muét el continua vègner<br />
‘vanti co’a man alta come ‘a paéta de un vigie,<br />
el me ‘riva vizhìn, e mèdho inrabià el me dise<br />
còss’ che fae, còss’ che vui, drento là; conósse<br />
chea vose, precisa a quea de Bairam, o de Aliù,<br />
‘ven lavorà sète àni tel stesso reparto prima<br />
È stronzo lui, e basta<br />
Anche oggi, tre agosto duemilaundici, mentre le borse<br />
bruciano migliaia di miliardi / e l’economia del mondo intero<br />
sguscia / via dalle mani sporche e bucate dei politici, //<br />
anche oggi sono qui sotto il sole che vago / fra capannoni<br />
aperti e altri chiusi o abbandonati, / sono qui che vado in<br />
cerca di un’azienda che / non riesco a rintracciare,<br />
Formaplast si chiama // e corre voce stia assumendo<br />
personale. Sono qui per / presentare la domanda, la via è<br />
quella giusta, / ho controllato tre volte sulla carta… Non mi<br />
rimane allora / che tentare dove i cancelli sono spalancati //<br />
e non c’è nome sul campanello, dove non hanno / ancora<br />
iniziato le vacanze. Mi avvicino ad uno di quei / capannoni<br />
dai portoni accostati, intravedo bobine e / scaffali, pile di<br />
pannelli, rulliere e macchinari… // dal fondo del magazzino<br />
uno in cima a un carrello elevatore a gesti / mi intima di<br />
fermarmi, mi guardo intorno, sono ancora / soltanto nel<br />
piazzale, non ho varcato nessun confine, nessun / accesso<br />
vietato, quello sul carrello continua ad avanzare // con la<br />
mano alta come la paletta di un vigile, mi si avvicina, e con<br />
un’aria nient’affatto amichevole mi chiede / cosa ci faccia lì,<br />
di cosa sono in cerca là dentro; riconosco / quella voce, la<br />
stessa pronuncia di Bairam, o di Aliù, // abbiamo lavorato<br />
sette anni nello stesso reparto prima /
Inediti. Da Tape del calvario (Tappe del calvario)<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
118<br />
che i serésse ‘a fabrica, ‘ò fat de chee barùfe<br />
co’ quei un fià razisti, ‘pena che i ‘é ‘rivàdhi,<br />
che anca ‘dèss co’ i me cata in piazha i vòl<br />
senpre pagarme el cafè. ‘Sto qua ghe somèjia:<br />
stessa barba longa, stessa maja smarìdha e curta,<br />
el par squasi un só sosia, no’ fusse che no’l ride<br />
intànt che ‘l me parla. No’a ‘é quea ‘a fabrica<br />
che zherche, e no’l sa ‘ndo’ che ‘a sie, però<br />
el me ricorda serio de ‘ndar fòra dai cancèi,<br />
suìto, l’é sora un muét e ghe par de èsser sora<br />
a un caro armato, co‘e pàe alte el me para via.<br />
Son qua, fòra dai cancèi che lù l’à za serà su,<br />
son qua che cète ‘a rabia inpizhàndo ‘na cica.<br />
Sotvose me dise che ‘ò fat ben a no’ voér zhigàr<br />
anca mì via i forèsti. L’é stronzo co’là, e basta.<br />
che chiudessero la fabbrica, ho fatto di quelle baruffe /<br />
per difenderli da quelli un po’ razzisti appena<br />
arrivarono, / che anche adesso quando mi incontrano<br />
in piazza vogliono // sempre offrirmi il caffè. Questo qui<br />
gli assomiglia: / stessa barba incolta, stessa maglia<br />
sbiadita e troppo corta, / sembra quasi un suo sosia,<br />
non fosse che non sorride / mentre mi parla. Non è<br />
quella l’azienda // che cerco e non sa dove sia, però /<br />
mi ricorda minaccioso di uscire dai cancelli /<br />
immediatamente, guida un carrello e gli sembra di<br />
essere sopra / a un carro armato, mi spinge fuori con le<br />
staffe all’altezza del mio petto. // Sono qui, oltre il<br />
cancello che lui ha già richiuso, / sono qui che domo la<br />
rabbia accendendomi una sigaretta. / Sottovoce mi<br />
convinco che / ho fatto bene a non unirmi al coro che<br />
urlava / via da qua gli immigrati. È stronzo lui, e<br />
basta.
Inediti. Da Tape del calvario (Tappe del calvario)<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
119<br />
Ajenzie interinài<br />
Sen in fia, zent da òni part del mondo,<br />
drio ‘a porta de ‘ste ajenzie interinài,<br />
sen in fia, oniùn co’a só carta in man,<br />
‘a speranza fiapa. ‘E tose drio ‘l banco<br />
òni tant ‘e sbufa, ‘e rebalta ‘i òci verso<br />
el sufìto come sante in estase tii quari<br />
del rinassimento. No’ un dio tea visión<br />
però, ma sol ‘na processión de pòri cristi<br />
che insiste, prega, domanda in imòsena<br />
un lavoro che no’ l’esiste pì, pa’ nissùni,<br />
che no’l se crea nianca co’ un miràcoeo.<br />
Sen in fia, strachi de star in coda pa’ nient,<br />
de tornàr indrìo co’i sòiti pensieri. Fòra<br />
l’è za scuro, fòjie zae sóea zo dae rame,<br />
un vent rabioso l’é fa córer tel ‘sfalto,<br />
le para drento ‘e pòce slòzhe. Ècoe qua<br />
‘e nostre speranze, èco ‘ndo’ che ‘e va<br />
a finìr. Fra poc el jazh le fermerà, là co’<br />
lù, fra poc sarò casa da mé fiòi, dai òci<br />
bèi de mé feména, e no’ ‘varò coràjo<br />
de incrosarli, no’ ‘varò paròe, par lori.<br />
Agenzie interinali<br />
Siamo in fila, genti da ogni parte del pianeta, / dietro<br />
la porta di queste agenzie interinali, / siamo in fila,<br />
ognuno col suo curriculum in mano, / la speranza<br />
fioca. Le addette oltre il banco / ogni tanto sbuffano,<br />
volgono lo sguardo / al soffitto come sante in estasi<br />
nei dipinti / del rinascimento. Non un dio la visione /<br />
però, ma solo una processione di poveri cristi / che<br />
insistono, pregano, chiedono l’elemosina / di un<br />
lavoro che non esiste più, per nessuno, / che non si<br />
crea neanche con un miracolo. / Siamo in fila, stanchi<br />
di stare in coda per niente, / di ritornare indietro coi<br />
soliti grattacapi. Fuori // è ormai buio, foglie gialle<br />
volteggiano giù dai rami, / un vento rabbioso le fa<br />
correre per l’asfalto, / le depone dentro le<br />
pozzanghere. Ecco / le nostre speranze, ecco dove<br />
vanno / a finire. Fra poco il ghiaccio le chiuderà, lì<br />
con / esso, fra poco sarò a casa dai mie figli, dagli<br />
occhi / belli di mia moglie, e non avrò coraggio / di<br />
incrociarli, non avrò parole, per loro.
Inediti. Da Tape del calvario (Tappe del calvario)<br />
Fabio<br />
Franzin<br />
120<br />
Curiculum<br />
No’ so, forse me sarò anca sbajià,<br />
forse no’l iera ‘l mé curiculum quel<br />
che ‘a segretaria bionda l’à fat su<br />
te un baeòt, e po’ butà sot ‘el banco,<br />
sot’ el só sorìso gentìe, el conpiuter,<br />
el teèfono «attenda in linea, vedo se<br />
è libero». Ma son vignù fòra rosegà<br />
da un brut dubio «ha compilato tutto?<br />
i recapiti telefonici li ha trascritti?»<br />
da che l’ofìcio lindo, pièn de vetrate<br />
e piante e divaneti rossi, giornài de<br />
barche e cavài da sfojiàr. L’é stat un<br />
rapresentante che spetéa de ‘à, sentà<br />
te chealtra saéta, ‘a só sagoma scura<br />
in jessàto a schermàr al vero, a farlo<br />
spècio che mostra ‘l sèst de chii déi,<br />
dea man, fra ragno e pugno intant che<br />
verdée ‘a porta. Forse ‘l mé toc de carta<br />
lo ‘vea za mess zo, forse ‘a baéta drento<br />
el zhestìn ièra un só apunto che no’<br />
servìa pì, sì, chissà. Forse me sarò<br />
anca sbajià, o forse l’é sbainà ‘sto<br />
tenpo, che sbrana senza pì ‘baiàr.<br />
Curriculum<br />
Non so, forse mi sarò anche sbagliato, / forse non<br />
era il mio curriculum quello / che la segretaria<br />
bionda ha appallottolato / fra le mani, e poi gettato<br />
sotto il bancone, / sotto il suo sorriso cordiale, il<br />
computer, / il telefono «attenda in linea, vedo se / è<br />
libero». Ma sono uscito roso / da un brutto dubbio<br />
«ha compilato tutto? / i recapiti telefonici li ha<br />
trascritti?» / da quell’ufficio lindo, tutto vetrate / e<br />
piante e divanetti rossi, riviste di / barche e cavalli da<br />
sfogliare. È stato un / rappresentante che attendeva<br />
di là, seduto / nell’altra saletta, la sua sagoma scura<br />
/ in gessato a schermare la trasparenza, a renderla /<br />
specchio che mostra il gesto di quelle dita, / della<br />
mano, fra ragno e pugno mentre / aprivo la porta.<br />
Forse il mio pezzo di carta / lo aveva già deposto,<br />
forse la pallina dentro / il cestino era un suo appunto<br />
che non le / serviva più, sì, chissà. Forse mi sarò /<br />
anche sbagliato, o forse è sballato questo / tempo,<br />
che sbrana senza più abbaiare.
Da Il teatro della neve -<br />
Serie composta tra il 1984 e il 1986<br />
con fotografie realizzate<br />
tra il 1954 e il 1986 a Senigallia
Mariangela Guàtteri<br />
121<br />
È nata a Reggio Emilia nel 1963. Dagli anni 80 transita tra arte visiva e scrittura; predilige in ogni caso la ricerca, i territori<br />
asemic, le geografie umane tratteggiate dal linguaggio e vice versa. Osserva le forme del labirinto con una certa<br />
costanza.<br />
Testi recenti, in rete, sono ospitati da: Nazione Indiana, gammm, slowforward, differxhost, lettere grosse, eexxiitt,<br />
Absoluteville, La dimora del tempo sospeso, Anterem.<br />
Con l’inedito Due dimensioni ha vinto la XXV edizione del Premio “Lorenzo Montano”, ora pubblicato in parte col titolo<br />
Stati di Assedio (Anterem Edizioni, 2011 - Riflessioni critiche di Giorgio Bonacini e Federico Federici).<br />
Ha partecipato alla 4a edizione del Laboratorio di nuove scritture RicercaBo 2011 con la lettura da due lavori: NUOVO<br />
SOGGETTARIO (differxhost, 2011) e rebàck.<br />
Nel marzo 2011 il testo del videopoema Trilogia (tratto da Due dimensioni) è stato tradotto in francese dal Groupe de<br />
Recherche CIRCE [Paris III - Sorbon Nuovelle] - Direzione di J.Ch. Vegliante - e pubblicato sul poéblog Une autre poésie<br />
italienne. La versione italiana di questo video è stata finalista al Premio “Bazzano Poesia” 2010 (sez. videopoesia).<br />
Ha pubblicato le raccolte poetiche Carbon copy [Cc] (Il Foglio, 2005) e EN (d’if, 2009) oltre a vari testi in antologie edite<br />
da LietoColle, Giulio Perrone, d'if, Cattedrale, tra il 2006 e il 2011.<br />
Gli ultimi testi antologizzati sono tratti da Quinta di cave e risorti (opera già finalista del Premio “Sandro Penna” 2009) e<br />
compaiono in Registro di poesia #4 (d’if, 2011) e Calpestare l’oblio (Cattedrale - Collana Argo, 2010); in rivista sono in<br />
“Versodove” n. 15 (Pendragon, 2010).<br />
Altri testi, pubblicati in rivista nel 2012, sono tratti da Due dimensioni e si trovano nel n. 269 di POESIA con un testo<br />
critico di Maria Grazia Calandrone. Altri interventi critici relativi al lavoro più recente sono usciti su il manifesto (Gian<br />
Maria Annovi), l'immaginazione (Marco Giovenale), ° punto critico (Federico Federici), Carte nel vento - Anterem (Paolo<br />
Donini e Viviana Scarinci).<br />
Recenti interviste sono sul sito POESIA 2.0: Parola ai poeti (2011) e PoetiCut n.3 (2012).<br />
Nel 2011 ha partecipato a 10-22-38 Astoria, FICTILIS (Seattle, WA - USA), art of xerography, ready-to-copy artworks, con<br />
alcune xerografie (ora visibili su Flickr), e a Fotografia Europea (Reggio Emilia) con alcune opere fotografiche e video.<br />
Molta parte del lavoro visivo (disegni, dipinti, installazioni, fotografia e video) - realizzato tra il 1987 e il 2005 - è<br />
riprodotto in cataloghi di mostre e in riviste. Alcune delle cose recenti (e anche qualcosa di storico) sono in rete e<br />
pubblicati/ospitati da Sleeping Fish - Calamari Press, Moria - poetry journal, REM magazine, The Klebnikov Mail Art Expo,<br />
eexxiitt.<br />
http://mariangelaguatteri.wordpress.com/
Da Carbon copy [Cc], 2005<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
122<br />
x<br />
* * *<br />
C'è un morto colle sue carni fresche<br />
e la speranza di un ballo che non sia l'ultimo.<br />
Io lo guardo e penso:<br />
bocca muta<br />
senza destino di parole.<br />
* * *<br />
Si scava il ventre di un mulo<br />
(un ricovero perfetto)<br />
Per colazione si mangia questa casa<br />
(diventata fredda)<br />
prima che la divori qualcun altro<br />
si mangia cruda<br />
si mangia intera<br />
(senza fare conversazione)<br />
* * *<br />
7<br />
punti di sutura poi<br />
21 prima<br />
2 e altri<br />
2.<br />
La cucitrice ha finito i punti.<br />
Allora va bene la saldatrice e per<br />
20 giorni non s'infila più niente.<br />
A cercare nel cassone dei rifiuti organici<br />
tra sacchetti molli<br />
ne cavo una<br />
44 Magnum<br />
e mi ispeziono la gola:<br />
2 volte sono troppo.<br />
Non si fa in tempo a levarmi la maglietta<br />
che ero già troppo pesante da spostare<br />
12 applausi di pazienti<br />
dalle ringhiere dei balconi ospedalieri.
Da Carbon copy [Cc], 2005<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
123<br />
x<br />
* * *<br />
Con la bocca<br />
piena di gomma<br />
effetto del marketing sociale<br />
i piedi macchiati sotto<br />
sporcano di sangue i calzini.<br />
Butto tutto<br />
in lavatrice<br />
accendo la<br />
televisione<br />
seziono le<br />
tecniche per modificare il<br />
comportamento<br />
e un budello mi penzola davanti<br />
come un cappio del Vecchio West.<br />
Hanno impiccato un ladro di cavalli<br />
con tre scalpi appesi alla sella.<br />
Tutta un'altra cosa<br />
rispetto ai maneggi di Dallas.<br />
* * *<br />
promisi un corpo a ciascuno<br />
e un letto<br />
egualmente spartito<br />
[un fosforo è bello<br />
perché rassicura la casa:<br />
'sono acceso. Tutto funziona!']<br />
grilli meccanici vociferano<br />
sotto i piedi<br />
della cassa congelatore:<br />
due scomparti<br />
un corpo per ciascuno<br />
* * *<br />
Metto un pentolino sul<br />
cerchio alogeno<br />
con dentro<br />
il riso<br />
fino a quando<br />
l'acqua che esce e<br />
la sua schiuma,<br />
formano croste<br />
attorno al filetto bianco<br />
che perimetra<br />
il calore.<br />
Mi distendo col riso<br />
davanti alla Scena del Crimine<br />
e numeri 0:00<br />
intermittenti<br />
mi fanno cadere<br />
almeno un occhio e<br />
ho stanchezza di<br />
questo andirivieni e<br />
faccio richiesta<br />
di avere un<br />
confine.
Da Carbon copy [Cc], 2005<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
124<br />
x<br />
* * *<br />
Fai il bagno nella vasca di Marat e<br />
mentre ti avvolgo<br />
la testa con la garza<br />
mi domandi<br />
se verrà qualcuno a spolverarti la schiena e<br />
se ti tengo il<br />
tracciato dei battiti<br />
il ricalco dei<br />
quadretti educa<br />
la mano<br />
e incide<br />
in vene<br />
deviate<br />
flussi che restano<br />
interrotti<br />
copia carbone binaria<br />
gratta matrici cartesiane<br />
* * *<br />
i punti si mettono in relazione [di forme]<br />
rinchiudono pezzi di nero<br />
altri infinitesimi di bianco negativo<br />
* * *<br />
John Fante mi guarda da mesi<br />
e io immagino<br />
le frasi che gli scorrono sugli occhi<br />
determinati e persi<br />
in aggetto sotto la fronte che straborda<br />
ai lati di un<br />
trapezio isoscele: - Non mi hai ancora aperto -<br />
e io: - Specchio delle mie brame, cosa mi racconti delle<br />
parole inconfessate? e delle cose che abitano ogni<br />
parola? quante cose ci sono dentro: «Provaci tu a farti<br />
sbattere la testa contro il vetro»<br />
Provaci tu a farmi un elenco di keywords -<br />
* * *<br />
se in macchina la strada,<br />
sopra i punti irradiati del reticolo,<br />
mappa l'andatura di un viaggio<br />
da Parigi<br />
al Texas<br />
(con le corde di Ry Cooder) -<br />
mi allontano da casa<br />
e non depongo tracce sulla<br />
linea di mezzeria<br />
and so on<br />
ogni stato interiore<br />
invade il perimetro adiacente
Da Carbon copy [Cc], 2005<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
125<br />
x<br />
* * *<br />
Con gli amanti si gioca<br />
alle prede a turno<br />
Tocca a te<br />
grattarmi la pelle<br />
farmi cibo digerito e<br />
contrabbando del pasto<br />
nel self-service aziendale<br />
oppure<br />
in cucina<br />
con la testa dove scolano i piatti<br />
si consolida<br />
l'associazione a delinquere<br />
E adesso tocca a me<br />
che mi lascio impietosire<br />
desiderando un patto<br />
regolato da clausole non vessatorie<br />
ti firmo un tacito accordo<br />
che mai ti mangerò vivo<br />
* * *<br />
come un disagio<br />
metodico<br />
osservato<br />
la scrittura<br />
a svolgere pratiche in cucina<br />
o in camera da letto<br />
come operazioni<br />
chirurgiche in stanze<br />
sterili<br />
con bisturi<br />
cucchiai per cisti e<br />
cauterî che sfilano<br />
impiccati sui muri<br />
e sui lettini<br />
incide il segno<br />
nel bianco negativo<br />
del foglio copia<br />
traccia il profilo delle cose<br />
in bianco/nero<br />
la scrittura<br />
per le sue prerogative di<br />
astrazione di<br />
testimonianza di assenze<br />
d'innesto
Da EN, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
126<br />
x<br />
* * *<br />
Devi farmi a brandelli<br />
ridurmi in grani<br />
poi rimontami come vuoi.<br />
Sarò sempre io.<br />
Satinato di nuovo<br />
(una pelle diversa) ogni arto<br />
le tue dita nel mio stomaco<br />
da un ombelico che deve ancora formarsi<br />
(e sarà poi un cristallo<br />
che terrai in bocca).<br />
Corpo a corpo<br />
tra un occhio verde<br />
e un occhio verde<br />
che nelle pause di un attimo<br />
fanno carezze alle colline<br />
di una camera con vista.<br />
* * *<br />
Nei fossi lungo la strada<br />
galleggiavano parti senza vita<br />
a gonfiarsi come annegate nell'acqua.<br />
Sei andata sull'orlo dei fossi<br />
hai raccolto dei mazzi di erba<br />
ne hai fatto un fascio<br />
legato con altri fili d'erba<br />
e uno<br />
un filo d'erba<br />
l'hai stretto sul mio avambraccio<br />
a gonfiare l'acqua dei fossi.<br />
Le parti morte sono esplose<br />
e i fili d'erba germogliati in gambi di rose<br />
e altri fiori sulla mia faccia,<br />
tra gli intrecci delle mani.<br />
* * *<br />
Un luogo primo<br />
ora divento<br />
e quando amo<br />
ora sempre<br />
un fiume<br />
di portata larga<br />
sono.<br />
Un luogo primo<br />
aggiungo<br />
ma sempre un luogo primo<br />
dove entri<br />
e innesti<br />
e aggiungi.
Da EN, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
127<br />
x<br />
* * *<br />
Ho incendiato cataste di corpi<br />
ho spazzato la casa<br />
estirpato l'erba straniera davanti alla porta.<br />
Così hai potuto entrare<br />
aderire alle pareti di ogni stanza<br />
e sei un muro antico.<br />
Ho serrato i miei fasci<br />
i rami buttavano occhi di altri dai nodi<br />
anche d'inverno, e non erano<br />
le mie gemme.<br />
Ho allungato il collo sul tronco<br />
e reciso la mia testa.<br />
Il dolore acuto è durato poco,<br />
nella ferita nessuna crosta<br />
- Sempre a mezzo metro dietro di te - mi dici - e se cadi ti<br />
aiuto ad alzarti.<br />
La mia strada e la tua<br />
uniscono gli stessi punti<br />
stelle in attesa da milioni di anni<br />
in figura d'infinito<br />
che è un segno adagiato su un fianco.<br />
* * *<br />
Delle immagini che hanno<br />
rotto le mie sembianze<br />
non ho ricordo.<br />
Ho un torace in sezione<br />
i suoi lembi di fibre e le coste fluttuanti<br />
adagiati sui lati<br />
come un letto per la notte.<br />
Dentro batte<br />
come sotto la rete<br />
il muscolo che mi dà il ritmo<br />
la fronte che ti sfiora;<br />
l'infrarosso degli occhi<br />
ti scansiona la nuca.<br />
Resto nell'immagine votiva<br />
donata per grazia ricevuta.
Da EN, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
128<br />
x<br />
* * *<br />
Un sentimento equo<br />
ci misura.<br />
Nessuna ansia.<br />
Le distanze minime<br />
sono camere adiacenti<br />
comunicanti come<br />
vasi.<br />
Pratichiamo il desiderio<br />
in cortili interni<br />
quadrati perfetti<br />
nel ritaglio di un cielo impeccabile.<br />
* * *<br />
Il sentire visionario dell'intero popolo<br />
- nel mio interno si rivolta -<br />
si spalma come un gel di connessione<br />
tra i margini che si sono separati.<br />
Le cicatrici formeranno un disegno<br />
- il mio ritratto perfetto -.<br />
Mi riconosco in questi segni che stai tracciando<br />
con un occhio sempre attento sul mio polso.<br />
Questo è un amore.<br />
* * *<br />
Dai nomi precisi alle cose<br />
il ragionare è pulito<br />
e a tutte le mie fibre mi assicuri:<br />
la corda di una nave dentro un porto.<br />
Dai suono alla tua voce,<br />
l'impulso della luce,<br />
la regola buona di un faro.<br />
E ascolto il rumore dell'acqua di mare<br />
cadenzare simile del battito vitale.<br />
Diamo nomi precisi alle cose,<br />
distese,<br />
allargate viste che tracciano i confini.<br />
* * *<br />
Un vapore a fior di campo,<br />
il sudore delle zolle piccole,<br />
dei prati.<br />
Mi dai da bere,<br />
accudisci il sale che produco,<br />
mi tieni al caldo.<br />
Appartengo ai filari dei tuoi denti,<br />
ai buchi,<br />
alle tane che mi scavi.
Da EN, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
129<br />
x<br />
* * *<br />
Occhi<br />
i miei sono la pancia<br />
di una grotta<br />
e da sopra<br />
e dal muscolo dove sopra<br />
si cammina<br />
il sale si congiunge in torri<br />
a segnare i punti cardinali<br />
e i meridiani. Ci scorri sopra<br />
pianti segnali:<br />
una mappa dalle dita<br />
alle dita.<br />
* * *<br />
Stiamo coperte<br />
con le piume rosse<br />
mangiamo corpi evirati<br />
senza ali né zampe<br />
d'insetti morti, libellule come grissini:<br />
un pasto bianco gustoso.<br />
Poi con lo sguardo mi apri il ventre<br />
con un colpo di Katana mi separi<br />
mi soffi dentro;<br />
hai la mia testa<br />
hai le mie piume.<br />
* * *<br />
Mi prenderò cura del mio nuovo giardino<br />
dove ho disteso pietre al posto di un prato<br />
perché sia pulito<br />
perché sia sempre ordinato.<br />
Mi prenderò cura di me e del mio amore<br />
dove ho serrato la vita nuova<br />
che sia sempre una gioia<br />
che sia meraviglia<br />
perché gli occhi mi sbocci addosso<br />
perché i tulipani forzano il sasso.
Su Carbon copy [Cc] e EN<br />
Nel film La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock lo spettatore sperimenta insieme al protagonista il panico e l’impotenza di essere testimone di<br />
un delitto di cui non si hanno le prove. Carbon Copy […] genera nel lettore lo stesso senso di impotenza e voyeurismo coatto trasportato dallo<br />
schermo cinematografico a quello del personal computer. Nel lessico informatico, infatti, la copia carbone è un messaggio inoltrato a un altro<br />
soggetto, reso testimone di una comunicazione in cui non è attivamente partecipe. Chi riceve la copia del messaggio è a conoscenza solo<br />
dell’identità di chi lo invia e di chi lo riceve ma è impossibilitato ad accedere alle risposte pervenute al mittente.<br />
…in questo libro ci si trova involontariamente implicati in una triangolazione comunicativa dove però la comunicazione si svolge a senso unico e<br />
prende forma di monologo: l’io-mittente e il tu-destinatario non si scambiano mai. Anche se trasposta in termini informatici questa è la<br />
condizione che da Petrarca in poi, caratterizza la forma lirica, con la differenza che mentre nel Canzoniere la morte di Laura è funzionale - e<br />
fictionale - alla creazione della persona poetica (ma lo stesso si potrebbe forse dire del Montale di Satura che si rivolge a Mosca) nel caso di<br />
Mariangela Guàtteri il «morto colle sue carni fresche» che apre la raccolta, oggetto delle violenze e forse dell’omicidio in cui il soggetto risulta<br />
implicato, non è occasione della scrittura ma verifica della possibilità stessa della dizione: «ne cavo una / 44 Magnum / e mi ispeziono la gola».<br />
È infatti il corpo-cadavere a ridisegnare gli oggetti domestici (tavoli, letti, stoviglie… una vasca da bagno che diventa scena dell’assassinio di<br />
Marat) ridefinendo la dicibilità stessa dello spazio/stanza - stanza come unità poetica luogo del darsi intermittente della parola. Proprio sul<br />
concetto di interruzione si struttura l’intera raccolta: sia a livello del racconto interno, che procede per continue cesure e censure, creando<br />
un’atmosfera da “scena del Crimine” con relativa indagine poliziesca in cui emergono inquietanti indizi; sia a livello formale, nell’uso di una<br />
sintassi che procede per blocchi, a volte evidenziati anche graficamente, spesso acefali o monchi di complemento e in una versificazione che<br />
alterna verso lungo e brevissimo, quest’ultimo vòlto ad interrompere - di parola-verso in parola-verso - il ritmo della lettura. L’interruzione<br />
domina inoltre il piano tematico, non solo in quanto figura dell’evento Assoluto (la morte che campeggia al centro di questa raccolta) ma anche<br />
perché è di «sentimenti / interrotti» che qui si parla, di una separazione, di una «partizione» che intacca corporalmente vittima e carnefice,<br />
totalmente intercambiabili nei loro ruoli: «con gli amanti si gioca / alle prede a turno». La stessa separazione che esperisce il lettore lasciato<br />
solo davanti alla testimonianza di una relazione («associazione a delinquere» erotica e comunicativa) a cui deve tentare di accedere («provaci<br />
tu a farmi un elenco di keywords»), colmando lacune e sondandone la verità, proprio perché il messaggio che gli perviene, non è autentico, ma<br />
una copia oscura: copia carbone.<br />
In queste poesie (che l’autrice insiste a chiamare “cose”) qualsiasi residuo lirico, emotivo, e sentimentale, viene dissolto dalla messa in dubbio<br />
dell’autenticità stessa del messaggio che comporta l’interrogarsi sulla verità del soggetto, ridotto a oggetto d’indagine. Ciò è confermato anche<br />
dalla forte tensione autoptica di questa scrittura, che forse richiama proprio per l’immediato collegamento anatomico tra io e corpo gli esiti<br />
poetici più recenti di Florinda Fusco ed Elisa Biagini. Se con quest’ultima possono risultare comuni il sezionarsi anatomico di un corpo<br />
sottoposto a uno sguardo freddo e crudele e il richiamo a un universo chiusissimo, perimentrato dai confini della casa, Mariangela Guàtteri si<br />
distacca completamente da qualsiasi dimensione domestica che serva a ridefinire un immaginario femminile: lo spazio della casa è vissuto solo<br />
come «accampamento / fantasma delle cose / da fare», che esclude qualsiasi attività prettamente femminile («è vietato / l’accesso / ai ferri da<br />
maglia / n° 5») o domestica («mangio vivo il cibo dal frigo») fino al limite della noncuranza («le finestre / piene di foglie e di mosche»). Anche il<br />
gesto simbolico del cucire, tentativo fallimentare di riparare la partizione, l’interruzione tra i corpi, avviene con mezzi assolutamente sganciati<br />
da qualsiasi immaginario femminile: una cucitrice, una saldatrice… Non si tratta infatti di definire una nuova identità del soggetto ma di<br />
abbassarne la definizione, di sgranarne la consistenza («io che mi dissolvo / nel monoblocco bianco»), di sviare le tracce dell’io e delle sue<br />
violenze: «e i / broccoli freschi / sciolti // si sventrano / sulle piastrelle / cotte / fatte a mano // feroci / per tutto questo / sangue raccolto / e<br />
sigillato / nei tapper». La freddezza dello sguardo che osserva e spartisce gli spazi, gli oggetti e i corpi, memore degli esiti più crudeli della<br />
poesia<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
130
Su Carbon copy [Cc] e EN<br />
poesia di Antonio Porta, non ha più nulla di umano e si esercita in maniera asettica e anestetizzata («se non sento più niente / l’anestesia si è /<br />
autoprodotta»). L’occhio spalancato di questi versi è infatti una «telecamera / blindata» che procede per «flussi che restano interrotti», per<br />
frames apparentemente statici che ricordano le immagini deformate degli apparati di video-sorveglianza, la fissità discontinua di un occhiowebcam,<br />
o la bassa definizione di una video-sonda che penetra sin dentro al corpo per giungere a dare «uno sguardo / allo stomaco». Tutta la<br />
raccolta è pervasa dall’idea di un’introiezione orale dello sguardo che arriva a confondere esterno ed interno e concorre a creare l’inquietante<br />
stato di low definition del reale che percorre questi testi. Mariangela Guàtteri, infatti, attraverso una scrittura asciutta, quasi allucinata nella sua<br />
precisione, toglie «le targhe dei nomi» creando qualcosa di molto simile a una realtà non ancora compiutamente reale. In essa, il soggetto<br />
nasconde le sue tracce, le sue impronte e la scrittura si fa «testimonianza d’assenze»: restano solo piste, solo indizi. L’io che scrive sembra<br />
letteralmente “farsi fuori”, quasi fuoriuscisse dallo spazio/stanza man mano che procede il suo tentativo di “far fuori” il tu. Ciò avviene<br />
principalmente attraverso una ricognizione chirurgica del proprio corpo alla ricerca della parola che lo abita («lascia che il corpo parli / che il<br />
ventre risponda alla lingua») e che ne riveli il destino («alluci / lobi / che mi dicono se / ucciderò mai qualcuno»). Gli inesausti esercizi di<br />
dissezione anatomica, la continua notomizzazione che il soggetto compie sul proprio corpo vivo, verificano la possibilità di resistenza a un<br />
crimine che avviene in realtà dentro di esso, perché corporalmente interna è l’alterità a cui si rivolge: «e io sono / con te dentro il corpo».<br />
Questa consapevolezza solleva solo parzialmente il lettore dal felice senso di apnea che sperimenta di fronte all’incisività di questi versi: quasi la<br />
sua impotente postazione di testimone lo rendesse complice del «disagio / metodico / osservato»: la scrittura.<br />
Gian Maria Annovi, da [Fwd: No Subject], prefazione a Carbon copy [Cc]<br />
* * *<br />
[…] La spina dorsale dell’intera raccolta […], il nerbo […] filosofico è semplice quanto inquietante: ricondurre alla fisiologia del corpo amano, alle<br />
leggi fisiche basilari del moto, le dinamiche più contorte dell’anima bagnata di solitudine o arsa di passione. Il tentativo ambizioso non cerca<br />
normalizzazioni o spiegazioni scientifiche, solo un sano e necessario ridimensionamento. E un abbraccio voluttuoso quanto irrimandabile tra il<br />
corpo e lo spirito… […].<br />
Cristian Sesena, da Carbon copy libro a-morale, in “La gazzetta di Reggio”, agosto 2005<br />
* * *<br />
•Uscito nella bella collana della casa editrice d’If i miosotis, EN di Mariangela Guàtteri fa l’effetto di un monolito in un paesaggio urbano. Una<br />
costruzione liscia e imprendibile, perfettamente autosoddisfatta e inattaccabile. Che cos’è EN? È un poema amoroso, enigmatico e preciso che,<br />
anche graficamente, alterna zone di pensiero dense, grumose ad improvvise ellissi dove i testi si appoggiano magri. Il vertice emotivo del libro,<br />
a me sembra, è il testo Tum-tum, una poesia dal tono crudamente colloquiale, dai versi lunghi, che illumina magnificamente quel nodo di carne<br />
e sangue, di dolcezza anche violenta, che è il nucleo dell’ispirazione della Guàtteri: «Tramuto, mentre ti tengo il polso come / impugnando un<br />
coltello; mi apro i pori, uno ad / uno. Tu entri e la tua voce mi sostiene la spina / dorsale, mi sollecita il muscolo del cuore». È in queste pagine<br />
che in maniera quasi cristallina la Guàtteri ci permette di penetrare nell’officina della sua riflessione con affondi come «Mi si spalanca un<br />
tempio e una cripta, piena di / colonne, ai piedi. Il luogo del nostro rito dove / offriamo noi stesse a noi stesse e il tempo storico / inizia a<br />
sparire». Una poesia del tempo congelato e della crisi che vive nel fuoco del presente e che seziona senza pietà e rimorso parti della realtà fino<br />
a ridurre il campo a due persone, e poi con sempre maggiore estremismo solo cicatrici, pori, lembi, tagli che formano ritratti e connotati umani.<br />
Fabio Orrico, in “ScrittInediti.it”, agosto 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
131
Da Quinta di cave e risorti, 2009<br />
Mariangela<br />
uno stato delle cose. come la terra. un prendere atto. una guerra.<br />
Guàtteri * * *<br />
Atto I<br />
Scene: Il giardino, La serra, La fossa del cane<br />
132<br />
x<br />
Il giardino<br />
* * *<br />
petali di carne del cuore<br />
un esercito in giardino<br />
nell'incanto del sonno ibernato<br />
un piede di terra smuove un sasso<br />
una benda grassa tiene un taglio<br />
l'erba ammucchia letti<br />
per le gambe recise<br />
vuote di cammino<br />
di casa<br />
mine metallo placche tonde<br />
inganna sorte fanno fronte<br />
casse di assi crollate<br />
farfalle di luci<br />
benzina solo per carri.<br />
i fiori si fanno dormire<br />
giorni su giorni<br />
restino ciechi<br />
in messa a dimora<br />
la cripta difesa dei bulbi<br />
l'ascia di guerra scava<br />
è pietra fluitata di fiume<br />
se ne fanno calchi<br />
tanto per esser sicuri<br />
se ne fanno copie<br />
e di varia materia.<br />
poi disabitati corpi<br />
disfatti e risorti in paesaggi atroci<br />
da radici ancora vive<br />
irrompono appuntiti:<br />
disintegrate razze<br />
è troppo caro il sangue:<br />
rimbocca le pelli<br />
termina gli occhi<br />
per sempre alle insegne<br />
(non parla e non piange<br />
e non muove il calanco<br />
rimette peccati<br />
frana la costa<br />
corrode il fianco)<br />
[…]
Da Quinta di cave e risorti, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
133<br />
x<br />
Atto II<br />
Scene: Il fronte, La quinta di cave, Il sacello<br />
Il fronte<br />
* * *<br />
sfondata la casa<br />
la grata del confessionale<br />
ficcate le dita negli occhi<br />
negato il respiro<br />
il suo suono<br />
la replica e il sonno<br />
arrivano in tanti<br />
coi ferri un clangore<br />
da bestie in catene<br />
scalate le antenne<br />
le forche a rastrello<br />
e paraboliche croste<br />
in piatte terrazze<br />
di facce espugnate<br />
si impiccano stracci<br />
a vista orizzonte reciso<br />
una conca di cielo<br />
un derma irritato di luce<br />
e brani di codice a stormi<br />
migranti per vie sconosciute<br />
solo un singhiozzo sfollato<br />
e ancora più fame<br />
(intermittente contrarsi)<br />
(vuoto di spasmo)<br />
non c'è vocazione di sazietà<br />
neppure di meditazione<br />
ma cose tenute tra i denti<br />
incommestibili ingombri confitti<br />
significati spariti<br />
in cumuli stipati in chiassi
Da Quinta di cave e risorti, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
134<br />
x<br />
La quinta di cave<br />
viene la notte<br />
coi suoi circuiti chiusi<br />
le sbarre ai suoi confini<br />
un popolo in tumulto<br />
sui gradini di un'arena.<br />
vengono i gladiatori su dai buchi<br />
eccitati i neuroni del sistema<br />
e viene più notte<br />
e il buio soffoca gli occhi<br />
la bocca non fa la sua funzione<br />
vengono come masse di ragni<br />
le ossessioni<br />
un delirio inchioda la fronte a un palo<br />
e si nutre e fa sangue nero<br />
viene la notte senza orizzonti<br />
neanche versi di uccelli<br />
e spigoli di luce<br />
neanche il ritmo di un cuore<br />
né bordi né grappe per mani<br />
nella quinta di cave<br />
panorama coartato<br />
mucchi d'insonni<br />
a gesti dirotti insistenti<br />
preposizioni in<br />
non articolati movimenti giocano<br />
prossimi alla morte<br />
puntando alla testa di un altro<br />
(prossimo colore sfacciato esploso)<br />
l'inadeguato alla vita del fronte<br />
in questo giocare<br />
come tra semplici carte<br />
shoot me<br />
cadendo sul tavolo verde<br />
si pronuncia un colore<br />
sia l'uno o l'altro<br />
è un adagio senza sfumature.<br />
benvenuta la scelta binaria<br />
che mostra gli argini di sepoltura<br />
il gioco è scavare labirinti<br />
nella tragedia con grazia di vita<br />
l'assiduo riciclo di scene in sequenza<br />
realizza puntuale numeri enormi<br />
a corpo uno scialo e alcune catarsi<br />
retablos pagani gesti e sembianze<br />
atti<br />
di dolore a brani<br />
inginocchiàti al preludio del sogno<br />
(termine ingiusto per blando eroismo)<br />
di fare il percorso finale col nome<br />
(luogo di pura scandita afflizione)<br />
tra rulli di titoli bianchi<br />
(e nera la quinta) di coda<br />
in ossario<br />
a misura di passi<br />
reliquie nel vetro di schermo a colore<br />
rettificando preghiere: i salmi cantati<br />
[…]
Da Quinta di cave e risorti, 2009<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
135 x<br />
Atto III<br />
Scene: L’orto, I risorti<br />
* * *<br />
[…]<br />
I risorti<br />
la terra s'infossa<br />
raspa chi sta seppellito:<br />
il cane coi vermi<br />
(ognuno mai conosciuta parola)<br />
(ognuno a suo modo in preghiera)<br />
lo spazio contratto sul corpo<br />
solo lo stato della coscienza si sposta<br />
fa il tempo<br />
(forse fa pioggia)<br />
nel buco che è nero<br />
resiste poi<br />
si concentra<br />
la terra s'infossa<br />
tra sé sta in rivolta<br />
rifiuta l'assetto di tomba<br />
il campo di guerra<br />
studiato a misura di ossa<br />
la terra s'infossa<br />
poi piove<br />
si mette tranquilla<br />
diviene camera calda<br />
con l'acqua che piomba<br />
fa solcatura<br />
traccia la scia dei risorti<br />
la riva<br />
è camera calda<br />
non è caverna di pasti<br />
e di morti.<br />
non sono interrati i morti:<br />
sono nel cuore<br />
nelle immagini in scatole di legno<br />
visitano a volte in sogno:<br />
aprono a forza la bocca<br />
in fissità di sembianza<br />
non si trasmette il suono<br />
(e sono senza moto)<br />
non fanno condono.<br />
solo al risveglio<br />
è remissione di febbre<br />
un andare di corpo<br />
si scarna il frantume<br />
(diluvia)<br />
uno sfrigo di baco sfoggia le ali.<br />
lo scasso dei vermi<br />
dà precipizio al prenome<br />
un nodo di prima creazione<br />
prima del tempo contato<br />
(contratto in un filo di buio)<br />
una calca dentro un pertuso<br />
matura<br />
la pancia del seme.<br />
è una scommessa giocata<br />
dio non conosce la propria esistenza dio<br />
non si scanta da<br />
lunga fiata cantava<br />
in disturbo una nenia<br />
un butto di ali<br />
in tempo reale<br />
(un germe di suono che sfocia).<br />
si apre una bocca<br />
di luce conflitto<br />
un vasto di ambigui<br />
un letto è un miraggio<br />
la carne un’assenza<br />
la posta versata<br />
(se dio si nasconde<br />
o risorge<br />
non fa differenza)<br />
tornarono a riva<br />
come farfalle morte.<br />
la riva era la casa<br />
con un fiore appena aperto<br />
(e pareva andata la pianta).<br />
chiesero della carne:<br />
quella ch'era loro appartenuta.<br />
la trovarono composta sul divano<br />
(largo come un letto e mezzo)<br />
respirava appena.<br />
fu nuovamente viva<br />
(in una luce quasi sparita)<br />
con loro ricomposte e asciugate<br />
sollevò il mento<br />
piombato sullo sterno<br />
liberò gli occhi.<br />
ne fece arcate.
Su Quinta di cave e risorti<br />
[…] …anche i nuovi “sperimentali freddi” sentono il bisogno, oggi, di comunicare “narrazioni”, di inserire cioè nell’ordito di una sperimentazione<br />
formale e linguistica anche radicale, dei contenuti riconoscibili (si leggano ad esempio Marco Giovenale, Adriano Padua, Luigi Socci e<br />
Mariangela Guàtteri, tra i migliori). […] Uno dei movimenti poetici a mio avviso più interessanti ed originali di questi ultimi undici anni di nuova<br />
poesia italiana è quello che invece chiamo lirica tellurica e che consiste, nel mantenimento della tradizione lirica popolare (la forma-canzone),<br />
nello smottamento del punto di vista dall’io-lirico all’oggetto dell’osservazione immedesimata, per cui l’io poetante diviene, come ho detto<br />
altrove a proposito della poesia di Enrico Piergallini (1975), un io-mondo, in quanto coincidenza di storia personale, collettiva e geologica,<br />
metodo che si riscontra anche nell’evoluzione ultima della poesia di una delle più fertili voci femminili di questi ultimi anni, Mariangela Guàtteri<br />
(1963), nome che abbiamo già incontrato (perché nella realtà non esistono queste categorie separate). Senza dubbio Giacimenti di Piergallini e<br />
l’inedito Quinta di cave e risorti della Guàtteri sono due opere centrali e sorelle, nel panorama della nuova poesia italiana. […]<br />
Davide Nota, da Dove va la poesia italiana?, in “La Gru”, marzo 2010<br />
* * *<br />
«Il Post human di Mariangela Guàtteri è un fenomeno complessivo che si manifesta in forma di lapsus e disturbo, interferenza di parentesi e<br />
asincronia fra tempo metrico lineare e amalgama vischioso del flusso ritmico. Gli smottamenti prosodici della forma “canzone popolare”<br />
aderiscono alla dimensione dei fenomeni terrestri, dove biologia, geologia e storia sono la stessa cosa.<br />
Nel poemetto tellurico Quinta di cave e risorti l’abbandono dell’io biografico e del punto di vista soggettivo, il superamento dei presupposti<br />
della tradizione lirica moderna, lungi dal volersi manifestare come violenza teorica trovano anzi proprio nel trattenimento tumefatto di taluni<br />
stilemi l’incarnazione partecipata di una gravità metamorfica in atto.<br />
Ed è lo slittamento immedesimato nel ciclo insonne dei fenomeni naturali, dei «disabitati corpi / disfatti e risorti in paesaggi atroci / da radici<br />
ancora vive», anche la significazione di un passaggio estetico centrale, nell’evoluzione della nuova poesia italiana ed europea, da io lirico ad io<br />
mondo, occhio senza autore, percezione senza biografia, radiografia del canto terrestre.<br />
Il verso di cui è composto è nudo, spoglio di decorativismi aggettivali e a volte persino facente rinuncia dell’articolazione: «il cane sta in buca /<br />
fuori decade il cielo / humus sopra fa crepe».<br />
Ne risulta così rafforzata l’evidenza elementare dell’oggetto crudo, uno stato di cose. Come la terra, un orto poetante e non domo la cui<br />
liquidità vitale sfocia in apertura al canto laico dei misteri della decomposizione e dei ritorni, degli elementi trasfigurati e dei ricordi incarnati,<br />
visivi e linguistici.»<br />
Davide Nota<br />
* * *<br />
Il poemetto di Guàtteri […] è distinto in tre atti, composti rispettivamente da tre, ancora tre, e infine solo due scene. La struttura teatrale<br />
magnifica l'aspetto di «sacra rappresentazione» laica che i testi sembrano proporre. Laica ma, occorre aggiungere, fortemente incentrata sulla<br />
corporeità, come appunto vuole la tradizione della cerimonialità religiosa di strada. La fossa del cane, qui antologizzato, sta infatti in rapporto<br />
coi risorti (l'ultima scena) non solo per una dinamica narrativa che dalla morte va alla resurrezione, ma anche per il contrasto-choc tra la morte<br />
del vivente e la sottesa memoria religiosa. Un tale sostrato, che si vorrebbe dire «umbro», nel senso di jacoponico, e certo tergano, agisce sulle<br />
scelte di lingua e di stile orientate in senso espressionista: così che, a distanza di pochi versi, troviamo insieme il «suono procreilo» e la<br />
«pellecchia».<br />
Dalla nota introduttiva pubblicata su REGISTRO DI POESIA #4, a cura di Giancarlo Alfano (Napoli, d'if, 2011)<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
136
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
137<br />
x<br />
Da [Neurosi I]<br />
<br />
potere [la detenzione di esistenza]<br />
una forma di potere [il maneggio di un processo volontario<br />
di una alterazione]<br />
è un potere [lo stato percettivo che organizza<br />
i dati]<br />
a scopo di visioni [disegni sonori<br />
corpo di odori<br />
ultravioletti emergenti<br />
forme in calore]<br />
come un sognare<br />
polvere in rivolta<br />
che mostra i lati:<br />
X sulle cose (irradiazioni)<br />
e allora solo ossa<br />
[uno stato pulito]<br />
un accesso immediato<br />
si trasmette l’esistente<br />
[si comunica]<br />
si salva<br />
[…]
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
138 x<br />
<br />
ho paura e non so cosa sono<br />
ché un barlume una luce ambientale<br />
mi separa<br />
e divido le cose per questo<br />
una protesi del niente<br />
che si lascia andare<br />
ortopedia assemblata<br />
in abbandono a distanza<br />
ancòra<br />
la paura mi rende un nulla<br />
ma dite soltanto una parola<br />
e io sarò salvato<br />
(resti sempre con me la vostra divina grazia<br />
col corpo col sangue)<br />
la paura mi aizza come un cane<br />
dal nemico maligno difendetemi<br />
nell’ora della morte chiamatemi<br />
(usatemi misericordia e concedetemi le grazie<br />
che sono necessarie per la mia salute)<br />
la paura mi conduce al peccato<br />
col vostro corpo salvatemi<br />
col vostro sangue inebriatemi<br />
(lasciatemi in vostra adorazione mio creatore<br />
sovrano padrone unico mio bene)
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
139<br />
x<br />
<br />
lo spazio incastonato<br />
tra corpi cruciformi<br />
termina il respiro<br />
viene assimilato<br />
un modulo in eterno ripetuto<br />
nel punto d’incrocio dei bracci<br />
trasuda un petrolio una sostanza<br />
riconversione del tempo in dolore<br />
un’intolleranza<br />
[l’ascesi parallela del silenzio al digiuno (1)<br />
risana la parola<br />
la richiama al suo potere<br />
distilla da uno sterile di talco<br />
fino al sangue non presente<br />
un tempo di fame<br />
un’indigenza del divino<br />
e vince chi muore per primo]<br />
(1): «[...] un’ascesi parallela e complementare al digiuno che consiste nella<br />
iniziazione al silenzio, attraverso la quale ci si svuota della parola come del<br />
cibo; liberandoci dal verbalismo e dalle chiacchiere potremo scoprire la parola<br />
come dono divino e come responsabilità. [...] la partecipazione della nostra<br />
carne all’indigenza». Sergio Romano Aguzzoli, Il digiuno cristiano, in Chiesa in<br />
cammino, febbraio 2010, n. 2.
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
140 x<br />
Da [Neurosi II]<br />
[…]<br />
<br />
pompa nelle cave un sangue<br />
alza le chiuse<br />
si lascia in visione<br />
(analitico osservare: lo sente come un tatto)<br />
lui dentro a un buco<br />
(in sempre maggiore apertura)<br />
con parti in esteso<br />
con parti slabbrate<br />
(tane occupate in abuso)<br />
l’occhio deposto e disperso<br />
la mano orientale detiene la vista<br />
palpando dà vita a piaceri visivi<br />
e chi vede si sente in coazione di corpo<br />
la pelle tirata<br />
(un seme che punta la testa sopra una crosta e la bagna)<br />
un calore in crescendo<br />
violenta pulsione<br />
natura in pre posizione (una forza estrema)<br />
lui è passivo in rivolta<br />
il senso si scioglie scompone<br />
esibisce se stesso soltanto<br />
singole parti (anche ingrandite)<br />
in astratto formale<br />
anatomia distillata:<br />
erezione di un corpo fibroso<br />
testa-corona di carne iterata<br />
in sempre più veloce vibrazione<br />
{apri le tue parti<br />
{porgile in alto<br />
{che si veda più dentro<br />
{falle stimolare da protesi rotanti<br />
innervate<br />
semoventi<br />
artificiali<br />
in profonda comunione<br />
con veri genitali<br />
{raccogli da uno dei cavi (l’orale)<br />
gli sfiati di un ventre<br />
gli scroti<br />
i capezzoli irti<br />
le piccole labbra<br />
le lingue<br />
[intanto qualcuno provvede a infilare qualcosa tra le altre<br />
piaghe<br />
(usa le dita in funzione precisa<br />
del divaricatore)]<br />
{rimani in assenza in protratta rotazione<br />
{rilascia lo stesso pensiero sulla forma che si muove<br />
(un’ossessione)<br />
{dalle da mangiare<br />
{a tua volta mangia<br />
{sfrega a tenaglia la scia di un odore<br />
{dichiara la resa<br />
voltando la schiena a una luce<br />
{tieni posizione di un cane che si stira<br />
{prendilo nel corpo<br />
(qualsiasi cosa impropria)<br />
senza fare resistenza<br />
{a tua volta sferza<br />
con una piccola carne<br />
una farfalla aperta
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
141<br />
x<br />
<br />
avanguardia di piacere<br />
(un vertice appuntito)<br />
non trova la somma delle parti<br />
né il prodotto<br />
desidera un confine<br />
si recinta:<br />
traccia un piccolo quadrato<br />
un solco al suolo<br />
un baratro sottile come un taglio<br />
[la polvere solleva un dolore]<br />
un assedio<br />
(negazione di scelta)<br />
violenta ogni crepa della terra inscritta<br />
[crede in qualcosa di vergine]<br />
affermando una propria esistenza<br />
smembrando scuotendo scuoiando<br />
ciò che è già assenza<br />
(corpo in latitanza)<br />
una gemma gonfia<br />
[priva di fiori futuri]<br />
un colpo più a fondo<br />
[l’innesco]<br />
deciso allo stupro<br />
sboccia in frantumi<br />
in un siero<br />
[le crepe letti di fiumi]<br />
ferite che sono già di nessuno<br />
le pratica ognuna in un turno<br />
in un gioco di carne<br />
[palindromo sino a esaurire]<br />
deposta e serrata<br />
[non si asciuga]<br />
infine la occulta<br />
per una prossima volta<br />
[la palpa (forse una parte la mangia)]<br />
[…]
Da Stati di Assedio, 2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
142<br />
x<br />
Da [Neurosi III]<br />
[…]<br />
<br />
s’involve s’incanta si alza<br />
fa un gesto al cielo<br />
e il fiore di paura che ha nel ventre<br />
scoppia in un dolore<br />
[si dissangua]<br />
raccoglie un detrito allungato<br />
pesante<br />
[un osso di cane una zampa]<br />
[un’ascia di guerra-zampa di cane]<br />
lo punta lo lancia<br />
fende un cielo già morto<br />
riscatta i suoi sassi i rifiuti<br />
s’incolla i bordi delle sue ferite<br />
prende a muoversi col capo<br />
[gira intorno come un radar]<br />
coglie punti sul visore<br />
[non è solo in territorio]<br />
altri da sé in spostamento<br />
lui è uno<br />
la mano orientale aiuta<br />
la sbozza in lama l’affila<br />
poi si taglia in più parti<br />
si separa per essere molti<br />
piccoli pezzi senz’arma<br />
boccate di carne in giacenza<br />
attorno a un moncone<br />
la mano orientale aiuta<br />
si trasforma in cosa da guerra<br />
[Luger Parabellum P 08]<br />
la infila nel buco<br />
[quello che lo nutre]<br />
e spara<br />
[…]
Su Stati di Assedio<br />
Una scrittura poetica efficace e necessaria agli intenti che si prefigge sperimenta, ingloba e manifesta anche la sua vocalità, ed è proprio ciò che<br />
Mariangela Guàtteri fa in Stati di Assedio: scrivere una poesia di voce. Ma c’è di più. Ciò che percorre internamente i suoi versi è un movimento<br />
che connota l’opera come un poema di sensi: dove si mescolano, in sinestesie ricche di variazioni e perciò di significazioni, aspetti palpabili,<br />
sonori, visivi e mentali. Ci troviamo, quindi, dentro un canto vivo dove la concretezza fonica è fondamentale per la scrittura che ne realizza i<br />
«disegni sonori».<br />
Il testo ha una struttura tripartita, che non è però una semplice architettura esteriore (seppure formalmente portante e importante), ma una<br />
determinante sostanza strutturale che sostiene la forza dei sentimenti fisici che in esso si manifestano. C’è, fra le varie parti, un<br />
rispecchiamento, che si presenta però con deformazioni, modulate tra una sezione e l’altra, che danno corpo a tre “stati di assedio”: il potere, il<br />
piacere, il dolore. Tre Neurosi, così come l’autrice li titola, che in quanto tali sono conflitto e alterazione di ogni aspetto sensoriale, percettivo e<br />
concettuale. Ed e così che questa poesia si fa carico e si impegna a far sprofondare e a lasciarsi affondare in un dire il cui soggetto ha un senso<br />
che batte come «una contrazione di cuore», che martella con «un colpo duro», che raffigura «ritratto in un punto del corpo». Eppure,<br />
nonostante questa presenza si srotoli lungo tutto il testo, qualcosa di sfuggente, di indeterminato o semplicemente di sconosciuto rimane: una<br />
polvere, una frantumazione da cui ricavare immagini e suoni a cui solo la poesia può dare senso. Tutto ciò che è denotazione discorsiva è<br />
annullato da una concentrazione verbale di cui l’autrice sente la responsabilità. L’assedio, allora, prende corpo dalle ossa, che si rimpolpano con<br />
la carne, per poi rendersi evanescente in un’ombra.<br />
Mariangela Guàtteri riesce a prosciugare l’andamento dei versi fino alla loro essenzialità: nulla è, seppur minimamente, ridondante e la parola è<br />
un’irradiazione frattale di circonvoluzioni che sprigionano una multiformità di sensi, e si proiettano alla ricerca di una rivolta contro il potere, di<br />
una penetrazione verso il piacere, e di un’urgenza per il dolore. Il tutto profuso in evocazioni di sgretolamenti e sregolamenti continui, affinché<br />
qualcuno possa, anche con una sola parola essere salvato. Ma non bisogna fraintendere: questa salvezza non è una cura attraverso l’orazione<br />
poetica, ma è, più materialmente, una palpitazione che «dà vita a piaceri visivi». Una vita che si fa e si rifà, con congiungimenti e lacerazioni,<br />
anche grazie a una materia fonica che produce, con una nominazione secca, stringente e lucida, una dissezione erotica che esibisce se stessa<br />
sciogliendo il senso dentro le sue parti: una singolarità distillata per dare pensiero visibile, dare attrito e snervare l’assedio.<br />
Anche leggendo questo poemetto con voce muta, pur non essendo una poesia fonetica, la risonanza che ogni singolo vocabolo, nella sua<br />
consequenzialità e interconnessione, produce nella formazione di questa lingua particolare, appare a tratti come una visione allucinata, una<br />
respirazione rotta, un silenzio sconfitto. Ma forse è proprio a causa di questo effetto disorientante, di questo sconfinamento o abbandono di sé,<br />
che riesce a trasmettere una vera e multiforme esistenza: grazie a un legame poetico in costante tensione, che divarica senza fine un «pensiero<br />
assoluto» che «s’involve s’incanta si alza».<br />
Una mente in rivolta, che ha parole che si incamminano in un processo che è quasi un’estasi a perdifiato, una voluttà tanto fisica e materica<br />
quanto visibile solo in un ansimare e sfiatare verso una mistica terrena, tesa «fino al sangue» e a «un’indigenza del divino». Perché se ciò che si<br />
corrompe è la vita, con la poesia si riesce, perché è originarietà del dire, a risentire e a ricostruire ciò che svanisce; e a farlo con il<br />
rimescolamento dei paradigmi, la ricombinazione dei sintagmi, che, in un poema come questo, sono estensioni propriamente esistenziali e<br />
pulsionali, non solo semantiche.<br />
La neurosi dell’assedio è senza mediazioni e può portare Potere al Piacere del Dolore, ma se si affronta il grido o il balbettio coltivando «il<br />
delirio del tocco / lo stile di mano / gli sfiati», come fa Mariangela Guàtteri, allora forse qualcosa, attraverso la primogenitura di uno sguardo<br />
emergente, si trova e si salva. […]<br />
Giorgio Bonacini, da UN CONFLITTO DI SENSI, premessa al libro<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
143
Su Stati di Assedio<br />
Tre Neurosi, tre ferite inferte alla materia viva del testo, fitte di dolorose suture, punti intrecciati in una grande allegoria di linguaggi. La<br />
scrittura è soffusa di codici, segni diversi combinati a ricostruirsi un senso nell’ambiguità. Così è per il latino mescolato al rigore di una cartella<br />
clinica, per i riferimenti diagnostici accostati al backup di una macchina sull’orlo del reset, per la solitudine colma di autorità nel cybersex<br />
masochistico che rielabora alcuni tòpoi della sottomissione religiosa e del delirio mistico.<br />
L’automa compenetra il corpo dell’Uomo, l’oggetto animato diviene pròtesi di quello inanimato, in un continuo morphing creatura-cosacreatura.<br />
Il principio darwiniano è sostituito da quelli casuali di una logica impazzita, quasi un codice genetico modificato, che regola il calcolo<br />
proposizionale/evolutivo secondo un’approssimativa tavola di verità. Questa idea riflette la conditio humana contemporanea, in cui l’identità è<br />
distribuita, frammentata in istanze di cloud computing prima di ricomporsi in ego e l’imprevisto è un dato incalcolabile per Natura, un margine<br />
di incertezza tra le pieghe di un modello statistico, probabilmente fuzzy. Tutto ciò che non può essere trascritto in un linguaggio vibra nella<br />
dislocazione non deterministica delle sue parti, una maceria, un dolore che vale per sé come malessere del corpo e non su scala elementare.<br />
L’impasto dei codici forgia una matrice linguistica pregnante, che riproduce nel testo la figura e le dinamiche di una complessa rete neurale, le<br />
cui terminazioni hanno carattere periferico e informano il corpo e il mondo l’uno dell’altro. Alcuni termini agiscono da tag, attrattori,<br />
cortocircuiti dall’esito imprevisto: salvare, stato corrotto, accesso, memoria, conflitto ecc.<br />
La dialettica tra programmazione, scrittura di ricerca e poesia è risolta in favore di quest’ultima, adottando un’impalcatura formale entro la<br />
quale condurre però il fiato della parola ispirata, accettando la sfida di installare la poesia nel cuore della macchina, negli interstizi del suo<br />
linguaggio, tra i segnacoli di una metrica diversa. […]<br />
Federico Federici, da CODE-VERSE, postfazione al libro<br />
* * *<br />
[…] …la sua terza raccolta […] offre un esempio icastico di contaminazione tra linguaggio poetico e linguaggio informatico. L'uso di parentesi<br />
quadre, tonde e graffe, ad esempio,trasforma i versi in elementi di operazione, funzioni e vettori in un processo compositivo estremamente<br />
raffreddato, che allude alla programmazione informatica e - in certo modo - alla definizione di una ratio all'interno di una realtà opprimente che<br />
invade il soggetto […]. Al cuore di Stati di assedio c'è quella contraddizione insanabile e incomprensibile che è spesso all'origine dell'atto<br />
poetico: la volontà di dire e l'impossibilità di nominare. La scrittura di Mariangela Guàtteri è dunque un processo anomico, fenomeno più che<br />
evidente se si considerano i componimenti liminari che aprono le tre sezioni della raccolta, dedicati rispettivamente alla definizione di potere,<br />
piacere e dolore. La «voce in frequenza / molto bassa subliminale» di questi testi, incespica in un tentativo ricorsivo di determinazione<br />
dell'oggetto del discorso, che resta indeterminato. Accade così che «il dolore» non possa che darsi come «un dolore», «una forma di dolore»,<br />
«uno stato nascosto». L'impiego degli articoli indeterminativi è l'indice dell'incapacità del soggetto, della sua impotenza a fissare con la parola<br />
la propria (e la nostra) realtà, che può dunque solo essere mostrata:immagine o figura sospesa su un vuoto. Questa mancanza di potere del<br />
soggetto poetante, «una protesi del niente / che si lascia andare» in una nebulosa di enti, apparentemente interscambiabili, si ripercuote nella<br />
sua anatomia, che diventa«ortopedia assemblata». Le parentesi operano come separatori fisici non solo della materia testuale, in parte<br />
«tagliata» da altre fonti testuali e ipertestuali, ma anche di quella corporea: «un cuore un polmone / un arto separato un solo resto /...». E il<br />
corpo, corpo disorganico e costantemente riorganizzato nell'articolarsi rigoroso dei testi, gioca un ruolo importante quanto ingrato, poiché è su<br />
di esso che si manifestano gli stati d'assedio del titolo, siano essi prodotti da piacere, dolore o potere. […] Stati d'assedio si rivela dunque anche<br />
un esercizio di resistenza alle forme codificate d'inscrizione della terra, lla descrizione della condizione umana tramite un linguaggio imposto e<br />
altresì insignificante. […]<br />
Gian Maria Annovi, da Da Mariangela Guàtteri, esercizi di astrazione, in “Il manifesto”, 12.7.2011<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
144
Su Stati di Assedio<br />
In questo poemetto … la voce poetica si declina lungo le assi di tre neurosi. Il termine neurosi ha una valenza polifunzionale e complessa ma qui<br />
sostanzialmente sembra instaurare campi di forze, zone di tensione o frizione vibrante, crampi in cui la parola coagula e per intensificazione<br />
prende voce Il dettato poetico è visibilmente organizzato su uno standard, un pattern ripete in tre versioni la pratica di un’indagine modulare<br />
dal tratto pseudo-scientifico reiterata sui tre ambiti d’elezione: potere, piacere, dolore. […] La poetessa è anche performer e artista visiva,<br />
dedita a quello che definisce “nomadismo mentale”. Prima ancora di leggere il testo occorre forse guardarlo, così come ascoltarlo nella lettura<br />
pubblica a viva voce è evento non accessorio ma rivelatore di coloriture interne e di emersioni nominali precise. Il verticalismo della scrittura,<br />
organizzata sui pianali dei versicoli discendenti lungo la direttrice di lettura dall’alto in basso, allude come a un carotaggio, a una trivellazione in<br />
profondità. La tri-partizione del lavoro lungo i tre stati d’elezione è scandita in progressione - dal primo al terzo - solo per la necessità tecnica<br />
della lettura progredente di pagina in pagina. In realtà l’esito semantico-visivo di questa scrittura suggerisce un moto a elica. I tre assi ruotano<br />
concettualmente fasciandosi a spirale. Non si tratta di tre steli discendenti in parallelo nella trivellazione conoscitiva ma dello sfaccettarsi di una<br />
spirale che si avvita in profondo, ruotando su se stessa, come la punta di un trapano. La rotazione avviene a una velocità concettuale che lascia<br />
percepire il testo, ogni volta che ne mostra una faccia, come un corpo unico. Il moto descritto dai tre assi avvitanti è quello<br />
dell’accerchiamento. L’assedio è prodotto dal moto di avvitamento accerchiante dei tre stati. In questo senso l’assedio è radicale. Ovvero,<br />
come ogni assedio, è radicale in quanto circolare. […] Domandiamo … : chi o cosa è assediato? L’ipotesi che vogliamo argomentare è che<br />
assediato non sia qui un corpo, un essere, un’esperienza biografica ma l’asse centrale attorno a cui il testo si dispiega come moto accerchiante.<br />
[…] Il quarto asse, centrale, attorno a cui l’assedio si determina come avvitamento accerchiante dei tre stati disposti sulle facce del moto<br />
elicoidale, non è esplicitato nel corpo del testo. I corpi testuali sono soltanto tre, e sono - intensificati entro i c(r)ampi di forza delle neurosi - gli<br />
stati dell’assedio, le facce ruotanti della vite potere-piacere-dolore. Il quarto asse non partecipa della materia verbale e tuttavia la innesca e la<br />
regge. Questo asse è un fenomeno pre-verbale: è l’energeia del testo. L’energeia da cui il poema attinge il moto è la neurosi stessa nella sua<br />
fase non verbalizzata. La neurosi, dichiarata nei tre stati, li precede come condizione pre-verbale in quanto fenomeno di frizione che produce<br />
l’energeia del testo, dispiegandolo come assedio. Neurosi ed energeia sono due fasi dello stesso fenomeno silente (non verbalizzato). La<br />
neurosi è la fase didascalica e funzionale dell’energeia che permane nell’indichiarato ma opera quale quarto asse attorno a cui (e grazie a cui)<br />
ruota l’avvitamento assediante. Ad essere assediata è quindi l’energeia poematica del testo. La tensione dell’artista alla parola. […]<br />
Paolo Donini, da Energeia sull’asse d’assedio, in “Carte nel vento. Anterem”, novembre 2011<br />
[un dolore solo]<br />
* * *<br />
un frattàle di una nota / che organizza il tempo / e in ogni altra dimensione<br />
mg<br />
Ascoltare Mariangela Guàtteri che legge Stati di assedio, fa delle parole un’enormità visibile: è fare esperienza dell’enormità di una visione<br />
inversamente proporzionale al numero delle parole usate per dirla. Stati di assedio è ideato secondo precise restituzioni architettoniche a una<br />
gigantiasi, nel senso di deformità per eccesso, ben compresa nel singolo dettaglio e riprodotta secondo precisi stadi. In questo lavoro, che<br />
l’autrice stessa definisce articolato dalla paura, la costante a stordire del terrore è arginata da un controllo lineare in un assemblaggio plausibile<br />
che risolve l’espressione algebrica dell’emotività innescata nel concetto di paura. Nel pixel infinitesimo di un frantume verbale c’è già l’affresco<br />
di tutta l’opera. Ma non su di uno schermo. Tutto l’affresco della Guàtteri non si compone per schermate. Giorgio Bonacini nella prefazione<br />
infatti di tutta l’opera.<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
145
Su Stati di Assedio<br />
infatti avverte della qualità di “disegni sonori” della lettura che si sta intraprendendo, riprendendo due parole che compaiono tra i primi versi<br />
del libro, che poi l’autrice, come altre formule, reitererà. Puntuale, la voce della poetessa, impegnata nella lettura dei suoi versi, fa intendere<br />
che quel disegno è solo l’ossatura che compare sul foglio. La lettura che Mariangela Guàtteri fa della sua poesia dice come una poesia<br />
autenticamente dissennata, elargita da una pianta perfetta, sta nel suo, pronta alla dizione, in una vocalità vicinissima a tre punti dell’essere<br />
estremo: il potere, il piacere, il dolore. Dico dissennata come segnando un confine tra il senno e il non senno che induce lo stremo dell’essere<br />
alla veggenza. Il testo è anche diviso in queste tre parti, che l’autrice chiama Neurosi. Neurosi I il potere, Neurosi II il piacere, Neurosi III il<br />
dolore. «Le Neurosi sono allora tre segmenti di un solo programma articolato in routine, veri e propri code-verse annidati nel corpo del testo»<br />
(Federico Federici). Le Neurosi sono il blackout delle normodotazioni umane. Se il potere è «la detenzione di esistere», il non potere risiede<br />
nella sparizione della volontà a modificare, quindi nella scelta di non avviare «un processo volontario di alterazione». A ridosso di questo<br />
concetto è avvertibile tutta una proliferazione politica che la Guàtteri controverte dalla società ai corpi che la compongono con un linguaggio<br />
tecnico tanto più crudo quanto più si rivolge a materia organica. Cessare il solco della propria volontà sull’asse ibrido dell’orizzonte comune,<br />
significa accostare per gradi sempre più spaventosi l’azzeramento, in un incedere paritetico al proprio fenomeno «sognare polvere in rivolta<br />
che mostra i lati» perché solo «un accesso immediato si trasmette l’esistente» altrimenti perduto nell’alienazione metodica delle scelte. Nel<br />
parlare a sé rivolti, può stare il primo grado dell’azzeramento, il vero riconoscimento che avviene trasecolati dai desideri, giunti all’oscuro del<br />
tempo e di qualsiasi altra coordinata, nella circostanza immobile di essere uno che è mosso dal fatto plurale di venire assediato «senza<br />
mediazione / mi parlo / distillo / la purità muove / e ho gusti di darmi desiderio che infiamma per essere ogni mio tutto». Venire presi<br />
dall’imboscata del dialogo con l’elemento alternativo di se stessi, ossia venire presi da un sé alterno che non subisce l’apoteosi di comparire, è<br />
come attraversare un desiderio barbaro e nullificante, che scatena la mossa della paura, è come essere trafitti da una corrente incontrovertibile<br />
che conduce alla continua verifica di esistere, enunciando se stessi a partire dal corpo e dal sangue «la paura mi conduce al peccato / col vostro<br />
corpo salvatemi / col vostro sangue inebriatemi». È il corpo come presupposto fallace all’esistere che bisogna parossisticamente comprovare. È<br />
«l’indigenza del divino» che dà al corpo la separazione che lo rende vuoto, e che spinge alla gara iniziatica di un’azione radicale, un’azione che<br />
recida di netto la sensazione di non appartenersi. E in tutto il disamore che c’è nel potere questo, «vince chi muore per primo». Tuttavia la<br />
Neurosi II, si apre con la definizione del piacere che per quanto sia non più la «detenzione» ma «l’abbandono di uno stato di esistenza» (che<br />
lascia ancora ogni intenzionalità a margine) esso conduce per cedimento ancora più da presso alla zero distanza dal baratro che separa il corpo<br />
e il suo latore. L’autrice a questo punto fa sapere che il corpo ha una possibilità nel piacere, cioè quella di giungere «in procinto di essere<br />
anima», e ciò accade in virtù di un’imponderabile “contagio” con l’altro. Dalla Neurosi del piacere scaturiscono tutte le mosse corporee della<br />
metafisica animale, ed è un catalogo snocciolato di seguito, trattenuto il respiro, quello che catapulta la cognizione dalla Neurosi del piacere<br />
all’alienazione finale. Nella terza Neurosi il dolore confina il libro e l’esistenza. Là dove il potere, o il suo contrario, ha liberato i corpi<br />
dall’esistenza codificata e il piacere ne ha reso plausibile direttamente nella carne la sottigliezza inumana, il dolore è un buco «lo stato di ansia<br />
collettiva che diserta la memoria». L’essere, reciso dal ricordo di poter ricordare, è eviscerato, per cui non nutribile. Il dolore è una costrizione<br />
che rende inagibili a tutte le dinamiche di scarto, in cui l’azzeramento smette la ricerca nell’inedia definitiva che prelude al distacco. Il dolore<br />
inghiottisce da «un pensiero assoluto», così trascendentale che disgrega corpo e ambito, come sgranando il rosario circolare che non si<br />
interrompe malgrado l’interdizione dolorosa pare compiersi nel nulla da cui ancora è vinto, chi muore per primo.<br />
Viviana Scarinci, Vince chi muore per primo, in “Carte nel vento. Anterem”, gennaio 2012<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
146
Altri segni<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
147 x<br />
Come si è accennato nella nota bio-bibliografica di apertura, Mariangela Guàtteri si muove tra arte visiva e scrittura<br />
privilegiando, comunque, la ricerca. Impossibile, in questo spazio, dar conto della vasta opera da lei prodotta ed affidata,<br />
negli ultimi anni, anche alla rete. In questa pagina e in quelle immediatamente successive si riporta una serie di link che<br />
consentono la visione dei suoi più recenti e significativi lavori.<br />
the interrupt set, 2011<br />
asemic xerographies in “Sleeping fish”:<br />
http://sleepingfish.net/Xi/Guatteri.html<br />
no-title#0109 e #0209, 2011<br />
in “Moria - THE ASEMIC ISSUE”:<br />
http://www.moriapoetry.com/guatteri6565.html<br />
PRNT.ERROR/LAND3/A e LAND3/B<br />
in “The Klebnikov Carnaval”:<br />
http://khlebnikov.wordpress.com/expo/mariangela-guatteri/<br />
#01_polaroid, #02_polaroid, #03_polaroid, #04_polaroid,<br />
2011<br />
in “REM Magazine” - New Zealand Journal of Experimental<br />
Writing, volume 2, December 2011<br />
http://remmagazine.net/sieverts-issues/<br />
exercise#20110609, 2011<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/06/exercise20110609.html<br />
exercise#20110526, 2011<br />
in “LAB4040” (Curt Cloninger)<br />
http://lab404.tumblr.com/post/8835550253<br />
exercise#20110514, 2011<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/07/exercise20110514.html<br />
exercise#20110427, 2011<br />
in “Nothing and Insight”<br />
http://nothingandinsight.blogspot.com/2011/07/exercise201104<br />
27.html<br />
Der Kopf, 1992<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/08/der-kopf-1992.html<br />
Grandi Casse, 1992<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/08/grandi-casse-1992.html<br />
Le teste /heads, 1992<br />
in “Nothing and Insight”<br />
http://nothingandinsight.blogspot.com/2011/08/le-teste-heads-<br />
1992.html<br />
Der Kopf set, 1992<br />
in “slowforward”<br />
http://slowforward.wordpress.com/2011/08/27/der-kopfmariangela-guatteri/<br />
altre immagini in “Flickr”<br />
http://www.flickr.com/photos/mariangela_guatteri/sets/
Video arte e videopoesia<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
148<br />
x<br />
2 0 1 2, 2012 glitch video in exixtere [http://exixtere.blogspot.com/2012/02/2-0-1-2.html]<br />
e Art Hub [http://www.arthub.it/index.php?action=video&video=1840]<br />
cubo ferito, 2011<br />
in “exixtere”<br />
http://exixtere.blogspot.com/2011/12/cubo-ferito.html<br />
Trilogie<br />
(de Deux dimensions, 2009/2010, traduzione francese di Trilogia –<br />
testi successivamente pubblicati in Stati di assedio, Anterem, 2011)<br />
in “Une autre poésie italienne”<br />
http://uneautrepoesieitalienne.blogspot.com/2011/03/trilogie-de-deux-dimensions-videopoesie.html<br />
(la versione italiana è visibile anche su vari siti e blog: ultimamente nel periodico online Carte nel Vento<br />
e in http://www.anteremedizioni.it/montano_newsletter_anno9_numero16_guatteri)<br />
Atti e invocazioni, 2010/2011<br />
(testo successivamente pubblicato in Stati di Assedio, Anterem, 2011)<br />
http://www.youtube.com/watch?v=5NL538zhhBQ&feature=plcp&context=C34c240fUDOEgsToPDskI2fFZT<br />
4TUAA9XHoQ6MYsEj<br />
arts|en|if, 2010<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/09/artsenif.html<br />
Altro materiale video su YouTube<br />
http://www.youtube.com/merrimoco
Testi recenti<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
149 x<br />
6044. la pista cifrata, 2011<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/12/6044-la-pista-cifrata.html<br />
soggiorno moderno in sequenza borderline, 2011<br />
in “GAMMM”<br />
http://gammm.org/index.php/2011/12/01/soggiorno-modernoin-sequenza-borderline-mariangela-guatteri-2011/<br />
evidence_series, 2011<br />
in “eexxiitt”<br />
http://eexxiitt.blogspot.com/2011/07/evidenceseries.html<br />
[in audiovideo, lettura del testo alla Golena del Furlo - La Zattera<br />
dei Poeti,<br />
a cura di Franca Mancinelli, 2011<br />
http://www.youtube.com/watch?v=mXzTYTiSIbM&feature=plcp<br />
&context=C326fbdcUDOEgsToPDskLQo6UgJie_ztmKS24xW84Q]<br />
(da Stati di assedio, Anterem, 2011)<br />
in “Absoluteville”<br />
http://www.absolutepoetry.org/Hardcore-pornography<br />
[in audiovideo, lettura del testo a Reggio Emilia, Poetarum Silva<br />
(corpi a confronto), a cura di Enzo Campi, 2010<br />
http://www.youtube.com/watch?v=p9W3z0UubA0&list=PLE3EB<br />
4F9C3E8D7830&index=4&feature=plpp_video]<br />
Neurosi I (da Stati di assedio, Anterem, 2011)<br />
in “Anterem - Carte nel Vento”, dicembre 2011,<br />
anno VIII, n. 15<br />
http://www.anteremedizioni.it/montano_newsle<br />
tter_anno8_numero15_guatteri_m<br />
altri testi da Stati di assedio, Anterem, 2011<br />
in “La dimora del tempo sospeso”<br />
http://rebstein.wordpress.com/2011/11/29/stati<br />
-di-assedio/<br />
[trauma (e) trittico], 2010<br />
In “slowforward_hosts”<br />
http://slowforward.wordpress.com/2010/11/09/<br />
hosts-m-guatteri-t/<br />
da metodi del ricupero, 2010<br />
in “lettere grosse”, draft 03, dicembre 2010<br />
http://letteregrosse.blogspot.com/2010/12/03.h<br />
tml<br />
Letture e performance in audiovideo<br />
Video sul canale YouTube<br />
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE3EB4F9C3E8D7830&feature=plcp
Testi recenti<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
150 x<br />
Da NUOVO SOGGETTARIO<br />
A.1.1. Entità individuali non indicate con un nome proprio<br />
Un assedio alle caselle, al casellario, ai posti. La conquista dello spazio; processi di delocalizzazione (prima protesi, poi non<br />
umani, poi anche protesi) hanno spaesato [lo spazio si tende a misurarlo, si assottiglia]. Va fuori da sé poi anche di sé.<br />
Deviatori di segnali.<br />
Il cervello del XXI secolo, L’identità della follia, Buchi e altre superficialità, Le forme dell’oblio scavano delle tane ma - i più<br />
efficienti - dei bunker con molte molte cose dentro, comprese le magliette da sera, da uscita, da feritoia, da cosa attillata,<br />
da cornice con luci, binary blob che si sgonfiano, presto esauriti. Rivendicano esigui umani. Una ricerca - che ha poca<br />
precisione - della felicità immediata. Un bunker portatile, le tendenze, le ultime, lo danno da indossare; le precedenti<br />
probabilmente da regalare: un presente importante, un’occasione speciale. Ora è tutto indispensabile.<br />
raccatta un foglio poi in molti fanno pressione e interrompono. siete solo avanzi. deteriora. una corrente della porta (eventi<br />
di una presenza costante).<br />
ancora una mano, due mani, fivefingers con dei fogli attaccati alle dita sono gli unici alberi (a parte quelli con gli aghi che<br />
cadono di continuo). ma si dice che: abbiano un così bel verde davanti!<br />
ANALISI DEI RUOLI<br />
(Enunciato del soggetto: bla bla bla)<br />
[…]<br />
parte proprietà<br />
concetto chiave trapianto complicanze<br />
elemento<br />
transitivo<br />
elemento<br />
transitivo impiego degli<br />
strumento<br />
ormoni della<br />
crescita<br />
in “differxhost”, 2011: http://issuu.com/differxhost/docs/mguatteri_nuovosoggettario_diyfferx_2011
Testi recenti<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
151 x<br />
Da copia cache<br />
serial killers: nel primo<br />
trimestre 25% dopo la flessione<br />
ricomincia. morti bianche in<br />
analisi territoriale e impresa<br />
(WhitePaper). Kentucky,<br />
Lousiana, Arkansas ed ora la<br />
Svezia. una giornata per<br />
riflettere: lavorare è un<br />
diritto. così come circondati<br />
dalle persone a morire quattro<br />
Bambini rom e Bilancio nazionale<br />
1 trim.; 114 contro le 91 decine<br />
di km lungo le rive vengono<br />
trovati morti; colpita la<br />
Spagna: da mesi circolava sul<br />
Web l’11 maggio 2011. avrebbe<br />
devastato Roma. Numeri<br />
allarmanti di informazione,<br />
cronaca, video e foto. influenza<br />
A, MedicinaLive. Commenta! Tag:<br />
influenza A, patologie<br />
respiratorie, inizia malissimo<br />
[…]<br />
in “lettere grosse”, draft 05, dicembre 2011<br />
http://letteregrosse.blogspot.com/2011/12/05.html
Inediti. Da Due dimensioni (2009-2010)<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
152<br />
x<br />
Da Discovery<br />
[Uno]<br />
chiede psicocibo<br />
per il muscolo che cresce<br />
l’occhio si dimette<br />
(è il nervo che si stacca)<br />
sviene<br />
- Nutriscilo! Bene<br />
- Lo alzo, lo imbocco ancòra<br />
gli registro il cuore<br />
prendo tutte le misure<br />
gira<br />
allarga degli arti<br />
trova rime tra le pieghe<br />
(rovista la pelle)<br />
fa la conta degli ormoni<br />
bene<br />
- È psicodisperso...<br />
- È in stato prematuro<br />
[bisbigli tirati<br />
fronde molli le parole]<br />
vaga<br />
x<br />
[Videorama I]<br />
Premio “Lorenzo Montano”, XXVa ediz. 2011<br />
(da cui è tratto Stati di Assedio, Anterem, 2011)<br />
verso la fine del mondo: non esiste<br />
lui si sente come su terra andata<br />
nessuna linea convergente, no punti<br />
zone tangenziali assimilate in lastra<br />
partizioni dei blocchi: nulla, di fatto<br />
non lascia impronte, ogni istante si perde<br />
geografie stanno in privazione di bordi<br />
scavi fissure abbozzi di più bachi<br />
bacini: allagati (chilometri cubi)<br />
rifiuti liofilizzati<br />
[Uno]<br />
è disorganizzato<br />
indigente itinerante<br />
vaga in stato di abbandono<br />
(in larga superficie)<br />
a distanza<br />
ha bisogno di vestiti<br />
fino ad ora li ha trovati<br />
procurati da dei corpi<br />
(abitini di seconda)<br />
da dei morti<br />
assai sofisticato<br />
è apparente, è in stato<br />
(non potrebbe esser diverso:<br />
sta schermato)<br />
sniffa solo psicoattivi<br />
ha uno sfogo attorno al buco<br />
che lo nutre e lui si cresce<br />
si ammaestra lui<br />
si palpa
Inediti. Da Due dimensioni (2009-2010)<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
153<br />
x<br />
[Benchmark]<br />
<br />
L’intero settore primario:<br />
[si esplora globalmente]<br />
un circolo ristretto in zona<br />
(riservata in specie all’homo sapiens)<br />
è sistema complesso in apparente<br />
ma di fatto un grafo chiuso<br />
(ogni nodo informativo<br />
mutuamente collegato)<br />
che in eccesso di legami<br />
si risolve in relazioni<br />
mute e non significanti.<br />
Non depone in positivo<br />
un’analisi del rischio<br />
che si basi su dei cluster<br />
con rapporti bilanciati<br />
tra fatica e dimensione<br />
degli assetti in stabilizzazione<br />
<br />
È completo<br />
il munizionamento del settore<br />
[corpo da competizione organizzato<br />
(cacciapredatore)]<br />
attuabili tutti<br />
i sistemi ausiliari<br />
schemi vincenti previsti:<br />
totali<br />
<br />
Nelle zone psicoattive<br />
il sangue plasma in bolle<br />
moventi dentro un vuoto<br />
s’inglobano a vicenda:<br />
ha sangue<br />
in ogni ambiente<br />
[indicazione di una vita animale]<br />
ha arti:<br />
almeno una mano orientale<br />
procura<br />
Premio “Lorenzo Montano”, XXVa ediz. 2011<br />
(da cui è tratto Stati di Assedio, Anterem, 2011)<br />
[Videorama II]<br />
tra colline artificiali asciugate<br />
(l’acqua non esiste) sono incavi di un tipo:<br />
nutrizione frazionata non composta<br />
(messa a caso) lungo costole di frane<br />
arretrate nelle tombe: giusti spazi vs. tempo<br />
[o l’avanzo del futuro (disavanzo che non chiude)]<br />
delle luci tra due sponde (dei segnali)<br />
per la mano che rovista che consuma<br />
il già degenerato (psicomimetico cibo)<br />
lui mangia<br />
[Uno]<br />
procede invertito tirando<br />
(polveri dal suolo essenziale)<br />
assaggia in rispetto di forma<br />
le quasi-sostanza rimaste<br />
e sono organelli mancati<br />
nel senso di estinti<br />
(sapori abboccati)<br />
fa giochi col gusto si acconcia<br />
si mette in assetto di lotta<br />
aziona il secondo settore<br />
testa i sistemi primari<br />
quelli di ausilio e gli schemi<br />
scoperta la lista controllo<br />
(sei righe di luce ad impulso)<br />
esegue ogni punto (si accende)<br />
poi ruota sull’asse mediano<br />
attivo in simulazione<br />
[…]
Inediti. Da Due dimensioni (2009-2010)<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
154<br />
x<br />
[Videorama III]<br />
un’alba uguale al tramonto<br />
giallo che fonde nel fuxia<br />
appena accennato che versa<br />
in affronto a quel grigio che ha dentro<br />
la luce neonata da un tubo<br />
è un’overdose di mancanza<br />
di cielo che muta di giorni stagioni<br />
alterni percorsi di stella spariti<br />
cammina<br />
in cerca di mossa visiva<br />
calibra l’occhio ed è breve<br />
il tempo di scatto<br />
e sei fotogrammi al secondo<br />
stroboscopia di visioni<br />
di movimento apparente<br />
periodico in brancolo<br />
di articolazioni<br />
[Uno]<br />
Premio “Lorenzo Montano”, XXVa ediz. 2011<br />
(da cui è tratto Stati di Assedio, Anterem, 2011)<br />
È visibile in moto<br />
come un Grande Vetro (1)<br />
[ci si vede attraverso<br />
(l’ambiente e dentro)]<br />
celibe<br />
tutta una storia<br />
un concetto mentale<br />
un mito inerte<br />
sulla soglia immateriale<br />
esiguo ubiquo<br />
un labirinto un grafo<br />
che lavora intimamente<br />
pare un ragno<br />
in crescita frattàle<br />
è ragno<br />
tesse qualcosa<br />
nel primo settore<br />
si disorienta<br />
al ritmo crescente<br />
un disegno un assente<br />
(1): Esplicito riferimento all’opera<br />
duchampiana. «La posizione dello stallo<br />
è quella che non ammette movimento<br />
univoco, non ammette direzione del<br />
desiderio, è quello circolare in cui il<br />
movimento è la massima accelerazione<br />
della stasi e la stasi la minima unità del<br />
movimento. Tale posizione è quella<br />
dell’indeterminazione, in cui il segno più<br />
che essere impreciso è direttamente<br />
collegato all’immaginario, senza che<br />
intervenga la nozione del lavoro.<br />
Il lavoro è il momento dell’elaborazione<br />
del segno, ciò che stabilisce la cesura e<br />
dà all’immaginario uno statuto di<br />
oggettività. Nel Vetro la nozione di<br />
lavoro è sostituita da quella del<br />
labirinto, letteralmente lavoro dentro.»<br />
Achille Bonito Oliva, Vita di Marcel<br />
Duchamp, Marani editore
Inediti. Da Due dimensioni (2009-2010)<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
155<br />
x<br />
[Killer app] (2)<br />
teste di ragno in crescita numerica<br />
per ogni testa: zampe<br />
ogni zampa su ogni testa<br />
variazioni numeriche di zampe<br />
un popolo eccessivo<br />
sino alla porta<br />
dell’insignificanza:<br />
tra unità di un sistema<br />
(latenza)<br />
la visione da un’altra angolazione<br />
consente un’alternanza percettiva:<br />
da uno stato in moto<br />
all’essere in stato<br />
fisso<br />
con un gesto immoto<br />
poi pietrificato<br />
da un muoversi troppo<br />
(come un malato)<br />
un Parkinson del senso delle cose<br />
profondo sino<br />
alle singole parole<br />
uno zoomimetismo degli automi<br />
surrogati dei bisogni primari<br />
surrogati di respiro<br />
una semplificazione<br />
del pensiero<br />
seicento milioni di morti<br />
(in apparenza)<br />
nessuna resistenza<br />
dal neuroprocessore<br />
la morte è funzionale<br />
alla crescita in rete<br />
neurale del futuro<br />
che va ad assimilare<br />
Premio “Lorenzo Montano”, XXVa ediz. 2011<br />
(da cui è tratto Stati di Assedio, Anterem, 2011)<br />
- Pare aver perso coscienza<br />
- Tesse nel suo labirinto<br />
- È come molti corpi<br />
- Molteplici stati mentali<br />
- Cervelli in numero enorme<br />
- Coscienza in più corpi<br />
- Un eccesso non ha significato<br />
- Non ha intenzioni<br />
nel corpo si fonde la coscienza<br />
è questo è uno stato un’organizzazione<br />
si adatta si uccide (in modo naturale)<br />
e ancora si forma (avrà pure un’intenzione)<br />
pensiero residente nell’azione<br />
un modello ambiguo<br />
dalla fine cresce il principio<br />
un algoritmo che torna su se stesso<br />
non c’è definizione<br />
[…]<br />
(2): An application (or service)<br />
is called a killer application if<br />
the app (service) alone is<br />
reason enough to buy a device<br />
or sign up to a subscription. [...]<br />
Killer apps tend to be personal<br />
and vary by customer.<br />
European communications,<br />
Spring 2004
Su Due dimensioni<br />
[…] …sentiamo Guàtteri limitrofa allo sguardo cristallino di Giovenale. La sua è una chirurgia delle superfici, della vista visibile e netta, è mossa<br />
da una passione dell’intelligenza, se intelligenza è vedere quanto è fuori di noi, accorgersi di un altro. Dunque nel fatto stesso di “vedere tutto”<br />
sta la compassione. Quella di Guàtteri è la simulazione di un elenco melancholico di io - o eteronimi piuttosto malconci. I volti dei suoi<br />
protagonisti appaiono - da una abbagliante cecità contemporanea e circostante - specchiati sulla lama di un bisturi. Questo perché, con<br />
Giovenale, Guàtteri non adopera la sofferenza per fare poesia, ma ne installa sulla scena della pagina una esposizione allegorica statica, sospesa<br />
nel moto immoto delle opere di Duchamp. Ostensioni di cose comuni le quali, poi che vengono poste “fuori luogo”, fuori dal luogo fluido della<br />
vita vera, sono esposte a contatto diretto con l’immaginario. […] Guàtteri ha … pudore e carità, fa dell’ospedale un museo, per dirne bene la<br />
distanza apparente, dove vengono “esposte” le paure - il seppellimento da vivi, il contagio del corpo di terra - le pulsioni e gli effetti dei<br />
“farmaci” - appunto - nei circuiti venosi e reattivi. Museo sì, l’ospedale, ma anche grande corpo labirintico, dirotto e bianco: colonizzato e<br />
pervaso, agitato da installazioni interne che, sebbene in stallo, compiono i moti circolari, palindromi e ossessi delle guerre di trincea. Linee,<br />
scavi, cave di terra pieni di uomini spesso emaciati. I malati non sono dignitosi e umbratili come quelli di Anedda, sono una desolata carne che<br />
si spegne e dimena, sono carne priva, corpi in battaglia che denutriscono sotto deangelisiane cartine mute (nella Cartina muta di Milo De<br />
Angelis la coppia entra in una farmacia alla periferia di Milano dopo che il tempo è tutto passato, dopo che è ormai accaduto ogni rimpianto).<br />
Questo è quello che la poetessa vede nell’avanzare e retrocedere e avanzare ancora dei degenti lungo i corridoi, un circolare appunto circolare,<br />
una deambulazione fredda, fissata nella costante della paura, fino alla marcia indietro verso un punto di fuga che è l’ingresso: nell’ambulatorio,<br />
nella corsia e nella sua straniante dimensione escheriana. L’ospedale è così: corpo-museo-di-corpi, corpo-cava-di-terra-con-soldati, corpoentomologo<br />
e insieme corpo-insetto - e fatto in particelle, stringhe, numeri e tranci - ma soprattutto e comunque e ovunque: mortale. Così<br />
comincia Guàtteri: a che giova la lotta contro il male, a che giova la cura, se comunque…. Eppure qui non si manifesta lacrimazione alcuna,<br />
bensì un fortissimo senso del destino: i testimoni - tutti sembrano essere testimoni di se stessi - sono anche incarnazioni di un abbandono<br />
ontologico. Questo luogo è un disperso frammento di pianeta, che obliquamente ci riassume tutti, riassume la somma teorica delle nostre<br />
ombre quando il sole va giù e le fa lunghissime.<br />
Desideriamo aggiungere, a conclusione, che abbiamo voluto menzionare due artisti visivi come Escher e Duchamp perché riteniamo che tutte<br />
le parole di Mariangela Guàtteri siano guidate dal senso superiore della vista. Lo sono per i temi, certamente, ma anche per la forma con la<br />
quale vengono deposte sul foglio […] e infine perché, fin dagli esordi, Guàtteri muove la propria opera in una zona liminare tra la poesia e video<br />
nei quali le parole sono tutte staccate e mescolate ad altrettanti oggetti freddi - luci al neon, ingranaggi, giunture robotiche in movimento e<br />
voci artificiali (mentre le fotografie di Giovenale sono archeologia di uno sfacelo ancora umano). Nei video di Guàtteri non c’è quasi più carne e<br />
non c’è sangue, siamo in una sorta di Tetsuo (l’uomo-macchina del regista giapponese Shinya Tsukamoto) raggelato dall’essere incruento.<br />
Fermissima la tenuta della ragione. Fermissima la mano e la parola, linea così sottile da diventare chimica. Ma pur sempre di chimica organica<br />
stiamo parlando, pur sempre di una terza dimensione di verticalità, tanto più viva perché più rimossa, tanto più cocente perché<br />
apparentemente rinunciata. Fin che si scrive non esiste scomparsa veramente avvenuta: nonostante i segni meno, le sottrazioni, le denutrizioni<br />
e tutta la raggiera dei mancamenti.<br />
Maria Grazia Calandrone, in “Poesia” n. 269 (commento ad una selezione di testi inediti tratti da Due dimensioni) -<br />
[http://www.mariagraziacalandrone.it/attivitacritica/?magazine=poesia_marzo_2012]<br />
Mariangela<br />
Guàtteri<br />
156
Da Il canto dei nuovi emigranti -<br />
Serie composta tra il 1984 e il 1985<br />
con fotografie realizzate in Calabria
Annalisa Teodorani<br />
157<br />
È nata a Rimini nel 1978. Vive a Sant’Angelo di Romagna.<br />
Si è laureata alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali (Università di Bologna, sede di Ravenna). Ha<br />
collaborato con il Museo Etnografico della sua città di residenza ad una ricerca sugli antichi giochi di strada<br />
praticati in Romagna.<br />
Scrive in dialetto santarcangiolese dall’età di diciassette anni.<br />
Suoi versi sono apparsi su quotidiani e riviste locali e nazionali e sui principali blog letterari italiani.<br />
Tre sono i libri al suo attivo:<br />
• Par sénza gnént (Per nulla), introduzione di Gianni Fucci, nota di retrocopertina di Narda Fattori, Rimini,<br />
Luisè, 1999.<br />
• La chèrta da zugh (La carta da gioco), prefazione di Andrea Brigliadori, postfazione di Narda Fattori,Cesena,<br />
Il Ponte Vecchio, 2004.<br />
• Sòta la guàza (Sotto la rugiada), note di lettura di Manuel Cohen, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2010.<br />
La sua opera è stata oggetto di studio nel saggio critico a cura di Pietro Civitareale: Poeti in romagnolo del<br />
secondo novecento (Imola, La Mandragora, 2005) e nel Dizionario dei poeti dialettali romagnoli del novecento<br />
(a cura di Gianni Fucci, Villa Verucchio, Pazzini, 2006).<br />
In una recente intervista ha avuto modo di dichiarare che il suo percorso di ricerca poetica sta seguendo una<br />
linea di progressivo “assottigliamento” del testo. Ha inoltre svelato, oltre che la sua immensa e presagibile<br />
passione per tutte le scritture dialettali, una singolare curiosità (una “bizzarria” forse meritevole di un<br />
approfondimento di analisi): i suoi primi approcci con la scrittura in versi sono avvenuti utilizzando il dialetto<br />
romanesco (http://www.icarotv.com/portale_web/lib/portale.aspx?video=1153).
Da Par senza gnént (Per nulla), 1999<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
158<br />
I zchéurs dla zénta<br />
Dal vólti a m mètt ma la finèstra<br />
e a stagh da sintói i zchéurs dla zénta:<br />
da spèss i è acsè strach<br />
che la s putrébb sparagnè<br />
la fadóiga d’arvói la bòcca.<br />
Mo se la zcòrr in dialètt<br />
alòura i zchéurs i arciàpa vigòur,<br />
énca al patachèdi,<br />
e u m vén vòia d’andè ad ciòtta<br />
a dói la mi.<br />
COSTA COSI’ POCO SOGNARE<br />
Costa così poco sognare / a volte basta una<br />
stella, / un fiocco di neve vola muto /<br />
dietro i vetri appannati, / le foglie d'ottobre tra<br />
i capelli del vento / o quelle nuvole scomposte /<br />
come i pensieri dei bambini. / Se chiudi gli<br />
occhi, poi, / in un attimo può cambiare il<br />
mondo.<br />
I DISCORSI DELLA GENTE<br />
A volte mi metto alla finestra / e sto a sentire i<br />
discorsi della gente: / spesso sono così stanchi /<br />
che si potrebbe risparmiare / la fatica di aprire<br />
la bocca. / Ma se parla in dialetto / allora i<br />
discorsi riprendono vigore, / anche le<br />
sciocchezze, e mi viene voglia di scendere in<br />
strada / a dire la mia.<br />
E gosta acsé poch insugnè<br />
E gòsta acsè poch insugnè<br />
dal volti e' basta una stèla,<br />
una froffla ad nòiva ch'la sguélla mòtta<br />
spèsa i voidri apanéd,<br />
al fòi d' utobri tra i cavéll de vént<br />
o cal novvli smanèdi<br />
cmè i pensìr di burdéll.<br />
Se t céud i occ, pu,<br />
t'un sbréss e' pò cambiè e' mònd.
Da Par senza gnént (Per nulla), 1999<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
159<br />
L'è arvàta l'instèda<br />
L'è arvàta l'instèda: la regina dl'an<br />
sa chi su dè long, stois cmè la stréssa de mèr,<br />
sa cla strachèzza ch'la t strasòina par al strèdi<br />
cmè un cavàl vèc<br />
e la porta a zirchè un po' ad fresch ti cantéun,<br />
ma l'òmbra dal chèsi,<br />
par la calèda<br />
ad chi dè che e' sòul u n s'indurmènta mai.<br />
E quant l'éultma fòia, l'éultma rònda, l'éultmi madòun<br />
i s'è sculè l'éultmi cécch ad sòul<br />
la zénta la scapa fura<br />
cmè al luméghi dòp dla piova,<br />
la s bèrda sòura i scalòin e la ciàcra d'inquèl:<br />
de magnè, di baiocch, di mil<br />
e da léusa biénca di lampiunzìn<br />
la toira fura stori d'una volta<br />
la cambia tòun: la pèr énca piò bona.<br />
Pu, quant la vèggia la s fa straca,<br />
e un vangìn lizìr e' scavèccia la poppla<br />
la s'artoira sbadaiènd<br />
s'unmagòun dròinta, s'un fat d'arcurdè<br />
s'un segrét da mantnòi.<br />
È ARRIVATA L’ESTATE<br />
È arrivata l'estate: la regina dell'anno /<br />
con quei suoi giorni lunghi, distesi come la<br />
striscia del mare / con quella stanchezza<br />
che ti trascina per le strade / come un<br />
vecchio cavallo / e ti porta a cercare un po'<br />
di fresco negli angoli, all'ombra delle case,<br />
/ al tramonto, / in quei giorni in cui il sole<br />
non si addormenta mai. / E quando<br />
l'ultima foglia, l'ultima rondine, l'ultimo<br />
mattone / si sono bevuti l'ultimo goccio di<br />
sole / la gente se ne viene fuori / come le<br />
lumache dopo la pioggia, / si acconcia sugli<br />
scalini di casa e conversa di ogni cosa: / di<br />
cibo, di soldi, di acciacchi / e nella luce<br />
bianca dei piccoli lampioni / tira fuori storie<br />
d'un tempo / cambia umore: sembra anche<br />
più buona. / Poi, quando la veglia si fa<br />
stanca, / e un vento leggero scompiglia i<br />
capelli / si ritira sbadigliando / con un nodo<br />
alla gola , con un fatto da ricordare / con<br />
un segreto da mantenere.
Da La chèrta da zugh (La carta da gioco), 2004<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
160<br />
L'udòur de sàbdi<br />
A n l’arcórd<br />
l’udòur de sàbdi scapènd da scóla<br />
arcórd snò ch’a séra lizìra<br />
e l’aria datòunda<br />
l’éra tótta da bòi.<br />
IL RUMORE DELLA NOTTE<br />
Il rumore della notte sta / nel fondo di una<br />
conchiglia vuota / là dove si raccoglie il mare /<br />
che non vedi ma sai che c’è / e lo senti quando<br />
cambia il vento.<br />
L’ODORE DEL SABATO<br />
Non ricordo / l’odore del sabato uscendo da<br />
scuola / ricordo soltanto che ero leggera / e<br />
l’aria intorno / era tutta da bere.<br />
E' malàn dla nòta<br />
E’ malàn dla nòta e’ sta<br />
te fònd d’una cunchéa svóita<br />
là do ch’u s racói e’ mèr<br />
che ta ne vòid mo ta l sé ch’u i è<br />
e ta l sint quant e’ cambia e’ vént.
Da La chèrta da zugh (La carta da gioco), 2004<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
161<br />
Setèmbri<br />
Énca un zéi<br />
e’ cmìnza a fè òmbra<br />
LA BALLATA DELLE OMBRE<br />
Ho preso confidenza / con le ombre della casa /<br />
sono lì che mi aspettano / quando torno, la<br />
sera. / Vado nelle camere e loro spariscono,/<br />
però mi aspettano / aspettano in piedi. / Dietro<br />
la porta, dietro la tenda / giocano tra di loro,<br />
giocano con me. / Ci ho preso gusto, mi sono<br />
imbastardito / sono diventato un’ombra che<br />
corre nel cortile.<br />
SETTEMBRE<br />
Anche un ciglio / comincia a fare ombra.<br />
La balèda dagli òmbri<br />
O’ ciàp cunfidénza<br />
sagli òmbri dla chèsa<br />
a gli è a lè ch’a l m’aspétta<br />
quant ch’à tourni, la sàira.<br />
A vagh tal càmbri e lòu al va vii,<br />
però a l m’aspétta aspétta d’impii.<br />
Spèssa la pórta, spèssa la tènda<br />
al zuga tra ‘d lòu, al zuga sa me.<br />
A i ò ciapè góst, a m so imbastardóid<br />
a so dvént un’òmbra ch’la córr te<br />
curtóil.
Da La chèrta da zugh (La carta da gioco), 2004<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
162<br />
Du an<br />
Al mèni a l vuntèva di giarùl<br />
te vièl s’uqn vstidìn a pois.<br />
L’éra la vóita d’un pasaròt ch’e’ zùga<br />
s’una sménta, un fiòur...<br />
Pu l’à tàch a pióv<br />
la catóiva stasòun la s’à ingulè.<br />
A i’ò cmè un’òmbra t’un cantòun d’un òc<br />
u n gn’è gnént in fònd a e’ curidéur<br />
però u m tòcca sèmpra guardè.<br />
ARIA DI MARZO<br />
Lasciate un'anta aperta / che non è più<br />
freddo. / Leggera.... / L'aria di marzo è<br />
piena di lucciole volatie / è la faccia di<br />
un bimbo / che ha pianto per un<br />
capriccio.<br />
DUE ANNI<br />
Le mani tracimavano di sassolini / nel viale con<br />
un vestitino a pois. /<br />
Era la vita di un passerotto che gioca / con una<br />
semenza, un fiore... / Poi ha cominciato a<br />
piovere / la cattiva stagione ci ha ingoiati. / Ho<br />
come un’ombra nell’angolo di un occhio / non<br />
c’è nulla in fondo al corridoio / però devo<br />
sempre guardare.<br />
Aria ad mèrz<br />
Lasé una pàca' vérta<br />
ch'u n'è piò frèd.<br />
Lizìra....,<br />
L'aria ad mèrz l'è pìna ad lozzli vulatéi<br />
l'è la fàza d'un burddlìn<br />
ch'l'à pianzéu par un caprézz.
Da La chèrta da zugh (La carta da gioco), 2004<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
163<br />
I pach<br />
Nadèl senza nàiva<br />
e léu l’éra quèl<br />
che i pach<br />
u i apuzéva te capàn.<br />
La chèrta sal fiséuri<br />
ócc ad burdèl<br />
la stóvva a cherosene<br />
e una machina da cusói<br />
fióla ad cla granda<br />
e made in URSS.<br />
MARZO<br />
È un chiaro d'aria quasi da bere /<br />
nei pomeriggi gentili / chiaccherati<br />
lungo i viali, nei trebbi degli uccelli. /<br />
In casa il mondo diventa più piccolo /<br />
fuori apre i polmoni. / Mi prende<br />
piano una voglia nuova / un non so<br />
cosa come di vivere fino in fondo /<br />
voglia di lasciare panni vecchi, libri... /<br />
Anche le parole sembrano dover<br />
spiccare il volo / dietro a un filo di<br />
vento che muove, appena, una<br />
ragnatela.<br />
I DONI<br />
Natale senza neve / e lui era quello / che i doni<br />
/ li appoggiava nel capanno. / La carta con le<br />
fessure / occhi di bambino / la stufa a<br />
cherosene / e una macchina da cucire / figlia di<br />
quella grande / e made in URSS.<br />
Mèrz<br />
L'è un cièr d'aria quèsi da bòi<br />
ti dopmezdè zantoil<br />
ciacaréd lòngh i viél, ti trébb di gazott.<br />
Ad chèsa e' mònd e' dvénta piò znìn<br />
ad fura l'érva i pulméun.<br />
U m ciàpa pién una vòia nova<br />
un nonsochè cmè ad campè dabon<br />
vòia ad lasè pan vécc, loibri...<br />
Enca al paroli e' pèr ch'agli apa da ciapè e' vòul<br />
dri m'un foil ad vént ch'è mov, apéna, un talaràgn.
Da La chèrta da zugh (La carta da gioco), 2004<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
164<br />
E' nòn<br />
Ad léu<br />
u m tòurna in amént al méni gràndi, pini ad caramèli<br />
e la voita l'éra dòulza<br />
mo me a ne savòiva<br />
a cridèvva m'al foli<br />
e ma che patàca de mi fradàl ch'u m gévva:<br />
«L'òs-cia la sa ad frèvla!»<br />
LA CARTA DA GIOCO<br />
Era così sottile / che pareva una carta<br />
da gioco / nella foto, un poster… / E<br />
lui è andato via / con lei tra le dita /<br />
che pareva uno di questi prestigiatori<br />
/ che si vedono in tivù.<br />
IL NONNO<br />
Di lui / mi tornano in mente le mani<br />
grandi, piene di caramelle / e la vita<br />
era dolce / ma io non me ne<br />
accorgevo / credevo alle fiabe / e a<br />
quello sciocco di mio fratello che mi<br />
diceva: / «L’ostia sa di fragola!»<br />
La chèrta da zugh<br />
La éra acsè stòila<br />
ch'la parévva una chèrta da zugh<br />
tal foto, un poster...<br />
E léu l'è andè vì<br />
sa lii tra 'l dòidi<br />
ch'e' parévva éun ad chi prestigiatéur<br />
ch'i s vòid in tivù.
Su Par senza gnént e La chèrta da zugh<br />
[…] Par senza gnént nell’ambito del “fare” è locuzione che può significare sia senza pretendere alcunché sia inutilmente, vanamente ed<br />
evidenzia la predilezione per il gioco dei rimandi, l’ironia, la sottile compiacenza per tutto ciò che attinge al circuito delle valenze multiple e<br />
quindi delle ambiguità che è uno degli “stratagemmi” del suo [di Annalisa Teodorani] fare poetico […]<br />
In questa raccolta, con una pronuncia personalissima e un originale registro linguistico, l’autrice viene a confermare, per dirla con Brevini, «la<br />
tendenza della poesia contemporanea a risalire in un regressus dal macro al micro, non soltanto dalle koinai regionali e dalle parlate municipali<br />
agli idiomi periferici, ma addirittura dal dialetto all’idioletto». […] A cifrare la qualità dei suoi testi, concorre … in vasta misura, tutta una serie di<br />
meccanismi che i linguisti chiamano “figure”. Da quelle di costruzione: ellissi, apposizioni, zeugmi; a quelle di elocuzione: allitterazioni, asindeti;<br />
da quelle di stile: enfasi, perifrasi; a quelle di significato o tropi: metonimie, metafore, sineddochi, ecc.<br />
Mentre sul piano strutturale, vediamo che la sua poesia si realizza fuori da qualsiasi gabbia metrica e quindi in versi sciolti di sostenuta<br />
intonazione lirica. […]<br />
La sua è una poesia dell’ascolto: Acsè e’ témp dla nòta / l’è tótt un ciacarè lizir (Così il tempo della notte / è tutto un parlottio leggero); Pu un<br />
tóun, cmè una bómba in piaza, / l’à smòs cl’aria indurmenta (Poi un tuono, come una bomba in piazza / ha smosso quell’aria assopita) … […]<br />
Poesia dell’ascolto, si è detto, ma anche attenta ai piccoli gesti, ai moti minimali delle cose e dell’animo. Infatti l’area semantica cui rinviano i<br />
materiali lessicali di Annalisa Teodorani è quella riconducibile alle piccole esperienze personali dove le istanze conoscitive sono inscindibili da<br />
quelle esistenziali. […]<br />
Se è vero che, come osserva Pasolini, «I pallori, gli éclats improvvisi, le ambigue sordità, le rozzezze, i cipigli di una parlata portata d’un tratto<br />
alla “luce della parola”, non possono non suggestionare», la Teodorani non sembra volersi gingillare attorno alle facili suggestioni esercitate<br />
dall’“intraducibilità” del dialetto. Anzi! Il suo discorso poetico si annuncia con tratti che si potrebbero chiamare di “elementarietà”, che fornisce<br />
alle parole la giusta chiarità; che proviene dalla semplicità di un dettato, dalla moderata densità degli assunti, e soprattutto dalla caparbietà con<br />
la quale rifugge da qualsiasi forma di vernacolarismo. […]<br />
Gianni Fucci, dall’introduzione a Par senza gnént<br />
* * *<br />
[…] La novità è quella di una poesia dialettale santarcangiolese […] che spunta imprevista e forse anche inattesa a due o tre generazioni di<br />
distanza dalla incredibile fioritura (incredibile perché avvenuta in tempi e spazi così ristretti) di talenti come Baldini e Guerra e Pedretti, fino a<br />
Giuliana Rocchi e Gianni Fucci. Ci si poteva aspettare che dopo di loro più nulla, o quasi, riuscisse a farsi sentire; che tutto il possibile fosse<br />
esaurito con loro […]<br />
Il mistero è quello di una voce di giovanissima donna, la quale si affida al dialetto in tempi di accelerato disfacimento della cultura della parola<br />
(parlata e tanto più se scritta) a vantaggio di una comunicazione fatta di segni, gesti, suoni, immagini, colori, monosillabi, la quale tocca e<br />
trascina soprattutto i più giovani […] e dunque in tempi in cui il dialetto patisce ancora una volta la precarietà del suo destino. […]<br />
Forse qualche spiegazione alla novità e al mistero di Annalisa Teodorani è data appunto [e anche] dai versi … nei quali l’insipida pochezza della<br />
lingua viene contrapposta al vigore comunicativo del dialetto, che è tale da farsi scegliere da chi è in cerca di un linguaggio (un modo, un<br />
lessico, un codice) adatto alla propria poesia, una lingua che lo coinvolge intero […].<br />
Pare dunque che la voce del “poeta” possa veramente esprimersi soltanto nel codice linguistico che condivide con la “zénta” in quanto egli<br />
stesso ne è parte, per nascita, orizzonte, cultura, intendimento di vita e di mondo; che il dialetto abbia insomma, per chi lo sceglie per la<br />
propria scrittura, una sorta di intraducibile unicità. D’altra parte fu Walter Galli, in una lettera ad Annalisa del 23 febbraio 1999, a scrivere: «La<br />
nostra lingua [il dialetto]<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
165
Su Par senza gnént e La chèrta da zugh<br />
nostra lingua [il dialetto] è oggi praticamente sconosciuta, o è stata rimossa, dalle giovani generazioni. Ritengo che tu sia cresciuta in ambiente<br />
dialettofono… Non mi convincono gli autori che disinvoltamente scrivono in italiano e in dialetto: non ne comprendo le motivazioni». Come<br />
dire che per scrivere “vera“ poesia dialettale, il dialetto bisogna averlo nel sangue, esserci nati, farne direttamente parte, trasferire in esso, per<br />
immediata necessità, pensieri e parole. […]<br />
Il dialetto santarcangiolese, e di radice rurale, […] forse spiega [ancora] il mistero della poesia di Annalisa, il cui ambito essenziale si lascia<br />
facilmente identificare in un perimetro che comprende centralmente “la chèsa”, luogo verticale degli affetti e del tempo, dei vivi e dei morti,<br />
delle presenze e delle ombre, dell’infanzia e della conoscenza […].<br />
Intorno, s’intende, un paese d’alberi e di viali, di stagioni e di giorni […]. Un paese che è mondo, ininterrotta chiacchiera di uccelli e di gente,<br />
pagina del tempo […]. […] La poesia di Annalisa: il senso angusto e povero del paese, di un’esistenza collettiva che condivide un che di<br />
rassegnato, di stanco e triste. Senza alcun abbandono descrittivo, comunque, né corrivamente realistico. Sempre, invece, un cogliere, per rapidi<br />
segni, i brividi e i presentimenti della vita; per tagli analogici […].<br />
Nel primo libro il suo battito si confondeva in qualche modo col ritmo collettivo della vita delle Contrade, si accomunava a quello della gente, vi<br />
si nascondeva, quasi. Il cuore intimo, intendo, la singolarità del sentire. Ma in questo secondo libro, per il tramite del ricordo o del sogno, sono i<br />
“moti del cuore” a farsi sentire , i suoi soprassalti, i suoi trasalimenti, i suoi presentimenti; come un tema sottostante e discreto, ma pur sempre<br />
assunto a misura delle cose vissute, a sentimento profondo dell’esistenza. […]<br />
Andrea Brigliadori, dalla presentazione a La chèrta da zugh<br />
* * *<br />
È … riuscita a descrivere in maniera “vissuta” i luoghi, le emozioni, le povertà materiali, le fatiche di lavori ingrati, gli inverni lunghi al buio delle<br />
quattro mura di casa, le piccole gioie dell’infanzia …, la strada …, l’attesa della neve; e il tutto in una lingua non inquinata, ma nella più pura<br />
tradizione della grande scuola dialettale santarcangiolese.<br />
C’è una vena di malinconia che sottende il libro, ma come addolcita dal riconoscimento di un’appartenenza ad un luogo e alla tradizione di un<br />
popolo. Tutto si articola attorno ad una casa fra le poche case del paese, quella strada, la madre, il nonno, la scuola, i giochi d’infanzia, ma i<br />
desideri, le timidezze, i piccoli grandi pensieri sono gli stessi di tutti gli uomini; è cioè presente un respiro che oltrepassa quel piccolo perimetro.<br />
[…]<br />
Franco Casadei, in “Il parlar franco”, anno IV, n.4 2004<br />
* * *<br />
[…] Diciamo subito che la poesia della Teodorani […] presta la sua voce alla chiusa esistenza di una comunità di provincia con un’adesione docile<br />
e persino rassegnata, ma con un’attenzione pronta a coglierne le asimmetrie, i cedimenti, le contraddizioni, i cambiamenti in atto tra un<br />
microcosmo fermo ai suoi secolari costumi ed una civiltà aggressiva ed omologante che ne sta via via cancellando le peculiarità sociali e<br />
culturali. Sempre attenta agli eventi della quotidianità nella loro molecolare scansione, La Teodorani esprime una radicale e radicata fedeltà ad<br />
un sistema di vita improntato alla semplicità, dettato dai sentimenti ed ubbidiente a se stesso, nei termini di un linguaggio coerente nei suoi<br />
stilemi con un contesto culturale consolidato, refrattario a contaminazioni neologistiche ed a forzature sintattiche.<br />
Sotto tale aspetto, la sua poesia si offre esplicitamente come una elegia sulla fugacità del tempo e sulla precarietà dell’esistenza, a cui<br />
contrappone la solidità del linguaggio dialettale, inteso come elemento di rigenerazione e di reintegrazione sociale. Da qui la compattezza del<br />
suo stile<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
166
Su Par senza gnént e La chèrta da zugh<br />
del suo stile, la peculiarità degli accostamenti verbali, la saldatura tra imprestiti letterari e memoria di una civiltà contadina percepita come<br />
paradigma morale. Frugando nel proprio passato linguistico di cui riutilizza lessemi e idiomatismi desueti, di provenienza rurale, ella ci dà la<br />
misura della evoluzione storica del suo dialetto, ci fornisce gli ambiti della sua psicologia, la dimensione del suo dinamismo comunicativo ed<br />
evocativo […].<br />
Con la seconda raccolta di versi Annalisa Teodorani fa un notevole salto in avanti, sia sul piano dell’invenzione linguistica che della essenzialità e<br />
della pregnanza del dettato poetico, mentre ci sembra che più acuto e risentito si sia fatto il sentimento della condizione esistenziale<br />
dell’uomo, bersaglio non soltanto delle necessità naturali ma anche della propria tendenza autodistruttiva; e ciò è motivo in lei d’ansia ed<br />
allarme […].<br />
Similmente il senso della propria vicenda personale sembra essersi fatto più esclusivo e cogente. Se nella prova precedente la Teodorani si<br />
osservava vivere nell’ambito di una realtà sociale condivisa, in questa sua seconda prova appare al contrario più attenta a se stessa, alle<br />
indicazioni che le provengono dai soprassalti del cuore e della mente: più chiusa, insomma, nella sua individualità.<br />
Ma ciò che maggiormente colpisce nella sua prova poetica più recente è la sintassi delle immagini, il loro articolarsi in un aggregato di elementi<br />
quasi privo di una giustificazione logica in cui è l’oggetto (un dato fisico della realtà) a fare da tramite tra il fantasma della “rivelazione” ed il<br />
Soggetto. Si dà cioè nel dettato diaristico ed occasionale quella illuminazione improvvisa (nascente di solito da un sentimento di nostalgia) che<br />
sembra alludere a certe forme di “euforia” a cui tende quasi sempre ogni fatto autentico di poesia. Una esperienza poetica dunque quella della<br />
Teodorani impegnata sul piano dell’invenzione e delle strutture poetiche, come si dà in certi suoi supponibili antecedenti letterari (mettiamo<br />
Pascoli, Montale, i crepuscolari) fino all’esperienza coeva di Tolmino Baldassari, dal quale media verosimilmente la capacità di accostare nuclei<br />
lirici apparentemente incongrui, circonfondendoli di un alone di stupore e di rivelazione:<br />
A n l’arcórd<br />
l’udòur de sàbdi scapènd da scóla<br />
arcórd snò ch’a séra lizìra<br />
e l’aria datòunda<br />
l’éra tótta da bòi.<br />
(L'udòur de sàbdi)<br />
Non ricordo<br />
l’odore del sabato uscendo da scuola<br />
ricordo soltanto che ero leggera<br />
e l’aria iatorno<br />
era tutta da bere.<br />
(L’odore del sabato)<br />
[…]<br />
Pietro Civitareale, da Sulla soglia del terzo millennio, in Poeti in romagnolo del secondo novecento, La Mandragora, 2005<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
167
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
168<br />
Paróli<br />
A campémm sparagnénd.<br />
I dói che al tartaréughi<br />
a l chèmpa una màsa perché li n zcòr.<br />
Paróli nóvi, paróli antóighi<br />
ch’a gli à fat la rózzna<br />
m’al grèdi di cunsinèri.<br />
AMORE<br />
Immagina il Vajont / una montagna che frana<br />
nell’acqua. / L’amore è un inverno che gela le<br />
tubature / una diga senza nemmeno un<br />
rubinetto.<br />
PAROLE<br />
Viviamo risparmiando. / Dicono che le<br />
tartarughe / campano molto perché non<br />
parlano. / Parole nuove, parole antiche / che<br />
hanno fatto la ruggine / alle grate dei<br />
confessionali.<br />
Amòur<br />
Fa còunt e’ Vajònt<br />
una muntàgna ch’la va zò tl’àqua.<br />
L’amòur l’è un’invarnèda<br />
ch’la giàza al tubadéuri<br />
una diga<br />
senza gnénca un rubinèt.
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
169<br />
La sudisfaziòun<br />
Ta m dé la sudisfaziòun<br />
d’una puràza svóita.<br />
COME LA LUNA<br />
Non puoi chiedere / di andare lontano da te<br />
stesso. / Una come la luna / nelle notti di me si<br />
vede / una fetta sottile.<br />
LA SODDISFAZIONE<br />
Mi dai la soddisfazione / di una vongola vuota.<br />
Cumè la léuna<br />
Ta n pu dmandè<br />
d’andè dalòngh da te.<br />
Euna cumè la léuna<br />
tal nòti ad me u s vòid<br />
una fitìna stóila.
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
170<br />
La dóta<br />
I cavéll pulóid i arléus te sòul<br />
cavéll ad ragàza<br />
da imbastói curòid<br />
che la nòna e la ma a l s’aracmànda.<br />
La mi dóta l’è un fas ad spóin.<br />
PRECIPIZIO<br />
È come cambiarsi d’abito senza uscire /<br />
prendere le misure a un dispiacere. / Questa<br />
vita che per precipizio / ha la sponda di un letto<br />
/ o la riva di un pensiero.<br />
LA DOTE<br />
I capelli puliti brillano nel sole / capelli di<br />
ragazza / da imbastirci corredi / che la nonna e<br />
la mamma si raccomandano. / La mia dote è<br />
un fascio di spini.<br />
Precipóizi<br />
L’è cumè mudès senza scapè<br />
tó al miséuri m’un dispiasòir.<br />
Sta vóita che par precipóizi<br />
l’à la spònda d’un lèt<br />
o la róiva d’un pensìr.
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
171<br />
Sparguiéd<br />
Dal vólti ta t sint sparguiéd<br />
e t fiuréss t’un fòs.<br />
UNA CESTA<br />
Lasciatemi lì / dove mi avete vista / come<br />
quella cesta / coi gomitoli di lana / con i ferri<br />
infilzati.<br />
Tacapàn<br />
Cumpàgn di gazótt ch’i dórma in vòul<br />
tacapàn<br />
tl’aria férma d’un armèri.<br />
SPARSO<br />
A volte di senti sparso/ e fiorisci in un fosso.<br />
Una zèsta<br />
Lasém a lè<br />
do ch’ a m’avói vést<br />
cumè cla zèsta<br />
s’i ghéffal ad lèna<br />
s’i férr instécch.<br />
ATTACCAPANNI<br />
Simili ad uccelli che dormono in volo /<br />
attaccapanni / nell’aria ferma di un armadio.
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
172<br />
Nuvèmbri<br />
L’aria fóina<br />
ch’la vén zò da e’ mòunt<br />
l’è cumè nòiva sòura la tu fàza.<br />
Nuvèmbri ti campsènt<br />
u s radàna.<br />
Al tu pavéuri al càsca<br />
a zantnèra, a mièra<br />
cumè fòi sòura i viél.<br />
A péunt i mi ócc<br />
ti ócc d’un petròs.<br />
ANCHE I GIRASOLI<br />
C’è un momento / in cui non capisci / se sono<br />
fuochi giù al mare / o tuoni su in montagna. /<br />
anche i girasoli non sanno più dove guardare /<br />
e gli uccelli da nido ti entrano in casa.<br />
NOVEMBRE<br />
L’aria fine / che scende giù dal monte / è come<br />
neve sopra la tua faccia. / Novembre nei<br />
cimiteri si riordina. / Le tue paure fioccano / a<br />
centinaia, a migliaia / come foglie sopra i viali.<br />
/ Punto i miei occhi / negli occhi di un<br />
pettirosso.<br />
Enca i giraséul<br />
U i è un mumént<br />
che ta n capéss<br />
s’l’è fugh zò a maròina<br />
o téun so in muntàgna<br />
Ènca i giraséul i n sa piò duvò guardè<br />
e i gazótt da nóid<br />
i t’òintra ad chèsa.
Da Sòta la guaza (Sotto la rugiada), 2010<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
173<br />
Al spòusi zòvni<br />
Al spòusi zòvni l’è pavaiòti<br />
ch’a l pérd l’arzént pr’una fulèda ad<br />
vént<br />
gòzli d’àqua<br />
ch’ a l róiga un vóidar<br />
la matòina prèst.<br />
LE ZIE<br />
Nel buio della vita / con il rosario tra le mani /<br />
hanno vegliato / un dolore alla volta. /<br />
Conoscono la radice di ogni fiore. / Le zie<br />
hanno la scorza dei cipressi / e quando<br />
piangono / resina e miele.<br />
Un pèl<br />
Dal vólti t’ arvènz<br />
cmè éun ad chi pèl<br />
ma la bòca de pòunt.<br />
Quand la vóita la n t lasa i ségn<br />
la t làsa agli òmbri.<br />
LE GIOVANI SPOSE<br />
Le giovani spose sono falene / che perdono<br />
l’argento per una folata di vento / gocce<br />
d’acqua / che rigano un vetro / al mattino<br />
presto.<br />
Al Zéi<br />
Te schéur dla vóita<br />
sla curòuna tal mèni<br />
a gli à fat la vègia<br />
m’un dispiasòir a la vólta.<br />
A l cnos la radga d’ogni fiòur.<br />
Al zéi a gli à la scórza di arzipréss<br />
e quant al piénz<br />
ràisna e mél.<br />
UN PALO<br />
A volte rimani / come uno di quei pali / alla<br />
bocca del ponte. / Quando la vita non ti lascia i<br />
segni / ti lascia le ombre.
Su Sòta la guaza<br />
“O’ vést che t’avivi ti occ una<br />
févra lizìra”<br />
(Giuliana Rocchi)<br />
Nell’arco di un decennio, o poco più, 1999-2010, la giovanissima Annalisa Teodorani, nata a Rimini nel 1978 e naturalizzata a Santarcangelo di<br />
Romagna, lontana dai clamori delle grandi vie della comunicazione letteraria, ma nell’alveo fecondo di una delle grandi couches della poesia<br />
mondiale, e oltremodo seguita affettuosamente da lettori di rango (Andrea Brigliadori, Caterina Camporesi, Franco Casadei, Pietro Civitareale,<br />
Narda Fattori, Gianni Fucci, Gianfranco Lauretano, Gianfranco Miro Gori), dal suo laboratorio appartato e molto discreto sulle opere e i giorni,<br />
ha prodotto e percorso, con l’attuale, tre raccolte di versi dal «timbro riconoscibile e distintivo» (sono parole di Narda Fattori che appaiono<br />
nella nota in retrocopertina a Par senza gnént): il momento, credo, è opportuno per un consuntivo o per una lettura d’insieme.<br />
Anche Sòta la guàza, Sotto la rugiada, come le precedenti raccolte, Par senza gnént, Per nulla (introduzione di Gianni Fucci, nota in<br />
retrocopertina di Narda Fattori, Luisè Editore, Rimini 1999) e La chèrta da zugh, La carta da gioco (presentazione di Andrea Brigliadori,<br />
postfazione di Narda Fattori, Il Ponte Vecchio, Cesena 2004) colpisce per l’esiguità del numero dei testi: nel primo libro 30, nel secondo 28, e in<br />
questo, 25; una vena apparentemente parsimoniosa e parca, ma pure una tenacia e una tenuta notevoli; e, per inciso, la parsimonia è persino<br />
nella scelta dei titoli che ricade in tutti e tre i casi sugli enunciati di componimenti eponimi. Leggo infatti le tre suites come parte di un tutto,<br />
tappe perimetrali e significative della caparbia edificazione di un possibile canzoniere; unius libri, di esistenza, di luoghi, di natura, e d’amore. A<br />
proposito, vale la pena riportare le affermazioni di uno dei più accreditati studiosi dei neodialettali romagnoli: «La Teodorani esprime una<br />
radicale e radicata fedeltà ad un sistema di vita improntato alla semplicità, dettato dai sentimenti ed ubbidiente a se stesso, nei termini di un<br />
linguaggio coerente nei suoi stilemi, con un contesto culturale consolidato, refrattario a certe contaminazioni neologistiche e a forzature<br />
sintattiche» (Cfr. Pietro Civitareale, in Poeti in romagnolo nel secondo Novecento, La Mandragora, Imola 2005, pp.106-108; argomentazioni<br />
riprese in, Poeti in romagnolo del Novecento, a cura di Pietro Civitareale, Confine, Roma 2006, pp. 17-18).<br />
Un elemento di coesione è dato dalla formularità dei testi: in ognuna delle tre raccolte, ad esempio, l’ultima composizione si riconnette con la<br />
prima per corrispondenza lessicale, per una immagine, o tropo. Nel primo libro, è il caso di un animale e di una immagine metaforica: nel testo<br />
ancillare si tratta di una ‘gattina’, ‘un gomitolo di pelo rossiccio’, che ritroviamo nell’ultimo testo trasmutati rispettivamente in un ‘gatto nero’ e<br />
nella metafora ‘un gomitolo di sogni’; mentre nel libro successivo, ricorre nel primo testo la metafora del ‘filo di mare’ ripresa nell’ultimo, dove<br />
si fa ‘filo lucente’. Parimenti, ora, il lettore di Sòta la guàza, potrà constatare l’assoluta corrispondenza stabilita tra il primo e l’ultimo testo: in<br />
questo caso, tuttavia, con uno scarto rispetto ai precedenti, la corrispondenza viene data non già dal lessico in frequenza bensì dall’orizzonte di<br />
riferimento: il primo testo Al zéi, Le zie, si apre con la metafora del ‘buio della vita’, oscurità che nell’ultimo, Murt, I morti, sta nella sinonimia<br />
della privazione della possibilità di vedere lontano, unitamente a una associazione o accostamento tra vecchiaia e fine della vita, con<br />
l’immagine delle anziane zie intente a recitare il rosario e quella conclusiva della sedia che prende la forma dei pensieri, sedia come correlativo<br />
oggettivo di una condizione. La curiosità del lettore, almeno questo è un auspicio, farà sì che questi possa scoprire, sotto la «apparente dimessa<br />
veste lessicale» (Cfr. Gianni Fucci, introduzione a Par senza gnènt, cit.), una fitta trama di riferimenti e di coordinate testuali e tematiche<br />
ricorrenti.<br />
All’esiguità del numero dei testi, di cui sopra, corrisponde pure la brevità: composizioni in versi ipometri e informali o liberi, divincolati dalla<br />
metrica e da esigenze di rima o musicalità; non di rado i testi sono singoli, castigatissimi versi-frasi monorematiche, o distici, mentre rarissimi<br />
(3, in tutta la produzione) quelli che sforano la pagina. Come per i versi e per la lunghezza, così per l’aggettivazione, mai in eccesso, e ridotta<br />
all’essenziale.<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
174
Su Sòta la guaza<br />
all’essenziale. Ma di una pratica di sottrazione, risente la sintassi, in genere piana, elementare, eppure caratterizzata da frequenti salti o<br />
cortocircuiti di senso (pregrammaticali, quasi di oralità) favoriti dal ricorso a un immaginario vegetale e animale. Di un millimetrico continuare<br />
‘a levare’, d’altro canto, ci dicono gli stessi testi, e particolarmente rivelatore è Paróli, Parole, che ricorda, per l’esercizio di pazienza e<br />
caparbietà, la laboriosità parsimoniosa di una civiltà contadina: A campémm sparagnénd. / I dói che al tartaréughi / a l chémpa una màsa<br />
perché li n zcòr, Viviamo risparmiando. / Dicono che le tartarughe / campano molto perché non parlano.<br />
Soffermandomi ancora sugli apparati di paratesto, e prima di entrare nel libro, una ulteriore spia è nei titoli delle raccolte, che fanno a vario<br />
grado riferimento a ricognizioni minime, a realtà marginali o ad attitudini secondarie: spie programmatiche di un orizzonte di riferimento che<br />
passa per strade non affollate, che ignora una dimensione metropolitana, (nessuna traccia di frequentazioni di città) ed evita l’avvitamento a<br />
grandi temi. In altre parole, già nei titoli è possibile cogliere l’attitudine a una humilitas, l’aderenza a un humus, un tenersi bassa, un osservare e<br />
dire le cose con pensieri e immagini quanto più vicini all’oggetto, o alla sua idea, un argomentare il proprio sentire con una lingua che ha per<br />
habitus l’understatement, in un procedimento di rastremazione e fine lima che producono una lingua basica, priva di compiacimenti, e non<br />
esibita. Si deve a Gianfranco Miro Gori, nella recensione a Par senza gnént (“Il corriere di Romagna”, giovedì 6 gennaio 2000) il richiamo alle<br />
«humiles myricae, i bassi tamerischi, che Pascoli - per citare un poeta vicino a noi nel tempo e nello spazio - riprese da Virgilio; alle cose e alle<br />
persone da poco; agli episodi minori o comunque non degni di Storia».<br />
Ma è la stessa Teodorani, invitata a dare una testimonianza su Giuliana Rocchi, a dirci nella doppia rivelazione della scoperta decisiva della<br />
poesia della sua concittadina e della natura della sua propria: «Nella casa dove trascorrevo gran parte dei miei pomeriggi di svago e presso cui<br />
Giuliana godeva di grande stima, quelle poche righe scritte in quella strana grafia (- o’ vést che t’avivi ti occ una févra lizìra, ho visto che avevi<br />
negli occhi una febbre leggera -, n.d.r.) mi incuriosivano e mi contrariavano allo stesso tempo. Non capivo bene che senso avessero eppure<br />
esercitavano su di me un fascino antico. La presa di coscienza di una grafia dialettale mi rese consapevole di quanto io fossi immersa in quella<br />
realtà umile e proletaria che sola si esprimeva attraverso il dialetto ma ne divenni anche profondamente gelosa. Mi infastidivano l’incoerenza e<br />
lo snobismo di chi cercava il dialetto scritto come un vezzo, decidendo razionalmente di non parlarlo quando ce l’aveva dentro, prendendo<br />
dunque a schiaffi la mia storia personale che sola passava attraverso quel buco, permettendosi di correggere, come già faceva la maestra delle<br />
elementari, le mie storpiature dialettali della lingua italiana» (Annalisa Teodorani, «E’ bén dabon»: il mio ricordo di Giuliana Rocchi, “Il parlar<br />
franco”, anno VII, n. 7, 2007, pp. 27-28).<br />
Anche in sede critica, a conferma delle parole della nostra, nella recensione di Caterina Camporesi (Par senza gnént, “Il parlar franco”, anno II,<br />
n. 2, 2002, pp. 135-136) e nell’intervento di Gianfranco Lauretano (La giovane speranza del dialetto, “Il parlar franco”, anno IV, n. 4, 2004, pp.<br />
116-118) è presente il richiamo alla Rocchi e a una ‘matrice popolare’. Mentre Andrea Brigliadori nella sua prefazione (cit.) accenna a un<br />
‘battito’ che si confonde ‘col ritmo collettivo della vita delle Contrade’.<br />
Si deve comunque a Gianni Fucci, primo grande lettore e sostenitore della Teodorani, l’aver segnato un solco critico, e un viatico, nella lettura<br />
della giovane voce. Nella introduzione al primo libro della nostra, la perizia del poeta romagnolo evidenzia, tra i molti rilievi, il portato popolare<br />
e ‘rurale della sua lingua: «Il suo è un santarcangiolese dalle sonorità più aspre dovute a lemmi e dittonghi arcaici di ascendenza rurale, in un<br />
contado che si può localizzare nel tratto di territorio comunale situato attorno al fiume Uso, con le frazioni di Canonica, Stradone-Gessi,<br />
Montalbano e Ciola Corniale che, rispetto a quello degli altri santarcangiolesi citati (Tonino Guerra, Lello Baldini, Nino Pedretti, Giuliana Rocchi,<br />
lo stesso Fucci, ndr.) attesta, in riferimento ai dittonghi: zantóil per zantéil (gentile), aróiva per aréiva (arriva)…» facendo seguire un lungo<br />
elenco di variazioni nella dittongazione, come pure la varietà nei lemmi.<br />
Grazie a Gianni Fucci che ha fornito le coordinate, è più agevole comprendere Annalisa Teodorani nelle sue scelte linguistiche, e pure nei suoi<br />
addentellati<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
175
Su Sòta la guaza<br />
addentellati di territorio: è in qualche modo possibile circoscrivere in una precisa area di Santarcangelo la matrice linguistica, la delimitazione di<br />
una couche geoantropologica, che sta ab origine di questa esperienza. Alcune grandi vicende poetiche ci ricordano che l’aver delimitato e<br />
focalizzato il proprio sguardo su uno specifico orizzonte fisico, tematico, affettivo, immaginativo, ontologico, ha significato delineare una<br />
autenticità di dire irredimibile nello stigma della propria unicità: da Giovanni Pascoli a Biagio Marin e Albino Pierro, da Tonino Guerra a Andrea<br />
Zanzotto, da Tolmino Baldassari a Attilio Bertolucci e a Umberto Piersanti, ma anche in due relativamente giovani neodialettali come Ivan Crico<br />
e Fabio Franzin, per stare a nomi a noi prossimi, in cui un sentimento precipuo dell’essere dentro il paesaggio e dentro una storia di civiltà e<br />
natura, assume una valenza eminentemente destinale, non già nel senso di una Historisch, bensì in una più intima e decisiva Geschichtlich.<br />
Le radici popolari e rurali, ràdghi, parola chiave dell’autrice, danno motivo della natura di questa poesia: sobria e raccolta, dove la discrezione<br />
più che l’allusività, ha la tonalità di una lancinante mitezza, quando ad esempio affronta l’amore, e dove la grazia è dolente, e il dolore è<br />
composto, affidato a immagini concrete, efficaci nella loro ispida nudità: un fas ad spóin (un fascio di spine), o dove anche la contentezza è a<br />
metà, cuntantèza a mità. È una poesia di dolcezze contenute e acuminate, come spesso in Giuliana Rocchi, ma come pure in una tutta al<br />
femminile grande triade neodialettale di riferimento: Franca Grisoni, Ida Vallerugo e Assunta Finiguerra, e i cui campi tematici delimitati vanno<br />
dal femminile al domestico-rurale con una campionatura di lessico in frequenza che comprende: lanzùl (lenzuolo), dòta (dote), curòid (corredi),<br />
cantòun d’un zinalòun (lembo di grembiule), ghéffal ad lèna (gomitoli di lana), férr instécc (ferri infilzati), mulèti (mollette), tacapàn<br />
(attaccapanni), armèri (armadio), scaràna (sedia), màchina da cusói (macchina da cucire), stóvva a cherosene (stufa), furminènt (fiammifero),<br />
chèsa (casa), capàn (capanno). Anche la religiosità, attesta origini popolari, come le anziane che recitano il rosario, la coròuna, grèdi di cunsinèri<br />
(grate di confessionali), il cristico fas ad spóin (fascio di spine), Nadèl (Natale), mirécal (miracolo), campani (campane), campsènt (cimiteri).<br />
Così, pure nella strumentazione retorica appare evidente l’originaria matrice popolare, chiaramente di oralità, eppure di eco sacroscritturale,<br />
nel frequente ricorso a figure di ripetizione, parallelismi e similitudini, che ne rappresentano un tratto distintivo della quiddità o stile.<br />
Similitudini spesso afferenti a campi semantici di natura e di paesaggio: ‘una come la luna’, ‘come foglie sopra il viale’, ‘come quando piove’,<br />
‘come la strada di un pomeriggio’, ‘come uno di quei pali alle bocche di ponte’, ‘come neve sopra la tua faccia’, ‘attaccapanni simili a uccelli’ (il<br />
lettore perdoni qui e sotto le citazioni in traduzione, dovute a esigenze di praticità).<br />
Accanto alla domestica e alla religiosa, una terza coordinata fondamentale o invariante afferisce al campo semantico della natura, nelle sue<br />
varie opzioni: vegetale, animale, esistenziale, atmosferica. Teodorani, annota Civitareale, «si ispira al ritmo delle stagioni, al dinamismo dei<br />
fenomeni naturali» (op.cit.); letta in questa ottica, i riferimenti ideali a una tradizione romagnola che vede in Aldo Spallicci il cantore di un<br />
mondo creaturale osservato nel trascorrere dei giorni, dei mesi, delle stagioni, e a lei più attiguo, per sensibilità e più contemporaneo gusto di<br />
rastremazione e contrizione della effusività lirica, la poesia di Tolmino Baldassari, per una poetica di contenuto stupore nell’osservazione del<br />
cosmo. Ecco allora i richiami frequenti al mare, ora mér, ora maròina, alla montagna, muntàgna e mòunt, cielo, zìl, terra, tèra, luna, léuna, sole,<br />
sòul, o i molti richiami a eventi atmosferici: vento, pioggia, neve, buio, luce, notte, fuochi, tuoni o nominazione di eventi e occasioni: mattina<br />
presto, matóina prèst, pomeriggio, dopmezdè, novembre, nuvèmbri, Natale, Nadèl, fino alla nominazione botanica di piante frutti, o di parte di<br />
essi: cipressi, arcipréss, quercia, arvùra, fiore, fiòur, girasoli, giraséul, foglie di radicchio, fòi di radécc, mandarino, mandaròin, germogli, zarmòi,<br />
scorza, scórza, radici, ràdghi, resina, résna, miele, mél. O i riferimenti al mondo animale e creaturale: uccelli da nido, uccelli, pettirosso, falene,<br />
vongola, tartarughe.<br />
Eppure, a ben leggere, il lettore noterà, quanto il richiamo alla natura e al paesaggio, sia lontano da un gusto prezioso di certa lirica dialettale<br />
un po’ arretrata, o dalla oleografia di un paesaggio o contrada tradizionale. Nella Teodorani, l’osservazione del paesaggio e della comunità<br />
rinvia sempre a una dinamica esistenziale, «sotto cui vibra un pensiero tattile, olfattivo, nel significato letterale, di senso attivo, vibratile a<br />
cogliere”<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
176
Su Sòta la guaza<br />
cogliere» (Cfr. Narda Fattori, postfazione a La chèrta da zugh, cit.) una riverberazione di uno stato o stadio emozionale: in questo senso il<br />
rischio di un lirismo fine a se stesso è evitato dall’autrice il cui gusto e la cui natura tendono a evidenziare in più occasioni le incrinature del<br />
diamante grezzo: accade così frequentemente che a una dimensione apparentemente sospesa segua la tensione di un allarme di indicibile<br />
precarietà: il buio della vita, l’inverno che gela, la montagna che frana, il cadere in una buca, il fiorire in un fosso, il sentirsi disperso, sparso,<br />
sparguiéd, le paure che fioccano, una perdita di orientamento che spinge uccelli da nido dentro casa, spaesamenti come indicatori di una<br />
inquietudine irriducibile.<br />
Di questa inquietudine, udito e vista, attraverso gli organi della bocca e degli occhi, si fanno testimoni o scribi. La bocca, bòca, organo<br />
attraverso cui la phonè, intima e di memoria collettiva, articola suoni, continuamente in bilico tra paróli nóvi (nuove parole) e paróli antóighi<br />
(parole antiche), avverte la minaccia di un inverno, molto metaforico nella sua carica visionaria, e molto metafisico nella sua polisemia, che<br />
serra la bocca: t’à srè la bòca. Ma pure allude la voce a una comunità che non parla, n zcòr, o che viene registrata nella conversazione<br />
pomeridiana sull’uscio delle case, nel suo parlózz (siesta). Sonar e radar di questa inquietudine, e ulteriori strumenti di una acuminata<br />
decodifica del mondo e dei suoi allarmi, sono gli occhi. Gli occhi, correlativi del campo semantico della vista affrontato nelle sue varie<br />
declinazioni: vedere e esser visti, ma soprattutto, l’ansia destabilizzante del non poter vedere: ócc dè par dè i n vòid piò dalòng, occhi che<br />
giorno per giorno non vedono più lontano, come è detto nel testo finale e più marcatamente malinconico; o occhi come rispecchiamento, di<br />
alterità e di purezza, e levità: occ ad burdèll, occhi di bambino, specchi ustori di una condizione di fragilità, di paura o vicissitudine sospesa,<br />
come nella bellissima Nuvèmbri, Novembre: gli occhi della Teodorani incontrano l’altro da sé creaturale, ne condividono il freddo e la pena, la<br />
condizione terrestre e terrena dalle valenze di una stimmung attuale: a péunt i mi ócc / ti ócc d’un petròs, punto i miei occhi / negli occhi di un<br />
pettirosso.<br />
Nel palinsesto della poesia contemporanea, Annalisa Teodorani potrebbe apparire, per le sue scelte di campo, come un meteorite precipitato<br />
sulla parterre della poesia italiana. Il lettore paziente e curioso, potrà invece cogliere le domande, le inquietudini, i dubbi attivi di una giovane<br />
donna, di una voce limpida e sicura, molto consapevole dei propri mezzi espressivi, e molto decisa nella sua scelta linguistica e tematica radicali,<br />
in cui, per inciso, le ‘radici’ e i ‘vecchi’ si fanno correlativi oggettivi di una vocazione testarda, di una fedeltà a una appartenenza. Nei suoi versi<br />
ci racconta di un mondo affettivo, esistenziale e creaturale, della sua voce e dei suoi silenzi, delle sue ansie e dei suoi smarrimenti. Un mondo<br />
che molto ha da dirci, e che ci riguarda un po’ tutti da vicino.<br />
Manuel Cohen, Annalisa Teodorani - Gli occhi negli occhi di un pettirosso, in “La dimora del tempo sospeso - Repertorio delle voci”, maggio<br />
2010<br />
* * *<br />
…ciò che stupisce, incontrando Annalisa Teodorani e la sua poesia, è la pienezza umana e linguistica, quasi impensabile in una donna ancora<br />
molto giovane. C’è infatti, nelle sue poesie, una capacità di rappresentare luoghi, personaggi, vicende e sentimenti come solo una personalità<br />
matura e con gli occhi pieni di stupore sa interpretare.<br />
Ha fatto sue le storie di chi l’ha cresciuta, delle strade e dei vicoli dove ha vissuto la sua infanzia, cosicché l’innato talento le ha permesso di<br />
regalare a noi - già poco più che ventenne - pagine di una caratura poetica straordinaria, sia per la sostanza che per la forma.<br />
Nella sua nuova pubblicazione […] non mancano versi di una liricità commovente […], tuttavia, rispetto a La chèrta da zugh, prevale una forma<br />
più asciutta, concisa, tant’è che la lunghezza della maggior parte delle ventuno composizioni non supera i 7-8 versi. Questo cambiamento<br />
comprova che quello del poeta è anche un lavoro sulla propria scrittura, un approfondimento del pensiero e un modo di obbedire<br />
all’ispirazione che muta nel tempo.<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
177
Su Sòta la guaza<br />
all’ispirazione che muta nel tempo.<br />
Analizzando i testi, nel complesso prevale un certo scetticismo nei confronti della condizione umana e il suo destino. L’amore sembra non<br />
decollare nei suoi aspetti gioiosi, di letizia. Prevale l’esperienza del gelo del rapporto […], della solitudine […], della fugacità della giovinezza<br />
della sposa […]. Per non parlare della dote, un fascio di spine […]. Come pure ferisce il guardarsi cinico […].<br />
Una profonda verità rinveniamo in Cumè la léuna («Ta n pu dmandè / d’andè dalòngh da te»). Non possiamo chiedere di andare lontani da noi<br />
stessi, quasi che per risolvere i drammi del vivere basti partire; che sia sufficiente viaggiare per lasciare a casa tormenti e angosce. Una perla<br />
nella sua intensa brevità è senza dubbio Sparguiéd («Dal vólti ta t sint sparguiéd / e t fiuréss t’un fòs») in cui, in due semplici versi, si coglie la<br />
sensazione di inutilità, di non contare nulla per nessuno (buttato là, sparguiéd); eppure dentro questo abbandono germina un fiore, proprio nel<br />
luogo meno appropriato, un fosso; come a dire che non c’è condizione umana in cui non possa riaffiorare la speranza, la possibilità di nascere di<br />
nuovo.<br />
In un’esperienza di deserto e di sconcerto che cadenza gran parte della raccolta […], trova spazio comunque il desiderio di un accadimento che<br />
possa positivamente investire la vita […]. Un’invocazione che sembra trovare ascolto nella lirica che dà il titolo alla silloge, Sòta la guàza, dove si<br />
descrive la meraviglia della grazia di un germoglio sotto la rugiada («E te t’è la grèzia d’un zarmòi / sòta la guàza»). Fra l’altro la stessa prima<br />
lirica, Al zèi, - un vero gioiello - descrive la fatica del vivere («Te schéur dla vóita / sla curòuna tal mèni / a gli à fat la vègia / m’un dispiasòir par<br />
vólta»), ma anche la consapevolezza che la vita ha un destino da coltivare e far fiorire («A l cnòs la ràdga d’ogni fiòur»). […]<br />
Franco Casadei, in “Corriere cesenate”, settembre 2010<br />
* * *<br />
[…] Ricordando un grande poeta santarcangiolese, Raffaello Baldini, si può dire che la Teodorani ne abbia raccolto il vessillo: la sua poesia così<br />
icastica e parca al contrario di quella di Baldini, traboccante nel dire, così fermamente cementata all’oralità, contiene una visione del mondo<br />
molto simile, tutt’altro che consolatoria, di solitudine che pervade sia il soggetto che l’oggetto della scrittura.<br />
Già la doppiezza semantica del titolo del libro, ancora una volta verso di una poesia, induce a riflettere sul sottotraccia: la guàza, cioè la rugiada,<br />
è notturna, bagna un poco, induce a rabbrividire ma anche disseta e dà vita al germoglio in cui si identifica la poetessa; dunque dolore e<br />
sentimento di una compiutezza ancora da conquistare e al buio ma con la certezza di avere radici salde, lunghissime, come quelle della quercia<br />
dove immagina gli antenati ancora seduti , lei, loro vita che s’abbevera al tempo.<br />
Ma il tempo è anche dolore e vita che muore: le giovani spose , come le farfalle, perdono l’argento della loro spensieratezza e le loro lacrime<br />
rigano i vetri la mattina presto. In questa poesia brevissima le immagini dicono il mondo, il sentire, il vedere: certe mattinate d’autunno o<br />
d’inverno, per un fatto fisico di differenza di temperatura capita un fenomeno di condensazione all’interno delle case che sui vetri si rende<br />
visibile con gocce che scendono. Pur essendo poeta di pochi , pochissimi versi, Annalisa è poetessa lirica non sapienziale, epigrammatica.<br />
Ma tutte le ventiquattro poesie sono scritte all’insegna della visionarietà e del presagio; il dialetto è per sua natura una lingua scarna, Annalisa<br />
la rastrema ulteriormente ma regala a parole e frasi la figurazione metaforica operata su più strati di senso. […]<br />
Ormai si parla con parole che hanno perduto consistenza e capacità di penetrare nel dire: questa è una consapevolezza di molti poeti, in lingua<br />
e in dialetto. O forse sta proprio alla base della scelta di una lingua poco usata, per questo rimasta concreta e piena di storia, per un dire fuori<br />
da ogni cortigianeria e /o partigianeria. […]<br />
Narda Fattori, in “VDBD - Viadellebelledonne”, novembre 2011<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
178
Inediti<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
179<br />
Par tott i piént, par tott i fùgh<br />
Par tótt i piént<br />
ch’i n’à tróv niséuna cunsulaziòun<br />
e par tótt i fùgh ch’i s’è smórt da par lòu<br />
ma pròima i s’è purtè via inquèl.<br />
L’ULTIMO GOCCIO<br />
Ti ho visto nello specchio / con le mani nelle<br />
tasche mi aspettavi. / Non mi sono voltata / ho<br />
scambiato per amore / l’ultimo goccio / nel<br />
fondo del bicchiere.<br />
PER TUTTI I PIATTI, PER TUTTI I FUOCHI<br />
Per tutti i pianti / che non hanno trovato<br />
alcuna consolazione / e per tutti i roghi che si<br />
sono estinti da soli / ma prima si sono portati<br />
via tutto.<br />
L’éultum cécch<br />
A t’ò vést te spèc<br />
sal mèni tal bascòzi<br />
ta m’aspitìvi.<br />
A m’u n so vultè<br />
ò scambiè par amòur<br />
l’éultum cécch<br />
te fònd de bicìr.
Inediti<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
180<br />
Èli e ràdghi<br />
A t’ò niné<br />
fin a fèt indurmantè<br />
èli e ràdghi a l s’è invrucèdi.<br />
E t’una nòta pursì<br />
da la nèbia l’è scap fùra<br />
un pésgh in fiòur.<br />
ZOCCOLETTI GIALLI<br />
Se guardi da una fessura/ vedi che si muovono<br />
da soli./ Zoccoletti gialli, tre per due,/ e l’estate<br />
con tutti i suoi dentini.<br />
ALI E RADICI<br />
Ti ho cullato / fino a farti addormentare / ali e<br />
radici si sono intrecciate. / E in una notte<br />
qualunque / dalla nebbia è spuntato / un pesco<br />
in fiore.<br />
Zuclitìn zal<br />
Se t guérd da una fiséura<br />
t vòid ch’i va in zóir da par lòu.<br />
Zuclitìn zal, tre par do,<br />
e l’instèda sa tótt i su dintìn.
Inediti<br />
Annalisa<br />
Teodorani<br />
181<br />
I tu murt<br />
Tl’òura che<br />
la pròima foschéa la bèsa la tèra<br />
tra quèl che t vòid<br />
e quèl che t pu imazinè<br />
fà còunt ch’i t vénga incòuntar lòu<br />
I tu murt<br />
a bràza ‘vérti cumè un vént dl’instèda.<br />
VOGLIA DI VITA<br />
Anche il colore dei tuoi occhi / si è stancato. / E<br />
ti vedo lontano / in fondo a una voglia di vita /<br />
che a volte ti duole.<br />
I TUOI MORTI<br />
Nell’ora in cui / la prima foschia sfiora la terra /<br />
tra ciò che vedi e ciò che puoi immaginare / fa’<br />
conto che ti vengano incontro loro / i tuoi morti<br />
/ a braccia aperte come un vento d’estate.<br />
Vòia ad vóita<br />
énca e’ culòur di tu ócc<br />
u s’è strach.<br />
E a t vègh dalòngh<br />
in chèva m’una vòia ad vóita<br />
che dal vólti la t fa mèl.
Da A Silvia -<br />
Serie composta tra il 1987 e il 1988<br />
con fotografie realizzate a Senigallia<br />
e a Recanati ,<br />
nella casa di Giacomo Leopardi
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
182<br />
1.<br />
Sono arenato sugli atolli dove esplodono le bombe del B52 che non sono riusciti a richiamare. Se la chiave<br />
strutturale del Dottor Stranamore è il coito, i funghi di quelle esplosioni nucleari sono orgasmi, schizzi di<br />
sperma nella vagina della terra. Ma questa lettura divertente e dissacrante non mi ha mai convinto sino in<br />
fondo. La cifra sessuale mi sembra piuttosto una sorta di controcanto alla follia della corsa agli armamenti.<br />
Sesso e volontà di dominio, orgia del potere, colonizzano la mente del militare, come ognuno che abbia a che<br />
fare con questa corporazione sa bene: il generale padre di famiglia, timorato di dio, pronto a rimproverare<br />
figli e nipoti per una parola volgare, comunica con i suoi soldati per mezzo di un codice pornolalico; e come<br />
prova di intimità raggiunta la prima cosa che dice al vicino, sino a poco prima solo un estraneo, è «A me delle<br />
donne piace il culo». E quando quello, un po’ seccato dal cambio di registro di uno che fino ad allora non<br />
aveva parlato che di patria e famiglia, gli domanda seccamente «Anche di tua moglie?» non sa fare di meglio<br />
che mettersi a sghignazzare e alza il bicchiere per l’ennesimo brindisi. «Al culo delle donne.» brindano D’altra<br />
parte, sessuale è la fobia di Ripper, il generale psicopatico che scatena la guerra nucleare. Per sfuggire alla<br />
cospirazione comunista internazionale tesa a diluire e contaminare gli umori vitali più preziosi, gli americani<br />
devono bere acqua pura, cioè acqua piovana o distillata, come fa lui che ha intuito il pericolo prima degli<br />
altri. Come se n’era accorto? Se n’era accorto quando durante il coito aveva avvertito una certa stanchezza,<br />
un vuoto dentro, quelli erano sintomi della perniciosa perdita d’essenze. Le donne infatti cercano nell’uomo<br />
la linfa vitale, quella che Ripper, avendo capito tutto, ora negava loro.<br />
La guerra dunque come psicopatologia della vita quotidiana. Ma l’ossessione sessuale, suggerita fin dalle<br />
famose immagini falliche delle prime scene, musi e proboscidi degli aerei, è solo, appunto, il controcanto<br />
sarcastico alla struttura portante della narrazione, quella che corrisponde alla logica dei “giochi” di guerra,<br />
impotente e folle. Come la narrazione del film dimostra. Come dimostra tutto il cinema di Kubrick, autore di<br />
Orizzonti di gloria. Parodia, piuttosto che analogia. Da questo punto di vista allora, considerato che i nemici<br />
non si vedono mai, fatta eccezione del caricaturale ambasciatore, il ‘corpo a corpo con i russi’ teorizzato da<br />
Ripper al momento dello scatenamento dei bombardieri strategici, non è altro che una colossale<br />
masturbazione meccanica, «Venga qui, mi tenga la cinghia…».
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
183<br />
Quando sto bene, le parole mi vengono facili. Eppure sono qui a domandarmi se riuscirò mai a finirlo<br />
questo libro.<br />
Sono il primo a svegliarmi. Voglio vedere il mare. Il sole è ancora dietro la collina di pini, il mattino è<br />
fresco. Scendo sino al porto in cerca di un bar. Finalmente ne trovo uno aperto nella piazzetta sull'Aurelia.<br />
Una coppia di vecchi sta facendo colazione con cappuccino e brioche. Mentre prendo il caffè guardo le<br />
barche, barche di ogni tipo e misura. All’inizio del molo una bacheca con la lunga lista d'attesa per i posti che<br />
si rendessero liberi. Un pescatore col secchio libera la barca dall'acqua piovuta durante la notte.<br />
«Buon anno, signore.»<br />
«Buon anno a lei.»<br />
Ora è giorno limpido. Voglio raggiungere la spiaggia e toccare il mare. Bisogna aggirare la scogliera e<br />
seguire per un paio di chilometri la statale. Il traffico, per fortuna, è ancora molto scarso e camminare è un<br />
piacere. La spiaggia è oltre una macchia di lecci. È ghiaia minuscola e levigatissima. Mi siedo a fumare la<br />
prima sigaretta. Ho voluto aspettare per godermela ora, così, in riva al mare. Mi ci è voluto molto a capirlo,<br />
ma ci sono arrivato: sto bene da solo. Per fare ciò che devo non devo avere nessuno tra i piedi. Ecco, decidere<br />
è facile. Mi alzo. Seguendo il ritmo delle onde, mi avvicino all’acqua schiumosa e la tocco prima che la ghiaia<br />
e la forte pendenza la inghiottano. Un uomo con i capelli bianchi sbuca dalla macchia di lecci e si precipita<br />
verso il mare, si piega a toccare l'acqua e scappa via. Sembra un altro me che fugge. Mentre io non desidero<br />
che stare fermo, guardare il tempo che corre, pensare ai fatti miei. La psicologa mi ha detto, «Pensa per te».<br />
È il momento di prenderla sul serio e farlo davvero, pensare per me.<br />
In albergo agli amici dico, «Me ne torno in Sicilia.»<br />
«Sei grullo, te ne vai ora?»<br />
«Ora, me ne vado.»<br />
«Che hai da fare?»<br />
«Vado a finire il libro.»<br />
«Allora sei grullo davvero.»<br />
Questo è il nostro saluto. Metto in valigia le mie poche cose, vado alla stazione e prendo il primo treno
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
184<br />
diretto a sud. I passeggeri continuano a scambiarsi gli auguri di capodanno. Siamo davvero pochi su questo<br />
treno il mattino di festa, così posso coltivare il silenzio.<br />
È da non credere come si dimentichino certe facce e certi nomi. Delle ragazze che vengono a trovarmi allo<br />
studio molte mi sembrano sconosciute e devo farmi ripetere il nome per tentare d'associarlo a qualche<br />
ricordo, spesso impreciso, fra l'altro, o del tutto errato. Ultimamente c’è Letizia, ragazza severa, un po'<br />
depressa, una che sta male per il lavoro che non ama. Vorrei a volte non si facesse più vedere, ma io non<br />
sono uno che riesce a cacciare le donne. Sono fatto così, nei confronti delle donne non riesco ad essere<br />
aggressivo, anzi indulgo a una certa passività. Mi lascio innamorare, ecco tutto. Tendo una rete in cui sono il<br />
primo a cadere. E questo mi piace, perché ogni volta è come entrare in un gineceo, nel mondo delle donne<br />
consacrato alla vita, e al piacere. Nell’amare infatti, come tutti sanno, anche soffrire è parte del piacere.<br />
Posso pensare che sia un modo di essere del desiderio, che poi è desiderio di essere, questo mio lasciarmi<br />
innamorare. Aspetto per non essere travolto dal desiderio, o perché l’oggetto d’amore non ne resti bruciato.<br />
Comunque sia, questa è la mia radice nella vita.<br />
Spettacolare congiunzione di astri in un azzurro limpido per il gelo. Venere è affiancata da Giove, l'una<br />
d'un bianco latte, l'altro vira verso il rosso. A prima vista sembra un aeroplano in fase d'atterraggio. Da Villa<br />
Giulia sto scendendo verso il Ponte a mare. Mi fermo a traguardare con i comignoli di una casa e le cime dei<br />
pini del Foro italico. Sembra inchiodato al cielo, Giove. Io alla terra. Al bar, dove compro le sigarette,<br />
domando se qualcuno s'intende di stelle. Gli avventori e il barista s'affacciano sull'uscio e guardano stupiti.<br />
Non sanno. Non hanno visto mai nulla di simile. L'indomani i telegiornali diranno che in migliaia hanno<br />
telefonato a giornali, polizia e osservatorio astronomico. Tanti hanno temuto l'arrivo dei marziani.<br />
Attacca bottone con me e non la finisce più. Ci tiene a dirmi che fa l’artista, che viene da Pisa, che da<br />
giovane ha fatto la corte a Gianfranco perché era un uomo davvero seducente. «Bell'uomo» confermo.<br />
«Inaccessibile» fa lei. La sto ad ascoltare perché le voglio chiedere un’informazione. Dopo che ho presentato<br />
il libro che Gianfranco ha scritto negli ultimi mesi di vita, una donna ha letto alcune poesie. Porta occhiali<br />
grandi e scuri, sta piegata su se stessa come una vecchia. Ma la sua voce è espressione del corpo profondo,
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
185<br />
fatta di vibrazioni mai udite, una bellezza assoluta che mi s’incide nella mente. A questa seccatrice che mi sta<br />
appiccicata e non mi molla domando se la conosce. «È Sara,» dice «mia figlia». Non occorre che domandi<br />
altro o l’incoraggi a parlarmene, perché la sua chiacchiera è inarrestabile. Ma ora sono ben disposto ad<br />
ascoltarla. Mi dice che Sara non voleva leggere, che è un brutto periodo per lei, che sta male. «Si sente<br />
troppo coinvolta, ha perso il marito». Tutto ciò lo dice senza compassione, con un distacco totale come si<br />
trattasse di un capriccio della figlia. Questo sguardo freddo su ciò che appartiene al passato di Sara mi<br />
contagia, neanch’io ho interesse per altro che non sia dentro il presente cono di luce da cui proviene la voce<br />
che m’incanta. Sara si è alzata dal tavolo e io non la perdo d’occhio. Non è più ripiegata su se stessa. Ha una<br />
figura bella, chiusa nel suo nero. Va verso la porta ed è tutto un entrare e uscire dalla sala, come aspettasse<br />
qualcuno.<br />
Col pretesto di salutare un amico, riesco a liberarmi della madre, e raggiungo Sara che si è fermata a<br />
fumare sulla soglia.<br />
«Tua madre m'ha detto che non volevi leggere. »<br />
«M'hanno avvertita solo due giorni fa, non c'era tempo di provare.»<br />
«La tua lettura è stata emozionante.»<br />
«Grazie.»<br />
«Brava come sei, non c’era motivo che avessi timore a leggere per un pubblico come questo.»<br />
«Devo dire che ho una certa soggezione verso questi intellettuali.»<br />
«Intellettuali? Mi sembra un’esagerazione.»<br />
È inquieta, Sara. Interrompe la conversazione scusandosi e s'allontana in cerca di qualcosa. La seguo con<br />
gli occhi finché non svolta l'angolo. La sento, sta parlando con qualcuno. Ora lo so, sono sedotto dalla sua<br />
voce.<br />
Torna mentre dal ristorante portano i vassoi per il buffet. Per la gioia di me impaziente che la sto<br />
aspettando, Sara si ferma. Finalmente si toglie gli occhiali. È bella. Occhi castani, scuri, brillanti. Pelle<br />
luminosa sotto i capelli neri. Muovendosi attorno alla tavola imbandita ora è lei a guardarmi e a sorridere.<br />
Disegno perfetto delle labbra nel viso armonioso. E ad attaccare discorso per dirmi che ama la Sicilia e i<br />
siciliani, che nell'isola si è davvero riconosciuta, che, nonostante ne stia spesso lontana, qui resta la radice dei<br />
suoi sentimenti. La voce mi incanta. Sara mi versa da bere, mi viene vicino, parlando mi prende le mani.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
186<br />
«Devo andare,» dice all’improvviso «ma dobbiamo sentirci.»<br />
«Promesso.»<br />
Mi scrive sull'agenda indirizzo e telefono. È una via di Palermo, verso piazza Marina. E subito mi manca.<br />
Come se il suono di quella voce avesse trovato i suoi propri recettori nelle cellule del mio corpo. Sono già in<br />
crisi di astinenza. È andata via senza la madre. Così posso illudermi di tenermi in contatto con Sara, sentendo<br />
parlare di lei da quella chiacchierona. Di Pisa è la madre, mentre il padre è un avvocato palermitano, perciò<br />
hanno casa in città, anche se le due donne, fin dall’adolescenza di Sara hanno vissuto in Toscana, dato che i<br />
genitori erano e sono separati di fatto. Di quelle separazioni però che non lacerano mai del tutto i legami,<br />
anzi nel tempo li rafforzano, tanto che negli ultimi anni, da vecchi - si può dire -, prima che la tragedia<br />
colpisse la figlia, hanno vissuto insieme nelle due case, un po’ qui un po’ là. La quale tragedia - apprendo -<br />
non è roba di ieri, come mi sembrava di aver capito, ma di qualche anno fa. Solo che Sara non si è del tutto<br />
ripresa o - insinua con un filo di malignità - si è affezionata al nero perché le dona.<br />
La chiamo al numero che mi ha scritto sull’agenda. Risponde un’anonima segreteria telefonica. Provo e<br />
riprovo, giorni e giorni. Non c’è la voce di Sara. Irraggiungibile, come la felicità. Devo lasciar perdere, mi dico.<br />
Ho il lavoro da portare avanti.<br />
Sfogliando l'agenda ho trovato il foglietto delle poesie che Letizia mi ha portato quando è passata per gli<br />
auguri. È scritto con calligrafia microscopica, come fosse un messaggio segreto da far circolare tra carcerati o<br />
affiliati a una setta segreta. Vuole sapere che ne penso, in realtà desidera che quelle parole arrivino a me. In<br />
quelle parole domina l'angoscia più cupa che schiaccia il respiro. Si ripete l'immagine ossessiva della<br />
morticina, lei, e i ragni neri pelosi che le camminano sulla pancia, l'urlo mentre cerca di divincolarsi dalle reti,<br />
l'urlo che squarcia lo spazio e acuisce i sensi sino a un piacere doloroso. Da quest'orgasmo cifrato discendono<br />
immagini di luce, il sole innanzitutto, anche se dura solo un attimo.<br />
Allora, la chiamo. Pensate che sono uno che si contraddice? Avete ragione. Con una donna devo parlare.<br />
Questa è una voce ragazza.<br />
«Dài, vieni a trovarmi» l’imploro quasi.<br />
Quando le parlo del piacere doloroso e delle immagini solari che danno una prospettiva di speranza,
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
187<br />
Letizia trova un tono di voce calmo e caldo per domandare, «Allora, c'è una via d'uscita?»<br />
«Certo, è quella che vedi. Sei ancora una ragazza che gioca con ossessioni di cartapesta, ma autentica mi<br />
sembra la ricerca di una via di libertà.»<br />
«Ti pare che questo sia un mondo in cui si possa essere felici?»<br />
Una domanda che immerge in una di quelle discussioni che si fanno da ragazzi, sulle ‘cose fondamentali’.<br />
Su una cosa siamo d’accordo. Lei è convinta, nonostante il pessimismo esibito, che non è importante saper<br />
dare risposte alle domande sulla felicità, quanto sapere vivere il presente. Il fatto che la felicità non sia<br />
possibile - aggiungo io - non uccide la speranza della felicità, la gioia di cogliere l'attimo di sole, la bellezza,<br />
l'amore.<br />
Letizia ci prende gusto, a me fa piacere ripercorrere il terreno delle illusioni.<br />
«E la poesia?»<br />
«È speranza di felicità la poesia. È verità. Se no è nulla.»<br />
«Si dice che da ragazzi tutti scrivano poesie.»<br />
«Chissà s’è poi vero! Io, per esempio, non ne ho mai scritte. Vero è che da adulti le scrivono i poeti e gli<br />
imbecilli. La poesia dei poeti , secondo me, ha una sua propria necessità, nel senso che dice di noi, della vita,<br />
qualcosa di non detto prima, che alla vita dà un qualche senso anche quando sembra negarlo, perché le<br />
parole della poesia ordinano l'esperienza del mondo.»<br />
«Perciò scrivo.»<br />
«Ma non avere fretta. Per arrivare al senso le parole, come la vita, devono sedimentarsi nella mente,<br />
dentro il corpo desiderio e pensiero, e trovare la loro musica insieme alla loro necessità. Se vuoi giungere a<br />
tanta bellezza, cerca di darti tempo e coltiva una mente aperta. Intanto, separati dall'odore di morticina e<br />
abbraccia il sole.»<br />
A Letizia posso, anzi devo dirlo. Tengo per me la consapevolezza che la vita eccede le potenzialità della<br />
parola. Sarà per questo che scrivo questo diario, e non poesie. Nessun discorso è definitivo, nessuno<br />
definisce per davvero la vita.<br />
Chiamo Sara, e sempre risponde la segreteria. Ho bisogno di sentire quella voce. Come se potesse<br />
rimediare a qualcosa di essenziale che manca alla mia vita. È amore? Ora, non voglio nessuno fra i piedi. Ma
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
188<br />
lei, mi dico, è una voce. Ho bisogno di ascoltarla. E in questo bisogno vedo il compimento di un destino. Devo<br />
rivederti, Sara.<br />
È salita quasi di corsa, perciò in cima alle scale ha un lieve affanno, e arrossisce un po' per l'imbarazzo e<br />
l'eccitazione. I piccoli capezzoli puntuti sotto la camicetta nera. Letizia gode dell'attenzione. Io dell'essere<br />
attento. La sua pelle è bruna, come quella delle beduine, le labbra scure piccole e brillanti, un bocciolo di<br />
rosa appena aperto; le gambe lunghe ma armoniche. La perfezione è il piede. Ha preso coraggio e ha tentato<br />
di forzare il divieto di venirmi a cercare. Le ho detto nel modo più chiaro e gentile che non la voglio in casa.<br />
Ma ora c’è.<br />
«Aspettami al bar, che fra qualche minuto scendo.»<br />
Al bar, mentre ci osserviamo, torniamo a speculare sul male del mondo, che in lei suscita stupore e un<br />
senso d'oscurità, alimentando una tensione in certi momenti esplosiva. La guardo e mi sorprende il ricordo<br />
della sua pelle. Come se la mente desiderasse sovrapporre al piacere presente il ricordo, per moltiplicarlo. O<br />
anestetizzarlo? È comunque un’onda di dolcezza. Letizia, nonostante il corpo di adolescente, offre grandi<br />
seni, e sodi. Minuta com’è, non te lo aspetti. Non ti aspetti questo piacere. Vista e tatto, mente e giudizio<br />
sono agitati nello stesso frullatore.<br />
«Vieni da me stasera?»<br />
È venuta per invitarmi. Mi preparerà il tabulè, le acciughe marinate. Tutto freddo, perché lei odia cucinare.<br />
Poi mi accompagnerà nella camera, dove ha preparato il materassino per i massaggi. Lei gode a toccarmi, io a<br />
essere toccato.<br />
Mi ha scritto un'altra lettera al nero Letizia, su carta pergamena bruciacchiata per fare tanto maledetta.<br />
Nulla c’è di nuovo, così non le rispondo. Ma poi si annuncia per telefono e mi lascio convincere a fissare un<br />
appuntamento.<br />
Lo scirocco ha trasformato Palermo in una città tropicale. Piove da tre giorni senza sosta, acquazzoni<br />
esplodono all’improvviso con la violenza degli uragani. La nuova pioggia sul terreno saturo d’acqua, sugli<br />
asfalti impermeabili, sulle fogne intasate, scivola via in onde sempre più alte che trasformano ogni strada in<br />
torrente e le più strette in fiumi. Ed è tutto un correre di garzoni dei negozi e fondachi e di padroni ad alzare
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
189<br />
dighe di assi tavole e sacchetti per tentare di dare riparo ai loro beni. Spesso inutilmente. L’acqua melmosa è<br />
negli scantinati, nei locali, nelle stanze.<br />
La tettoia della fermata degli autobus in piazza Politeama è però un riparo ancora sufficiente. Aspetto<br />
Letizia. Arriva in ritardo, così posso osservarla mentre attraversa tutta nera la piazza, percorre con passo<br />
lento i marciapiedi ed evita con scarti le pozze più profonde, anche se i suoi stivali alti sopra il ginocchio<br />
sembrerebbero adatti alla piena di un fiume. «Per intonarmi a te,» le dico «mi sono messo il vecchio<br />
montgomery».<br />
Letizia mi guida verso il bar all'angolo della piazza dove tutti la conoscono e la salutano. A tutti mi<br />
presenta. Le fa piacere stare con me. Me lo dice mentre ci sediamo a un tavolo e ordina due cappuccini.<br />
Sotto il cappotto ha una maglia anch'essa nera con grande scollatura a V e un top trasparente, nero, e<br />
fuseaux neri. Labbra e unghie viola. E per ornamento tanta chincaglieria metallica da aprirci un commercio di<br />
bijou. Certo non vuole passare inosservata. Desidera raccontare e racconta di nuovo la sua storia. Comincia<br />
con voce piana e calda, esibendo fogli dipinti, decorati, bruciati, fogli di lettere bucati dalle sigarette. Gioca<br />
con una fantasia di autodistruzione. «Ancora questa storia? Ma lascia perdere. Andiamo,» le dico «andiamo a<br />
vivere».<br />
Quando siamo fuori mi lascio portare. Letizia guida in scioltezza un’Alfa d’annata. «È di mia madre,» ci<br />
tiene a dire «io non posseggo nulla». Conosce tanti locali ma poi mi conduce al centro sociale di Ballarò dove<br />
ci dovrebbe essere l'incontro con un romanziere. Non c'è nulla, a parte il solito bar, la solita birra, il solito<br />
fumo. Solo tanto fango in più, a inzaccherarmi le scarpe e i pantaloni. Con il suo armamentario Letizia si lascia<br />
guardare. C'è un ceffo che la riconosce. Letizia lo allontana, «Vedi che sono in compagnia».<br />
«Un altro sballato che mi sbava dietro» commenta.<br />
«Quasi ne sono geloso» dico. «Ce ne possiamo andare».<br />
Ora Letizia si sente padrona della situazione e mi porta a spasso. Sceglie un locale che sembra la stiva<br />
d'una nave, abbandonata dall’equipaggio, perché ai tavoli non c’è nessuno. I baristi scrutano questa coppia<br />
curiosa, la ragazza dark e l'uomo col montgomery nero. Nella penombra di quel ventre di legno Letizia ordina<br />
il vino e prende le mie mani. L'attacco è sempre tragico, del genere amico scoppiato d'eroina, ma è di sé che<br />
vuole parlare. La storia con il tossico è il fantasma della libertà che lei rincorre impulsivamente per sfuggire<br />
all'ordine ossessivo della sua casa borghese.
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
190<br />
«Sai come finiscono queste ribellioni giovanili? Si torna alla casa borghese. Intanto però puoi sperimentare<br />
chi sei, oltre il tuo animo scisso, oltre la mente fine. Qualcosa di buono può venirne fuori».<br />
Letizia si avvicina e mi bacia. L’aspettavo. Il ragno che tesse la tela, sono io o è lei?<br />
La mattina lo scirocco è cessato e ci sorprende una luce nitida che esalta le miserie e le bellezze delle case<br />
e della natura, quella selvaggia delle montagne verdastre alle nostre spalle, quella ordinata e strapazzata dei<br />
giardini urbani. Mentre facciamo colazione nella terrazza dei gelsomini da dove si vede il porto e il mare<br />
schiumoso in lontananza, Letizia tira fuori il suo lato solare. Mi racconta la sua adolescenza a Linguaglossa, le<br />
escursioni sull’Etna. Senza trucco, è una ragazza dallo sguardo tenero e curioso; gli occhi scuri, il portamento<br />
severo le danno un che di altezzoso, come ho visto nelle donne beduine.<br />
«Non credere davvero che io sia una morticina» dice. «Sono una ragazza che sa camminare sulle<br />
montagne e anche affacciarsi sulla bocca del vulcano.».<br />
«Ci credo, ci credo.»<br />
«So anche fare la pasta e i dolci.»<br />
«Vedo, e mangi con gusto.»<br />
«Io cerco il piacere.»<br />
«Non sai quanto sia felice di vedere dissolversi la maschera della donna dannata.»<br />
Letizia allora si alza, viene dietro le mie spalle e mi sussurra, «Io saprei fare felice un uomo.»<br />
«Non ne dubito. Sposerai un proprietario e farai tanti figli.»<br />
Si dovrebbe essere contenti di una giornata fatta d'incontri casuali, una giornata in cui i destini<br />
s'incrociano nelle strade del mondo senza alcuna ragione. Donde la felicità. Benché non tutti gli incontri siano<br />
felici.<br />
Mi lascio portare, mi lascio guidare dalle presenze femminili. A volte ho l’impressione di essermi perso e di<br />
non avere altra speranza di salvezza che le donne, come se loro ne avessero la chiave. Mi abbandono ai loro<br />
discorsi, ai loro sguardi, alle carezze come all’unica cosa che conti davvero. Nel disincanto, è l’unica vera<br />
felicità che mi è rimasta, o forse la speranza della felicità. Franco dice che sono un maniaco sessuale represso,
SOLO INEDITI<br />
Da<br />
Tutto<br />
il tempo<br />
di Giovanni<br />
Commare<br />
Giovanni<br />
Commare<br />
191<br />
perché a noi ci hanno rovinato la mamma e la rivoluzione.<br />
«Quale rivoluzione? Quella che non abbiamo fatto ?»<br />
«Se non è rivoluzione, è consolazione» ribatte.<br />
«Già» dico. «Se voglio, riesco ancora a non dormire solo».<br />
Di questo passo, però, il libro su Kubrick non lo finirò mai.<br />
[…]<br />
* * *<br />
Siciliano (è nato nel 1948 a Campobello di Mazara - TP), vive e lavora a Firenze.<br />
Ha pubblicato: Presenti e invisibili. Storie e dibattiti degli emigranti di Campobello, Feltrinelli, Milano,<br />
1978, in collaborazione con Chiara Sommavilla; L’azione distratta, con postfazione di G. Ciabatti,<br />
Cesati, Firenze, 1990 (segnalata al Premio Montale 1991); La distrazione, opera aperta, Firenze, 1998-<br />
1999; il poemetto Aspettando l’imbarco, in La clessidra, Novi Ligure, novembre 2002; La distrazione<br />
(Immagini - per un processo d’identificazione), Poetry Wave, Napoli 2004; La lingua batte, con<br />
prefazione di M. Biondi e una nota di D. Sparti, Passigli Editori, Firenze, 2006.<br />
È autore del saggio Il sonetto italiano del Novecento presentato al convegno “Le sonnet au risque du<br />
sonnet” (Université de Franche-Comté, Besançon, 8-10 dicembre 2004) e successivamente pubblicato<br />
in “Nuova Antologia” (n. 2240, ottobre-dicembre 2006).<br />
Suoi racconti e articoli sono usciti sulle riviste “Linea d’ombra”, “Paragone”, “NumerO”, “Il ponte”,<br />
“Allegoria”, “La clessidra”, “Lo straniero” e “Il grandevetro” di cui è anche redattore.<br />
Il brano scelto da Danilo Mandolini e qui presentato è l’anteprima del primo dei sette capitoli di cui si<br />
compone il racconto inedito intitolato, appunto, Tutto il tempo.
Da La mia vita intera -<br />
Serie composta tra il 1998 e il 2000<br />
con fotografie realizzate a Senigallia<br />
e nella campagna marchigiana
Collage William Butler Yeats<br />
192<br />
Easter, 1916<br />
I have met them at the close of the day<br />
Coming with vivid faces<br />
From counter or desk among grey<br />
Eighteenth-century houses.<br />
I have passed with a nod of the head<br />
Or polite meaningless words,<br />
Or have lingered awhile and said<br />
Polite meaningless words,<br />
And thought before I had done<br />
Of a mocking tale or a gibe<br />
To please a companion<br />
Around the fire at the club<br />
Being certain that they and I<br />
But lived where motley is worn:<br />
All changed, changed utterly:<br />
A terrible beauty is born.<br />
That woman’s days were spent<br />
In ignorant good-will,<br />
Her nights in argument<br />
Until her voice grew shrill.<br />
What voice more sweet than hers<br />
When, young and beautiful,<br />
She rode to harriers?<br />
This man had kept a school<br />
And rode our winged horse;<br />
This other his helper and friend<br />
Was coming into his force;<br />
He might have won fame in the end,<br />
So sensitive his nature seemed,<br />
So daring and sweet his thought.<br />
This other man I had dreamed<br />
A drunken, vainglorious lout.<br />
He had done most bitter wrong<br />
To some who are near my heart,<br />
Yet I know him in the song;<br />
He, too, has resigned his part<br />
In the casual comedy;<br />
He, too, has been changed in his turn,<br />
Transformed utterly:<br />
A terrible beauty is born.<br />
Hearts with one purpose alone<br />
Through summer and winter seem<br />
Enchanted to a stone<br />
To trouble the living stream.<br />
The horse that comes from the road,<br />
The rider, the birds that range<br />
From cloud to tumbling cloud,<br />
Minute by minute they change;<br />
A shadow of cloud on the stream<br />
Changes minute by minute,<br />
A horse-hoof slides on the brim,<br />
And a horse plashes within it;<br />
The long-legged moor-hens dive,<br />
And hens to moor-cocks call;<br />
Minute by minute they live:<br />
The stone’s in the midst of all.<br />
Too long a sacrifice<br />
Can make a stone of the heart.<br />
O when may it suffice?<br />
That is Heaven’s part, our part<br />
To murmur name upon name,<br />
As a mother names her child<br />
When sleep at last has come<br />
On limbs that had run wild.<br />
What is it but nightfall?<br />
No, no, not night but death;<br />
Was it needless death after all?<br />
For England may keep faith<br />
For all that is done and said.<br />
We know their dream; enough<br />
To know they dreamed and are dead;<br />
And what if excess of love<br />
Bewildered them till they died?<br />
I write it in a verse –<br />
Macdonagh and MacBride<br />
And Connolly and Pearse<br />
Now and in time to be,<br />
Wherever green is worn,<br />
Are changed, changed utterly:<br />
A terrible beauty is born.
ARCIPELAGO itaca prima apparizione. Giovanni Commare su Gianfranco Ciabatti, Adriàn Bravi, Maria Lenti, Nicola Romano e<br />
Norma Stramucci. Collage Dino Campana. Riproduzioni di opere di Giorgio Bertelli e Lorenza Alba.<br />
ARCIPELAGO itaca seconda apparizione. Danilo Mandolini su Attilio Zanichelli, Lucetta Frisa, Ivano Mugnaini, Adelelmo Ruggieri e<br />
Luigi Socci. Collage Guido Gozzano. Riproduzioni di immagini di Michele Rogani e di un’opera di Pietro Spica.<br />
ARCIPELAGO itaca terza apparizione. Contributi da interventi di Maria Lenti e Gianfranco Lauretano su Tolmino Baldassari, Danilo<br />
Mandolini su Renata Morresi, Maria Grazia Calandrone, Mauro Ferrari, Daniele Garbuglia e Massimo Morasso. Inediti di Enzo<br />
Filosa. Collage Vladimir Majakovskij. Riproduzioni di opere di Silvana Russo e Lucia Marcucci.<br />
ARCIPELAGO itaca quarta apparizione. Un ricordo di Leonardo Mancino (con un testo inedito di Biagio Balistreri), Danilo Mandolini<br />
su Anna Elisa De Gregorio, Gianni Caccia, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, Liliana Ugolini. Inediti di Marina Pizzi. Collage Charles<br />
Baudelaire. Riproduzioni di opere di Enzo Esposito, Giovanna Ugolini, Cosimo Budetta, Alfredo Malferrari e Giordano Perelli.<br />
ARCIPELAGO itaca quinta apparizione. Un ricordo di Alfonso Gatto (con un saggio di Laura Pesola), Rossella Maiore Tamponi (con<br />
note di Francesco Scaramozzino e Giorgio Linguaglossa), Linnio Accorroni (con note di Danilo Mandolini e Adelelmo Ruggieri),<br />
Manuel Cohen (con una nota di Danilo Mandolini), Enrico De Lea, Evelina De Signoribus, Stelvio Di Spigno ed Eva Taylor. Collage<br />
Cesare Pavese. Riproduzioni di immagini di Sauro Marini e di un’opera di Adriano Spatola.<br />
ARCIPELAGO itaca sesta apparizione. Un brano dal discorso di Eugenio Montale pronunciato in occasione dell’assegnazione del<br />
Premio Nobel per la letteratura del 1975, un ricordo di Ferruccio Benzoni (con un articolo di Francesco Magnani, un’intervista<br />
all’autore a cura di Gabriele Zani e una poesia di Francesco Scarabicchi), Cristina Babino (con una nota di Danilo Mandolini),<br />
Francesco Accattoli, Guglielmo Peralta e Lucilio Santoni. Inediti di Narda Fattori. Collage Arthur Rimbaud. Riproduzioni di opere di<br />
Agostino Perrini e di Emilio Tadini. Commento all’opera di Agostino Perrini a cura di Marco Frusca.<br />
ARCIPELAGO itaca settima apparizione. Un ricordo di Giovanni Giudici (con brani da una nota commemorativa di Goffredo Fofi),<br />
Alessandro Moscè (con una nota di Danilo Mandolini), Marco Ercolani, Fabio Franzin, Mariangela Guàtteri e Annalisa Teodorani.<br />
Inedito di Giovanni Commare. Collage William Butler Yeats. Riproduzioni di immagini di Mario Giacomelli.<br />
Per effettuare il download delle ultime apparizioni di ARCIPELAGO itaca: www.arcipelagoitaca.it/download.<br />
Per ricevere, a ½ e-mail, tutte le apparizioni di ARCIPELAGO itaca, inoltrare relativa richiesta a info@arcipelagoitaca.it.
Quando ti metterai in viaggio per <strong>Itaca</strong><br />
devi augurarti che la strada sia lunga<br />
fertile in avventure e in esperienze.<br />
Costantino Kavafis, <strong>Itaca</strong>
La piccola immagine in basso a destra nella seconda di copertina e in alto a sinistra nella terza di copertina raffigura la<br />
sagoma dell’isola di <strong>Itaca</strong>.<br />
Le note di Gio Ferri (68), Dario Capello (76) ed Alessio Franzin, figlio di Fabio, (116) sono, fino ad oggi, rimaste inedite.<br />
Guàtteri<br />
Ercolani<br />
Teodorani<br />
Mandolini<br />
Fofi<br />
Giacomelli<br />
Giudici<br />
Commare<br />
Moscè<br />
Yeats<br />
Franzin<br />
ARCIPELAGO itaca: Danilo Mandolini - Via Mons. D. Brizi, 4 - 60027 Osimo (AN).<br />
www.arcipelagoitaca.it<br />
info@arcipelagoitaca.it