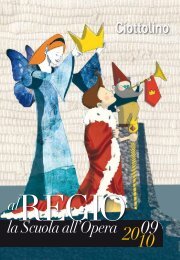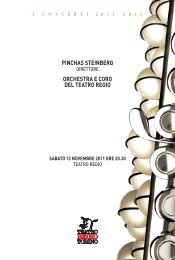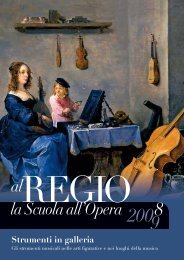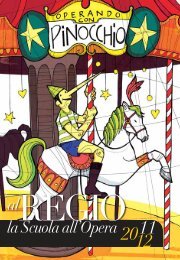View index, preface, introduction and specimen letter V
View index, preface, introduction and specimen letter V
View index, preface, introduction and specimen letter V
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Introduzione<br />
L’erudizione è un settore dell’attività umana che soddisfa le due passioni<br />
del collezionista e dell’esploratore: raccogliere quanti più dati<br />
possibile nei territori, sovente inesplorati, delle biblioteche, degli archivi,<br />
dei fondi pubblici e privati e catalogarli in bell’ordine, secondo i<br />
criteri scelti di volta in volta in rapporto alla natura dell’argomento e<br />
alla tipologia dello studio che si intende pubblicare.<br />
L’erudizione ha la sua poesia: amore, innanzi tutto, per la memoria<br />
storica della propria civiltà, per il mondo che si dischiude dietro il<br />
dato storico, filologico, biografico; fascino della ricerca e della scoperta,<br />
attrazione per il cimelio conquistato attraverso ricerche minute,<br />
pazienti, tenaci, e conservato con trepidante emozione. Attraverso i<br />
dati raccolti, il ricercatore che non sia tanto un raccoglitore di materiali<br />
inerti ma un autentico conservatore di esperienze lontane, nello<br />
spazio e nel tempo, vede e trasmette l’immagine di un intero mondo.<br />
Qu<strong>and</strong>o poi questo mondo è quello dello spettacolo musicale, la scena<br />
si affolla delle presenze più disparate e colorite: compositori, librettisti,<br />
cantanti, teatri diversi, ambienti e spettatori diversissimi compaiono<br />
in filigrana dietro i dati di fatto, e la fortuna dell’opera come<br />
fenomeno europeo appare in tutta la sua evidenza.<br />
A questa immagine dell’erudito come appassionato cultore di memorie<br />
storiche appartiene Gianni Legger. La sua notorietà nell’ambiente<br />
torinese risale a molto tempo fa, e così la fama della sua collezione di<br />
libretti, programmi di sala, documenti legati al mondo della musica<br />
italiana e, in particolare, al teatro. Ma negli ultimi vent’anni Legger<br />
non si è limitato alla passione del collezionista: ha lavorato a questa<br />
poderosa Drammaturgia Musicale Italiana che intende illustrare e<br />
documentare «l’italianità nell’opera dalle origini al terzo millennio».<br />
Il concetto di «italianità» come lo intende Legger è, in realtà, estesissimo,<br />
perché la sua Drammaturgia comprende, oltre alle opere dei<br />
compositori italiani e di quelli stranieri, le opere che «siano state<br />
composte su testo italiano o derivato da fonte (<strong>letter</strong>aria, librettistica,<br />
teatrale) italiana, o siano stati ispirati da argomenti, fatti, luoghi,<br />
personaggi (reali, <strong>letter</strong>ali, teatrali) italiani»; e, ancora, «le opere che<br />
siano state rappresentate o eseguite in Italia; che contengano parti<br />
musicali di compositori italiani anche anonimi anche in forma indiretta<br />
(in centoni o adattamenti) o anche in occasione di riprese»; e,<br />
infine, anche le opere che «siano connesse a iniziative, concorsi ecc.<br />
italiani»; «rappresentino parodie o satire di opere italiane»; «abbiano<br />
avuto il libretto edito in versione italiana». In tal modo saranno esclusi<br />
dal suo catalogo solo quei titoli, verosimilmente piuttosto pochi,<br />
che non possono vantare alcun legame con l’ambiente del teatro musicale<br />
italiano.<br />
Legger non viene dalla cultura scientifica degli ambienti accademici e<br />
si definisce un autodidatta. Sotto questo profilo è un outsider che,<br />
dopo decenni di accurate ricerche condotte per pura passione personale,<br />
mette a disposizione degli studiosi una quantità di dati raccolti<br />
da ogni genere di fonti. Lascio agli esperti di archivistica e biblioteconomia<br />
la discussione sui criteri adottati da Legger nella compilazione<br />
del suo catalogo che, come l’autore dichiara, non ha pretese di sistemazione<br />
definitiva. A ben vedere, però, questa Drammaturgia Musicale<br />
Italiana non è esclusivamente riservata agli addetti ai lavori.<br />
Anche il lettore comune, il frequentatore di teatro d’opera,<br />
l’ascoltatore appassionato possono scorrerla con profitto perché le<br />
schede non si limitano alla presentazione nuda e cruda dei dati ma<br />
“parlano” attraverso le citazioni più o meno estese, informano su aspetti<br />
diversi dell’opera in questione, suscit<strong>and</strong>o curiosità e interesse.<br />
Significativa per comprendere lo spirito che ha animato il lavoro di<br />
Legger è la sezione dedicata ai «libretti più belli». Grafico e tipografo<br />
di professione, Legger segnala in questa parte del volume i testi che<br />
attirano l’ammirazione del lettore per la loro qualità di stampa, la<br />
scelta dei caratteri, l’armonia delle proporzioni tra il testo stampato e<br />
il margine bianco, la presenza di incisioni. Viene fuori da questo<br />
semplice elenco tutto l’amore del collezionista per i propri oggetti, la<br />
passione dell’erudito per il mondo che vi sta dietro, l’occhio<br />
dell’intenditore che ha avuto tra le mani centinaia e centinaia di libretti<br />
antichi: quella «poesia dell’erudizione», insomma, di cui parlavamo<br />
all’inizio e che caratterizza questo poderoso lavoro con un tratto<br />
significativo.<br />
Paolo Gallarati