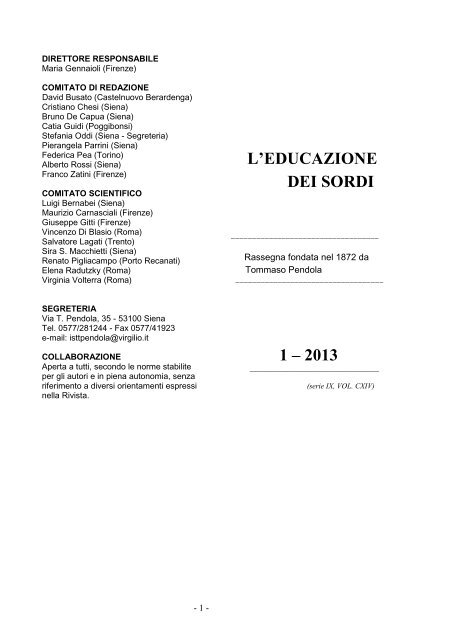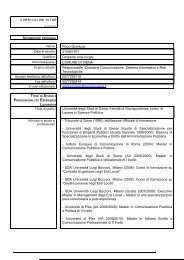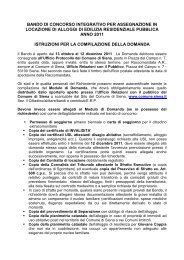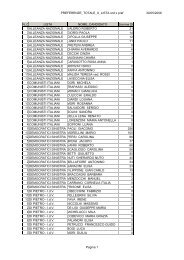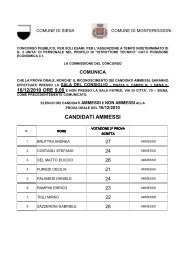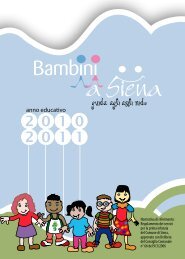Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena
Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena
Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DIRETTORE RESPONSABILE<br />
Maria Gennaioli (Firenze)<br />
COMITATO DI REDAZIONE<br />
David Busato (Castelnuovo Berardenga)<br />
Cristiano Chesi (<strong>Siena</strong>)<br />
Bruno De Capua (<strong>Siena</strong>)<br />
Catia Gui<strong>di</strong> (Poggibonsi)<br />
Stefania Od<strong>di</strong> (<strong>Siena</strong> - Segreteria)<br />
Pierangela Parrini (<strong>Siena</strong>)<br />
Federica Pea (Torino)<br />
Alberto Rossi (<strong>Siena</strong>)<br />
Franco Zatini (Firenze)<br />
COMITATO SCIENTIFICO<br />
Luigi Bernabei (<strong>Siena</strong>)<br />
Maurizio Carnasciali (Firenze)<br />
Giuseppe Gitti (Firenze)<br />
Vincenzo Di Blasio (Roma)<br />
Salvatore Lagati (Trento)<br />
Sira S. Macchietti (<strong>Siena</strong>)<br />
Renato Pigliacampo (Porto Recanati)<br />
Elena Radutzky (Roma)<br />
Virginia Volterra (Roma)<br />
SEGRETERIA<br />
Via T. Pendola, 35 - 53100 <strong>Siena</strong><br />
Tel. 0577/281244 - Fax 0577/41923<br />
e-mail: isttpendola@virgilio.it<br />
COLLABORAZIONE<br />
Aperta a tutti, secondo le norme stabilite<br />
per gli autori e in piena autonomia, senza<br />
riferimento a <strong>di</strong>versi orientamenti espressi<br />
nella <strong>Rivista</strong>.<br />
- 1 -<br />
L’EDUCAZIONE<br />
DEI SORDI<br />
___________________________________<br />
Rassegna fondata nel 1872 da<br />
Tommaso Pendola<br />
___________________________________<br />
1 – 2013<br />
__________________________________<br />
(serie IX, VOL. CXIV)
L’EDUCAZIONE DEI SORDI – TRIMESTRALE DELL’ISTITUTO SIENA<br />
- 2 -
SOMMARIO<br />
E<strong>di</strong>toriale ………………………………………………….….…….pag. 4<br />
Stu<strong>di</strong> e ricerche<br />
- La produzione <strong>di</strong> frase relative oggetto in parlanti non udenti:<br />
elicitazione e parlato <strong>di</strong> Grazia Trento…..........................................pag. 6<br />
- Un Sordo illustre: Ludwing Ven Beethoven<br />
Ricerca del Professore EnricoCimino………………………………...…pag. 50<br />
Per la Storia dell'<strong>Educazione</strong> dei <strong>Sor<strong>di</strong></strong><br />
- Lettere varie del P. Tommaso Pendola<br />
a cura <strong>di</strong> Stefania Od<strong>di</strong> e Alberto Rossi…………………………………..pag. 84<br />
Per la cronaca.……………………..…………………………........... pag. 87<br />
- 3 -
EDITORIALE<br />
In questo primo numero della rivista dell’anno 2013 mi<br />
preme fare una breve ma importante riflessione che è alla base<br />
dell’educazione all’ascolto per gli alunni in generale e per il<br />
sordo in particolare.<br />
Un suono ci incita sempre ad andare in cerca della sorgente <strong>di</strong><br />
ciò che sentiamo. Fin dalla nascita il bambino si esercita nello<br />
scoprire la causa dei suoni e dei rumori percepiti. In questo<br />
modo fin dalla prima infanzia si sviluppa la consapevolezza<br />
della relazione tra causa ed effetto. Nel piccolo bambino sordo<br />
invece, ricevendo molto meno stimoli o nessun stimolo<br />
acustico, questa capacità <strong>di</strong> collegare causa effetto è molto<br />
meno sollecitata.<br />
Spesso il bambino sordo può vedere solo l’effetto senza<br />
essere in grado <strong>di</strong> percepire anche la causa: per esempio il<br />
compagno <strong>di</strong> gioco all’improvviso, senza ragione visibile lascia<br />
il gioco e corre via (è stato chiamata da qualcuno), oppure i<br />
compagni <strong>di</strong> classe ad un tratto corrono alla finestra, perché<br />
hanno sentito la sirena dei pompieri o dell’ambulanza ecc..<br />
Nell’educazione del bambino sordo quin<strong>di</strong> è importante far<br />
notate fin dall’inizio la relazione fra causa ed effetto del suono<br />
e <strong>di</strong> far scoprire la funzionalità del suono. Il suono ha inoltre<br />
un’importante valore affettivo. Basti pensare al ruolo della<br />
musica ed ai suoni della natura! Il suono collega in noi le cose e<br />
le persone nel tempo e nello spazio. Il suono stimola i nostri<br />
movimenti, ci attiva, ha quin<strong>di</strong> una forte potenza <strong>di</strong>namica che<br />
influisce anche sulla nostra vita affettiva. Ciò che sentiamo<br />
penetra in noi, ciò che ve<strong>di</strong>amo invece resta sempre ad una<br />
certa <strong>di</strong>stanza. Questo fatto comporta fra l’altro che lo sviluppo<br />
del bambino sordo sarà meno <strong>di</strong>fferenziato, se non cerchiamo<br />
<strong>di</strong> arricchire fin dall’inizio la vita affettiva e la fantasia del<br />
bambino sordo con un’appropriata educazione all’ascolto e con<br />
l’educazione ritmico-musicale.<br />
All’educazione all’ascolto spetta un compito importantissimo,<br />
infatti per limitare ad un minimo gli effetti negativi che la<br />
sor<strong>di</strong>tà comporta per lo sviluppo del bambino questo deve<br />
imparare a sfruttare al massimo il suo residuo u<strong>di</strong>tivi, anche se<br />
minimo. Tutti i bambini sor<strong>di</strong> possono percepire i suoni! La<br />
- 4 -
maggior parte dei bambini sor<strong>di</strong> per fortuna possiede dei buoni<br />
residui u<strong>di</strong>tivi sfruttabili.<br />
Con protesi adeguate, nonché con l’impianto coclearie<br />
supportate da un’educazione ritmico-musicale molto intensiva e<br />
precoce si possono ottenere risultati fino a qualche anno fa<br />
impensabili.<br />
Spetterà poi alla professionalità del logope<strong>di</strong>sta e alle<br />
competenze <strong>di</strong>dattiche, professionali ed umane dell’ insegnante<br />
fare il resto, per il migliore sviluppo intellettuale del bambino.<br />
In questo numero della <strong>Rivista</strong>, in Stu<strong>di</strong> e Ricerche vi<br />
proponiamo, due importanti lavori. Nel primo la Dott.ssa<br />
Grazia Trento presenta il processo <strong>di</strong> acquisizione del<br />
linguaggio relativo sia ai bambini udenti che non udenti,<br />
successivamente si illustrano le proprietà sintattiche delle frasi<br />
relative presentandone i principali approcci, vengono inoltre<br />
testate alcune situazioni sperimentali ed infine si illustrano i<br />
risultati dell’esperimento.<br />
Il secondo lavoro è relativo ad una vecchia ricerca del Prof<br />
Enrico Cimino, già Direttore <strong>di</strong> questa rivista, nella quale ci<br />
mostra un Ludwing Ven Beethoven, universalmente<br />
riconosciuto come uno dei migliori musicisti europei,<br />
specialmente per le sue nove sinfonie, da una visuale <strong>di</strong>versa.<br />
Infatti il musicista, <strong>di</strong>venuto sordo all’età <strong>di</strong> 26 anni, viene<br />
spesso ricordato, specialmente nella comunità dei sor<strong>di</strong>, come<br />
uno <strong>di</strong> loro, arrivando persino a pensare che quando lui era<br />
udente scriveva una musica me<strong>di</strong>ocre, ma una volta <strong>di</strong>ventato<br />
sordo, ha scritto una musica bellissima.<br />
Continua poi la pubblicazione dello scambio epistolare fra il<br />
Pendola e personaggi vari. Nella Cronaca infine, portiamo a<br />
conoscenza i sor<strong>di</strong> del Concorso Internazionale <strong>di</strong> Poesia<br />
“Città <strong>di</strong> Poto Recanati”, inviatoci dall’amico Dott. Renato<br />
Pigliacampo.<br />
IL DIRETTORE<br />
- 5 -<br />
Maria Gennaioli<br />
La Redazione chiede a tutti, sor<strong>di</strong> e udenti, <strong>di</strong> collaborare alla <strong>Rivista</strong>, inviando ogni materiale<br />
ritenuto adatto alla pubblicazione.<br />
Anche per il 2013 vogliamo proporre la rubrica, La voce degli ex alunni, siate certi che<br />
risponderemo a tutti. (E-mail: isttpendola@virgilio.it)<br />
Tutti i lettori potranno inviare loro proposte e giu<strong>di</strong>zi particolari.<br />
Sede del Comitato <strong>di</strong> Redazione: Struttura Pendola Via T. Pendola, 35/37 - 53100 – <strong>Siena</strong>.<br />
Tel 0577-281244; Fax 0577- 41923; E-mail : isttpendola@virgilio.it
l’educazione dei sor<strong>di</strong>, 1 – 2013 (Serie IX - CXIV)<br />
LA PRODUZIONE DI FRASI<br />
RELATIVE OGGETTO IN<br />
PARLANTI NON UDENTI:<br />
ELICITAZIONE E PARLATO<br />
cura <strong>di</strong> Grazia Trento<br />
Introduzione<br />
“Imparare a parlare” è una capacità che il bambino, in<br />
con<strong>di</strong>zioni non deficitarie, acquisisce in brevissimo tempo e<br />
senza alcuno sforzo conscio. Tuttavia, non per tutti i bambini il<br />
processo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> una lingua orale è così semplice;<br />
basti pensare al bambino affetto da sor<strong>di</strong>tà.<br />
L’ipoacusia, ossia la mancanza più o meno grave dell’u<strong>di</strong>to,<br />
qualora si presenti nelle sue forme più gravi e non curata<br />
adeguatamente e tempestivamente, potrebbe non consentire al<br />
bambino <strong>di</strong> acquisire la lingua orale e <strong>di</strong> raggiungerne un<br />
livello linguistico accettabile, in quanto questo deficit non<br />
permette <strong>di</strong> percepire gli input provenienti dall’ambiente<br />
esterno necessari per l’acquisizione della lingua orale.<br />
Tipicamente, il bambino sordo, soprattutto se nato in una<br />
famiglia udente e non immerso sin dalla nascita in un ambiente<br />
che gli consenta <strong>di</strong> acquisire la lingua dei segni, imparerà il<br />
metodo oralista. Per acquisire questo metodo il bambino, nella<br />
maggior parte dei casi, dovrà seguire un percorso logope<strong>di</strong>co e<br />
dovrà usufruire del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> protesi esterne o impianto<br />
cocleare.<br />
Ciò nonostante, ogni bambino sordo ha una storia <strong>di</strong>fferente,<br />
pertanto il modo tramite il quale ha avuto accesso alla lingua<br />
orale potrebbe essere <strong>di</strong>verso rispetto ad un altro bambino<br />
sordo, ragion per cui il livello linguistico dei non udenti è<br />
estremamente <strong>di</strong>fferente.<br />
- 6 -<br />
Stu<strong>di</strong> e ricerche
Da qui, l’interesse <strong>di</strong> analizzare la produzione linguistica<br />
riguardante la frase relativa oggetto in parlanti affetti da sor<strong>di</strong>tà.<br />
Tale interesse nasce dall’evidenza per la quale la computazione<br />
<strong>di</strong> questa struttura sintattica risulta essere particolarmente<br />
complessa sia per i parlanti udenti che non udenti, così come<br />
già <strong>di</strong>mostrato da alcuni lavori condotti in precedenza. Infatti,<br />
la produzione <strong>di</strong> questa struttura sintattica è evitata a favore <strong>di</strong><br />
altre strutture sintattiche la cui computazione è più semplice.<br />
Per giustificare tale complessità, assumeremo, anche noi,<br />
l’approccio in termini <strong>di</strong> tratti morfosintattici (featural<br />
approach) proposto da Friedmann, Belletti & Rizzi (2009) che<br />
deriva <strong>di</strong>rettamente dal Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata<br />
(Rizzi,1990, 2004).<br />
I risultati da noi ottenuti sono il frutto sia <strong>di</strong> una<br />
somministrazione sperimentale che presenta due task che <strong>di</strong><br />
un’analisi riguardante un piccolo corpus <strong>di</strong> parlato spontaneo<br />
da noi creato1.<br />
1. BREVI CENNI SUL PROCESSO DI ACQUISIZIONE<br />
DEL LINGUAGGIO E SORDITÀ.<br />
1.1 Come impariamo a parlare?<br />
Questa è una domanda che quasi nessuno si pone nel corso<br />
della propria vita, poiché l’acquisizione <strong>di</strong> una lingua 2 , per gli<br />
essere umani, è un processo così naturale e per niente costoso,<br />
che è da noi considerato “dato per scontato”. Infatti, l’essere<br />
umano privo <strong>di</strong> deficit genetici specifici acquisisce la lingua<br />
senza alcuno sforzo conscio e in brevissimo tempo 3 .<br />
Ma come avviene il processo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> una lingua?<br />
Secondo Chomsky, tutti gli essere umani sono in grado <strong>di</strong><br />
acquisire una lingua, ed anche molto rapidamente, poiché<br />
<strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un <strong>di</strong>spositivo che consente loro <strong>di</strong> acquisire il<br />
linguaggio: LAD (Language Acquisition Device). Esso<br />
contiene i principi della grammatica universale (GU) 4 che<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Pertanto tutti i soggetti sperimentali sono a conoscenza della lingua orale (quattro sono<br />
anche a conoscenza della lingua dei segni italiana).<br />
2 In questo caso orale.<br />
3 Il bambino è anche in grado <strong>di</strong> acquisire più <strong>di</strong> una lingua contemporaneamente; i casi<br />
<strong>di</strong> bilinguismo.<br />
4 Capacità linguistica innata che contiene gli universali assoluti che non variano da lingua<br />
a lingua, ed inoltre, fornisce i parametri linguistici che possono invece, variare tra le<br />
lingue.<br />
- 7 -
guida il processo <strong>di</strong> acquisizione del linguaggio, senza tener<br />
conto della particolare lingua a cui il bambino è esposto; per<br />
cui, essa non è con<strong>di</strong>zionata dalle variazioni provenienti<br />
dall’ambiente (input) in cui il bambino vive. Un esempio <strong>di</strong><br />
input, che nel nostro caso, come si suole <strong>di</strong>re, “calza a<br />
pennello” è l’input riguardante il tipo <strong>di</strong> lingua a cui il bambino<br />
è esposto: lingua orale o lingua dei segni. Infatti, il bambino<br />
sordo proveniente da genitori sor<strong>di</strong> segnanti è esposto sin dalla<br />
nascita alla lingua dei segni, per cui <strong>di</strong>venterà segnante <strong>di</strong><br />
questa lingua, mentre il bambino udente è esposto sin dalla<br />
nascita alla lingua orale, per cui <strong>di</strong>venterà parlante della propria<br />
lingua madre.<br />
Pertanto, il bambino tramite le proprie capacità cognitive, il<br />
<strong>di</strong>spositivo che ha in dotazione dalla nascita (LAD) e la<br />
ricezione degli input arriverà, in breve tempo, all’acquisizione<br />
della propria L1 1 .<br />
1.2 La sor<strong>di</strong>tà.<br />
La sor<strong>di</strong>tà, o ipoacusia, è la riduzione più o meno grave<br />
dell’u<strong>di</strong>to. Tuttavia, è proprio il corretto funzionamento<br />
dell’apparato u<strong>di</strong>tivo che consente al bambino <strong>di</strong> percepire i<br />
suoni provenienti dall’ambiente.<br />
È opportuno precisare che non è possibile ottenere una<br />
sensazione sonora per qualunque frequenza, bensì esistono dei<br />
limiti <strong>di</strong> u<strong>di</strong>bilità, che variano tra esseri viventi. Infatti, solo le<br />
vibrazioni aventi una frequenza compresa fra 20 Hz e 20.000<br />
Hz vengono percepite come sensazione sonora dall’uomo.<br />
Tuttavia, le vibrazioni inferiori a 20 Hz e superiori a 20.000 Hz<br />
non danno luogo ad alcuna sensazione sonora e vengono<br />
rispettivamente chiamate infrasuoni e ultrasuoni. Si sottolinea,<br />
infine, che nel parlare comune si hanno frequenze comprese fra<br />
50 Hz e 4.000 Hz. Inoltre, l’energia totale emessa da una<br />
sorgente sonora nell’unità <strong>di</strong> tempo costituisce la potenza<br />
sonora emessa dalla sorgente stessa, che convenzionalmente,<br />
viene espressa in decibel [dB].<br />
Pertanto, è proprio tramite il suono che il bambino percepisce<br />
gli input necessari che permetteranno lui <strong>di</strong> acquisire<br />
correttamente la lingua a cui è esposto, fissandone i parametri e<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Lingua madre, che in questo caso può riferirsi sia alla lingua orale che alla lingua dei<br />
segni.<br />
- 8 -
acquisendone la fonetica. Quin<strong>di</strong>, una compromissione al<br />
sistema u<strong>di</strong>tivo, può avere, <strong>di</strong> conseguenza, ripercussioni per<br />
quanto riguarda il linguaggio e il suo appren<strong>di</strong>mento. Infatti,<br />
l’ipoacusia bilaterale profonda, se insorta in epoca prenatale o<br />
precoce, e non adeguatamente curata, comporta la mancata<br />
acquisizione del linguaggio, determinando anche gravi<br />
conseguenze sul piano cognitivo, affettivo–relazionale e sociale<br />
(Nicastro, 2001).Quin<strong>di</strong>, una <strong>di</strong>agnosi precoce della sor<strong>di</strong>tà è<br />
fondamentale perché consente un intervento tempestivo. Infatti,<br />
per quanto riguarda le sor<strong>di</strong>tà gravi e profonde, il bambino<br />
imparerà a parlare solo se sottoposto ad una terapia logope<strong>di</strong>ca;<br />
per cui quanto più l’educazione è stata precoce, tanto maggiori<br />
saranno le possibilità <strong>di</strong> avere risultati accettabili; è, comunque,<br />
opportuno sottolineare che spesso questi soggetti non arrivano<br />
ad una competenza linguistica completa (Maragna, 2004).<br />
Tuttavia, oggi si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> protesi <strong>di</strong> ultima generazione sia<br />
tra<strong>di</strong>zionali che <strong>di</strong>gitali, che permettono al bambino affetto da<br />
ipoacusia bilaterale profonda <strong>di</strong> ottenere una resa protesica <strong>di</strong><br />
40–50 dB, che permettono, quanto meno, <strong>di</strong> percepire tutte le<br />
frequenze utili per la deco<strong>di</strong>fica del linguaggio. Inoltre, in casi<br />
<strong>di</strong> estrema gravità, la tecnologia mette a <strong>di</strong>sposizione un<br />
sussi<strong>di</strong>o protesico altamente sofisticato, quale l’impianto<br />
cocleare, che <strong>di</strong>venta un sussi<strong>di</strong>o sempre più <strong>di</strong>ffuso nel<br />
trattamento dell’ipoacusia bilaterale profonda.<br />
Ciò nonostante, sembra opportuno illustrare quali siano le<br />
<strong>di</strong>fficoltà che incontrano i bambini sor<strong>di</strong> nel processo <strong>di</strong><br />
acquisizione del linguaggio (Chesi, 2006):<br />
l’impossibilità <strong>di</strong> accedere agli input linguistici<br />
quantitativamente e qualitativamente;<br />
l’impossibilità del trattamento naturale dell’informazione<br />
fonologica segmentale (proprietà fonetiche, fonotattiche<br />
ecc.) e soprattutto soprasegmentale (intonazione, ritmo,<br />
accentuazione).<br />
Inoltre, è utile mostrare, almeno a gran<strong>di</strong> linee, quelle che<br />
sono le funzioni dell’apparato u<strong>di</strong>tivo, che è strettamente<br />
connesso con il processo dell’acquisizione del linguaggio.<br />
L’apparato u<strong>di</strong>tivo, o orecchio, è costituito da determinati<br />
organi, che sono contenuti nello spessore dell’osso temporale.<br />
- 9 -
La funzione che questi organi svolgono è quella <strong>di</strong> assicurare<br />
la percezione <strong>di</strong> due stimoli <strong>di</strong>fferenti: sonori e gravitari.<br />
Pertanto nell’orecchio sono presenti due tipi <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong><br />
recettori (Giuseppe C. Balboni et al. 2000):<br />
1. acustici: che si occupano della sensibilità u<strong>di</strong>tiva;<br />
2. statocinetici: che si occupano della sensibilità<br />
gravitazionale e dell’accelerazione.<br />
Inoltre, l’apparato u<strong>di</strong>tivo viene <strong>di</strong>viso in tre parti <strong>di</strong>fferenti:<br />
orecchio esterno,<br />
orecchio me<strong>di</strong>o ed<br />
orecchio interno<br />
Figura 2 1 : Apparato U<strong>di</strong>tivo<br />
L’orecchio esterno e l’orecchio me<strong>di</strong>o sono <strong>di</strong> esclusiva<br />
pertinenza per quanto riguarda la sensibilità u<strong>di</strong>tiva, mentre<br />
nell’orecchio interno si situano i due recettori acustici situati<br />
nella parte del condotto cocleare e statocinetico, situati nella<br />
parte che comprende gli organi vestibolari e i canali<br />
semicircolari membranosi.<br />
L’orecchio esterno è costituito dal pa<strong>di</strong>glione auricolare, che<br />
svolge la funzione <strong>di</strong> percepire le onde sonore provenienti<br />
dall’ambiente esterno e convogliate nel canale u<strong>di</strong>tivo, fino a<br />
raggiungere la membrana del timpano con cui termina<br />
l’orecchio interno. La funzione della membrana timpanica è<br />
quella <strong>di</strong> emettere delle vibrazioni che convogliano agli ossicini<br />
dell’orecchio me<strong>di</strong>o: incu<strong>di</strong>ne, martello e staffa. La funzione<br />
che questi tre ossicini svolgono è trasmettere gli impulsi alla<br />
coclea (organo deputato alla trasduzione u<strong>di</strong>tiva): una<br />
membrana a forma <strong>di</strong> spirale situata nell’orecchio interno.<br />
Infine, le cellule ciliate dell’orecchio interno trasducono<br />
l’energia dello stimolo sonoro (energia meccanica) in segnale<br />
nervoso (segnale elettrico), così che il cervello possa<br />
riconoscerli come suoni.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Questa immagine è stata scaricata dal sito:<br />
http://www.au<strong>di</strong>ologia.unina.it/anatomia%20e%20fisiologia.htm<br />
- 10 -
Pertanto, è proprio il mezzo attraverso il quale il bambino<br />
udente, <strong>di</strong>fferentemente da quello non udente, impara a parlare,<br />
poiché mentre il primo si serve del canale u<strong>di</strong>tivo imparando<br />
così la lingua orale, il secondo deve ricorrere a metodologie<br />
<strong>di</strong>fferenti, come ad esempio il metodo oralista 1 che consentirà<br />
lui <strong>di</strong> imparare la lingua orale, oppure l’uso della lingua dei<br />
segni che consentirà lui, invece, <strong>di</strong> comunicare utilizzando il<br />
sistema visivo-gestuale. Ovviamente, il bambino non udente,<br />
che nella maggior parte dei casi dopo essere stato riconosciuto<br />
affetto da sor<strong>di</strong>tà, inizierà ad usufruire del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una<br />
protesi esterna o impianto cocleare, ha le medesime capacità<br />
cognitive <strong>di</strong> un bambino udente, ed essendo anch’egli dotato<br />
del <strong>di</strong>spositivo addetto all’acquisizione del linguaggio, sarà in<br />
grado <strong>di</strong> acquisire una lingua <strong>di</strong> tipo naturale.<br />
2 LA FRASE RELATIVA<br />
2.1 Le proprietà sintattiche della frase relativa.<br />
Quale sia la derivazione sintattica <strong>di</strong> una frase relativa è<br />
ancora al centro <strong>di</strong> numerosi <strong>di</strong>battiti. In questa sede ci<br />
limiteremo solo a presentare le proprietà sintattiche che<br />
caratterizzano le relative restrittive, nelle quali la testa della<br />
frase relativa può svolgere sia la funzione <strong>di</strong> soggetto 2 che <strong>di</strong><br />
oggetto 3 .<br />
Le RS 4 e le RO 5 sono delle frasi subor<strong>di</strong>nate che mo<strong>di</strong>ficando<br />
il loro antecedente, restringono il numero dei possibili<br />
referenti 6 .<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista sintattico, queste frasi appartengono al<br />
sintagma del complementatore (CP) (Cinque 1982, Vergnaud<br />
1985, Rizzi 1997, Bianchi 1999) e sono incassate all’interno <strong>di</strong><br />
un sintagma nominale complesso (DP). Esse sono introdotte dal<br />
complementatore che e contengono un gap collocato nella<br />
posizione in cui il movimento ha avuto origine.<br />
Pertanto, prendendo in considerazione una RS, il gap è<br />
collocato nella posizione <strong>di</strong> soggetto incassato 1 :<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 La lettura del labiale che viene insegnata dagli specialisti ai soggetti non udenti durante<br />
un percorso logope<strong>di</strong>co.<br />
2 In questo caso si parla <strong>di</strong> RS.<br />
3 In questo caso <strong>di</strong> parla <strong>di</strong> RO.<br />
4 Relative soggetto, da ora in poi RS.<br />
5 Relative oggetto, da ora in poi RO.<br />
6 In una frase del tipo: “la bambina che pettina la bambola”, la subor<strong>di</strong>nata che pettina la<br />
bambola restringe il campo dei possibili referenti.<br />
- 11 -
1) RS : L’elefante che ___ bagna il leone;<br />
invece, prendendo in considerazione una RO, il gap è collocato<br />
nella posizione <strong>di</strong> oggetto incassato 2 :<br />
2) RO: L’elefante che il leone bagna ___<br />
Tuttavia, per quanto riguarda la derivazione sintattica delle<br />
relative restrittive sono state presentate due teorie contrastanti.<br />
La prima teoria ipotizza che, strutture sintattiche <strong>di</strong> questo<br />
tipo sono state derivate grazie a un movimento wh da parte <strong>di</strong><br />
un operatore relativo (OP) (Cinque 1978, 1982); che si solleva<br />
dalla sua posizione originaria a Spec, CP e viene coin<strong>di</strong>cizzato<br />
con la testa della relativa, creando così una catena tra l’OP e la<br />
testa della relativa.<br />
Seguendo questa teoria avremo delle strutture sintattiche <strong>di</strong><br />
questo tipo:<br />
per quanto riguarda le RS (3a) la derivazione sintattica è<br />
rappresentata in 3b:<br />
3) a: L’elefante che bagna il leone.<br />
3) b : [DP l’ [NP elefantei [CP OPi che [IP ti ha bagna il leone ]]]]<br />
per quanto, invece, riguarda le RO (4a) la derivazione sintattica<br />
è rappresentata in 4b:<br />
4) a: l’elefante che il leone bagna<br />
4) b: [DP l’ [NP elefante [CP OPi che [IP il leone bagna ti]]]]<br />
La seconda teoria, invece, ipotizza un’analisi a raising<br />
(Vergnaud 1985, Kayne 1994, Bianchi 1999), secondo la quale<br />
l’elemento che si solleva dalla posizione incassata a Spec, CP è<br />
la testa stessa della relativa 3 .<br />
Seguendo questa teoria avremo delle strutture sintattiche <strong>di</strong><br />
questo tipo:<br />
per quanto riguarda le RS (5a) la derivazione sintattica è<br />
rappresentata in 5b:<br />
5) a: L’elefante che bagna il leone<br />
5) b: [DP l’ [CP [NP elefantei] che [IP [NP ti ] bagna il leone]]]]<br />
1 Posizione originaria del soggetto.<br />
2 Posizione originaria dell’oggetto.<br />
3 Il sintagma nominale l’elefante si sposta dalla posizione – θ a Spec, CP.<br />
- 12 -
per quanto, invece, riguarda le RO (6a) la derivazione sintattica<br />
è rappresentata in 6b:<br />
6) a: l’elefante che il leone bagna<br />
6) b: [DP l’ [CP [NP elefantei] che [IP il leone bagna [NP ti]]]<br />
Questi sono i due approcci principali riguardanti l’analisi<br />
della derivazione sintattica della frase relativa. In questo lavoro<br />
prenderemo in considerazione il secondo tipo <strong>di</strong> analisi, ossia<br />
quello a raising.<br />
2.2 Le RO e il Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata.<br />
Per poter spiegare al meglio i dati ottenuti dall’esperimento<br />
da noi condotto 1 , è opportuno ripercorrere, almeno a gran<strong>di</strong><br />
linee, le <strong>di</strong>fferenze sostanziali che intercorrono tra una RS e una<br />
RO.<br />
In <strong>di</strong>versi lavori riguardanti le frasi relative (Belletti &<br />
Contemori; 2010; Contemori & Belletti, forthcoming;<br />
Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009; Friedmann, Novogrodsky,<br />
Szterman, Preminger, 2008; Volpato, 2010; Utzeri, 2007)<br />
emerge che la computazione <strong>di</strong> una RO è decisamente più<br />
complessa rispetto alla computazione <strong>di</strong> una RS. Questo<br />
fenomeno è presente sia negli adulti che nei bambini, ma<br />
mentre i primi non mostrano alcuna <strong>di</strong>fficoltà per quanto<br />
riguarda la comprensione, bensì solo un rallentamento nel<br />
processo <strong>di</strong> computazione sintattica (De Vincenzi, 1991); i<br />
secon<strong>di</strong>, invece, presentano delle <strong>di</strong>fficoltà sia per quanto<br />
riguarda la comprensione che la produzione (Adani, 2011;<br />
Belletti, 2009; Belletti & Contemori; 2010; Contemori &<br />
Belletti, forthcoming; Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009;<br />
Friedmann, Novogrodsky, Szterman, Preminger, 2008 ).<br />
La motivazione per la quale la computazione sintattica <strong>di</strong> una<br />
RO risulta più problematica rispetto alla computazione<br />
sintattica <strong>di</strong> una RS è stata esplicata nel lavoro <strong>di</strong> Friedmann,<br />
Belletti, Rizzi (2009) 2 , nel quale i linguisti hanno interpretato<br />
tale <strong>di</strong>fficoltà in termini tratti morfosintattici (featural<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Cfr. § 3.<br />
2 L’esperimento da loro condotto mirava a testare la comprensione <strong>di</strong> quattro tipologie<br />
<strong>di</strong>verse <strong>di</strong> strutture relative, da parte <strong>di</strong> bambini normo-dotati parlanti nativi della lingua<br />
ebraica, <strong>di</strong>mostrando che le relative con gap e quelle con pronome resuntivo erano<br />
comprese decisamente meno, rispetto alle relative libere e con testa oggetto con pronome<br />
arbitrario come interveniente.<br />
- 13 -
approach), teoria che segue dal Principio <strong>di</strong> Minimalità<br />
Relativizzata (Rizzi, 1990)<br />
Considerando la classica configurazione schematica del<br />
Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata, avremo:<br />
X ……… Z ……… Y<br />
“una relazione tra X e Y si stabilisce se e solo se non c’è Z che:<br />
(i) interviene tra X e Y<br />
(ii) è dello stesso tipo <strong>di</strong> X<br />
(iii) c- comanda Y e non c-comanda X” (Rizzi, 1990).<br />
Pertanto, da tale principio segue che: X e Z devono essere<br />
sufficientemente <strong>di</strong>versi nella loro composizione in tratti<br />
morfosintattici affinché la <strong>di</strong>pendenza tra X e Y possa essere<br />
adeguatamente stabilita così che Z non blocchi tale relazione 1<br />
(Rizzi, 1990, 2004).<br />
In Friedmann, Belletti, Rizzi (2009), è stato in<strong>di</strong>viduato, per<br />
quanto riguarda la frase relativa, un tratto R nella posizione<br />
target X all’interno del CP, che funge da attrattore per la testa<br />
della relativa.<br />
Pertanto, se si tratta <strong>di</strong> una RS, ovviamente, il soggetto si sposta<br />
dalla sua posizione incassata per raggiungere la posizione target<br />
all’interno del CP, che ha il tratto R:<br />
7) RS : L’elefante che bagna il leone<br />
R+NP NP+R NP<br />
X Z Y<br />
se, invece, si tratta <strong>di</strong> una RO è l’oggetto che si sposta dalla sua<br />
posizione incassata per raggiungere la posizione target<br />
all’interno del CP, che ha il tratto R:<br />
8) RO: L’elefante che il leone bagna <br />
NP+R NP R+NP<br />
X Z Y<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 L’importanza relativa alla presenza <strong>di</strong> una restrizione lessicale che l’oggetto della frase<br />
relativa incontra nel suo percorso da posizione incassata a Spec, CP, viene espressa in<br />
termini <strong>di</strong> featural approach; approccio che segue dal principio della Minimalità<br />
Relativazzata (Rizzi, 1190,2004) e sviluppato in Starke (2001).<br />
- 14 -
Come si può ben notare dalla configurazione N°8, l’elemento<br />
interveniente Z è portatore del tratto lessicale NP, esattamente<br />
come l’elemento target X.<br />
Dunque, ciò che accade in una RO è che l’oggetto, portatore<br />
del tratto R + NP 1 , nel suo percorso da posizione incassata <strong>di</strong><br />
oggetto a Spec, CP incontra il soggetto della frase dotato<br />
anch’esso del tratto NP, creando così un rallentamento per il<br />
processo <strong>di</strong> computazione e un ostacolo sia per la comprensione<br />
che per la produzione 2 . Questa problematica, invece, non è<br />
presente nelle RS, la cui computazione sintattica non<br />
caratterizza alcuna <strong>di</strong>fficoltà per i soggetti.<br />
Seguendo Starke (2001) e Friedmann, Belletti, Rizzi (2009),<br />
per quanto riguarda le RO, ci troviamo <strong>di</strong> fronte al così detto<br />
caso <strong>di</strong> inclusione (9 II). Infatti, sono state ipotizzate tre <strong>di</strong>verse<br />
relazioni che possono stabilirsi tra l’elemento target X e<br />
l’elemento interveniente Z. La configurazione schematica è <strong>di</strong><br />
seguito rappresentata:<br />
9) X Z Y<br />
I) +A ….. +A …. * (Identità)<br />
II) +A,+B …. +A …. OK (Inclusione)<br />
III) +A ….. +B …. OK (Disgiunzione)<br />
Quin<strong>di</strong> in una RO il tratto lessicale (NP) accomuna sia<br />
l’elemento target X che l’elemento Z interveniente creando,<br />
così, delle <strong>di</strong>fficoltà relative al processo <strong>di</strong> computazione<br />
sintattica.<br />
2.3 Il passivo elimina l’intervenienza.<br />
A causa della <strong>di</strong>fficile computazione sintattica delle RO, i<br />
parlanti molto spesso evitano la produzione <strong>di</strong> questa struttura a<br />
favore della frase passiva 3 , in quanto la computazione è<br />
senz’altro più semplice e allo stesso tempo consente <strong>di</strong><br />
mantenere il medesimo significato <strong>di</strong> una RO. Infatti, Belletti<br />
nel lavoro del 2009, assumendo l’analisi alla Collins (2005),<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 R rappresenta il tratto attrattore della testa della relativa; NP rappresenta il tratto<br />
lessicale <strong>di</strong> cui sia il soggetto che l’oggetto della frase sono composti.<br />
2 Infatti, dall’esperimento condotto da Friedmann, Belletti e Rizzi (2009) è emerso che i<br />
bambini, nel loro caso parlanti nativi della lingua ebraica comprendevano con mote<br />
<strong>di</strong>fficoltà una RO con gap, in quanto sia il soggetto che l’oggetto della frase relativa sono<br />
portatori del medesimo tratto, ossia quello lessicale.<br />
3 A volte anche scritta con l’acronimo POR (Passive Object Relative)<br />
- 15 -
considera il passivo un modo ottimale per eliminare<br />
completamente l’effetto <strong>di</strong> intervenienza.<br />
Seguendo la derivazione sintattica del passivo proposta da<br />
Collins nel 2005, che tramite l’operazione dello smuggling<br />
innescata dal sintagma del by 1 che consiste nel muovere un<br />
chunk del sintagma verbale (VP) contenente il participio<br />
passato del verbo e l’argomento interno fino alla posizione <strong>di</strong><br />
Spec, VoiceP, l’intervenienza è eliminata; e sarà poi<br />
l’argomento interno, che si sposterà ulteriormente per andare ad<br />
occupare la posizione <strong>di</strong> Spec, TP, ossia la posizione <strong>di</strong><br />
soggetto della frase.<br />
La derivazione sintattica appena descritta è <strong>di</strong> seguito<br />
rappresentata nell’albero N°1.<br />
Albero N°1<br />
T<br />
T’<br />
la mela T VP<br />
<br />
essere VoiceP<br />
PartP Voice’<br />
Part’ Voice<br />
Part VP da<br />
mangiata < DP2> vP<br />
- 16 -<br />
v’<br />
Maria v<br />
Come si può chiaramente osservare dall’albero sintattico, una<br />
derivazione <strong>di</strong> questo tipo risulta essere abbastanza complessa.<br />
Infatti, viene acquisita piuttosto tar<strong>di</strong>vamente da parte dei<br />
bambini, intorno ai 5 anni d’età 2 . Tuttavia, una volta sviluppata,<br />
si rivela essere la strategia <strong>di</strong> “evitamento” maggiormente<br />
utilizzata dai parlanti, poiché lo smuggling permette <strong>di</strong><br />
eliminare l’intervenienza sintattica(Belletti, 2009).<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Inteso come in<strong>di</strong>catore della voce passiva.<br />
2 Cfr. il lavoro <strong>di</strong> Contemori&Belletti forthcoming.
3 L’ESPERIMENTO: SOMMINISTRAZIONE E RISULTATI<br />
3.1 Design sperimentale.<br />
Il design sperimentale da noi utilizzato è stato adattato da<br />
Belletti & Chesi (2011) 1 . Lo scopo <strong>di</strong> questo design è osservare<br />
se manipolando il tratto [+/- animato], relativo ora alla testa<br />
della frase relativa, ora al soggetto della frase relativa ed ora ad<br />
entrambi, si possano creare delle con<strong>di</strong>zioni affinché la RO<br />
possa essere più accessibile ai parlanti, nel nostro caso non<br />
udenti. Pertanto, sono stati somministrati due esperimenti <strong>di</strong><br />
elicitation task:<br />
I) Subject–Change: nel quale si ha il cambio del<br />
soggetto nei due eventi; come ad<br />
esempio:<br />
I poliziotti rincorrono un ragazzo<br />
I commercianti rincorrono un ragazzo<br />
II) Verb–Change: nel quale si ha il cambio del verbo<br />
nei due eventi; come ad esempio:<br />
I poliziotti salutano un ragazzo<br />
I poliziotti rincorrono un ragazzo<br />
In entrambi gli esperimenti sono presentate quattro possibili<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali, sufficienti a sod<strong>di</strong>sfare tutte le<br />
possibilità logiche, <strong>di</strong> seguito presentate:<br />
1) Testa [+ animata], Soggetto [– animato];<br />
2) Testa [+ animata], Soggetto [+ animato];<br />
3) Testa [- animata], Soggetto [+ animato];<br />
4) Testa [- animata], Soggetto [- animato].<br />
Il design sperimentale è il seguente:<br />
3 item per ogni con<strong>di</strong>zione sperimentale; per un totale <strong>di</strong><br />
12 item sperimentali;<br />
28 frasi filler per separare gli item sperimentali;<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Esperimento a sua volta adattato da Belletti & Contemori (2010), a sua volta adattato da<br />
Novogrosky & Friedmann (2006).<br />
- 17 -
4 randomizzazioni create in maniera semi–automatica ed<br />
ogni randomizzazione inizia con un item <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione<br />
sperimentale <strong>di</strong>versa;<br />
almeno 2 item separano una con<strong>di</strong>zione dall’altra, e<br />
nessun item della medesima con<strong>di</strong>zione sperimentale<br />
appare in sequenza;<br />
i primi 4 item, in ognuna delle 4 randomizzazioni,<br />
esauriscono le 4 possibili con<strong>di</strong>zioni sperimentali.<br />
Inoltre, per eliminare una potenziale ambiguità le frasi che<br />
introducono i due eventi sono così strutturate:<br />
tutti i soggetti sono: definiti e plurali;<br />
tutti gli oggetti sono: maschili e singolari;<br />
tutti i verbi sono: flessi al presente.<br />
Le tabelle N°1 e N°2 mostrano le quattro con<strong>di</strong>zioni<br />
sperimentali riguardanti gli esperimenti Subject-Change e<br />
Verb-Change.<br />
Tabella N°1:<br />
Le quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali del Subject-Change.<br />
cond. testa<br />
relativa<br />
1 + anim +anim I poliziotti salutano un<br />
ragazzo<br />
I commercianti salutano<br />
un ragazzo<br />
2 + anim -anim I secchi sporcano un<br />
imbianchino<br />
I pennelli sporcano un<br />
imbianchino<br />
3 -anim +anim I giornalisti scrivono un<br />
articolo<br />
I reporter scrivono un<br />
articolo<br />
4 -anim -anim I camini riscaldano un<br />
appartamento<br />
I termosifoni riscaldano<br />
un appartamento<br />
Soggetto Eventi Frase per la produzione<br />
- 18 -<br />
Tu quale ragazzo vorresti<br />
incontrare?<br />
“Vorrei incontrare il<br />
ragazzo ….”<br />
Tu quale imbianchino<br />
vorresti aiutare<br />
“Vorrei aiutare<br />
l’imbianchino ….”<br />
Tu quale articolo vorresti<br />
leggere?<br />
“Vorrei leggere l’articolo<br />
…”<br />
Tu quale appartamento<br />
vorresti scegliere?<br />
“Vorrei scegliere<br />
l’appartamento …”<br />
Tabella N° 2:<br />
Le quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali del Verb-Change.
cond. testa<br />
relativa<br />
1 + anim +anim I poliziotti salutano un<br />
ragazzo<br />
I poliziotti rincorrono un<br />
ragazzo<br />
2 + anim -anim I secchi sbilanciano un<br />
imbianchino<br />
I secchi sporcano un<br />
imbianchino<br />
3 -anim +anim I giornalisti scrivono un<br />
articolo<br />
I giornalisti copiano un<br />
articolo<br />
4 -anim -anim I camini riscaldano un<br />
appartamento<br />
I camini affumicano un<br />
appartamento<br />
Soggetto Eventi Frase per la produzione<br />
- 19 -<br />
Tu quale ragazzo vorresti<br />
incontrare?<br />
“Vorrei incontrare il<br />
ragazzo ….”<br />
Tu quale imbianchino<br />
vorresti aiutare<br />
“Vorrei aiutare<br />
l’imbianchino ….”<br />
Tu quale articolo vorresti<br />
leggere?<br />
“Vorrei leggere l’articolo<br />
…”<br />
Tu quale appartamento<br />
vorresti scegliere?<br />
“Vorrei scegliere<br />
l’appartamento …”<br />
3.2 Soggetti sperimentali.<br />
Sono stati testati 7 soggetti sor<strong>di</strong>, 3 femmine e 4 maschi, <strong>di</strong><br />
età compresa tra i 18 e 29 anni; 6 <strong>di</strong> essi sono stati reclutati da<br />
un Ente Nazionale <strong>Sor<strong>di</strong></strong> della Toscana 1 , e 1 <strong>di</strong>rettamente<br />
dall’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong>.<br />
Nella tabella N°3 riporteremo i dati relativi ai soggetti<br />
sperimentali, ai quali abbiamo convenzionalmente assegnato<br />
dei nomi fittizi.<br />
Tabella N°3:<br />
Dati ragazzi<br />
IDENTIFICATIVO Beatrice Melissa Francesco Dario Rebecca Alberto Clau<strong>di</strong>o<br />
ETÀ 18 29 20 28 25 26 20<br />
ISTRUZIONE Scuola Università Scuola Scuola Università Università Università<br />
superiore<br />
superiore superiore<br />
INSORGENZA<br />
SORDITÀ<br />
Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita<br />
GRAVITÀ Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia<br />
bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale<br />
profonda profonda profonda profonda profonda profonda profonda<br />
CONOSCENZA LIS Sì Sì Sì Sì Sì Sì No<br />
(passiva)<br />
(passiva)<br />
PROTESI Sì Sì Sì Sì Sì Sì No<br />
IMPIANTO<br />
COCLEARE<br />
No No No No No No Sì<br />
PROTESIZZAZIONE 17 mesi 9 mesi 4 anni 9 mesi 8 mesi 8 mesi<br />
8 mesi 2<br />
OPERAZIONE<br />
IMPIANTO<br />
COCLEARE<br />
/ / / / / / 19 anni<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Per una maggiore privacy nei confronti dei ragazzi, ci è stato cortesemente chiesto <strong>di</strong><br />
non specificare il luogo preciso dell’Ente.<br />
2 Clau<strong>di</strong>o prima dell’intervento chirurgico per inserire l’impianto cocleare ha usufruito<br />
del sussi<strong>di</strong>o delle protesi esterne, la cui protesizzazione è avvenuta nell’ottavo mese <strong>di</strong><br />
vita.
Come si evince dalla tabella N°3, tutti i soggetti sono affetti<br />
sin dalla nascita da ipoacusia bilaterale profonda, ma mentre<br />
Clau<strong>di</strong>o utilizza l’impianto cocleare ormai da un anno, i rimanti<br />
6 usufruiscono del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una protesi esterna.<br />
Tuttavia, è importante considerare l’età in cui i soggetti sono<br />
stati protesizzati, in quanto questo influirà molto sul proprio<br />
parlato. Infatti, come abbiamo precedentemente accennato, una<br />
<strong>di</strong>agnosi precoce della sor<strong>di</strong>tà è fondamentale per raggiungere<br />
un buon livello linguistico, grazie anche al sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> protesi o<br />
impianto cocleare e un percorso linguistico specifico.<br />
In ogni caso, ad eccezione <strong>di</strong> Francesco che è stato<br />
protesizzato all’età <strong>di</strong> quattro anni, i rimanenti sei soggetti sono<br />
stati protesizzati tra gli otto e i <strong>di</strong>ciassette mesi <strong>di</strong> vita.<br />
Per quanto riguarda i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> istruzione, Melissa e Alberto<br />
posseggono un titolo universitario, Rebecca e Clau<strong>di</strong>o stanno<br />
compiendo gli stu<strong>di</strong> universitari, Dario possiede il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong><br />
scuola superiore, Beatrice e Francesco frequentano l’ultimo<br />
anno <strong>di</strong> scuola superiore.<br />
Il gruppo <strong>di</strong> controllo è composto da soggetti adulti normodotati<br />
provenienti dalle regioni: Toscana, Campania, Calabria e<br />
Sicilia:<br />
14 soggetti per il Subject-Change, <strong>di</strong> età compresa tra i<br />
20;10 e 28;5;<br />
12 soggetti per il Verb-Change, <strong>di</strong> età compresa tra i<br />
21;11 e 28;5.<br />
Si noti che il numero dei soggetti appartenenti al gruppo <strong>di</strong><br />
controllo è il doppio del numero dei soggetti appartenenti al<br />
gruppo sperimentale, così che la comparazione possa risultare<br />
più equilibrata.<br />
3.3 Metodo.<br />
Poiché i nostri soggetti sono tutti affetti da ipoacusia<br />
bilaterale profonda abbiamo pensato che il modo più ottimale<br />
per svolgere l’esperimento fosse quello <strong>di</strong> far leggere ogni<br />
elemento. È stato, quin<strong>di</strong>, creato un PowerPoint tramite il quale<br />
i soggetti potevano leggere:<br />
il contesto;<br />
l due eventi;<br />
- 20 -
la domanda che avrebbe condotto loro ad una scelta tra i<br />
due eventi;<br />
lo start con cui iniziare la produzione linguistica<br />
(risposta).<br />
Queste parti sperimentali non venivano presentate<br />
contemporaneamente nella slide, bensì ciascuna <strong>di</strong> esse<br />
appariva solo quando il soggetto premeva il tasto “Invio” del<br />
PC, fino a raggiungere la start con cui iniziare la risposta che il<br />
soggetto avrebbe dato alla domanda.<br />
Per maggiore chiarezza si riporta l’or<strong>di</strong>ne sequenziale degli<br />
elementi <strong>di</strong> una slide del Subject-Change.<br />
Figura 3: contesto<br />
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
- 21 -
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
Figura 4: primo evento.<br />
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I militari cercano un bambino<br />
Figura 5: secondo evento.<br />
- 22 -
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I militari cercano un bambino<br />
Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />
Figura 6: domanda.<br />
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I militari cercano un bambino<br />
Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />
Rispon<strong>di</strong> con:<br />
Figura 7: si richiedeva <strong>di</strong> “rispondere con”.<br />
- 23 -
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I militari cercano un bambino<br />
Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />
Rispon<strong>di</strong> con:<br />
“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO …”<br />
Figura 8: start risposta.<br />
Per concludere l’esperimento non abbiamo posto un tempo<br />
limite. Le slides presentate per ogni randomizzazione erano 46,<br />
<strong>di</strong> cui:<br />
1 per presentare le istruzioni;<br />
3 <strong>di</strong> Warm up;<br />
1 per informare i soggetti che l’esperimento stava per<br />
aver inizio;<br />
12 per la produzione delle RO;<br />
28 per le frasi filler;<br />
1 per ringraziare i soggetti della partecipazione.<br />
Ai soggetti sperimentali è stato somministrato prima il<br />
Subject-Change, e successivamente il Verb-Change, a <strong>di</strong>stanza,<br />
almeno, <strong>di</strong> una settimana; tempo necessario per rimuovere i dati<br />
memorizzati dal precedente esperimento.<br />
- 24 -
Il gruppo <strong>di</strong> controllo è costituito da soggetti <strong>di</strong>versi per<br />
entrambi i task, eccetto che per tre <strong>di</strong> loro che hanno eseguito<br />
prima il Subject-Change, e a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> una settimana il Verb-<br />
Change.<br />
3.4 Risultati Subject-Change.<br />
In questa sede si illustrano i risultati ottenuti sia dal gruppo<br />
sperimentale che dal gruppo <strong>di</strong> controllo relativi al Subject-<br />
Change. Illustreremo, inoltre, un confronto tra il nostro gruppo<br />
<strong>di</strong> controllo e il gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011),<br />
in quanto entrambi i gruppi sono composti da soggetti normoudenti,<br />
ma il metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale<br />
utilizzato è <strong>di</strong>fferente. 1<br />
3.4.1 Gruppo sperimentale.<br />
Tabella N°4:<br />
Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo sperimentale:<br />
Subject-Change.<br />
Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />
da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />
POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />
con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />
RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />
Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />
pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />
SUBJECT-CHANGE Testa+ Sogg+ Testa+ Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />
POR TOT 8 (38%) 6 (29%) 7 (33%) 8 (38%)<br />
POR 0 0 0 0<br />
POR da 0 0 0 0<br />
POR r. 0 0 0 0<br />
POR r. da 7 6 7 8<br />
POR+viene 1 0 0 0<br />
RO TOT 6 (29%) 3 (14%) 3 (14%) 3 (15%)<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 In Belletti & Chesi (2011) per la somministrazione dell’esperimento era stato creato un<br />
PowerPoint tramite il quale i soggetti potevano ascoltare un file au<strong>di</strong>o che presentava<br />
loro un contesto, i due eventi, la domanda e lo start con cui iniziare la risposta. Per<br />
maggiore chiarezza si confronti Belletti & Chesi (2011).<br />
- 25 -
RO S-V 2 1 0 1<br />
RO V-S 1 0 2 0<br />
RO rip.trac 0 0 1 0<br />
RO Pr.Re 3 2 0 2<br />
RO pro 0 0 0 0<br />
Altro 4 (19%) 8 (38%) 9 (43%) 7 (33%)<br />
RS 1 4 0 0<br />
PP 3 4 9 7<br />
Errate 3 (14%) 4 (19%) 2 (9%) 3 (14%)<br />
Come mostra la tabella N°4, il gruppo sperimentale preferisce<br />
produrre principalmente delle strutture passive, in particolar<br />
modo delle POR ridotte con by-phrase, in tutte e quattro le<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali, fatta, però, eccezione per la con<strong>di</strong>zione<br />
Testa [- animata]e Soggetto [+ animato] in cui la strategia <strong>di</strong><br />
risposta maggioremente adottata è l’uso <strong>di</strong> un PP. Per quanto<br />
riguarda, invece, le RO esse sono state maggiormente prodotte<br />
nella con<strong>di</strong>zione sperimentale in cui sia il soggetto che la testa<br />
della frase relativa sono entrambi animati, ossia Testa [+<br />
animata] e Soggetto [+ animato], con<strong>di</strong>zione in cui la<br />
percentuale corrispondente alle RO è del 29%.<br />
Tuttavia, si sottolinea che a contribuire molto sulla<br />
percentuale relativa alle POR è Clau<strong>di</strong>o, che si è comportato<br />
come un normo-udente, producendo tutte POR ridotte con byphrase<br />
eccetto che per un PP nella con<strong>di</strong>zione Testa [- animata]<br />
e Soggetto [- animato]. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno<br />
effettuare un conteggio delle strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal<br />
gruppo sperimentale anche senza Clau<strong>di</strong>o, per osservarne la<br />
<strong>di</strong>fferenza. Di seguito il grafico che ne mostra il risultato.<br />
Grafico N°1:<br />
Risultati Subject-Change senza Clau<strong>di</strong>o.<br />
- 26 -
Come si evince dal grafico soprastante, qualora Clau<strong>di</strong>o non<br />
avesse partecipato all’esperimento, le POR non sarebbero<br />
risultate le strategie <strong>di</strong> evitamento preferite dai soggetti<br />
sperimentali in nessuna delle quattro con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> questo task.<br />
Infatti, le RO sarebbero state le strategie maggiormente<br />
adottate nella con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />
animato], e le strategie corrispondenti alle RS e ai PP quelle<br />
preferite nelle altre tre con<strong>di</strong>zioni.<br />
Ci è sembrato opportuno illustrare come Clau<strong>di</strong>o abbia<br />
notevolmene contribuito sulla percentuale delle POR; ciò<br />
nonostante, terremo conto del risultato totale, ossia quello in cui<br />
è incluso anche Clau<strong>di</strong>o.<br />
Illustriamo ora i risultati ottenuti dal gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
3.4.2 Gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
Tabella N°5:<br />
Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo controllo:<br />
Subject-Change.<br />
Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />
da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />
POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />
con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />
RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />
Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />
pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />
SUBJECT-CHANGE Testa+Sogg+ Testa+Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />
POR TOT 33 (79%) 35 (83%) 24 (57%) 30 (63%)<br />
POR r. 0 0 0 0<br />
- 27 -
POR r.+ da 27 26 24 24<br />
POR N.r. 0 0 0 0<br />
POR N.r.+da 2 4 0 0<br />
POR + viene 0 0 0 0<br />
POR + viene + da 4 5 0 6<br />
RO TOT 9 (21%) 1 (3%) 4 (10%) 1 (3%)<br />
RO S-V 5 1 1 0<br />
RO V-S 4 0 3 1<br />
RO pro 0 0 0 0<br />
ALTRO 0 (0%) 5 (12%) 14(33%) 11 (34%)<br />
PP 0 2 14 9<br />
RS 0 3 0 2<br />
ERRATE 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)<br />
Come mostrano i dati riportati nella tabella N°5 la strategia<br />
maggiormente adottata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dal<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo è l’uso della POR, in particolar modo un<br />
POR ridotta con by-phrase. Anche per questo gruppo la<br />
percentuale maggiore <strong>di</strong> RO è stata prodotta nella con<strong>di</strong>zione<br />
sperimentale in cui sia la testa che il soggetto della frase<br />
relativa sono animati, ossia Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />
animato] con<strong>di</strong>zione in cui la RO è stata prodotta nel 21% dei<br />
casi. 1 Per quanto riguarda, invece, le strategie corrispondenti<br />
alle RS e ai PP, queste sono state largamente adottate,<br />
soprattutto i PP nella con<strong>di</strong>zione Testa [- animata] e Soggetto<br />
[+ animato].<br />
Infine, ci è sembrato opportuno effettuare un ulteriore<br />
confronto tra i risultati ottenuti dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo e<br />
i risultati ottenuti dal gruppo sperimentale testato da Belletti &<br />
Chesi (2011). Di seguito la tabella che illustra i dati da loro<br />
ottenuti.<br />
Tabella N°6:<br />
Esperimento 2 (subject-change) risultato (28 soggetti<br />
sperimentali); r.= ridotta, by = presenza del by-phrase, VS =<br />
soggetto post-verbale, pro = soggetto nullo, ALT SR = RS<br />
prodotta anziché una RO, ALT PP = Prepositional Phrase<br />
prodotto anziché una RO.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 In ogni caso percentuale minore rispetto a quella del gruppo sperimentale.<br />
- 28 -
Da questa comparazione emerge che entrambi i gruppi,<br />
composti da soggetti normo-dotati, preferiscono produrre delle<br />
POR ridotte con by-phrase in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni<br />
sperimentali, in quanto l’intervenienza sintattica è eliminata dal<br />
movimento dello smuggling 1 . Le RO, anche se scarsamente<br />
prodotte da entrambi i gruppi, sono state maggiormente<br />
utilizzate quando sia il soggetto che la testa della frase relativa<br />
sono animati, ossia nella con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e<br />
Soggetto [+ animato]. In questa con<strong>di</strong>zione sperimentale il<br />
nostro gruppo <strong>di</strong> controllo ha, però, prodotto una percentuale<br />
maggiore <strong>di</strong> RO rispetto al gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti &<br />
Chesi (2011), nonostante il numero dei soggetti appartenenti al<br />
nostro gruppo <strong>di</strong> controllo è la metà del numero dei soggetti<br />
appartenenti al gruppo sperimentali <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />
Questa maggiore percentuale <strong>di</strong> RO prodotta da parte del nostro<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo potrebbe scaturire dal metodo <strong>di</strong><br />
somministrazione sperimentale da noi utilizzato, il quale<br />
prevede che i soggetti leggano tutti gli elementi presenti nella<br />
slide, e nel momento in cui si chiede loro <strong>di</strong> rispondere alla<br />
domanda come noi suggeriamo, è sufficiente che aggiungano il<br />
complementatore che all’evento che è stato da loro scelto.<br />
Ad esempio:<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Cfr. albero sintattico N°1 § 2.3.<br />
- 29 -
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I militari cercano un bambino<br />
Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />
Rispon<strong>di</strong> con:<br />
“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO che …”<br />
Figura 9: Facilitazione produzione RO, Subject-Change.<br />
Pertanto, anche se la RO, per ragioni spiegate in precedenza,<br />
è più complessa <strong>di</strong> una struttura passiva, questo metodo <strong>di</strong><br />
somministrazione sperimentale potrebbe facilitarne, ma non<br />
favorirne, la produzione.<br />
Nel sottoparagrafo successivo, analizzeremo i risultati relativi<br />
all’esperimento Verb-Change.<br />
3.5 Risultati Verb-Change.<br />
In questa sede illustreremo i risultati ottenuti sia dal gruppo<br />
sperimentale che dal gruppo <strong>di</strong> controllo, ed inoltre mostreremo<br />
il confronto effettuato tra il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo e il<br />
gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />
3.5.1 Gruppo sperimentale.<br />
Tabella N°7:<br />
Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dai soggetti non udenti:<br />
Verb-Change.<br />
Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />
da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />
POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />
con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />
RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />
- 30 -
Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />
pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />
VERB-CHANGE Testa+ Sogg+ Testa+ Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />
POR TOT 8 (44%) 11 (61%) 7 (39%) 11 (61%)<br />
POR N.r. 0 0 0 0<br />
POR N. r.+da 1 2 0 8<br />
POR r. 3 6 4 3<br />
POR r. da 4 3 3 0<br />
POR+viene 0 0 0 0<br />
RO TOT 7 (39%) 2 (11%) 7 (38%) 4 (22%)<br />
RO S-V 2 0 2 2<br />
RO V-S 2 0 3 0<br />
RO rip.trac 0 0 1 0<br />
RO Pr.Re 2 2 1 2<br />
RO pro 1 0 0 0<br />
Altro 0 (0%) 2 (11%) 1 (6%) 0 (0%)<br />
RS 0 2 0 0<br />
PP 0 0 1 0<br />
Errate 3 (17%) 3 (17%) 3 (17%) 3 (17%)<br />
Come si evince dalla tabella N°7, la strategia maggiormente<br />
adottadata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dai soggetti<br />
non udenti è l’uso <strong>di</strong> una POR, in particolar modo una POR<br />
ridotta senza il by-phrase. Per quanto riguarda, invece, le<br />
strategie <strong>di</strong> risposta corridpondenti alle RO esse sono state<br />
maggiormente adottate nelle due con<strong>di</strong>zioni in cui il soggetto<br />
della frase relativa è animato ossia Testa [+ animato] e<br />
Soggetto [+ animato], e Testa [- animata] e Soggetto [+<br />
animato]. Le strategie <strong>di</strong> risposta corrispondenti alle RS e ai PP,<br />
sono state scarsamente utilizzate in questo task sperimetale.<br />
Inoltre, abbiamo nuovamente ritenuto opportuno effettuare un<br />
conteggio senza Clau<strong>di</strong>o, in quanto, anche per questo task<br />
- 31 -
sperimentale ha contribuito notevolmente sulla percentuale<br />
delle POR, poichè ha prodotto tutte POR ridotte senza byphrase<br />
1 e una POR ridotta con by-phrase. Di seguito il grafico<br />
che ne illustra le percentuali.<br />
Grafico N° 2:<br />
Risultati Verb-Change senza Clau<strong>di</strong>o.<br />
Come si evince dal grafico soprastante, qualora Clau<strong>di</strong>o non<br />
avesse partecipato all’esperimento le POR sarebbero state le<br />
strategie <strong>di</strong> risposta maggiormente adottate solo nelle<br />
con<strong>di</strong>zioni in cui il soggetto della frase relativa non è animato,<br />
ossia Testa [+ animato] e Soggetto [- animato], e Testa [-<br />
animata] e Soggetto [- animato], mentre nelle con<strong>di</strong>zioni in cui<br />
il soggetto della frase relativa è animato, ossia Testa [- animata]<br />
e Soggetto [+ animato], e Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />
animato] le strategie <strong>di</strong> risposta maggiormente adottate<br />
sarebbero state le RO.<br />
Ovviamente terremo conto del risultato complessivo, ossia<br />
quello in cui Claus<strong>di</strong>o è incluso.<br />
Osserviamo ora i risultati relativi al gruppo <strong>di</strong> controllo; <strong>di</strong><br />
seguito la relativa tabella.<br />
3.5.2 Gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
Tabella N°8:<br />
Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo <strong>di</strong> controllo:<br />
Verb-Change.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Il complemento d’agente non è necessario, in quanto i due eventi <strong>di</strong>fferiscono per il<br />
cambio del verbo.<br />
- 32 -
Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />
da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />
POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />
con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />
RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />
Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />
pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />
VERB-CHANGE Testa+Sogg+ Testa+Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />
POR TOT 25 (69%) 23 (64%) 25 (69%) 27 (77%)<br />
POR r. 5 5 8 9<br />
POR r.+ da 13 13 16 15<br />
POR N.r. 0 0 1 0<br />
POR N.r.+da 3 3 0 1<br />
POR + viene 2 0 0 1<br />
POR + viene + da 2 2 0 1<br />
RO TOT 10 (28%) 8 (22%) 10 (28%) 5 (9%)<br />
RO S-V 10 8 9 4<br />
RO V-S 0 0 1 1<br />
RO pro 0 0 0 0<br />
ALTRO 1 (3%) 5 (14%) 1 (3%) 3 (14%)<br />
PP+che 0 0 1 2<br />
RS 1 5 0 1<br />
ERRATE 0 0 0 1<br />
Come mostrano i dati riportati nella tabella N°8 la strategia<br />
maggiormente adottata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dal<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo è l’uso della struttura passiva, in particolar<br />
modo una POR ridotta con by-phrase. Per quanto riguarda le<br />
RO, anche questo gruppo le ha prodotte in percentuale<br />
maggiore nelle due con<strong>di</strong>zioni sperimentali in cui il soggetto<br />
della frase relativa è animato, ossia Testa [+ animata] e<br />
Soggetto [+ animato], e Testa [- animata] e Soggetto [+<br />
animato]. Le strategie corrispondenti alle RS e ai PP sono state<br />
scarsamente adottate anche da questo gruppo.<br />
Infine, così come fatto per il Subject-Change, abbiamo<br />
effettuato un ulteriore confronto tra i risultati ottenuti dal nostro<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo e i risultati ottenuti dal gruppo sperimentale<br />
testato da Belletti & Chesi (2011). Di seguito la tabella che<br />
illustra i risultati ottenuti nel lavoro <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />
- 33 -
Tabella N°9:<br />
Esperimento 1 (verb-change) risultato (24 soggetti<br />
sperimentali); r.= ridotta, by = presenza del by-phrase, VS =<br />
soggetto post-verbale, pro = soggetto nullo, ALT SR = RS<br />
prodotta anziché una RO, ALT PP = Prepositional Phrase<br />
prodotto anziché una RO.<br />
Da questa comparazione emerge che entrambi i gruppi,<br />
composti da soggetti normo-dotati, preferiscono produrre delle<br />
POR ridotte, in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni sperimentali, in<br />
quanto l’intervenienza sintattica è eliminata dal movimento<br />
dello smuggling, ma mentre il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo<br />
preferisce produrre delle POR ridotte con by-phrase il gruppo<br />
sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011) preferisce produrre<br />
delle POR ridotte senza by-phrase. Le RO, sono state<br />
maggiormente prodotte dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo 1 nelle<br />
due con<strong>di</strong>zioni sperimentali in cui il soggetto della frase<br />
relativa è animato, ossia Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />
animato] e Testa [- animata] e Soggetto [+ animato].<br />
Anche per questo task, il numero <strong>di</strong> maggiore <strong>di</strong> RO che è<br />
stato prodotto dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo rispetto al gruppo<br />
sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011) potrebbe essere<br />
ricondotto al metodo <strong>di</strong> somministrazione da noi utilizzato.<br />
Questo giustificherebbe anche il numero elevato <strong>di</strong> RO con<br />
soggetto pre-verbale prodotto dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Anche se i soggetti appartenenti al nostro gruppo <strong>di</strong> controllo sono la metà dei soggetti<br />
appartenenti al gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />
- 34 -
Siamo in un bosco.<br />
Due bambini si sono persi.<br />
Dei boyscout stanno cercando questi due bambini.<br />
• I boyscout cercano un bambino<br />
• I boyscout trovano un bambino<br />
Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />
Rispon<strong>di</strong> con:<br />
“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO che”<br />
Figura 10: Facilitazione produzione RO; Verb-Change.<br />
Per quanto riguarda, invece, le strategie <strong>di</strong> risposta<br />
corrispondenti alle RS e ai PP non sono state adottate con larga<br />
frequenza da nessuno dei due gruppi.<br />
3.6 Discussione e Conclusioni Esperimento.<br />
Dalla somministrazione <strong>di</strong> questi due task sperimentali, si può<br />
concludere che anche i soggetti non udenti, complessivamente,<br />
producono la RO con meno frequenza rispetto alla POR.<br />
Dal confronto tra gruppo sperimentale e gruppo <strong>di</strong> controllo è<br />
emerso che il primo gruppo ha prodotto una percentuale<br />
maggiore <strong>di</strong> RO rispetto al secondo gruppo in tutte e quattro le<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task, eccetto che per la<br />
con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e Soggetto [- animato] del Verb-<br />
Change, dove il gruppo sperimentale ha prodotto l’11% <strong>di</strong> RO,<br />
mentre il gruppo <strong>di</strong> controllo ha prodotto il 22% <strong>di</strong> RO.<br />
Inoltre, abbiamo osservato come il numero <strong>di</strong> produzioni<br />
corrispondenti alle RO sia maggiore quando il soggetto della<br />
relativa è animato.<br />
Inoltre, dalla comparazione che abbiamo effettuato con<br />
Belletti & Chesi (2011) è emerso che in quasi tutte le<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo ha<br />
prodotto più RO, in particolar modo RO con soggetto preverbale,<br />
soprattutto nel task del Verb-Change, probabilmente,<br />
- 35 -
perché, il metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale da noi<br />
utilizzato ne facilita la produzione. Tuttavia, anche se il metodo<br />
<strong>di</strong> somministrazione sperimentale può agevolarne la<br />
produzione, la percentuale delle RO prodotte dal nostro gruppo<br />
sperimentale è quasi sempre maggiore della percentuale <strong>di</strong> RO<br />
prodotta dal gruppo <strong>di</strong> controllo. A nostro parere è questo il<br />
dato più interessante, in quanto <strong>di</strong>mostra che le RO, a<br />
prescindere dal metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale, sono<br />
più prodotte dai soggetti non udenti. Questo risultato è<br />
ulteriormente rafforzato dal fatto che i soggetti appartenenti al<br />
gruppo sperimentale sono la metà dei soggetti appartenenti al<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
Il caso <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o è comunque interessante, in quanto ci <strong>di</strong>ce<br />
che le strategie <strong>di</strong> risposte adottate da ciascun soggetto non<br />
udente non sono solo legate alla sor<strong>di</strong>tà, bensì anche alla<br />
modalità <strong>di</strong> accesso alla lingua orale. Questo rimane un<br />
problema aperto, in quanto non abbiamo chiesto ai singoli<br />
soggetti <strong>di</strong> parlarci delle con<strong>di</strong>zioni tramite le quali hanno avuto<br />
accesso alla lingua orale; ci siamo solo limitati a domandare<br />
quando è avvenuta la protesizzazione.<br />
Pertanto, sarebbe estremamente interessante testare un gruppo<br />
sperimentale più ampio e qualora ci fossero più casi come<br />
Clau<strong>di</strong>o, verificarne, a quel punto, le con<strong>di</strong>zioni tramite le quali<br />
i soggetti hanno avuto accesso alla lingua orale. Anche questa<br />
resta una questione aperta.<br />
Concludendo, i dati ottenuti, dalla somministrazione<br />
sperimentale <strong>di</strong> entrambi i task, sono perfettamente in linea con<br />
la teoria proposta da Friedmann, Belletti & Rizzi (2009), che<br />
esplica la ragione per cui una RO risulta essere più complicata<br />
per la computazione sintattica rispetto ad una POR; <strong>di</strong>fficoltà<br />
che abbiamo riscontrato nei soggetti non udenti, così come nei<br />
soggetti udenti.<br />
5 RS, RO e POR nel parlato spontaneo del gruppo<br />
sperimentale: un piccolo corpus<br />
5.1 Registrazioni.<br />
Oltre alla somministrazione dei due task sperimentali,<br />
abbiamo ritenuto opportuno effettuare delle registrazioni <strong>di</strong><br />
parlato spontaneo con i soggetti non udenti da noi testati, per<br />
- 36 -
poter ricercare la frequenza con la quale le frasi relative<br />
vengono da loro prodotte in sede non sperimentale.<br />
Pertanto, per ogni soggetto abbiamo qualche minuto <strong>di</strong><br />
conversazione registrata e successivamente trascritta.<br />
Infine, abbiamo ritenuto opportuno confrontare le occorrenze<br />
delle frasi relative calcolate nel nostro piccolo corpus, con<br />
quelle calcolate nei tre corpora analizzati da Belletti & Chesi<br />
(2011), così da osservarne le <strong>di</strong>fferenze e le uguaglianze.<br />
Nella tabella che segue si riportano le durate delle<br />
registrazioni effettuate con i soggetti non udenti che hanno<br />
svolto l’esperimento.<br />
Tabella N°10:<br />
Registrazioni<br />
SOGGETTO DATA DURATA<br />
Francesco 12 Giugno 2012 22,21 minuti<br />
Beatrice 4 Giugno 2012 22,17 minuti<br />
Beatrice 14 Giugno 2012 5,58 minuti<br />
Melissa 14 Giugno 2012 8,5 minuti<br />
Dario 9 Ottobre 2012 33,46 minuti<br />
Melissa 12 Ottobre 2012 37,32 minuti<br />
Rebecca 18 Ottobre 2012 5, 27 minuti<br />
Alberto 18 Ottobre 2012 4,28 minuti<br />
Clau<strong>di</strong>o 28 Novembre 2012 16,33 minuti<br />
Il totale corrisponde a 155,12 minuti <strong>di</strong> conversazione<br />
registrata e successivamente trascritta.<br />
Il passo successivo è stato calcolare la frequenza delle<br />
occorrenze delle frasi relative attestate nelle conversazioni<br />
registrate. Questo sarà l’oggetto del seguente sottoparagrafo.<br />
5.1.1 Occorrenze delle frasi relative.<br />
La tabella che segue riporta i dati relativi al numero <strong>di</strong> parole<br />
<strong>di</strong> cui il corpus è composto, il totale delle frasi presenti in esso,<br />
le occorrenze del “che” e quante <strong>di</strong> queste introducono una<br />
frase relativa.<br />
Tabella N°11:<br />
Parole <strong>di</strong> cui il corpus è composto, frasi presenti nel corpus,<br />
occorrenze “che” e frasi relative.<br />
- 37 -
TOT<br />
Parole<br />
Frasi<br />
%<br />
8.553 1.256<br />
(100%)<br />
Occorrenze “che”<br />
%<br />
136<br />
(10%)<br />
- 38 -<br />
Frasi Relative<br />
%<br />
61<br />
(5%)<br />
Come si evince dalla tabella N°11 su un totale <strong>di</strong> 8.553<br />
parole, le frasi prodotte sono 1.256 (100%), le frasi in cui è<br />
presente il complementatore “che” sono 136 (10% su 1.256), e<br />
<strong>di</strong> queste 136 occorrenze del complementatore “che”, solo 61<br />
(5% su 1.256) introducono una frase relativa. Pertanto, le<br />
occorrenze delle frasi relative sono estremamente basse se<br />
confrontate con il numero <strong>di</strong> tutte le frasi <strong>di</strong> cui il corpus è<br />
composto.<br />
Nelle seguenti tabelle riporteremo il numero delle frasi<br />
relative, esplicitando quante <strong>di</strong> esse sono oggetto e soggetto.<br />
Tabella N°12:<br />
Totale frasi relative<br />
Numero parole TOT frasi relative RS RO<br />
8.553 61 (100%) 40 (66%) 21 (34%)<br />
Come si evince dalla tabella appena riportata su un totale <strong>di</strong><br />
8.553 parole, le occorrenze delle frasi relative sono 61 (100%),<br />
<strong>di</strong> cui, 40 (66%) RS, e 21 (34%) RO. Pertanto, le occorrenze<br />
delle RS sono maggiori rispetto alle occorrenze delle RO.<br />
Questo era un risultato atteso, in quanto le RS, come<br />
precedentemente <strong>di</strong>scusso, non presentando il fattore<br />
intervenienza, non caratterizzano alcun problema per la<br />
computazione sintattica e pertanto sono largamente prodotte sia<br />
dai soggetti non udenti che dai soggetti udenti 1 .<br />
Inoltre, anche se l’esperimento da noi condotto non<br />
prevedeva un task per la produzione delle RS, il fatto che esse<br />
siano attestate con più frequenza rispetto alle RO nel parlato<br />
spontaneo della maggior parte dei soggetti sperimentali,<br />
garantisce che, qualora avessimo presentato uno specifico task,<br />
le avrebbero prodotte senza <strong>di</strong>fficoltà. Infatti, alcuni<br />
esperimenti condotti in precedenza hanno <strong>di</strong>mostrato che la RS<br />
è largamente prodotta anche dai parlanti non udenti. (Volpato,<br />
2010; Friedmann et al. 2008).<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Cfr. § 5.2.
Tuttavia, poiché nel precedente paragrafo abbiamo posto<br />
particolare attenzione alla produzione, in sede sperimentale,<br />
delle RO e alla loro tipologia, è ora interessante osservare quale<br />
siano le tipologie delle RO prodotte dai parlanti durante una<br />
conversazione; la tabella che segue ne riporta le tipologie con le<br />
rispettive percentuali.<br />
Tabella N°13:<br />
Tipologia RO prodotte dai soggetti non udenti.<br />
Tipologia RO Numero (%)<br />
RO S-V 1 (5%)<br />
RO V-S 0 (0%)<br />
RO Pr.Re 0 (0%)<br />
RO pro S 17 (81%)<br />
RO pro Espr. S 2 (9%)<br />
R in<strong>di</strong>rette 1 (5%)<br />
RO TOT 21 (100%)<br />
Come si evince chiaramente dalla tabella N°13, le RO<br />
prodotte più frequentemente dai parlanti sono le RO con<br />
interveniente un pronome (90%), che in genere non è espresso<br />
(81%) eccetto che in due casi (9%), ad esempio:<br />
la risposta che tu dai (Dario, REG: 9<br />
Ottobre 2012);<br />
quello che _ ho preparato (Melissa,<br />
REG: 12 Ottobre 2012).<br />
Non meraviglia che la maggior parte delle RO prodotte siano<br />
<strong>di</strong> questa tipologia, in quanto la computazione <strong>di</strong> questa<br />
struttura sintattica è più semplice poiché non presenta il fattore<br />
intervenienza 1 . Infatti,<br />
il bambino che la mamma lava __<br />
R+NP NP NP<br />
il bambino che lei lava __<br />
R+NP pro NP<br />
il primo caso è un caso <strong>di</strong> inclusione e il secondo caso è un caso<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sgiunzione (Starke, 2001, Friedamann et al; 2009;), ed è<br />
coerente con l’idea che non rappresenta nessun problema per la<br />
computazione sintattica, in quanto i tratti morfosintattici<br />
dell’elemento target X e dell’elemento interveniente Z sono<br />
<strong>di</strong>fferenti; il primo è portatore del tratto pro e il secondo è<br />
portatore del tratto lessicale.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Infatti, come già <strong>di</strong>scusso in Friedamann, Belletti e Rizzi (2009) le RO meglio<br />
comprese dai bambini sono le RO con interveniente un pronome, in quanto l’elemento<br />
target e l’elemento interveniente hanno tratti morfosintattici <strong>di</strong>fferenti.<br />
- 39 -
Dunque, la RO maggiormente prodotta dai soggetti<br />
sperimentali durante le conversazioni è la RO con interveniente<br />
un pronome, principalmente nullo. Infatti, i soggetti hanno<br />
prodotto l’81% <strong>di</strong> RO con pronome nullo come interveniente, il<br />
9% <strong>di</strong> RO con pronome espresso come interveniente, il 5% <strong>di</strong><br />
RO in<strong>di</strong>rette e il 5% <strong>di</strong> RO con soggetto pre-verbale; nessuna<br />
RO con pronome resuntivo e con soggetto post-verbale è stata<br />
prodotta.<br />
5.1.2 Discussione Risultati.<br />
Da questa analisi effettuata sul nostro piccolo corpus<br />
possiamo concludere che le frasi relative sono delle strutture<br />
sintattiche attestate nel parlato spontaneo dei soggetti<br />
sperimentali, o almeno nella maggior parte <strong>di</strong> questi, anche se<br />
molto poche se confrontate con il totale delle frasi presenti nel<br />
corpus.<br />
Tuttavia, le RO maggiormente prodotte dai parlanti sono le<br />
RO con pronome come interveniente, in quanto essendo<br />
<strong>di</strong>fferenti i tratti morfosintattici relativi all’elemento target X e<br />
all’elemento interveniente Z, la produzione da parte dei parlanti<br />
ne risulterà meno complessa.<br />
Inoltre, in sede sperimentale abbiamo osservato che la<br />
strategia maggiormente adottata dai soggetti per evitare la<br />
produzione <strong>di</strong> una RO con gap, è l’adozione <strong>di</strong> una POR.<br />
Pertanto abbiamo ritenuto opportuno anche calcolare le<br />
occorrenze delle POR attestate nelle registrazioni.<br />
Tabella N°14:<br />
Registrazione totale: Frasi relative + POR.<br />
Numero parole TOT frasi rel+POR RS RO POR<br />
8.553 61 + 2 (100%) 40 (64%) 21 (33%) 2 (3%)<br />
Come si evince dalla tabella le POR prodotte sono 2, pari al<br />
3% dei casi, una percentuale scarsissima se confrontata con<br />
quella corrispondente alle RS e RO.<br />
Inoltre, le POR sono state tutte e due prodotte da Clau<strong>di</strong>o e<br />
sono <strong>di</strong> seguito riportate:<br />
1. 1 POR ridotta con by-phrase: un corso tenuto da un<br />
professore;<br />
2. 1 POR non ridotta con by-phrase: una compagnia che,<br />
però, è seguita da un regista;<br />
- 40 -
Questo dato <strong>di</strong>mostra che, nonostante le POR possano essere<br />
largamente prodotte e utilizzate in sede sperimentale,<br />
soprattutto da Clau<strong>di</strong>o, ai fini <strong>di</strong> evitare la produzione delle RO<br />
da parte dei soggetti non udenti, nel parlato spontaneo sono<br />
attestate con scarsissima frequenza.<br />
Confrontiamo, ora, i nostri risultati con quelli ottenuti da<br />
un’analisi molto più ampia eseguita da Belletti & Chesi (2011)<br />
5.2 Comparazione con Belletti & Chesi (2011).<br />
Belletti & Chesi nel lavoro del 2011, oltre a testare la<br />
produzione delle frasi RO, hanno compiuto una ricerca su<br />
alcuni corpora, il cui scopo era calcolare la frequenza con la<br />
quale le frasi relative fossero attestate nel parlato spontaneo dei<br />
soggetti normo-dotati.<br />
I corpora da loro utilizzati per estrapolare le produzioni<br />
spontanee riguardanti le frasi relative sono riportati nella tabella<br />
che segue.<br />
Tabella N°15:<br />
Corpora utilizzati da Belletti & Chesi (2011).<br />
Come si evince dalla tabella i corpora analizzati sono tre:<br />
CHILDES 1 , dal quale sono stati estrapolati 132 file<br />
riguardanti 9 bambini;<br />
SUT (<strong>Siena</strong> University Treebank), dal quale sono stati<br />
estrapolati 29 file riguardanti delle e<strong>di</strong>zioni speciali <strong>di</strong><br />
telegiornali, che contengono un italiano semplificato<br />
adattabile per una trasduzione in LIS;<br />
CIT (Corpus Italiano Televisivo) dal quale sono stati<br />
estrapolati 7 files riguardanti dei programmi televisivi,<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Sarà <strong>di</strong>viso CHI A e CHI C; relativamente produzioni adulte e produzioni bambini.<br />
- 41 -
come ad esempio delle e<strong>di</strong>zioni nazionali <strong>di</strong> talk show,<br />
standard news, programmi commerciali ecc.<br />
Nella tabella che segue è riportato il numero delle occorrenze<br />
delle frasi relative riscontrate nei corpora analizzati.<br />
Tabella N°16:<br />
Errore. Non è stata trovata alcuna voce dell'in<strong>di</strong>ce delle<br />
figure.Macrosud<strong>di</strong>visione delle frasi relative.<br />
Come si evince dalla tabella appena riportata, il numero delle<br />
occorrenze riguardanti le RS è maggiore rispetto alle<br />
occorrenze riguardanti le RO e le relative in<strong>di</strong>rette (IOR) 1 .<br />
Inoltre, osservando con maggiore attenzione, si nota che nei<br />
corpora CIT e CHI A si ha un numero nettamente più elevato<br />
<strong>di</strong> produzioni riguardanti le frasi relative, rispetto ai corpora<br />
SUT e CHI C 2 . La scarsa frequenza <strong>di</strong> frasi relative attestata in<br />
SUT viene spiegata dal fatto che il corpus in questione contiene<br />
un italiano semplificato adattabile per una traduzione in LIS, e<br />
quin<strong>di</strong> un italiano più semplice nel quale le produzioni <strong>di</strong> frasi<br />
relative sono ridotte al minimo.<br />
Pertanto, il numero maggiore <strong>di</strong> frasi relative prodotte è<br />
quello corrispondente alle RS. Tuttavia, è interessante osservare<br />
quali siano invece, le tipologie delle RO attestate nei tre<br />
corpora; <strong>di</strong> seguito la tabella.<br />
Tabella N°17:<br />
Tipologia <strong>di</strong> soggetto presente nelle RO (pro V = soggetto<br />
nullo; SV = soggetto lessicale pre-verbale; VS = soggetti<br />
lessicale post-verbale).<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Frase relativa con l’oggetto in<strong>di</strong>retto.<br />
2 Non è sorprendente poiché i bambini hanno un’età superiore ai 3; 4 <strong>di</strong> vita.<br />
- 42 -
Come si evince dalla tabella N°17, nei corpora CIT e CHI A i<br />
soggetti mostrano una chiara preferenza nel produrre delle RO<br />
con soggetto nullo, mentre in SUT questa struttura sintattica è<br />
usata solo marginalmente. I bambini appartenenti al corpus<br />
CHI C mostrano, invece, una chiara preferenza nel produrre<br />
delle RO con soggetto post-verbale, struttura che, in ogni caso,<br />
non risulta essere assente nei tre rimanenti corpora.<br />
Pertanto, così come nel nostro piccolo corpus, la RO<br />
maggiormente prodotta dai parlanti è la RO con interveniente<br />
un pronome.<br />
Successivamente, sono state osservate quante delle RS sono<br />
state espresse alla voce passiva POR; i risultati sono riportati<br />
nella tabella N°18 sottostante.<br />
Tabella N°18:<br />
Macrosud<strong>di</strong>visione delle frasi relative, e <strong>di</strong>visione tra RS<br />
espresse alla voce attiva e RS espresse alla voce passiva (POR)<br />
Come mostrano i dati riportati nella tabella N°18, le POR<br />
risultano essere quasi assenti nel parlato spontaneo degli adulti,<br />
e completamente assenti nel parlato spontaneo dei bambini.<br />
Tuttavia, il dato riguardante i bambini non è sorprendente,<br />
poiché, come già accennato, il passivo è una struttura acquisita<br />
tar<strong>di</strong>vamente; a sorprendere, invece, è il dato relativo agli<br />
adulti, in quanto sono da loro largamente prodotte in sede<br />
sperimentale, e scarsamente attestate nel proprio parlato<br />
spontaneo.<br />
Inoltre, al conteggio del totale riguardante le frasi relative,<br />
sono state aggiunte tutte le POR ridotte presenti nei corpora<br />
analizzati; ciò nonostante, il risultato non cambia notevolmente<br />
come mostrano i dati riportati nella tabella N°19.<br />
Tabella N°19:<br />
Macrosud<strong>di</strong>visione delle RS scisse alla voce attiva e passiva,<br />
più tutte le POR presenti nei corpora.<br />
- 43 -
Come si evince dalla tabella soprastante, nei corpora CIT e<br />
CHI A le POR sono quantitativamente meno prodotte rispetto<br />
alle RO, mentre nei corpora SUT e CHI C le POR risultano<br />
essere maggiormente prodotte rispetto alle RO. Pertanto, la<br />
produzione relativa a questa struttura sintattica è<br />
quantitativamente scarsa. Questo risultato è emerso sia dai tre<br />
corpora analizzati da Belletti & Chesi (2011) che dal nostro<br />
piccolo corpus.<br />
5.3 Discussione e Conclusioni Corpus.<br />
Dall’analisi del nostro piccolo corpus e dalla comparazione<br />
che abbiamo effettuato con i risultati ottenuti da Belletti &<br />
Chesi (2011), possiamo concludere che le frasi relative sono<br />
attestate nel parlato spontaneo dei soggetti sia udenti che non;<br />
la frase relativa prodotta maggiormente è la RS.<br />
Per quanto riguarda, invece, la RO, la tipologia che i parlanti<br />
sor<strong>di</strong> così come quelli udenti producono con maggiore<br />
frequenza è la RO che ha come interveniente un pronome, che<br />
tipicamente non è espresso, in quanto non rappresenta un<br />
problema per la computazione sintattica. La RO meno prodotta<br />
spontaneamente dai soggetti sia udenti che non udenti è la RO<br />
con gap che, come abbiamo potuto osservare, è attestata con<br />
scarsissima frequenza nei corpora analizzati.<br />
Le POR, invece, sono attestate con scarsissima frequenza sia<br />
nel nostro corpus che nei tre corpora analizzati da Belletti &<br />
Chesi (2011). Questo risultato è in netto contrasto con quelli<br />
riscontrati da alcuni esperimenti condotti in precedenza<br />
(Belletti & Contemori, 2010; Contemori & Belletti,<br />
forthcoming), in quanto la strategia maggiormente adottata dai<br />
soggetti sperimentali è l’uso <strong>di</strong> una struttura passiva.<br />
Concludendo, i risultati ottenuti dal nostro piccolo corpus<br />
sono in linea con i risultati ottenuti dall’analisi dei tre corpora<br />
condotta da Belletti & Chesi (2011), in quanto per entrambi è<br />
- 44 -
isultato che, la RO maggiormente prodotta è quella con<br />
soggetto nullo e le POR sono prodotte con scarsa frequenza.<br />
Tuttavia, è opportuno sottolineare che se i risultati ottenuti dal<br />
corpus relativo ai soggetti non udenti sono simili a quelli dei<br />
soggetti normo-udenti, i dati ottenuti in sede sperimentale non<br />
lo sono, in quanto i soggetti non-udenti hanno prodotto sempre<br />
una percentuale maggiore <strong>di</strong> RO, fatta eccezione per Clau<strong>di</strong>o 1 ,<br />
in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task,<br />
mentre i soggetti normo-udenti hanno prodotto sempre una<br />
percentuale maggiore <strong>di</strong> POR, in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni<br />
sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task.<br />
Conclusioni Generali.<br />
Come abbiamo potuto osservare il parlato dei soggetti non<br />
udenti è estremamente <strong>di</strong>fferente, questo è emerso sia dalla<br />
somministrazione sperimentale, che dall’analisi del nostro<br />
piccolo corpus.<br />
Dall’analisi del corpus è emerso che la frase relativa è<br />
prodotta con scarsissima frequenza se confrontata con il totale<br />
delle frasi in esso attestate. Ancor meno frequenti sono le<br />
produzioni relative alle POR, che in sede sperimentale sono le<br />
strategie maggiormente adottate. Pertanto, i dati ottenuti dal<br />
nostro corpus sono in linea con quelli ottenuti dall’analisi dei<br />
tre corpora, riguardanti il parlato spontaneo <strong>di</strong> soggetti normoudenti,<br />
condotta da Belletti & Chesi (2011).<br />
Dalla somministrazione sperimentale, è emerso che, nel<br />
complesso, la strategia adottata con più frequenza è l’uso <strong>di</strong> una<br />
POR, in quasi tutte le con<strong>di</strong>zioni sperimentali dei due task.<br />
Questo si è verificato sia per il gruppo sperimentale che per il<br />
gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
Per quanto riguarda la produzione delle RO in entrambi i<br />
task, è emerso che, nel Subject-Change il numero maggiore <strong>di</strong><br />
produzioni si ha nella con<strong>di</strong>zione in cui sia il Soggetto che la<br />
Testa della frase relativa sono entrambi animati, mentre nel<br />
Verb-Change il numero maggiore <strong>di</strong> produzioni si ha nelle due<br />
con<strong>di</strong>zioni in cui il Soggetto della frase relativa è animato.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Si comporta come un normo-udente, in quanto ha prodotto delle POR in tutte le<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali, eccetto che per un PP nella con<strong>di</strong>zione Testa [- animata] e<br />
Soggetto [- animato] del Subject-Change.<br />
- 45 -
Anche questo fenomeno si è verificato sia per il gruppo<br />
sperimentale che per il gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />
Per cui, anche se la manipolazione del tratto relativo<br />
all’animatezza non gioca alcun ruolo fondamentale nel rendere<br />
maggiormente accessibile la produzione delle RO da parte dei<br />
soggetti sia udenti che non udenti, probabilmente le con<strong>di</strong>zioni<br />
sperimentali sopra citate sono più idonee alla produzione <strong>di</strong> una<br />
RO.<br />
Si sottolinea che, generalmente, la RO è prodotta in<br />
percentuale maggiore dai soggetti non udenti, in quasi tutte e<br />
quattro le con<strong>di</strong>zioni sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task, questo a<br />
nostro parere è il dato più interessante 1 .<br />
Concludendo, il gruppo sperimentale, complessivamente, ha<br />
maggiormente adottato l’uso <strong>di</strong> una POR. Tuttavia, abbiamo<br />
osservato come Clau<strong>di</strong>o abbia notevolmente contribuito sulla<br />
percentuale ad essa relativa, infatti, qualora non avesse preso<br />
parte all’esperimento, le POR non sarebbero risultate le<br />
strategie <strong>di</strong> risposta maggiormente adottate in tutte le<br />
con<strong>di</strong>zioni sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task. Infatti, per quanto<br />
riguarda il Subject-Change la POR non sarebbe mai stata la<br />
strategia <strong>di</strong> risposta maggiormente adottata in nessuna delle<br />
quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali, e per quanto riguarda il Verb-<br />
Change lo sarebbe stata solo nelle con<strong>di</strong>zioni in cui il Soggetto<br />
della frase relativa non è animato, ossia Testa [- animata] e<br />
Soggetto [- animato], e Testa [+ animata] e Soggetto [-<br />
animato].<br />
Da qui, abbiamo pensato che sarebbe particolarmente<br />
interessante testare un gruppo più ampio <strong>di</strong> soggetti non udenti,<br />
e qualora ci fossero più casi come Clau<strong>di</strong>o, il cui parlato è<br />
paragonabile a quello <strong>di</strong> un adulto normo-udente, valutarne le<br />
con<strong>di</strong>zioni tramite le quali i soggetti hanno avuto accesso alla<br />
lingua orale.<br />
Sono proprio le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> modalità <strong>di</strong> accesso alla lingua<br />
orale che fanno sì che il soggetto raggiunga un ottimo livello<br />
linguistico.<br />
Bibliografia.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Infatti, i soggetti non udenti per quanto riguarda il proprio parlato spontaneo si<br />
comportano come i soggetti normo-udenti, mentre in sede sperimentale non avviene<br />
questa similitu<strong>di</strong>ne, in quanto producono più RO rispetto ai normo-udenti.<br />
- 46 -
Adani, F., van der Lely, H.K.J., Forgiani, M., Guasti, M.T.<br />
(2010). Grammatical feature <strong>di</strong>ssimilarities make relative<br />
clauses easier: a comprehension study with Italian children,<br />
Lingua, M.T.<br />
Balboni, G. C. (2000). Anatomia Umana, Vol. 3, Milano, E<strong>di</strong>-<br />
Ermes, pp. 471-516.<br />
Belletti, A. (2009). Notes on the Passive Object Relatives, to<br />
appear in P. Svenonius, eds., Functional structure from Top to<br />
Toe, Oxford University Press.<br />
Belletti, A. & Chesi, C. (2011). Relative Clauses from the<br />
input: syntactic consideration on a corpus based analysis of<br />
Italian, CISCL Working Press, vol 4, University of <strong>Siena</strong>.<br />
Belletti, A. & Contemori, C. (2010). Intervention and<br />
Attraction. On the production of Subject and Object Relatives<br />
by Italian (young) children and adults. In Costa, J., Castro, A.,<br />
Lobo, M., Pratas, F., eds., Language Acquisition and<br />
Development, 3 Procee<strong>di</strong>ngs of Gala 2009, UK, CSP,<br />
Cambridge, pp. 39-52.<br />
Belletti, A. & Rizzi, L. (2010). Ways of avoi<strong>di</strong>ng interventions:<br />
some thoughts on the development of object relatives, passive<br />
and control, to appear in Berwick, R. & Piattelli Palmarini, M.,<br />
eds., Rich grammars from a poor input, Oxford University<br />
Press.<br />
Benjafield, J.G. (1999). Psicologia dei processi cognitivi,<br />
Bologna, Il Mulino, pp. 11-55; 229-260.<br />
Bergamasco, B. & Mutani, R. (2007). La neurologia <strong>di</strong><br />
Bergamini, Torino, E<strong>di</strong>zioni Libreria Cortino, pp. 71.81.<br />
Bianchi, V. (2012). Semantica. Dalle parole alle frasi, Roma,<br />
Carocci, pp. 180-184.<br />
Caselli, M. C., Maragna, S., Pagliari Rampelli, L., Volterra, V.<br />
(1994). Linguaggio e sor<strong>di</strong>tà, Firenze, La Nuova Italia, pp. 163-<br />
242.<br />
Collins, C. (2005). A Smuggling approach to the passive in<br />
English, Syntax, 8 (2), pp. 81-120.<br />
Chesi, C. (2006). Il linguaggio verbale non standard dei<br />
bambini sor<strong>di</strong>. Univ. Romane.<br />
Contemori, C. & Belletti, A. (under submission). Relative and<br />
Passive Object Relatives in Italian speaking children and<br />
adults: Intervention in production and comprehension, ms.,<br />
CISCL Working Paper, University of <strong>Siena</strong>.<br />
- 47 -
De Vincenzi. M. (1991). Syntactic Parsing Strategies in Italian,<br />
The Nerthrlands: Kluwer, Dordrecht.<br />
Favilla, E. M. (2002). Neuroimmagini e compiti linguistici in<br />
soggetti sor<strong>di</strong>, In (a cura <strong>di</strong>) Favilla, E., Comunicazione e<br />
sor<strong>di</strong>tà, Atti, Pisa, E<strong>di</strong>zioni Plus, pp. 67-78.<br />
Franchi, E. & Musola, D. (2010). La logogenia come strumento<br />
<strong>di</strong> indagine dell’autonomia linguistica dei sor<strong>di</strong> in italiano:<br />
metodo e primi risultati. In (a cura <strong>di</strong>) Franchi, E. & Musola,<br />
D., Acquisizione dell’italiano e sor<strong>di</strong>tà, in Dipartimento <strong>di</strong><br />
Scienze del linguaggio/Atti, Venezia, Libreria e<strong>di</strong>trice<br />
Cafoscarina, vol. 11, pp. 47-69.<br />
Friedmann, N., Szterman, R., Haddad-Hanna, M. (2010). The<br />
comprehension of relatives clauses and Wh question in Hebrew<br />
and Palestinian Arabic Hearing impairment. In Costa, J.;<br />
Castro, A., Lobo, M., Pratas, F., eds., Language Acquisition<br />
and Development, Generative Approaches to Language<br />
Acquisition, UK, CSP, Cambridge, pp. 157-169.<br />
Friedmann, N., Novogrodsky, R., Sterman, R., Peminger, O.<br />
(2008). Resumptive pronouns as last resort when the movement<br />
is impaired: Relative Clause in hearing impairment. In Armon-<br />
Lotem, Sharon, Gabi Danon ans Susan Rothstein, eds.,<br />
Currentlssues in Generative Hebrew Linguistics, pp. 267-290.<br />
Guasti, M. T. (2007). L’acquisizione del linguaggio.<br />
Un’introduzione. Milano, Cortina.<br />
Haegeman, L. (2000). Manuale <strong>di</strong> Grammatica Generativa.<br />
Milano, Hoepli, [trad. AA. VV., a cura <strong>di</strong>, Adriana Belletti, Ed.<br />
Or. Introduction to Government and Bin<strong>di</strong>ng Theory, UK,<br />
Blackwell Publishers].<br />
Maragna, S. (2000). La sor<strong>di</strong>tà. <strong>Educazione</strong>, scuola, lavora e<br />
integrazione sociale. Presentazione <strong>di</strong> Ida Collu e Virginia<br />
Volterra. Milano, Hoepli.<br />
Massoni, P., Maragna, S. (2009). Manuale <strong>di</strong> logope<strong>di</strong>a per<br />
bambini sor<strong>di</strong>. Con esemplificazioni <strong>di</strong> unità logope<strong>di</strong>che,<br />
esercitazioni ed itinerari metodologici. Franco Angeli E<strong>di</strong>tore,<br />
Milano.<br />
Nicastro, R. (2002). Aspetti logope<strong>di</strong>ci nella riabilitazione del<br />
linguaggio nel bambino sordo profondo. In (a cura <strong>di</strong>) Favilla,<br />
E., Comunicazione e sor<strong>di</strong>tà, Atti, Pisa, E<strong>di</strong>zioni Plus, pp. 97-<br />
100.<br />
- 48 -
Novogrosky, R. & Friedmann, N. (2006). The production of<br />
relatives clauses in SLI. A window to the nature of the<br />
impairment, Advances in Speech-Language Pathology 8 (4),<br />
pp. 364-375.<br />
Radelli, B. (1998). Nicola vuole le virgole, Padova, Decibel,<br />
Zanichelli.<br />
Radelli, B. (2010). La lingua orale e la lingua letta e scritta. In<br />
(a cura <strong>di</strong>) Franchi, E., Musola, D., Acquisizione dell’italiano e<br />
sor<strong>di</strong>tà, in Dipartimento <strong>di</strong> Scienze del linguaggio/Atti,<br />
Venezia, Libreria e<strong>di</strong>trice Cafoscarina, vol. 11, pp. 23-45.<br />
Rizzi, L. (1990). Relativazed Minimality. Press Cambridge<br />
Mass, MIT.<br />
Rizzi, L. (2004). Locality and left periphery. In A., Belletti,<br />
eds., Structures and Beyond: The cartography of syntactic<br />
structures, vol 3, Oxford University Press, pp. 223-251.<br />
Russo Cardona, T., Volterra, V. (2007). Le lingue dei segni.<br />
Storia semiotica, Roma, Carocci.<br />
Strake, M. (2001). Move Dissolves into a Merge: A Teory of<br />
locality. Doctoral Diss., University of Geneva.<br />
Utzeri, I. (2007). The production and acquisition of subject and<br />
object relative clauses in Italian, Nazan Linguistic Special<br />
Issie3, pp. 283-314.<br />
Volpato, F. (2010). The acquisition of relative clauses and phifeatures:<br />
evidence from hearing-impaired populations. Tesi <strong>di</strong><br />
dottorato, Università Ca’Foscari, Venezia.<br />
Volpato, F. (2010). Valutazione delle abilità linguistiche dei<br />
bambini con impianto cocleare: uno strumento per indagare la<br />
produzione delle frasi relative. In (a cura <strong>di</strong>) Franchi, E.,<br />
Musola, D., Acquisizione dell’italiano e sor<strong>di</strong>tà, in<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze del linguaggio/Atti, Venezia, Libreria<br />
e<strong>di</strong>trice Cafoscarina, vol. 11, pp. 71-85.<br />
Volterra, V. (2004). La lingua dei segni Italiana. La<br />
comunicazione visivo-gestuale dei sor<strong>di</strong>, Bologna, Il Mulino.<br />
- 49 -
l’educazione dei sor<strong>di</strong>, 1 – 2013 (Serie IX - CXIV)<br />
UN SORDO ILLUSTRE:<br />
LUDWIG VAN BEETHOVEN<br />
Da una ricerca del Prof. Enrico Cimino<br />
Premessa<br />
Ludwig Van Beethoven, universalmente conosciuto come<br />
uno dei maggiori musicisti europei, in particolare per le sue<br />
nove sinfonie, viene spesso ricordato, specialmente nella<br />
comunità dei sor<strong>di</strong>, per la sua sor<strong>di</strong>tà, e spesso si nota una<br />
tendenza ad esagerare il significato simbolico che in tale ambito<br />
può assumere questa circostanza, fino a percepirlo quasi come<br />
un sordo tra i sor<strong>di</strong>, «uno dei nostri», con tutte le caratteristiche<br />
e i problemi che appartengono ai sor<strong>di</strong> dalla nascita o dai primi<br />
anni <strong>di</strong> vita, prima dell’acquisizione del linguaggio<br />
fonoarticolato, tramite il normale circuito o feedback u<strong>di</strong>tovoce.<br />
In qualche occasione, pur rendendosi conto che<br />
Beethoven è <strong>di</strong>ventato sordo in età adulta, si arriva a pensare e<br />
ad affermare che «quando lui era udente scriveva una musica<br />
me<strong>di</strong>ocre, ma una volta <strong>di</strong>ventato sordo ha scritto musica<br />
bellissima». 1<br />
In effetti, Beethoven, che era nato a Bonn nel 1870, avvertì<br />
nel 1796, all’età <strong>di</strong> 26 anni, i primi sintomi della sor<strong>di</strong>tà<br />
progressiva da cui fu afflitto, ma <strong>di</strong>ventò veramente sordo solo<br />
nel 1822, all’età <strong>di</strong> 52 anni, quando non fu in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere<br />
l’orchestra nelle prove del Fidelio, che aveva composto prima<br />
del 1805.<br />
Testimonianze atten<strong>di</strong>bili riferiscono che fino al 1805,<br />
quando aveva trentacinque anni, Beethoven era in grado <strong>di</strong><br />
giu<strong>di</strong>care severamente le più piccole sfumature nell’esecuzione<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Cfr. l’intervento <strong>di</strong> Anna Folchi alla Tavola Rotonda tenuta il 22 giugno a <strong>Siena</strong>, in<br />
occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita <strong>di</strong> Tommaso .Pendola (Cfr.<br />
L’educazione dei sor<strong>di</strong>, 3/2000, p. 218).<br />
- 50 -<br />
Stu<strong>di</strong> e ricerche
delle sue opere, e fino al 1813, all’età <strong>di</strong> 43 anni, esercitava<br />
ancora in pubblico la funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore. Dal 1816, all’età <strong>di</strong><br />
46 anni, dovette fare uso <strong>di</strong> un cornetto acustico, e dopo il<br />
1822, l’orecchio destro era praticamente privo della facoltà <strong>di</strong><br />
u<strong>di</strong>re. 1<br />
Quin<strong>di</strong>, la sor<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Beethoven ebbe una progressione lenta e<br />
fino a circa cinquanta anni non gli impedì <strong>di</strong> scrivere e <strong>di</strong><br />
contribuire in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi all’esecuzione delle sue opere.<br />
Certamente egli soffrì atrocemente della sua sor<strong>di</strong>tà,<br />
specialmente in momenti della sua vita in cui si aggiungevano<br />
altre avversità, come l’amore infelice per Elena Guicciar<strong>di</strong>, a<br />
cui de<strong>di</strong>cò nel 1802 la sonata detta al Chiaro <strong>di</strong> luna, lo stesso<br />
anno in cui scrisse l’accorato Testamento <strong>di</strong> Heilingenstadt, nel<br />
quale non manca però la speranza <strong>di</strong> una guarigione, che<br />
«richiederà lunghissimo tempo o è forse impossibile».<br />
È da notare che Beethoven consultò i me<strong>di</strong>ci più in vista del<br />
tempo, <strong>di</strong>ventandone amico e confidando loro, in lettere <strong>di</strong><br />
indubbio valore umano, ma anche letterario, la sua angoscia,<br />
specialmente per la sua posizione sociale <strong>di</strong> musicista, che non<br />
gli consentiva <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, come chiunque altro: «Parlate più forte,<br />
gridate , perché io sono sordo».<br />
Comunque, ancora per venti anni, fino al 1822, la sor<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
Beethoven si aggravò, ma non gli impedì <strong>di</strong> comporre e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rigere l’orchestra.<br />
Proprio nel 1796, quando avvertì i primi sintomi della sor<strong>di</strong>tà,<br />
ma non poteva ancora <strong>di</strong>rsi sordo, Beethoven teneva concerti a<br />
Norimberga, Praga, Dresda e a Berlino. Intanto, incominciava<br />
ad eseguire e a pubblicare le sue opere giovanili, come le<br />
Variazioni del 1782 e una raccolta <strong>di</strong> sei quartetti nel 1800,<br />
composizioni per la morte dell’imperatore Giuseppe II e per<br />
l’ascesa al trono del suo successore (1790), sonate per<br />
pianoforte (1792) e per violino e pianoforte (1798), tra cui la<br />
Patetica e, più tar<strong>di</strong>, l’Aurora (1803-1804) e al Chiaro <strong>di</strong> luna<br />
(1801). Era pertanto un giovane concertista-compositore che<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Queste notizie sono riprese dalle numerose biografie esistenti, tra cui quella <strong>di</strong> Romain<br />
Rolland, e più in particolare dal volume <strong>di</strong> Guglielmo Bilancioni, <strong>di</strong> cui è riportato qui <strong>di</strong><br />
seguito il quarto capitolo. Le opere da noi citate non esauriscono la ricca produzione<br />
artistica <strong>di</strong> Beethoven.<br />
- 51 -
non <strong>di</strong>mostrò, comunque, una precocità artistica come quella,<br />
per esempio, <strong>di</strong> Mozart.<br />
Tra l’altro, nel 1789 si era anche iscritto ai corsi <strong>di</strong> Filosofia<br />
dell’Università.<br />
Dal 1800 al 1812 scriverà le prime otto sinfonie, il Coriolano<br />
(1807) e l’Egmont (1810), opere della sua maturità artistica e<br />
non della sua sor<strong>di</strong>tà, che si aggraverà più tar<strong>di</strong>, come si è detto,<br />
con la per<strong>di</strong>ta completa dell’orecchio destro, nel 1822. Solo la<br />
Nona sinfonia fu eseguita dopo questa data fatale, nel 1823-<br />
1824, ma Beethoven aveva cominciato a scriverla nel 1816.<br />
Su queste basi storiche, è <strong>di</strong>fficile giu<strong>di</strong>care «me<strong>di</strong>ocri» le<br />
prime opere, e affermare che le altre costituiscono «una musica<br />
bellissima». È <strong>di</strong>fficile fare una simile <strong>di</strong>stinzione, senza<br />
l’ausilio <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi critici motivati, che non trovano certamente<br />
riscontri nella musicologia de<strong>di</strong>cata a Beethoven. Appare più<br />
ragionevole pensare allo sviluppo <strong>di</strong> un’arte che muove dalle<br />
sue prime manifestazioni giovanili verso una maturità che sarà<br />
raggiunta verso i trenta anni, prescindendo dalla sor<strong>di</strong>tà<br />
incipiente. Personalmente può piacermi una sinfonia anziché<br />
un’altra, ma non posso <strong>di</strong>re che l’una è me<strong>di</strong>ocre e l’altra<br />
bellissima, e imporre ad altri questo giu<strong>di</strong>zio a <strong>di</strong>r poco<br />
arbitrario. E con quale sensibilità musicale è lecito supportare<br />
giu<strong>di</strong>zi così apo<strong>di</strong>ttici?<br />
La vita <strong>di</strong> Beethoven, oltre il valore innegabile della sua<br />
musica, che ci annovera, per inciso, tra i più convinti<br />
estimatori, può effettivamente <strong>di</strong>ventare un esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità<br />
umana <strong>di</strong> fronte alle avversità più crudeli, <strong>di</strong> fronte alla malattia<br />
che colpisce, tra le capacità fisiche <strong>di</strong> un uomo, proprio quelle<br />
che sono alla base del suo lavoro, dei suoi ideali, della sua arte.<br />
Ma si tratta <strong>di</strong> un esempio valido più per chi <strong>di</strong>venta sordo da<br />
adulto che per chi è nato sordo o lo è <strong>di</strong>ventato precocemente.<br />
Beethoven aveva stu<strong>di</strong>ato la musica fin da piccolo, tenuto<br />
conto che il nonno fu maestro <strong>di</strong> cappella a Bonn. Anche il<br />
padre, benché descritto come non eccessivamente intelligente e<br />
de<strong>di</strong>to al vino, era un tenore. Il piccolo Beethoven faceva parte<br />
a un<strong>di</strong>ci anni dell’orchestra del teatro locale, a tre<strong>di</strong>ci era<br />
organista. Sembra che avesse iniziato, costretto dal padre, a<br />
stu<strong>di</strong>are musica e a suonare il clavicembalo fin dall’età <strong>di</strong><br />
- 52 -
quattro anni. Quando a ventisei anni, non ancora sordo, fu<br />
colpito dai primi sintomi della sor<strong>di</strong>tà, doveva avere una<br />
perfetta conoscenza della musica e, d’altra parte, aveva già<br />
scritto le opere che abbiamo citato, che non sono certamente<br />
«me<strong>di</strong>ocri», se furono apprezzate e gli <strong>di</strong>edero la fama. Si<br />
trovava nella con<strong>di</strong>zione, su un piano <strong>di</strong>verso, <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>venta<br />
sordo avendo già una perfetta conoscenza della lingua parlata e<br />
scritta e continua a parlare e a scrivere con efficacia e proprietà.<br />
Certamente Beethoven ebbe il merito <strong>di</strong> non arrendersi alla<br />
sua malattia, anche se ne soffrì fino a pensare al suici<strong>di</strong>o, e<br />
rimane un esempio per tutti, sor<strong>di</strong> e udenti, anche se aveva a<br />
suo favore il genio della sua arte, che pochi possono vantare in<br />
eguale misura.<br />
Le biografie scritte su Beethoven sono molte, come abbiamo<br />
già notato, e ne abbiamo contato più <strong>di</strong> venti, <strong>di</strong> autori <strong>di</strong>versi,<br />
senza pretesa <strong>di</strong> completezza. Qui <strong>di</strong> seguito riportiamo il<br />
quarto capitolo dell’opera <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co otologo, Guglielmo<br />
Bilancioni, pubblicata a Roma nel 1921, riconoscendo il rigore<br />
scientifico delle sue argomentazioni, sulla base delle<br />
conoscenze me<strong>di</strong>che del suo tempo, e per l’umanità con cui<br />
affronta la vicenda umana <strong>di</strong> Beethoven, basandosi su fonti <strong>di</strong><br />
prima mano, come le sue lettere.<br />
Il Bilancini era nato a Rimini nel 1881 e si laureò in<br />
Me<strong>di</strong>cina nel 1905 nell’Università <strong>di</strong> Roma. Fu Assistente e poi<br />
Aiuto presso la Clinica Otorinolaringoiatria dell’Università <strong>di</strong><br />
Roma; conseguì la Libera docenza nel 1911 e fu Professore<br />
or<strong>di</strong>nario presso l’Università <strong>di</strong> Pisa dal 1924. Nel 1925 fondò<br />
una prestigiosa rivista <strong>di</strong> otorinolaringoiatria: Il Valsalva. Fu<br />
autore <strong>di</strong> molte pubblicazioni scientifiche e <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse opere <strong>di</strong><br />
carattere più generale, come: La voce parlata e cantata<br />
normale e patologica (Pozzi, Roma, 1926) e:<br />
Otorinolaringoiatria <strong>di</strong> pace e <strong>di</strong> guerra (Mariotti, Pisa, 1926).<br />
- 53 -
LA SORDITÀ DI BEETHOVEN<br />
Considerazioni <strong>di</strong> un otologo 1<br />
<strong>di</strong> Gugliemo Bilancini<br />
Beethoven giungeva a levare già grande fama <strong>di</strong> sé, quando si<br />
vide funestata l'esistenza dalla più grande sventura che possa<br />
colpire un musicista. A 26 anni cominciava a perdere l’u<strong>di</strong>to.<br />
Era come il veleno versato nella coppa del trionfatore.<br />
Leggendo i suoi biografi, v’ha chi l’attribuisce a<br />
un’imprudenza commessa dal maestro, il quale, tornando un<br />
giorno a casa, si sarebbe esposto per più ore a una corrente <strong>di</strong><br />
aria, mentre, intento al lavoro, non avvertiva il profuso sudore<br />
ond’era ma<strong>di</strong>do. Altri - e fra questi il dott. Breuning - ne<br />
vedono la causa nelle frequenti docce gelate che Beethoven<br />
soleva fare, quando per il prolungato lavoro mentale «si<br />
sentiva» il sangue alla testa; correva allora nel suo gabinetto, si<br />
spogliava e si versava sul capo torrenti d'acqua fredda,<br />
suscitando le rimostranze degli inquilini sottostanti, che<br />
vedevano cadere l'acqua dal soffitto.<br />
Altri hanno pensato che la sor<strong>di</strong>tà fosse un postumo lontano<br />
della varicella <strong>di</strong> cui aveva sofferto nell'infanzia e che aveva<br />
lasciato traccia sul suo volto.<br />
Ma nessuno sospetta che la ipoacusia progressiva sia<br />
espressione <strong>di</strong> una tara organica, ere<strong>di</strong>taria, un equivalente della<br />
etisia della madre e del fratello, un derivato dell'alcoolismo<br />
paterno. Ostmann ha scritto sulla <strong>di</strong>sposizione alle malattie<br />
d’orecchio dei fanciulli che hanno parenti prossimi<br />
tubercolotici e il Gradenigo ha stu<strong>di</strong>ato l’otosclerosi nei suoi<br />
rapporti con la tubercolosi.<br />
È ben vero che Beethoven in alcune sue lettere accenna al<br />
continuo stato catarrale e pure fa menzione <strong>di</strong> qualche <strong>di</strong>sturbo<br />
al naso:<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Il volume fu pubblicato presso l’E<strong>di</strong>tore A. F. Formiggini, Roma, 1921.<br />
- 54 -
«io sono arrivato qui con un catarro e un raffreddore, l’uno e<br />
l'altro poco propizi per me, poiché il mio stato consueto è già<br />
catarroso e io temo che questo non rompa ben presto il filo<br />
della vita, o, ciò che sarebbe ancor peggio, non lo venga<br />
rodendo a poco a poco...» (a Carlo, Baden, 16 agosto 1823).<br />
«quanto a me, i miei occhi non sono ancora completamente<br />
ristabilito e sono venuto qui con uno stomaco in <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne e un<br />
terribile catarro, il primo dovuto a questa maledetta governante,<br />
il secondo a questa cuoca, che io avevo già licenziata...» (a<br />
Giovanni, Baden, 19 agosto 1823).<br />
È molto probabile che il continuo stato catarrale rinofaringeo<br />
abbia aggravato per tubam le con<strong>di</strong>zioni dell'orecchio, portando<br />
a un’otite scleromatosa grave e precoce. Ma il germe<br />
dell'otosclerosi che gli recò la sor<strong>di</strong>tà è oggi considerato <strong>di</strong><br />
natura costituzionale e nella compagine ere<strong>di</strong>taria dobbiamo<br />
trovare l’agente primo della terribile malattia.<br />
Dai ritratti si può escludere che il Beethoven fosse stato da<br />
ragazzo un adenoideo; ma certo fu soggetto alle malattie<br />
dell’apparato respiratorio. Le fosse nasali e la faringe superiore,<br />
per <strong>di</strong>fettosa ventilazione e per alterata secrezione <strong>di</strong> muco<br />
germicida, non offrirono più sufficiente <strong>di</strong>fesa ai microrganismi<br />
patogeni; <strong>di</strong>vennero facile preda <strong>di</strong> tutti gli agenti infettivi e<br />
delle flogosi consecutive, che hanno tendenza a <strong>di</strong>ffondersi<br />
all’orecchio, alla laringe e a tutto l'albero respiratorio.<br />
Ostruzione e infezione agiscono ad un tempo. Dagli orifizi<br />
della tuba eustachiana, l'infezione sale alla cassa timpanica,<br />
determinando dei versamenti e poi delle otiti me<strong>di</strong>e ripetute.<br />
Così l'insufficienza nasale e la sor<strong>di</strong>tà camminano <strong>di</strong> pari passo.<br />
Dal carteggio <strong>di</strong> Beethoven, noi conosciamo molti me<strong>di</strong>ci che<br />
egli consultò per la sua otopatia. Anzitutto era ricorso una delle<br />
personalità me<strong>di</strong>che più stimate del tempo, .Johann Peter Frank<br />
(19 marzo 1745 - 24 aprile 1821), <strong>di</strong> Rotalben nel Baden,<br />
celebre me<strong>di</strong>co e scrittore, nel 1785-95 professore a Pavia, ove<br />
<strong>di</strong>rigeva gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina, poi all'ospedale generale <strong>di</strong><br />
Vienna, ove morì. Lasciò De curan<strong>di</strong>s hominum morbis<br />
epitome (1792-1821). Un illustre successore ne ha<br />
solennemente compen<strong>di</strong>ati i meriti chiamandolo «emporium<br />
- 55 -
eru<strong>di</strong>tionis, artis salutiferae sidus, quem nominasse .jam<br />
laudasse est» .<br />
Poi ricorse a Vering seniore, me<strong>di</strong>co militare capo,<br />
consigliere imperiale, ungherese <strong>di</strong> nascita. Gherard Ritter von<br />
Vering (nato il 28 gennaio 1775, morto a Vienna, ove era sino<br />
dal 1775, 1'8 novembre 1823) pubblicò una monografia, Ueber<br />
<strong>di</strong>e eindringenden Brustwunder (Wien, 1801).<br />
Suo figlio Joseph Ritter von Vering nel 1816 si laureò in<br />
Vienna con la tesi De convalescentia eiutsque cura, e <strong>di</strong>venne<br />
me<strong>di</strong>co pratico <strong>di</strong> buon nome. Nel 1830 pubblicò degli<br />
Aphorismen über Orenkrankheiten.<br />
Più che in qualità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co, troviamo nella vita <strong>di</strong> Beethoven<br />
il nome <strong>di</strong> Wegeler come quello <strong>di</strong> un amico affezionato e <strong>di</strong> un<br />
confidente sicuro.<br />
Francesco Gherardo Wegeler, nato a 9 Bonn il 22 agosto<br />
1765, stu<strong>di</strong>ò in quella Università nella quale, nel 1786, con la<br />
<strong>di</strong>ssertaziolle De respiratione et usu pulmonum, si addottorò in<br />
me<strong>di</strong>cina. Al tempo dell' invasione dei Francesi, nel 1794, si<br />
recò a Vienna, dove si occupò in particolar modo <strong>di</strong> lavori<br />
letterari. Nel 1796 fece ritorno a Bonn e quivi <strong>di</strong>venne uno dei<br />
me<strong>di</strong>ci più ricercati; ma nel 1807 venne chiamato a Coblenza<br />
dal Prefetto Lezay-Marnesia e nominato membro del giurì<br />
me<strong>di</strong>co del Dipartimento del Reno e della Mosa, e relatore<br />
presso la stessa amministrazione e professore <strong>di</strong> ostetricia. Nel<br />
1816, dal governo prussiano ebbe la qualità <strong>di</strong> Reg. Med. Rath e<br />
nel 1825 venne nominato Consigliere me<strong>di</strong>co intimo, carica che<br />
tenne fino alla fine della sua vita, avvenuta il 17 maggio 1848.<br />
Joham Adam Schmidt, <strong>di</strong> Vienna, me<strong>di</strong>co militare e<br />
consigliere aulico, professore <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina all’Accademia<br />
Giuseppina, oculista, autore <strong>di</strong> opere classiche. Ricordata una<br />
sua Biblioteca oftalmologica pubblicata con Hilmy dal 1801 al<br />
]805. Era nato il 17 settembre 1759 ad Aub, nel Wurtzbourg;<br />
morì il 19 febbraio 1809.<br />
Dopo la morte dello Schmidt, <strong>di</strong>venne me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Beethoven<br />
un italiano, il Malfatti, il quale deve molta della sua notorietà<br />
all'assistenza prestata, insieme col Wawruch, nell' ultima<br />
malattia che condusse il grande compositore al sepolcro.<br />
- 56 -
Giovanni M. Malfatti, nobile <strong>di</strong> Monteregio, nato a Lucca nel<br />
1776 (o 1775), stu<strong>di</strong>ò a Bologna e nel 1795 venne chiamato a<br />
Vienna da Peter Franck ed ivi, con lo stesso, conseguì il<br />
dottorato. Fu per sette anni me<strong>di</strong>co secondario nell'ospedale<br />
pubblico. Scrisse in giornali tedeschi e italiani, p. e.<br />
nell'Hufeland (1802-3), alcuni stu<strong>di</strong>i su <strong>di</strong> una epidemia <strong>di</strong><br />
febbre scarlattina maligna nelle puerpere; sulla formazione del<br />
vaccino dal vaiuolo dei cavalli, ecc.; e tradusse il lavoro <strong>di</strong><br />
Antonio Scarpa: Sui pie<strong>di</strong> storpi congeniti (Vienna, 1805).<br />
Dopo che P. Franck, nel 1804, lasciò Vienna, egli abbandonò<br />
il suo posto nell'ospedale civico, de<strong>di</strong>candosi alla pratica<br />
privata e scrisse: Concezione (Entwurf) <strong>di</strong> una patogenesi<br />
dell’evoluzione e rivoluzione della vita (Vienna 1809} e un<br />
anno più tar<strong>di</strong> <strong>di</strong>venne me<strong>di</strong>co particolare dell’arciduchessa<br />
Beatrice d’Este, posto in cui rimase fino alla sua morte.<br />
Durante il congresso <strong>di</strong> Vienna riscosse molte attestazioni <strong>di</strong><br />
stima dai principi stranieri e dai <strong>di</strong>plomatici. In premio<br />
dell’interessamento avuto per far prosperare la stazione <strong>di</strong><br />
Bagni <strong>di</strong> Ischl, ne ricevette la citta<strong>di</strong>nanza onoraria e nel 1837<br />
con tale titolo gli venne conferita la nobiltà. Nel medesimo<br />
anno la sue cure furono rivolte alla fondazione della I. R.<br />
Società dei me<strong>di</strong>ci in Vienna, <strong>di</strong> cui fu il primo presidente.<br />
Ritiratosi dalla pratica, scrisse su L’anarchia e la gerarchia<br />
della scienza con particolare relazione alla me<strong>di</strong>cina (Lipsia,<br />
1845).<br />
Tentò nuovi meto<strong>di</strong> terapeutici, come quello accennato in una<br />
sua nota: Guarigione della cataratta grigia ottenuta con un<br />
nuovo metodo <strong>di</strong> cura esterno (Vienna, 1847). Si occupò anche<br />
<strong>di</strong> agricoltura, scrisse un trattato sulla malattia delle patate, ecc.<br />
Nel 1850 ebbe la ventura <strong>di</strong> festeggiare il suo 50° anno <strong>di</strong><br />
dottorato e morì, il 12 o 15 settembre 1859, nella sua villa<br />
presso Hitzing, dopo avere filosoficamente trascorsi gli ultimi<br />
anni della sua vita.<br />
Andrea Ignazio Wawruch, nato nel 1782 a Niemczig in<br />
Moravia, fu assistente alla clinica me<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> Vienna, e alla fine<br />
del 1810 anche supplente <strong>di</strong> patologia e materia me<strong>di</strong>ca. Si<br />
addottorò in Vienna nel 1812 e nello stesso anno <strong>di</strong>venne<br />
professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> patologia e materia me<strong>di</strong>ca<br />
- 57 -
all’Università. In questo tempo scrisse: De priscorum Graeciae<br />
ac Latii me<strong>di</strong>corum stu<strong>di</strong>o restaurando oratio (Vienna 1808), e<br />
alcuni anni dopo: Tentamen inaugur. philologico-mee<strong>di</strong>cum<br />
sistens antiquitates typhi contagiosi (ìb., 1812).<br />
Chiamato nel 1819 quale professore alla Clinica chirurgica<br />
dell’Università <strong>di</strong> Vienna, <strong>di</strong>venne egli stesso un me<strong>di</strong>co<br />
rinomato, che si fece particolarmente conoscere per le sue<br />
osservazioni sulla malattia indotta dalla tenia e il suo<br />
trattamento. A tale riguardo egli scrisse: Observationes clinicae<br />
Taeniam concernentes (Vienna, 1833) e la monografia pratica<br />
sulla malattia della tenia illustrata da 206 casi (Vienna 1744),<br />
che venne pubblicata <strong>di</strong>eci anni più tar<strong>di</strong>, dopo la sua morte.<br />
L'apparire del colera indusse Wawruch a uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> storia<br />
della me<strong>di</strong>cina: Disquisitio me<strong>di</strong>ca cholerae cujus mentio in<br />
sacri biblii occurrrit (ìb. 1832), e precisamente al c. XI dei<br />
Numeri. Di lui si trovano inoltre degli scritti nella Oesterr. med.<br />
Jahr., alla redazione della quale egli apparteneva dal 1832.<br />
Morì il 20 marzo 1842.<br />
Beethoven ebbe adunque <strong>di</strong>mestichezza con molti me<strong>di</strong>ci del<br />
suo tempo; così portò simpatia al Dott, Braunhoffer, della cui<br />
opera me<strong>di</strong>ca non rimane traccia durevole.<br />
Questi doveva essere persona dotata <strong>di</strong> molto buon senso e<br />
alieno dalle infatuazioni della me<strong>di</strong>cina dell’epoca sua.<br />
In un quaderno dell'aprile 1825 Braunhoffer scrive: «Io tratto<br />
la malattia secondo le leggi <strong>di</strong> natura e non secondo le teorie<br />
immaginarie».<br />
A lui, il Beethoven in<strong>di</strong>rizzò questa curiosa lettera, che si<br />
chiude con un motivo musicale con questo canone: «dottore<br />
sbarra la porta alla morte; anche le note ci sottraggono al<br />
dolore»:<br />
- 58 -
Al dottore Braunhoffer<br />
Mio egregio amico!<br />
- Dottore: Come va, paziente?<br />
- 59 -<br />
Baden. il 13 maggio 1825.<br />
- Paziente: Non stiamo in una pelle troppo buona, sempre<br />
molto debole, delle eruttazioni ecc. Io credo che mi occorra una<br />
me<strong>di</strong>cina più energica, che pertanto non riscal<strong>di</strong>; io dovrei già<br />
potere bere del vino bianco nell’acqua! poiché questa birra<br />
mefitica non può che essermi controin<strong>di</strong>cata. Il mio stato<br />
catarroso si manifesta qui nel modo seguente: io sputo del<br />
sangue, probabilmente dai bronchi soltanto; ma più <strong>di</strong> frequente<br />
cola dal naso, come appunto spesso in questo inverno. Non v’è<br />
dubbio che il mio stomaco sia terribilmente indebolito e in<br />
genere tutto il mio fisico. Poiché io conosco il mio organismo,<br />
le mie forze non potranno restaurarsi che lentamente da loro<br />
stesse.<br />
Dottore: Io lo aiuterò; io sarò in qualche caso Browniano 1 ,<br />
talora Stolliano 2 .<br />
Paziente: Sarebbe bene che io potessi <strong>di</strong> nuovo sedere al mio<br />
tavolo dotato <strong>di</strong> un po’ <strong>di</strong> forza. Pensateci. Finis.<br />
BEETHOVEN<br />
È notevole il fatto che nelle lettere dell'ultimo periodo della<br />
vita, Beethoven ha una istintiva ritrosia <strong>di</strong> parlare della sua<br />
sor<strong>di</strong>tà e dei <strong>di</strong>sturbi auricolari; ancor qui non ve ne è alcun<br />
cenno. Mentre si intrattiene con molti dei suoi corrispondenti<br />
delle sofferenze viscerali, dopo le prime confessioni a Wegeler<br />
, all’Amenda e alla Brentano, non -parla mai più, si può <strong>di</strong>re,<br />
del proprio orecchio.<br />
Dopo aver conosciuto le principali figure dei me<strong>di</strong>ci che<br />
incontreremo a consulto del grande maestro, è tempo <strong>di</strong><br />
scorrere i documenti relativi alla sua progressiva sor<strong>di</strong>tà.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 John Brown (1785-88), me<strong>di</strong>co inglese, allievo <strong>di</strong> Cullen, presidente della Società<br />
Me<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo (1776), quin<strong>di</strong> professore a Londra (1786)...<br />
2 Max Stoll (12 ott. 1742-22 marzo 1788) da gesuita <strong>di</strong>venne professore <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina<br />
pratica a Vienna nel 1776, con grande successo...
Alcuni ci sono offerti da testimonianze <strong>di</strong> amici e <strong>di</strong><br />
contemporanei; altre - e le più importanti e commoventi - dalle<br />
lettere stesse dì Beethoven, specie nelle prime <strong>di</strong>rette con un<br />
trepido senso dì pudore all'amico Wegeler, e dal famoso<br />
testamento.<br />
La sor<strong>di</strong>tà crebbe in guisa che Beethoven non percepiva più i<br />
toni me<strong>di</strong>. Narra Ries che, durante una passeggiata col<br />
musicista, avendo richiamata l'attenzione <strong>di</strong> questi su una<br />
canzone boschereccia, suonata da un pastore con molta grazia<br />
su un flauto <strong>di</strong> sambuco, il maestro porgendo l'orecchio rimase<br />
a lungo in quell'atteggiamento, senza nulla u<strong>di</strong>re. A questa<br />
prova crudele, egli stette tutto il giorno taciturno e malinconico.<br />
Nel 1805 Beethoven era in grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care severamente<br />
anche delle più lievi sfumature nelle ripetizioni della sua opera.<br />
Nel 1807, 1809 e 1813 concertò personalmente varie sue<br />
composizioni. Nel 1814 eseguì il trio in re, ultima volta che<br />
suonò in pubblico. Dal 1816 al 1818 dovette far uso del corno<br />
acustico e degli strumenti <strong>di</strong> protesi costrutti appositamente per<br />
il maestro dal Mälzel, conservati nel museo beethoveniano <strong>di</strong><br />
Bonn: e che noi qui riproduciamo.<br />
I primi tentativi <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> «cornetti acustici» risalgono<br />
ad epoca lontana; ma la loro insufficienza pratica e la bizzarria<br />
delle loro forme stimolò a ricercarne dei meno imperfetti.<br />
L'eru<strong>di</strong>to Claude Comiers parla <strong>di</strong> un istrumento ideato<br />
dall'abate Jean Hautefeuille (1647 -1724) che ingran<strong>di</strong>va<br />
mirabilmente i suoni. Samuel Morland costruì il suo porta-voce<br />
- detto tromba stentorea o tuba stentorophonica - che gli servì<br />
per importanti esperienze <strong>di</strong> acumetria. Nuck (1692) dà la<br />
descrizione <strong>di</strong> un apparecchio ritorto come un corno da caccia.<br />
Nel Traité des sens (1740) e nel libro de<strong>di</strong>cato alla Théorie de<br />
l'ouïe, il Lecat dà vari modelli <strong>di</strong> cornetti acustici, a conchiglia<br />
o a scafo oppure a duplice imbuto. Ancor quelli adottati da<br />
Beethoven hanno varia forma, sia <strong>di</strong> semplice tromba, sia con<br />
l'aggiunta <strong>di</strong> una cassa <strong>di</strong> risonanza; alcuni recano una fascia<br />
metallica per poterli fissare sul capo, a guisa delle moderne<br />
cuffie da telefonista.<br />
Joham Nepomak Mälzel, <strong>di</strong> Ratisbona {1772-1838), era un<br />
geniale meccanico della Corte <strong>di</strong> Vienna, inventore <strong>di</strong> una<br />
grande scatola musicale - la Panharmonica - per il quale<br />
- 60 -
Beethoven aveva composto la sua Vittoria <strong>di</strong> Wellington o<br />
Battaglia <strong>di</strong> .Vittoria, eseguita per la prima volta nel 1813 e che<br />
fra loro <strong>di</strong>venne fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>atribe e <strong>di</strong> malumori. 1<br />
Il Mälzel inventò pure il metronomo, che ha conservato il suo<br />
nome. Nel 1826 emigrò a Boston e morì a La Guayra nel<br />
Venezuela.<br />
La durezza <strong>di</strong> u<strong>di</strong>to andava così minacciosamente<br />
progredendo, che tutta la vita <strong>di</strong> relazione e artistica <strong>di</strong><br />
Beethoven ne risentì un doloroso contraccolpo.<br />
In occasione dell'apertura del teatro Josephstadt tentò <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rigere in persona un concerto, ma l'esecuzione fu un <strong>di</strong>sastro.<br />
Un altro tentativo – l’ultimo - fu quello del novembre 1822,<br />
quando volle <strong>di</strong>rigere le prove del Fidelio, ripreso dopo otto<br />
anni d’interruzione, con la famosa artista Wilhelmine<br />
Schroeder nella parte <strong>di</strong> Leonora. Il <strong>di</strong>rettore del teatro <strong>di</strong> Porta<br />
Carinzia offrì a Beethoven la condotta delle prove. Sebbene gli<br />
amici lo <strong>di</strong>ssuadessero, questi accettò.<br />
«L'ouverture in mi maggiore - narra lo Schindler, testimonio<br />
del triste episo<strong>di</strong>o - andò egregiamente, poiché la falange<br />
<strong>di</strong>sciplinata dei musicisti si comportava come un sol uomo,<br />
secondo il suo costume, malgrado le visibili incertezze del<br />
<strong>di</strong>rettore. Ma quando si fu al duetto fra Marcellina e Pasquino<br />
era manifesto che Beethoven non u<strong>di</strong>va affatto quanto avveniva<br />
sulla scena. Ritardava considerevolmente il movimento e,<br />
mentre l'orchestra seguiva la battuta del maestro, i cantanti<br />
procedevano per loro conto. Giunti al punto quando si ode<br />
picchiare all’uscio della prigione, ne seguì una confusione<br />
generale. Il <strong>di</strong>rettore d'orchestra or<strong>di</strong>nario, Umlauf, propose un<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Risale all’incirca al 1814 una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Beethoven in cui, tra l'altro, è<br />
detto: «Poiché Mälzel è un uomo grossolano, senza alcuna educazione, senza<br />
coltura, si può pensare come si sia condotto verso <strong>di</strong> me durante questo tempo e<br />
come mi abbia sempre più in<strong>di</strong>gnato... Il Mälzel mi aveva promesso delle<br />
macchine acustiche. Per incoraggiarlo scrissi la Sinfonia della Vittoria per la sua<br />
panharmonica. I suoi apparecchi furono infine ultimati, ma non si <strong>di</strong>mostrarono<br />
abbastanza pratici per me. Per questa piccola noia, Malzel pensava che dopo aver<br />
composto la Sinfonia della Vittoria per grande orchestra, io lo avrei fatto<br />
proprietario esclusivo <strong>di</strong> questa opera. Concedo che, in riguardo alle macchine<br />
acustiche, io mi senta in qualche modo obbligato; ma ora noi siamo liberi, poiché<br />
a Monaco, con la Battaglia che mi aveva rubato o <strong>di</strong> cui aveva ricostruito i<br />
frammenti, egli ha ricavato almeno 500 fiorini <strong>di</strong> moneta convenzionale...».<br />
- 61 -
momento <strong>di</strong> pausa, senza darne ragione; e dopo alcune parole<br />
scambiate con gli artisti si riprese da capo. Ma appena<br />
incominciò il duetto, la mancanza d’insieme si fece sentire <strong>di</strong><br />
nuovo; ai colpi dati alla porta accadde il medesimo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne,<br />
Occorse una seconda pausa. L’impossibilità <strong>di</strong> continuare sotto<br />
la <strong>di</strong>rezione del compositore era evidente; ma in qual modo<br />
farglielo comprendere? Né l'amministratore Duport, né<br />
l’Umlauf avevano l'animo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rgli: «Ritirati, povero infelice, tu<br />
non puoi più <strong>di</strong>rigere». Intanto Beethoven, inquieto, agitato, si<br />
volgeva ora a dritta, ora a manca, stu<strong>di</strong>andosi <strong>di</strong> leggere<br />
nell’espressione delle varie fisionomie e <strong>di</strong> intendere donde<br />
proveniva l'ostacolo; ma dovunque silenzio, Allora, a un tratto,<br />
mi chiamò in modo imperioso. Quando gli fui vicino mi porse<br />
il suo taccuino e mi fece cenno <strong>di</strong> scrivere. Io tracciai queste<br />
parole: «Vi supplico <strong>di</strong> non proseguire, vi spiegherò a casa il<br />
perché». D’un balzo, saltò nella platea gridandomi: «Usciamo<br />
presto!». Poi, d’un fiato corse a casa sua (posta allora alla<br />
Pfargasse, nel sobborgo <strong>di</strong> Leimgrube). Entrato, si lasciò cadere<br />
inerte sopra una poltrona, coprendosi il viso con ambo le mani<br />
e restando così sino all'ora <strong>di</strong> pranzo. A. tavola non <strong>di</strong>sse<br />
parola, serbando l'espressione del più completo abbattimento e<br />
del più profondo dolore. Quando, dopo pranzo, volli lasciarlo in<br />
libertà, egli mi trattenne, esternandomi il desiderio che non lo<br />
lasciassi sino all'ora del teatro; al momento <strong>di</strong> separarci, mi<br />
pregò d’accompagnarlo dal suo me<strong>di</strong>co, che godeva <strong>di</strong> grande<br />
reputazione per le malattie auricolari.<br />
«In tutto il corso dei miei lunghi rapporti con Beethoven non<br />
trovo un giorno che possa paragonarsi a questo. Quali si fossero<br />
le contrarietà, le sofferenze fisiche e morali che lo avevano<br />
afflitto, esse non lo prostravano che momentaneamente: poco<br />
dopo rialzava il capo, e ritrovando tutta la sua energia e la<br />
consueta fermezza, trionfava dell'avverso fato e rientrava nel<br />
pieno possesso del suo genio.<br />
Questa volta invece era stato ferito sul vivo e sino al giorno<br />
della sua morte visse sotto l’ incubo della terribile scena».<br />
Da quell’epoca l’orecchio destro era perduto quasi<br />
completamente: egli non <strong>di</strong>resse più e il giorno dell’esecuzione<br />
della IX Sinfonia - il 7 maggio 1824, al teatro <strong>di</strong> Porta Carinzia<br />
- all’infelice maestro, che era in orchestra (il programma <strong>di</strong>ceva<br />
- 62 -
«prendendo parte alla <strong>di</strong>rezione del concerto»), bisognò fargli<br />
cenno perché si volgesse a ringraziare il pubblico, il quale, in<br />
pie<strong>di</strong>, applau<strong>di</strong>va entusiasta il compositore.<br />
Sphor racconta <strong>di</strong> aver u<strong>di</strong>to suonare, al piano nel '14, il<br />
maestro alle prove <strong>di</strong> un suo trio (op. 97), in un concerto <strong>di</strong><br />
beneficenza. «Non era invero una cosa piacevole. Il piano era<br />
scordato e Beethoven, che non sentiva più una nota, non ne<br />
pareva punto <strong>di</strong>sturbato. D'altro canto non rimaneva più nulla in<br />
lui <strong>di</strong> quella meravigliosa valentia tanto ammirata e tanto<br />
celebrata. Nel forte l’infelice batteva i tasti con tal violenza che<br />
le corde si spezzavano una dopo l'altra; e nel piano li sfiorava<br />
così leggermente che interi gruppi <strong>di</strong> note gli rimanevano nelle<br />
<strong>di</strong>ta... Io compiansi con tutta l'anima questa immensa sciagura».<br />
Sebbene la dolce arte dei suoni fosse veramente veicolo <strong>di</strong><br />
affettuoso conforto, Beethoven ha <strong>di</strong> fronte all'incombente<br />
terrore della malattia che lo assale dei momenti <strong>di</strong> ribellione e<br />
<strong>di</strong> paura. Dovrà superare molte prove, occorrerà del tempo<br />
perché egli accetti la sciagura con uno spirito <strong>di</strong> rassegnazione<br />
commovente nella sua stoica semplicità.<br />
La semplicità per l’appunto ci fa prova della sua intera<br />
schiettezza: l’essere perituro, schiavo delle esigenze e vittima<br />
dei bisogni <strong>di</strong> un organismo malato, ha una face donde si<br />
irra<strong>di</strong>a una luce ideale; la ingenita influenza fisica, inseguita ed<br />
espulsa con la forza dell’arte, non turberà l'opera del genio, che<br />
pur nel dolore, conserva prontezza estrosa, erompente,<br />
signoreggiata sempre da un nobile intuito e da un severo<br />
miraggio <strong>di</strong> gloria.<br />
Possiamo dal suo epistolario seguire le fasi del suo stato<br />
d’animo. In una lettera, spe<strong>di</strong>ta da Vienna, al dott. Wegeler, 1<br />
Beethoven scrive:<br />
..«Sventuratamente un demone geloso è venuto a turbare la<br />
mia tranquillità, arrecandomi spaventevoli inquietitu<strong>di</strong>ni sulla<br />
mia salute. Da tre anni, infatti, il mio u<strong>di</strong>to è <strong>di</strong>venuto sempre<br />
più debole. La cagione <strong>di</strong> questa infermità. risiede, pare, nel<br />
basso ventre. Vi ricorderete che altre volte già fui soggetto a<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Questa lettera è senza data. Secondo Wegeler e Ries è probabilmente del 25 febbraio<br />
1800.<br />
- 63 -
in<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> queste parti: ma la situazione è molto<br />
peggiorata e da qualche tempo sono travagliato da una continua<br />
<strong>di</strong>arrea. Il dott. Franck ha cercato <strong>di</strong> darmi il tono con pozioni<br />
corroboranti ed ha curato le mie orecchie con olio <strong>di</strong> mandorle;<br />
ma tutto questo non è servito a nulla: la sor<strong>di</strong>tà. non faceva che<br />
progre<strong>di</strong>re e il basso ventre era sempre al medesimo punto.<br />
Questo stato <strong>di</strong> cose si prolungò fino allo scorso autunno e mi<br />
ha gettato più volte in una vera <strong>di</strong>sperazione. Frattanto un<br />
me<strong>di</strong>conzolo dalle lunghe orecchie volle farmi prendere dei<br />
bagni fred<strong>di</strong>; ma persona pratica più giu<strong>di</strong>ziosa, mi consigliò,<br />
invece, <strong>di</strong> prenderli tiepi<strong>di</strong> e <strong>di</strong> acqua del Danubio. La cura fece<br />
miracoli, lo stato del ventre migliorò un poco, ma le mie<br />
orecchie rimasero nello stesso stato, anzi, a <strong>di</strong>r meglio,<br />
<strong>di</strong>vennero ancor più deboli.<br />
Quest'inverno la situazione era in vero deplorevole; soffrivo<br />
<strong>di</strong> coliche orribili e avevo dato in una completa ricaduta.<br />
Rimasi in questo stato fino al giorno in cui andai a trovare<br />
Vering, circa quattro settimane or sono. Ebbi l’idea <strong>di</strong><br />
rivolgermi a lui perché a me sembra che la mia malattia sia<br />
affare <strong>di</strong> chirurgo e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co. D'altronde Vering m’inspirava<br />
fiducia. Infatti, egli riusciva a far quasi cessare questa <strong>di</strong>arrea<br />
insopportabile a mezzo <strong>di</strong> bagni tiepi<strong>di</strong> d’acqua del Danubio,<br />
nei quali mi faceva versare una bottiglia <strong>di</strong> liquore<br />
corroborante. Non mi dette altre me<strong>di</strong>cine, eccetto alcune<br />
pillole per lo stomaco ed una specie <strong>di</strong> the per le orecchie.<br />
Questa cura, (debbo convenirne, mi ha calmato e mi ha<br />
ricostituito; ma le mie orecchie continuavano a rumoreggiare e<br />
a ronzare notte e giorno.<br />
Dopo tutto ciò, vi lascio pensare se io conduca una vita triste<br />
e sciagurata. Da oltre due anni vado schivando ogni sorta <strong>di</strong><br />
riunioni e <strong>di</strong> società, perché mi è impossibile confessare che<br />
sono sordo. Se io esercitassi tutt’altra professione che non<br />
quella del musicista, non esiterei a confessare la mia malattia;<br />
ma col mio mestiere! E poi, che <strong>di</strong>rebbero i numerosi miei<br />
nemici se venissero a conoscere la sventura che mi ha colpito?<br />
«Per darvi un'idea della mia strana sor<strong>di</strong>tà basti <strong>di</strong>rvi che a<br />
teatro sono costretto collocarmi presso l’orchestra se voglio<br />
u<strong>di</strong>re gli artisti; i suoni elevati della voce o degli strumenti mi<br />
sfuggono, dato che m’allontani, anche <strong>di</strong> poco. Molti hanno<br />
- 64 -
tuttavia parlato con me e non si sono accorti <strong>di</strong> nulla:<br />
attribuiscono la cosa alle mie <strong>di</strong>strazioni. Di quei che parlano<br />
piano odo la voce senza capire le parole; quelli che gridano mi<br />
cagionano una sofferenza insopportabile.<br />
«Ciò che dovrà accadere <strong>di</strong> tutto questo, solo il buon Dio lo<br />
sa! Vering mi lascia sperare che la situazione migliorerà, ma<br />
non mi promette una guarigione completa. Mille volte,<br />
pensando alla mia infelicità, ho maledetto la vita. Plutarco mi<br />
ha consolato e mi ha inspirata la rassegnazione. Sono<br />
fermamente risoluto <strong>di</strong> contrapporre alle avversità della sorte<br />
un'anima forte; ma vi sono, decisamente, dei momenti nei quali<br />
io sono l’essere più <strong>di</strong>sgraziato del mondo. Vi supplico <strong>di</strong> non<br />
tra<strong>di</strong>re queste mie confidenze e <strong>di</strong> non farne parola con alcuno,<br />
neppure con Lorchen. 1 Vi confido tutto sotto il suggello del<br />
segreto e vorrei che scriveste a Vering per <strong>di</strong>rgli la vostra<br />
opinione».<br />
Queste lettere del sommo artefice del suono hanno un<br />
interesse che supera i confini delle solite epistole dei gran<strong>di</strong>.<br />
Per gli altri maestri dell'arte, l'epistolario, semplice<br />
manifestazione letteraria, rivela talora particolari tendenze<br />
intime o nascoste dell'autore; e null'altro. Per i musicisti una<br />
lettera è la loro parte <strong>di</strong> umanità che si palesa, è quella parte<br />
mortale dell'infinito spirito immortale che regna nel dominio<br />
dei suoni e che è costretta a percorrere la sua triste via <strong>di</strong><br />
miserie umane, <strong>di</strong> gioie e <strong>di</strong> dolori. Gli artisti del suono vivono<br />
nella regione dell'ignoto, perché la musica appartiene alla<br />
categoria del sublime, perché l'arte che <strong>di</strong>letta senza mai<br />
corrompere è più alta <strong>di</strong> ogni rivelazione, più alta della<br />
saggezza e della filosofia, <strong>di</strong>ce Beethoven.<br />
Quando essi si liberano dalle vertigini dell’inconoscibile<br />
<strong>di</strong>vengono umani e vivono e soffrono e amano come uomini;<br />
ma rimangono partecipi, nella <strong>di</strong>vinità del loro ingegno,<br />
dell'estasi suprema, avendo quasi coscienza dell'infinito. V’è un<br />
raggio <strong>di</strong> quella <strong>di</strong>vinità in tutto ciò che fanno nel giro<br />
dell'esistenza comune, con le loro speranze e con i loro<br />
desideri? Ebbene, nelle lettere, hanno un riflesso i desideri e le<br />
speranze umane degli artefici del suono .<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Diminutivo <strong>di</strong> Eleonora Breuning, moglie <strong>di</strong> Wegeler.<br />
- 65 -
E il 16 novembre 1800 Beethoven scriveva ancora:<br />
«Mio buon Wegeler!<br />
«Io ti ringrazio <strong>di</strong> questa nuova prova della tua sollecitu<strong>di</strong>ne<br />
per me, tanto più che io la merito così poco. Tu vuoi sapere<br />
come sto, ciò <strong>di</strong> cui abbisogno. Benché io parli sempre contro<br />
voglia <strong>di</strong> tale argomento, pure con te lo faccio più volentieri<br />
che con qualunque altro.<br />
«Da alcuni mesi Vering mi fa porre su le due braccia dei<br />
vescicanti composti, come tu sai, <strong>di</strong> una certa corteccia. È una<br />
cura delle più te<strong>di</strong>ose, poiché io sono sempre privato dell’uso<br />
delle mie braccia per molti giorni (fino a che la corteccia non<br />
abbia tirato abbastanza), senza contare le sofferenze; ora, è<br />
vero, non posso negarlo, i rumori auricolari sono un poco più<br />
fievoli che per il passato, specie all'orecchio sinistro, dal quale<br />
appunto si è iniziata la mia malattia, ma l'u<strong>di</strong>to non è <strong>di</strong> certo<br />
ancora migliorato; io non oso decidere se non sia invece<br />
peggiorato».<br />
L'uso dei derivativi, l’applicazione <strong>di</strong> potassa caustica sulla<br />
regione mastoidea, il .setone alla nuca erano <strong>di</strong> pratica comune<br />
nella sor<strong>di</strong>tà; si voleva in tal modo ottenere una suppurazione <strong>di</strong><br />
lunga durata, che mo<strong>di</strong>ficasse lo stato dell'orecchio. Quanto ai<br />
vescicanti sulle braccia : «je ne parle pas de ceux qu'on<br />
applique au bras - scrive l'Itard nel secondo volume del suo<br />
classico trattato (1821, p. 70) - je n'ai jamais vu l'au<strong>di</strong>tion en<br />
être influencée d'une manière notable».<br />
Ripren<strong>di</strong>amo il corso della lettera interrotta :<br />
«Gli intestini vanno meglio; sopratutto quando io uso dei<br />
bagni tiepi<strong>di</strong> quoti<strong>di</strong>ani, me ne trovo bene per 8-10 giorni; ogni<br />
tanto qualche tonico per lo stomaco; ho anche, giusta il tuo<br />
consiglio, cominciato le applicazioni <strong>di</strong> erbe sul ventre. Vering<br />
non vuol sentir parlare <strong>di</strong> docce; ma, in generale, sono molto<br />
poco sod<strong>di</strong>sfatto <strong>di</strong> lui; egli ha troppo poca cura e attenzione<br />
per una tal malattia; se io non andassi da lui - il che posso fare<br />
con grande fatica - io non lo vedrei mai. Che ne pensi <strong>di</strong><br />
Schmidt? lo non cambio volentieri, ma mi sembra che Vering<br />
sia troppo praticante per acquistare molte idee nuove dalla<br />
lettura. Schmidt mi sembra sotto questo aspetto tutt'altro uomo<br />
e forse non sarebbe così negligente.<br />
- 66 -
«Si narrano meraviglie del galvanismo. 1 Quale è la tua<br />
opinione in proposito? Un me<strong>di</strong>co mi ha assicurato che a<br />
Berlino aveva veduto ricuperare l'u<strong>di</strong>to a un fanciullo sordomuto;<br />
un uomo sordo da sette anni sarebbe stato egualmente<br />
guarito, Mi vien detto che Schmidlt stia facendo degli<br />
esperimenti in proposito...».<br />
Pochi forse ricordano che lo stesso Alessandro Volta<br />
partecipò <strong>di</strong> questo entusiasmo; nel Conservatorio delle povere<br />
zitelle <strong>di</strong> Como applicò con pazienza per quin<strong>di</strong>ci giorni<br />
continui l’elettro-motore ad una <strong>di</strong> quelle infelici <strong>di</strong> 15anni,<br />
nata sordomuta, tentando <strong>di</strong> farle riacquistare l'u<strong>di</strong>to.<br />
Egli ha descritto nel Giornale fisico-me<strong>di</strong>co e chimico <strong>di</strong> L.<br />
V. Brugnatelli (XXI, 1802, 100) la cura, la quale consisteva<br />
nell’elettrizzare l’uno e l’altro orecchio, applicando<br />
«alternativamente l’estremità <strong>di</strong> un filo metallico che forma un<br />
bottoncino e che procede dall’estremità positiva dell’apparato,<br />
per un minuto al tragus, per due al meato esterno, e per un altro<br />
minuto <strong>di</strong>etro l’orecchio interno al processo gastroenemio, e<br />
portandovi frequenti scosse me<strong>di</strong>ante il toccamento ad ogni<br />
minuto dell’altra estremità negativa con un cannone metallico<br />
impugnato dalla mano umida sinistra quando si opera<br />
sull’orecchio dritto e viceversa; e ciò quattro volte almeno al<br />
giorno. Ella ha sicuramente acquistato qualche cosa: non<br />
sentiva punto i suoni più forti da nessuno degli orecchi; or sente<br />
i <strong>di</strong>scretamente forti singolarmente dall’orecchio dritto; ma<br />
siamo ben lontani da quella finezza d’u<strong>di</strong>to che si ricerca per<br />
ben sentire la voce umana e <strong>di</strong>stinguere l’articolazione delle<br />
parole come si richiede per imparare a parlare. Che se anche<br />
potessimo giungere fino a questa finezza e perfezione d’u<strong>di</strong>to,<br />
chi sa se e quanto durerà, giacché siamo informati dalle stesse<br />
relazioni delle pro<strong>di</strong>giose cure successe in Germania, che<br />
parecchi sono ricaduti quasi nella primitiva sor<strong>di</strong>tà dopo<br />
qualche tempo; non tutti però; ma degli altri non sappiamo<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Per avere un concetto del fervore degli stu<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci sulle possibili applicazioni <strong>di</strong><br />
questa nuova forza, misteriosa e mirabile, stu<strong>di</strong> che si conducevano in tutta Europa,<br />
riporteremo soltanto alcuni titoli <strong>di</strong> lavori pubblicati tra la fine del secolo XVIII e l'inizio<br />
del XIX, epoca in cui Beethoven scriveva questa lettera.<br />
Qui il Bilancioni cita opere <strong>di</strong> molti autori, Al<strong>di</strong>ni, Birch, Bishoff, Bohadsch e altri, che<br />
tralasciamo, rimandando al testo originale (N.d.R.).<br />
- 67 -
ancora se molti o pochi, o qualcuno dei già sor<strong>di</strong>-muti abbia poi<br />
imparato a parlare: giacché dopo il mese <strong>di</strong> giugno non ho<br />
relazione come sieno andate le cose; e fino allora non potevano<br />
ancora i guariti aver appreso il linguaggio. Mi si <strong>di</strong>ce che anche<br />
a Parigi nell'Istituto dei sor<strong>di</strong> e muti si sieno intraprese da<br />
qualche tempo le esperienze; ma non so con qual modo né con<br />
qual esito. In Germania ove si son fatti i tentativi in tanti<br />
luoghi, da tanti, ed ove si sono pubblicate tante relazioni ed<br />
opere stimabili intorno all'applicazione del Galvanismo, o come<br />
amano meglio <strong>di</strong> chiamarlo, elettricità metallica, si decantano<br />
varie altre guarigioni <strong>di</strong> debilità <strong>di</strong> vista, e fin <strong>di</strong> gotta serena,<br />
<strong>di</strong> membri paralizzati; ma ciò che è curioso è che alcuni oltre<br />
l'u<strong>di</strong>to, hanno acquistato anche il senso dell'odorato, <strong>di</strong> cui<br />
erano affatto privi, e ciò col solo elettrizzare gli orecchi col<br />
metodo in<strong>di</strong>cato. Non è però maraviglia; giacché quasi tutte le<br />
parti interne della testa si risentono da quelle scosse, quasi tutte<br />
vengono invase e attraversate dalla corrente elettrica, ed anche<br />
molte delle parti esterne, come si vede dal convellersi in tutte le<br />
scosse che si danno all'orecchio i muscoli temporali, e i<br />
zigomatici...».<br />
Nella limpida prosa del Volta si è infiltrato il dubbio,<br />
purtroppo giustificato. «Je pourrais confirmer cette inefficacité<br />
du traitement électrique - <strong>di</strong>ce l'Itard (vol. II, p. 72) - non<br />
seulement par mes propres essais, mais en rapportant <strong>di</strong>vers<br />
traitements qu’avaient déjà subis plusieurs personnes qui ont<br />
réclamé mes conseils.<br />
«Je puis <strong>di</strong>re précisément la même chose du galvanisme. Sur<br />
la foi des .journaux anglais et allemands, et particulièrement<br />
d'après le recueil pério<strong>di</strong>que de Hufeland, plusieurs médecins<br />
de Paris (et .je suis de ce nombre) ont soumis la sur<strong>di</strong>té à ce<br />
nouveau mode de traitement, et n'en ont retiré aucun avantage».<br />
Mentre la prima parte <strong>di</strong> questa lettera al Wegeler (16<br />
novembre 1800) è informativa, <strong>di</strong>rei <strong>di</strong> tecnica e <strong>di</strong> nosologia,<br />
la seconda è un’analisi <strong>di</strong> mirabile introspezione, che tratteggia<br />
la psicologia del maestro, ove ha palli<strong>di</strong> riflessi la pena<br />
universale che si risolve nel calvario <strong>di</strong> un solo; il dolore <strong>di</strong> tutti<br />
che làncina un unico cuore che una trama invisibile lega ai<br />
cuori <strong>di</strong> tutti gli infelici, i reietti, i <strong>di</strong>spersi; e sul quale<br />
assommano i tormenti, le sofferenze, le miserie dell'umanità.<br />
- 68 -
Beethoven prosegue:<br />
«Io ora vivo in modo meno ingrato, poiché sto più a contatto<br />
con gli uomini. Tu puoi a pena credere quale vita desolata,<br />
triste, io abbia trascorso da due anni in qua; la debolezza del<br />
mio u<strong>di</strong>to mi è ovunque apparsa come uno spettro ed io fuggivo<br />
gli uomini; era forza apparire misantropo, mentre io lo sono<br />
così poco. Questo mutamento è opera <strong>di</strong> una cara, <strong>di</strong> una<br />
magica fanciulla che io amo e che mi ama; 1 io ho ancora, dopo<br />
due anni, alcuni istanti <strong>di</strong> felicità e per la prima volta sento che<br />
il matrimonio mi potrebbe rendere felice; <strong>di</strong>sgraziatamente essa<br />
non è della mia sfera ed ora io non potrei certo pensare a una<br />
famiglia; per il momento io non posso che bastare a me stesso<br />
con coraggio.<br />
La vita non acquista pregio, se non quando acquista un fine.<br />
È giovinezza, è forza il fare, sempre; e nel fare, senza<br />
aspettazione <strong>di</strong> nulla, trovare tutta la contentezza e la<br />
sod<strong>di</strong>sfazione dell'animo. Ed ecco una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />
indomita volontà:<br />
«Se non fossero state le mie orecchie, da lungo tempo io avrei<br />
percorso la metà del mondo. Per me non è piacere eguale a<br />
quello che mi procura l'esercitare e il produrre nella mia arte.<br />
«Non credo tuttavia che io possa oggi trovare maggior felicità<br />
in mezzo a voi. Felice! come potrei esserlo? Le stesse vostre<br />
sollecitu<strong>di</strong>ni mi riuscirebbero penose. Ad ogni momento<br />
leggerei sul vostro volto l’espressione della compassione, e<br />
l’idea <strong>di</strong> essere un oggetto da destar pietà mi renderebbe il più<br />
sventurato degli uomini. Le belle contrade della mia patria, che<br />
cosa mi hanno riserbato? Nulla all’infuori della speranza <strong>di</strong> uno<br />
stato migliore; esso lo avrei già se non soffrissi <strong>di</strong> questo male.<br />
Oh! se io me ne liberassi, stupirei il mondo! La mia giovinezza.<br />
lo sento, è appena ai suoi inizi; non sono stato sempre un<br />
organismo debole? La forza corporea aumenta in me da qualche<br />
tempo come non mai e con essa le forze del mio spirito. Ogni<br />
giorno io mi avvicino al fine che io sento, ma che non posso<br />
descrivere. Là soltanto il tuo Beethoven potrà vivere. Nessun<br />
riposo! io non ne conosco, oltre il sonno, e tuttavia mi spiace <strong>di</strong><br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Gulietta Guicciar<strong>di</strong>, poi <strong>di</strong>venuta contessa <strong>di</strong> Gallemberg.<br />
- 69 -
dovergli concedere più tempo <strong>di</strong> una volta. Potessi liberarmi<br />
soltanto a metà del mio male: allora, <strong>di</strong>venuto un uomo<br />
completo, maturo, verrei verso <strong>di</strong> voi, rinnovellando gli antichi<br />
sentimenti <strong>di</strong> amicizia».<br />
Con quale sincerità <strong>di</strong> spasimo esprime lo spavento della<br />
propria labilità corporea, il terrore <strong>di</strong> potere sentirsi invecchiare<br />
e fisicamente decadere! Non è il sentimento <strong>di</strong> semplicità<br />
animale, come quella che raggela certi silenzi conviviali <strong>di</strong><br />
Anacreonte; è un senso nel quale entra la coscienza del<br />
sostituirsi della persona fisica transitoria alla personalità<br />
artistica. È il sentire minacciata la propria opera da un pericolo<br />
giacente nella carne. Fra l'arte e la vita circostante, per<br />
Beethoven, non v’è l'in<strong>di</strong>viduo morale fermo proteggente: la<br />
sua arte e il suo «io» pratico si sono confusi e questo sembra<br />
comunicare a quella il senso doloroso della terra, la caducità.<br />
E in un supremo appello <strong>di</strong>sperato, chiude così la lettera al<br />
Wegeler, in un commovente commiato:<br />
«Se noi dobbiamo rivederci voglio almeno apparirti tanto<br />
felice, quanto io possa esserlo quaggiù. Non <strong>di</strong>sgraziato: non<br />
potrei sopportarlo. Voglio afferrare il destino alla gola; per<br />
certo non riuscirà ad abbattermi. Oh! è cosi bello vivere mille<br />
volte la vita! Una vita silenziosa, no, io lo sento, non è fatta per<br />
me...».<br />
Povero Beethoven! Quante illusioni e quali turbamenti non<br />
gli arrecavano le continue oscillazioni della sua cenestesi<br />
turbata <strong>di</strong> sordastro! Esse si traducono nei repentini mutamenti<br />
<strong>di</strong> tono e <strong>di</strong> umore, che in questa lettera sono rivelatori, nei<br />
trapassi sùbiti dalla gioia infantile e luminosa <strong>di</strong> speranza al più<br />
tetro e cupo pessimismo. Unica affermazione salda e recisa<br />
quella della sua ferrea volontà!<br />
Nel 1802 Beethoven, per consiglio dello Schmidt, andò<br />
cercare tranquillità e solitu<strong>di</strong>ne in una casa <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni posta su<br />
<strong>di</strong> un poggio nella. ridente vallata <strong>di</strong> Heiligenstadt, donde si<br />
abbraccia tutta la. valle del Danubio.<br />
In questa casetta scrisse più tar<strong>di</strong> la sinfonia pastorale.<br />
Isolandosi dal mondo, Beethoven <strong>di</strong>ssimulava un’infermità<br />
che lo faceva arrossire e sperava <strong>di</strong> trovare lieve miglioria. Ma<br />
l'eremo non apportò alcun beneficio alla crudele malattia e un<br />
- 70 -
giorno il grande musicista, più prostrato del consueto, scrisse il<br />
famoso testamento, nel quale svela quanta influenza essa abbia<br />
esplicato sul suo carattere.<br />
Per i miei fratelli Carlo 1 ....... Beethoven.<br />
«Voi che mi credete invi<strong>di</strong>oso, intrattabile o misantropo, e<br />
che come tale mi rappresentate, quanto siete ingiusti! Voi non<br />
conoscete la causa segreta per cui vi appaio tale. Sin<br />
dall’infanzia ero incline al sentimento della benevolenza,<br />
provavo anch’io il bisogno <strong>di</strong> fare buone azioni; ma pensate che<br />
da sei anni soffro un male terribile, aggravato dall’ignoranza<br />
dei me<strong>di</strong>ci; che, deluso <strong>di</strong> anno in anno nella speranza d’un<br />
miglioramento sono venuto nella prospettiva <strong>di</strong> essere<br />
incessantemente sotto l'influenza <strong>di</strong> un male duraturo, la cui<br />
guarigione sarà tarda e forse impossibile.<br />
«Pensate che nato con un carattere ardente, impressionabile e<br />
suscettibile a tutti i piaceri che offre la società, io fui costretto a<br />
separarmene sì presto, ad allontanarmi dagli uomini e passare la<br />
mia vita nella solitu<strong>di</strong>ne. Se qualche volta cercai <strong>di</strong> <strong>di</strong>menticare<br />
la mia infermità, oh come ne ero severamente punito dalla triste<br />
e dolorosa prova della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> u<strong>di</strong>re! Tuttavia mi era<br />
impossibile <strong>di</strong>re alla gente: - Parlate più forte; gridate, perché<br />
sono sordo! - Come risolvermi a confessare la debolezza <strong>di</strong> un<br />
senso che avrebbe dovuto in me essere più perfetto che in<br />
qualunque altro! <strong>di</strong> un senso che io possedevo allo stato <strong>di</strong> tale<br />
perfezione che pochi dell’arte mia potevano vantare l'eguale!<br />
No, io non lo poteva!<br />
«Perdonatemi, dunque, se vedete trarmi in <strong>di</strong>sparte, mentre<br />
avrei provata tanta sod<strong>di</strong>sfazione a confondermi tra voi; è<br />
doppia pena per me essere costretto a confinarmi nella<br />
solitu<strong>di</strong>ne e vedere il mio contegno interpretato in cattivo<br />
senso. Per me, infelice, non v’ha più <strong>di</strong>strazione <strong>di</strong> sorta nella<br />
società degli uomini, non m' è dato <strong>di</strong> prender parte alle loro<br />
elevate conversazioni, alle loro gioie: solo, sempre solo! A<br />
meno che una imperiosa necessità non mi obblighi ad uscire dal<br />
mio isolamento, io trascorro la mia vita nella solitu<strong>di</strong>ne come<br />
un ban<strong>di</strong>to, e se il caso mi conduce in mezzo a voi, subito mi<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Beethoven ha lasciato in bianco il nome del fratello Giovanni, così <strong>di</strong>ssimile da lui per<br />
sentimenti, e che egli amava poco.<br />
- 71 -
sento invaso da una penosa inquietu<strong>di</strong>ne, pensando che mi<br />
espongo a svelare il segreto della mia sor<strong>di</strong>tà.<br />
«Ho passato sei mesi in campagna <strong>di</strong>etro i consigli del mio<br />
valente dottore, il quale mi ha raccomandato <strong>di</strong> avere molto<br />
riguardo al mio u<strong>di</strong>to. La prescrizione s’accorda perfettamente<br />
con le <strong>di</strong>sposizioni attuali della mia mente. Tuttavia quando il<br />
mio piacere naturale per la società mi ha a volte trascinato a<br />
violare le mie risoluzioni, me ne dovevo subito rammaricare!<br />
Quale tristezza e quale scoramento quando, a mo' d'esempio, io<br />
non potevo percepire i suoni d’una zampogna campestre o il<br />
canto d'un mandriano, che altri u<strong>di</strong>va <strong>di</strong>stintamente da lungi!<br />
Tali prove mi gettavano in così profonda <strong>di</strong>sperazione, che per<br />
poco non attentavo ai miei giorni, Solo l'amore per l'arte mia ha<br />
potuto trattenermi per questo fatale pen<strong>di</strong>o: mi sembrava<br />
sarebbe stato un delitto lasciare il mondo prima d’aver dato<br />
all'arte ciò che mi sentivo in grado <strong>di</strong> produrre. Ed è così che mi<br />
aggrappavo a questa miserabile esistenza: tanto misera in vero,<br />
che a cagione della mia impressionabilità io passo, da un istante<br />
all’altro, dallo stato <strong>di</strong> maggiore tranquillità alla più grande<br />
angoscia.<br />
«La pazienza - ecco l'unica cosa che mi resta. Di pazienza ne<br />
ho e ne avrò, fino al giorno in cui piacerà alla Parca inesorabile<br />
troncare lo stame dei miei giorni. Il mio stato migliorerà forse,<br />
forse non migliorerà affatto: non importa, sono rassegnato! Ma<br />
a 28 anni ragionare con questa filosofica in<strong>di</strong>fferenza non è<br />
cosa facile per un artista<br />
«Oh mio Dio! il tuo sguardo dall'alto penetra nel profondo<br />
dell'anima mia: tu conosci il mio cuore e tu sai - non è vero ? -<br />
che esso non aspira che all'amore degli uomini e al desiderio <strong>di</strong><br />
bene, « E voi tutti, che un giorno leggerete queste righe, vi<br />
accorgerete che mi accusaste ingiustamente; e se questi fogli<br />
cadano allora fra le mani <strong>di</strong> un infelice come me, egli si<br />
consolerà forse, vedendo i miei sforzi per elevarmi, malgrado<br />
gli ostacoli e le crudeltà della natura, sino al grado degli<br />
ingegni e degli artisti più eletti.<br />
«Voi miei fratelli, se al momento in cui avrò cessato <strong>di</strong> vivere<br />
il professore Schmidt, sopravviva, pregatelo a mio nome <strong>di</strong><br />
scrivere una relazione sulla mia infermità. Pubblicatela insieme<br />
con questo foglio affinché il mondo, leggendo questi due scritti,<br />
- 72 -
si riconcilii, per quanto sarà possibile, con l’innocente che<br />
riposerà nella tomba.<br />
«Da parte mia <strong>di</strong>chiaro <strong>di</strong> nominarvi ere<strong>di</strong> della mia piccola<br />
fortuna, se tal nome può darsi a ciò che posseggo. Dividete<br />
lealmente questa modesta sostanza, procurate <strong>di</strong> vivere <strong>di</strong> buon<br />
accordo e <strong>di</strong> aiutarvi vicendevolmente.<br />
«Tutte le pene che m'avete cagionato ve le ho perdonate da<br />
lungo tempo, voi ben lo sapete; ma io non <strong>di</strong>menticherò mai, in<br />
cambio, l'affezione che Carlo mi ha <strong>di</strong>mostrato in questi ultimi<br />
tempi. Quello che vi auguro si è che la vostra vita sia più felice<br />
della mia. Insegnate ai vostri figli <strong>di</strong> coltivare la virtù; essa, e<br />
non il denaro, può rendere felici. Io parlo per esperienza: è la<br />
virtù che mi ha confortato nella sciagura ed ha alleviato le mie<br />
sofferenze: è l'amore della virtù, insieme con l’amore alla mia<br />
arte, che mi ha salvato dal suici<strong>di</strong>o.<br />
Siate felici, amatevi e comunicate l'espressione della mia<br />
riconoscenza a tutti gli amici e in particolare modo al principe<br />
Lichnowski e al professore Schmidt. Desidero che gli strumenti<br />
del principe siano conservati da uno <strong>di</strong> voi. Tuttavia questo<br />
tesoro non <strong>di</strong>venga argomento <strong>di</strong> litigi: quando non ne potete<br />
fare uso vantaggioso, vendetelo. Sarò contento <strong>di</strong> potervi essere<br />
utile anche nella tomba.<br />
«Ed ora si compia il mio destino! Io sono preparato; corro<br />
incontro alla morte senza <strong>di</strong>spiacere; ma non vorrei che venisse<br />
prima d’avermi concesso <strong>di</strong> spiegare tutte le mie facoltà<br />
artistiche. A qualunque ora venga, io l’accoglierò con gioia,<br />
poiché verrà a liberarmi da una sofferenza che non ha fine. Sì,<br />
vieni quando vuoi, o morte, t'attendo senza timore!<br />
«Ad<strong>di</strong>o. Non mi <strong>di</strong>menticate del tutto dopo la morte. Sento <strong>di</strong><br />
meritare che mi serbiate un ricordo e che rivolgiate a me il<br />
pensiero quando non sarò più, poiché durante tutta la mia vita<br />
ho pensato al modo <strong>di</strong> rendervi felici. Siatelo!<br />
Heiligenstandt, 6 ottobre 1802.<br />
E in una postilla del 10 ottobre:<br />
LUDOVICO VAN BEETHOVEN».<br />
- 73 -
«Così io mi congedo da te, e con grande tristezza; sì, la cara ,<br />
speranza - che io avevo portato qui, <strong>di</strong> essere guarito, almeno in<br />
parte - dev'e abbandonarmi del tutto. Come le foglie <strong>di</strong> autunno<br />
cadono smorte, cosi essa è inari<strong>di</strong>ta per me; io parto quasi nelle<br />
stesse con<strong>di</strong>zioni in cui venni. Anche quel fiero coraggio che<br />
mi animava sovente nei bei giorni d’estate è scomparso. Oh,<br />
Provvidenza! lascia che almeno mi appaia, per una volta sola,<br />
un puro giorno <strong>di</strong> .gioia; da così lungo tempo l'eco intima della<br />
vera gioia mi è estranea. Oh, quando, quando, Divinità! potrò <strong>di</strong><br />
nuovo sentirla nel tempio della Natura e degli uomini. Mai più?<br />
No! sarebbe troppo doloroso!<br />
Questo testamento ha una bellezza che eguaglia quella <strong>di</strong><br />
alcune pagine della sua musica. Qui vi è tutto il carattere <strong>di</strong><br />
Beethoven, l'uomo ha l'impronta sua e impronta vale la parola<br />
greca.<br />
Da queste carte s'erge un'anima varia, agitata, un'anima che<br />
ha portato al parossismo tutte le sue emozioni, che una parola<br />
piombava nell'abisso della <strong>di</strong>sperazione e del furore o lanciava<br />
fino al delirio della gioia più pura. Vi è tutta la natura<br />
complessa e il meccanismo complicato dello spirito <strong>di</strong> un uomo<br />
che al medesimo tempo era lo spirito <strong>di</strong> una eletta moltitu<strong>di</strong>ne<br />
<strong>di</strong> anime vibranti. Gli eventi e le cose, uscendo dall’isolamento<br />
nel quale si producono, si rivestivano agli occhi suoi d’una<br />
significazione simbolica, a traverso la quale si esprime la voce<br />
della natura infinita.<br />
Questa concezione dell'universo, questa Weltanschaung,<br />
determinava nell'interiore <strong>di</strong> Beethoven quell'armonia che si<br />
rifletteva poi nella sua opera musicale e le dava quella<br />
normalità e universalità che troviamo solo nella poesia del<br />
Goethe e che - a proposito <strong>di</strong> quest' ultimo - valutava con<br />
esattezza Felice Mendelsshon, <strong>di</strong>cendo: «a volte mi pare che<br />
Goethe si trovi ad esprimere per caso, con tutta precisione, quel<br />
che è occorso a me stesso ».<br />
E v'è, in questo atto testamentario, un sentimento della forza,<br />
una forza nuda, gigantesca emanante dalla sicurezza della<br />
propria fede e della propria virtù. Infine v'è la trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un<br />
cuore afflitto, tormentato, umiliato da un male che lo logorava<br />
in segreto e che, in altra tempra, avrebbe minacciato <strong>di</strong> renderlo<br />
ri<strong>di</strong>colo e oggetto <strong>di</strong> scherno agli occhi del volgo <strong>di</strong>stratto...<br />
- 74 -
La confessione delle sue sofferenze è tragica ed ha pochi<br />
confronti. Forse nella vita intima <strong>di</strong> Guy de Maupassant v’è<br />
qualcosa d'analogo. In questi, ultimo anello <strong>di</strong> una lunga catena<br />
<strong>di</strong> psicopatici, le facoltà sono lontane dall'equilibrio. Troppo<br />
intelligente per non avvedersene, ne soffre crudelmente, <strong>di</strong>viene<br />
acre e infierisce con lo sprezzo e il <strong>di</strong>leggio contro la fallacia<br />
umana. La sua opera letteraria è tutta un vano tentativo <strong>di</strong><br />
liberazione, è la dolorosa sinfonia <strong>di</strong> un cuore <strong>di</strong>silluso e<br />
spezzato, un’impari lotta per la riconquista dell'armonia interna.<br />
Egli stesso lo <strong>di</strong>ce in una lettera, e<strong>di</strong>ta dal dott. C. Ladame: «Il<br />
mio cervello reca tante ferite, che le idee non vi si possono<br />
muovere senza indurmi a gridare. Ma io taccio; nulla lascio<br />
notare in me e riesco, credo, a nascondere il mio stato. Mi si<br />
giu<strong>di</strong>ca un in<strong>di</strong>fferente, uno scettico, perché io ho una chiara<br />
visione... Ma i miei veggenti occhi <strong>di</strong>cono al cuore: nascon<strong>di</strong>ti,<br />
vecchio cuore, tu sei grottesco - ed esso si nasconde».<br />
Molte frasi contenute nelle lettere più espansive completano<br />
la descrizione dello stato d'animo del musicista sordo quale è in<br />
modo scultorio delineata nel testamento, Eccone alcune:<br />
A Wegeler,<br />
Vienna, il 12 maggio 1810.<br />
Io posso pensare sin d’ora che le mie parole risveglieranno in<br />
te qualche stupore e tuttavia, sebbene tu non ne abbia alcuna<br />
prova scritta, tu occupi sempre vivamente il mio- pensiero. Fra<br />
i miei manoscritti, ve ne è uno che, già da lungo tempo, ti è<br />
destinato e che tu riceverai certamente nell’estate. Da vari anni,<br />
è cessato per me ogni vivere un po’ calmo e tranquillo ed io<br />
sono stato trascinato a forza nella vita deI mondo; io non ne ho<br />
ancora ottenuto alcun risultato, forse anzi è il contrario: ma su<br />
chi non hanno agito le tempeste dell'ambiente esterno ?<br />
Tuttavia io sarei felice, forse uno dei più felici, se un demone<br />
non avesse stabilito domicilio nelle mie orecchie. Se io non<br />
avessi letto, non ricordo dove, che l’uomo non deve<br />
volontariamente rinunciare alla vita, sino a che non ha<br />
compiuto una buona azione, da tempo io non sarei più! Oh! la<br />
vita è così bella! ma per me è stata avvelenata per sempre...<br />
- 75 -
Beethoven ha inteso che tutto il pregio della vita dell'uomo è<br />
nello sforzo verso l'assoluto, ciò che la fa degna <strong>di</strong> essere<br />
vissuta. Se noi non possiamo possedere in terra l'assoluto, pure,<br />
nel fatto stesso che lo cerchiamo, illuminiamo la nostra vita <strong>di</strong><br />
un raggio <strong>di</strong> luce <strong>di</strong>vina. È il cercare che fa gran<strong>di</strong>, se anche<br />
non metterà mai capo al trovare. Eternamente insod<strong>di</strong>sfatto<br />
perché eternamente contrad<strong>di</strong>ttorio e per ciò stesso sempre<br />
rinnovellato, lo slancio che porta l'uomo al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> sé non è<br />
mai irrito e vano.<br />
Anche nell’espansione confidenziale <strong>di</strong> queste lettere<br />
Beethoven ha sprazzi <strong>di</strong> profonda filosofia e mostra squisite<br />
qualità innate <strong>di</strong> scrittore adusato. Ascoltate :<br />
A Bettina Brentano,<br />
Vienna, 11 agosto 1810.<br />
...Io sono stato sorpreso da voi in un istante in cui lo<br />
scoramento era padrone <strong>di</strong> me, ma esso scomparve in vostro<br />
cospetto, ed io ne fui subito liberato: voi siete <strong>di</strong> un altro<br />
mondo, <strong>di</strong>verso da questo mondo assurdo, al quale, con la<br />
migliore volontà, non si può aprire le orecchie. Io sono un<br />
uomo miserabile e poi mi lagno degli altri! Voi me lo<br />
perdonerete, con il vostro buon cuore, che si legge nei vostri<br />
occhi, e con la vostra ragione che risiede nelle vostre orecchie;<br />
almeno le vostre orecchie sanno lusingare allorché ascoltano.<br />
Le mie formano sventuratamente una muraglia a traverso la<br />
quale io non posso avere alcuna comunicazione <strong>di</strong> amicizia con<br />
gli uomini. Se fosse altrimenti, forse, avrei acquistata maggior<br />
confidenza in voi, ma io non ho potuto intendere che lo sguardo<br />
timido dei vostri occhi; esso mi ha così dominato che io non<br />
potrò mai obliarlo. Cara amica, carissima fanciulla, l’Arte! chi<br />
la comprende? Con chi possiamo <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> questa cosa così<br />
<strong>di</strong>vina ? Come mi riescono cari i pochi giorni in cui parlavamo,<br />
o piuttosto corrispondevamo insieme; io ho conservato tutte le<br />
piccole carte in cui sono le vostre intellettuali e grate risposte,<br />
così che debbo al cattivo stato delle mie orecchie il fatto che la<br />
miglior parte <strong>di</strong> questi trattenimenti fugaci sia scritta.<br />
Appena voi siete partita, io ebbi delle ore <strong>di</strong> rimpianto, delle<br />
ore <strong>di</strong> ombra in cui non vi è rime<strong>di</strong>o alcuno; io ho vagabondato<br />
tre ore intorno alla passeggiata <strong>di</strong> Schoenbrunn, ma nessun<br />
- 76 -
angelo mi è venuto incontro), che mi abbia preso come «te, mio<br />
angelo».<br />
Scusate, cara amica, questi mutamenti bruschi <strong>di</strong> tono; mi<br />
occorrono <strong>di</strong> tali intervalli per dare aria al mio cuore.<br />
Quale squisita sensibilità, quanto calore <strong>di</strong> sentimento, vorrei<br />
<strong>di</strong>re che movimento lirico in questa lettera! Beethoven aveva<br />
delicate tenerezze <strong>di</strong> fanciullo; la sua corporatura era forte,<br />
muscolosa, ma sensibile. Dante <strong>di</strong>ce che tale contrasto è in<br />
natura, dato che<br />
...Quanto la cosa è più perfetta,<br />
Più senta il bene, e così la doglienza.<br />
Non v'è pagina dell’epistolario, forse non v’è paragrafo, dove<br />
non si trovi un tratto <strong>di</strong> poesia, chiuso in un cerchio d’incanto.<br />
Egli getta <strong>di</strong>speratamente come dentro un crogiuolo gli<br />
elementi della sua varia esperienza, fa che vi si <strong>di</strong>battano le<br />
creature che non esistono per sé stesse, ma nascono dalle<br />
necessità antinomiche del suo spirito: le demolisce e le ricrea; è<br />
<strong>di</strong> volta in volta con le une e con le altre; mette <strong>di</strong> contro il<br />
mondo dal quale è nato, fatto d’istinto o <strong>di</strong> necessità bruta con<br />
quello dove s'è immerso, maturo <strong>di</strong> nobile e fiera volontà.<br />
Ogni tanto il suo spirito, preso in tale groviglio, beve a larghi<br />
sorsi alla natura immanente, per non soccombere: sono<br />
momenti d’eternità. Tutto il resto si combatte e si <strong>di</strong>strugge a<br />
vicenda: le illusioni degli uomini crollano ad una ad una. Ma<br />
l’artista il cui impero è nell’aria - Mein reich ist der Luft, scrive<br />
Beethoven al Brunswick - dalla trage<strong>di</strong>a quoti<strong>di</strong>ana si eleva con<br />
un poema <strong>di</strong> così vasta potenza, <strong>di</strong> tono così vario, permeato e<br />
respirante in un’atmosfera cosmica, che ritorna, fortificato e<br />
rifatto, all’umanità.<br />
E continua quella lettera alla Brentano:<br />
E voi avete scritto a Goethe <strong>di</strong> me? Io vorrei nascondere il<br />
mio capo in un sacco, ove io non sentirei né vedrei nulla <strong>di</strong><br />
quanto accade nel mondo poiché tu non mi verrai più incontro,<br />
o angelo mio: ma io ricevetti tuttavia una vostra lettera; la<br />
speranza mi alimenta, essa nutre almeno la metà del mondo; ed<br />
io l’ho avuta vicina per tutta la vita. Altrimenti che sarebbe<br />
avvenuto <strong>di</strong> me?<br />
- 77 -
Io vi invio, scritto <strong>di</strong> mia mano: Conosci tu il paese, in<br />
ricordo dell'ora in cui vi ho conosciuto; vi mando anche l’altra<br />
melo<strong>di</strong>a che ho composto dopo aver preso congedo da voi, o<br />
cuore carissimo!<br />
«Cuore, mio Cuore, che cosa mai ti affretta così forte? Quale<br />
via nuova e strana; io non ti riconosco più!» (Op. 75, da una<br />
poesia <strong>di</strong> Goethe).<br />
Sì, cara amica, rispondetemi, scrivetemi ciò che deve essere<br />
<strong>di</strong> me, dopo che il mio cuore è <strong>di</strong>ventato un simile ribelle.<br />
Scrivete al Vostro fedele amico<br />
- 78 -<br />
BEETHOVEN<br />
Alla Brentano, che sposava il conte d’Arnim, scriveva da<br />
Vienna il 10 febbraio 1811:<br />
...Che debbo <strong>di</strong>re <strong>di</strong> me? «Deploro il mio destino», grido con<br />
Giovanna [d’Arco, nel dramma <strong>di</strong> Schiller]. Se io salvo ancora<br />
alcuni anni <strong>di</strong> vita, io ne voglio ringraziare, come per ogni bene<br />
e ogni male, colui che abbraccia tutto in sé, l’Altissimo.<br />
Per Goethe, se gli scrivete a mio riguardo, cercate tutte le<br />
parole che valgano a esprimergli il mio rispetto e la mia<br />
ammirazione più profonda; io sto per scrivergli a proposito<br />
dell’Egmont, <strong>di</strong> cui ho composto la musica (Op. 84), e ciò per<br />
un puro amore per le sue poesie, che mi rendono felice; e anche<br />
per rendere grazie. a un grande poeta, il gioiello più prezioso <strong>di</strong><br />
una nazione.<br />
Ed ora basta, mia buona amica; io sono tornato questa<br />
mattina alle 4 da un baccanale, in cui ho persino dovuto ridere<br />
molto per piangere oggi quasi altrettanto; sovente la gioia<br />
snervante mi rigetta con violenza in me stesso...<br />
Sembra quasi che, me<strong>di</strong>tando, Beethoven si ponga delle<br />
domande: - Perché il dolore? perché vi potesse essere la gioia.<br />
E il riso non è prodotto anche dal dolore? - Talora si vede una<br />
persona, nell'ascoltare il racconto <strong>di</strong> una sventura, atteggiare il<br />
volto e contrarre i muscoli pellicciai come se volesse sorridere,<br />
in un rictus ambiguo. Non aveva detto il Petrarca: «conviensi<br />
che l'estremo del riso assaglia il pianto»?<br />
Strana anima <strong>di</strong> artista, sorprendente miscuglio <strong>di</strong> passioni<br />
umane alberga in quest'uomo alla ToIstoi, con la severità dei
costumi, con la sua religione del dovere, con la visione cosmica<br />
ampia e serena, con l’ufficio <strong>di</strong> una carità innata: nella sua<br />
sapienza artistica era sovente nascosto il nucleo <strong>di</strong> una<br />
esperienza umana e civile!<br />
A Wegeler<br />
Vienna, il 7 ottobre 1826.<br />
Mio vecchio ed amato amico, Qual piacere mi hanno<br />
procurato la tua lettera e quella della tua Lorchen! Io non posso<br />
esprimerlo. Certo io avrei dovuto rispondere imme<strong>di</strong>atamente,<br />
ma io sono sempre un po’ negligente nello scrivere, poiché io<br />
penso che i buoni mi conoscono anche senza le mie lettere. Io<br />
formulo spesso la risposta nel mio cervello, ma allorquando<br />
vado per metterla in iscritto, il più delle volte getto la penna,<br />
poiché non sono in grado <strong>di</strong> scrivere come io penso. Io ricordo<br />
tutto l’amore che tu e i tuoi mi avete sempre <strong>di</strong>mostrato, per<br />
esempio quando hai fatto <strong>di</strong>pingere la mia camera, con mia<br />
gran<strong>di</strong>ssima sorpresa. Lo stesso si <strong>di</strong>ca della famiglia Breuning,<br />
Se ci siamo separati, ciò era nell’or<strong>di</strong>ne delle cose; ognuno ha<br />
dovuto perseguire e cercare <strong>di</strong> raggiungere il fine del suo<br />
destino; ma i principi eterni e ineluttabili del bene ci hanno<br />
tuttavia tenuti solidamente uniti. Io non posso <strong>di</strong>sgraziatamente<br />
scriverti oggi quanto vorrei, poiché sono in letto e mi limito a<br />
rispondere ad alcuni punti della tua lettera.<br />
Tu mi scrivi che qualcuno mi ritiene per un figlio naturale del<br />
defunto re <strong>di</strong> Prussia [Federico II]; me ne è stato parlato già da<br />
tempo; ma io mi sono imposto <strong>di</strong> non scrivere nulla <strong>di</strong> me né <strong>di</strong><br />
rispondere a qualunque cosa si stampi <strong>di</strong> me. Ti lascio quin<strong>di</strong><br />
volentieri la briga <strong>di</strong> far conoscere al mondo l'onorabilità dei<br />
miei genitori e <strong>di</strong> mia madre in particolare.<br />
Curiosa questa leggenda, frutto <strong>di</strong> volgare sospetto: d'altronde<br />
voci consimili sono corse a proposito <strong>di</strong> altri gran<strong>di</strong>. Così nei<br />
lineamenti del celebre anatomico Bartolomeo Panizza , vi era<br />
qualche ricordo del sembiante del suo sommo maestro Antonio<br />
Scarpa, quale venne delineato e inciso dall’Anderloni. Il colore<br />
dei capelli e la pienezza leonina del tratto naso-labiale<br />
richiamavano stranamente la fisionomia dell'anatomico<br />
friulano. Questa somiglianza, e l'amore paterno che lo Scarpa -<br />
uomo poco espansivo - portò al Panizza, fecero, nascere il<br />
- 79 -
dubbio che anche questi - come si era pensato falsamente dello<br />
Jacobi - fosse un erede spurio dello Scarpa.<br />
Beethoven prosegue nella lettera all'amico devoto:<br />
Tu mi scrivi a proposito <strong>di</strong> tuo figlio. Si sottintende che se<br />
egli verrà qui, 1 troverà in me il suo amico e un secondo padre, e<br />
che ovunque io possa essergli utile, lo farò con gioia.<br />
Io conservo ancora la silhouette della tua Lorchen; da ciò tu<br />
puoi vedere quanto mi siano ancora preziosi i buoni e cari<br />
ricor<strong>di</strong> della mia giovinezza.<br />
Quanto ai miei <strong>di</strong>plomi, mi limiterò a <strong>di</strong>rti che io sono<br />
membro d’onore della Società R. delle Scienze <strong>di</strong> Svezia, come<br />
pure ad Amsterdam, e che sono anche citta<strong>di</strong>no onorario <strong>di</strong><br />
Vienna. Recentemente un certo dott. Spieker ha portato a<br />
Berlino la mia ultima grande sinfonia con cori, de<strong>di</strong>cata al re, al<br />
quale ho dovuto scrivere l’offerta <strong>di</strong> mia mano. Io avevo già<br />
prima sollecitato dall’ambasciata il permesso, che mi fu<br />
concesso, <strong>di</strong> poter de<strong>di</strong>care questa opera al re. Per invito del<br />
dott. Spieker ho consegnato per il re il manoscritto corretto <strong>di</strong><br />
mio pugno, poiché esso sarà conservato nella Biblioteca reale.<br />
Mi si è accennato vagamente al conferimento dell'Aquila rossa<br />
<strong>di</strong> seconda classe; io non so quanto possa valere, poché io non<br />
ho mai cercato queste <strong>di</strong>stinzioni onorifiche; ma ai nostri tempi,<br />
e per molte altre ragioni, ciò non mi <strong>di</strong>spiacerebbe. D'altronde<br />
io sono sempre al Nulla <strong>di</strong>es sine linea e se lascio dormire la<br />
musa, è soltanto perché essa si svegli più forte. Io spero <strong>di</strong> dare<br />
ancora al mondo alcune gran<strong>di</strong> opere, e poi, come un vecchio<br />
fanciullo, chiudere la mia carriera terrestre in mezzo a della<br />
buona gente.<br />
16/04/201316/04/2013<br />
1 Probabilmente accenna al figlio <strong>di</strong> Wegeler, Giulio, che <strong>di</strong>venne poi me<strong>di</strong>co, e che<br />
allora. aveva 19 anni: egli forse era incerto se andare a stu<strong>di</strong>are a Vienna o in qualche<br />
altra città universitaria.<br />
Giulio Wegeler nacque a Bonn il 21 febbraio 1807, stu<strong>di</strong>ò dal 1825 come volontario<br />
dell'istituto me<strong>di</strong>co chirurgico Federico-Guglielmo all'ateneo <strong>di</strong> Berlino, ove nel 1829<br />
ottenne la laurea, svolgendo la tesi De aurium chirurgia. Nel 1841 <strong>di</strong>venne Med. Rath e<br />
morì il. 29 luglio 1883; nella qualità <strong>di</strong> Geh. Med. Rath.<br />
È un fatto degno <strong>di</strong> molto interesse che, allorquando pochissimi si occupavano <strong>di</strong><br />
otologia, Wegeler juniore abbia scelto per tema della sua <strong>di</strong>ssertazione dottorale un<br />
argomento otologico:. come pure che il figlio <strong>di</strong> Vering abbia dettato degli aforismi sulle<br />
malattie auricolari. È presumibile che vi fossero indotti più o meno consciamente<br />
dall'interesse che i loro genitori, che furono me<strong>di</strong>ci e amici <strong>di</strong> Beethoven, ponevano<br />
nell’assistenza al grande infelice.<br />
- 80 -
Questa calma serena, questa pace interna, che ricorda il<br />
panteistico atman dei filosofi in<strong>di</strong>ani, Beethoven ha ottenuto<br />
nel suo animo eroico, temprato nell'abitu<strong>di</strong>ne del dolore. Una<br />
me<strong>di</strong>tazione lunga, intensa, infinita gli ha permesso <strong>di</strong><br />
conoscere che egli pure fa parte dell'Essere, e, <strong>di</strong>ssipata ogni<br />
ingannevole illusione dei sensi, <strong>di</strong> raggiungere l'ideale suo,<br />
l'ideale tanto sospirato. Allora non gli resterà che <strong>di</strong> morire. Ma<br />
morire è parola che usano soltanto gli stolti, ai quali non è dato<br />
<strong>di</strong> penetrare a dentro nelle cose. L'uomo <strong>di</strong> pensiero, giunto a<br />
questa alta idealità intende che il morire, per lui, è<br />
l’identificarsi all'Essere, spogliato della coscienza sua umana e<br />
in<strong>di</strong>viduale.<br />
La lettera del 7 ottobre 1826 continua:<br />
Tu riceverai presto dai fratelli Schott <strong>di</strong> Magonza alcuni pezzi<br />
<strong>di</strong> musica. Il ribatto che troverai qui accluso è senza dubbio un<br />
capolavoro artistico, ma non è l’ultimo che mi sia stato fatto.<br />
In argomento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzioni onorifiche, che, lo so, ti faranno<br />
piacere, ti annuncio che il defunto re <strong>di</strong> Francia mi mandò una<br />
medaglia con questa scritta: «Donné par le Roi à Monsieur<br />
Beethoven» e accompagnata da una lettera molto lusinghiera<br />
del primo gentiluomo, duca <strong>di</strong> Châtres,<br />
Ma dunque Beethoven al declinare della sua vita non era<br />
insensibile agli onori, egli che era stato sempre così fiero e<br />
in<strong>di</strong>pendente? Come si spiega il contrasto? In generale la vita,<br />
così come ci appare, è piena <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni, non perché non<br />
abbia alcune leggi profonde, mal definibili, ma perché le<br />
apparenze da cui la giu<strong>di</strong>chiamo si urtano frammentarie su un<br />
piccolo schermo. Un uomo <strong>di</strong>ce oggi una cosa; alcuni mesi<br />
dopo gliene u<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>re un'altra, <strong>di</strong>versa; più tar<strong>di</strong> una opposta.<br />
L'uomo - sentenziamo - si contrad<strong>di</strong>ce. Ma noi ignoriamo il<br />
tessuto fondamentale della sua esistenza: le parole non<br />
pronunziate che collegavano un <strong>di</strong>scorso a un altro, la logica<br />
delle variazioni che univa le antitesi in una tesi più vasta.<br />
E Beethoven conchiude con un tenero saluto:<br />
Caro amico, per oggi accontentati <strong>di</strong> quanto t’ho detto. Le<br />
rimembranze del passato mi assalgono e tu riceverai questa<br />
lettera bagnata dalle mie lacrime. Ora il primo passo è fatto e<br />
ben presto riceverai un'altra lettera e più spesso tu mi scriverai,<br />
- 81 -
più mi darai piacere. La nostra amicizia non fa questioni <strong>di</strong><br />
precedenza.<br />
Ad<strong>di</strong>o, caro; ti prego <strong>di</strong> abbracciare a mio nome la tua<br />
Lorchen e i tuoi ragazzi, e <strong>di</strong> pensare allora a me. Dio sia con<br />
voi tutti, come sempre il tuo fedele e vero amico che ti onora.<br />
- 82 -<br />
BEETHOVEN<br />
Ma il destino della sua vita lo incalzava. Ormai il maestro è al<br />
termine della esistenza mortale, in cui ebbe ostile tanta parte <strong>di</strong><br />
sé e del mondo esterno: dalle sue parole si spande un mistico<br />
senso della piccolezza infinita e dell'inquietu<strong>di</strong>ne umana nel<br />
solenne universo.<br />
A Wegeler.<br />
Vienna, il 17 febbraio 1827.<br />
Mio vecchio e degno amico,<br />
Fortunatamente ho almeno ricevuto da Breuning la tua<br />
seconda lettera. Io sono ancora troppo debole per rispondere ad<br />
essa, ma tu puoi pensare che tutto ciò che contiene è benvenuto<br />
e adempie ai miei voti. La mia guarigione, se posso chiamarla<br />
così, va tuttora molto lentamente; è da presumere che si debba<br />
ricorrere a un quarto intervento, benché i me<strong>di</strong>ci non <strong>di</strong>cano<br />
ancora nulla.<br />
Io sopporto tutto, con pazienza e penso che ogni male arreca<br />
sovente qualche bene. Ma io sono stupito nel leggere nella tua<br />
lettera che tu non hai ancora nulla ricevuto...<br />
Quante cose vorrei ancora <strong>di</strong>rti oggi, ma io sono troppo<br />
debole; io non posso adunque che abbracciarvi in spirito, tu e la<br />
tua Lorchen.<br />
Con vera amicizia e un affetto sincero per te e i tuoi, il tuo<br />
vecchio e fedele amico.<br />
BEETHOVEN<br />
Qui la parte lirica appare soverchiata e quasi nascosta dalla<br />
parte riflessiva e morale; dal suo letto <strong>di</strong> morte, dalla<br />
considerazione delle apparenze della vita, al Beethoven<br />
importava giungere a una organica persuasione etica. E intanto,<br />
affaticato dall’idrope-ascite, era in attesa <strong>di</strong> una quarta<br />
paracentesi...
Vi sono varie forme <strong>di</strong> eroismo. Accanto a colui che in un<br />
istante <strong>di</strong> suprema generosa de<strong>di</strong>zione fa getto della propria<br />
vita; accanto al martire che muore per un'idea, offrendo la più<br />
alta espressione della perfezione umana e la prova più sicura<br />
del netto <strong>di</strong>stacco tra l'uomo e gli altri animali, vi è chi<br />
persegue con pertinacia una <strong>di</strong>rettiva costante a traverso una<br />
folla <strong>di</strong> ostacoli, turbato e afflitto dai mali, ma inflessibile. Così<br />
Beethoven, che indìce, contro le infermità, una lotta ostinata<br />
per il trionfo <strong>di</strong> un alto ideale artistico, ha l'eroismo<br />
consapevole <strong>di</strong> tutti i giorni, <strong>di</strong> tutte le ore.<br />
Gli eroi emozionali e improvvisi attingono la mèta unica e<br />
decisiva con un atto inopinato e magnanimo che s'impone a<br />
tutti; gli eroi pensosi e lenti giungono all'ultimo grande risultato<br />
a traverso atti in apparenza meschini e che sfuggono<br />
all'attenzione del volgo.<br />
- 83 -
- 84 -<br />
(a cura <strong>di</strong> Stefania Od<strong>di</strong> e Alberto Rossi)<br />
Lettere Varie del P. Tommaso Pendola.<br />
Egregio amico,<br />
Per la Storia<br />
dell’<strong>Educazione</strong> dei <strong>Sor<strong>di</strong></strong><br />
<strong>Siena</strong>, 13 Gennaio 1860<br />
L’Arci<strong>di</strong>acono Enrico Formichi <strong>di</strong> Asinalunga, il quale<br />
è Deputato già da 5 anni della scuola Comunale del suo paese,<br />
desidera <strong>di</strong> essere presentato e raccomandato a Voi per<br />
ottenere a suo tempo il posto <strong>di</strong> ispettore o Sotto-Ispettore delle<br />
scuole Compartimentali.<br />
Io lo conosco da lungo tempo: è stato mio scolaro: è<br />
tuttora giovane e può lavorare: ha fatto bene i suoi stu<strong>di</strong>;<br />
perciò ve lo raccomando.<br />
Speravo <strong>di</strong> vedervi in <strong>Siena</strong> per l’apertura della nostra<br />
Università; ma la mia speranza rimase fallita.<br />
Accogliete almeno il saluto affettuoso, che v’invio per<br />
lettura.<br />
Il Vostro Pendola<br />
Tommaso Pendola delle V. Pie
Gent.ssa Sig.ra Contessa,<br />
- 85 -<br />
<strong>Siena</strong>, 9 Dicembre 1842<br />
Questa volta non è una porta-voce: ma Le mando in<br />
dono un piccolo ninnolo da me fatto per istruire i sordo-muti.<br />
Ella non deve valutare il dono; ma il pensiero; perché questo<br />
pensiero è accompagnato da molta riconoscenza e gratitu<strong>di</strong>ne.<br />
Queste sordo-mute stanno tutte bene, e se io avessi molti<br />
quattrini starei benissimo. Speriamo che gli i avrò quando sarò<br />
fatto o Vescovo o Car<strong>di</strong>nale.<br />
Mi permetta frattanto che con tutto l’ossequio mi<br />
confermi.<br />
Di Lei, Gent.ssima Contessa.<br />
Dev.mo ed Aff.mo Servitore<br />
Tommaso Pendola delle V. Pie
Gent.ssimo Sig. Orlan<strong>di</strong>,<br />
- 86 -<br />
<strong>Siena</strong>, 16 Aprile 1852<br />
Quello che sarà al terminare dell’anno scolastico non<br />
sarei indovinarlo. Tale è oggi la situazione della povera<br />
Toscana, che Id<strong>di</strong>o solo può riparare a tanti cangiamenti, che<br />
le sovrastano. Posso per altro <strong>di</strong>rle, che per ora i temi non<br />
sono cangiati, e solo è stato eliminato il tema 34 dai 60.<br />
Parimenti sono state tolte dalle Rubriche del Sommario tutte<br />
quelle, le quali riguardano la dottrina del Gioberti. Questa<br />
eliminazione è stata or<strong>di</strong>nata dall’atto in forza della<br />
proibizione fatta da Roma <strong>di</strong> tutte le opere dell’insigne filosofo<br />
Piemontese.<br />
Se Le occorressero altri schiarimenti mi scriva pure con<br />
tutta libertà, e si assicuri, che, per la stima ed affezione che ho<br />
per Lei, Le risponderò prontamente.<br />
Mi riverisca il Sig. Micheli, e mi creda con tutto l’animo.<br />
Di Lei, Gent.ssimo Sig. Orlan<strong>di</strong>.<br />
Dev.mo ed Aff.mo Servitore<br />
Tommaso Pendola delle V. Pie
- 87 -<br />
Per la cronaca<br />
(a cura <strong>di</strong> Stefania Od<strong>di</strong>)<br />
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA «CITTA’ DI<br />
PORTO RECANATI» XXIV<br />
E<strong>di</strong>zione 2013<br />
Col Patrocinio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Porto Recanati e la<br />
Regione Marche<br />
Art. 1 – Il Poeta invierà una sola poesia a tema<br />
libero. L’organizzazione tuttavia consiglia <strong>di</strong><br />
trattare tematiche sulla <strong>di</strong>sabilità, sulla solitu<strong>di</strong>ne<br />
degli anziani, sui “nuovi poveri”, sugli<br />
extracomunitari, sugli eventi climatici ecc.,<br />
affinché si rifletta sulla con<strong>di</strong>zione esistenziale<br />
dell’uomo, ideazione che portò all’istituzione del<br />
Premio «Città <strong>di</strong> Porto Recanati» quasi 30 anni fa.<br />
Comunque sia, il tema vuole essere solo<br />
in<strong>di</strong>cativo. La poesia inviata, che non dovrà<br />
superare i 35 vv potrà anche essere stata e<strong>di</strong>ta, ma<br />
che non abbia mai vinto il primo premio in altri<br />
concorsi. L’originale riporti: Nome e Cognome<br />
dell’autore, in<strong>di</strong>rizzo e in<strong>di</strong>cazione dell’email e la<br />
<strong>di</strong>chiarazione: «Dichiaro d’essere l’autore<br />
dell’opera inviata al concorso».<br />
Art. 2 - La Giuria, composta da quattro elementi,<br />
sarà resa nota il giorno della premiazione, stilerà<br />
una graduatoria <strong>di</strong> tre Vincitori dei premi in denaro<br />
e <strong>di</strong> altri meritevoli sino al 10°. La Giuria, a suo<br />
insindacabile giu<strong>di</strong>zio, deciderà <strong>di</strong> premiare quei<br />
poeti che, con l’impegno culturale e la propria<br />
testimonianza <strong>di</strong> vita, hanno contribuito a superare<br />
una con<strong>di</strong>zione esistenziale <strong>di</strong>fficile, o rendendola<br />
ad<strong>di</strong>rittura fonte <strong>di</strong> ispirazione.<br />
Art. 3 – I Premi in denaro sono:<br />
1° Classificato 500 euro, Targa o Trofeo e<br />
Pergamena.<br />
2° Classificato 300 euro, Targa o Trofeo e<br />
Pergamena.
3° Classificato 200 euro, Targa o Trofeo e<br />
Pergamena.<br />
Art. 4 – La poesia dovrà essere spe<strong>di</strong>ta entro il 31<br />
luglio 2013 (farà fede il timbro postale <strong>di</strong><br />
spe<strong>di</strong>zione) in quattro copie, per posta or<strong>di</strong>naria al<br />
seguente in<strong>di</strong>rizzo: Prof. Renato Pigliacampo C/o<br />
Concorso Internazionale <strong>di</strong> Poesia «Città <strong>di</strong> Porto<br />
Recanati», XXIV E<strong>di</strong>zione 2013 Casella Postale<br />
n. 61 62017 PORTO RECANATI (Macerata).<br />
Solo la copia originale riporterà i dati. La poesia<br />
potrà essere inviata anche per email a:<br />
pigliacampo@cheapnet.it Il concorrente è tenuto<br />
a versare la quota d’iscrizione <strong>di</strong> 20 (venti) euro<br />
sul conto corrente postale n. 29 68 76 21 intestato<br />
a Renato Pigliacampo c/o Casisma, o tramite altra<br />
modalità a scelta del partecipante. La somma è a<br />
<strong>di</strong>sposizione del monte-premi.<br />
Informazioni. La data <strong>di</strong> premiazione avverrà a<br />
Porto Recanati, prevista nella seconda decade <strong>di</strong><br />
settembre. I Vincitori dei premi in denaro avranno<br />
comunicazione scritta del giorno, dell’ora e del<br />
luogo della Cerimonia. Le migliori opere saranno<br />
(probabilmente) raccolte in un volumetto. Si<br />
chiede la cortesia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere il Premio nei<br />
me<strong>di</strong>a e tra gli amici interessati. Grazie<br />
- 88 -