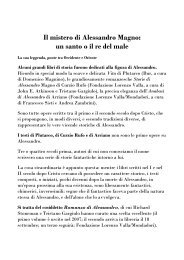Paolo e Seneca - Q. Orazio Flacco
Paolo e Seneca - Q. Orazio Flacco
Paolo e Seneca - Q. Orazio Flacco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Capitolo 18<br />
A Roma: Claudio. 2º viaggio di <strong>Paolo</strong>. 49 - 52 d.C. Inizio 3º viaggio, 53 d.C.<br />
<strong>Paolo</strong> a Corinto.<br />
1 - Dopo queste cose, <strong>Paolo</strong>, partitosi da Atene, venne a Corinto.<br />
2 E avendo trovato un certo giudeo, di nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di<br />
fresco dall'Italia insieme con Priscilla sua moglie (perché Claudio aveva ordinato che<br />
tutti i giudei se n'andasssero da Roma), s'accostò a loro;<br />
3 e siccome era dello stesso mestiere, andò a stare e a lavorare con loro: facevano il<br />
mestiere di fabbricanti di tende.<br />
4 Ogni sabato poi ragionava nella sinagoga, interponendo il nome del Signore Gesù, e<br />
persuadeva Giudei e Greci.<br />
5 Ma, venuti che furono Sila e Timoteo dalla Macedonia, <strong>Paolo</strong> si diè tutto alla<br />
predicazione, testimoniando a' Giudei che Gesù era il Cristo.<br />
6 Siccome però questi gli facevan contrasto e bestemmiavano, egli, scotendosi le vesti,<br />
disse loro: «Il sangue vostro ricada sul vostro capo; io non ne ho colpa; d'ora in poi me<br />
n'andrò a' Gentili».<br />
7 E, partitosi di là, entrò in casa d'uno chiamato Tito Giusto, adoratore di Dio; la casa di<br />
lui era presso alla sinagoga.<br />
8 Or Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua famiglia, e<br />
molti de' Corinti, udendo credevano, ed eran battezzati.<br />
9 E il Signore, di notte in visione, disse a <strong>Paolo</strong>: «Non temere, ma parla e non tacere;<br />
10 perché io son teco, e nessuno giungerà a farti del male: io ho un gran popolo in<br />
questa città».<br />
11 Così <strong>Paolo</strong> si fermò a Corinto un anno e sei mesi, insegnando a tutti la parola di Dio.<br />
12 Essendo poi Gallione proconsole dell'Acaia, i Giudei tutti d'accordo insorsero contro<br />
<strong>Paolo</strong>, e lo menarono al tribunale,<br />
13 dicendo: «Costui persuade la gente a rendere a Dio un culto contrario alla legge».<br />
14 E come <strong>Paolo</strong> era lì pronto a parlare, Gallione disse a' Giudei: «Se si trattasse di<br />
qualche delitto, di qualche grave misfatto, io, o Giudei, vi darei ascolto come ragion<br />
vuole;<br />
15 ma, poiché si tratta di questioni di parole e di nomi, e appartengono alla vostra legge,<br />
pensateci voi: io non voglio farmi giudice di queste cose».<br />
16 E li mandò via dal tribunale.<br />
17 Tutti allora presero Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero dinanzi al<br />
tribunale; e Gallione non se ne curava affatto.<br />
18.<br />
(1.) Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς<br />
Κόρινθον. (2.) καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, @1<br />
Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς<br />
Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατετα-<br />
χέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ
τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς, (3.) καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον<br />
εἶναι ἔμενεν παρ’ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ<br />
σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ. (4.) διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ<br />
κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας.<br />
(5.) Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας<br />
καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος, δια-<br />
μαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.<br />
(6.) ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτινα-<br />
ξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ<br />
τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ<br />
ἔθνη πορεύσομαι. (7.) καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς<br />
οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν, @1<br />
οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. (8.) Κρίσπος δὲ<br />
ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ<br />
οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπί-<br />
στευον καὶ ἐβαπτίζοντο. (9.) εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ<br />
δι’ ὁράματος τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ<br />
σιωπήσῃς, (10.) διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπι-<br />
θήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς<br />
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. (11.) Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας<br />
ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.<br />
(12.) Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας κατε-<br />
πέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ<br />
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, (13.) λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν<br />
νόμον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν.<br />
(14.) μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ<br />
Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι<br />
ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν<br />
ἀνεσχόμην ὑμῶν· (15.) εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου<br />
καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ’ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί·<br />
κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. (16.) καὶ ἀπήλασεν<br />
αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. (17.) ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες<br />
Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ<br />
βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν.
Carteggio <strong>Paolo</strong> – <strong>Seneca</strong><br />
Conosci Wikiquote, l'antologia libera di aforismi e citazioni? Guarda la breve<br />
video-guida prodotta da Wikimedia Italia<br />
Conosci Wikiquote, l'antologia libera di aforismi e citazioni? Guarda la breve<br />
video-guida prodotta da Wikimedia Italia<br />
Carteggio apocrifo di <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong><br />
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.<br />
Valentin de Boulogne: san <strong>Paolo</strong>, ca 1620, Blaffer Coll., Houston<br />
Il carteggio apocrifo di <strong>Seneca</strong> e san <strong>Paolo</strong> - Epistolae <strong>Seneca</strong>e ad Paulum et Pauli<br />
ad <strong>Seneca</strong>m - è un corpus di quattordici lettere latine scritte da un anonimo falsario del<br />
IV secolo, sei delle quali da lui attribuite all'apostolo <strong>Paolo</strong> e otto al filosofo e letterato<br />
romano Lucio Anneo <strong>Seneca</strong>. Costituisce un apocrifo del Nuovo Testamento.<br />
Indice [nascondi]<br />
1 La leggenda del Cristianesimo di <strong>Seneca</strong><br />
1.1 La datazione del carteggio<br />
1.2 La leggenda dell'amicizia di <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong><br />
1.3 L'evoluzione della leggenda: il Cristianesimo<br />
di <strong>Seneca</strong><br />
1.4 La critica moderna: autori e scopo del<br />
carteggio<br />
2 Le lettere<br />
2.1 Lettera I: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.1.1 Commento<br />
2.2 Lettera II: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong><br />
2.2.1 Commento<br />
2.3 Lettera III: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.3.1 Commento<br />
2.4 Lettera IV: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong><br />
2.4.1 Commento<br />
2.5 Lettera V: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.5.1 Commento<br />
2.6 Lettera VI: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> e a Lucilio<br />
2.6.1 Commento<br />
2.7 Lettera VII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> e a Teofilo<br />
2.7.1 Commento
2.8 Lettera VIII: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong><br />
2.8.1 Commento<br />
2.9 Lettera IX: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.9.1 Commento<br />
2.10 Lettera X: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong><br />
2.10.1 Commento<br />
2.11 Lettera XI (XIV): <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.11.1 Commento<br />
2.12 Lettera XII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.12.1 Commento<br />
2.13 Lettera XIII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
2.13.1 Commento<br />
2.14 Lettera XIV: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong><br />
2.14.1 Commento<br />
3 Note<br />
4 I codici contenenti l'epistolario<br />
5 Bibliografia<br />
6 Voci correlate<br />
La leggenda del Cristianesimo di <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
La datazione del carteggio [modifica]<br />
Cordova: monumento a <strong>Seneca</strong><br />
È ancor oggi diffusa convinzione che nel Medioevo si ritenesse Lucio Anneo <strong>Seneca</strong><br />
un cristiano: prima di verificare il reale fondamento di tale convincimento, è opportuno<br />
rilevare che la leggenda dell'esistenza di un'amicizia tra lo scrittore latino e l'apostolo<br />
<strong>Paolo</strong> trae la propria origine soltanto a partire dal IV secolo e proprio in virtù<br />
dell'apparizione in quegli anni di un epistolario attribuito a <strong>Seneca</strong> e a <strong>Paolo</strong> di Tarso.<br />
Nei secoli precedenti nessun Padre della Chiesa aveva mai considerato <strong>Seneca</strong> un<br />
cristiano né era stato a conoscenza di una sua amichevole relazione con <strong>Paolo</strong>. Alla<br />
fine del II secolo Tertulliano (De anima, 20, 1) scrive che «<strong>Seneca</strong> saepe noster» -<br />
<strong>Seneca</strong> è spesso cristiano - proprio perché tale non lo considerava, malgrado vi<br />
fossero elementi del pensiero di <strong>Seneca</strong> assonanti con l'etica cristiana; all'inizio del IV<br />
secolo Lattanzio lo dichiara ancora «uomo ignaro della vera religione che avrebbe<br />
potuto appartenere al Cristianesimo se qualcuno glielo avesse fatto conoscere».[1]<br />
In base alla testimonianza di Lattanzio si può pertanto stabilire come termine post<br />
quem di compilazione del carteggio l'anno 324 circa, periodo entro il quale lo scrittore<br />
portò a termine la revisione della sua opera maggiore; il termine ante quem è stabilito<br />
con certezza nel 392, anno nel quale san Girolamo dimostra di essere a conoscenza<br />
di quella corrispondenza. In quell'anno scrive infatti Girolamo che «Lucio Anneo
<strong>Seneca</strong> di Cordova fu discepolo dello stoico Sozione e suocero del poeta Lucano. Si<br />
distinse per la grande purezza dei suoi costumi. Non lo avremmo compreso fra gli<br />
scrittori ecclesiastici senza la corrispondenza con <strong>Paolo</strong> che alcuni autori gli<br />
attribuiscono. Benché fosse precettore di Nerone e il più influente personaggio del suo<br />
tempo, egli dichiara nelle sue lettere che preferirebbe avere fra i suoi concittadini lo<br />
stesso rango che <strong>Paolo</strong> occupava fra i cristiani. Morì per ordine di Nerone due anni<br />
prima che <strong>Paolo</strong> e Pietro ricevessero la palma del martirio».[2]<br />
Dürer, San Girolamo nello studio (1521)<br />
È da rilevare la prudenza di Girolamo: egli non avrebbe considerato <strong>Seneca</strong> un amico<br />
di <strong>Paolo</strong> se non fosse esistito quel carteggio che egli conosce direttamente - come<br />
mostra il passo che egli cita, «qui meus tuus apud te locus, qui tuus velim ut meus»,<br />
tratto dalla lettera XII - ma sull'autenticità del quale non si pronuncia, lasciandone<br />
l'onere a non precisati «autori», mentre condivide la conclamata opinione della<br />
presunta purezza di costumi di <strong>Seneca</strong>.<br />
Se è certo che in nessun suo scritto Girolamo ha mai considerato il filosofo latino un<br />
cristiano, è controverso se il Padre della Chiesa ritenesse autentico o meno<br />
l'epistolario e credesse perciò all'amicizia tra <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong> di Tarso: il Fleury [3]<br />
risponde affermativamente, a condizione però di ipotizzare l'esistenza di un originario<br />
carteggio in greco - di cui peraltro non vi è notizia alcuna - non ritenendo possibile che<br />
egli abbia potuto essere ingannato da una «composizione di troppo bassa lega». Il<br />
motivo per il quale Girolamo non si pronuncia sull'autenticità dell'epistolario può essere<br />
tuttavia che la notizia di un'amicizia tra <strong>Paolo</strong> e un intellettuale del livello di <strong>Seneca</strong><br />
tornava a tutto vantaggio del prestigio della nascente religione e dei suoi maggiori<br />
rappresentanti. Infatti, il De viris illustribus ha un intento dichiaratamente polemico<br />
contro la cultura pagana, come premette lo stesso Girolamo: «Celso, Porfirio, Giuliano,<br />
questi cani arrabbiati contro Cristo, così come i loro seguaci che pensano che la<br />
Chiesa non abbia mai avuto oratori, filosofi e colti dottori, sappiano quali uomini di<br />
valore l'hanno fondata, edificata, illustrata, e smettano le loro sommarie accuse di<br />
rozza semplicità contro la nostra fede».[4]<br />
Anche Sant'Agostino era a conoscenza dell'esistenza del carteggio: verso il 413<br />
scriveva a Macedonio [5] di «<strong>Seneca</strong>, che visse ai tempi apostolici, del quale si<br />
leggono anche alcune lettere a <strong>Paolo</strong>», dove non è chiaro se egli abbia mai<br />
direttamente letto quelle lettere. In ogni caso, sia la neutra ma comunque autorevole<br />
testimonianza di Girolamo e Agostino, sia il sermone apocrifo, attribuito a quest'ultimo,<br />
ma del XII secolo,[6] che dichiarava <strong>Seneca</strong> «quel famoso pagano amico carissimo del<br />
santissimo Apostolo», faranno a lungo credere autentico il carteggio e incontestabile la<br />
loro amicizia.<br />
La leggenda dell'amicizia di <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong> [modifica]
Circa un secolo dopo la lettera di Agostino, nella Passio sancti Pauli apostoli,<br />
rielaborazione latina, attribuita falsamente a papa Lino, degli Atti apocrifi di Pietro e<br />
<strong>Paolo</strong>, viene aggiunta la notizia della corrispondenza di <strong>Paolo</strong> e <strong>Seneca</strong>, e persino di<br />
loro personali colloqui - quatinus si ore ad os alloqui non valeret, frequentibus datis et<br />
acceptis epistolis ipsius dulcedine et amicali colloquio atque consilio frueretur [7] - non<br />
però di una conversione di <strong>Seneca</strong> al Cristianesimo.<br />
Trascorsi tre secoli, l'epistolario viene pubblicato nel IX secolo da Alcuino e dedicato a<br />
Carlo Magno: dal cronachista dell'epoca, Freculfo di Lisieux,[8] ai successivi Onorio<br />
d'Autun,[9] Vincenzo di Beauvais [10] Ottone di Frisinga,[11] Pietro Comestore,[12] e<br />
Martino Polono,[13] sono tutti convinti dell'amicizia dei due personaggi ma nessuno di<br />
essi ritiene <strong>Seneca</strong> un cristiano. Anche i ben più autorevoli Pietro il Venerabile,[14]<br />
Abelardo [15] e Giovanni di Salisbury [16] citano le lettere, senza dedurre alcuna<br />
conversione di <strong>Seneca</strong> al Cristianesimo.<br />
L'evoluzione della leggenda: il Cristianesimo di <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
Il primo a fare di <strong>Seneca</strong> un cristiano sembra essere stato il domenicano Giovanni<br />
Colonna (c. 1298 - c. 1343), il quale nel suo De viris illustribus sostiene che <strong>Seneca</strong><br />
«fu spesso creduto cristiano, specie quando il grande dottore Girolamo lo inserì nel<br />
suo santo catalogo [...] ma sono indotto a credere che egli sia stato cristiano in base a<br />
quelle lettere note in tutto il mondo, intitolate <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> e <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong>».[17]<br />
Dunque, fu più l'analisi del carteggio che la memoria di una tradizione a indurre il dotto<br />
frate a convincersi del Cristianesimo di <strong>Seneca</strong>.<br />
Giusto Lipsio<br />
Commentando il <strong>Seneca</strong> morale di Dante,[18] il Boccaccio pensa che le lettere, «bene<br />
intese, assai chiaro mi pare dimostrino san <strong>Paolo</strong> lui avere per cristiano» e giunge a<br />
interpretare la notizia di Tacito della libagione di <strong>Seneca</strong> suicida a Giove Liberatore [19]<br />
come un battesimo: «quantunque il battesimo della fede avesse [...] non essendo<br />
rigenerato secondo il comune uso de' cristiani nel battesimo dell'acqua e dello Spirito<br />
Santo, quell'acqua in fonte battesimale consecrasse a Giove Liberatore, cioè a Iesù<br />
Cristo [...] né osta il nome di Giove, il quale altra volta è stato mostrato ottimamente<br />
convenirsi a Dio, anzi a lui, e non ad alcuna creatura». Considerazioni condivise nel<br />
XV secolo dal letterato Sicco Polenton che, oltre al battesimo da se stesso impartito,<br />
immagina che <strong>Seneca</strong> detti il proprio epitaffio concluso dal verso Namque animam<br />
caelo reddimus, ossa tibi [20]<br />
A partire dal XV secolo l'affinamento della critica filologica umanistica e la conoscenza<br />
delle opere autentiche di <strong>Seneca</strong> permette a Lorenzo Valla,[21] a Celio Secondo<br />
Curione [22] e a Giusto Lipsio [23] di contestare apertamente e con argomenti di merito<br />
l'autenticità della corrispondenza, anche se non mancano argomenti opposti e di moda<br />
nel XVI secolo [24]: per Sisto Senese, <strong>Seneca</strong> avrebbe utilizzato uno stile rozzo per
dissimularne la paternità qualora in alienas manus apistolas venissent [25] mentre nel<br />
Seicento Françisco de Bivar, commentando il Dextri Chronicon - una storia universale<br />
attribuita all'amico di Girolamo, il senatore Flavio Lucio Dexter, ma in realtà<br />
falsificazione del gesuita Jerónimo Román de la Higuera - vi legge la notizia della<br />
segreta conversione al Cristianesimo di <strong>Seneca</strong>, discepolo di <strong>Paolo</strong>, al quale avrebbe<br />
scritto mentre l'apostolo non si trovava a Roma ma in Spagna.[26]<br />
Naturalmente, l'inserimento degli elementi romanzeschi ha lo scopo di rendere più<br />
credibile la leggenda e il vantaggio di appianarne le contraddizioni, ma le contestazioni<br />
dell'autenticità del carteggio si erano infittite: nella sua edizione delle opere di <strong>Seneca</strong>,<br />
Erasmo, ribadendo la matrice pagana del suo pensiero, considera «freddo e inetto»<br />
l'anonimo compilatore e accusa Girolamo di malafede e di aver abusato della credulità<br />
dei semplici non denunciando il falsario.[27] Concordano anche Teodoro di Beza,[28] il<br />
cardinale Bellarmino [29] e il Tillemont che tuttavia non vuole escludere che i due<br />
possano essersi realmente conosciuti.[30]<br />
Nel XVIII secolo la definizione del carteggio come apocrifo e la contestuale negazione<br />
del Cristianesimo senechiano sembrano essersi imposte ma, forse anche per il mutato<br />
clima politico cui corrisponde il recupero di una particolare sensibilità religiosa, con<br />
l'Ottocento riprendono vigore le tesi dell'autenticità dell'epistolario e del <strong>Seneca</strong><br />
cristiano. Joseph de Maistre si dichiara «sicuro che <strong>Seneca</strong> ha ascoltato san<br />
<strong>Paolo</strong>»,[31] mentre l'archeologo pontificio Giovanni Battista de Rossi, scoprendo nel<br />
1867 un'iscrizione ad Ostia - D M / M. ANNAEO / PAULO PETRO / M. ANNEUS<br />
PAULUS / FILIO CARISSIMO - della fine del II secolo, deduce che, siccome dei<br />
membri della famiglia degli Annei erano cristiani, lo fosse anche il celebre antenato.[32]<br />
Lo sforzo maggiore per sostenere l'esistenza di rapporti di <strong>Paolo</strong> e <strong>Seneca</strong> è compiuto<br />
da Amédée Fleury,[33] che sottolinea le assonanze del pensiero cristiano con quello di<br />
<strong>Seneca</strong> e deduce la possibilità di contatti fra le due personalità dal fatto che il fratello<br />
del filosofo, il proconsole dell'Acaia Gallione, aveva conosciuto <strong>Paolo</strong>, trascinato in<br />
giudizio davanti a lui dagli Ebrei, secondo la testimonianza degli Atti degli Apostoli (18,<br />
12-17). Ma dall'atteggiamento sprezzante tenuto da Gallione - «se sono questioni<br />
riguardanti parole, nomi e la vostra legge, vedetevela voi, perché non voglio essere<br />
giudice di tali cose. E li cacciò dal tribunale» - non si vede come egli avrebbe potuto<br />
far da tramite tra <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong>, come sostiene il Fleury,[34] interessandosi delle<br />
opinioni e degli scritti di <strong>Paolo</strong> di Tarso, fino a mandare al fratello «estratti di prediche<br />
o frammenti di lettere che <strong>Seneca</strong> avrebbe avuto fra le mani fin da allora».[35]<br />
La critica moderna: autori e scopo del carteggio [modifica]<br />
Arnaldo Momigliano<br />
Svanito il tentativo di dare un nome all'autore del carteggio,[36] la ricerca si è<br />
concentrata modernamente a stabilire la sussistenza o meno di un'unità nella
corrispondenza. Per il Momigliano l'autore è unico e soltanto le date in calce alle<br />
ultime lettere sono state apposte da una mano estranea qualche anno dopo.[37] Per il<br />
Barlow, invece, si tratterebbe dell'opera di forse tre autori i quali, appartenenti a una<br />
scuola di retorica, avrebbero sostenuto semplicemente un'esercitazione assegnata dal<br />
loro maestro.[38]<br />
Già il Westerburg [39] volle distinguere tra le lettere X, XI e XII, attribuite al IV secolo, in<br />
quanto riportanti una data corretta, con tutte le altre, attribuite al VI secolo perché non<br />
datate o, secondo lui, datate scorrettamente, come la XIII e la XIV. In realtà si accertò<br />
poi che i due consoli citati nelle lettere, Petronio Lurcone e Paconio Sabino, furono<br />
effettivamente consoli suffetti [40] nell'anno 58. Se si considera poi che la datazione<br />
per consoli suffetti venne a cessare alla fine del III secolo,[41] è decisamente<br />
improbabile che un falsario del VI secolo potesse essere in grado di utilizzarla.<br />
In alcuni codici - il Vindobonensis 969 e il Parisinus latinus 2772 - mancano le lettere<br />
XIII e XIV e nel Bernensis 225 manca la XIV: è possibile però che essere alla fine<br />
della serie abbia favorito la loro perdita. Non vi sono, inoltre, nelle lettere,<br />
disomogeneità linguistiche tali da rendere necessaria l'ipotesi di un diverso autore e di<br />
una diversa datazione: vi sono tuttavia difformità di contenuto. Se Nerone è presentato<br />
nella XI lettera come feroce tiranno e crudele persecutore, altrove è persino visto ben<br />
disposto nei confronti dei Cristiani. La XIV lettera, poi, sembra esprimere una<br />
concezione neo-platonica del Verbo e, in generale, sembra voler accennare a<br />
problemi teologici che sono invece del tutto estranei agli interessi puramente retorici<br />
delle altre lettere.<br />
Se esistono dubbi sulla presenza di un secondo autore per la lettera XIV, non ne<br />
esiste alcuno sul fatto che la lettera XI sia un'interpolazione. Costituiscono indizi<br />
sufficienti aver presentato differentemente la figura di Nerone, scagionato <strong>Seneca</strong> da<br />
ogni responsabilità della persecuzione, accomunato gli ebrei alle vittime della<br />
repressione - in altre lettere essi sono guardati con ostilità - turbato la regolare e logica<br />
successione delle lettere e confuso le date.<br />
Infatti, nell'epistolario le lettere dei due corrispondenti si succedono regolarmente: alla<br />
X lettera di <strong>Paolo</strong> dovrebbe seguire la logica risposta di <strong>Seneca</strong> (XII lettera), poi una<br />
successiva lettera di <strong>Paolo</strong> (XIV lettera) e infine l'ultima lettera di <strong>Seneca</strong> (nell'ordine<br />
che è stato tramandato, la XIII). Aggiungendo come undicesima la sua lettere<br />
sull'incendio, probabilmente il secondo falsario ha voluto datare la lettera precedente e<br />
le tre successive per «mettere in chiaro che mentre la lettera 11 appartiene al 64, la<br />
lettera precedente e le seguenti risalgono al 58 e 59: da questo punto di vista le lettere<br />
1-9 potevano rimanere senza data, se dovevano essere considerate anteriori alla<br />
lettera 10».[42] Se questo è vero, allora il secondo falsario ebbe a disposizione le<br />
ultime lettere del carteggio secondo l'ordine X-XIII-XIV-XII, che datò di conseguenza;<br />
solo un successivo intervento definirà l'ordine - pur insoddisfacente - con il quale le<br />
lettere ci sono infine pervenute.
I motivi per i quali si costruisce una falsa documentazione possono essere molteplici e<br />
di natura politica, ideologica, personale. Per il nostro carteggio si è ritenuto che il<br />
falsario fosse mosso dall'intento di rilevare l'affinità culturale esistente tra Stoicismo e<br />
Cristianesimo, dimostrando, di quest'ultimo, la piena legittimità di inserirsi nello<br />
sviluppo culturale del pensiero classico: in effetti, le lodi tributate da <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong><br />
nella I, VII, IX e XIII lettera sembrano dar ragione di questa interpretazione. Ma si<br />
tratta di un generico apprezzamento, non accompagnato da nessuna esposizione del<br />
pensiero cristiano e da alcun confronto delle tematiche cristiane con quelle proprie<br />
della cultura pagana.<br />
Non solo: <strong>Seneca</strong> non manca di far notare la povertà dello stile e le manchevolezze<br />
formali della scrittura di <strong>Paolo</strong>, presentato come uomo di poca cultura se non persino<br />
ignorante (lettere VII e XIII), bisognoso di studiare i fondamenti dell'esposizione<br />
retorica. E <strong>Paolo</strong> sembra riconoscere la giustezza della critica che gli viene rivolta,<br />
esprimentdo in tutto l'epistolario convinta deferenza rispetto al prestigioso letterato<br />
latino.<br />
Si può in definitiva ritenere che l'autore - anche a dispetto della propria pochezza<br />
formale - abbia inteso esortare gli scrittori cristiani allo studio della retorica classica e<br />
alla cura dello stile, esprimendo un'esigenza sentita tra i letterati e gli uomini colti del<br />
suo tempo, che comprendevano e denunciavano la modesta qualità dello stile delle<br />
Scritture.[43] Tale invito è accompagnato dalla difesa dell'alto contenuto morale e<br />
spirituale degli scritti cristiani e di <strong>Paolo</strong> in particolare che, come fu compreso da<br />
<strong>Seneca</strong>, così deve essere apprezzato da tutti gli uomini colti, anche non cristiani.<br />
Le lettere [modifica]<br />
Lettera I: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« I - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem<br />
Credo tibi, Paule, nuntiatum quod heri cum Lucilio nostro de apocrifis [1] et aliis<br />
rebus habuerimus. Erant enim quidam disciplinarum tuarum comites mecum. Nam in<br />
hortos Sallustianos [2] secesseramus, quo loco occasione nostri [3] alio tendentes hi<br />
de quibus dixi visis nobis adiuncti sunt. Certe quod tui praesentiam [4] optavimus, et<br />
hoc scias volo: [5] libello tuo lecto, id est de plurimis aliquas litteras [6] quas ad<br />
aliquam civitatem seu caput provinciae [7] direxisti [8] mira exortatione vitam<br />
moralem continentes, usquequaque referti sumus. Quos sensus non puto ex te<br />
dictos, sed per te, certe aliquando ex te et per te. Tanta enim maiestas earum est<br />
rerum tantaque generositate [9] clarent, ut vix suffecturas putem aetates hominum<br />
quae his institui perficique possint. Bene te valere, frater, cupio. [10] »<br />
Commento [modifica]<br />
(IT)<br />
« I - <strong>Seneca</strong> salut<br />
Credo, <strong>Paolo</strong>, che<br />
conversato di cose<br />
delle tue dottrine.<br />
della nostra prese<br />
dei quali ho parlat<br />
sappia che con la<br />
una città o piuttost<br />
retta condotta mor<br />
siano state dette n<br />
tuo. Davvero è tan<br />
penso che agli uom<br />
auguro di star ben
▪ [1] - Apocrifis, o apocriphis, apogriphis, apocryphys, ecc, è grecismo tardo latino,<br />
d'uso solo cristiano; qui significa «cose segrete, riservate agli iniziati», come già<br />
interpretava Lefèvre d'Etaples [44] Da escludere che possa significare «libri non<br />
canonici», come sostiene Erbetta,[45] ché sarebbe un'anacronistica ingenuità<br />
imperdonabile in un falsario<br />
▪ [2] - In hortos Sallustianos: i sontuosi giardini di Sallustio erano divenuti proprietà<br />
privata dell'imperatore già sotto Tiberio e nessuna fonte afferma che essi<br />
fossero aperti al pubblico al tempo di Nerone. È probabile che il falsario abbia<br />
immaginato l'incontro tra <strong>Seneca</strong> e i cristiani in una tale cornice nel conforme<br />
rispetto del topos che vuole che i dialoghi letterari e filosofici si svolgano nella<br />
cornice amena di una serena natura umanizzata, senza porsi «il problema se la<br />
presenza di questo gruppo di Cristiani nei giardini dell'imperatore fosse<br />
veramente attendibile dal punto di vista storico».[46]<br />
▪ [3] - occasione nostri, anziché nostra, secondo un uso raro nel latino classico ma<br />
frequente nella tarda latinità per l'influsso della traduzione pressoché letterale<br />
dal greco dei testi biblici.<br />
▪ [4] - tui praesentiam: formula simile alla precedente. È da notare l'analogia con<br />
l'espressione praesentia mei (παρουσίᾳ μου) di <strong>Paolo</strong> in Filippesi 2, 12.<br />
▪ [5] - hoc scias volo: altra locuzione frequente in <strong>Paolo</strong>.[47]<br />
▪ [6] - libello tuo ... aliquas litteras: classicamente, libellus si riferisce a una sola<br />
lettera; qui è riferito invece a un gruppo di lettere - de plurimis aliquas litteras - di<br />
<strong>Paolo</strong>. Il falsario suppone che già vivente <strong>Paolo</strong> circolasse la raccolta delle sue<br />
lettere nelle comunità cristiane. L'accusativo aliquas litteras - presente in quasi<br />
tutti i codici e corretto dai copisti in aliquibus litteris solo in quattro codici più<br />
recenti - è un errore dovuto all'attrazione del successivo accusativo quas.<br />
▪ [7] - caput provinciae: espressione tardo-latina.<br />
▪ [8] - litteras direxisti: altra espressione del linguaggio parlato, divenuta comune nella<br />
scrittura letteraria tardo-latina.<br />
▪ [9] - generositate: generositas appartiene alla retorica della terminologia classica,<br />
«nel senso di grande, pomposo, brillante»;[48] nel latino tardo significa, come<br />
qui, la grandezza derivata dall'ispirazione divina, già enfatizzata dal precedente<br />
non puto ex te dictos, sed per te, del tutto impropria in <strong>Seneca</strong>.<br />
▪ [10] - Bene te valere, frater, cupio: il frater è naturalmente formula cristiana: Il nostro<br />
autore usa, in tutte le sue lettere, una generica forma di saluto che non<br />
corrisponde né a quella delle vere lettere di <strong>Paolo</strong> né a quelle, di finzione<br />
letteraria, delle lettere di <strong>Seneca</strong>.[49] Anche dall'uso convenzionale di tali<br />
formule di saluto si potrebbe dedurre che questo carteggio non intende essere<br />
un'esercitazione stilistica, che obbligherebbe l'anonimo a una accurata<br />
imitazione dello stile epistolare dei due corrispondenti e a un'ampia citazione dei<br />
loro scritti.[50]<br />
Lettera II: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> [modifica]
(LA)<br />
« II - Annaeo <strong>Seneca</strong>e Paulus [1] salutem<br />
Litteras tuas hilaris heri accepi, ad quas rescribere statim potui, si praesentiam<br />
iuvenis, quem ad te eram missurus, habuissem. [2] Scis enim quando et per quem et<br />
quo tempore et cui quid dari committique debeat. [3] Rogo ergo non putes<br />
neglectum, dum personae qualitatem respicio. Sed quod litteris meis vos bene<br />
acceptos alicubi scribis, felicem me arbitror tanti viri iudicio. Nec enim hoc diceres,<br />
censor, [4] sophista, [5] magister tanti principis, etiam omnium, nisi quia vere dicis.<br />
Opto te diu bene valere. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Annaeo <strong>Seneca</strong>e Paulus: nelle lettere indirizzate da <strong>Paolo</strong>, il suo nome figura<br />
sempre dopo quello di <strong>Seneca</strong>, contrariamente all'uso classico, che vuole il<br />
nome del mittente precedere quello del destinatario. In effetti, dal II secolo la<br />
regola s'inverte e il nome del mittente viene più spesso posposto, come avviene<br />
regolarmente per le lettere indirizzate da inferiori a superiori e per quelle scritte<br />
da cristiani, come espressione di umiltà.[51] Il nostro autore presume che questa<br />
convenzione esistesse già nel I secolo e sottolinea altresì la differenza di fede:<br />
<strong>Seneca</strong>, di elevata condizione sociale ma anche pagano, antepone il proprio<br />
nome a quello di <strong>Paolo</strong>.<br />
▪ [2] - praesentiam iuvenis... habuissem: praesentiam iuvenis è espressione tarda. Nel<br />
I secolo non si sarebbe utilizzato l'astratto praesentia ma direttamente il<br />
concreto iuvenis. Il Fleury [52] sostiene che il falsario abbia tenuto presenti le<br />
vere lettere paoline che citano l'utilizzo di un giovane portalettere - Efesini 6, 21;<br />
Colossesi 4, 7; Romani 16, 22 - per rendere più credibile l'autenticità della<br />
lettera, ma lamentare l'assenza di un messaggero per giustificare un ritardo di<br />
risposta era anche un espediente retorico noto fin dall'antichità classica.[53]<br />
▪ [3] - quando et per quem et quo tempore et cui quid: barocco sfoggio pedantesco<br />
dell'anonimo che sembra aver avuto un'educazione retorica.[54]<br />
▪ [4] - censor: sta per giudice, censor morum o censor disciplinarum, come in<br />
Tertulliano, De pudicitia 14, 27.<br />
▪ [5] - sophista: in generale, ha sia il significato negativo di retore vacuo e verboso,<br />
quanto quello positivo, come l'originario σοφιστῄς, accolto da Cicerone, di<br />
retore eloquente in quanto ricco di dottrina filosofica, ossia di «oratorefilosofo».[55]<br />
Con il tempo, prevale il senso spregiativo, mentre quello elogiativo<br />
perde il significato di oratore-filosofo per assumere quello di «maestro di<br />
retorica», dal quale ogni riferimento alla filosofia viene decisamente a cadere.<br />
Così Mario Vittorino nel IV secolo definisce retore «colui che insegna letteratura<br />
ed eloquenza», è il maestro di tecnica oratoria, sofista è «colui che insegna<br />
l'arte del dire», è il maestro di pratica oratoria, mentre oratore è l'avvocato<br />
eloquente.[56] Le sottili distinzioni di Vittorino non impedivano nell'uso comune di<br />
confondere tra di loro i tre diversi appellativi: in ogni caso, per il nostro scrittore<br />
(IT)<br />
« II - Ad Anneo Se<br />
Con gioia ho ricev<br />
potuto disporre di<br />
a chi si debba dar<br />
trascurato, mentre<br />
scrivi da qualche p<br />
per il giudizio di un<br />
precettore di tanto<br />
credessi. Ti augur
<strong>Seneca</strong> è «maestro di retorica», e questo fa sospettare che egli confonda il<br />
filosofo Lucio Anneo con l'omonimo padre <strong>Seneca</strong> il retore, autore delle<br />
Oratorum et rhetorum sententiae, secondo una lunghissima contaminazione<br />
delle due figure attestata già nella tarda latinità e sciolta solo alla fine del XV<br />
secolo,[57] durante la quale si distinse un <strong>Seneca</strong> tragediografo da un <strong>Seneca</strong><br />
morale e insieme retore, nel quale confluì anche la figura del padre.[58] A parte<br />
queste considerazioni, la fervida ammirazione di <strong>Paolo</strong> per le virtù retoriche è in<br />
assoluto contrasto con la sua figura storica ma, ancora una volta, l'anonimo<br />
sembra interessato a presentare i primi cristiani come convinti ammiratori della<br />
cultura classica, di contro alle accuse di rozzezza e di ignoranza loro rivolte.<br />
Lettera III: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« III - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem.<br />
Quaedam volumina [1] ordinavi et divisionibus suis statum eis dedi. Ea quoque<br />
Caesari legere sum destinatus. Si modo fors prospere annuerit, [2] ut novas aures<br />
adferat, eris forsitan et tu praesens; sin, alias reddam tibi diem, ut hoc opus invicem<br />
inspiciamus. Et possem non edere ei eam scripturam, nisi prius tecum conferrem, si<br />
modo impune hoc fieri potuisset, hoc ut scires, non te praeteriri. Vale, Paule<br />
carissime. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Quaedam volumina: non si sa quali siano questi scritti di <strong>Seneca</strong> né si capisce<br />
perché egli debba farli leggere a <strong>Paolo</strong> prima di mostrarli a Nerone. Tutta la<br />
lettera appare «una finzione letteraria, un espediente per dar modo a <strong>Seneca</strong> di<br />
dimostrare quanta considerazione nutra nei confronti di S. <strong>Paolo</strong>».[59]<br />
▪ [2] - Fors prospere annuerit: tra gli altri, anche Erasmo criticò l'introduzione nella<br />
lettera della sorte in luogo di Dio o della provvidenza, che pure «<strong>Seneca</strong><br />
paganus toties nominat in scriptis suis»,[60]<br />
Lettera IV: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« IV - Annaeo <strong>Seneca</strong>e Paulus salutem<br />
Quotienscumque litteras tuas audio, praesentiam tui cogito nec aliud existimo quam<br />
omni tempore te nobiscum esse. Cum primum itaque venire coeperis, [1] invicem<br />
nos et de proximo [2] videbimus. Bene te valere opto. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Cum primum itaque venire coeperis: costruzione tardo-latina, per cum primum<br />
veneris, che si trova spesso nelle traduzioni dal greco della letteratura biblica,<br />
specie nella versione dell' Itala, portata a termine nel III secolo.<br />
▪ [2] - de proximo: il rafforzativo de, tratto dalla lingua parlata, si trova spesso in<br />
Tertulliano.<br />
(IT)<br />
« III - <strong>Seneca</strong> a Pa<br />
Ho messo in ordin<br />
di leggerli a Cesar<br />
insperato, forse po<br />
esaminare insieme<br />
prima averne parla<br />
tu sappia che non<br />
(IT)<br />
« IV - Ad Anneo S<br />
Ogni volta che leg<br />
se non che tu sei s<br />
persona. Ti auguro
Lettera V: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« V - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem<br />
Nimio tuo secessu angimur. Quid est? Quae te res remotum faciunt? Si indignatio<br />
dominae, [1] quod a ritu et secta [2] veteri recesseris et aliorsum converteris, [3] erit<br />
postulandi locus, ut ratione factum, non levitate hoc existimet. [4] Bene vale. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Domina è qui senz'altro imperatrice, come usa Svetonio. Il giudaismo di Poppea<br />
è attestato da Giuseppe Flavio nelle Antichità giudaiche (20, 8, 11 e 20, 11, 1);<br />
secondo Tacito (Annali, 16, 6), Poppea non fu cremata, secondo l'uso romano,<br />
ma fu sepolta secondo «l'uso dei re stranieri». Il giudaismo si era diffuso a<br />
Roma nel I secolo anche fra esponenti delle classi socialmentne elevate e in<br />
particolare fra le donne le quali «non trovavano l'ostacolo della circoncisione ed<br />
erano meno tenute alla partecipazione ai riti del culto ufficiale».[61]<br />
▪ [2] - ritu et secta: ritus indica nel IV secolo «religione»;[62] per il nostro anonimo<br />
secta sta proprio per giudaismo come appare anche nella epistola VIII, e anche<br />
negli Atti degli apostoli 26, 5 secta esprime direttamente la religione ebraica.<br />
▪ [3] - aliorsum converteris: nel IV secolo convertere non significa più soltanto<br />
rivolgersi ma già aderire al cristianesimo.[63]<br />
▪ [4] - Poppea si sarebbe potuta offendere alla notizia della conversione di <strong>Paolo</strong> solo<br />
se l'avesse conosciuto bene. La leggenda delle frequentazioni di <strong>Paolo</strong> con la<br />
corte neroniana nacque nel II secolo e viene riportata negli Atti apocrifi e di essa<br />
si mostra informato anche Giovanni Crisostomo che scrive dei rapporti di <strong>Paolo</strong><br />
con «una concubina di Nerone» [64] È da rilevare come solo in questo carteggio<br />
<strong>Seneca</strong> giochi un ruolo nell'ambito di quella leggenda, come figura intermediaria<br />
tra la corte imperiale e <strong>Paolo</strong>.<br />
Lettera VI: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> e a Lucilio [modifica]<br />
(LA)<br />
« VI - <strong>Seneca</strong>e et Lucilio Paulus salutem. [1]<br />
De his quae mihi scripsistis non licet harundine et atramento eloqui, [2] quarum<br />
altera res notat et designat aliquid, altera evidenter ostendit, praecipue cum sciam<br />
inter vos esse, hoc est apud vos et in vobis, [3] qui me intelligant. Honor omnibus<br />
habendus est, tanto magis quanto indignandi occasionem captant. [4] Quibus si<br />
patientiam demus, [5] omni modo eos et quaqua parte vincemus, si modo hi sunt qui<br />
paenitentiam sui gerant. [6] Bene valete. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Questa epistola appare la diretta risposta di <strong>Paolo</strong> alla lettera precedente: egli<br />
rifiuta l'intercessione presso Poppea proposta da <strong>Seneca</strong>.<br />
▪ [2] - harundine et atramento: harundo, nel significato di penna da scrivere, in luogo<br />
(IT)<br />
« V - <strong>Seneca</strong> a Pa<br />
Soffriamo per la tu<br />
l'indignazione dell'<br />
riti per rivolgerti al<br />
non per leggerezz<br />
(IT)<br />
« VI - A <strong>Seneca</strong> e<br />
Delle cose che mi<br />
perché la prima se<br />
che tra voi, cioè fr<br />
onorare tutti, sopra<br />
mostreremo conci<br />
parte, purché essi
di calamus, è termine soltanto poetico.[65] Poiché l'abbinamento calamus et<br />
atramentum è frequente nei testi sia classici che tardi, sembra che il nostro<br />
autore abbia voluto nobilitare retoricamente un'espressione di uso comune.<br />
▪ [3] - apud vos et in vobis: sono, rispettivamente, le comuni amicizie e quelle più<br />
intime<br />
▪ [4] - indignandi occasione captant: è l' indignatio di Poppea cui faceva riferimento la<br />
lettera precedente.<br />
▪ [5] - si patientiam demus: patientiam dare è una iunctura senza tradizione né<br />
classica né tarda; l'esortazione alla patientia, cristianamente intesa, non è la<br />
sopportazione stoica, ma è l'arrendevolezza di fronte all'avversione del nemico,<br />
testimoniata dalle autentiche lettere paoline. In questa lettera, patientia è invece<br />
la semplice accortezza a evitare i problemi che deriverebbero dal mettersi in<br />
conflitto con un potente.<br />
▪ [6] - paenitentiam sui gerant: anziché la comune paenitentiam agerant. Paenitentiam<br />
gerere è forma attestata in autori cristiani e la paenitentia - equivalente alla<br />
greca μετάνοια - indica il pentimento del convertito.<br />
Lettera VII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> e a Teofilo [modifica]<br />
(LA)<br />
« VII - Annaeus <strong>Seneca</strong> Paulo et Theophilo [1] salutem<br />
Profiteor bene me acceptum lectione litterarum tuarum quas Galatis Corinthiis<br />
Achaeis [2] misisti, et ita invicem vivamus, ut etiam cum honore divino eas exhibes.<br />
Spiritus enim sanctus in te et super excelsos sublimi ore satis venerabiles sensus<br />
exprimit. [3] Vellem itaque, cum res eximias proferas, ut maiestati earum cultus<br />
sermonis non desit. [4] Et ne quid tibi, frater, subripiam aut conscientiae meae<br />
debeam, confiteor Augustum sensibus tuis motum. Cui perlecto virtutis in te exordio,<br />
[5] ista vox fuit: mirari [6] eum posse ut qui non legitime imbutus sit taliter sentiat. Cui<br />
ego respondi solere deos ore innocentium effari, haut eorum qui praevaricare<br />
doctrina sua quid possint. [7] Et dato ei exemplo Vatieni hominis rusticuli, [8] cui viri<br />
duo adparuerunt in agro Reatino, qui postea Castor et Pollux sunt nominati, satis<br />
instructus videtur. Valete. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Theophilo: dalle fonti canoniche non risulta nessun Teofilo amico di <strong>Paolo</strong>. È<br />
possibile che l'anonimo abbia confuso Teofilo con Timoteo oppure [66] che abbia<br />
tratto quel nome dall'apocrifa lettera ai Corinzi 1, 1.<br />
▪ [2] - Corinthiis Achaeis: vi è chi interpreta «ai Corinzi dell'Acaia», ma Corinto non<br />
faceva parte dell'Acaia nella Grecia indipendente, mentre tutta la Grecia romana<br />
era denominata Acaia. Probabilmente occorre tradurre Acheis «agli Achei»,<br />
secondo il dettato della II Corinzi 1, 1: «Corinthi, cum omnibus sanctis, qui sunt<br />
in universa Acaia».<br />
(IT)<br />
« VII - Anneo Sen<br />
Confesso di esser<br />
Corinzi e agli Ache<br />
onorando Dio. In e<br />
esprime con bocca<br />
argomenti elevati,<br />
per non nasconde<br />
confesso che l'imp<br />
iniziasti la tua vita<br />
regolare istruzione<br />
esprimersi per boc<br />
utilizzando la sua<br />
nell'agro reatino a<br />
Polluce, e Nerone
▪ [3] - Spiritus ... exprimit: qui s'intende che <strong>Paolo</strong>, essendo ispirato da Dio, supera<br />
ogni ingegno umano e parla in modo sublime, esprimendo concetti elevatissimi -<br />
satis venerabiles - avendo qui satis significato di valde, come è comune quando<br />
si leghi a un aggettivo o a un avverbio. Naturalmente l'autentica concezione di<br />
<strong>Seneca</strong> era ben diversa da quella che l'anonimo intende accreditargli: egli non<br />
scrive mai di Spiritus santus, ma semmai di sacer spiritus, che è il «Pneuma», il<br />
principio vivificante che circola e permea tutta la realtà, e non trascende il<br />
mondo, come il Dio cristiano, né come Spirito discende sull'uomo per grazia.<br />
▪ [4] - Vellem... desit: il nostro autore sbaglia la consecutio temporum proprio quando<br />
si preoccupa di mettere in rilievo la sapienza retorica di <strong>Seneca</strong> rispetto alla<br />
pochezza della formazione culturale di <strong>Paolo</strong>! Chi legge il carteggio «rimane<br />
colpito dal fatto che manca tutto ciò che ci si aspetterebbe di trovare in un<br />
epistolario di <strong>Seneca</strong> e S. <strong>Paolo</strong>: manca a queste lettere una reale problematica<br />
filosofica e religiosa e non c'è da parte dell'anonimo la volontà di porre<br />
intenzionalmente a confronto Stoicismo e Cristianesimo. I problemi a cui l'autore<br />
dimostra di essere più sensibile sono quelli riguardanti la forma e lo stile. Ciò<br />
avvalora l'ipotesi [...] che l'anonimo, presentando <strong>Seneca</strong> come maestro di stile<br />
nei confronti di <strong>Paolo</strong>, confonda in una sola persona <strong>Seneca</strong> padre e <strong>Seneca</strong><br />
figlio».[67]<br />
▪ [5] - Cui perlecto virtutis in te exordio: passo controverso. Contro l'opinione del<br />
Barlow [68] che traduce «Quando il mio trattato sulla virtù che è in te gli fu letto»<br />
- dove non si capisce come «exordium» possa significare «trattato» - il Fleury<br />
interpreta exordium la conversione di <strong>Paolo</strong> al Cristianesimo, in quanto inizio<br />
della sua vita virtuosa, narrata nella lettera ai Galati.[69] Nella traduzione del<br />
passo è però da tener conto che la virtus testamentaria non è la classica areté<br />
ma semmai la dýnamis, il potere dato all'apostolo dall'ispirazione divina che lo<br />
anima.<br />
▪ [6] - mirari: è nota la leggenda, narrata negli Atti apocrifi, che certamente il nostro<br />
anonimo conosce, dello stupore di Nerone di fronte a parole e azioni di cristiani:<br />
per esempio, nella Passio sanctorum apostolorum Petri et Pauli, Nerone<br />
conosce e dialoga con <strong>Paolo</strong> e alle sue parole obstupuit.[70]<br />
▪ [7] - Con ciò si intende giustificare la presunta scarsa cultura di <strong>Paolo</strong> e dei cristiani<br />
in generale, e si polemizza con i pagani, spesso incapaci, malgrado o proprio a<br />
causa della loro erudizione, di cogliere le verità del messaggio cristiano.<br />
▪ [8] - Vatieni hominis rusticuli: la leggenda di Publio Vatinio (o Vatieno o Vacieno) fu<br />
molto popolare per secoli ed è narrata per la prima volta da Cicerone (De natura<br />
deorum II, 6): «mentre di notte tornava a Roma da Rieti, di cui era prefetto, due<br />
giovani su due cavalli bianchi gli dissero che il re Perseo di Macedonia era stato<br />
fatto prigioniero quel giorno stesso. Informato il Senato, fu in un primo tempo<br />
gettato in carcere per aver parlato sconsideratamente di affari di Stato ma poi,<br />
giunte le lettere di <strong>Paolo</strong> che confermavano il fatto e il giorno, dal Senato gli fu<br />
donato un campo e fu esentato dal servizio militare»; Cicerone chiama Vatinio
homo rusticus in un successivo passo (III, 11), chiedendosi perché i due dei non<br />
dessero piuttosto la notizia a Catone, allora princeps, «il cittadino più in vista<br />
della città». Contro la diffusa immagine di un <strong>Paolo</strong> rusticulus polemizzò san<br />
Girolamo nell' Apologeticum ad Pammachium: egli afferma che le sue parole<br />
sembrerebbero sì simplicia et quasi innocentis hominis ac rusticani ma a<br />
guardar bene si rivelano tronitrua et fulmina e <strong>Paolo</strong> stesso un artifex prudens.<br />
Lettera VIII: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« VIII - <strong>Seneca</strong>e Paulus salutem. [1]<br />
Licet non ignorem Caesarem nostrum rerum admirandarum, si quando deficiet,<br />
amatorem esse, [2]permittes tamen te non laedi, sed admoneri. Puto enim te<br />
graviter fecisse, quod ei in notitiam perferre voluisti quod ritui et disciplinae eius sit<br />
contrarium. Cum enim ille gentium deos colat, quid tibi visum sit ut hoc scire eum<br />
velles non video, nisi nimio amore meo facere te hoc existimo. [3] Rogo de futuro ne<br />
id agas. Cavendum est enim ne, dum me diligis, offensum dominae facias, cuius<br />
quidem offensa neque oberit, si perseveraverit, neque, si non sit, proderit; si est<br />
regina, non indignabitur, si mulier est, offendetur. Bene vale. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - In questa lettera <strong>Paolo</strong> rimprovera <strong>Seneca</strong> per aver fatto conoscere i suoi scritti<br />
a Nerone, ritenendo imprudente tale iniziativa, malgrado l'ammirazione<br />
dimostrata dall'imperatore.<br />
▪ [2] - rerum admirandarum ... amatorem esse: ritorna qui il motivo del Nerone amante<br />
dei racconti meravigliosi.<br />
▪ [3] - Cum enim ... existimo: qui l'autore sembra tener presente la I Lettera ai Corinzi<br />
[71] nella quale <strong>Paolo</strong> invita a comportarsi in modo da non dare scandalo.<br />
Lettera IX: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« IX - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem.<br />
Scio te non tam tui causa commotum litteris quas ad te de editione epistolarum<br />
tuarum Caesari feci quam natura rerum, quae ita mentes hominum ab omnibus<br />
artibus et moribus rectis revocat, ut non hodie admirer, quippe ut multis documentis<br />
hoc iam notissimum habeam. Igitur nove agamus, et si quid facile in praeteritum<br />
factum est, veniam inrogabis. Misi tibi librum de verborum copia. [1] Vale, Paule<br />
carissime. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - De verborum copia: di quest'opera - Sulla facondia - che dovrebbe essere un<br />
manuale di retorica, non vi è traccia tra le opere attribuite a <strong>Seneca</strong>, ma figura<br />
come titolo in alcuni codici dell'XI secolo di un miscellanea di autentiche lettere<br />
(IT)<br />
« VIII - A <strong>Seneca</strong><br />
So bene che il nos<br />
a volte, ma perme<br />
in modo inopportu<br />
alla sua religione.<br />
come ti sia venuto<br />
pensare che tu l'ab<br />
non farlo più. Devi<br />
rancore, se lei per<br />
utile; comportando<br />
come una donna q<br />
(IT)<br />
« IX - <strong>Seneca</strong> a P<br />
So bene che non s<br />
delle tue lettere a<br />
ogni abitudine e co<br />
noto da tante prov<br />
qualcosa con legg<br />
bene, carissimo P
di <strong>Seneca</strong> e del trattato morale del vescovo Martino di Braga, la Formula vitae<br />
honestae, composto nel VI secolo. In seguito, è avvenuto che da taluno [72]<br />
erroneamente si identificasse senz'altro la Formula vitae honestae con il De<br />
verborum copia, deducendo così che il carteggio di <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong> fosse<br />
posteriore al VI secolo, nella presunzione che il nostro falsario scrivesse<br />
conoscendo l'opera del vescovo Martino. Ipotesi inconsistente, sia perché il<br />
nostro carteggio, come detto, non è certamente posteriore al IV secolo, sia<br />
perché lo scritto di Martino tratta di argomenti morali, mentre questa presunta<br />
opera si occupa di retorica, né mai Martino, che titolò esplicitamente [73] Fortuna<br />
vitae honestae il suo trattato, risulta avervi aggiunto altri titoli. Fu dunque la<br />
conoscenza di questa lettera a provocare, dopo il VI secolo, la falsa<br />
identificazione delle due opere. Resta aperto il problema se il falsario, come<br />
sembra più probabile, fosse a conoscenza di un tale scritto di retorica - da<br />
attribuirsi semmai a <strong>Seneca</strong> il vecchio - o se invece se ne sia semplicemente<br />
inventata l'esistenza.<br />
Lettera X: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« X - <strong>Seneca</strong>e Paulus salutem.<br />
Quotienscumque tibi scribo et nomen meum subsecundo, [1] gravem sectae meae<br />
et incongruentem [2] rem facio. Debeo enim, ut saepe professus sum, cum omnibus<br />
omnia esse et id observare in tua persona quod lex Romana [3] honori senatus<br />
concessit, perfecta epistola ultimum locum eligere, ne cum aporia et dedecore<br />
cupiam efficere quod mei arbitrii fuerit. Vale, devotissime [4] magister. Data V Kal.<br />
Iul. Nerone III et Messalla consulibus. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - subsecundo: il problema manifestato da <strong>Paolo</strong> in questa lettera è che egli pur<br />
scrivendo il proprio nome subito dopo quello di <strong>Seneca</strong>, nel segno di una umiltà<br />
tipicamente cristiana - ma, come già osservato, anacronistica nel I secolo -<br />
pensa che dovrebbe in realtà inserirlo in fondo alla lettera, perché così, nel caso<br />
di lettere indirizzate a un senatore, prevederebbe una legge romana, o almeno<br />
una consuetudine.<br />
▪ [2] - gravem ... et incongruentem: endiadi.<br />
▪ [3] - lex romana: di tale legge non risulta esistenza, ma potrebbe trattarsi di una<br />
norma, come scrive Gaio Giulio Vittore (Rethorica, 27): «Praefationes ac<br />
subscriptione litterarum computandae sunt pro discrimine amicitiae aut<br />
dignitatis, habita ratione consuetudinis».<br />
▪ [4] - devotissime: devotus assunse distinzione onorifica solo nel IV secolo.<br />
Lettera XI (XIV): <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA) (IT)<br />
(IT)<br />
« X - A <strong>Seneca</strong> Pa<br />
Ogni volta che ti s<br />
gravemente incon<br />
essere tutto per tu<br />
legge romana rico<br />
non volendo fare a<br />
devotissimo maes<br />
Messala. »
« XI (XIV) - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem. [1]<br />
Ave, mi Paule carissime. Putasne me aut contristari et non luctuosum esse quod de<br />
innocentia vestra subinde supplicium sumatur? Dehinc quod tam duros tamque<br />
obnoxios vos reatui omnis populus iudicet, putans a vobis effici quicquid in urbe<br />
contrarium fit? Sed feramus aequo animo et utamur foro [2] quod sors concessit,<br />
donec invicta felicitas [3] finem malis imponat. Tulit et priscorum aetas Macedonem,<br />
Philippi filium, Cyros Darium Dionysium, nostra quoque Gaium Caesarem, quibus<br />
quicquid libuit licuit. [4] Incendium urbs Romana manifeste saepe unde [5]patiatur<br />
constat. Sed si effari humilitas humana potuisset quid causae sit et impune in his<br />
tenebris loqui liceret, iam omnes omnia [6] viderent. Christiani et Iudei [7] quasi<br />
machinatores incendii - pro! - supplicio adfecti fieri solent. Grassator [8] iste quisquis<br />
est, cui voluptas carnificina est et mendacium velamentum, tempori suo [9]<br />
destinatus est, et ut optimus quisque unum pro multis datum est caput, [10] ita et hic<br />
devotus pro omnibus igni cremabitur. Centum triginta duae domus, insulae quattuor<br />
milia [11] sex diebus arsere; septimus pausam dedit. Bene te valere, frster, opto.<br />
Data V Kal. Apr. Frugi et Basso consulibus. [12] »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Questa lettera, datata all'anno 64, subito dopo l'incendio di Roma, interrompe il<br />
filo logico della corrispondenza - la risposta di <strong>Seneca</strong>, con data 29 marzo 59,<br />
alla precedente lettera di <strong>Paolo</strong> è infatti rappresentata dalla lettera XII - e<br />
dovrebbe pertanto essere l'ultima del carteggio. È generalmente considerata di<br />
altra mano ancora: forse fu interpolata in questa posizione per l'errore dovuto al<br />
fatto di avere lo stesso incipit della XII, Ave, Paule carissime.<br />
▪ [2] - uti foro: l'espressione, usata da Terenzio (Phormio 79) e nell'anonimo Querolus,<br />
era proverbiale e significava «saper stare al mondo, sfruttare l'occasione<br />
buona»; è possibile però che qui il nostro scrittore la usi in altro senso, e il<br />
passo potrebbe tradursi: «accettiamo il nostro destino».<br />
▪ [3] - invicta felicitas: per un cristiano è la beatitudine dell'altra vita, come in Agostino<br />
(Sermone 280) è perpetuae felicitatis premium o (De civitate 7) aeternae vitae<br />
felicitatem. Naturalmente, in <strong>Seneca</strong> (Dialoghi VII, 2, 2) la felicitas non ha nulla<br />
di sovrannaturale: in virtute posita est vera felicitas e l'immortalità dell'anima non<br />
esiste.[74]<br />
▪ [4] - quibus quicquid libuit licuit: altra espressione proverbiale, che Dante (Inferno V,<br />
56) riportò nel noto «libito fe' licito in sua legge».<br />
▪ [5] - saepe unde: unde indica chiaramente Nerone, meno chiaro è se saepe si<br />
riferisca in generale agli incendi patiti da Roma nella sua storia o, come tuttavia<br />
sembra probabile nel testo, proprio durante il regno di Nerone.<br />
▪ [6] - omnes omnia: casi di polittoti come questo si trovano anche in <strong>Paolo</strong>, I Corinzi<br />
9, 22: «Omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos» e 10, 33: «ego<br />
per omnia omnibus placeo non quaerens».<br />
▪ [7] - Iudei: non è attestato che anche gli Ebrei fossero accusati dell'incendio. È<br />
« XI (XIV) - Senec<br />
Salve, mio carissim<br />
che voi innocenti s<br />
incalliti e portati al<br />
città? Ma sopporti<br />
sorte, finché la be<br />
dovuto subire il Ma<br />
Caligola, ai quali f<br />
subisca spesso un<br />
e fosse permesso<br />
tutto. Cristiani ed E<br />
organizzatori dell'i<br />
carneficina e che s<br />
migliore tra gli uom<br />
nel fuoco per tutti.<br />
condomìni; il settim<br />
marzo [dell'anno 6
possibile che il nostro scrittore abbia presente Svetonio (Claudio, 25), Iudeos<br />
impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit, dove per altro lo storico<br />
non distingue tra Cristiani ed Ebrei.<br />
▪ [8] - Grassator: in Nerone 36, Svetonio scrive Nec minore saevitia ... grassatus est.<br />
Nella lettera appare l'identificazione di Nerone con l'Anticristo: «Nella persona di<br />
Nerone (tiranno, persecutore, Anticristo) culmina la sintesi cristiana della<br />
tradizione letteraria antitirannica pagana con la letteratura apocalittica giudaica:<br />
nei Cristiani si ritrovano tutti gli elementi topici dell'invettiva antitirannica pagana<br />
arricchiti dei toni profetici e oscuramente minacciosi delle Apocalissi».[75]<br />
▪ [9] - tempore suo: allusione alla fine dei tempi.<br />
▪ [10] - unum pro multis datum est caput: citazione di Virgilio (Eneide 5, 815): Unum<br />
pro multis dabitur caput, dove la morte di Palinuro permette ai compagni di<br />
scampare al naufragio.<br />
▪ [11] - Centum ... milia: le precise informazioni sulle distruzioni provocate dall'incendio<br />
appaiono attendibili, in quanto il rapporto di circa 1:30 tra domus e insulae è<br />
attestato dalla mappa della città di Roma del IV secolo. Poiché gli storici del<br />
tempo non danno il numero delle domus e delle insulae andate distrutte,[76]<br />
resta il problema se questo secondo falsario abbia inventato le cifre date nella<br />
lettera deducendole dai Regionari del IV secolo o se le abbia attinte da una<br />
fonte del I secolo andata poi perduta.<br />
▪ [12] - Data V Kal. Apr. Frugi et Basso consulibus: 28 marzo 64. L'incendio iniziò<br />
invece, secondo Tacito (Annali 15, 41), il 19 luglio, XIIII Kal. Sextiles principium<br />
incendii. Secondo il Momigliano [77] la data dell'incendio sarebbe stata anticipata<br />
ad arte per far sì che <strong>Paolo</strong> - morto, secondo la tradizione, il 29 giugno 64 e<br />
dunque prima dell'incendio - potesse essere ancora in corrispondenza con<br />
<strong>Seneca</strong> e poi cadere vittima della persecuzione neroniana. Si ritiene, inoltre, che<br />
l'autore di questa lettera abbia aggiunto le date presenti in calce alle altre<br />
quattro lettere dell'epistolario.<br />
Lettera XII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« XII - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem. [1]<br />
Ave, mi Paule carissime. Si mihi nominique meo vir tantus et a Deo dilectus omnibus<br />
modis, non dico fueris iunctus, sed necessario mixtus, [optume] actum erit de<br />
<strong>Seneca</strong> tuo. [2] Cum sis igitur vertex et altissimorum omnium montium cacumen, non<br />
ergo vis laeter, si ita sim tibi proximus ut alter similis tui deputet? [3] Haut itaque te<br />
indignum prima facie epistolarum nominandum [4] censeas, ne temptare me quam<br />
laudare videaris, quippe cum scias te civem esse Romanum. Nam qui meus tuus<br />
apud te locus, qui tuus velim ut meus. [5] Vale, mi Paule carissime. Data X Kal. Apr.<br />
Aproniano et Capitone consulibus. »<br />
Commento [modifica]<br />
(IT)<br />
« XII - <strong>Seneca</strong> a P<br />
Salve, mio <strong>Paolo</strong> c<br />
aspetto sarà, non<br />
la cosa migliore pe<br />
non vuoi che mi ra<br />
te stesso? Non rite<br />
lettere, ché altrime<br />
sapendo bene di e<br />
vorrei che il tuo pr<br />
marzo [dell'anno 5
▪ [1] - <strong>Seneca</strong> risponde alla lettera X di <strong>Paolo</strong>.<br />
▪ [2] - La corruzione del testo ha reso necessaria l'aggiunta dell'avverbio optume,<br />
senza il quale il senso della frase sarebbe opposto a quello logico.[78]<br />
▪ [3] - vedi nota [5]<br />
▪ [4] - indignum ... nominandum: in luogo del classico indignum nominari. Il gerundio<br />
invece dell'infinito è uso della latinità tarda, come in Agostino, Epistola CXVIII, 3,<br />
16: «fruendum Deo [...] bonum nostrum esse dicunt».<br />
▪ [5] - meus tuus ... ut meus: nel passo si gioca sul duplice significato di locus,<br />
posizione del loro nome nella lettera e la posizione personale di <strong>Seneca</strong> e di<br />
<strong>Paolo</strong> nel mondo. Si confronti con la Praefatiuncula di Ausonio a Siagrio:<br />
«Pectoris ut nostri sedem colis, alme Syagri / communemque habitas alter ego<br />
Ausonium: / sic etiam nostro praefatus habebere libro, / differat ut nihilo, sit tuus<br />
anne meus». L'amico Siagrio è un alter ego di Ausonio e l'autore del libro, posti i<br />
loro nomi uno accanto all'altro in segno di vicinanza spirituale, non sarà più<br />
distinto. Come nella lettera meus tuus apud te locus, qui tuus velim ut meus<br />
riecheggia il sit tuus anne meus, così lo spirito del nostro scrittore è vicino - pur<br />
nella lontananza dello stile e del gusto - all'educazione retorica del<br />
contemporaneo poeta.<br />
Lettera XIII: <strong>Seneca</strong> a <strong>Paolo</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« XIII - <strong>Seneca</strong> Paulo salutem.<br />
Allegorice et aenigmatice [1] multa a te usquequaque colliguntur et ideo rerum tanta<br />
vis et muneris tibi tributa [2] non ornamento verborum, sed cultu quodam decoranda<br />
est. [3] Nec vereare, quod saepius dixisse retineo, multos qui talia adfectent sensus<br />
corrumpere, rerum virtutes evirare. Certum mihi velim concedas latinitati morem<br />
gerere, [4] honestis vocibus et speciem adhibere, ut generosi muneris concessio<br />
digne a te possit expediri. Bene vale. Data pridie Non. Iul. Lurcone et Sabino<br />
consulibus. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - aenigmatice: questo avverbio si riscontra soltanto nel Tractatus Origenis de<br />
libris SS scripturam di Gregorio di Elvira, scritto nel IV secolo. Aenigma è<br />
propriamente un'oscura allegoria [79] Anche Gerolamo lamentava l'oscurità di<br />
san <strong>Paolo</strong>, aggravata dalla scarsa qualità delle traduzioni latine.[80]<br />
▪ [2] - muneris tibi tributa: ritorna qui il concetto di un <strong>Paolo</strong> ispirato da Dio.<br />
▪ [3] - decoranda est: le preoccupazioni stilistiche attribuite a <strong>Seneca</strong> sono in realtà<br />
quelle dell'anonimo e dei cristiani colti del suo tempo. Anche Filastrio esprime<br />
indirettamente esigenze di cura dello stile quando (Diversarum hereseon liber<br />
89, 3) riferisce che la Lettera agli Ebrei era spesso non attribuita a <strong>Paolo</strong> proprio<br />
a causa del suo stile discretamente elegante: «rhetorice scripsit, sermone<br />
(IT)<br />
« XIII - <strong>Seneca</strong> a P<br />
Molte cose sono d<br />
bisognerebbe orna<br />
divina non con l'ab<br />
quel che ricordo d<br />
indeboliscono la fo<br />
concederai certam<br />
bellezza alle tue n<br />
concesso possa e<br />
sotto il consolato d
plausibili». E in effetti, com'è noto, quella lettera non è attribuibile all'Apostolo.<br />
▪ [4] - latinitati morem gerere: poiché <strong>Seneca</strong> non si riferisce soltanto alle lettere di<br />
questo carteggio, è curioso che il falsario non si preoccupi del fatto che le lettere<br />
di <strong>Paolo</strong> fossero scritte in greco, e che pertanto le esortazioni di <strong>Seneca</strong> a<br />
scrivere in buon latino appaiono fuori luogo, a meno di ammettere<br />
avventurosamente che il nostro anonimo sottintenda l'esistenza di versioni latine<br />
redatte dallo stesso <strong>Paolo</strong>. In ogni caso, questa lettera smentisce l'ipotesi<br />
formulata da Harnack [81] e da altri che questo carteggio fosse originariamente<br />
scritto in greco.<br />
Lettera XIV: <strong>Paolo</strong> a <strong>Seneca</strong> [modifica]<br />
(LA)<br />
« XIV - <strong>Seneca</strong>e Paulus salutem. [1]<br />
Perpendenti tibi ea sunt revelata quae paucis divinitas concessit. Certus igitur ego in<br />
agro iam fertili semen fortissimum seo, non quidem materiam quae corrumpi videtur,<br />
[2] sed verbum stabile Dei, derivamentum [3] crescentis et manentis in aeternum,<br />
quod [4] prudentia tua adsecuta indeficiens fore debebit. Ethnicorum [5]<br />
Israhelitarumque observationes censere vitandas novumque te auctorem feceris<br />
Christi Iesu, praeconis ostendendo rhetoricis inreprehensibilem sophiam, quam<br />
propemodum adeptus regi temporali eiusque domesticis [6] atque fidis amicis<br />
insinuabis, quibus aspera et incapabilis erit persuasio, [7] cum plerique illorum<br />
minime flectuntur insinuationibus tuis. Quibus vitale commodum sermo Dei instillatus<br />
novum hominem sine corruptela [8] perpetuum animal parit ad Deum istinc<br />
properantem. [9] Vale, <strong>Seneca</strong> carissime nobis. Data Kal. Aug. Lurcone et Sabino<br />
consulibus. »<br />
Commento [modifica]<br />
▪ [1] - Recentemente si è avanzata l'ipotesi che anche questa lettera, come la XI, sia<br />
opera di un altro falsario.[82]<br />
▪ [2] - semen ... videtur: il semen fortissimum è il verbum Dei. Sembra qui essere<br />
parafrasata la I Pietro 1, 23: renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili<br />
per verbum Dei vivi et permenentis in aeternum. Anche in <strong>Seneca</strong> [83] è<br />
presente il concetto di semi divini nell'uomo, ma in un contesto molto diverso:<br />
«È dio che scende tra gli uomini, anzi è in intima relazione con loro, è in loro.<br />
Nessuno spirito virtuoso è senza dio. Semi divini sono stati sparsi nei corpi degli<br />
uomini. Se li raccoglie un buon coltivatore, essi si sviluppano conformemente<br />
alla loro origine divina, fino ad acquistare tutti i caratteri dell'essere da cui sono<br />
nati. Ma se li raccoglie un malvagio, non diversamente da un terreno sterile e<br />
paludoso, li uccide e poi produce erbaccia al posto del buon grano».<br />
▪ [3] - derivamentum: il tardo derivamentum ha lo stesso significato di derivatio,<br />
ἀπόρροια, «emanazione», utilizzato già in ambito stoico e poi soprattutto neoplatonico.<br />
▪ [4] - quod: è riferito a verbum.<br />
(IT)<br />
« XIV - A <strong>Seneca</strong><br />
Alle tue meditazio<br />
Consapevolmente<br />
corruttibile, la stab<br />
la tua saggezza è<br />
evitare i riti dei Pa<br />
mostrando con ele<br />
insuperabile, farai<br />
fidati, ai quali l'opin<br />
non si piegherà m<br />
instillata come un<br />
eterno, proteso da<br />
[dell'anno 58] sotto
▪ [5] - Ethnicorum: derivato dal greco ἐθνικοί, è termine cristiano per indicare<br />
spregiativamente i pagani e si trova spesso già nei vangeli.<br />
▪ [6] - domesticis: sono i nobili che frequentano la corte di Nerone. Nella lettera ai<br />
Filippesi (4, 22) <strong>Paolo</strong> cita cristiani «qui de Caesaris domo sunt», intesi come<br />
schiavi o liberti della corte imperiale, presso i quali il messaggio evangelico<br />
aveva potuto far presa; qui s'immagina invece di poter già tentare di convertire<br />
gli esponenti delle classi più elevate, come a voler «nobilitare» lo stesso<br />
Cristianesimo.<br />
▪ [7] - incapabilis erit persuasio: persuasio significa «opinione», mentre incapabilis è<br />
attestata solo dal II secolo.<br />
▪ [8] - sine corruptela: è da notare che nell' Itala - la traduzione latina poi soppiantata<br />
dalla Vulgata - la I Corinzi (15, 42) riporta «Seminatur corpus in corruptione,<br />
surgit sine corruptela», che nella Vulgata è invece tradotto con «in<br />
incorruptione».<br />
▪ [9] - properantem: concordato con hominem.<br />
Note [modifica]<br />
1. ^ Divinae Institutiones 6, 24, 13-14: «homine verae religionis ignaro [...] potuit esse verus<br />
Dei cultor, si quis illi monstrasset»<br />
2. ^ De viris illustribus XII<br />
3. ^ A. Fleury, Saint Paul et Sénèque, Paris 1853, I, p. 258<br />
4. ^ Girolamo, cit., prologo, 14<br />
5. ^ Agostino, Epistolae, 153, 14<br />
6. ^ Pseudo-Agostino, Sermo XVII, De vigilatione et otiositate vivanda: «ut ait paganus ille<br />
[<strong>Seneca</strong>] santissimi Apostoli amicus charissimus», in «PL 40, 1263»<br />
7. ^ in Lipsius, Acta Apostolorum apocrypha, Lipsiae 1891<br />
8. ^ Chronicon 2, 1, 16 in Patrologia Latina 106, 1132<br />
9. ^ De luminaribus ecclesiae I, 12<br />
10. ^ Speculum historiale IX, 9<br />
11. ^ Chronicon III, 16<br />
12. ^ Historia scholastica XVI, 126<br />
13. ^ Chronicon IV, 4<br />
14. ^ Tractatus adversus Petrobrusianos 1150, in Patrologia Latina 189, 737 C<br />
15. ^ Introductio ad Theologiam I, 24 ed Expositio in epistolam Pauli ad Romanos I, 1<br />
16. ^ Policraticus VIII, 13<br />
17. ^ Riportato da R. Sabbadini, Giovanni Colonna biografo e bibliografo del sec. XIV,<br />
«Atti Accademia delle scienze di Torino», 46, 1911, p. 892<br />
18. ^ G. Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, IV, 354<br />
19. ^ Tacito, Annali 15, 64<br />
20. ^ In Anthologia Latina I, 2, 667<br />
21. ^ A. Momigliano, cit., p. 340<br />
22. ^ Nella sua edizione delle Epistolae, Basileae 1557
23. ^ De vita et scriptis L. Annaei <strong>Seneca</strong>e, X<br />
24. ^ Il dibattito su dissimulazione e nicodemismo nasce nella prima metà del Cinquecento<br />
25. ^ S. Senese, Paulus, in «Bibliotheca sancta» II, Coloniae 1586, p. 88<br />
26. ^ F. de Bivar, Dextri Chronicon, Lugduni 1627: factus christianus occultus, eius fuisse<br />
discepulus creditur, dulciterque scribit ad Paulum in Hispania morantem<br />
27. ^ «Divus Hieronimus non ignarus fuit, abusus est simplicium credulitate», in <strong>Seneca</strong>e<br />
opera, Basileae 1529, p. 679<br />
28. ^ Novi Testamenti interpretatio cum annotationibus, II, 1565, p. 420<br />
29. ^ Citato in Fabricius, Codex apocryphus Novi testamenti, Hamburgi 1703<br />
30. ^ Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, Paris 1693<br />
31. ^ J. de Maistre, Les soirées de Saint-Petersbourg, II, pp. 160-169<br />
32. ^ Sulla questione, G. B. de Rossi, «Bullettino di archeologia cristiana» 5, 1867; A.<br />
Codara, <strong>Seneca</strong> filosofo e san <strong>Paolo</strong>, «Rivista italiana di Filosofia», 12 1897, e C.<br />
Aubertin, Sénèque et Saint Paul, Paris 1872<br />
33. ^ A. Fleury, Saint Paul et Sénèque. Recherches sur les rapports du philosophe avec<br />
l'apõytre, et sur l'infiltration du chistianisme naissant à travers le paganisme, Paris<br />
1853<br />
34. ^ Seguito ancora recentemente, sempre sulla base dell'episodio neo-testamentario e<br />
dall'iscrizione di Ostia, da Maria Sordi: <strong>Seneca</strong> e <strong>Paolo</strong>, in AA. VV., in «Il cristianesimo<br />
e Roma», 1965, e I rapporti personali di <strong>Seneca</strong> con i Cristiani, in «AA. VV., <strong>Seneca</strong> e i<br />
Cristiani», 2001<br />
35. ^ A. Fleury, cit., II, p. 75. Per una confutazione delle ipotesi del Fleury, C. Aubertin, cit.,<br />
pp. 63-66; A. Codara, cit., p 165 e J. N. Sevenster, Paul and <strong>Seneca</strong>, 1961, p. 8<br />
36. ^ E. Liénard, La Collatio Alexandri et Dindimi, 1936, credette di intravvedere la stessa<br />
mano in queste due corrispondenze<br />
37. ^ A. Momigliano, Note sulla leggenda del Cristianesimo di <strong>Seneca</strong>, 1950<br />
38. ^ C. W. Barlow, Epistolae <strong>Seneca</strong>e ad Paulum et Pauli ad <strong>Seneca</strong>m, 1938, p. 92<br />
39. ^ E. Westerburg, Der Ursprung der Sage, dass <strong>Seneca</strong> Christ gewesen sei, 1881<br />
40. ^ Cioè subentrati a due consoli deceduti<br />
41. ^ In Italia: nel resto dell'impero non fu più utilizzata dal II secolo<br />
42. ^ A. Momigliano, cit., p. 331<br />
43. ^ Per esempio, Arnobio, Adversus Nationes 1, 58: «ab indoctis hominibus et rudibus<br />
scripta sunt» o Gerolamo, Epistolae 22, 30: «Si quando in memet reversus prophetam<br />
legere coepissem, sermo horrebat incultus»<br />
44. ^ «In cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza», in S. Pauli<br />
Apostoli Epistola XIV cum commentario Jacobi Fabri, Parisiis 1512<br />
45. ^ M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, II, 1969, p. 88<br />
46. ^ L. Bocciolini Palagi, Il carteggio apocrifo di <strong>Seneca</strong> e san <strong>Paolo</strong>, 1978, p. 81<br />
47. ^ Il Fleury, cit., enumera Colossesi 2, 1; Filippesi 1, 12; II Corinzi 1, 8 e I Tessalonicesi<br />
4, 13<br />
48. ^ C. Aubertin, Étude critique sur les rapports supposés entre Sénèque et Saint Paul,<br />
1857<br />
49. ^ Un'analisi della diversa tipologia delle lettere di <strong>Paolo</strong> e di <strong>Seneca</strong> è in J. N.<br />
Sevenster, Paul and <strong>Seneca</strong>, 1961
50. ^ Così la Bocciolini Palagi, cit., pp. 91-92, peraltro diveramente, per esempio, da C. W.<br />
Barlow, Epistolae <strong>Seneca</strong>e ad Paulum et Pauli ad <strong>Seneca</strong>m, 1938, p. 92<br />
51. ^ Sulle formule epistolari si possono vedere A. Dihle, Antike Hõflichkeit und christliche<br />
Demut, Halis Saxonum 1910, p. 170, e M. Naldini, Il Cristianesimo in Egitto, Firenze<br />
1968, p. 21-22<br />
52. ^ cit., II, p. 302<br />
53. ^ Come in Cicerone, Ad Atticum 6, 7, 2; in Plinio, Epistolae 2, 12, 6, fino a Simmaco,<br />
Epistolae 8, 34<br />
54. ^ C. W. Barlow, cit., p. 90; L. Bocciolini Palagi, cit., p. 95<br />
55. ^ Cicerone, Orator 14 e 65; De oratore 3, 55<br />
56. ^ M. Vittorino, Rhetorica 1, 1: «Rhetor est qui docet litteras atque artes tradit<br />
eloquentiae, sophista est apud quem dicendi exercitium discitur, orator est qui in<br />
causis privatis ac publicis plena et perfecta utitur eloquentia»<br />
57. ^ Da Raffaele Volterrano, Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et<br />
triginta libri, XIX<br />
58. ^ Sulla questione, R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e<br />
XV. Nuove ricerche, Firenze 1967 e L. Bocciolini Palagi, cit., pp. 98-102<br />
59. ^ L. Bocciolini Palagi, cit., p. 106<br />
60. ^ Erasmo, cit., p. 679<br />
61. ^ A. Omodeo, <strong>Paolo</strong> di Tarso, 1922<br />
62. ^ G. B. Pighi, Latinità cristiana negli scrittori pagani del IV secolo, 1937, p. 45<br />
63. ^ A. Blaise, Le vocabulaire latin des principaux thèmes liturgiques, 1966, p. 594<br />
64. ^ Omelie sugli Atti degli apostoli 46 in «PG XL, 325»<br />
65. ^ In Persio I, 3, 11; in Marziale I, 3, 10 e in Ausonio, Epistolae 15, 50<br />
66. ^ L. Vouaux, Correspondence entre Sénéque et saint Paul, in «Les Actes de Paul et<br />
ses lettres apocryphes», 1913, p. 248<br />
67. ^ L. Bocciolini Palagi, cit., p. 131<br />
68. ^ C. W. Barlow, cit., p. 143<br />
69. ^ A. Fleury, cit., II, p. 314. In questo senso, per esempio, anche Girolamo, Homiliae<br />
Origenis in Ezechielem VIII, in PL XXV, c. 751, ha «in exordio fidei constitutus»<br />
70. ^ Lipsius, cit., p. 153<br />
71. ^ secondo J. N. Sevenster, cit., p. 89<br />
72. ^ Come il Fleury, cit., II, pp. 272-273<br />
73. ^ Titulus autem libelli est Formula vitae honestae, si legge nella dedica di Martino al re<br />
svevo Mirone: in «Martini episcpopi Bracarensis opera omnia», New Haven 1950<br />
74. ^ Il problema è affrontato da R. Hoven, Stoïcisme et Stoïcien face au problème de l'aude-là,<br />
Paris 1971<br />
75. ^ L. Bocciolini Palagi, cit., p. 170<br />
76. ^ Tacito (Annali 15, 40) indica tre regioni distrutte, sette danneggiate e quattro rimaste<br />
intatte<br />
77. ^ Cit., p. 331<br />
78. ^ Senza l'avverbio, actum erit de <strong>Seneca</strong> tuo significherebbe «è finita per il tuo<br />
<strong>Seneca</strong>». La scrittura continua dell'originale «optumeactumerit», con la ripetizione di<br />
tume, dovrebbe aver provocato l'omissione di optume
79. ^ Quintiliano, Institutiones VIII, 6, 52: Allegoria, quae est obscurior, aenigma dicitur<br />
80. ^ Epistolae 121, 10<br />
81. ^ Geschichte der altchristlichen Litteratur, I, 1893, p. 765<br />
82. ^ I. Ramelli, L'epistolario apocrifo <strong>Seneca</strong>-San <strong>Paolo</strong>, in «Vetera Christianorum», 1997<br />
e in «<strong>Seneca</strong> e i cristiani», 2001<br />
83. ^ Ad Lucilium 73<br />
I codici contenenti l'epistolario [modifica]<br />
▪ Bruxellensis 2839-2843, IX secolo<br />
▪ Remensis 434, IX secolo<br />
▪ Turicensis C. 129, IX secolo<br />
▪ Vindobonensis 969, IX secolo<br />
▪ Vindobonensis 751, IX secolo<br />
▪ Argentorasensis C. VI 5, X secolo<br />
▪ Sangallensis 197, X secolo<br />
▪ Metensis 500, X secolo<br />
▪ Vaticanus Reg. lat. 1424, X secolo<br />
▪ Monacensis lat. 14.436, XI secolo<br />
▪ Vaticanus lat. 251, XI secolo<br />
▪ Bernensis 225, XI secolo<br />
▪ Einsidlensis 262, XI secolo<br />
▪ Andegavensis 284, XI secolo<br />
▪ Argentorasensis C. VI 17, XI secolo<br />
▪ Ambrosianus C. 90 Inf., Xi secolo<br />
▪ Parisinus lat. 8539, XI secolo<br />
▪ Guelferbytanus Gud. lat 335, XI secolo<br />
▪ Metensis 300, XI secolo<br />
▪ Ambrosianus C. 72 Inf., XI secolo<br />
▪ Vaticanus Reg. lat. 1636, XII secolo<br />
▪ Vaticanus Reg. lat. 119, XII secolo<br />
▪ Vaticanus Reg. lat. 147, XII secolo<br />
▪ Monacensis lat. 18.467, XII secolo<br />
▪ Parisinus lat. 12.295, XII secolo<br />
▪ Laurentianus Plut. 45 cod. 26, XII secolo<br />
▪ Riccardianus 391, XIV secolo<br />
▪ Bodleianus 292, XIV secolo<br />
Bibliografia [modifica]<br />
▪ J. Faber Stapulensis (J. Lefèvre d'Etaples), S. Pauli Apostoli Epistolae XIV cum<br />
commentario, in coenobio S. Germani iuxta Parisios ex off. Henrici Stephani
1512<br />
▪ G. B. de Rossi, Iscrizione trovata in Ostia di un M. Anneo <strong>Paolo</strong> Pietro e le relazioni<br />
tra <strong>Paolo</strong> l'Apostolo e <strong>Seneca</strong>, in «Bullettino di Archeologia cristiana», 5, 1867<br />
▪ H. Rönsch, Itala und Vulgata, Marburg-Leipzig 1875<br />
▪ C. Pascal, La falsa corrispondenza tra <strong>Seneca</strong> e S. <strong>Paolo</strong>, Catania 1909<br />
▪ A. Fleury, Saint Paul et Sénèque, 2 voll., Paris 1853<br />
▪ C. Aubertin, Étude critique sur les rapports supposés entre Sénèque et Saint Paul,<br />
Paris 1857<br />
▪ C. W. Barlow, Epistolae <strong>Seneca</strong>e ad Paulum et Pauli ad <strong>Seneca</strong>m, American<br />
Academy in Rome 1938<br />
▪ Arnaldo Momigliano, Note sulla leggenda del Cristianesimo di <strong>Seneca</strong>, in «Rivista<br />
Storica Italiana», 62, 1950<br />
▪ J. Beaujeu, L'incendie de Rome en 64 et les Chrétiens, in «Latomus», 19, 1960<br />
▪ P. Benoit, Sénéque et Saint Paul, in «Revue Biblique», 53, 1946<br />
▪ J. N. Sevenster, Paul and <strong>Seneca</strong>, Leiden 1961<br />
▪ S. Jannaccone, S. Girolamo e <strong>Seneca</strong>, in «Giornale Italiano di Filologia», 16, 1963<br />
▪ AA. VV., Il cristianesimo e Roma, Bologna 1965<br />
▪ A. Momigliano, Il conflitto tra Paganesimo e Cristianesimo nel secolo IV, Torino 1968<br />
▪ M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, 3 voll., Torino 1969<br />
▪ Girolamo, De viris illustribus, Torino 1971<br />
▪ Lattanzio, Divinae Institutiones, Firenze 1973<br />
▪ L. Bocciolini Palagi, Il carteggio apocrifo di <strong>Seneca</strong> e san <strong>Paolo</strong>, Firenze 1978<br />
▪ Tertulliano, L'anima, Venezia 1988 ISBN 88-317-5126-3<br />
▪ I. Ramelli, L'epistolario apocrifo <strong>Seneca</strong>-San <strong>Paolo</strong>, in «Vetera Christianorum» 34,<br />
1997<br />
▪ AA. VV., <strong>Seneca</strong> e i cristiani, Milano 2001 ISBN 88-343-0665-1<br />
▪ <strong>Seneca</strong>, San <strong>Paolo</strong>. Lettere, a cura di M. Tondelli, Milano 2005 ISBN 8877684417<br />
Voci correlate [modifica]<br />
▪ Apocrifi del Nuovo Testamento<br />
▪ <strong>Paolo</strong> di Tarso<br />
▪ Lucio Anneo <strong>Seneca</strong><br />
Portale Apocrifi Portale Cris<br />
Categoria: Lettere apocrife<br />
Crea un nuovo utente<br />
Entra<br />
Voce<br />
Discussione<br />
Leggi
Modifica<br />
Visualizza cronologia<br />
Pagina principale<br />
Ultime modifiche<br />
Una voce a caso<br />
Vetrina<br />
Aiuto<br />
Comunità<br />
Portale Comunità<br />
Bar<br />
Il Wikipediano<br />
Fai una donazione<br />
Contatti<br />
Stampa/esporta<br />
Strumenti<br />
Altre lingue<br />
Dansk<br />
Deutsch<br />
English<br />
Français<br />
Latina<br />
norsk (bokmål)<br />
Polski<br />
Português<br />
Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 4 mag 2012 alle 17:14.<br />
Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso<br />
modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli.<br />
Wikipedia® è un marchio registrato della Wikimedia Foundation, Inc.<br />
Politica sulla privacy<br />
Informazioni su Wikipedia<br />
Avvertenze<br />
Versione mobile