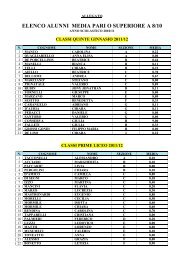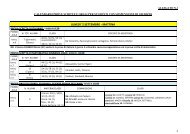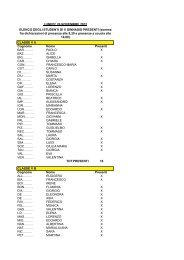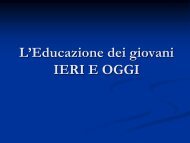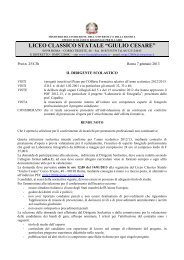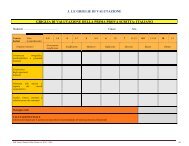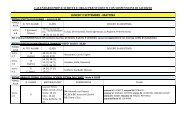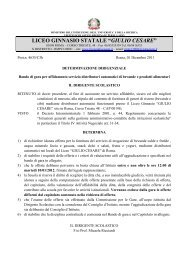Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />
X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />
Prot.n. 1643 / D1 a<br />
15/5/2013<br />
DOCUMENTO<br />
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. F<br />
Anno Scolastico 2012/13<br />
IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
Prof. Micaela Ricciardi
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> F<br />
Anno scolastico 2012-2013<br />
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,<br />
recante disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione<br />
Secondaria Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale F ha definito contenuti, obiettivi, metodi e<br />
strumenti valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo<br />
anno di corso.<br />
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />
Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi<br />
in cui è sorto (1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />
Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran<br />
parte residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da<br />
diversa collocazione urbana.<br />
L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali<br />
attività didattiche, diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e<br />
multimedialità ) ed aule speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una<br />
ricca Biblioteca, dotata di moderni sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi<br />
audiovisivi; due grandi palestre e un campo di basket all’aperto; un ambulatorio medico, con<br />
servizio di consulenza psicologica.<br />
Dal POF dell’anno scolastico 2011 – 2012 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta<br />
formativa nei seguenti ambiti: perseguimento del successo scolastico, in particolare, per quanto<br />
riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una ricca attività di orientamento in uscita; potenziamento dei saperi<br />
disciplinari, attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari ed<br />
extracurricolari; educazioni, con particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai<br />
seguenti percorsi educativi: educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità;<br />
educazione alla salute.<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La <strong>classe</strong>, costituita all’inizio del quinquennio da 20 alunni, al secondo anno risultava composta da<br />
27 studenti: 17 del nucleo originario, in seguito alla non ammissione di 3 allievi, e 9 provenienti da<br />
altra <strong>sez</strong>ione dell’Istituto. All’inizio del triennio la <strong>classe</strong> era formata da 29 allievi: 23 provenienti<br />
dalla V F, in seguito al trasferimento di 3 alunni, e 6 provenienti da altre due <strong>sez</strong>ioni, E e D,<br />
dell’Istituto. Al secondo e al terzo anno il numero degli alunni è rimasto invariato.<br />
La <strong>classe</strong>, nel corso del quinquennio, ha fruito di una sostanziale continuità didattica, fatta<br />
eccezione per la lingua inglese, per cui, in seguito al pensionamento della prof. Amati, si sono<br />
succeduti tre docenti diversi nel triennio, e per le discipline di storia e filosofia, per cui, in seguito<br />
al pensionamento della prof. Merlicco, nell’ultimo anno di corso è subentrata una nuova docente<br />
(cfr. quadro sinottico). L’avvicendamento degli insegnanti non ha influito negativamente sul<br />
rendimento della <strong>classe</strong>, anzi ha finito per essere fonte di stimolo e arricchimento culturale e<br />
didattico.<br />
Nel corso dell’intero triennio gli studenti, pur con differenti livelli di rendimento, hanno seguito<br />
le diverse discipline con interesse e impegno evidenziando una maturazione crescente e hanno<br />
raggiunto, nella maggior parte dei casi, una buona preparazione generale. Alcuni allievi hanno<br />
messo in luce particolari capacità, vivacità intellettuale e critica, sostenute da competenze di ottimo<br />
livello.<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO
DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />
MATERIE LETTERARIE,<br />
LATINO E GRECO<br />
MATEMATICA<br />
MIRABILIA MIRABILIA<br />
GALLO GALLO<br />
INGLESE AMATI AMATI<br />
STORIA DELL'ARTE BELLISARIO BELLISARIO<br />
ED. FISICA LO BIANCO LO BIANCO<br />
IRC JORI JORI<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 20010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />
ITALIANO E LATINO TAMBURRINO TAMBURRINO TAMBURRINO<br />
GRECO CORREALE CORREALE CORREALE<br />
STORIA E FILOSOFIA MERLICCO MERLICCO MALORNI<br />
MATEMATICA<br />
E FISICA<br />
GALLO GALLO GALLO<br />
INGLESE BRUNACCI TESTA ZERBONI<br />
SCIENZE ALTOBELLI ALTOBELLI ALTOBELLI<br />
STORIA DELL'ARTE BELLISARIO BELLISARIO BELLISARIO<br />
ED. FISICA LO BIANCO LO BIANCO LO BIANCO<br />
IRC JORI JORI JORI
OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate<br />
sono stati concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e<br />
valutazione; nelle previste riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente<br />
verificato il percorso didattico e culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e<br />
integrassero omogeneamente gli apporti delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì<br />
programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere nei seguenti punti :<br />
• acquisizione dei contenuti generali e specifici<br />
• padronanza dei mezzi espressivi<br />
• applicazione delle conoscenze e abilità nell’uso degli strumenti cognitivi e interpretativi<br />
• sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi, di sintesi<br />
• capacità di attuare collegamenti pluridisciplinari.<br />
• capacità di interpretazione e rielaborazione critica.<br />
• valorizzazione della creatività personale<br />
A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per<br />
disciplina.<br />
MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />
ITALIANO • Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella<br />
produzione orale e scritta in situazioni comunicative diverse.<br />
• Conoscenza degli aspetti principali della cultura dell’Ottocento<br />
e del Novecento.<br />
• Padronanza delle diverse tipologie testuali.<br />
• Capacità di confronto tra le diverse interpretazioni critiche dei<br />
fenomeni letterari e degli autori.<br />
• Capacità di attuare collegamenti pluridisciplinari.<br />
• Capacità di interpretazione e rielaborazione critica.<br />
LATINO E<br />
GRECO<br />
• Leggere e comprendere il significato complessivo di un testo<br />
riconoscendone le strutture linguistiche fondamentali.<br />
• Interpretare un testo e tradurlo in lingua italiana con padronanza<br />
linguistica e sensibilità nelle scelte lessicali.<br />
• Inquadrare i testi e gli autori in una prospettiva storico-letteraria<br />
individuandone le peculiarità stilistiche e di genere.<br />
FILOSOFIA • Ricostruire lo sviluppo del pensiero filosofico occidentale ed indicarne<br />
sia le relazioni con il contesto storico e culturale sia la portata<br />
potenzialmente universalistica.<br />
• Leggere ed analizzare un testo filosofico.<br />
• Essere in grado di problematizzare ed esporre le questioni filosofiche,<br />
suscitare nuove domande e sviluppare l’attitudine alla riflessione<br />
personale.<br />
• Usare consapevolmente strategie argomentative e procedure logiche.<br />
STORIA • Saper focalizzare i principali eventi e le trasformazioni di lungo<br />
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia e del mondo.<br />
• Comprendere con sicurezza e padronanza i processi e le dinamiche<br />
che regolano i fatti storici, cogliendone le relazioni causa ed effetto,
stabilendo confronti ed operando comparazioni tra presente e passato.<br />
• Saper leggere, utilizzare e comprendere un testo storico.<br />
• Usare con padronanza il linguaggio specifico.<br />
INGLESE • Potenziare le capacità comunicative ed elaborative finalizzate all’autonomia<br />
linguistica<br />
• Affinare le strategie di lettura di testi con apprezzamento stilisticolinguistico<br />
• Ampliare il panorama storico-letterario, contestualizzandolo nei più<br />
importanti fenomeni socio-economici e culturali europei.<br />
MATEMATICA • Conoscenza dei nodi fondanti della disciplina.<br />
• Comprensione del linguaggio formale specifico.<br />
• Utilizzo dei procedimenti matematici.<br />
FISICA • Conoscenza dei nodi fondanti della disciplina.<br />
• Conoscenza dei fenomeni naturali più significativi.<br />
• Padronanza nell’uso del linguaggio adeguato a descrivere i fenomeni.<br />
• Capacità di utilizzare modelli e leggi fisiche in diverse situazioni.<br />
SCIENZE • Conoscere i nodi fondanti della disciplina.<br />
• Saper argomentare e rielaborare i temi trattati in maniera personale e critica.<br />
• Saper utilizzare un linguaggio tecnico scientifico rigoroso.<br />
STORIA<br />
DELL’ARTE<br />
• Contestualizzare il prodotto artistico e gli artisti in relazione al momento<br />
storico<br />
• Riconoscere stili e tecniche artistiche.<br />
• Leggere l'opera d'arte sia dal punto di vista iconografico che iconologico.<br />
• Confrontare, esprimere pareri critici e relazionarsi con le altre discipline.<br />
• Gli alunni sanno usare correttamente il lessico specifico.<br />
ED.FISICA • Formazione sia sotto l’aspetto fisico che psichico<br />
• Consolidamento e perfezionamento degli schemi motori precedentemente<br />
acquisiti.<br />
• Potenziamento fisiologico, rielaborazione del linguaggio motorio,<br />
• Sviluppo della socialità e della coscienza civica attraverso la pratica dei<br />
giochi sportivi<br />
• Assunzione della pratica sportiva come abitudine di vita<br />
IRC • Contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della<br />
chiesa dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.<br />
• Identificare i punti teologici fondamentali della dottrina sociale della<br />
chiesa (encicliche sociali) e del Concilio Vaticano.<br />
• Argomentare lo sviluppo teologico interno al Paradiso di Dante, con<br />
particolare attenzione al Canto XXX<strong>III</strong>.<br />
• Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose.<br />
contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della chiesa<br />
dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.
Gli obiettivi prefissati, nella maggioranza dei casi e a diversi livelli, possono dirsi<br />
raggiunti.<br />
I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di<br />
insegnamento/apprendimento sono stati:<br />
• lezione frontale<br />
• didattica laboratoriale<br />
• didattica interattiva<br />
• lavori di ricerca e approfondimento<br />
• uso delle ITC<br />
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />
La <strong>classe</strong> ha partecipato nel suo insieme ai seguenti progetti d’Istituto, le cui attività si sono svolte<br />
in orario curriculare:<br />
• Conferenza di fisica “International Cosmic Day”<br />
• Itinerario geopaleontologico e serata astronomica Prof.Maurizio Chirri presso Rocca di Cave<br />
• Conferenza“La struttura dell’Universo “ Prof. Alessandro Melchiorri presso l’Università La<br />
Sapienza di Roma<br />
• Conferenza“Alla scoperta dei minerali, le cellule del pianeta Terra” Prof. Giovanni Battista<br />
Andreozzi presso l’Università La Sapienza di Roma<br />
• Conferenza“Eruzioni vulcaniche: funzionamento e impatto sull’ambiente” Prof.Mario Gaeta<br />
presso il <strong>Liceo</strong> <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />
• Attività didattica “Astronomia con il planetario digitale” Dott. Alessandro Granati-<br />
Associazione culturale Club della Scienza presso il liceo <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />
• Attività didattica “L’Astronomia al Pantheon”Dott.ssa Serena Caciolli-Associazione culturale<br />
Ars in Urbe<br />
• Allestimento della Mostra “Ezio Sclavi: il pittore, l’atleta”<br />
• Lezioni di economia per le terze liceali del Prof Giuliano Amato presso il <strong>Liceo</strong> <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />
• Spettacolo in lingua inglese “The Glass Menagerie”di Tennessee.Williams.<br />
Gli alunni hanno partecipato individualmente, a seconda dei loro personali interessi alle seguenti<br />
attività, che si sono svolte in orario extracurriculare:<br />
!<br />
• Laboratorio di Restauro<br />
• Giornata di Studi pascoliani “Pascoli 101. Tra antico e moderno”.<br />
• Progetto “ Giornale d’Istituto - Le Idi di…”<br />
• Laboratorio Teatrale<br />
• Letture Filosofiche<br />
• Due Masterclass di Fisica, uno sulla fisica delle particelle, l’altro di ottica<br />
• Cinque lezioni pomeridiane di Fisica alla Sapienza<br />
• Attività di Orientamento
• Progetto “Orientamento in rete” per le Facoltà ad accesso programmato dell’area medicosanitaria<br />
dell’Università La Sapienza di Roma<br />
Cinque alunni hanno partecipato al Campionato di Filosofia.<br />
Due alunni hanno partecipato allo stage di tre giorni promosso dalla FARMM dal tema<br />
“Clonaggio della proteina GFP “<br />
Due alunni , selezionati per eccellenza nelle discipline scientifiche, hanno partecipato allo stage di<br />
due giorni promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.<br />
Nel mese di novembre la <strong>classe</strong> si è recata in viaggio di istruzione in Portogallo<br />
VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />
In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia<br />
di indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />
La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione<br />
che si allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie<br />
sono state approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame (durata della<br />
1°prova: 5 ore, durata della 3° prova: 3 ore)<br />
1° PROVA 14 maggio 2013<br />
3° PROVA<br />
TIP. B<br />
3° PROVA<br />
TIP. B<br />
9 febbraio 2013: latino, storia, matematica, scienze, arte<br />
24 aprile 2013: greco, filosofia, inglese, fisica, scienze<br />
Dai riscontri in sede di valutazione collegiale è risultato che la tipologia B è più congeniale al<br />
conseguimento di risultati positivi. Gli alunni hanno ottenuto risultati complessivamente<br />
equivalenti nelle discipline oggetto di simulazione di prova.<br />
I testi delle prove si allegano al <strong>Documento</strong> <strong>finale</strong> (allegato n.5).
Si allegano al presente documento:<br />
ALLEGATI<br />
Allegato n.1 Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />
Allegati n.2,3,4 Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza<br />
prova<br />
Allegati n. 5 Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />
Allegati n. 6-17 Programmi disciplinari<br />
Roma 15 maggio 2013
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
ITALIANO prof. GABRIELLA TAMBURRINO ……………………..<br />
LATINO prof. GABRIELLA TAMBURRINO ……………………..<br />
GRECO prof. LAURA CORREALE ……………………..<br />
INGLESE prof. LAURA ZERBONI ……………………..<br />
STORIA E FILOSOFIA prof. PAOLA MALORNI ……………………..<br />
STORIA DELL’ARTE prof. FABIO BELLISARIO …………………….<br />
MATEMATICA E FISICA prof. MARIA GRAZIA GALLO ……………………..<br />
SCIENZE prof. LUCIA ALTOBELLI ……………………..<br />
ED. FISICA prof. SIMONETTA LO BIANCO ……………………..<br />
IRC prof. ANTONELLA JORI ……………………..
ALLEGATO N.1<br />
VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />
strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />
pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />
culturale.<br />
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />
Voto<br />
1 – 3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 – 10<br />
Indicatori di<br />
conoscenze<br />
Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />
argomenti disciplinari e disarticolate<br />
nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />
Conosce in modo vago e confuso gli<br />
argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />
difficoltà i nuclei essenziali e le<br />
interrelazioni.<br />
E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />
conoscenze, delle quali coglie<br />
parzialmente implicazioni e rimandi<br />
essenziali.<br />
Conosce gli ambiti delle diverse<br />
discipline e ne coglie in linea globale<br />
contenuti e sviluppi.<br />
Conosce gli argomenti e li colloca<br />
correttamente nei diversi ambiti<br />
disciplinari.<br />
Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />
grazie ad approfondimenti personali negli<br />
aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />
Mostra piena padronanza degli ambiti<br />
disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />
di informazioni.<br />
Indicatori di<br />
abilità<br />
Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />
assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />
argomentazione.<br />
Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />
nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />
un linguaggio disordinato e scorretto.<br />
Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />
incompleto, con non certa padronanza delle<br />
soluzioni espressive.<br />
Comprende le consegne e risponde in modo<br />
semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />
linguaggi disciplinari.<br />
Comprende e contestualizza le consegne e le<br />
sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />
complessivamente coerenti.<br />
Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />
operando collegamenti con<br />
appropriata scelta di argomentazioni.<br />
E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />
dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />
efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />
collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />
Indicatori di<br />
competenze<br />
Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />
non è in grado di applicare regole o elementari<br />
operazioni risolutive.<br />
Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />
semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />
procedure di risoluzione.<br />
Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />
limitato di contesti. Applica, non sempre<br />
adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />
Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />
scelta e nella applicazione delle strategie di<br />
risoluzione.<br />
Sa impostare problemi di media complessità e<br />
formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />
di risoluzione.<br />
E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />
di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />
operare scelte coerenti ed efficaci.<br />
Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />
ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />
anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />
Livello di certificazione delle competenze di<br />
base<br />
(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />
Non ha raggiunto il livello base delle<br />
competenze.<br />
Livello base: lo studente svolge compiti<br />
semplici in situazioni note, mostrando di<br />
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />
saper applicare regole e procedure<br />
fondamentali.<br />
Livello intermedio: lo studente svolge<br />
compiti e risolve problemi complessi in<br />
situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />
le abilità acquisite.<br />
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />
problemi complessi in situazioni anche non<br />
note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />
sostenere le proprie opinioni e assumere<br />
autonomamente decisioni consapevoli
ALLEGATO N.2<br />
Voto in<br />
decimi<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto<br />
in<br />
quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Correttezza ortografica,<br />
morfosintattica e proprietà<br />
lessicale<br />
Conoscenza<br />
degli argomenti<br />
proposti<br />
Aderenza alla traccia e<br />
rispetto dei vincoli<br />
comunicativi<br />
Analisi, sintesi, coerenza e<br />
rielaborazione dei<br />
contenuti<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />
ALLEGATO N.3<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Comprensione del testo<br />
Conoscenza della morfosintassi<br />
Qualità linguistica della traduzione<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
I DOCENTI<br />
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />
STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto<br />
in<br />
quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e<br />
dei linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste<br />
e capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è<br />
approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale<br />
maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI<br />
ALLEGATO N.4
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />
STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto in<br />
quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Descrittori<br />
ALLEGATO N.4<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
Quesiti<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e<br />
dei linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste<br />
e capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è<br />
approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale<br />
maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
ALLEGATO N. 5<br />
SIMULAZIONE PRIMA PROVA<br />
14 maggio 2013<br />
LATINO<br />
SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME<br />
SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />
9 febbraio 2013<br />
Tipologia B – max 8 righe<br />
1.Il primo libro di Elegie di Properzio si apre nel nome di Cinzia : spiega quale funzione svolge<br />
questa collocazione di forte rilievo e analizza le diverse connotazioni della tematica amorosa nel<br />
Canzoniere.<br />
2. Amores ed Heroides di Ovidio: analizza le tematiche, i caratteri stilistici, gli elementi di novità<br />
rispetto all’elegia amorosa di Tibullo e Properzio.<br />
STORIA<br />
1.La Germania dopo il primo conflitto mondiale.<br />
2. Analizza i motivi sociali dell’ascesa del Fascismo in Italia .<br />
MATEMATICA<br />
1) Verifica la seguente identità condizionata<br />
( 1 cos )<br />
2<br />
( 1#<br />
cos!<br />
)( 1+<br />
cos!<br />
)<br />
+ ! #<br />
" cotg ! = 1+<br />
2cos!<br />
!<br />
tg!<br />
"#!$%&'(&%!)&!*%&(+,!-,&&%!.,/0,12,!,.3+,..)(1,4!<br />
1" cos2! 2 1<br />
! ( cotg! " cos ! ) +<br />
sen 2!<br />
!<br />
sen 2! 2<br />
SCIENZE<br />
1.In quale fase della vita evolutiva di una stella si trova il Sole? Quale sarà la sua probabile<br />
evoluzione?<br />
2. Illustra e spiega cosa dimostra l’esperienza di Guglielmini<br />
ARTE
1.In quest’opera di E.L. Kirchner “Autoritratto da soldato” del 1915, sono presenti le caratteristiche<br />
peculiari di questo artista e dell’Espressionismo in generale. Delineatele dal punto di vista formale<br />
e poetico.<br />
2.!Cosa intende affermare V. Van Gogh quando attribuisce alla presenza di un<br />
“demone” nella sua mente la sua espressione artistica?<br />
GRECO<br />
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA<br />
24 aprile 2013<br />
1.Illustra i caratteri tipici della Commedia Nuova di Menandro facendo riferimento in particolare<br />
al dramma L’Arbitrato<br />
!<br />
") “Non sopporto un architetto che si sforza di fare case alte come la cima dell’Oromedonte; e<br />
neppure quegli uccelli delle Muse che invano si sgolano gracchiando di fronte al cantore di Chio”<br />
(Teocrito,IdillioVII,vv.45-48).<br />
In riferimento a queste parole del capraio Licida nell’Idillio le Talisie, descrivi i tratti distintivi<br />
dell’opera bucolica di Teocrito, mettendo in luce i caratteri più propriamente alessandrini della sua<br />
poetica.<br />
FILOSOFIA<br />
1)Spiega in che modo la dottrina dell’oltreuomo si pone nella filosofia nietzscheana, come<br />
superamento del nichilismo e come giunga alla creazione di nuovi valori.<br />
2) La fede è appunto questo paradosso che il Singolo come Singolo è più alto del generale. Spiega<br />
il significato di questa frase di Kierkegaard evidenziando le peculiarità dello stadio religioso<br />
rispetto a quello etico.
INGLESE<br />
1.Illustrate how and why does Dorian’s character change and develop in the second part of the<br />
novel.<br />
2.Discuss Joyce’s relationship with Dublin and how the feeling of ‘paralysis’ he associates with his<br />
hometown is developed in Dubliners.<br />
FISICA<br />
1) Definisci la grandezza fisica potenziale elettrico ,specificando la sua unità di misura nel siste-<br />
ma internazionale. Descrivi le proprietà e le caratteristiche delle superfici equipotenziali<br />
anche rispetto alle linee di campo elettrostatico.<br />
2) Definisci la grandezza intensità di corrente elettrica spiegando in che modo sia possibile<br />
generare una corrente in un conduttore. Scrivi e spiega la prima legge di Ohm anche da un<br />
punto di vista grafico<br />
SCIENZE<br />
1. Perchè sulla Luna non vi è atmosfera? Quali sono le conseguenze più importanti?<br />
2. Descrivi la teoria del rimbalzo elastico
ALLEGATI<br />
ALLEGATO N. 6. Italiano<br />
ALLEGATO N. 7. Latino<br />
ALLEGATO N. 8. Greco<br />
ALLEGATO N. 9. Inglese<br />
ALLEGATO N. 10. Storia<br />
ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />
ALLEGATO N. 12. Matematica<br />
ALLEGATO N. 13. Fisica<br />
ALLEGATO N. 14. Scienze<br />
PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />
ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />
ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />
ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica
ALLEGATO N.6<br />
PERCORSO STORICO CULTURALE N.1<br />
PROGRAMMA DI ITALIANO<br />
CLASSE <strong>III</strong> F<br />
Anno scolastico 2012-‘13<br />
Orientamenti artistico-letterari tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento: gusto neoclassico<br />
e gusto preromantico.<br />
(Winckelmann; Schiller; Goethe; Foscolo)<br />
Autori e testi:<br />
T 1 J.J Winckelmann “ La statua di Apollo” (da Storia dell’arte nell’antichità)<br />
T 3 W.Goethe “l’artista e il borghese” (da I dolori del giovane Werther)<br />
U. FOSCOLO<br />
dall’Ortis<br />
T 1 “Il sacrificio della patria”( Lett. 11-X-’97)<br />
T 2 “Il colloquio con Parini”(Lett. 4-XII)<br />
T 3 “La lettera da Ventimiglia:la storia e la natura”(Lett. 19,20-II)<br />
T 4 “La sepoltura illacrimata”( Lett.12-XI e 15-V)<br />
T 5 “Illusioni e mondo classico” (Lett. 15-V)<br />
dai Sonetti<br />
T 7 “Alla sera”<br />
T 8 “In morte del fratello Giovanni”<br />
T 9 “A Zacinto”<br />
T 11 “Dei Sepolcri”<br />
dalle Grazie<br />
T 14 “Il velo delle Grazie” II,153-196<br />
M 2 “Il sistema dei personaggi nell’ Ortis<br />
PERCORSO STORICO CULTURALE N.2<br />
L’età del Romanticismo in Europa. Complessità del movimento:tendenze<br />
irrazionali,soggettive,tendenze realistiche e propositive. Il ruolo dell’intellettuale.<br />
Tipologie dell’eroe romantico. La polemica tra classicisti e romantici in Italia. Il Conciliatore. I<br />
modelli e i generi letterari.<br />
(W.A.Schlegel; Goethe; M.me De Stael; Berchet; Giordani; Manzoni)<br />
Autori e testi<br />
T 3 W.Wordsworth “La poesia, gli umili, il quotidiano” (dalla Prefazione alle Ballate liriche)<br />
T 5 M.me de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (dalla Biblioteca Italiana)<br />
T 6 P.Giordani “Un Italiano risponde al Discorso della Stael”(dalla Biblioteca italiana)<br />
T 7 Giovanni Berchet “La poesia ‘popolare”(dalla Lettera semiseria)<br />
A.MANZONI<br />
Dalle Odi<br />
T 6 “Il cinque maggio”<br />
dalla Lettre à M.Chauvet<br />
T 3 “Storia e invenzione poetica”<br />
dalla Lettera sul Romanticismo<br />
T 4 “L’utile, il vero, l’interessante”
dall’Adelchi<br />
T 8 Atto V, scene V<strong>III</strong>, IX, X “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia”<br />
T 10 Coro dell’atto IV “Morte di Ermengarda”<br />
M 7 “Le unità aristoteliche”<br />
M 8 “Mescolanza e separazione degli stili”<br />
M 9 “Il discorso narrativo nei Promessi Sposi: il narratore e i punti di vista dei personaggi”<br />
I promessi sposi (conoscenza generale)<br />
PERCORSO STORICO CULTURALE N.3<br />
Il realismo nel Secondo Ottocento. Il “dualismo” della Scapigliatura. Il Naturalismo francese. Il<br />
Verismo. Verga.<br />
( Praga; Tarchetti; E. e J. De Goncourt; Zola; Capuana ; Verga)<br />
Autori e testi<br />
T 1 E.Praga “Preludio” (Da Penombre)<br />
T3 A. Boito”Dualismo”vv1-36 (dal Libro dei versi)<br />
A.Boito “Lezione di anatomia (fotocopia)<br />
M 1 “La bohème parigina”<br />
T 2 E. e J. De Goncourt “La Prefazione a Germinie Lacerteux”(da Germinie Lacerteux)<br />
T 3 E. Zola “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”(da Il romanzo sperimentale)<br />
T 5 L.Capuana “ Scienza e forma letteraria. L’impersonalità” (dalla Recensione ai Malavoglia)<br />
M 2 “Il discorso indiretto libero”<br />
G. VERGA<br />
T 3 “Impersonalità e regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna)<br />
T 4 “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” ( A,B : Lettere a Capuana)<br />
T 8 “I vinti e la fiumana del progresso” (I Malavoglia ,Prefazione)<br />
da Vita dei Campi<br />
T 5 “Fantasticheria”<br />
T 6 “Rosso Malpelo”<br />
Da Novelle rusticane<br />
T 14 “La roba”<br />
Da I Malavoglia<br />
T 9 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”<br />
T 13 “La conclusione del romanzo : l’addio al mondo pre-moderno”<br />
da Mastro don Gesualdo<br />
T 26 “La morte di Mastro don Gesualdo” ( IV, cap.V)<br />
M 9 “La struttura dell’intreccio nei Malavoglia “<br />
M 10 “Il tempo e lo spazio nei Malavoglia”<br />
M 8 “Lotta per la vita e darwinismo sociale”<br />
PERCORSO STORICO CULTURALE N.4<br />
L’età della crisi di fine Ottocento -inizi Novecento. Il decadentismo. Il ruolo dell’intellettuale.<br />
Poetiche del Primo Novecento. Futurismo.<br />
(Huysmans; Wilde; Pascoli; D’annunzio; Pirandello)<br />
Autori e testi<br />
T 2 C.Baudelaire “L’albatro”(da I fiori del male)<br />
T 1 G.Pascoli “Una poetica decadente” (da Il fanciullino)<br />
T 1 L.Pirandello “Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo)<br />
T 3 O. Wilde “I principi dell’estetismo” (da Il ritratto di Dorian Gray)<br />
PERCORSO GENERE N.1<br />
Evoluzione del romanzo nel corso dell’800 e del ‘900.<br />
(U. Foscolo; A. Manzoni; E. Zola; G. Verga; O.Wilde; G. D’Annunzio; L. Pirandello; I. Svevo.
Il percorso è stato affrontato secondo le seguenti modalità:<br />
1) Lettura integrale di alcuni testi.<br />
2) Letture antologiche.<br />
3) Analisi e contestualizzazione.<br />
4) Utilizzazione trasversale di alcuni motivi per collegamenti con altri autori, testi, generi,<br />
problemi etc. In particolare: a) l’io e la natura nell’elaborazione letteraria tra la fine del ‘700,<br />
il primo ‘800 e l’ultimo ‘800; b) la rappresentazione della realtà nell’elaborazione letteraria<br />
dell’800/’900; c) individuo e società: l’eroe romantico/ l’eroe decadente; d) il ruolo<br />
dell’intellettuale fra ‘800 e ‘900; e) trasformazione delle strutture narrative (dal realismo al<br />
suo dissolvimento); f) la crisi del soggetto tra ‘800 e ‘900<br />
Autori e testi<br />
Lettura integrale:<br />
L. Pirandello Il fu Mattia Pascal<br />
I. Svevo La coscienza di Zeno<br />
G. D’Annunzio Il piacere o Il trionfo della Morte o Le vergini delle rocce (a scelta del candidato)<br />
Lettura antologica:<br />
Goethe I dolori del giovane Werther (cfr. percorso storico culturale 1)<br />
Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis (cfr. “ “ “ 1)<br />
Verga I Malavoglia ( cfr. “ “ “ 3)<br />
Mastro don Gesualdo ( cfr. “ “ “ 3)<br />
D’Annunzio Il piacere T1“Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti”(<strong>III</strong>,cap.II)<br />
Manzoni I promessi sposi (conoscenza generale)<br />
PERCORSO GENERE N.2<br />
La linea della poesia dal secondo Ottocento al Novecento. Il rinnovamento del linguaggio poetico.<br />
(Baudelaire e i simbolisti francesi; Pascoli; D’Annunzio).<br />
T 4 A. RIMBAUD “Vocali” (da Poesie)<br />
Autori e testi<br />
T 2 P. VERLAINE“Languore”(da Un tempo e poco fa)<br />
C.BAUDELAIRE<br />
Da I fiori del male<br />
T 1 « Corrispondenze »<br />
T 2 « L’albatro »<br />
T 4 « Spleen »<br />
G. PASCOLI<br />
da Myricae<br />
T 3 “Arano”<br />
T 4 “X agosto”<br />
T 6 “L’assiuolo”<br />
T 7 « Novembre »<br />
« Il lampo » ( fotocopia)<br />
« Lavandare » ( fotocopia)<br />
da I Canti di Castelvecchio<br />
T 14 “Il gelsomino notturno”<br />
dai Poemi conviviali<br />
C. XX<strong>III</strong>I,1-55 “L’ultimo viaggio di Ulisse”(fotocopia)<br />
G.D’ANNUNZIO
Da Alcyone<br />
T 9 “La pioggia nel pineto”<br />
E. MONTALE<br />
da Ossi di seppia<br />
T 2 “Non chiederci la parola”<br />
T 4 “Spesso il male di vivere ho incontrato”<br />
G. UNGARETTI<br />
da L’allegria<br />
T 6 “San Martino del Carso”<br />
T 8 “Mattina”<br />
T 10 “Soldati”<br />
MODULO AUTORE N.1: Giacomo Leopardi<br />
L’itinerario poetico filosofico di Leopardi:l’evoluzione della visione materialistica e pessimistica<br />
dell’uomo e della natura,dalla ‘poetica del vago e dell’indefinito’ alla scelta antiidillica della fase<br />
conclusiva.<br />
Testi<br />
dallo Zibaldone<br />
T 1a “La teoria del piacere”<br />
T 1b “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”<br />
T 1d “Indefinito e infinito”<br />
T 1e “Il vero è brutto”<br />
T 1f “Teoria della visione”<br />
T 1g “Parole poetiche”<br />
T 1h “Ricordanza e poesia”<br />
T 1l “Indefinito e poesia”<br />
T 1n “La doppia visione”<br />
T 1o “La rimembranza”<br />
“Il giardino sofferente” Pensiero del 19-22/V/1826 (fotocopia)<br />
dai Canti<br />
T 2 “L’infinito”<br />
T 5 “Ultimo canto di Saffo”<br />
T 6 “A Silvia”<br />
T 8 “La quiete dopo la tempesta”<br />
T 9 “Il sabato del villaggio”<br />
T 10 “Canto notturno di un pastore errante nell’Asia”<br />
T 13 “A se stesso”<br />
T 14 “La ginestra” (vv 1-157,158-296:sintesi; 297-317)<br />
dalle Operette morali<br />
T 6 “Dialogo della Natura e di un Islandese”<br />
PERCORSO AUTORE N.2: Luigi Pirandello<br />
La coscienza della crisi. La Forma e la Vita: l’identità impossibile. Gli sdoppiamenti. Il relativismo<br />
gnoseologico. La poetica dell’umorismo. Le Novelle e i romanzi: caratteri generali. Il teatro:<br />
questioni generali, Sei personaggi in cerca d’autore .<br />
da L’umorismo<br />
T 1 “Un’arte che scompone il reale”<br />
Da Novelle per un anno<br />
T 2 “La trappola”<br />
Testi
T 4 “Il treno ha fischiato”<br />
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)<br />
DANTE ALIGHIERI PARADISO<br />
Conoscenza generale della Cantica; analisi dei canti I, <strong>III</strong>; VI; XI; XII; XV;XVII; XXX<strong>III</strong>; sintesi dei<br />
canti XXX e XXXII.<br />
Libri di testo<br />
Baldi-Giusso-Razetti- Zaccaria La letteratura Paravia Volumi IV, V, VI<br />
Dante, Paradiso (a cura di N. Sapegno) La Nuova Italia<br />
ALUNNI DOCENTE<br />
Prof. Gabriella Tamburrino
ALLEGATO N. 7<br />
PROGRAMMA DI LATINO<br />
!<br />
!"#$$%&'''&(&<br />
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
ANNO SCOLASTICO 2012-2013<br />
LETTERATURA<br />
L’età di Augusto :<br />
Orazio.<br />
• Satire 1,6 (T4)<br />
L’elegia:<br />
Tibullo<br />
Properzio<br />
• Elegie 2,1 (T 9)<br />
Ovidio.<br />
L’età giulio-claudia: caratteri generali.<br />
Seneca.<br />
• Apokolokyntosis 1-4,1 : l’esordio (T17)<br />
• Apokolokyntosis 14-15: il giudizio infernale (T18)<br />
Lucano.<br />
• Pharsalia 6,654-718:l’incantesimo di Eritto (T6)<br />
Petronio.<br />
Lettura integrale in lingua italiana del Satyricon<br />
La satira: Persio .<br />
• Satire 1,13- 21: la polemica contro le recitationes (T3)<br />
• Satire 1,30-40: la polemica contro le recite a banchetto (T4)<br />
• Satire 1,92-106: gli stereotipi della poesia epica e tragica (T6)<br />
• Satire1,114-123: i modelli di Persio: Lucilio e Orazio (T7)<br />
L’età flavia: caratteri generali.<br />
Marziale e l’epigramma<br />
• Epigrammata 10,96:.nostalgia di Bilbilis(T1)<br />
• Epigrammata 10,47: amicizia e vita ideale (T5)<br />
• Epigrammata 4,49: igusti del pubblico (T7)<br />
• Epigrammata 1,30: da medico a becchino (T10)<br />
• Epigrammata 3,26: proprietà private e.. beni comuni (T12)<br />
• Liber de spectaculis 1: esaltazione del Colosseo (T14)
Quintiliano.<br />
• Institutio oratoria 12,1-13: onestà e idealità nell’attività politica (T1)<br />
• Institutio oratoria 10,1,105-110 Greci e Latini a confronto:Demostene e Cicerone (T5)<br />
L’età degli imperatori per adozione: caratteri generali.<br />
Giovenale.<br />
• Satire 7,22-47: i finti mecenati (T10)<br />
• Satire 6,136-141: la moglie ricca (T11)<br />
• Satire 6,434-456: l’intellettuale (T14)<br />
• Satire 2,29-63: uomini e donne :il rovesciamento dei ruoli (T15)<br />
• Satire 2,65-116 : uomini vestiti da donne(T16)<br />
Plinio il Giovane.<br />
• Epistulae 10,97La risposta dell’imperatore (T3)<br />
Tacito.<br />
• Agricola 1: il principato spegne la virtus (T1)<br />
• Agricola 6:L’esempio di Agricola (T9)<br />
• Dialogus de oratoribus 36 : solo la libertà alimenta l’eloquenza (T2)<br />
Apuleio.<br />
• Metamorfosi 1,2-3: L’inizio del romanzo (T3)<br />
• Lettura della “Bella fabella” di Amore e Psiche (IV,28-VI,24).<br />
TESTI<br />
Orazio<br />
Odi<br />
• "#$%&!!'!(!)&*&+&,!%&!-,..,*+&,!56!7#!<br />
• I,9: paesaggio invernale (T 3);<br />
• I,11: carpe diem (T4);<br />
• I,37: Come un avvoltoio sulle colombe (T2)<br />
• II,10: aurea mediocritas (T10)<br />
• II,14: lo scorrere del tempo (T5)<br />
• <strong>III</strong>,30: compimento del programma (T13)<br />
Epistole<br />
• I,4: all’amico Tibullo (T16)<br />
• I,8: la depressione<br />
• I,11: a Bullazio ,sulla ricerca della felicità(T11)<br />
Seneca<br />
• De brevitate vitae 1,1-4: la vita non è breve (T4)<br />
• De vita beata 16,1-3: la felicità (T6)<br />
Epistulae ad Lucilium<br />
• 47,1-5; 10-11:gli schiavi sono uomini (T3)<br />
• 59,14—18: solo il saggio è felice (T4)
Lucano<br />
Pharsalia,1,1-32 Proemio (T1)<br />
Persio<br />
Choliambi 1-14 (T11)<br />
Marziale<br />
Epigrammata 10,4 (T6)<br />
Tacito<br />
Historiae 1,1Proemio (T3)<br />
Annales<br />
• 1,1 Proemio (T5)<br />
• XV, 62-64: la morte di Seneca (fotocopia)<br />
• XVI, 18-19l: la morte di Petronio (fotocopia)<br />
N.B. La lettura dei brani antologici è avvenuta prevalentemente in traduzione italiana. Alcuni dei<br />
testi indicati sono stati forniti in fotocopia<br />
LIBRI DI TESTO<br />
G.B.Conte-E.Pianezzola “Corso integrato di letteratura latina” - Le Monnier Vol.3 L’età di<br />
Augusto<br />
G.B.Conte-E.Pianezzola “Corso integrato di letteratura latina” - Le Monnier Vol.4 La prima età<br />
imperiale<br />
Seneca “La saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo “ Simone editore<br />
Virgilio ,Orazio,Tibullo “Auori latini”( a cura di M. Bettini) La Nuova Italia<br />
ALUNNI DOCENTE<br />
Prof .Gabriella Tamburrino
ALLEGATO N.8<br />
L'ORATORIA:<br />
Lisia<br />
Isocrate<br />
Demostene<br />
LA COMMEDIA NUOVA:<br />
Menandro:<br />
PROGRAMMA DI GRECO<br />
CLASSE <strong>III</strong> F<br />
ANNO SCOLASTICO 2012-2013<br />
LETTERATURA<br />
• L’arbitrato vv.42-186; 200-242: un giudizio improvvisato<br />
• L’arbitrato vv.288-380: un padre per un trovatello<br />
• L’arbitrato vv.558-.611: un uomo in crisi<br />
L'ELLENISMO. LA POESIA ALESSANDRINA:<br />
Callimaco:<br />
• Aitia vv.1-38: contro i Telchini<br />
• Aitia: fr.75: la storia di Acontio e Cidippe<br />
• Inno ad Apollo vv.106-114<br />
• Epigramma XXV: promesse d’amore<br />
• Epigramma XXV<strong>III</strong>: vita e arte<br />
Apollonio Rodio:<br />
Teocrito:<br />
• Argonautiche 3, 275-298: il dardo di Eros<br />
• Argonautiche 3, 616-664: il sogno di Medea<br />
• Argonautiche 3, 744-769; 802-824: tormento notturno<br />
• Argonautiche 3, 984-1024; 1063-1132:l’incontro di Medea con Giasone<br />
• Idillio I :Tirsi<br />
• Idillio VII: le Talisie<br />
• Idillio XV: le Siracusane<br />
L'EPIGRAMMA:<br />
Asclepiade:<br />
• Antologia Palatina 12, 46: Il male di vivere
• Antologia Palatina 5, 189: Il dardo di Afrodite<br />
• Antologia Palatina 5, 169: A ognuno la sua dolcezza<br />
• Antologia Palatina 12, 50: Breve è il giorno<br />
• Antologia Palatina 12, 135: Tradito dal vino<br />
Leonida di Taranto:<br />
Meleagro:<br />
• Antologia Palatina 7, 295: Teride vecchio<br />
• Antologia Palatina 7, 455: Qui giace Maronide<br />
• Antologia Palatina 7, 504: Una morte atroce<br />
• Antologia Palatina 7, 506: Doppia sepoltura<br />
• Antologia Palatina 7, 715: Leonida<br />
• Antologia Palatina 5, 8: I testimoni del giuramento<br />
• Antologia Palatina 5, 174: Leggero come il sonno<br />
LA STORIOGRAFIA:<br />
Polibio:<br />
• Historiae 1, 1-4: Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità<br />
• Historiae 3,6-7: Il ‘secondo proemio’ e l’analisi delle cause<br />
• Historiae 12, 25b-25e: Il compito specifico dello storiografo<br />
• Historiae 6, 2-5; 7-10: La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni<br />
vicenda<br />
ORATORIA E RETORICA.<br />
Asianesimo e atticismo.<br />
Anonimo autore Del Sublime:<br />
• Del Sublime 1-2: Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi<br />
• Del Sublime 7-9: Le fonti del sublime<br />
• Del Sublime 32-33: 35, 2-5: È preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente?<br />
• Del Sublime 44: Le cause della corrotta eloquenza<br />
PLUTARCO<br />
• Vite parallele: Lettura integrale di una coppia di biografie a scelta dell’alunno<br />
LA SECONDA SOFISTICA:<br />
Luciano di Samosata:<br />
• Vite all’incanto 7,11: La povertà elargisce la vera felicità<br />
• Dialoghi dei morti: Caronte e Menippo<br />
• Dialoghi dei morti: Menippo ed Ermes<br />
• Morte di Peregrino 32-40: Un plateale suicidio<br />
• Morte di Peregrino 11-13: I cristiani<br />
• Storia Vera: lettura integrale in traduzione italiana<br />
N.B.: La lettura dei brani antologici è avvenuta prevalentemente in traduzione italiana. Alcuni<br />
dei testi indicati sono stati forniti in fotocopia
SOFOCLE, Antigone<br />
LISIA<br />
• !**4!7899!!<br />
• !**4!7:"8"7;!!<br />
• !**4!
ALLEGATO N.9<br />
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Anno Scolastico 2012-13 Classe <strong>III</strong>F<br />
Testo di riferimento: “Literary Hyperlinks” Silvia Maglioni - Graeme Thomson, CIDEB<br />
THE ROMANTIC AGE<br />
HISTORICAL SETTING<br />
The Age of Revolutions<br />
The Industrial Revolution<br />
The new urban population<br />
The road to reforms<br />
LITERARY GROUND<br />
The origin of the word “Romantic”<br />
The Sublime<br />
Characteristics of Romanticism<br />
Poetic visions<br />
The first generation of Romantic poets<br />
The second generation of Romantic poets<br />
§ THOMAS GRAY<br />
Historical context<br />
Ø “Elegy Written in a Country Churchyard”<br />
§ WILLIAM BLAKE<br />
Historical context<br />
Ø “The Lamb” (from “Songs of Innocence” )<br />
Ø “The Tyger” (from “Songs of Experience” )
§ WILLIAM WORDSWORTH<br />
Historical context<br />
Ø “Sonnet Composed upon Westminster Bridge”<br />
Ø “I Wandered Lonely as a Cloud”<br />
§ SAMUEL TAYLOR COLERIDGE<br />
Historical context<br />
Ø Extract 1 “There was a ship” (from “The Rime of the Ancient Mariner”)<br />
Ø Extract 2 “The ice was all around” (from “The Rime of the Ancient Mariner “ )<br />
§ PERCY BYSSHE SHELLEY<br />
Historical context<br />
Ø “Ode to the West Wind”<br />
§ JOHN KEATS<br />
Historical context<br />
Ø “La Belle Dame Sans Mercy”<br />
Ø “Ode on a Grecian Urn”<br />
§ JANE AUSTEN<br />
Historical context<br />
Ø Chapter One from “Pride and Prejudice”<br />
THE VICTORIAN AGE<br />
HISTORICAL SETTING<br />
The Age of Empire<br />
Economy and society<br />
The growth of industrial cities<br />
The pressure for reforms
Technological innovation<br />
The communication revolution<br />
The cost of living<br />
Poverty and the Poor Laws<br />
Managing the Empire<br />
The Victorian ideal<br />
The late Victorian period<br />
A time of new ideas<br />
Darwin and the Theory of Evolution<br />
LITERARY GROUND<br />
The Victorian novel<br />
§ CHARLES DICKENS<br />
Historical context<br />
Ø Extracts from “Oliver Twist”<br />
Ø Extract: “A man of realities” (from “Hard times” )<br />
Ø Extract: “I’ve made a gentleman on you!” (from “Great expectations” )<br />
§ ROBERT LOUIS STEVENSON<br />
Historical context<br />
Ø Extract: “Dr Jekyll first experiment” (from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” )<br />
§ OSCAR WILDE<br />
Historical context<br />
Ø “The Picture of Dorian Gray”<br />
THE AGE OF MODERNISM<br />
LITERAY GROUND<br />
Modernism in Europe: a break with the past
§ JAMES JOYCE<br />
Historical context<br />
Ø “An Encounter” (from “Dubliners” )<br />
Ø “Eveline” (from “Dubliners” )<br />
Ø “The Dead” (from “Dubliners” )<br />
§ VIRGINIA WOOLF<br />
Historical context<br />
Ø “Mrs Dalloway”<br />
§ E.M. FORSTER<br />
Historical setting<br />
Ø Comparing extracts from the novel and the film“A Room with a View<br />
Gli Alunni L’Insegnante<br />
Prof.ssa Laura Zerboni
ALLEGATO N.10<br />
PROGRAMMA DI STORIA<br />
Anno scolastico 2012/2013<br />
Caratteristiche generali degli Stati europei nella seconda metà del XIX secolo.<br />
Nazione e Nazionalismo. L’Imperialismo.<br />
La seconda Rivoluzione industriale, le invenzioni, le trasformazioni, la società di massa.<br />
3 F<br />
La Grande crisi del 1873 e il declino dello Stato Liberale.<br />
La crisi dell’agricoltura e le grandi migrazioni.<br />
Il protezionismo e l’intervento dello Stato.<br />
Il Capitalismo organizzato. I grandi gruppi monopolistici. Il Taylorismo. La catena di montaggio.<br />
Il movimento operaio e la Prima internazionale: Anarchismo e marxismo.<br />
La seconda Internazionale: il revisionismo di E. Bernstein.<br />
L’Italia e la crisi di fine secolo.<br />
Il XX secolo e la nascita della società di massa:<br />
L’Italia nell’età giolittiana(1903-1914):<br />
Il decollo industriale italiano. I nuovi compiti dello Stato liberale e la politica riformatrice.<br />
Il problema del Mezzogiorno e l’emigrazione.<br />
Il nazionalismo italiano e il Futurismo: la guerra di Libia.<br />
La Grande Guerra (1914-1918):<br />
Analisi delle cause. Interpretazioni e caratteristiche del conflitto.<br />
Gli schieramenti e le alleanze.<br />
Neutralismo e interventismo in Italia.<br />
L’intervento italiano a favore dell’Intesa.<br />
La guerra dal 1914 al 1916: Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea.<br />
Il 1917 l’anno decisivo. L’intervento degli Stati Uniti, Il ritiro della Russia, la sconfitta di Caporetto.<br />
La conclusione del conflitto e i 14 punti di Wilson. I trattati di Pace. La nascita della Società delle<br />
Nazioni.<br />
La Rivoluzione bolscevica
La Russia zarista e i partiti d’opposizione.<br />
La Russia nella Prima guerra mondiale.<br />
La Rivoluzione del Febbraio 1917: il governo provvisorio della Duma e l’opposizione dei soviet.<br />
Lenin e le tesi di Aprile. Il problema del passaggio al socialismo.<br />
La Russia tra guerra e Rivoluzione. La Rivoluzione di Ottobre 1917 e la conquista del potere da<br />
parte dei bolscevichi.<br />
La pace di Brest-Litovsk.<br />
Dal comunismo di guerra alla Nep del 1921<br />
La Terza Internazionale comunista.<br />
La morte di Lenin 1924 , l’ascesa di Stalin: l’industrializzazione del paese.<br />
La collettivizzazione delle campagne. “Il Socialismo in un solo paese.”<br />
Il mondo tra le due guerre:<br />
L’Europa del primo dopoguerra: un’età di trasformazioni e inquietudini:<br />
Italia : La crisi della società italiana nel primo dopoguerra e il biennio rosso.<br />
La nuova destra e l’impresa fiumana di D’Annunzio.<br />
Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento: il discorso di San Sepolcro. La nascita del Partito<br />
Nazionale Fascista.<br />
L’ultimo ministero Giolitti: l’occupazione delle fabbriche, il Trattato di Rapallo e il blocco<br />
nazionale con i fascisti.<br />
I problemi della Sinistra italiana e la nascita del Partito Comunista.<br />
Il Partito Popolare Italiano e i rapporti con il Vaticano. La fine dello Stato liberale.<br />
La marcia su Roma.<br />
Il Fascismo al potere. Elementi ideologici.<br />
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime” del 1925 e l’organizzazione dello<br />
Stato Fascista.<br />
Le politiche economiche del fascismo: dal Liberismo al protezionismo, all’autarchia.<br />
La Carta del Lavoro e il sistema corporativo.<br />
La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi.<br />
L’organizzazione del consenso delle masse. Il Fascismo come regime totalitario di massa.<br />
La politica di Mussolini dopo la crisi del 1929: lo Stato imprenditore: le opere pubbliche e la<br />
politica rurale in Italia.
La politica estera: la prima e la seconda fase della politica estera di Mussolini. L’aggressione<br />
all’Etiopia e l’Impero. L’avvicinamento alla Germania di Hitler. Le leggi razziali. L’Asse Roma<br />
Berlino.<br />
L’Italia antifascista.<br />
Gli Stati uniti : Lo sviluppo degli anni ’20 e la grande crisi del 1929.<br />
Roosevelt e il New Deal .<br />
La teoria keynesiana e lo Stato sociale.<br />
La Germania:<br />
Dalla Repubblica di Weimer al Nazionalsocialismo.<br />
1933: Hitler e la realizzazione della dittatura nazionalsocialista.<br />
Il programma economico e sociale del Nazionalsocialismo.<br />
La politica razziale di Hitler e l’antisemitismo.<br />
Il concetto di Totalitarismo.<br />
La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945):<br />
Caratteristiche generali e cause.<br />
Il Patto di Monaco . Il Patto Ribbentrop-Molotov(Germania-Russia). Il Patto d’acciaio(Germania-<br />
Italia).<br />
L’invasione della Polonia<br />
L’avanzata di Hitler in Europa. Paesi e tipo di conquiste.<br />
1940. L’entrata in guerra dell’Italia. Il Patto Tripartito. .<br />
1941. L’attacco di Hitler alla Russia. Pearl Harbour. L’intervento degli Stati Uniti.<br />
La Carta Atlantica. La Conferenza di Washington.<br />
1942. Lo sterminio degli ebrei e i campi di concentramento.<br />
La sconfitta tedesca a Stalingrado. La controffensiva americana sul Pacifico.<br />
La controffensiva anglo-americana nel Mediterraneo.<br />
1943: Italia: La crisi del regime fascista. Lo sbarco alleato in Sicilia.<br />
L’armistizio e il governo Badoglio. La Repubblica di Salò.<br />
1944. La Liberazione in Europa.<br />
La Resistenza in Europa e in Italia : i Comitati di Liberazione Nazionale.<br />
1945: Fine delle due dittature in Italia e in Germania. Hiroshima e Nagasaki.
Le armi nel secondo conflitto mondiale.<br />
La Conferenza di Yalta e l’inizio del mondo bipolare. La conferenza di Postdam.<br />
La Dottrina Truman e “ la guerra fredda ”.<br />
I trattati di Pace, la nascita dell’Onu, la Nato.<br />
L’Italia dalla Liberazione agli anni del centrismo:<br />
I problemi della ricostruzione economico sociale.<br />
Il Referendum. La Costituzione. Le elezioni del 1948.<br />
Il Piano Marshall. Gli anni del centrismo: A. De Gasperi.(1948-1953)<br />
1953-1958 . Inizio apertura a sinistra: Togliatti e la via italiana al socialismo. XX Congresso del<br />
PCUS : Kruscev e la destalinizzazione. 1956 e l’intervento armato in Ungheria.<br />
Gli anni del boom economico.<br />
1962-63. Il primo governo di centro-sinistra.<br />
Gli Alunni Prof.ssa Paola Malorni
ALLEGATO N.11<br />
I.KANT<br />
PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />
Anno scolastico 2012/2013<br />
3 F<br />
Il Criticismo come “ filosofia del limite”e l’orizzonte storico del pensiero kantiano.<br />
• La Critica della Ragion Pura: Significato dell’opera. I giudizi sintetici a priori.<br />
• La” rivoluzione copernicana”. Il concetto di trascendentale.<br />
• La partizione della Critica della Ragion Pura:<br />
• L’estetica trascendentale: le forme a priori dello spazio e del tempo.<br />
• L’analitica trascendentale: Le categorie. La deduzione trascendentale: l’Io penso.<br />
• Il concetto kantiano di noumeno.<br />
• La dialettica trascendentale: Le tre idee della Ragione. L’uso regolativo delle idee.<br />
• La Critica della Ragion Pratica: Il significato e i compiti dell’opera.<br />
• L’assolutezza della legge morale e il valore della Ragione.<br />
• La categoricità dell’imperativo morale e le tre formule dell’imperativo categorico.<br />
• La teoria dei postulati pratici. Il primato della Ragion Pratica.<br />
• La Critica del Giudizio: L’analisi del bello e del sublime.<br />
• Il giudizio teleologico.<br />
Il Romanticismo e l’Idealismo<br />
• Intima connessione tra idealismo e romanticismo<br />
• Esaltazione dell’arte<br />
• Rivalutazione della tradizione. Lo storicismo.<br />
FICHTE: l’Idealismo Etico<br />
• La critica alla “cosa in sé “ di Kant<br />
• L’Io come principio assoluto e infinito<br />
• L’Io e i tre momenti della vita dello spirito. L’Io puro e il non io .<br />
• Carattere etico dell’idealismo fichtiano<br />
• “La Missione” del dotto<br />
• “Discorsi alla nazione tedesca”<br />
HEGEL:La Filosofia come Comprensione del Reale<br />
• Formazione e scritti giovanili<br />
• La critica all’idealismo soggettivo di Fichte.<br />
• Il sistema assoluto. La Dialettica dell’Idea: i tre momenti.<br />
• La Razionalità del reale: Infinito e finito.<br />
• La funzione della Filosofia. Il giustificazionismo hegeliano<br />
• La Fenomenologia dello spirito: significato e divisione dell’opera.
• L’Autocoscienza e le “figure” storico-ideali dello Spirito: la figura servo-padrone, lo<br />
stoicismo-scetticismo, la coscienza infelice.<br />
• L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: Ripartizione generale dell’opera.<br />
In modo particolare:<br />
• Filosofia dello spirito soggettivo<br />
• Filosofia dello Spirito oggettivo:<br />
• Diritto<br />
• Moralità<br />
• Eticità:<br />
• Famiglia. Società civile. Stato.<br />
• La Filosofia della Storia.<br />
• Filosofia dello Spirito assoluto:<br />
• Arte<br />
• Religione<br />
• Filosofia<br />
Analisi dell’Esistenza in Shopenhauer e Kierkegaard<br />
• Opposizione all’ottimismo idealistico<br />
SHOPENHAUER: dolore dell’esistenza e possibili vie di liberazione<br />
• Ambiente familiare e formazione<br />
• Riferimenti culturali: (Kant, Platone e pensiero orientale)<br />
• Il mondo come mia rappresentazione.<br />
• Realtà fenomenica come illusione e inganno,”il velo di Maya”<br />
• Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo.<br />
• Il Mondo come Volontà: caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere<br />
• Vita come continuo oscillare tra dolore, piacere e noia. La vita come sofferenza universale.<br />
Il pessimismo. L’illusione dell’amore.<br />
• L’Arte come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza.<br />
• La Morale come seconda via di liberazione<br />
• Ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere<br />
KIERKEGAARD: esistenza come scelta e fede come paradosso.<br />
• Tormentata giovinezza<br />
• Fondamento religioso della sua filosofia<br />
• L’esistenza come possibilità.<br />
• La critica all’hegelismo: Dal primato della Ragione al primato del Singolo.<br />
• Gli stadi dell’esistenza:<br />
• Scelta della vita estetica, etica e religiosa.<br />
L’Angoscia.<br />
• Fede come unico antidoto alla disperazione<br />
• La fede come paradosso.<br />
Progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e in Marx<br />
• Destra e sinistra hegeliana: Caratteri generali.<br />
FEUERBACH: materialismo naturalistico<br />
• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione hegeliani
• La critica alla religione: l’alienazione<br />
• Indagine sull’uomo come essere libero e naturale<br />
• Il materialismo di Feuerbach .<br />
MARX: La vita e le opere.<br />
• Le caratteristiche generali del marxismo. Il concetto di prassi.<br />
• La critica al misticismo logico di Hegel.<br />
• La critica allo Stato moderno e al liberalismo<br />
• Riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach<br />
• La critica all’economia borgese e il concetto di Alienazione.<br />
• Cause dell’alienazione e possibile superamento.<br />
• Concezione materialistica della storia<br />
• Rapporti fra struttura e sovrastruttura<br />
• La lotta di <strong>classe</strong> e il Manifesto del Partito Comunista.<br />
• Il Capitale:<br />
• Analisi della merce<br />
• Concetto di plusvalore<br />
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato.<br />
• Le fasi della futura società comunista: la società senza classi.<br />
Scienza dei Fatti: Positivismo ed evoluzionismo:<br />
• Celebrazione del primato della scienza<br />
• Significato e valore del termine “positivo”<br />
• Origine del movimento positivista in Francia<br />
In particolare:<br />
COMTE: Filosofia positiva e nuova scienza della società<br />
• Fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze<br />
• Legge dei tre stadi<br />
• Fondazione della sociologia<br />
• Culto della scienza<br />
DARWIN: evoluzionismo<br />
• L’Evoluzione della specie<br />
• Teoria della selezione naturale<br />
• Conseguenze filosofiche del darwinismo<br />
La crisi delle certezze dell’Ottocento e la Filosofia di Nietzsche:<br />
• Vita e scritti.<br />
• Filosofia e malattia<br />
• Fasi della filosofia:<br />
• Il periodo giovanile, romantico:<br />
La nascita della tragedia:<br />
Apollineo e dionisiaco<br />
Rottura dell’armonia: Euripide<br />
Socrate e l’esaltazione del concetto e la fondazione della morale.<br />
Le Considerazioni inattuali: la critica allo storicismo e i tre tipi di Storia.<br />
Rapporti con Shopenhauer e Wagner.
• Il periodo illuministico<br />
Decostruzione della morale occidentale<br />
Analisi genealogica della morale<br />
Ascetismo,obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori<br />
“ Morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche<br />
Il grande annuncio dell’”uomo folle”<br />
L’avvento del superuomo e il nichilismo attivo.<br />
L’autosoppressione della morale e la fine del platonismo.<br />
• Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche:<br />
L’Oltreuomo<br />
Dottrina dell’eterno ritorno e suoi significati. La fedeltà alla terra.<br />
Volontà di potenza<br />
Volontà e creatività<br />
Transvalutazione dei valori e il prospettivismo nietzschano.<br />
Freud e la Psicanalisi<br />
• Psicanalisi: una disciplina rivoluzionaria.<br />
• Formazione e rapporto con la medicina del tempo<br />
• Ricerche sui casi d’isteria<br />
• Origine sessuale della nevrosi e rottura con Breuer<br />
• Abbandono della pratica dell’ipnosi<br />
• Significato dei sogni e il lavoro onirico: la terapia psicoanalitica.<br />
• Es, Super-Io, Io<br />
• Cause della nevrosi: Prima topica: principio del piacere e principio di realtà.<br />
Le fasi della libido e la sessualità infantile<br />
• Il complesso di Edipo e la seconda topica. Il Super-Io.<br />
• Eros e thanatos.<br />
• Il “Disagio della civiltà”. Il concetto di sublimazione<br />
L’Esistenzialismo: caratteristiche generali.<br />
• Heiddeger: il problema del senso dell’Essere. L’Esserci.<br />
• Temporalità e storicità dell’esserci.<br />
• La cura , l’autenticità e l’inautenticità .<br />
Prof.ssa Paola Malorni
ALLEGATO N.12<br />
Le funzioni goniometriche<br />
Programma di Matematica<br />
Anno scolastico 2012-13 Classe <strong>III</strong> F<br />
Gli angoli e la loro ampiezza: la misura in gradi e in radianti. La circonferenza goniometrica. Le<br />
funzioni goniometriche seno,coseno,tangente e cotangente. Variazioni e periodicità delle funzioni<br />
goniometriche. Rappresentazione grafica delle funzioni seno,coseno tangente e cotangente. La<br />
prima relazione fondamentale della goniometria. Relazioni tra le funzioni seno,coseno,tangente e<br />
cotangente di uno stesso angolo. Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta.<br />
Le funzioni secante e cosecante e i relativi grafici. Le funzioni inverse: arcoseno e arcocoseno. Le<br />
funzioni goniometriche di angoli particolari: 30°, 60°, 45°. Gli angoli associati: le funzioni<br />
goniometriche di angoli associati.. Riduzione al primo quadrante . Le formule di addizione e<br />
sottrazione del seno,coseno e tangente. Le formule di duplicazione, le formule di bi<strong>sez</strong>ione, le<br />
formule parametriche. Applicazioni delle formule studiate alla risoluzione di esercizi, identità,<br />
equazioni.Le equazioni elementari. Equazioni riconducibili ad elementari. Equazioni riducibili ad<br />
elementari mediante l’applicazione di formule goniometriche. Equazioni lineari in seno e coseno<br />
risolte sia attraverso l’applicazione delle formule parametriche che con il metodo grafico.<br />
Equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno. Equazioni riconducibili ad omogenee di<br />
secondo grado in seno e coseno.<br />
La Trigonometria<br />
I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazione dei teoremi<br />
sui triangoli rettangoli: l’area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso, il teorema della<br />
corda. I triangoli qualunque: il teorema dei seni e il teorema di Carnot. La risoluzione dei triangoli<br />
qualunque.<br />
La funzione esponenziale e la funzione logaritmo<br />
Definizione di funzione : dominio e codominio. Le funzioni numeriche e la ricerca del campo<br />
d’esistenza. La classificazione delle funzioni. Le funzioni iniettive,suriettive e biettive. La funzione<br />
inversa. Le proprietà delle potenze ad esponente reale. La funzione esponenziale<br />
.Rappresentazione grafica della funzione esponenziale con base a>1 e con base 0
ALLEGATO N.13<br />
Elettromagnetismo<br />
La carica elettrica e la legge di Coulomb<br />
Programma di Fisica<br />
Anno scolastico 2012 –‘13<br />
Classe <strong>III</strong> F<br />
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. La polarizzazione dei dielettrici.<br />
L’induzione elettrostatica. La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia.<br />
Il campo elettrico<br />
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.<br />
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: il teorema di Gauss. Applicazione del<br />
teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di<br />
carica. Campo elettrico tra le armature di un condensatore piano. Campo elettrico all’esterno di<br />
una distribuzione sferica di carica .<br />
L’energia potenziale elettrica<br />
Il campo elettrostatico conservativo e l’energia potenziale elettrica . Espressione del’energia<br />
potenziale nel caso di un campo uniforme e nel caso di un campo radiale. Definizione del<br />
potenziale e della differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Il<br />
potenziale di un carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. Perpendicolarità tra superfici<br />
equipotenziali e linee di campo. La circuitazione del campo elettrostatico .<br />
Fenomeni di elettrostatica<br />
La distribuzione di carica in un conduttore all’equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il<br />
potenziale in un conduttore all’equilibrio. La capacità di un conduttore:la capacità di una sfera<br />
conduttrice isolata. Definizione di capacità di un condensatore . La capacità di un condensatore<br />
piano. Il teorema di Coulomb.<br />
La corrente elettrica continua<br />
L’intensità di corrente in un conduttore metallico. I circuiti elettrici: collegamento in serie e in<br />
parallelo. La prima e la seconda legge di Ohm.La dipendenza della resistività dalla temperatura.<br />
Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi,la legge delle maglie.<br />
L’effetto Joule. I superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.<br />
Fenomeni magnetici<br />
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza tra magneti e correnti. Interazione<br />
corrente-corrente. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica deflettente su un filo<br />
percorso da corrente. Principio di funzionamento del motore elettrico. La legge di Biot-Savart. La<br />
forza di Lorentz: il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo<br />
magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo: il teorema di<br />
Ampère. Calcolo del campo magnetico in un solenoide con il teorema Ampère. Le proprieta’<br />
magnetiche dei materiali: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Il ciclo di isteresi<br />
magnetica.
L’induzione elettromagnetica<br />
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.<br />
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche<br />
Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto. Il termine mancante: la<br />
corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Lo spettro<br />
elettromagnetico.<br />
Libro di testo adottato: U. Amaldi “ La fisica di Amaldi : Elettromagnetismo” Zanichelli<br />
!<br />
Prof. Maria Grazia Gallo
ALLEGATO N. 14<br />
Programma di Scienze Naturali<br />
A.S. 2012/2013 Classe <strong>III</strong> F Prof. Lucia Altobelli<br />
Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli<br />
L’ambiente celeste<br />
Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta.<br />
Stelle doppie e sistemi di stelle. Colori, temperatura e spettri stellari. Stelle in fuga ed in<br />
avvicinamento. Materia interstellare e nebulose. La fornace nucleare del Sole e delle altre stelle. Il<br />
diagramma H.R. Dalle nebulose alle giganti rosse. Masse iniziali diverse , stelle con destini<br />
diversi. La nostra Galassia. Galassie e famiglie di galassie. La legge di Hubble e l’espansione<br />
dell’Universo. L’Universo stazionario. Il big bang e l’Universo inflazionario. Evoluzione futura<br />
dell’Universo<br />
Il Sistema Solare<br />
Il Sistema Solare. La struttura ad involucri del Sole. L’attività solare. Il movimento dei pianeti<br />
attorno al Sole: leggi di Keplero e legge della gravitazione universale .Pianeti terrestri. Pianeti<br />
gioviani . Un pianeta a scelta del candidato. Gli asteroidi. Meteore e meteoriti. Le comete. Origine<br />
del Sistema Solare<br />
Il pianeta Terra<br />
La forma della Terra. Il Geoide .Il calcolo di Eratostene della circonferenza terrestre. Il reticolato<br />
Geografico. La posizione dei luoghi sulla Terra e quella degli astri nel cielo:definizione di<br />
latitudine , longitudine ,declinazione celeste e ascensione retta. Il moto di rotazione. Prove e<br />
conseguenze del moto di rotazione . Il ciclo quotidiano del dì e della notte. Il moto di rivoluzione.<br />
Prove e conseguenze della rivoluzione terrestre .Unità di misura del tempo: giorno solare , giorno<br />
sidereo, anno sidereo , anno tropico, anno civile. I fusi orari. Moto doppio conico. La precessione<br />
degli equinozi.<br />
La Luna e il sistema Terra –Luna<br />
Caratteristiche della Luna. Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera. Il moto di rotazione. Il<br />
moto di rivoluzione. Mese sidereo e mese sinodico. Il moto di traslazione. Le fasi lunari. Eclissi di<br />
Luna e di Sole. Il paesaggio lunare. Origine della Luna: ipotesi dell’impatto gigante<br />
La crosta terrestre: minerali e rocce.<br />
I minerali. La struttura cristallina dei minerali. Proprietà fisiche dei minerali .La classificazione dei<br />
minerali. I minerali silicatici. Genesi dei minerali. I processi litogenetici. Dal magma alle rocce<br />
magmatiche. Classificazione dei magmi. Famiglie di rocce magmatiche. Origine e formazione dei<br />
magmi. Dai sedimenti alle rocce compatte. Le rocce clastiche. Le rocce organogene .Le rocce<br />
chimiche.. Le rocce metamorfiche. Facies metamorfiche . Il metamorfismo di contatto. Il<br />
metamorfismo regionale Il ciclo litogenetico.
I fenomeni vulcanici.<br />
Vulcanismo. Attività vulcanica. Edifici vulcanici. I tipi di eruzione.. Il vulcanismo effusivo delle<br />
dorsali oceaniche e dei punti caldi. Il vulcanismo esplosivo: esplosioni e nubi ardenti. La<br />
distribuzione geografica dei vulcani.<br />
I fenomeni sismici<br />
La teoria del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Differenti tipi di onde sismiche. I sismografi.<br />
Localizzazione dell’epicentro di un terremoto. La scala di intensità: la scala MCS. Le isosisme. La<br />
magnitudo di un terremoto. Magnitudo e intensità a confronto. I terremoti e l’interno della Terra.<br />
La distribuzione geografica dei terremoti.<br />
La tettonica delle placche : un modello globale.<br />
La struttura interna della Terra:involucri e discontinuità . Il flusso di calore. La temperatura<br />
interna della Terra. Il campo magnetico terrestre. Il paleomagnetismo. Crosta continentale e crosta<br />
oceanica a confronto. L’isostasia. La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. Le<br />
dorsali oceaniche e le fosse abissali:espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi<br />
oceanici. La tettonica delle placche. Le placche litosferiche. I margini delle placche. Saggiando il<br />
modello:vulcanismo,sismicità e placche. Un possibile motore per la tettonica delle placche: celle<br />
convettive e punti caldi.<br />
ALUNNI DOCENTE<br />
Prof.ssa Lucia Altobelli
ALLEGATO N.15<br />
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE<br />
A.S. 2012/13 CLASSE 3^ F<br />
Il Realismo:<br />
-G. Courbet:<br />
-S.F. Millet:<br />
-H. Daumier<br />
L’Impressionismo:<br />
-C. Monet<br />
-E. Degas<br />
-P. Cezanne<br />
Il Postimpressionismo:<br />
-V. Van Gogh<br />
Il Modernismo:<br />
-A. Gaudì<br />
La Sucessione austriaca:<br />
- G. Klimt<br />
Lo spaccapietre<br />
Seppellimento a Ornans<br />
Signorine sulla riva della Senna<br />
L’Angelus<br />
Scompartimento di terza <strong>classe</strong><br />
La Grennouillère<br />
La Cattedrale di Rouen<br />
Lo stagno delle ninfee<br />
L’assenzio<br />
La <strong>classe</strong> di danza del signor Pierrot<br />
Giocatori di carte<br />
La montagna Sainte Victoire<br />
Mangiatori di patate<br />
Autoritratto<br />
La camera da letto<br />
Notte stellata<br />
La cattedrale di Auvers<br />
Campo di grano con corvi<br />
Casa Milà – Casa Batllò – La Sacrada Familia<br />
Il ballo dell’Opera<br />
Giuditta
Pre-espressionismo ed Espressionismo:<br />
Il Cubismo:<br />
-E. Munch<br />
-E.L. Kirchner<br />
-P. Picasso<br />
L’Astrattismo:<br />
-V. Kandinskij<br />
Il Futurismo:<br />
- U. Boccioni<br />
La pittura metafisica:<br />
Il Dadaismo:<br />
Il Surrealismo:<br />
-G. De Chirico<br />
-M. Duchamp<br />
-K.Schwitters<br />
-R. Magritte<br />
L’urlo<br />
Pubertà<br />
Passeggiata in Corso Karl Johans<br />
Madonna<br />
Marcella<br />
Nollendorfplatz<br />
Foresta in inverno<br />
Poveri in riva al mare<br />
I giocolieri<br />
Les Demoiselles d’Avignon<br />
Ritratto di A. Vollard<br />
Guernica<br />
Il cavaliere azzurro<br />
Alcuni cerchi<br />
Autoritratto<br />
Officine a Porta Romana<br />
La città che sale<br />
Stati d’animo:quelli che restano<br />
Stati d’animo:gli addii<br />
Ritratto del Maestro F. Busoni<br />
Forme uniche della continuità nello spazio<br />
Canto d’amore<br />
La piazza d’Italia<br />
Le Muse inquietanti<br />
Fontana<br />
La Gioconda<br />
Merzbau<br />
Impero della luce
Il Ritorno all’ordine:<br />
- Novecento<br />
- I Sei di Torino<br />
- I Chiaristi Lombardi<br />
- La Scuola Romana<br />
Architettura del XX secolo:<br />
Il doppio segreto<br />
- Architettura Razionalista – Le Corbusier<br />
- Architettura Organica – F. L. Wright<br />
- Bauhaus<br />
Gli Alunni Il Docente<br />
Fabio Bellisario
ALLEGATO N.16<br />
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />
CLASSE 3 <strong>sez</strong> F - ANNO SCOLASTICO 2012/13<br />
Prof.ssa Simonetta Lo Bianco<br />
1) MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI ORGANICHE<br />
- Esercizi per lo sviluppo della resistenza organica e muscolare<br />
2) POTENZIAMENTO MUSCOLARE<br />
- Esercizi a carico naturale con impegno della muscolatura dorsale, addominale, degli arti<br />
superiori ed inferiori.<br />
- Esercizi di opposizione e resistenza.<br />
- Esercizio di potenziamento con macchine e con manubri..<br />
3) RISTRUTTURAZIONE E PERFEZIONAMENTO DI SCHEMI MOTORI<br />
- Esercizi di coordinazione dinamica generale ,oculo-manuale, braccia-gambe.<br />
- Andature, combinazione di passi,saltelli, salti, giri.<br />
- Esercizi di equilibrio statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.<br />
- Esercizi di destrezza e velocità.<br />
4 ) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA<br />
- Giochi presportivi e sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping pong,<br />
badminghton.<br />
5) EQUILIBRIO PSICO-FISICO<br />
TEORIA:<br />
- Esercizi di flessibilità,di allungamento.<br />
- Esercizi di respirazione e rilassamento.<br />
- Linguaggio corporeo, interpretazione e comunicazione non verbale.<br />
Cenni di alimentazione.<br />
Doping: sostanze e tecniche proibite.<br />
!<br />
Gli alunni L’insegnante<br />
Simonetta Lo Bianco
ALLEGATO N. 17<br />
Programma IRC (insegnamento di religione cattolica) 3 F<br />
prof. Antonella Jori<br />
1. Riferimenti biblici ed elementi teologici e mistici nei canti I, <strong>III</strong>, VI, XI, XII, XXX, XXXI, XXXII,<br />
XXX<strong>III</strong> del Paradiso di Dante<br />
2. Concetti fondamentali e documenti principali (encicliche pontificie) della Dottrina sociale della<br />
Chiesa<br />
ALUNNI DOCENTE<br />
prof. Antonella Jori