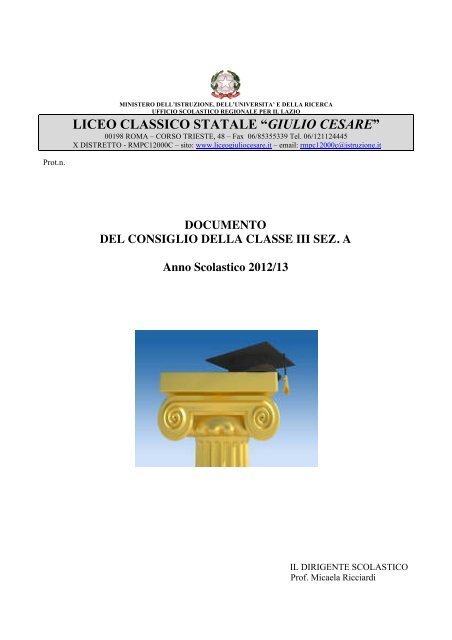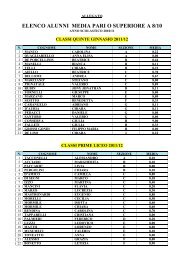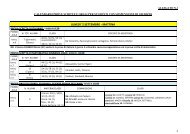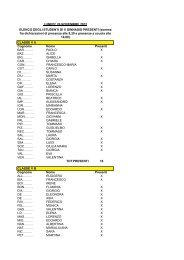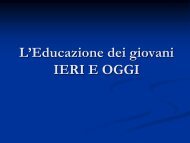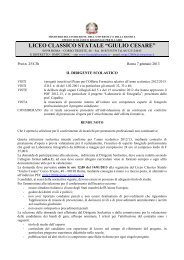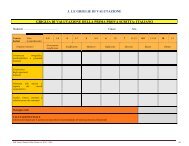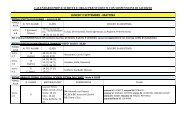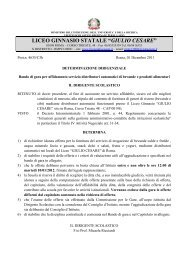Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prot.n.<br />
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />
X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />
DOCUMENTO<br />
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. A<br />
Anno Scolastico 2012/13<br />
IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
Prof. Micaela Ricciardi
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZIONE A<br />
Anno scolastico 2012/13<br />
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />
disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />
Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione A ha definito contenuti, obiettivi, metodi e strumenti<br />
valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.<br />
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />
Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è sorto<br />
(1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />
Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran parte<br />
residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa<br />
collocazione urbana.<br />
L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />
diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità ) ed aule<br />
speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca, dotata di moderni<br />
sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi palestre e un campo di<br />
basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />
Dal POF dell’anno scolastico 2012/13 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />
ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />
ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />
per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />
particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione<br />
alla legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute.<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La <strong>classe</strong> è attualmente composta da 17 studenti provenienti dalla fusione in I liceo di ben quattro V ginnasio<br />
dell’Istituto, di due alunni provenienti da altri Istituti cui si è aggiunto un alunno non promosso in V<br />
ginnasio. All’interno del gruppo <strong>classe</strong> si è distinto un numero di alunni che ha saputo nel corso del triennio<br />
operare un percorso di crescita culturale ed umano di rilievo, consolidando costantemente il proprio metodo<br />
di lavoro fino a ottenere risultati brillanti e talvolta eccellenti. E’ presente altresì un gruppo di alunni che,<br />
pur in possesso di apprezzabili capacità, ha palesato fragilità culturali, di metodo e di impegno<br />
raggiungendo non senza difficoltà gli obiettivi fissati dalle diverse discipline e conseguendo risultati<br />
complessivamente quasi sufficienti.<br />
.<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />
MATERIE LETTERARIE,<br />
LATINO E GRECO<br />
FEDERICO FEDERICO<br />
MATEMATICA MARAZZI MARAZZI<br />
INGLESE DODARO GENOVESE<br />
STORIA DELL'ARTE REGGIANI REGGIANI<br />
ED. FISICA SPINELLI SPINELLI<br />
IRC RONCONI RONCONI
!<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />
ITALIANO/ LATINO NEBBIA NEBBIA NEBBIA<br />
GRECO TESTINI TESTINI TESTINI<br />
STORIA E FILOSOFIA DE ANGELIS IENI IENI<br />
MATEMATICA E FISICA MARAZZI MARAZZI MARAZZI<br />
INGLESE RESCIGNO RESCIGNO RESCIGNO<br />
SCIENZE DE PASQUALE LAURA LAURA<br />
STORIA DELL'ARTE CAPALBO CAPALBO CAPALBO<br />
ED. FISICA SPINELLI SPINELLI SPINELLI<br />
IRC GENOVESE RONCONI SARRIA
OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate sono stati<br />
concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />
riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e<br />
culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti<br />
delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono<br />
riassumere nei seguenti punti :<br />
- acquisire i contenuti generali delle diverse discipline<br />
- usare in modo pertinente il linguaggio specifico delle diverse discipline<br />
- saper argomentare e rielaborare i diversi contenuti disciplinari in maniera personale e critica<br />
- conoscere gli elementi fondanti il nostro patrimonio culturale<br />
- interpretare messaggi espressi in diversi codici (verbali, matematici, grafici ec.)<br />
A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina.<br />
MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />
ITALIANO • Acquisizione dei contenuti generali di autori e movimenti letterari dell’800 e ’900;<br />
• analisi e contestualizzazione del testo letterario<br />
• affinamento delle capacità espressive ed argomentative<br />
LATINO • Conoscenza degli elementi fondamentali della morfosintassi latina;<br />
• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e<br />
sincronica<br />
• analisi e contestualizzazione del testo letterario;<br />
• riconoscimento della tipologia testuale<br />
GRECO • Conoscenza degli elementi fondamentali della morfosintassi greca;<br />
• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e<br />
sincronica<br />
• analisi e contestualizzazione del testo letterario;<br />
• riconoscimento della tipologia testuale e<br />
STORIA • Capacità di cogliere la genesi e l’evoluzione di un evento storico;<br />
• ricostruzione e riproduzione delle strategie argomentative e valutazione della loro<br />
coerenza interna;<br />
• sviluppo del giudizio critico attraverso la discussione razionale;<br />
• educazione alla tolleranza e al rispetto della multiculturalità<br />
FILOSOFIA • Conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale;<br />
• riconoscimento del valore della problematicità in relazione alla complessità del reale;<br />
• ricerca di una sostanziale unità della cultura.<br />
INGLESE • Conoscenza delle principali tematiche storico letterarie del mondo anglosassone;<br />
• abilità nella lettura, nell’interpretazione e nell’applicazione della lingua scritta e<br />
parlata;<br />
• potenziamento delle capacità comunicative ed elaborative finalizzate all’autonomia<br />
linguistica.<br />
MATEMATICA • Sviluppare dimostrazioni all'interno dei sistemi assiomatici studiati<br />
• operare con il simbolismo matematico<br />
• saper risolvere semplici problemi geometrici nel piano con l'ausilio della trigonometria<br />
FISICA Saper analizzare leggi individuando le variabili che le caratterizzano;<br />
• saper esaminare grafici e ricavare da essi informazioni significative sulle variabili<br />
da essi correlate<br />
• saper risolvere semplici problemi<br />
SCIENZE • Conoscere i nodi fondanti della disciplina;<br />
• saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale<br />
STORIA DELL’ARTE • Acquisizione dei contenuti generali di autori e movimenti artistici dell’800 e ‘’900;<br />
• saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale<br />
ED.FISICA • Conoscere i gesti tecnici ed il regolamento essenziale delle varie discipline;<br />
• capacità di percezione, comprensione ed analisi di un compito motorio e di produzione<br />
di una risposta adeguata;<br />
• competenza nel saper applicare schemi di gioco, assumere ruoli e progettare nelle linee<br />
essenziali una seduta di allenamento
IRC • Saper collocare il fenomeno religioso sull’asse storico;<br />
• capacità di riferire il dibattito storiografico e le principali questioni teologiche<br />
• apertura al confronto e al dialogo fra diverse scelte religiose;<br />
I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di insegnamento/apprendimento sono stati:<br />
x lezione frontale<br />
x didattica laboratoriale<br />
x didattica interattiva<br />
x lavori di ricerca e approfondimento<br />
x uso delle ITC<br />
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />
STORIA: Progetti di Istituto:<br />
Il quotidiano in <strong>classe</strong><br />
Progetto della Memoria (Beretta, Bigiotti,Drago Forte, Iafolla, Sportelli)<br />
SCIENZE: Progetti di Istituto<br />
Scienze al <strong>Giulio</strong><br />
Lezioni sotto il Planetario<br />
Orientamento in rete ( Bigiotti, Forte, Loli, Marano)<br />
FISICA: Progetti di Istituto<br />
PLS ( Drago,Iafolla, Marano,Sportelli)<br />
Masterclass di Ottica (Beretta, Marano)<br />
EDUCAZIONE FISICA: Progetto di Istituto<br />
Campionati studenteschi<br />
VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />
In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia di<br />
indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />
.<br />
La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione che si<br />
allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie sono state<br />
approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni della terza prova d’esame, con una durata di 3<br />
ore:<br />
I simulazione 23 gennaio 2013 Materie: Greco, Scienze, Inglese, Storia, Fisica<br />
II simulazione 15 aprile 2013 Materie: Greco, Scienze, Inglese, Filosofia, Matematica<br />
Tipologia B per entrambe le simulazioni.<br />
Dai riscontri in sede di valutazione collegiale, emerge che la tipologia B (2 “quesiti a risposta singola”<br />
articolata entro le 8-10 righe) è più congeniale al conseguimento di risultati positivi.<br />
Le materie in cui gli studenti hanno conseguito migliori esiti di profitto risultano essere: Storia, Filosofia,<br />
Scienze, Matematica, Inglese.<br />
I testi delle prove sono allegati al presente <strong>Documento</strong> <strong>finale</strong> (allegato n.5).<br />
Si allegano al presente documento:<br />
ALLEGATI<br />
Allegato n.1 Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />
Allegati n.2 - 3 - 4 Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza prova<br />
Allegati n. 5 Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />
Allegati n. 6 - 17 Programmi disciplinari<br />
Roma 15 maggio 2013
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
ITALIANO prof. NEBBIA Luisa Maria ……………………………<br />
LATINO prof. NEBBIA Luisa Maria ……………………………<br />
GRECO prof. TESTINI Gabriella ……………………………<br />
INGLESE prof. RESCIGNO Fiorella ……………………………<br />
STORIA E FILOSOFIA prof. IENI Carmela ……………………………<br />
MATEMATICA E FISICA prof. MARAZZI Giovanna ……………………………<br />
SCIENZE prof. LAURA Elena ……………………………<br />
ARTE prof. CAPALBO Caterina ……………………………<br />
ED. FISICA prof. SPINELLI Saverio ……………………………<br />
IRC prof. SARRIA Enrique ……………………………
! ALLEGATO N.1<br />
VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />
strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />
pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />
culturale.<br />
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />
Voto<br />
1 – 3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 – 10<br />
Indicatori di<br />
conoscenze<br />
Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />
argomenti disciplinari e disarticolate<br />
nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />
Conosce in modo vago e confuso gli<br />
argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />
difficoltà i nuclei essenziali e le<br />
interrelazioni.<br />
E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />
conoscenze, delle quali coglie<br />
parzialmente implicazioni e rimandi<br />
essenziali.<br />
Conosce gli ambiti delle diverse<br />
discipline e ne coglie in linea globale<br />
contenuti e sviluppi.<br />
Conosce gli argomenti e li colloca<br />
correttamente nei diversi ambiti<br />
disciplinari.<br />
Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />
grazie ad approfondimenti personali negli<br />
aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />
Mostra piena padronanza degli ambiti<br />
disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />
di informazioni.<br />
Indicatori di<br />
abilità<br />
Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />
assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />
argomentazione.<br />
Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />
nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />
un linguaggio disordinato e scorretto.<br />
Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />
incompleto, con non certa padronanza delle<br />
soluzioni espressive.<br />
Comprende le consegne e risponde in modo<br />
semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />
linguaggi disciplinari.<br />
Comprende e contestualizza le consegne e le<br />
sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />
complessivamente coerenti.<br />
Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />
operando collegamenti con<br />
appropriata scelta di argomentazioni.<br />
E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />
dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />
efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />
collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />
Indicatori di<br />
competenze<br />
Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />
non è in grado di applicare regole o elementari<br />
operazioni risolutive.<br />
Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />
semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />
procedure di risoluzione.<br />
Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />
limitato di contesti. Applica, non sempre<br />
adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />
Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />
scelta e nella applicazione delle strategie di<br />
risoluzione.<br />
Sa impostare problemi di media complessità e<br />
formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />
di risoluzione.<br />
E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />
di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />
operare scelte coerenti ed efficaci.<br />
Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />
ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />
anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />
Livello di certificazione delle competenze di<br />
base<br />
(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />
Non ha raggiunto il livello base delle<br />
competenze.<br />
Livello base: lo studente svolge compiti<br />
semplici in situazioni note, mostrando di<br />
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />
saper applicare regole e procedure<br />
fondamentali.<br />
Livello intermedio: lo studente svolge<br />
compiti e risolve problemi complessi in<br />
situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />
le abilità acquisite.<br />
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />
problemi complessi in situazioni anche non<br />
note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />
sostenere le proprie opinioni e assumere<br />
autonomamente decisioni consapevoli
!<br />
Voto in<br />
decimi<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Correttezza ortografica,<br />
morfosintattica e proprietà<br />
lessicale<br />
Conoscenza<br />
degli argomenti<br />
proposti<br />
Aderenza alla traccia e<br />
rispetto dei vincoli<br />
comunicativi<br />
Analisi, sintesi, coerenza e<br />
rielaborazione dei contenuti<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
ALLEGATO N.2<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo
!<br />
Voto in<br />
decimi<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Comprensione del testo<br />
Conoscenza della morfosintassi<br />
Qualità linguistica della traduzione<br />
Punteggio totale<br />
ALLEGATO N.3<br />
1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
I DOCENTI<br />
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />
STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
!<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI<br />
ALLEGATO N.4
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />
STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto in<br />
quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Descrittori<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
Quesiti<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
!<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
Simulazione del 23gennaio 2013<br />
TIPOLOGIA B<br />
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
<strong>III</strong> Prova<br />
Discipline coinvolte: GRECO, STORIA , FISICA, SCIENZE, INGLESE<br />
GRECO<br />
1. Quali possono essere considerate le “fonti letterarie” del teatro menandreo.<br />
2. Riassumi, con precisi riferimenti testuali, i punti essenziali del proemio degli !"#"$<br />
STORIA<br />
ALLEGATO N.5<br />
1. I Patti lateranensi del 1929 furono un importante risultato ottenuto da Mussolini che poté così<br />
presentarsi come colui che aveva posto fine ad una grave lacerazione che aveva turbato la vita<br />
italiana per decenni. Di che lacerazione si tratta? Che cosa furono i patti lateranensi? Che cosa è e<br />
che cosa contiene il concordato compreso nei Patti?<br />
2. Su quali strati sociali fece presa il progetto politico di Hitler e perché?<br />
FISICA<br />
1. Esprimi cosa rappresenta la resistività in un metallo, indica la sua unità di misura nel SI e<br />
giustifica il fatto che essa aumenta all’aumentare della temperatura<br />
2. Enuncia e dimostra il teorema di Gauss per il campo elettrico e spiegane il significato fisico.<br />
GEOGRAFIA ASTRONOMICA<br />
1. Spiega quali sono le condizioni di illuminazione durante gli equinozi<br />
2. Descrivi le fasi lunari<br />
INGLESE<br />
1. What does Jekyll feel and think when he becomes Hyde for the first time?<br />
2. How did Wide show his nonconformism towards the Victorian values?
Simulazione del 15 aprile 2013<br />
TIPOLOGIA B<br />
<strong>III</strong> Prova<br />
Discipline coinvolte: GRECO, FILOSOFIA, MATEMATICA, SCIENZE, INGLESE<br />
GRECO<br />
1. Indica caratteri e contenuti degli Idilli di Teocrito, ed evidenzia eventuali differenze con la<br />
poesia bucolica virgiliana.<br />
2. Spiega l’origine dell’epigramma e definiscine i caratteri con particolare riferimento alla<br />
produzione di Leonida di Taranto<br />
FILOSOFIA<br />
1. Il Positivismo nasce in un periodo in cui l’uomo vuole certezze. Auguste Comte e Charles<br />
Darwin sono gli esponenti dei due diversi indirizzi. Parlane brevemente.<br />
2. Lo Spiritualismo rappresenta la reazione al Positivismo. Indica i motivi e spiega perché<br />
Henry Bergson distingue tra il tempo della scienza e il tempo della vita.<br />
1. Si verifichi la seguente identità<br />
!<br />
!!!!!!!!! !"#$!!"# ! ! !<br />
! ! !<br />
2. Risolvere la seguente equazione<br />
!!!<br />
!!!!!!!!!!!!!!"#$ ! !!!!"#$ ! ! !!<br />
MATEMATICA<br />
! !!"# ! ! ! ! !"#$!!"# ! ! !<br />
! !
SCIENZE<br />
1. Spiega le caratteristiche della litosfera e dell’astenosfera.<br />
2. La distribuzione dei vulcani sulla Terra è localizzata lungo i margini delle zolle. Spiegane i<br />
motivi.<br />
INGLESE<br />
1. Why and how modernist writers adopted the stream of consciousness?<br />
2. How are the lives of Mrs. Dalloway and Septimus interwoven?
ALLEGATI<br />
PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />
ALLEGATO N. 6. Italiano<br />
ALLEGATO N. 7. Latino<br />
ALLEGATO N. 8. Greco<br />
ALLEGATO N. 9. Inglese<br />
ALLEGATO N. 10. Storia<br />
ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />
ALLEGATO N. 12. Matematica<br />
ALLEGATO N. 13. Fisica<br />
ALLEGATO N. 14. Scienze<br />
ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />
ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />
ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica
PROGRAMMA DI ITALIANO<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa NEBBIA LUISA MARIA<br />
ALLEGATO N.6<br />
L’Età del Romanticismo.<br />
A. Manzoni<br />
La vita, la poetica; prima della conversione: le opere classicistiche; dopo la conversione: la<br />
concezione della storia e della letteratura,gli Inni Sacri; le tragedie; il romanzo storico; Il Fermo e<br />
Lucia e I Promessi Sposi.<br />
Testi:<br />
Lettre à Monsieur Chauvet<br />
Storia ed invenzione poetica<br />
Lettera sul Romanticismo<br />
L’utile, il vero, l’interessante<br />
Inni sacri<br />
La Pentecoste<br />
Odi<br />
Il Cinque Maggio<br />
Adelchi<br />
Il dissidio romantico di Adelchi (atto <strong>III</strong>, scena I)<br />
Un volgo disperso ( atto <strong>III</strong>, coro ) ( in fotocopia)<br />
La morte di Ermengarda (atto IV, coro)<br />
La morte di Adelchi ( atto V, scene V<strong>III</strong>-X)<br />
I promessi sposi<br />
Lucia e Don Rodrigo: Un sopruso feudale/ La vergine e il seduttore<br />
La “Signora”: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude/ La sventurata rispose<br />
Il conte del Sagrato e l’Innominato: Il conte del Sagrato: un documento di costume storico/L’In-<br />
Nominato: dalla storia al mito.<br />
G, Leopardi<br />
La vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo Le Operette<br />
morali. I Canti. Lo Zibaldone di pensieri.<br />
Testi:<br />
Zibaldone<br />
La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. L’antico. Indefinito e<br />
infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. Teoria del<br />
suono. Indefinito e poesia. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza.<br />
Operette morali<br />
Dialogo della Natura e di un Islandese<br />
Dialogo di Tristano e di un amico
Canti<br />
Ultimo canto di Saffo<br />
L’infinito<br />
La sera del dì di festa<br />
A Silvia<br />
Le ricordanze<br />
La quiete dopo la tempesta<br />
Il sabato del villaggio<br />
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />
Il passero solitario<br />
A se stesso<br />
La ginestra ( vv. 1-51; 87-157 )<br />
L’ ETÀ POSTUNITARIA: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati<br />
I. U. Tarchetti<br />
Fosca: L’attrazione della morte.<br />
C. Boito<br />
Senso: Una turpe vendetta<br />
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano<br />
Il Naturalismo francese<br />
G. Flaubert: I sogni romantici di Emma<br />
E. e J. de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo<br />
E. Zola: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale<br />
Il Verismo italiano<br />
L. Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità<br />
G. Verga<br />
La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del verga verista,<br />
l’ideologia verghiana; il verismo di verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi,il ciclo dei Vinti;<br />
I Malavoglia; Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana; Il Mastro don Gesualdo;<br />
l’ultimo Verga<br />
Testi:<br />
Vita dei campi<br />
L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”; L’”eclisse” dell’autore e la<br />
regressione nel mondo rappresentato<br />
Fantasticheria<br />
Rosso Malpelo<br />
La lupa<br />
Novelle rusticane<br />
La roba<br />
Libertà (in fotocopia)<br />
Mastro don Gesualdo<br />
La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV)<br />
I Malavoglia ( lettura integrale )
IL DECADENTISMO: CULTURA, IDEE.<br />
La poesia simbolista.<br />
C. Baudelaire<br />
Testi:<br />
I fiori del male:<br />
L’albatro<br />
Corrispondenze<br />
“Spleen”<br />
Il romanzo decadente:<br />
J.K Huysmans: A’ rebours: La realtà sostitutiva; La vegetazione mostruosa e malata.<br />
O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray:I principi dell’estetismo; Un maestro di edonismo.<br />
G. D’Annunzio<br />
La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi;il periodo “notturno”;<br />
Testi:<br />
Il piacere (lettura integrale)<br />
Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo<br />
Alcyone<br />
La sera fiesolana<br />
La pioggia nel pineto<br />
Nella belletta<br />
I pastori<br />
Notturno:<br />
La prosa “notturna”<br />
G. Pascoli<br />
La vita, la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le<br />
soluzioni formali; le raccolte poetiche; i Poemetti<br />
Testi:<br />
Il fanciullino<br />
Una poetica decadente<br />
Myricae<br />
Arano<br />
X Agosto<br />
L’assiuolo<br />
Novembre<br />
Lavandare (in fotocopia)<br />
Temporale; Il lampo; Il tuono (in fotocopia)<br />
Poemetti<br />
La digitale purpurea<br />
Canti di Castelvecchio<br />
Il gelsomino notturno
La mia sera (in fotocopia)<br />
IL PRIMO NOVECENTO: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />
La stagione delle avanguardie<br />
I futuristi<br />
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista<br />
La lirica del primo Novecento in Italia<br />
I crepuscolari<br />
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta<br />
G. Gozzano: Totò Merùmeni<br />
Italo Svevo<br />
La vita; la cultura di Svevo, il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.<br />
Testi:<br />
Una vita:<br />
Le ali del gabbiano<br />
Senilità:<br />
Il ritratto dell’inetto<br />
La trasfigurazione di Angiolina<br />
La coscienza di Zen:<br />
La morte del padre<br />
La salute “malata” di Augusta<br />
Psico-analisi<br />
La profezia di un’apocalisse cosmica<br />
L. Pirandello<br />
La vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali e il periodo<br />
“grottesco”; il “teatro nel teatro”.<br />
Testi:<br />
L’Umorismo<br />
Un’arte che scompone il reale<br />
Novelle per un anno<br />
La trappola<br />
Il treno ha fischiato<br />
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)<br />
Uno, nessuno e centomila : Nessun nome<br />
Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio<br />
TRA LE DUE GUERRE: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />
La società italiana fra arretratezza e modernità<br />
I. Silone: Fontamara (lettura integrale)<br />
L’assurdo, l’irreale, il fantastico<br />
D. Buzzati: Il deserto dei Tartari (lettura integrale)
L’Ermetismo<br />
G. Ungaretti<br />
La vita; L’allegria; Il Sentimento del tempo; Il dolore.<br />
Testi:<br />
L’Allegria<br />
Il porto sepolto<br />
Veglia<br />
San Martino del Carso<br />
Mattina<br />
Soldati<br />
Il dolore<br />
Tutto ho perduto<br />
E. Montale<br />
La vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni;il “terzo” Montale: La bufera e altro;<br />
l’ultimo Montale<br />
Testi:<br />
Ossi di seppia<br />
Non chiederci la parola<br />
Meriggiare pallido e assorto<br />
Spesso il male di vivere ho incontrato<br />
Forse un mattino andando in un’aria di vetro<br />
Le occasioni<br />
Non recidere, forbice, quel volto<br />
La casa dei doganieri<br />
L’età contemporanea<br />
I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)<br />
G. Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo (lettura integrale)<br />
Dante Alighieri<br />
Paradiso: canti I, <strong>III</strong>, VI, V<strong>III</strong>, XI, XV, XVII, XXX<strong>III</strong><br />
Testi:<br />
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: “la letteratura” volumi 4,5,6. Ed. Paravia
Storia della letteratura e autori<br />
Il I secolo<br />
Contesto: Da Tiberio ai Flavi<br />
Autore: Seneca.<br />
Testi:<br />
PROGRAMMA DI LATINO<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa NEBBIA LUISA MARIA<br />
ALLEGATO N.7<br />
T.1: Il tempo, il bene più prezioso, De brevitate vitae,8 (in italiano)<br />
T.2: Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium,1<br />
T.3: Gli aspetti positivi della vecchiaia, Epistulae ad Lucilium, 12<br />
T.4: Viviamo alla giornata! Epistulae ad Lucilium, 101,1-9<br />
T.5: La morte non è un male, Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3<br />
T.6: Il suicidio, via per raggiungere la libertà, Epistolae ad Lucilium, 70,14-19<br />
T.7: Male vivet quisquis nesciet bene mori, De tranquillitate animi, 11<br />
T.8: La vera felicità consiste nella virtù, De vita beata,16<br />
T.10: L’inviolabilità del perfetto saggio, De con stantia sapientis, 5,3-5 (in italiano)<br />
T.11: Un dio abita dentro ciascuno di noi, Epistolae ad Lucilium, 41,1-5<br />
T.12: L’immoralità della folla e la solitudine del saggio, Epistulae ad Lucilium,7 (in italiano)<br />
T.15: L’otium filosofico come forma superiore di negotium, De otio, 6,1-5 (in italiano)<br />
T.16: Anche gli schiavi sono esseri umani, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (in italiano)<br />
T 19: Un esordio all’insegna della parodia, Apokolokyntosis, 1-4,1 (in italiano)<br />
T.20: Claudio all’inferno, Apokolokyntosis,14-15 (in italiano)<br />
Autore: Lucano<br />
Testi:<br />
T.1: Il tema del canto: la guerra fratricida, Pharsalia: 1, 1-32 (in italiano)<br />
T.2: Mito e magia: l’incantesimo di Eritto, Pharsalia, 6, 654,718 (in italiano)<br />
T.3: La profezia del soldato: la rovina di Roma, Pharsalia, 6, 776-820 (in italiano)<br />
T.4: L’”eroe nero”: <strong>Cesare</strong> passa il Rubicone, Pharsalia, 1,183-227 (in italiano)<br />
T.5: Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo, Pharsalia, 8,610-635 (in italiano)<br />
T.6: Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio, Pharsalia, 2,380-391 (in italiano)<br />
Autore: Petronio<br />
Testi:<br />
T.3: L’ira di Encolpio, Satyricon,82 (in italiano)<br />
T.4: Una novella: “La matrona di Efeso”, Satyricon, 111-112 (in italiano)<br />
T.7: L’ingresso di Trimalchione, Satyricon, 31,3-33,8 (in italiano)<br />
T.8: Chiacchiere tra convitati, satirico, 44,1-46,8 (in italiano)<br />
T.9: L’ascesa di un parvevu, Satyricon, 75,10-77,6<br />
Genere: La satira<br />
Autore: Persio<br />
Testi:<br />
T.1: Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze, Choliambi,1-14<br />
T.2: Persio e le mode poetiche del tempo, Satire,1,1-78; 114-134 (in italiano)
T.3: Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei, Satire,4 (in italiano)<br />
Autore: Giovenale:<br />
Testi:<br />
T.4: E’ difficile non scrivere satire, Satire,1,1-30 (in italiano)<br />
T.6: Uomini che si comportano da donne, Satire, 2,65-109 (in italiano)<br />
T.7: Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio, Satire, 6,136-160<br />
Genere: Plinio il Vecchio e il sapere specialistico<br />
Autore: Marziale:<br />
Testi:<br />
T.1: Bilbilis contro Roma, Epigrammi, 10,96 (in italiano)<br />
T.2: I valori di una vita serena, Epigrammi, 10,47<br />
T.4: Poesia lasciva, vita onesta, Epigrammi, 1,4<br />
T.5: Medico o becchino, fa lo stesso, Epigrammi,1,47<br />
T.6: Beni privati, moglie pubblica, Epigrammi,3,26<br />
T.7: Una sdentata che tossisce, Epigrammi,1,19<br />
T.9: Libri tascabili, Epigrammi, 1,2<br />
T.11: Il gradimento del pubblico, Epigrammi,4,49 (in italiano)<br />
T.14: Epitafio per la piccola Erotion, Epigrammi,5,34<br />
T.15: Un’incantevole sala da pranzo, Epigrammi,2,59<br />
Autore: Quintiliano:<br />
Testi:<br />
T.3: Il maestro ideale, Institutio oratoria, 2,2,4-13 (in italiano)<br />
T.5: La concentrazione, Institutio oratoria, 10,3,22-30 (in italiano)<br />
T.6: L’oratore deve essere onesto, Institutio oratoria, 12,1-13 (in italiano)<br />
Il II secolo<br />
Contesto: L’età degli imperatori per adozione<br />
Genere: Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico<br />
Testi:<br />
Epistulae: 16,96 e 97 (fotocopia in italiano)<br />
!!!!!!!!!<br />
Autore:Tacito<br />
Testi:<br />
T.1: Origine e carriera di Agricola, Agricola, 4-6 (in italiano)<br />
T.3: L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola, Agricola, 39-40<br />
T.4: L’elogio di Agricola, Agricola, 44-46 (in italiano)<br />
T.5: La Britannia, Agricola, 10<br />
T.6: I Britanni, Agricola, 11,12,4 (in italiano)<br />
T.7: I confini della Germania, Germania,1<br />
T.8: I Germani: le origini e l’aspetto fisico, Germania,2;4<br />
T.9: Il valore militare dei Germani, Germania, 6;14 (in italiano)<br />
T.11: Le cerimonie funebri, Germania, 27<br />
T.12: Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo, Germania, 23-24<br />
T.13: L’onestà delle donne germaniche, Germania, 18,1-20,2<br />
T.19: Il ritratto “indiretto”: Tiberio, Annales, 1,6-7 (in italiano)<br />
T.20: Il ritratto “paradossale”, Licinio Muciano, Historiae, 1,10 (in italiano)<br />
T.21: La morte di Messalina, Annales, 11,37-38 (in italiano)<br />
T.22: Nerone fa uccidere Agrippina, Annales, 14,1-10 (in italiano)
T.26: L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto Annales, 15,62-64; 16,34-35 (in<br />
italiano)<br />
T.27: Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio, Annales,16,18-19 (foto-<br />
copia in italiano)<br />
Genere: Svetonio<br />
Autore: Apuleio<br />
Testi:<br />
T.2: La difesa di Apuleio, Apològia, 90-91 (in italiano)<br />
T.7: Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside, Metamorfosi, 11,29-30 (in italiano)<br />
Amore e Psiche, Metamorfosi, IV,28-VI,24 (in italiano)<br />
!!!!!!!!!!!!!!!<br />
Testo: Conte, Pianezzola: Lezioni di Letteratura latina, corso integrato; vol.3, L’età imperiale. Ed. Le<br />
Monnier Scuola<br />
Autore<br />
Lucrezio, De Rerum Natura<br />
Testi:<br />
L’inno a Venere, I,1-43<br />
Il trionfo di Epicuro, I,62-79<br />
Le dolcezze della vita, II, 1-61<br />
Il lume di Epicuro, <strong>III</strong>, 1-30<br />
Un empio rito, I, 80-101<br />
Madre o matrigna?, V, 195-234<br />
L’uomo primitivo, V, 925-1010<br />
Autore<br />
Ovidio, Metamorfosi<br />
Testi:<br />
Il re Cigno è mutato in cigno, II,367-380<br />
Febo crucciato, II,381-400<br />
Eco e Narciso, <strong>III</strong>, 370-510<br />
Orfeo ed Euridice, X,1-77<br />
Metrica: Lettura dell’esametro
LETTERATURA<br />
PROGRAMMA DI GRECO<br />
a.s. 2012/2013<br />
Prof.ssa TESTINI GABRIELLA<br />
La prima stagione dell’oratoria<br />
Retorica ed oratoria<br />
Lisia<br />
La seconda stagione dell’oratoria<br />
Isocrate<br />
Contro i sofisti I venditori di parole<br />
Panegirico L’intera Grecia è debitrice di Atene<br />
Aeropagitico La %$#&"'s %'("#)"$<br />
Filippo: Difesa di Filippo dalle Calunnie degli avversari<br />
Demostene<br />
Prima Filippica Contro l’inerzia degli Ateniesi<br />
Sulla corona Attacco frontale ad Eschine<br />
L’ellenismo<br />
Caratteri e luoghi della produzione culturale<br />
L’età alessandrina<br />
La commedia nuova: Menandro<br />
Il Misantropo: ravvedimento di Anemone e lieto fine vv. 640-772<br />
La donna rapata: equivoco ed intreccio vv. 1-51<br />
L’arbitrato: un padre per un trovatello vv. 288-380<br />
Lo scudo: cronaca di una morte sperata vv. 1-148<br />
La poesia elegiaca: Callimaco<br />
Gli !"#"$<br />
Contro i Telchini fr.1<br />
La storia di Acontio e Cidippe fr. 75<br />
La chioma di Berenice fr. 110<br />
I Giambi<br />
La contesa fra l’alloro e l’ulivo<br />
L’Ecale<br />
Il discorso della cornacchia<br />
Gli Inni<br />
L’inno ad Artemide vv. 1-86<br />
Per i lavacri di Pallade vv. 70-142<br />
Gli epigrammi<br />
La poesia epico-didascalica: Apollonio Rodio<br />
Le Argonautiche<br />
Il proemio I, vv. 1-22<br />
Il rapimento di Ila I, vv. 1207-1272<br />
Il passaggio delle Simplegadi II, vv. 549-637<br />
Il sogno di Medea <strong>III</strong>, vv.616-664<br />
L’incontro di Medea con Giasone <strong>III</strong>, 1063-1132<br />
L’uccisione di Apsirto IV, vv.445-481<br />
La poesia bucolico-mimetica: Teocrito<br />
Le Talisie Idillio VII<br />
Polifemo e Galatea Idillio VI<br />
Le Siracusane Idillio XV<br />
Eracle bambino Idillio XXIV<br />
Simo di Magnesia; Il lamento dell’esclusa<br />
La diffusione dell’epigramma<br />
L’epigramma dorico-peloponnesiaco<br />
Anite, Nosside e Leonida<br />
ALLEGATO N. 8
Ionico-alessandrino<br />
Asclepiade<br />
L’epigramma fenicio<br />
Meleagro e le antologie<br />
La letteratura scientifica e le scuole filologiche<br />
La storiografia: Polibio<br />
Proemio I, 1-4<br />
La costituzione degli stati VI, 2-5, 7-10<br />
La costituzione romana VI, 11-14, 56<br />
L’età imperiale<br />
La storiografia: Plutarco<br />
Dalle vite parallele:<br />
Le Idi di marzo Vita di <strong>Cesare</strong><br />
Dai moralia, Discorso sull’amore<br />
La seconda sofistica e Luciano<br />
I dialoghi<br />
Menippeo ed Ermete<br />
La storia vera<br />
Omero e la questione omerica<br />
Il romanzo greco<br />
Caritone: Le avventure di Cherea e Calliroe<br />
Achille Tazio: Le avventure di Leucippe e Clitofonte<br />
Longo Sofista: Vicende pastorali di Dafni e Cloe<br />
TESTI<br />
ANTIFONTE: Per veneficio contro la matrigna (1-31)<br />
SOFOCLE Trachinie:<br />
Dalla Biblioteca di Apollodoro II, VII, 5 (148-159) Argumentum<br />
1-48 (prologo, Deianira)<br />
141-177 (I episodio, Deianira)<br />
346-382 (I episodio, Deianira-Messaggero)<br />
555-587 (II episodio, Deianira)<br />
735-771 (<strong>III</strong> episodio, Illo)<br />
899-946 (IV episodio, Nutrice)<br />
1064- 1106 (esodo, Eracle)<br />
1188-1251 (esodo, Eracle-Illo)<br />
Lettura in metrica del trimetro giambico
PROGRAMMA DI INGLESE<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa RESCIGNO FIORELLA<br />
ALLEGATO N.9<br />
LITERARY PERIOD – Testo in adozione: Lit & Lab ed. Zanichelli<br />
The Romantic Age (1760- 1830)<br />
1st Generation Poets<br />
2 nd Generation Poets<br />
W. Wordsworth:” Emotions recollected in Tranquillity”<br />
S.T. Coleridge<br />
Keats (life)<br />
Daffodils – My Heart Leaps Up<br />
The Rime of the Ancient Mariner<br />
The Victorian Age (1839-1901)<br />
C. Dickens<br />
Oliver Twist<br />
Hard Times<br />
R.L. Stevenson<br />
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde<br />
Aestheticism<br />
O. Wilde<br />
The Picture of Dorian Gray<br />
The Ballad of the Reading Gaol (1 st section)<br />
The Importance of Being Earnest<br />
Modernism (1901-1950)<br />
J. Joyce<br />
V. Woolf<br />
Dubliners<br />
Mrs. Dalloway<br />
Ulysses<br />
A Passage to India (plot)<br />
The Two World-War Period<br />
G. Orwell<br />
Animal Farm<br />
1984<br />
Dai testi sono stati studiati i seguenti brani:<br />
The Rime of the Ancient Mariner ! The Killing of the Albatross<br />
Hard Times ! The Murder of Innocents – A Town of Red Bricks<br />
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ! Jekyll’s Experiment<br />
The Picture of Dorian Gray ! I Would Give My Soul<br />
Mrs. Dalloway ! She Loves Life, London and This Moment of June<br />
Dubliners ! Eveline<br />
Ulysses ! Molly’s Monologue<br />
Animal Farm ! The Execution<br />
1984 ! Big Brother Is Watching You<br />
I ragazzi hanno assistito alla proiezioni dei seguenti film in lingua originale:<br />
Bright Star<br />
Oliver Twist<br />
The Importance of Being Earnest<br />
Mrs. Dalloway<br />
A Passage to India<br />
La <strong>classe</strong> ha visitato “Shelley + Keats Museum” con guida in Inglese e il Cimitero acattolico di Roma.<br />
I periodi letterari sono stati introdotti partendo dal contesto storico e sociale.
PROGRAMMA DI STORIA<br />
a.s. 2012/2013<br />
Prof.ssa IENI CARMELA<br />
L’età giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia<br />
La Prima guerra mondiale :<br />
- Le cause del conflitto,<br />
- 1914: il fallimento della guerra lampo,<br />
- L’entrata dell’Italia in guerra, 1915-1916:<br />
- La guerra di posizione, dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra.<br />
La Rivoluzione russa.<br />
- La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista.<br />
- La rivoluzione di ottobre.<br />
- Lenin alla guida dello Stato sovietico.<br />
L’ Europa e il mondo dopo il conflitto<br />
- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni<br />
- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa.<br />
L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo.<br />
- La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra.<br />
- La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss.<br />
- Il regime del terrore e i gulag.<br />
- Il consolidamento dello Stato totalitario.<br />
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.<br />
- Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione<br />
- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra.<br />
- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.<br />
- L’ascesa del fascismo<br />
- La costruzione del regime.<br />
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29.<br />
- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista.<br />
- Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali<br />
- La crisi del ‘29<br />
- Roosevelt e il New Deal<br />
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo<br />
- La nascita della repubblica di Weimar<br />
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo<br />
- Il nazismo al potere<br />
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo<br />
Il regime fascista in Italia.<br />
- Il consolidamento del regime<br />
- Il fascismo fra consenso e opposizione<br />
- La politica interna ed economica<br />
- I rapporti tra Chiesa e fascismo<br />
- La politica estere e le leggi razziali.<br />
ALLEGATO N.10
L’Europa verso una nuova guerra<br />
- Il riarmo della Germania naziste e l’alleanza con l’Italia ed il Giappone<br />
- La Spagna e la dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano<br />
- La guerra civile in spagnola<br />
La seconda guerra mondiale<br />
- Il successo della guerra-lampo<br />
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale<br />
- L’inizio della controffensiva alleata<br />
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia<br />
- La vittoria degli Alleati<br />
- La guerra civile e lo sterminio degli Ebrei<br />
Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione della Urss.<br />
- 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti<br />
- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda<br />
- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica.<br />
La decolonizzazione in Medio Oriente.<br />
- I conflitti arabo-israeliani.<br />
- Nascita dello Stato di Israele<br />
- La crisi del petrolio e i nuovi conflitti in Medio Oriente.<br />
L’Italia della prima Repubblica<br />
- La nuova Italia postbellica.<br />
- La ricostruzione economica.<br />
- L’epoca del centro-sinistra e il miracolo economico<br />
- Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali<br />
- Gli anni del terrorismo e della crisi economica<br />
Films visti in relazione agli argomenti del programma:<br />
1- Tempi moderni<br />
2- La grande guerra<br />
3- Amen<br />
4- Roma città aperta<br />
5- Piazza delle Cinque lune<br />
EDUCAZIONE CIVICA<br />
- La Costituzione<br />
- I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.<br />
Autori vari La città della storia, vol. <strong>III</strong>, ed. Scolastiche Bruno Mondadori
PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />
a.s. 2012/2013<br />
Prof.ssa IENI CARMELA<br />
L’Idealismo. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “ cosa in sé”.<br />
L’idealismo romantico tedesco.<br />
ALLEGATO N.11<br />
L’ Idealismo etico : Johann Gottlieb Fichte. La vita e gli scritti.<br />
L’infinità dell’Io.La dottrina morale, la “missione” sociale dell’uomo e del dotto.<br />
La filosofia politica: lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania.<br />
L’ Idealismo estetico: Friedrich Wilhlem Joseph Schelling. L’ Assoluto come indifferenza di spirito e<br />
natura: la teoria dell’arte.<br />
G. W.F. Hegel. La vita. Gli scritti. La tesi di fondo del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito,<br />
l’identità tra ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La<br />
funzione della filosofia.<br />
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. La logica. la filosofia della natura, la filosofia dello spirito. Lo<br />
spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.<br />
La filosofia della storia.<br />
Lo Spirito assoluto: l’arte,la religione, filosofia e storia della filosofia.<br />
Critica e rottura del sistema hegeliano.<br />
Arthur Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere.<br />
Le radici culturali del sistema.<br />
Il velo di Maya. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.<br />
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.<br />
Il pessimismo(dolore, piacere e noia).L’illusione dell’amore. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. Il rifiuto<br />
dell’ottimismo sociale. Il rifiuto dell’ottimismo storico.<br />
Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.<br />
Soren Aabye Kierkergaard: le vicende biografiche e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto<br />
dell’hegelismo e la verità del “singolo” . Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede.<br />
La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali.<br />
Ludwig Feuerbach. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.<br />
La critica alla religione. La critica ad Hegel.<br />
Umanesimo e filantropismo. La teoria degli alimenti.<br />
Karl Marx. Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo.<br />
La critica del “misticismo logico” di Hegel.<br />
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana.<br />
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.<br />
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.<br />
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica<br />
della storia, la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana.<br />
La sintesi del Manifesto, borghesia, proletariato e lotta di <strong>classe</strong>, la critica dei falsi socialismi.<br />
Il Capitale: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo.<br />
La dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.<br />
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.<br />
Auguste Comte: vita e opere.<br />
La legge dei tre stadi. La sociologia.<br />
Il positivismo evoluzionistico: C. Darwin e la teoria dell’evoluzione.<br />
Lo spiritualismo: Caratteri generali<br />
Henry Bergson : vita e scritti, Tempo durata e libertà.
Friedrich Wilhelm Nietzsche e la demistificazione delle illusioni della tradizione.<br />
Vita e opere.<br />
Nazificazione e denazificazione.<br />
Le caratteristiche del filosofare nietzscheano.<br />
La nascita della tragedia.<br />
Il periodo di Zarathustra. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori.<br />
La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento.<br />
Lo smascheramento delle illusioni del passato: l’arte e la storia.<br />
La trasformazione della morale. Le due morali : dei signori e degli schiavi.<br />
Tra svalutazione dei valori e volontà di potenza.<br />
L’annuncio di Zarathustra . Il superuomo e il nichilismo estremo.<br />
La rivoluzione psicoanalitica. Sigmund Freud.<br />
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni,<br />
gli atti mancati e i sintomi nevrotici.<br />
La teoria della sessualità ed il complesso edipico.<br />
La religione e la civiltà<br />
L’esistenzialismo.<br />
Caratteri generali.<br />
Jean Paul Sartre: vita e scritti.<br />
Esistenza e libertà. Dalla “nausea” all’ “impegno”.<br />
Karl Popper, vita e opere; la riabilitazione della filosofia,le dottrine epistemologiche,il rifiuto<br />
dell’induzione.La teoria della democrazia.<br />
Sono stati letti brani contenuti sul testo tratti dalle opere dei diversi filosofi.<br />
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero - ‘la filosofia’- Paravia,<br />
voll. 2B-3A-3B
LE FUNZIONI<br />
PROGRAMMA DI MATEMATICA<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa MARAZZI GIOVANNA<br />
Le funzioni e la loro classificazione<br />
Le potenze con esponente reale e la funzione esponenziale<br />
Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali<br />
Il logaritmo di un numero, l’uso dei logaritmi nei calcoli.<br />
La funzione logaritmica<br />
Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche<br />
GONIOMETRIA<br />
ALLEGATO N.12!<br />
Misura degli angoli<br />
Circonferenza goniometrica<br />
Definizione e grafico delle seguenti funzioni goniometriche : seno, coseno, tangente,<br />
cotangente di un angolo.<br />
Dimostrazione delle relazioni fondamentali della goniometria.<br />
Le funzioni goniometriche di angoli particolari(dimostrazione relativa a quelli di 30 0 ,60 0 ,45 0 )<br />
Relazione relativa agli angoli associati. La riduzione al primo quadrante.<br />
Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bi<strong>sez</strong>ione<br />
Equazioni goniometriche: identità goniometriche, equazioni goniometriche elementari,<br />
equazioni goniometriche in una sola incognita riconducibili ad elementari, equazioni<br />
lineari in senx e cosx, risoluzione grafica di equazioni lineari non omogenee, equazioni di<br />
secondo grado aventi per incognita una funzione goniometrica, equazioni omogenee di<br />
secondo grado in senx e cosx intere e fratte.<br />
TRIGONOMETRIA<br />
Dimostrazione dei teoremi sugli elementi del triangolo rettangolo.<br />
Dimostrazione dei teoremi per la risoluzione di un triangolo qualsiasi: teorema dei seni,<br />
teorema della corda, teorema del coseno o di Carnot.<br />
Risoluzione di semplici problemi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque.<br />
!
ELETTROMAGNETISMO<br />
PROGRAMMA DI FISICA<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa MARAZZI GIOVANNA<br />
CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI<br />
Carica elettrica<br />
Isolanti e conduttori<br />
La legge di Coulomb<br />
Elettrizzazione dei corpi per strofinio, contatto, induzione.<br />
Il campo elettrico<br />
Il campo elettrico di una carica puntiforme<br />
Linee di forza del campo elettrico<br />
Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss<br />
MODELLO ATOMICO<br />
Esperienza di Rutherford<br />
Esperimento di Millikan<br />
Modello di Bohr<br />
POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA<br />
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico<br />
Conservazione dell’energia<br />
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme<br />
Superfici equipotenziali e campo elettrico<br />
La capacità di un conduttore<br />
Condensatori<br />
Condensatori in serie e in parallelo<br />
Energia immagazzinata in un condensatore<br />
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA<br />
Corrente elettrica<br />
Generatori di tensione e circuiti elettrici<br />
La prima legge di Ohm<br />
Resistori in serie e in parallelo<br />
Le leggi di Kirchoff<br />
Energia e potenza nei circuiti elettrici<br />
La seconda legge di Ohm<br />
Dipendenza della resistività dalla temperatura<br />
Circuiti contenenti condensatori<br />
Carica e scarica di un condensatore<br />
Amperometri e voltmetri<br />
MAGNETISMO<br />
Il campo magnetico e le linee del campo<br />
La forza magnetica sulle cariche in movimento<br />
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente<br />
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente<br />
Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère<br />
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide<br />
La forza di Lorentz<br />
Forza elettrica e magnetica<br />
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme<br />
ALLEGATO N.13!
FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO E LEGGE DI FARADAY<br />
Il flusso del campo magnetico<br />
Le proprietà magnetiche dei materiali<br />
La corrente indotta<br />
Legge di Faraday -Neumann<br />
Legge di Lenz<br />
Autoinduzione e induttanza<br />
Tensioni e correnti alternate:<br />
circuiti RC, RL, RLC<br />
TERMOLOGIA<br />
TEMPERATURA E CALORE<br />
Temperatura e scale termometriche<br />
Dilatazione termica<br />
Le trasformazioni di un gas<br />
La legge di Boyle<br />
La prima e la seconda legge di Gay-Lussac<br />
Il gas perfetto<br />
Calore e lavoro meccanico<br />
Capacità termica e calore specifico<br />
Conduzione ,convezione e irraggiamento<br />
LE LEGGI DELLA TERMODINAMICA<br />
Il principio zero della termodinamica<br />
Trasformazioni termodinamiche<br />
Primo principio della termodinamica<br />
Calori specifici di un gas ideale: a pressione costante, a volume costante.<br />
Le trasformazioni adiabatiche<br />
Il secondo principio della termodinamica<br />
Macchine termiche<br />
Trasformazioni reversibili e irreversibili<br />
Il teorema di Carnot<br />
Il ciclo di Carnot<br />
Il terzo principio della termodinamica
PROGRAMMA DI SCIENZE<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa LAURA ELENA<br />
ALLEGATO N.14<br />
ASTRONOMIA<br />
L’ambiente celeste<br />
Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta. Stelle doppie<br />
e sistemi di stelle. Colori, temperatura e spettri stellari. Stelle in fuga ed in avvicinamento. La fornace<br />
nucleare del Sole e delle altre stelle. Il diagramma H.R. Dalle nebulose alle Giganti rosse. Masse diverse<br />
destini diversi.. L’origine degli elementi. La nostra Galassia. Galassie e famiglie di galassie.<br />
Il Sistema Solare<br />
All’interno del Sole. La superficie del Sole. Oltre la fotosfera. L’attività solare. Il moto dei pianeti attorno al<br />
Sole. Famiglie di pianeti. Un pianeta di tipo terrestre e un pianeta di tipo gioviano a scelta del candidato. Gli<br />
asteroidi. Meteore e meteoriti .Le Comete. Dalla nebulosa originaria ai planetesimali. Il Sole si accende<br />
L’evoluzione dei pianeti di tipo terrestre. L’evoluzione dei pianeti gioviani..<br />
Il pianeta Terra<br />
La geometria della superficie terrestre. Un modello particolare. Il calcolo di Eratostene. Dalla misura della<br />
Terra alla misura delle grandezze fisiche. Il reticolato geografico. Definizione di latitudine e longitudine. Il<br />
moto di rotazione. Il moto di rivoluzione. Prove e conseguenze del moto di rotazione: il pendolo di Foucault.<br />
L’esperienza di Guglielmini. Il ciclo quotidiano del dì e della notte. Il giorno solare e il giorno sidereo. Il<br />
coordinamento universale dell’orario. Prove e conseguenze della rivoluzione terrestre.<br />
La Luna<br />
Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera. Il moto di rotazione. Il moto di rivoluzione. Il moto di<br />
traslazione. Le fasi lunari. Le eclissi. .<br />
SCIENZE DELLA TERRA.<br />
La crosta terrestre: minerali e rocce.<br />
Elementi, composti e miscele. Stati di aggregazione della materia. La composizione chimica dei minerali. La<br />
struttura cristallina dei minerali. Proprietà fisiche dei minerali. La classificazione dei minerali. Come si<br />
formano i minerali. Dal magma alle rocce magmatiche. Classificazione dei magmi. Classificazione delle<br />
rocce magmatiche. Origine e formazione dei magm Dai sedimenti alle rocce compatte. Le rocce clastiche. .<br />
Le rocce organogene .Le rocce chimiche. Il processo sedimentario. Le rocce metamorfiche. Il metamorfismo<br />
di contatto. Le facies metamorfiche. La classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.<br />
I fenomeni vulcanici.<br />
L’attività vulcanica. I magmi. La forma degli edifici vulcanici. I prodotti dell’attività vulcanica. Correlazione<br />
tra caratteristiche dei magmi e tipi di attività vulcanica. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. Il<br />
vulcanismo effusivo ed esplosivo. La distribuzione geografica dei vulcani.<br />
I fenomeni sismici<br />
La teoria del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Differenti tipi di onde sismiche.. come si registrano le onde<br />
sismiche. Localizzazione di un terremoto. La scala di intensità. I terremoti e l’interno della Terra. La<br />
distribuzione geografica dei terremoti.<br />
La tettonica delle placche : un modello globale.<br />
La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. La temperatura interna della Terra. La<br />
geodinamo. Il paleomagnetismo. Crosta continentale e crosta oceanica. L’isostasia. La deriva dei continenti.<br />
Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi<br />
oceanici. Le placche litosferiche. L’orogenesi . Il ciclo di Wilson.Vulcani ai margini delle placche. Terremoti<br />
ai margini delle placche. Moti convettivi e punti caldi.<br />
Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto. “ Il globo terrestre e la sua evoluzione “ Zanichelli editore
IL NEOCLASSICISMO:<br />
J. J. WINCKELMANN<br />
G. B. PIRANESI<br />
A. CANOVA<br />
JACQUES-LOUIS DAVID<br />
FRANCISCO GOYA<br />
IL ROMANTICISMO (il sublime)<br />
EUGENE DELACROIX<br />
TEODORE GERICAULT<br />
WILLIAM BLAKE<br />
WILLIAM TURNER<br />
J. HEINRICH FUSSLI<br />
GUSTAVE COURBET<br />
JEAN FRANCOIS MILLET<br />
PITTURA STORICA IN ITALIA<br />
FRANCESCO HAYEZ<br />
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO<br />
L’IMPRESSIONISMO<br />
EDUARD MANET<br />
CLAUDE MONET<br />
EDGAR DEGAS<br />
P. AUGUSTE RENOIR<br />
ALFRED SISLEY<br />
PAUL CEZANNE<br />
IL POST-IMPRESSIONISMO<br />
PAUL GAUGUIN<br />
VINCENT VAN GOGH<br />
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof.ssa CAPALBO CATERINA<br />
ALLEGATO N.15
HENRY MATISSE<br />
IL DIVISIONISMO<br />
GEORGE SEURAT<br />
L’ESPRESSIONISMO<br />
EDVARD MUNCH<br />
L’ARCHITETTURA DEL FERRO<br />
HENRY LABROUSTE<br />
GUSTAVE ALEXANDRE EIFFEL<br />
L’ASTRATTISMO<br />
PAUL KLEE<br />
VASILIJ KANDINSKIJ<br />
IL CUBISMO<br />
PABLO PICASSO<br />
GEORGE BRAQUE<br />
IL FUTURISMO<br />
FILIPPO TOMMASO MARINETTI<br />
CARLO CARRA’<br />
UMBERTO BOCCIONI<br />
GIACOMO BALLA<br />
ANTONIO SANT'’ELIA<br />
LA METAFISICA IL SURREALISMO E DADA<br />
AMEDEO MODIGLIANI<br />
GIORGIO DE CHIRICO<br />
ALBERTO SAVINIO<br />
SALVADOR DALI’<br />
ANDRE’ DERAIN<br />
MAX ERNST<br />
MARCEL DUCHAMP<br />
MAN RAY<br />
RENE’ MAGRITTE
LA POP ART<br />
ANDY WARHOL<br />
CLAES OLDEMBURG<br />
PIERO MANZONI<br />
L’INFORMALE<br />
JACKSON POLLOK<br />
ALEXANDER CALDER<br />
EMILIO VEDOVA<br />
GIUSEPPE CAPOGROSSI<br />
ALBERTO BURRI<br />
LUCIO FONTANA<br />
MARK ROTHKO<br />
APPROFONDIMENTI<br />
IL GRAND TOUR, LE ACCADEMIE E LA NASCITA DEI MUSEI<br />
I MARMI DEL PARTENONE A LONDRA: DIBATTITO E POLEMICHE<br />
LE TEORIE SCIENTIFICHE DEL COLORE<br />
MARINETTI: MANIFESTO DEL FUTURISMO<br />
LE DONNE E GLI AMORI DI PABLO<br />
PASSIONI E DELIRIO ARTISTICO IN DALI’<br />
LA GALLERIA D’ARTE MODERNA A ROMA<br />
LIBRO DI TESTO LA STORIA DELL'ARTE di G.C. ARGAN vol. 4-5
PARTE PRATICA<br />
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof. SPINELLI SAVERIO<br />
Potenziamento fisiologico:<br />
-esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria mediante attività di durata in<br />
regime prevalentemente aerobico;<br />
-esercizi per il miglioramento della mobilità articolare eseguiti a corpo libero, alla spalliera e<br />
con la bacchetta; esercizi di stretching;<br />
-esercizi per lo sviluppo della tonicità muscolare svolti a carico naturale e con forme di<br />
sovraccarico, a corpo libero ed ai grandi attrezzi;<br />
-esercizi per la rapidità degli arti inferiori eseguiti alla speed ladder;<br />
Rielaborazione degli schemi motori di base:<br />
-esercizi di coordinazione generale con composizione di movimenti semplici;<br />
-traslocazioni al quadro svedese: orizzontali, oblique ascendenti e discendenti con precedenza<br />
del capo;<br />
-arrampicate alla pertica a passo unito e alternato,<br />
-traslocazioni alla scala orizzontale a passo unito e alternato su montanti e pioli;<br />
-esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico alla trave bassa e alle parallele;<br />
-esercizi per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo agli ostacoli e con la funicella.<br />
Conoscenza e pratica delle attività sportive:<br />
-atletica leggera: salto triplo (tecnica in estensione );<br />
-elementi di ginnastica artistica - alla trave (parte fem.): progressione con entrate, elementi<br />
statici e dinamici, uscite;<br />
alle parallele pari (parte maschile): progressione con entrate, oscillazioni dall’appoggio<br />
brachiale e a braccia ritte, sedute e uscita dietro;<br />
-pallavolo– fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta e schiacciata; fondamentali di<br />
squadra: schema di ricezione a 5 (w), schema di gioco 3-1-2 e coperture difensive.<br />
Sono stati svolti i seguenti argomenti teorici:<br />
-elementi di fisiologia della prestazione (adattamento e allenamento, carico allenante,<br />
supercompensazione);<br />
-primo soccorso: BLS (rianimazione cardio-polmonare/teorico-pratico).<br />
Gli studenti esonerati dalle attività pratiche hanno svolto, in aggiunta agli argomenti teorici<br />
comuni a tutta la <strong>classe</strong>, le seguenti attività:<br />
-conoscenza specifica del regolamento della pallavolo e applicazione pratica nell’arbitraggio di<br />
partite scolastiche;<br />
-muscolatura addominale e dorsale profonda: cenni di anatomia, funzione e proposta alla <strong>classe</strong><br />
di esercizi.<br />
ALLEGATO N.16
Le azioni didattiche hanno avuto i seguenti obiettivi:<br />
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA<br />
a.s. 2012/13<br />
Prof. SARRIA JULIAN ENRIQUE<br />
1. Avvicinare testi magisteriali e teologici, maturando competenze nel linguaggio specifico.<br />
1.1. “Fides et Ratio”<br />
1.2. “Deus Caritas est”<br />
1.3. “Veritatis Splendor”<br />
ALLEGATO N.17<br />
2. Collocare sull’asse storico avvenimenti rilevanti della storia della Chiesa nel XX secolo, con<br />
particolare riferimento il Concilio Ecumenico Vaticano II: “Gaudium et Spes”<br />
3. Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose ivi compreso il fenomeno<br />
dell’ateismo e il movimento agnostico.<br />
"# Riconoscere elementi della rivelazione e della tradizione cristiana e la sua validità ed attualità nelle<br />
scelte concrete di vita.!<br />
4.1. Teologia e linguaggio Paolino.<br />
4.2. Principio di oggettività insito nella sessualità umana.<br />
"#$# Progetto di vita e Matrimonio.!