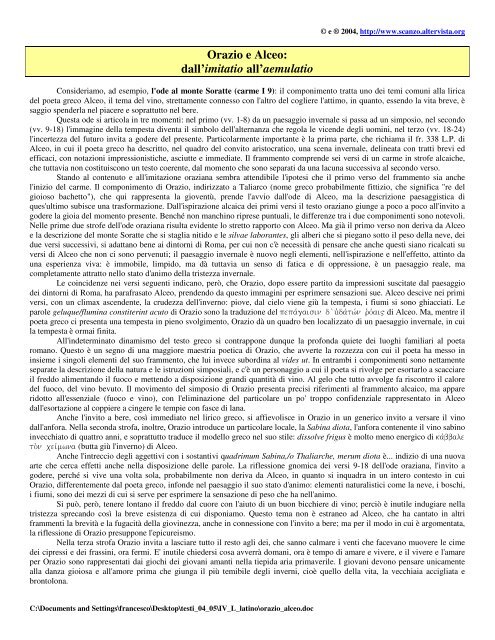Orazio e Alceo: dall'imitatio all'aemulatio - Altervista
Orazio e Alceo: dall'imitatio all'aemulatio - Altervista
Orazio e Alceo: dall'imitatio all'aemulatio - Altervista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Orazio</strong> e <strong>Alceo</strong>:<br />
dall’imitatio all’aemulatio<br />
C:\Documents and Settings\francesco\Desktop\testi_04_05\IV_L_latino\orazio_alceo.doc<br />
© e ® 2004, http://www.scanzo.altervista.org<br />
Consideriamo, ad esempio, l'ode al monte Soratte (carme I 9): il componimento tratta uno dei temi comuni alla lirica<br />
del poeta greco <strong>Alceo</strong>, il tema del vino, strettamente connesso con l'altro del cogliere l'attimo, in quanto, essendo la vita breve, è<br />
saggio spenderla nel piacere e soprattutto nel bere.<br />
Questa ode si articola in tre momenti: nel primo (vv. 1-8) da un paesaggio invernale si passa ad un simposio, nel secondo<br />
(vv. 9-18) l'immagine della tempesta diventa il simbolo dell'alternanza che regola le vicende degli uomini, nel terzo (vv. 18-24)<br />
l'incertezza del futuro invita a godere del presente. Particolarmente importante è la prima parte, che richiama il fr. 338 L.P. di<br />
<strong>Alceo</strong>, in cui il poeta greco ha descritto, nel quadro del convito aristocratico, una scena invernale, delineata con tratti brevi ed<br />
efficaci, con notazioni impressionistiche, asciutte e immediate. Il frammento comprende sei versi di un carme in strofe alcaiche,<br />
che tuttavia non costituiscono un testo coerente, dal momento che sono separati da una lacuna successiva al secondo verso.<br />
Stando al contenuto e all'imitazione oraziana sembra attendibile l'ipotesi che il primo verso del frammento sia anche<br />
l'inizio del carme. Il componimento di <strong>Orazio</strong>, indirizzato a Taliarco (nome greco probabilmente fittizio, che significa "re del<br />
gioioso bachetto"), che qui rappresenta la gioventù, prende l'avvio dall'ode di <strong>Alceo</strong>, ma la descrizione paesaggistica di<br />
ques'ultimo subisce una trasformazione. Dall'ispirazione alcaica dei primi versi il testo oraziano giunge a poco a poco all'invito a<br />
godere la gioia del momento presente. Benché non manchino riprese puntuali, le differenze tra i due componimenti sono notevoli.<br />
Nelle prime due strofe dell'ode oraziana risulta evidente lo stretto rapporto con <strong>Alceo</strong>. Ma già il primo verso non deriva da <strong>Alceo</strong><br />
e la descrizione del monte Soratte che si staglia nitido e le silvae laborantes, gli alberi che si piegano sotto il peso della neve, dei<br />
due versi successivi, si adattano bene ai dintorni di Roma, per cui non c'è necessità di pensare che anche questi siano ricalcati su<br />
versi di <strong>Alceo</strong> che non ci sono pervenuti; il paesaggio invernale è nuovo negli elementi, nell'ispirazione e nell'effetto, attinto da<br />
una esperienza viva: è immobile, limpido, ma dà tuttavia un senso di fatica e di oppressione, è un paesaggio reale, ma<br />
completamente attratto nello stato d'animo della tristezza invernale.<br />
Le coincidenze nei versi seguenti indicano, però, che <strong>Orazio</strong>, dopo essere partito da impressioni suscitate dal paesaggio<br />
dei dintorni di Roma, ha parafrasato <strong>Alceo</strong>, prendendo da questo immagini per esprimere sensazioni sue. <strong>Alceo</strong> descive nei primi<br />
versi, con un climax ascendente, la crudezza dell'inverno: piove, dal cielo viene giù la tempesta, i fiumi si sono ghiacciati. Le<br />
parole geluque/flumina constiterint acuto di <strong>Orazio</strong> sono la traduzione del di <strong>Alceo</strong>. Ma, mentre il<br />
poeta greco ci presenta una tempesta in pieno svolgimento, <strong>Orazio</strong> dà un quadro ben localizzato di un paesaggio invernale, in cui<br />
la tempesta è ormai finita.<br />
All'indeterminato dinamismo del testo greco si contrappone dunque la profonda quiete dei luoghi familiari al poeta<br />
romano. Questo è un segno di una maggiore maestria poetica di <strong>Orazio</strong>, che avverte la rozzezza con cui il poeta ha messo in<br />
insieme i singoli elementi del suo frammento, che lui invece subordina al vides ut. In entrambi i componimenti sono nettamente<br />
separate la descrizione della natura e le istruzioni simposiali, e c'è un personaggio a cui il poeta si rivolge per esortarlo a scacciare<br />
il freddo alimentando il fuoco e mettendo a disposizione grandi quantità di vino. Al gelo che tutto avvolge fa riscontro il calore<br />
del fuoco, del vino bevuto. Il movimento del simposio di <strong>Orazio</strong> presenta precisi riferimenti al frammento alcaico, ma appare<br />
ridotto all'essenziale (fuoco e vino), con l'eliminazione del particolare un po' troppo confidenziale rappresentato in <strong>Alceo</strong><br />
dall'esortazione al coppiere a cingere le tempie con fasce di lana.<br />
Anche l'invito a bere, così immediato nel lirico greco, si affievolisce in <strong>Orazio</strong> in un generico invito a versare il vino<br />
dall'anfora. Nella seconda strofa, inoltre, <strong>Orazio</strong> introduce un particolare locale, la Sabina diota, l'anfora contenente il vino sabino<br />
invecchiato di quattro anni, e soprattutto traduce il modello greco nel suo stile: dissolve frigus è molto meno energico di<br />
(butta giù l'inverno) di <strong>Alceo</strong>.<br />
Anche l'intreccio degli aggettivi con i sostantivi quadrimum Sabina,/o Thaliarche, merum diota è... indizio di una nuova<br />
arte che cerca effetti anche nella disposizione delle parole. La riflessione gnomica dei versi 9-18 dell'ode oraziana, l'invito a<br />
godere, perché si vive una volta sola, probabilmente non deriva da <strong>Alceo</strong>, in quanto si inquadra in un intero contesto in cui<br />
<strong>Orazio</strong>, differentemente dal poeta greco, infonde nel paesaggio il suo stato d'animo: elementi naturalistici come la neve, i boschi,<br />
i fiumi, sono dei mezzi di cui si serve per esprimere la sensazione di peso che ha nell'animo.<br />
Si può, però, tenere lontano il freddo dal cuore con l'aiuto di un buon bicchiere di vino; perciò è inutile indugiare nella<br />
tristezza sprecando così la breve esistenza di cui disponiamo. Questo tema non è estraneo ad <strong>Alceo</strong>, che ha cantato in altri<br />
frammenti la brevità e la fugacità della giovinezza, anche in connessione con l'invito a bere; ma per il modo in cui è argomentata,<br />
la riflessione di <strong>Orazio</strong> presuppone l'epicureismo.<br />
Nella terza strofa <strong>Orazio</strong> invita a lasciare tutto il resto agli dei, che sanno calmare i venti che facevano muovere le cime<br />
dei cipressi e dei frassini, ora fermi. E' inutile chiedersi cosa avverrà domani, ora è tempo di amare e vivere, e il vivere e l'amare<br />
per <strong>Orazio</strong> sono rappresentati dai giochi dei giovani amanti nella tiepida aria primaverile. I giovani devono pensare unicamente<br />
alla danza gioiosa e all'amore prima che giunga il più temibile degli inverni, cioè quello della vita, la vecchiaia accigliata e<br />
brontolona.
© e ® 2004, http://www.scanzo.altervista.org<br />
Non sappiamo se il testo alcaico proseguisse con l'invito a non pensare al futuro e a godere di ogni gioia dell'esistenza, è<br />
certo comunque che la terza parte è quella più lontana da <strong>Alceo</strong>, in quanto presuppone la vita galante della gioventù della Roma<br />
del tempo di <strong>Orazio</strong>, una città con piazze e portici, in cui gli innamorati si danno appuntamento. La vivacità della scena del<br />
convegno segreto ci ricorda il realismo alessandrino. I giochi tra innamorati che chiudono il carme rappresentano le gioie della<br />
vita e sono certo molto lontani dalla sensibilità del lirico greco.<br />
Uno dei problemi estetici più importanti - secondo La Penna - nell'ode di <strong>Orazio</strong> è quello posto dal contrasto tra la<br />
staticità e la malinconia quasi solenne dell'inizio e la dinamicità realistica del resto, tra l'ispirazione alcaica e la conclusione<br />
alessandrina. Tuttavia la tristezza iniziale, quasi oppressiva, si va attenuando già nella terza e quarta strofa attraverso l'accenno al<br />
placarsi della tempesta, ai dulces amores e alle danze giovanili, che fanno sì che non giunga improvvisa la scena finale. Di<br />
alessandrino non c'è solo la corrispondenza tra paesaggio e stato d'animo, ma anche il passare da un argomento all'altro, da un<br />
sentimento all'altro rapidamente. Ma, vista nel suo sviluppo, l'ode non presenta delle stonature, in quanto l'ispirazione alcaica<br />
risulta armonizzata al gusto alessandrino della vita quotidiana.<br />
Analogo è il contenuto dell'ode I 11, "una delle più brevi, ma nello stesso tempo una delle più celebri e significative di<br />
<strong>Orazio</strong>, non solo perché contiene alcuni dei temi tipici della sua filosofia, ma anche perché lo stato d'animo in essa racchiuso è<br />
espresso con tale aderenza ed essenzialità di linguaggio da dare l'impressione a chi legge di ascoltare l'intima voce del cuore<br />
umano, mentre scandisce le sillabe dell'essenza stessa della vita, che è tutta nel fluire eterno e inarrestabile del tempo che fugge".<br />
Questo carme ha la forma dell'invito rivolto dal poeta ad una ragazza dal nome emblematico, Leuconoe, che deriva dal greco e<br />
significa "dai candidi pensieri". Forse si tratta di una interlocutrice immaginaria, o forse <strong>Orazio</strong> si rivolge da uomo saggio e<br />
maturo, attraverso uno pseudonimo significativo, ad una ragazza reale che è troppo ansiosa di crescere e di conoscere il futuro.<br />
<strong>Orazio</strong> suggerisce alla ragazza di non consultare cabale ed astri per sapere il futuro prima del tempo, perché questo potrebbe solo<br />
procurarle degli affanni, mentre è meglio ignorare l'astrologia e vivere saggiamente tutto ciò che offre il presente. Questo<br />
consiglio parte prima come un invito a non nutrire speranze eccessive nel futuro, poi diventa esortazione a cogliere le gioie del<br />
momento, che è diventata proverbiale.<br />
L'ideale di <strong>Orazio</strong> resta sempre la saggezza, sia pure una saggezza sorridente. L'idea dell'incertezza del futuro è<br />
simboleggiata dall'immagine dell'inverno con il vento che fa infrangere le onde del Tirreno sulle rocce. Questa tempesta<br />
suggerisce una immagine della vita che può essere intesa come lo scoglio su cui si abbattono perennemente le ondate del destino.<br />
L'ode di <strong>Orazio</strong> è basata proprio sul consiglio di non chiedersi cosa avverrà domani, perché il tempo "invidioso", già mentre<br />
parliamo, ci sottrae il presente e, siccome noi non sappiamo quanto ci è ancora concesso di vivere, ci conviene non sprecare altro<br />
tempo per pensare al futuro, ma piuttosto affrontare tutto quello che accade, così come accade, senza concepire troppe speranze<br />
per il domani.<br />
In quest'ode di <strong>Orazio</strong> non è evidente, come nelle altre, l'affinità con <strong>Alceo</strong>, tuttavia il tema che fa da sfondo è lo stesso.<br />
Nel frammento 346 L.-P. <strong>Alceo</strong> invita un amico a cominciare il simposio prima che venga il tempo ad esso riservato, cioè la sera.<br />
L'invito, espresso con un imperativo iniziale, è urgente: il giorno è di breve durata, quindi è meglio cominciare a bere subito,<br />
prima che si accendano le lucerne. Bisogna buttare giù le coppe grandi piene fino all'orlo di forte vino, diverso dal solito. Le due<br />
motivazioni che il poeta dà per giustificare questo invito sono legate una al presente, l'avvicinarsi della sera, l'altra, più generale,<br />
ad una verità di principio, il fatto che il vino sia una meravigliosa bevanda donata dal dio Dioniso agli uomini come mezzo per far<br />
dimenticare gli affanni.<br />
In <strong>Alceo</strong> il vino, , ha un'importanza notevole, mentre in <strong>Orazio</strong> lo troviamo menzionato solo in un pacato<br />
invito, vina liques, che non costituisce certo il fulcro del carme. Ma l'accenno alle luci della sera,<br />
(perché aspettiamo le lucerne?), o alla brevità del giorno, (il giorno è un dito), ha una valenza che va al di là del<br />
significato letterale: forse la sera a cui allude <strong>Alceo</strong> è la sera della vita, che prende troppo presto il posto della luce del giorno ed è<br />
annunciatrice della morte.<br />
L'invito di <strong>Alceo</strong> ci fa capire che ci si trova in un simposio, al quale il poeta dà il via con il suo canto conviviale; già la<br />
prima parola del carme greco (beviamo) ci chiarisce l'occasione e l'intenzione del canto, mentre la domanda seguente ha<br />
solo un carattere rafforzativo e non di effettiva persuasione; <strong>Orazio</strong>, invece, si rivolge unicamente ad una ragazza, forse irreale,<br />
anche se il Pascoli immagina suggestivamente il poeta e la fanciulla presso la mensa ancora imbandita nel giorno del compleanno<br />
di uno dei due, occasione in cui era d'uso recitare gli oroscopi dei maghi caldei.<br />
La stessa consapevolezza della precaria condizione umana si avverte in <strong>Alceo</strong>, nel frammento 335, dove, con un incipit<br />
caratteristico della sua poesia parenetica, il poeta esorta Bicchis a ubriacarsi per porre rimedio alle sofferenze:<br />
(non bisogna abbandonare l'animo alle sofferenze, infatti non<br />
guadagneremo nulla tormentandoci).<br />
Ma per <strong>Alceo</strong> il vino non serve soltanto ad alleviare gli affanni: un altro frammento dice che il vino è spia dell'uomo.<br />
Questa massima concisa si ricollega alla funzione essenziale che nell'ambito dell'eteria assumeva necessariamente il valore della<br />
sincerità. Il vino è inteso infine come mezzo per celebrare le vittorie ed è così che <strong>Alceo</strong> festeggia la scomparsa di Mirsilo,<br />
l'odiato tiranno succeduto a Melancro. La sua morte getta il poeta in una gioia incontenibile e selvaggia: !<br />
" (Ora bisogna ubriacarsi e che ognuno beva a viva forza, poiché Mirsile<br />
è morto) egli proclama trionfalmente.<br />
C:\Documents and Settings\francesco\Desktop\testi_04_05\IV_L_latino\orazio_alceo.doc
C:\Documents and Settings\francesco\Desktop\testi_04_05\IV_L_latino\orazio_alceo.doc<br />
© e ® 2004, http://www.scanzo.altervista.org<br />
Qui si intrecciano i due motivi poetici più appariscenti in quel che resta dei carmi di <strong>Alceo</strong>, la passione politica e il<br />
conforto dato dal vino. Essi trovano la loro cornice nel simposio: riunendosi insieme per bere i Greci affrontavano spesso i più<br />
alti temi filosofici e civili. Probabilmente i due versi che ci sono giunti costituivano l'inizio di un canto conviviale, che diventò<br />
molto famoso per l'imitazione di <strong>Orazio</strong> nell'ode I 37. Con questo carme il poeta latino vuole celebrare ufficialmente il vincitore<br />
di Azio, ma soprattutto brindare alla morte di Cleopatra. Ottaviano, infatti, viene nominato solo di sfuggita, Antonio, causa della<br />
guerra civile, viene completamente dimenticato (in tal modo l'esultanza dell'ode non viene ad essere turbata da nessun amaro<br />
ricordo, da nessun rimpianto): unica protagonista è la regina egiziana. <strong>Orazio</strong> apre l'ode ricalcando l'inizio irruento del carme<br />
alcaico, ma il resto, sia per la situazione che per i motivi svolti, è nettamente autonomo, ed evidenzia, specie nei versi successivi,<br />
uno spirito assai diverso dal feroce scoppio di gioia del poeta greco. Già nell'invito a bere possiamo notare le prime differenze.<br />
<strong>Alceo</strong> è più duro nelle immagini, invita i suoi concittadini ad ubriacarsi ed a bere mentre in <strong>Orazio</strong> l'invito si<br />
trasforma, placandosi in un est bibendum più temperato, un semplice bere il vino Cecubo conservato nelle cantine per l'occasione,<br />
accompagnato da una sontuosa cena degna dei sacerdoti Salii, in cui si deve ballare sfrenatamente.<br />
Ma la reazione immediata si perde dopo l'inizio, quando l'ode tende ad una solennità epico lirica evidente nella scelta<br />
delle immagini e nell'ampiezza della sintassi. La regina, sconfitta da Ottaviano, alla notizia del suicidio di Antonio, decide di<br />
seguirlo e si toglie la vita facendosi mordere da un aspide velenoso. La pacata umanità di <strong>Orazio</strong> lo porta a riconoscere la<br />
grandezza della regina sconfitta, rievocandone il suicidio deciso e affrontato con nobile fierezza. Infatti colei che è stata definita<br />
dal poeta fatale monstrum, alla fine del carme viene dipinta quasi come un'eroina e fornisce un esempio di fermezza ed<br />
impassibilità degno di ammirazione, quando con il volto sereno osserva i segni della sua sconfitta, l'umiliazione della sua reggia,<br />
e decide con coraggio di togliersi la vita. <strong>Orazio</strong>, pur esaltando epicamente la gloria di Ottaviano vincitore, ha reso omaggio alla<br />
grandezza del nemico, che ha saputo morire nella libertà. Il poeta greco sembra più coinvolto nella vicenda, la morte del tiranno<br />
lo riguarda da vicino e gli provoca una gioia maggiore di quella che la morte di Cleopatra provoca in <strong>Orazio</strong>. Per <strong>Alceo</strong> si tratta<br />
della vittoria della sua fazione politica; egli si esprime come un uomo di parte che ha sempre lottato e tramato per eliminare<br />
l'avversario ed ora vede con gioia affacciarsi la possibilità che il suo partito conquisti il potere; <strong>Orazio</strong>, invece, non può ignorare<br />
che, eliminata l'ultima oppositrice dell'Urbe, il vincitore resta ormai signore del mondo, senza rivali interni ed esterni. Con la<br />
morte di Cleopatra, dunque, tramonta a Roma anche l'antica libertas, perciò la gioia di <strong>Orazio</strong> non é piena, ma attenuata sia da<br />
un'istintiva simpatia verso il vinto-che oltre tutto è una donna- sia dalla consapevolezza dell'imminente crollo della repubblica.<br />
Probabilmente il poeta latino nell'invitare al brindisi per la sconfitta di Cleopatra, della quale successivamente esalta il suicidio,<br />
vuole fare dell'ironia su Augusto, che si è liberato di una tiranna per poi diventare lui stesso un tiranno.