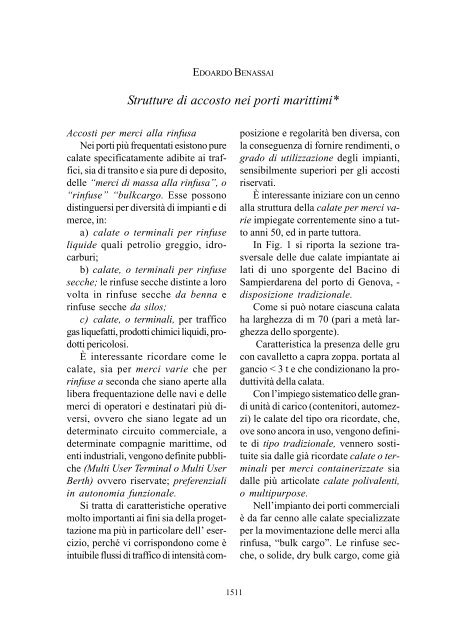You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
EDOARDO BENASSAI<br />
Strutture di accosto nei porti marittimi*<br />
Accosti per merci alla rinfusa<br />
Nei porti più frequentati esistono pure<br />
calate specificatamente adibite ai traffici,<br />
sia di transito e sia pure di deposito,<br />
delle “merci di massa alla rinfusa”, o<br />
“rinfuse” “bulkcargo. Esse possono<br />
distinguersi per diversità di impianti e di<br />
merce, in:<br />
a) calate o terminali per rinfuse<br />
liquide quali petrolio greggio, idrocarburi;<br />
b) calate, o terminali per rinfuse<br />
secche; le rinfuse secche distinte a loro<br />
volta in rinfuse secche da benna e<br />
rinfuse secche da silos;<br />
c) calate, o terminali, per traffico<br />
gas liquefatti, prodotti chimici liquidi, prodotti<br />
pericolosi.<br />
È interessante ricordare come le<br />
calate, sia per merci varie che per<br />
rinfuse a seconda che siano aperte alla<br />
libera frequentazione delle navi e delle<br />
merci di operatori e destinatari più diversi,<br />
ovvero che siano legate ad un<br />
determinato circuito commerciale, a<br />
determinate compagnie marittime, od<br />
enti industriali, vengono definite pubbliche<br />
(Multi User Terminal o Multi User<br />
Berth) ovvero riservate; preferenziali<br />
in autonomia funzionale.<br />
Si tratta di caratteristiche operative<br />
molto importanti ai fini sia della progettazione<br />
ma più in particolare dell’ esercizio,<br />
perché vi corrispondono come è<br />
intuibile flussi di traffico di intensità com-<br />
1511<br />
posizione e regolarità ben diversa, con<br />
la conseguenza di fornire rendimenti, o<br />
grado di utilizzazione degli impianti,<br />
sensibilmente superiori per gli accosti<br />
riservati.<br />
È interessante iniziare con un cenno<br />
alla struttura della calate per merci varie<br />
impiegate correntemente sino a tutto<br />
anni 50, ed in parte tuttora.<br />
In Fig. 1 si riporta la sezione trasversale<br />
delle due calate impiantate ai<br />
lati di uno sporgente del Bacino di<br />
Sampierdarena del porto di Genova, -<br />
disposizione tradizionale.<br />
Come si può notare ciascuna calata<br />
ha larghezza di m 70 (pari a metà larghezza<br />
dello sporgente).<br />
Caratteristica la presenza delle gru<br />
con cavalletto a capra zoppa. portata al<br />
gancio < 3 t e che condizionano la produttività<br />
della calata.<br />
Con l’impiego sistematico delle grandi<br />
unità di carico (contenitori, automezzi)<br />
le calate del tipo ora ricordate, che,<br />
ove sono ancora in uso, vengono definite<br />
di tipo tradizionale, vennero sostituite<br />
sia dalle già ricordate calate o terminali<br />
per merci containerizzate sia<br />
dalle più articolate calate polivalenti,<br />
o multipurpose.<br />
Nell’impianto dei porti commerciali<br />
è da far cenno alle calate specializzate<br />
per la movimentazione delle merci alla<br />
rinfusa, “bulk cargo”. Le rinfuse secche,<br />
o solide, dry bulk cargo, come già
EDOARDO BENASSAI<br />
Fig. 1 – Sezione trasversale sporgente del bacino di Sampierdarena – Genova<br />
ricordato sono spesso ripartite - con riguardo<br />
alle apparecchiature di movimentazione<br />
e deposito nelle calate - in<br />
rinfuse secche da benna, quali carboni<br />
(sale, rottami di ferro, e rinfuse secche<br />
da silos, quali cereali, semioleosi, cementi,<br />
etc. Nei principi essenziali le calate<br />
presentano tuttora le caratteristiche<br />
d’impianto delle calate realizzate prima<br />
degli anni ‘50, radicalmente potenziate.<br />
Ovviamente, la potenzialità degli impianti<br />
di cardiscarica e di messa a deposito,<br />
devono essere in accordo con i grandiosi<br />
aumenti dei volumi di merce trasportata<br />
dalle grandi navi specializzate<br />
e con i grandi progressi delle attuali tecnologie<br />
di movimentazione delle rinfuse.<br />
Nella Fig 2 sono poste in evidenza le<br />
principali attrezzature di una calata per<br />
scarico rinfuse da benna (carboni, minerale<br />
e similari):<br />
- grande gru, o ponte scaricatore a<br />
benna, corrente su binario di banchina<br />
parallelamente alla fiancata della nave.<br />
- trasferimento della rinfusa scaricata<br />
al parco di deposito a mezzo di convogliatori<br />
a nastro;<br />
- messa a parco (e ripresa poi per la<br />
spedizione) con potenti attrezzature<br />
mobili su rotaia (stacker, stackerreclaimer).<br />
1512<br />
Le apparecchiature di trasferimento<br />
e di messa a deposito possono raggiungere<br />
la stessa resa oraria di quelle di<br />
scarico a lato della nave, che diventa<br />
fattore di qualifica per l’operatività dell’intera<br />
calata. È evidente la semplicità<br />
e linearità dell’impianto, in pieno accordo<br />
con i criteri della moderna portualità;<br />
con impianti potenti si possono scaricare<br />
navi di portata 150.000 DWT/<br />
200.OOO DWT in meno di tre giorni<br />
(compresi tempi di ormeggio e disormeggio).<br />
Negli impianti più recenti all’impiego<br />
degli scaricatori a benna, ad azione<br />
tipicamente discontinua, si vanno sostituendo<br />
quelli ad azione continua, con<br />
azione di principio, simile a quella da tempo<br />
in azione per il trattamento di merce<br />
a pezzatura minuta o in polvere (granaglie,<br />
minerale in polvere, cementi). Un<br />
ulteriore decisivo progresso sia sotto il<br />
profilo funzionale che di protezione ambientale<br />
si raggiunge con applicazione<br />
del cosidetto “slurry system”, per il trasporto<br />
di minerali e carbone in pezzatura<br />
minuta miscelata con acqua e cosi reso<br />
movimentabile con sistemi di pompaggio<br />
in condotte. Le esigenze primarie da<br />
osservare per strutture da adibire al traffico<br />
delle navi rinfusa sono:
- profondità dei fondali degli accosti,<br />
a motivo del gigantismo caratteristico<br />
delle navi porta rinfuse. I fondali<br />
dell’altezza di m 10/11 possono consentire<br />
l’accosto a navi cariche sino alle 40/<br />
45000 DWT di portata;<br />
- ampiezza dei piazzali di deposito,<br />
perché in un impianto commerciale non<br />
è dato prevedere un allontanamento<br />
immediato di tutta la merce scaricata;<br />
- circolazione dei convogli ferroviari<br />
della maggiore efficienza, con adeguata<br />
dotazione di binari di calata e linee<br />
di raccordo veloci ai parchi ferroviari<br />
di smistamento (in dipendenza<br />
dal traffico viario e cittadino).<br />
Un più agevole e spedito servizio alla<br />
nave ed alla merce si può ottenere nei<br />
terminali specializzati per il trattamento<br />
delle rinfuse liquide: oli minerali: grezzi<br />
(petroli grezzi) e raffinati (nafta, olio<br />
combustibile, gasolio, benzina, oli minerali<br />
lubrificanti) effettuati per i grezzi con<br />
navi fino alle 250.000 ~ 400.000 DWT<br />
e più e per i prodotti raffinati con navi<br />
minori, portate sino alle 60 000-120.000<br />
DWT. Per l’accosto sono sufficienti<br />
pontili di tipo discontinuo, la movimentazione<br />
della merce è affidata a sistemi<br />
di pompe che hanno resa elevata<br />
in proporzione della portata delle navi,<br />
cosicchè di norma in 18/24 h possono<br />
essere effettuate tutte le operazioni di<br />
sbarco o imbarco, qualunque sia il volume<br />
di merce trasportata dalla nave.<br />
Di consueto, sempre mediante pompaggi<br />
in condotte (oleodotti) la merce<br />
può essere avviata anche a grande distanza<br />
nell’hinterland, e l’accosto avere<br />
disponibilità di stoccaggio contenuto<br />
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
1513<br />
Fig. 2 – Movimentazione di merci<br />
da nave bulk cargo<br />
(in proporzioni alla portata delle navi che<br />
lo frequentano). L’impianto di terminal<br />
per i prodotti liquidi grezzi, ed in particolare<br />
quelli raffinati, esige l’osservanza<br />
di particolari attenzioni per la difesa<br />
antincendio dell’ impianto e per la difesa<br />
dell’ambiente (inquinamento delle<br />
acque marine, rischi di incendi, di<br />
esplosioni per le zone vicine, ecc.). Cautele<br />
accresciute sono richieste per terminali<br />
adibiti al traffico di navi speciali<br />
per il trasporto di gas liquefatti sia naturali<br />
(essenzialmente il metano) e sia<br />
derivati del petrolio (propano, propilene,<br />
butano, ammoniaca, cloruro di vinil,<br />
ed altri).<br />
Accosti per contenitori<br />
Movimentazione verticale<br />
Gli accosti per navi portacontainer,<br />
containership cellulari, caratterizzate<br />
dalla movimentazione verticale dei<br />
container, assunsero ben presto la configurazione<br />
indicata nella Fig. 3.<br />
L’accosto per nave sino alle 35.000<br />
DWT realizzato nella grande isola artificiale,<br />
di Port Island, a Kobe è in eser-
cizio dal 1977. La calata affianca cinque<br />
terminali - eventualmente interagenti<br />
- per uno sviluppo di 500 m. Si può rilevare<br />
la pianta rettangolare di superficie<br />
complessiva m 300 x 350 = 10.5 ettari<br />
comprendente una banchina di larghezza<br />
m 40, sulla quale corrono due sole<br />
grandi gru, ampia zona di deposito all’aperto<br />
(container yard) di 7 ettari, ai<br />
margini un limitato gruppo di fabbricati<br />
tra cui: officina manutenzioni mezzi operativi<br />
e container, direzione, ingresso.<br />
Condizionanti per l’operatività del terminai<br />
sono anzitutto le due grandi gru<br />
dette portainer, e la superficie di deposito<br />
- senza confronto superiori a quanto<br />
previsto nelle già cennate calate tradizionali<br />
per merci varie, - la gran facilità<br />
e scioltezza dei collegamenti viari e<br />
ferroviari.<br />
Le gru portainer hanno portata di 40/<br />
50t, sbraccio lato mare adeguato alla<br />
Fig. 3 – Accosto per contenitori a Port Island<br />
a Kobe<br />
EDOARDO BENASSAI<br />
1514<br />
larghezza delle navi portacontainer delle<br />
varie generazioni, si arriva sino a 35/<br />
40 m e più, lato terra sbraccio 22/30 m,<br />
notevole altezza per superare l’ingombro<br />
della nave a pieno carico di contenitori<br />
vuoti, scartamento 18/27 m.<br />
La gru è in grado di afferrare e sollevare<br />
il contenitore con un particolare<br />
telaio, spreader, fornito di freni elettromagnetici;<br />
l’operazione può essere svolta<br />
dal gruista (La Spezia, Fig. 4). Con<br />
orario di lavoro di 24 h di solito applicato<br />
in tutti i terminali efficienti si raggiunsero<br />
così le 14.000 t/giorno per un<br />
accosto, valori senza confronto superiori<br />
a quelli delle calate tradizionali. I<br />
contenitori possono esser collocati dalla<br />
gru sui vettori terrestri ma più frequentemente<br />
vengono messi a deposito sul<br />
grande piazzale, con ricorso a sistema<br />
diversi di movimentazione, che, in via<br />
semplificata possono esser ricondotti ai<br />
tre schemi della Fig. 5: movimentazione<br />
su carrelli, o trayler, a mezzo gru a<br />
cavaliere (straddle carrier), con apposite<br />
gru a portale (transteiner). ù<br />
Ammessa una portata media di merce<br />
di un TEU pari a 10 t, si sono così<br />
ottenuti con i nuovi traffici rese dalle 200/<br />
300 t/gru/h e, con due gru, 400/600t/h<br />
per nave, rese più elevate con i tipi più<br />
recenti di gru.<br />
Nella pratica sono usati spesso sistemi<br />
misti e nei grandi terminali il sistema<br />
più adottato è quello a transteiner.<br />
Ovviamente col ricorso all’appilamento<br />
dei container si può ridurre sensibilmente<br />
la richiesta di area di deposito, però diminuisce<br />
pure la flessibilità e la operatività<br />
dell’impianto.
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
Fig. 4 – Movimentazione contenitori nel porto di La Spezia<br />
Fig. 5 – Diversi sistemi di movimentazione di contenitori<br />
1515
Fig. 6 – Terminali per contenitori ad Amburgo<br />
Di norma non si superano mediamente<br />
i due container pieni sovrapposti. In<br />
ogni caso, con l’impiego di navi Lo/lo<br />
della terza ed attualmente anche quarta<br />
generazione è ben presto continuata a<br />
crescere l’ampiezza dell’area di calata,<br />
(Fig. 6).<br />
La Fig. 7 presenta lo schema di progetto<br />
di un nuovo terminal container del<br />
porto di Amburgo.<br />
Ad Anversa sono in esercizio due<br />
calate lunghe rispettivamente 2600 m e<br />
2150 m e della larghezza di circa 600 m<br />
a cui si aggiungono le aree richieste dagli<br />
impianti viari e ferroviari di servizio.<br />
Di importanza basilare è il tempo di sosta<br />
media, strettamente correlato all’ operatività<br />
non solamente del terminale ma<br />
pure dell’intera catena di traffico. È infatti<br />
da rilevare come il costo d’esercizio<br />
di una nave full container è di per se<br />
stesso assai più elevato di quello delle<br />
navi tradizionali, riferito al peso di merce<br />
trasportato e per vari motivi:<br />
- elevati oneri di ammortizzo del maggior<br />
costo di costruzione;<br />
- minore resa di carico della nave<br />
perché la quantità di merce trasportata<br />
su una full containers è minore di quella<br />
di una nave tradizionale di eguali dimensioni;<br />
- le più elevate velocità etc.<br />
EDOARDO BENASSAI<br />
1516<br />
Fig. 7 – Piazzali per contenitori nel porto<br />
Per ottimizzare il costo complessivo<br />
dei traffici occorre pertanto che molte<br />
navi scalino il porto, ma che si abbiano:<br />
- soste brevissime delle navi (due/<br />
tre giorni) e dei contenitori nel sistema<br />
portuale;<br />
- che le navi arrivino e ripartano con<br />
buona percentuale di containers pieni.<br />
Movimentazione orizzontale<br />
Decisamente più semplice l’impianto<br />
delle calate per il traffico navi a<br />
movimentazione orizzontale dei carichi:<br />
container, od in generale temporanee<br />
unità di carico, (autocarri, etc.). Con ulteriore<br />
innovazione rispetto alle navi tradizionali<br />
la merce unitizzata è mobile, o<br />
resa mobile, può essere caricata, o scaricata<br />
su rampe mobili, (Fig. 8).<br />
Le navi Ro/ro sono assai versatili; e<br />
la movimentazione dei contenitori e dell’unità<br />
di carico può esser effettuata in<br />
vari modi: su carrelli con l’aiuto di trattori<br />
che restano sulle navi, restano sulla<br />
nave solo i carrelli, non restano nè carrelli<br />
nè trattori. Sulle navi Ro/ro si assumono<br />
a bordo pure partite di merci varie<br />
a caricamento verticale (frequente-
mente contenitori appilati in coperta scaricati<br />
con gru di bordo, ovvero gru<br />
semoventi sulle banchine), di rinfuse<br />
solide, e le navi (pur sempre dotate di<br />
rampe per traffici orizzontali) vengono<br />
ad assolvere compiti di traffico similari<br />
alla navi multipurpose, propriamente<br />
dette. L’esercizio delle navi Ro/ro è di<br />
per se stesso, ancora più costoso di quello<br />
delle navi tipo Lo/lo, a causa del maggiore<br />
volume perduto per consentire la<br />
movimentazione dei carichi mobili, la<br />
nave trova giustificazione e convenienza<br />
commerciale nei traffici veloci di partite<br />
di non grande entità, diverse e articolate,<br />
di merce, nel richiedere soste anche<br />
molto brevi, di consentire l’accosto<br />
anche in porti non molto attrezzati, facilitare<br />
i collegamenti, i servizi di<br />
federaggio tra porti maggiori e porti minori,<br />
servizi traghetto.<br />
L’impiego di navi del genere potrebbe<br />
intensificarsi nel quadro della cosiddetta<br />
“autostrada del mare” di cui si<br />
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
Fig. 8 – Camion in manovra per navi traghetto<br />
1517<br />
auspica una razionale organizzazione tra<br />
i tanti porti, anche minori, dei nostri litorali,<br />
con possibilità di evidenti vantaggi<br />
energetici (riduzione traffico autocarrato<br />
su autostrada) ed ambientali.<br />
Accosti polivalenti<br />
Le calate per il traffico navi multipurpose,<br />
o calate polivalenti, calate<br />
multipurpose, sono calate idonee per<br />
struttura, molteplicità di attrezzature di<br />
manipolazione e deposito della merce, a<br />
soddisfare le richieste delle navi multipurpose,<br />
apparse sullo scenario marittimo<br />
per offrire alla merce una più ampia<br />
libertà di condizionamento per rispetto<br />
non solamente alla navi fullcontainer ma<br />
pure alle navi Ro/ro, essendo in grado<br />
di movimentare la merce sia per linea<br />
verticale (con intervento di gru di bordo<br />
o di banchina) e sia per linea orizzontale<br />
(disponendo di una rampa d’accesso per<br />
rotabili). Negli esempi più completi, (Fig.<br />
9), ritornano le gru - di diversa portata -
Fig. 10 – Porto di Felixstowe nel 1985<br />
correnti al lato nave su binari di banchina,<br />
possibilità cosi di carico/scarico diretto<br />
a/da vettore “terrestre”, automezzo<br />
o ferrovia, depositi scoperti e coperti<br />
EDOARDO BENASSAI<br />
Fig. 9 –Terminale per traffico navi multiporpose<br />
1518<br />
per merci varie in colli e pure per partite<br />
di merci alla rinfusa, zone attrezzate<br />
per depositi container od altri carichi<br />
unitizzati. Gli schemi lineari della figura<br />
sopra citata sono riferiti a strutture di<br />
nuovo impianto della portualità estera.<br />
Nei nostri porti, sfruttando la versatilità<br />
caratteristica dei traffici multipurpose,<br />
il loro frazionamento in partite di<br />
merce di diverso condizionamento (e<br />
pertanto avviate a distinte disposizioni<br />
di deposito) di più contenuta entità, l’impiego<br />
di navi di mole minore, o media<br />
(frequente la presenza di navi tipo Ro/<br />
ro con container appilati in coperta), sono<br />
state, di norma utilizzate calate esisten-
ti, create a suo tempo per il traffico tradizionale<br />
di merci varie. Vengono eliminati,<br />
o ridotti, gli esistenti fabbricati magazzino,<br />
per preferire zone scoperte o<br />
capannoni, sostituite le tradizionali gru,<br />
di riva portata < 3 t correnti su rotaie<br />
con gru semoventi di diversa portata,<br />
anche elevata, per la movimentazione<br />
dei carichi più vari, pezzi di impiantistica,<br />
sino a pesi anche molto rilevanti, facilitata<br />
la circolazione di automezzi, o traini,<br />
di diverso tipo, presente il raccordo<br />
ferroviario.<br />
Nuove disposizioni planimetriche<br />
Con l’affermarsi delle nuove forme<br />
di traffico, caratterizzate da accresciute<br />
dimensioni e tipologie delle navi, da<br />
nuovi condizionamenti della merce ed<br />
anzitutto da enorme aumento dei volumi<br />
trasportati, si sono accresciute le dimensioni<br />
delle calate e si sono modificate<br />
le loro disposizioni planimetriche<br />
Due aspetti strutturali sono diventati<br />
sempre più condizionanti: il fronte d’accosto<br />
di grande lunghezza (per rispetto<br />
Fig. 11 – Diminuzione dei costi all’aumentare<br />
della capacità<br />
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
1519<br />
a quella della nave), associato a fondali<br />
d’altezza adeguata e la circolazione dei<br />
mezzi di trasporto terrestri. Solamente<br />
con questi requisiti di impianto strutturale<br />
le calate possono avere la flessibilità<br />
necessaria per poter far fronte alle<br />
variazione di volume e pure di condizionamento<br />
dei traffici che potrebbero<br />
verificarsi nel futuro. Infatti lo sviluppo<br />
di un lungo fronte continuo d’accosto,<br />
atto all’ormeggio contemporaneo di<br />
un dato numero di navi è di per stesso<br />
minore della somma degli sviluppi del<br />
maggior numero di accosti richiesti per<br />
il servizio dello stesso numero di navi,<br />
però previsti gli accosti distinti e separati.<br />
Un lungo sviluppo offre cioè importanti<br />
economie di scala perché il<br />
volume dei traffici cresce di misura più<br />
che proporzionale al numero degli accosti;<br />
per effetto delle compensazioni<br />
che si possono stabilire in un gruppo di<br />
accosti funzionalmente collegati viene a<br />
diminuire la sosta delle navi e ad elevarsi<br />
il fattore di utilizzazione degli impianti<br />
(particolarmente traffici Ro/ro,<br />
polivalenti, etc.). Si può inoltre sempre<br />
trovare in una lunga calata, se fornita<br />
nel contempo di adeguata larghezza,<br />
sufficiente disponibilità per l’impianto<br />
Fig. 12 – Porto di Voltri-Genova
delle zone di deposito e di quelle di circolazione<br />
e di sosta dei veicoli viari e<br />
ferroviari. Assieme alla lunghezza delle<br />
calate è andata del pari crescendo la<br />
necessità di disporre di sempre più ampie<br />
larghezze del piatto di calata, in<br />
particolare, dei relativi piazzali destinati<br />
al deposito della merce ed alla circolazione<br />
dei vettori terrestri, cosicché negli<br />
ultimi decenni pur senza aprioristiche<br />
esclusioni si hanno pochi esempi in nuovi<br />
impianti portuali di disposizione delle<br />
calate su sporgenti paralleli preferendo<br />
l’impianto di calate di grande lunghezza<br />
e larghezza secondo il cosiddetto<br />
longitudinal quay system Fig. 10, che<br />
meglio può consentire la formazione di<br />
calate delle grandi dimensioni ormai richieste.<br />
EDOARDO BENASSAI<br />
Fig. 13 – Porto di Gioia Tauro<br />
1520<br />
Ciò in quanto, come pone in evidenza<br />
il grafico UNCTAD (con dati aggiornati<br />
al 1979) riportato alla Fig. 11, i costi<br />
unitari di trasporto per tonnellata di merce<br />
manipolata decrescono al crescere<br />
del volume movimentato.<br />
L’evoluzione subita dagli impianti dei<br />
porti commerciali può essere messa in<br />
evidenza confrontando l’impianto portuale<br />
del Bacino di Sampierdarena del<br />
porto di Genova, con quello del Bacino<br />
di Voltri, (Fig. 12), di recente divenuto<br />
operativo nello stesso porto di Genova.<br />
Adeguare pienamente porti, o calate, alle<br />
esigenze delle forti concentrazioni di traffico<br />
comporta però elevatissimi investimenti<br />
finanziari per la costruzione di<br />
impianti e relativi apparecchiature meccaniche<br />
ad alto potenziale e pure rile-
vanti spese per il loro esercizio. Investimenti<br />
e spese giustificate solamente se<br />
i traffici che devono usufruirne raggiungono<br />
effettivamente tali forti concentrazioni.<br />
Gerarchie nel potenziamento dei porti<br />
Grandi quantitativi di merce imbarcate/sbarcate<br />
si possono ottenere<br />
però solo in pochi porti che potremmo<br />
definire oceanici, “ocean sea ports”,<br />
aperti alla frequentazione continua delle<br />
massime navi dei vari tipi. In questi<br />
porti non è solamente consigliabile ma<br />
necessario predisporre opere delle massima<br />
efficienza e potenzialità. Giova ricordare<br />
come le maggiori acquisizioni<br />
di traffici internazionali si siano avute nei<br />
porti che con le loro realizzazioni hanno<br />
saputo precedere la domanda dei traffici,<br />
perseguendo prospettive che altri<br />
porti non avevano ancora intuito. Con<br />
riferimento ai minori quantitativi delle<br />
merci scambiate ed alla più contenuta<br />
frequentazione di massime navi potremmo<br />
individuare una seconda fascia, o<br />
categoria di porti, o porti di mare profondo<br />
o deep ports nei quali i traffici<br />
sono ancora rilevanti, ma meno intensi<br />
e generali, e la presenza delle navi di<br />
grande portata possibile ma non sistematica.<br />
Segue poi il vasto gruppo di porti<br />
adibiti a traffici locali e di cabotaggio,<br />
cosiddetti short sea ports, serviti da<br />
navi di più ridotta portata, navi feeder e<br />
di cabotaggio nazionale. È evidente che<br />
nei porti di categoria minore che non<br />
Strutture di accosto nei porti marittimi<br />
* La prima parte della nota è riportata nel Tomo primo, a pag. 595.<br />
1521<br />
hanno il compito di essere pienamente<br />
disponibili a tutte le più varie evoluzioni<br />
dei traffici marittimi, sia razionale predispone<br />
infrastrutture ed apparati di<br />
manipolazione delle merci di minore<br />
potenzialità, e pertanto di minor costo di<br />
costruzione e di esercizio.<br />
Nella pianificazione dei porti commerciali<br />
(e pure delle singole calate) è<br />
pertanto necessario seguire criteri dì<br />
chiara selezione o dì gerarchia. Una<br />
nazione con importante ruolo marittimo<br />
deve disporre di porti e scali specializzati<br />
aperti ai grandi traffici internazionali<br />
ad evitare che le costose operazioni<br />
di transhipment dalle grandi navi<br />
alle navi medie, o minori, vengano effettuate<br />
in porto estero con vantaggio<br />
per le economie estere e svantaggio per<br />
la nazione stessa.<br />
Un esempio italiano di scalo internazionale<br />
per contenitori è rappresentato<br />
dal porto di Gioia Tauro (Fig. 13). Giova<br />
specificare che un porto si qualifica nel<br />
contesto internazionale dei traffici commerciali<br />
per la soglia superiore dei servizi<br />
che offre e che, per logica correlazione,<br />
si qualifica per la forza<br />
polarizzante che esso esercita sui flussi<br />
oceanici, sui mercati che più intensamente<br />
animano il trasporto marittimo. Gli<br />
ocean sea ports diventano centri di reti<br />
di traffico marittimo di ridistribuzione<br />
della merce (importanti traffici di<br />
transhipment) che impiegano navi minori<br />
adatte alle caratteristiche di impianto<br />
dei porti di minore potenziale.
EDOARDO BENASSAI<br />
1522