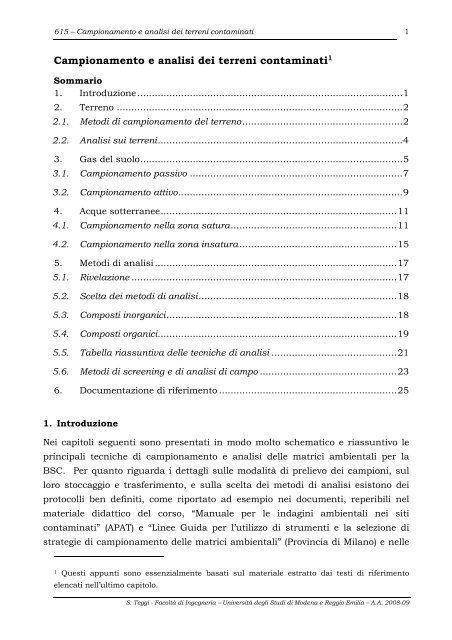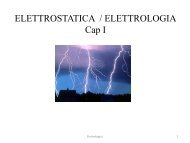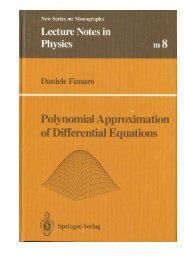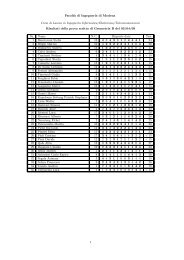615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati
615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati
615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
<strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong> 1<br />
Sommario<br />
1. Introduzione ........................................................................................... 1<br />
2. Terreno .................................................................................................. 2<br />
2.1. Metodi di campionamento del terreno ....................................................... 2<br />
2.2. Analisi sui <strong>terreni</strong> .................................................................................... 4<br />
3. Gas del suolo .......................................................................................... 5<br />
3.1. <strong>Campionamento</strong> passivo ......................................................................... 7<br />
3.2. <strong>Campionamento</strong> attivo ............................................................................. 9<br />
4. Acque sotterranee ................................................................................. 11<br />
4.1. <strong>Campionamento</strong> nella zona satura ......................................................... 11<br />
4.2. <strong>Campionamento</strong> nella zona insatura ...................................................... 15<br />
5. Metodi di <strong>analisi</strong> ................................................................................... 17<br />
5.1. Rivelazione ........................................................................................... 17<br />
5.2. Scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong> .................................................................... 18<br />
5.3. Composti inorganici ............................................................................... 18<br />
5.4. Composti organici .................................................................................. 19<br />
5.5. Tabella riassuntiva delle tecniche di <strong>analisi</strong> ........................................... 21<br />
5.6. Metodi di screening e di <strong>analisi</strong> di campo ............................................... 23<br />
6. Documentazione di riferimento ............................................................. 25<br />
1. Introduzione<br />
Nei capitoli seguenti sono presentati in modo molto schematico e riassuntivo le<br />
principali tecniche di campionamento e <strong>analisi</strong> delle matrici ambientali per la<br />
BSC. Per quanto riguarda i dettagli sulle modalità di prelievo <strong>dei</strong> campioni, sul<br />
loro stoccaggio e trasferimento, e sulla scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong> esistono <strong>dei</strong><br />
protocolli ben definiti, come riportato ad esempio nei documenti, reperibili nel<br />
materiale didattico del corso, “Manuale per le indagini ambientali nei siti<br />
<strong>contaminati</strong>” (APAT) e “Linee Guida per l’utilizzo di strumenti e la selezione di<br />
strategie di campionamento delle matrici ambientali” (Provincia di Milano) e nelle<br />
1 Questi appunti sono essenzialmente basati sul materiale estratto dai testi di riferimento<br />
elencati nell’ultimo capitolo.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
1
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
pagine internet dell’ARPA Piemonte “Proposta di guida tecnica sui metodi di<br />
<strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>” (http://ctntes.arpa.piemonte.it/<br />
Raccolta%20Metodi%202003/home.htm).<br />
2. Terreno<br />
2.1. Metodi di campionamento del terreno<br />
I metodi di campionamento del terreno sono solitamente sono suddivisi in prelievi<br />
superficiali e prelievi profondi.<br />
Per i prelievi superficiali si utilizzano palette, per il prelievo direttamente in<br />
superficie oppure sulle pareti di scavo di una trincea, oppure delle normali<br />
trivelle, generalmente manuali, per raggiungere profondità di 1-1.5 m.<br />
Nel caso di prelievi profondi si utilizzano sonde (campionatori) poste all’estremità<br />
di aste perforatrici di comune uso in geotecnica.<br />
I campionatori possono essere non sigillati oppure sigillati. Alcuni esempi di<br />
campionatori non sigillati sono riportati nella figura sottostante (in alto). In<br />
questo caso la cavità della sonda è mantenuta aperta fino alla profondità<br />
desiderata, quindi il materiale estratto può provenire da un qualsiasi strato<br />
attraversato.<br />
I campionatori sigillati sono praticamente uguali ai precedenti, con l’aggiunta di<br />
un pistone che occupa la cavità e viene retratto solo alla profondità desiderata.<br />
Un esempio di campionatori sigillati è riportato nella figura sottostante (in basso):<br />
prima si fa il foro, poi viene inserita la sonda a pistone avanzato, dopodiché viene<br />
fatta avanzare la sonda a pistone ritratto.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
2
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
Campionatori di terreno<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
3
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
2.2. Analisi sui <strong>terreni</strong><br />
Una procedura standard di <strong>analisi</strong> di un terreno è sinteticamente riassumibile in<br />
4 fasi (che possono essere omesse o ripetute in relazione allo specifico composto):<br />
- estrazione dal terreno,<br />
- purificazione dell’estratto grezzo,<br />
- separazione degli analiti,<br />
- rivelazione (trattata nel capitolo finale).<br />
Estrazione dal terreno<br />
Consiste nell’ isolamento delle sostanze estraibili con un opportuno solvente dalla<br />
matrice solida. I metodi più utilizzati sono:<br />
- Spazio di testa e Purge and Trap<br />
- Desorbimento termico<br />
- Estrazione liquido-solido<br />
Spazio di testa e Purge and Trap: Sono tecniche utilizzate per estrarre i COV.<br />
Questi composti possono essere estratti riducendo al minimo il materiale<br />
coestratto, facendo passare un gas inerte (di solito azoto o elio) attraverso il<br />
campione di terreno (Purge and Trap), oppure lasciando instaurare un<br />
equilibrio tra il terreno, posto in un contenitore sigillato e la fase gassosa<br />
soprastante (spazio di testa). Questi metodi sono semplici e non richiedono<br />
purificazioni prima dell’<strong>analisi</strong>.<br />
Desorbimento termico: Si applica per l’estrazione di composti la cui volatilità non è<br />
particolarmente elevata (SVOC). Il campione viene riscaldato a temperature<br />
comprese fra 90 oC e 650 oC. I vapori liberati vengono poi raccolti in modo<br />
analogo a quello descritto per il metodo precedente. Il metodo è problematico<br />
da applicare nel caso di composti termicamente instabili. Ad esempio sopra i<br />
300 °C molti composti vengono distrutti per pirolisi.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
4
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
Estrazione liquido-solido: Si basa sulla partizione all’equilibrio degli analiti tra il<br />
suolo e il solvente. La scelta delle condizioni sperimentali per il processo di<br />
estrazione, la polarità e la stabilità chimica <strong>dei</strong> composti sono fattori di<br />
fondamentale importanza.<br />
Le condizioni di estrazione adottate dipendono dalla forza de legame tra<br />
l’inquinante e il suolo. Per composti idrofili che solitamente sono debolmente<br />
legati alla matrice del suolo, si possono utilizzare delle condizioni<br />
relativamente blande. In questo caso il materiale coestratto è limitato. Per<br />
composti fortemente lipofili, come PCDD/PCDF, PCB, IPA, DDT e pesticidi<br />
clorurati, che sono forte mente adsorbiti alla componente organica del suolo,<br />
sono necessarie condizioni di estrazione più vigorose. Più severe sono le<br />
condizioni di estrazione, meno è selettiva l’estrazione e quindi maggiori sono<br />
i problemi nella successiva fase di purificazione e di eliminazione delle<br />
interferenze.<br />
Purificazione dell’estratto grezzo<br />
Serve essenzialmente per eliminare composti coestratti interferenti.<br />
Separazione degli analiti.<br />
In questa fase gli analiti sono separati in sottogruppi di classi chimiche, per<br />
essere quantificati con metodi di rivelazione differenti o per evitare interferenze<br />
reciproche nella fase di <strong>analisi</strong>.<br />
La scelta del metodo di purificazione dell’estratto grezzo e di separazione degli<br />
analiti è strettamente dipendente dalle loro proprietà chimiche e fisiche ed è<br />
fortemente correlata al metodo di estrazione e alla tecnica di rivelazione utilizzati<br />
per la quantificazione.<br />
La presentazione di questo argomento esula dall’ambito di questo corso ed è stata<br />
trattata in altri corsi, come quello di chimica generale e di chimica applicata<br />
all’ambiente (vedere inoltre i testi di riferimento).<br />
3. Gas del suolo<br />
Non essendo, ad oggi, definite da alcuna normativa le concentrazioni limite di<br />
contaminanti nel gas interstiziale, il campionamento <strong>dei</strong> gas del suolo (Soil Gas<br />
Survey, SGS) è generalmente utilizzato come metodo per la mappatura<br />
preliminare della contaminazione nel terreno e nelle acque sotterranee e per il<br />
monitoraggio della tenuta di serbatoi sotterranei.<br />
Rispetto ai metodi di indagine invasiva tradizionali (carotaggi, pozzi di<br />
monitoraggio), il campionamento <strong>dei</strong> gas del suolo offre il vantaggio di un costo<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
5
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
estremamente inferiore e di una grande rapidità di esecuzione. Ciò si traduce, in<br />
pratica, nella possibilità di effettuare estese campagne di rilevamento all'interno<br />
dell'area di studio, i cui risultati consentono di selezionare i criteri per le<br />
successive, più impegnative, indagini su <strong>terreni</strong> e acque.<br />
Tipici impieghi di tale metodo riguardano:<br />
- l'identificazione <strong>dei</strong> composti volatili e semivolatili presenti in un sito<br />
- l'individuazione delle sorgenti e <strong>dei</strong> pennacchi di contaminazione<br />
- l'ubicazione di punti di campionamento delle matrici suolo e acqua<br />
(sondaggi, pozzi di monitoraggio)<br />
- l'ubicazione di punti permanenti di monitoraggio.<br />
Questi obiettivi sono raggiunti attraverso due tipi di campionamento:<br />
- il campionamento passivo, in cui i campionatori vengono lasciati in sito per<br />
un periodo di tempo sufficientemente lungo (settimane), dopodiché il gas<br />
adsorbito al loro interno viene recuperato per desorbimento e analizzato in<br />
laboratorio;<br />
- il campionamento attivo, in cui il gas viene estratto dal terreno per mezzo di<br />
una pompa e quindi direttamente analizzato o conservato in idonei<br />
contenitori per successive <strong>analisi</strong>.<br />
Il campionamento passivo è generalmente adatto a tutti i tipi di terreno; tuttavia,<br />
condizioni di scarsa permeabilità e forte umidità possono limitare la quantità di<br />
gas che entra in contatto col campionatore e la quantità di gas che viene<br />
adsorbito su di esso. Nonostante tali limitazioni il metodo risulta più efficace del<br />
campionamento attivo.<br />
D'altra parte, il campionamento attivo, pur risultando più rapido, è inapplicabile<br />
in <strong>terreni</strong> argillosi compatti e nei <strong>terreni</strong> con grado di saturazione superiore a 0.8-<br />
0.9 a causa della mancanza di vuoti interconnessi in seno alla matrice solida del<br />
terreno.<br />
Le sostanze campionabili con queste metodologia devono ovviamente essere<br />
abbastanza volatili, indicativamente con H > 0.1. Nella tabella sottostante sono<br />
riportate alcune indicazioni sull’applicabilità del SGS per alcuni gruppi di<br />
contaminanti.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
6
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
3.1. <strong>Campionamento</strong> passivo<br />
I campionatori passivi sono costituiti da un materiale adsorbente (resine<br />
polimeriche o carbonatiche) sigillato all'interno di una membrana di<br />
politetrafluoroetilene (PTFE) microporosa, idrofobica e chimicamente inerte che<br />
permette al contaminante di migrare dagli interstizi del terreno al materiale<br />
adsorbente, bloccando al contempo le particelle di terreno e l'acqua<br />
eventualmente presente.<br />
La struttura descritta viene adagiata all'interno di fori praticati nel terreno<br />
mediante trivelle manuali fino alla profondità massima di 1 m circa e lasciata in<br />
posto per un periodo variabile da 3 a 21 giorni dopo aver sigillato il foro in<br />
superficie. Altri apparati sono costituiti da carboni attivi racchiusi entro celle di<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
7
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
flusso che vengono adagiate sulla superficie del terreno e mantenute in posizione<br />
per il tempo necessario.<br />
Trascorso tale periodo, il campionatore viene rimosso e inviato al laboratorio per<br />
le <strong>analisi</strong> sui composti organici volatili (COV).<br />
I risultati vengono espressi come quantità di contaminante rilevato per ogni<br />
campionatore dopodiché si effettua il confronto (concentrazioni relative) con i<br />
valori misurati da altri campionatori. Non è infatti possibile determinare la<br />
concentrazione di contaminante poiché non è nota la quantità di gas del suolo<br />
entrata in contatto con il materiale adsorbente. La concentrazione relativa <strong>dei</strong> vari<br />
composti rilevati è infatti più riconducibile all'affinità <strong>dei</strong> singoli composti per il<br />
materiale adsorbente e alla velocità di flusso del gas che alla concentrazione di<br />
ciascun composto nel gas del suolo.<br />
A tale limitazione si aggiunge il fatto che il campionamento passivo è una tecnica<br />
di rilevazione essenzialmente puntuale, non adatta all'interpretazione della<br />
distribuzione tridimensionale della contaminazione.<br />
Nelle due figure soprastanti sono riportati i due sistemi più utilizzati per questo<br />
tipo di campionamento.<br />
A sinistra (Sonda PETREX®): la sonda ha dimensioni di una decina di cm di<br />
lunghezza e diametro di circa 2 cm e che viene posta all’interno di uno scavo o<br />
perforazione ed è costituita da una fiala di vetro all’interno della quale è posto un<br />
filamento metallico rivestito di carbone attivo sul quale vengono adsorbiti i<br />
composti volatili presenti nel sottosuolo.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
8
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
A destra (Sonda GORE-SORBER®) : è costituita da granuli di carbone attivo, che<br />
adsorbono i composti volatili, racchiusi all’interno di una membrana in ePTFE di<br />
GORE-TEX®.; la sonda, che ha una lunghezza superiore al metro, può essere<br />
posta nel sottosuolo, mediante una apposita attrezzatura di diametro inferiore ai<br />
2 cm, ma a profondità limitata a qualche metro.<br />
3.2. <strong>Campionamento</strong> attivo<br />
Nel campionamento attivo i gas interstiziali vengono prelevati inserendo il<br />
campionatore nel foro generato da tramite un carotiere o da una piccola trivella<br />
(visti nel capitolo sul campionamento <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong>). La maggior parte <strong>dei</strong><br />
campionatori consiste in tubi fessurati infissi nel terreno o direttamente o<br />
all'interno di aste cave che vengono successivamente rimosse.<br />
I gas del suolo vengono aspirati attraverso le fessure mediante una pompa da<br />
vuoto e, risalendo lungo tubazioni in plastica (polietilene o teflon), vengono<br />
convogliati in recipienti di raccolta o direttamente agli strumenti di misura (figura<br />
sottostante).<br />
Uno <strong>dei</strong> vantaggi principali del campionamento attivo è la possibilità di acquisire i<br />
dati a diverse profondità per ottenere un profilo verticale della contaminazione. Il<br />
metodo è usato generalmente per la ricerca di COV e garantisce una rapida<br />
acquisizione del campione dalla profondità desiderata.<br />
Nella tabella sottostante sono riportati i principali vantaggi/svantaggi delle<br />
tecniche di campionamento attivo e passivo.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
9
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
10
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
4. Acque sotterranee<br />
Le tecniche di campionamento di acqua nel sottosuolo differiscono molto a<br />
seconda che l’estrazione avvenga nella zona satura o in quella insatura.<br />
4.1. <strong>Campionamento</strong> nella zona satura<br />
Lo strumento principale per il controllo della qualità delle acque sotterranee nella<br />
zona satura è il piezometro di monitoraggio.<br />
Il termine piezometro, letteralmente "misuratore di pressione", nel campo<br />
dell'idrogeologia sta ad indicare un pozzo di osservazione avente lo scopo di<br />
misurare il carico idraulico di una falda ad una certa profondità.<br />
L'uso di piezometri consente di ricostruire la superficie piezometrica della falda,<br />
ossia la superficie lungo la quale la pressione dell'acqua è pari a quella<br />
atmosferica. In pratica, la superficie piezometrica viene ricostruita interpolando le<br />
misure effettuate in più piezometri presenti nell'area investigata. La ricostruzione<br />
della superficie piezometrica consente di definire il gradiente idraulico, e la<br />
direzione del flusso di falda.<br />
L'utilità <strong>dei</strong> piezometri nel campo della BSC ambientale è anche legata alla<br />
possibilità che essi offrono di prelevarne campioni d'acqua a diverse profondità.<br />
Rispetto ai pozzi, i piezometri presentano diametri più piccoli e minore profondità<br />
e solo occasionalmente sono equipaggiati con una pompa per il prelievo<br />
dell'acqua di falda.<br />
A seconda che il piezometro o la rete di piezometri installati servano al<br />
monitoraggio periodico o occasionale della falda, essi sono detti permanenti o<br />
temporanei: i primi sono costruiti con accorgimenti tali da garantire la loro<br />
durata nel tempo e impedire la loro interazione con gli equilibri chimici e<br />
idrologici propri della falda; i secondi vengono installati per il tempo necessario<br />
all'acquisizione <strong>dei</strong> parametri chimico-fisici, ambientali e idrogeologici e vengono<br />
poi abbandonati previa sigillatura della tubazione o estratti con ritombamento del<br />
foro. Per tale motivo essi sono quasi sempre di diametro assai piccolo (< 5 cm) e<br />
di rapida installazione.<br />
La struttura di un piezometro per il monitoraggio della falda è quella di un tubo,<br />
in parte cieco e in parte fessurato, con le estremità chiuse da tappi che viene<br />
inserito in un foro di sondaggio precedentemente predisposto fino ad intercettare<br />
la falda o la porzione di falda che si vuole esaminare.<br />
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un acquifero multifalda, ossia composto<br />
da falde acquifere sovrapposte, e si ritenga necessario acquisire informazioni da<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
11
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
ciascun livello sarà possibile operare in uno <strong>dei</strong> seguenti modi (veder figura<br />
sottostante):<br />
- installare un gruppo di piezometri a distanza ravvicinata fra loro, uno per<br />
ogni falda che si intende indagare<br />
- eseguire un unico foro di diametro tale da poter ospitare vari piezometri,<br />
ognuno finestrato in corrispondenza di una falda.<br />
La prima tipologia presenta miniori complicazioni rispetto alla prima, e quindi è<br />
maggiormente utilizzata.<br />
Grande importanza riveste la scelta del materiale da utilizzare per il<br />
completamento del pozzo o del piezometro, il cui scopo è di garantire la durata<br />
nei confronti di processi di attacco e degradazione chimico fisica da parte <strong>dei</strong><br />
contaminanti. Infatti, in presenza di soluzioni acquose chimicamente reattive,<br />
alcuni componenti potrebbero essere rilasciati nei campioni che vengono<br />
prelevati, i quali, pertanto, non sarebbero più rappresentativi. Quindi è<br />
necessario scegliere i materiali delle tubazioni tenendo presente le potenziali<br />
interazioni con le sostanze presenti in falda.<br />
Le tubazioni comunemente utilizzate per il rivestimento possono essere<br />
schematicamente suddivise in tre tipologie:<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
12
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
- in acciaio (elevata resistenza meccanica): al carbonio, inossidabile,<br />
galvanizzato,<br />
- a base di fluoro polimeri (inerti, stabili e chimicamente inataccabili):<br />
politetrafluoroetilene (PTFE) o Teflon®, fluoroetilene (TFE), etilen propilene<br />
fluorato (FEP)<br />
- in materiali termoplastici (buona resistenza meccanica, abbastanza inerti e<br />
chimicamente poco attaccabili, sono quelli maggiormente usati): cloruro di<br />
polivinile (PVC), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polipropilene (PP),<br />
polietilene ad alta densità (PEAD).<br />
La porzione di piezometro che consente all'acqua di falda di penetrare al suo<br />
interno è detta filtro. Esso è costituito da una serie di piccole aperture<br />
(finestratura) omogeneamente distribuite sulla superficie del tubo la cui funzione<br />
è quella di lasciar passare l'acqua trattenendo le particelle di terreno senza, nel<br />
contempo, indebolire la struttura del piezometro.<br />
Il posizionamento del filtro rispetto all'acquifero è fattore essenziale affinché il<br />
piezometro assolva correttamente ai compiti per cui è stato installato.<br />
- Vengono detti piezometri (o pozzi) completi quelli che attraversano l'intero<br />
spessore dell'acquifero fino ad intestarsi nel suo livello di base.<br />
- Viceversa, sono detti incompleti quei piezometri che intercettano solo una<br />
porzione dell'acquifero.<br />
L'esigenza di avere un piezometro completo o incompleto è strettamente legata al<br />
tipo di contaminanti da campionare ed in particolare alla presenza di NAPL. Nel<br />
caso di LNAPL si potrà ricorrere ad un piezometro incompleto, col filtro nello<br />
strato di terreno immediatamente sotto la tavola d’acqua, mentre nel caso di<br />
DNAPL è consigliabile ricorrere ad piezometro completo.<br />
La misura della soggiacenza della falda si effettua per mezzo del freatimetro. Il<br />
freatimetro è uno strumento costituito da una sonda di lettura alimentata a<br />
batteria che viene calata all'interno del piezometro per mezzo di un cavo<br />
millimetrato o centimetrato. Il circuito elettrico si chiude nel momento in cui la<br />
sonda viene a contatto con la superficie dell'acqua.<br />
Un suono, spesso abbinato all'accensione di un led, avverte dell'avvenuto<br />
contatto con l'acqua e che si può procedere con la lettura della profondità.<br />
Una evoluzione del freatimetro, chiamata sonda d'interfaccia, è uno strumento del<br />
tutto simile a questo tranne per la capacità di segnalare l'attraversamento di due<br />
distinte interfacce utilizzando suoni diversi (in genere uno continuo, l'altro<br />
intermittente) e/o appositi led luminosi. In tal modo è possibile misurare la<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
13
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
profondità di una eventuale interfaccia aria/olio in galleggiamento e della<br />
sottostante interfaccia olio/acqua. La differenza di profondità tra le due interfacce<br />
esprime lo spessore della fase in galleggiamento.<br />
Freatimetri<br />
I parametri chimico-fisici della falda richiedono una misura il più possibile rapida<br />
per evitare che essi subiscano variazioni in seguito al contatto con l'atmosfera.<br />
Ove possibile, è consigliabile la misura diretta nel piezometro mediante<br />
l'introduzione di sonde collegate a strumenti in grado di rilevare temperatura, pH,<br />
ossigeno disciolto, salinità, conducibilità elettrica, potenziale di ossidoriduzione.<br />
In alternativa, la misura <strong>dei</strong> suddetti parametri va effettuata durante lo spurgo<br />
con l'ausilio di una cella di flusso. Questa è costituita da un contenitore munito<br />
di un ingresso e una uscita per l'acqua e di alloggiamenti per i sensori degli<br />
strumenti di misurazione. Facendo fluire l'acqua di spurgo all'interno della cella<br />
questa viene a contatto degli elettrodi senza entrare in contatto con l'aria.<br />
La misura <strong>dei</strong> parametri chimico-fisici viene effettuata mediante strumenti<br />
portatili di facile utilizzo quali termometri, pH-metri, conduttimetri, misuratori di<br />
ossigeno disciolto. Alcuni strumenti, detti multiparametrici, consentono la misura<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
14
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
simultanea di più parametri collegando vari elettrodi allo stesso strumento. Pur<br />
non avendo la stessa precisione e sensibilità di uno strumento da banco, gli<br />
strumenti portatili presentano il vantaggio di poter misurare le caratteristiche<br />
chimico-fisiche dell'acqua quasi in tempo reale.<br />
4.2. <strong>Campionamento</strong> nella zona insatura<br />
Per le acque contenute nella zona insatura sono possibili diverse metodologie di<br />
campionamento; di seguito sono brevemente illustrate alcune fra le principali.<br />
<strong>Campionamento</strong> diretto del terreno<br />
Consiste nell’ottenere campioni indisturbati e sigillati di terreno (le metodologie di<br />
prelievo e conservazione <strong>dei</strong> campioni ambientali sono reperibili nei testi di<br />
riferimento) che vengono sottoposti in laboratorio sia alla determinazione delle<br />
caratteristiche fisiche, quali densità naturale e contenuto idrico, sia ad un<br />
processo di estrazione dell’acqua interstiziale.<br />
Quest’ ultimo viene effettuato utilizzando, in funzione del tipo di campione e del<br />
tipo di <strong>analisi</strong> necessaria, uno <strong>dei</strong> seguenti metodi:<br />
- centrifugazione,<br />
- spostamento mediante passaggio di un altro fluido,<br />
- estrazione mediante passaggio di gas,<br />
- compattazione meccanica,<br />
- lisciviazione e diluizione.<br />
L’acqua estratta viene quindi analizzata per determinarne il contenuto chimico.<br />
Da notare che con questi metodi di estrazione può essere forzata anche<br />
l’estrazione di sostanze che sono adsorbite alla fase solida e quindi l’<strong>analisi</strong><br />
chimica può non rispecchiare esattamente il livello di contaminazione delle acque.<br />
Lisimetri attivi<br />
Lo strumento consiste in un tubo di lunghezza variabile con un tratto di<br />
materiale poroso in punta o nella sua parte mediana grazie al quale, una volta<br />
posizionato alla profondità desiderata, risulta idraulicamente collegato con i pori<br />
del terreno. Producendo il vuoto all’interno del tubo è possibile quindi creare una<br />
suzione nel terreno circostante superiore alle forze di tensione dell’acqua presente<br />
nei pori e quindi un gradiente di pressione che richiama il fluido interstiziale dal<br />
terreno all’interno del tubo. Da qui può essere infine estratto con semplici<br />
procedimenti.<br />
Nelle figure sottostante sono presentati tre tipi di lisimetri tipicamente utilizzati.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
15
<strong>615</strong> <strong>–</strong> CCampionameento<br />
e analissi<br />
<strong>dei</strong> terrenni<br />
contamina ati<br />
Lisimettro<br />
attivo a depressioone<br />
I due lisimetri rip iportati soppra<br />
sono<br />
utilizzzabili<br />
per pprofondità<br />
iinferiori<br />
ai<br />
10m.<br />
Per prrofondità<br />
ssuperiori<br />
(4 40-90m) si<br />
utilizzzano<br />
i lisimmetri<br />
ad altta<br />
pressionne<br />
riportaati<br />
a fiancoo<br />
Lisimetri passivi<br />
Lisim metro attivoo<br />
a depresssione-pres<br />
ssione<br />
Lisimetro<br />
attivo<br />
a deprressione-alta<br />
pr ressione<br />
I lisimetrri<br />
passivi sono in sostanzaa<br />
dreni so otterranei che venggono<br />
utilizzati<br />
perr<br />
raccoglieere<br />
e recupperare<br />
cammpioni<br />
d’ acqua.<br />
Un esemmpio<br />
tipicoo<br />
è rappreesentato<br />
ddai<br />
lisimet tri passivii<br />
di superrficie<br />
in si ito e dallee<br />
scatole liisimetrichhe<br />
(figura sottostannte).<br />
S. Teggi - Faccoltà<br />
di Ingegnneria<br />
<strong>–</strong> Università<br />
degli Studi di Modena e RReggio<br />
Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-099<br />
166
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
Le scatole lisimetriche sono costituite da un recipiente a tenuta che viene<br />
interrato alla profondità di 1-3 m e riempito di terreno fino a piano campagna. Il<br />
materiale drenante posto sul fondo permette di raccogliere le acque di<br />
infiltrazione e di valutare la componente verticale della permeabilità.<br />
I lisimetri passivi in sito consentono di non rimaneggiare il terreno in quanto<br />
vengono costruiti sul posto, generalmente sul lato di una trincea che viene<br />
successivamente colmata.<br />
Un altro esempio di è rappresentato dal lisimetro a tubo filtrante consistente in<br />
un tubo fenestrato che, posizionato orizzontalmente nel terreno ad una certa<br />
profondità, campiona l’acqua gravidica; in esso viene quindi applicata una<br />
depressione per il recupero del campione.<br />
5. Metodi di <strong>analisi</strong> 2<br />
5.1. Rivelazione<br />
Di solito i rivelatori misurano le variazioni di proprietà fisiche in un eluente, in<br />
presenza o assenza di un dato composto.<br />
I rivelatori universali sono in grado di determinare tutte (o quasi) le specie<br />
molecolari, però, proprio a causa della loro estrema genericità, sono solitamente<br />
poco sensibili. Passando a rivelatoti più selettivi, che possono quindi determinare<br />
2 Questo argomento è stato trattato anche in corsi precedenti<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
17
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
specifiche classi di sostanze, si ha un aumento di sensibilità, inoltre la maggiore<br />
selettività consente spesso di semplificare le procedure di preparazione<br />
(diminuiscono le possibilità di interferenza con altre sostanze). Anche in questo<br />
caso per gli approfondimenti si rimanda agli opportuni corsi.<br />
5.2. Scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong><br />
Per la determinazione <strong>dei</strong> parametri previsti dalla normativa, i CTN (Centri<br />
Tematici Nazionali) hanno sviluppato una guida tecnica contenente una raccolta<br />
di metodi ufficiali di <strong>analisi</strong>, ove esistenti, ed altri metodi riconosciuti e approvati<br />
da organismi internazionali.<br />
Per ogni parametro sono di solito indicati uno o più metodi di <strong>analisi</strong>, selezionati<br />
con i seguenti criteri:<br />
• la precedenza, come indicato nello stesso decreto, è stata data ai “Metodi<br />
Ufficiali di <strong>analisi</strong> chimica del suolo”, emanati con il DM 248 del 13<br />
settembre 1999, dove sono stati indicati i metodi per la determinazione del<br />
contenuto di cadmio, cobalto, cromo, rame, manganese, nichel, piombo e<br />
zinco;<br />
• sono stati successivamente presi in considerazione i metodi emessi da<br />
organismi ufficiali nazionali come UNICHIM, europei (CEN, UNI) e i metodi<br />
USEPA (United States Environmen/al Protection Agency), sia per la loro<br />
completezza, sia perché rimangono i metodi maggiormente utilizzati, anche<br />
in Italia, per la determinazione <strong>dei</strong> parametri organici. Per ciascun<br />
parametro sono fornite indicazioni sulle caratteristiche delle procedure di<br />
<strong>analisi</strong>, anche in relazione ai limiti di determinazione rispetto ai valori<br />
limite richiesti nel decreto.<br />
5.3. Composti inorganici<br />
I contaminanti inorganici sono presenti nei suoli in un ampio intervallo di<br />
concentrazioni. Normalmente la concentrazione totale di un elemento tossico è il<br />
primo parametro che fornisce informazioni sul livello di contaminazione.<br />
La forma chimica (speciazione), piuttosto che la concentrazione totale, è invece il<br />
parametro che meglio aiuta a valutare il grado di mobilità e di disponibilità<br />
dell’elemento tossico.<br />
La determinazione della concentrazione totale di un elemento può essere condotta<br />
sia mediante metodi diretti, per esempio attraverso l’<strong>analisi</strong> XRF (Spettroscopia di<br />
Fluorescenza a Raggi X), che indiretti.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
18
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
Questi ultimi prevedono una fase di estrazione acida (mineralizzazione) degli<br />
elementi dalla matrice (terreno) prima della loro quantificazione. Solo una<br />
mineralizzazione che porta ad una completa distruzione della matrice (ottenuta<br />
utilizzando anche acido fluoridrico) consente di determinare il contenuto totale di<br />
un dato metallo. Generalmente invece questa fase di solubilizzazione viene<br />
condotta con acidi forti concentrati o miscele degli stessi (come acido nitrico o<br />
acqua regia, una miscela di acido nitrico e acido cloridrico); in questo caso però si<br />
determina un concentrazione “pseudo totale”, in quanto non vengono estratti per<br />
esempio quei metalli legati ai silicati.<br />
Gli studi di speciazione sono invece condotti utilizzando agenti estraesti selettivi,<br />
come acetato d’ammonio, acido acetico, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico),<br />
le modalità con cui effettuare le prove e la scelta del tipo di estraente dipendono<br />
però dal lo scopo specifico dell’indagine e dal tipo di informazioni che si vogliono<br />
ottenere.<br />
5.4. Composti organici<br />
Mentre l’<strong>analisi</strong> inorganica riguarda principalmente un definito numero di<br />
elementi, quella organica, dato l’elevato numero <strong>dei</strong> composti coinvolti (la cui<br />
origine è quasi sempre antropica) e la complessisità delle miscele, richiede spesso<br />
due diversi tipi dì indagini:<br />
• individuazione <strong>dei</strong> composti presenti (speciazione, <strong>analisi</strong> qualitativa):<br />
• determinazione della quantità del singolo composto o di una miscela di<br />
composti (<strong>analisi</strong> quantitativa).<br />
L’<strong>analisi</strong> qualitativa può essere condotta utilizzando metodi analitici che<br />
consentano di confermare la presenza, ed eventualmente fornire indicazioni sulla<br />
quantità, di classi di composti come gli IPA, i TPH, i solventi clorurati e composti<br />
fenolici.<br />
Spesso queste tecniche forniscono delle valutazioni “totali” di una certa famiglia<br />
di composti, come nel caso <strong>dei</strong> TPH. Il termine totale, applicato ai composti<br />
organici, di solito significa che la tecnica analitica utilizzata non distingue tra<br />
composti simili. Tuttavia il termine totale può essere inesatto; è sempre possibile<br />
che alcuni composti possano non essere determinabili.<br />
L’identificazione <strong>dei</strong> singoli composti presenti in miscele complesse può essere<br />
effettuata con l’utilizzo di tecniche accurate come quelle cromatografiche (GC o<br />
HPLC — High Performance Liquid Chromatography) accoppiate a rivelatori a<br />
spettrometria di massa (MS). La cromatografia consente infatti di separare la<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
19
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
miscela in esame in singoli composti, mentre lo spettrometro di massa fornisce<br />
indicazioni sulla loro struttura molecolare, che ne consentono l’identificazione.<br />
L’<strong>analisi</strong> di COV presenta particolari difficoltà: varie ricerche hanno dimostrato<br />
che, anche in condizioni ideali di campionamento, trasporto e conservazione del<br />
campione, possono esserci perdite notevoli (>50%); inoltre differenti metodi di<br />
laboratorio (come Purge and Trap e spazio di testa) forniscono risultati<br />
sostanzialmente diversi. In questo caso i metodi in situ sono più utili nel fornire<br />
indicazioni sulla distribuzione e sulle concentrazioni delle sostanze d’interesse.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
20
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
5.5. Tabella riassuntiva delle tecniche di <strong>analisi</strong><br />
Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune fra le principali caratteristiche delle<br />
tecniche di <strong>analisi</strong> maggiormente utilizzate.<br />
Tecniche riportate nelle tabelle:<br />
spettrofotometria UV-visibile; spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS);<br />
spettrometria di assorbimento atomico a fornetto di grafite (GFAAS); spettrometria di<br />
assorbimento atomico con generazione di idruri (HG-AAS); spettrometria di assorbimento<br />
atomico a vapori freddi (CV-AAS); spettrometria di emissione atomica a plasma ad<br />
accoppiamento induttivo (ICP-AES); spettrometria di massa con sorgente a plasma (ICP-MS);<br />
gascromatografia (GC); gascromatografia <strong>–</strong> spettrometria di massa (GC-MS); cromatografia<br />
liquida (HPLC); cromatografia ionica (IC); polarografia a impulsi differenziale (DPP);<br />
potenziometria. spettrometria di assorbimento nell’infrarosso (IR e FT-IR).<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
21
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
22
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
5.6. Metodi di screening e di <strong>analisi</strong> di campo<br />
Il ruolo delle indagini in campo è quello di identificare e quantificare le sostanze<br />
“esotiche” presenti.<br />
I problemi che si possono incontrare durante queste indagini sono stanzialmente<br />
simili a quelli già descritti per le <strong>analisi</strong> di laboratorio e derivano principalmente<br />
dalla eterogeneità delle situazioni che si possono di volta in volta incontrare. Le<br />
principali variabili sono legate alla molteplicità delle possibili sostanze presenti e<br />
delle loro concentrazioni.<br />
Le varie tecniche possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:<br />
• tecniche routinarie di indagine chimica;<br />
• procedure di estrazione del campione;<br />
• tecniche analitiche per la misura di gas o che richiedono la presenza di una<br />
fase gassosa durante il processo analitico, se questa non fosse già presente;<br />
• luminescenza, spettrofotometria o altre tecniche spettroscopiche;<br />
• misure per via umida;<br />
• radiometria e altre tecniche;<br />
• elementi in traccia.<br />
Metodi di screening<br />
Il termine screening di campo è stato sempre più utilizzato in anni recenti per<br />
descrivere un’ampia varietà di metodi per la caratterizzazione chimica <strong>dei</strong> siti<br />
<strong>contaminati</strong>.<br />
Metodi analitici<br />
Questi metodi in campo comprendono tutti i metodi di <strong>analisi</strong> chimica in grado di<br />
fornire dati quantitativi specifici per i vari composti chimici, in condizioni di<br />
campo o comunque esterne al laboratorio.<br />
I metodi di screening e le tecniche analitiche in campo sono generalmente più<br />
rapide (minuti, ore) e meno costose delle <strong>analisi</strong> chimiche simili, condotte in<br />
laboratori con strumentazioni fisse (giorni).<br />
Di seguito sono brevemente riportati alcuni metodi di screening e tecniche<br />
analitiche in campo particolarmente utilizzate.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
23
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
Fotoionizzatori - Quantità totale di COV, solitamente come benzene<br />
equivalente<br />
- Non individuano i singoli composti<br />
Gas cromatografi<br />
(GC) portatili<br />
Sonde a fibre<br />
ottiche<br />
Assorbimento<br />
atomico<br />
Fluorescenza ai<br />
raggi X<br />
Cromatografia su<br />
strato sottile (TLC)<br />
Fluorimetria<br />
Elettrodi ioneselettivi<br />
Spettroscopia<br />
infrarossa<br />
Indicatori<br />
colorimetrici<br />
- Determinare di singoli composti organici volaili come<br />
benzene, toluene, xileni, benzina e solventi clorurati<br />
- Determinazione di idrocarburi (BTEX e IPA) e solventi<br />
clorurati in fase vapore,<br />
- Determinazione <strong>dei</strong> metalli<br />
- Determinazione <strong>dei</strong> metalli, in particolare piombo, zinco,<br />
rame, arsenico, ferro e cromo<br />
- Tecnica non distruttiva<br />
- Determinazione di molti SVOC<br />
- Permette la separazione <strong>dei</strong> composti<br />
- Determinazione <strong>dei</strong> composti aromatici, quindi IPA<br />
- Permette la separazione <strong>dei</strong> composti<br />
- Determinazione <strong>dei</strong> composti cloruralti, quindi PCB<br />
- Determinazione degli idrocarburi, TPH<br />
- Rivelazione di un gran numero di sostanze<br />
- Generalmente poco accurati<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
24
<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />
6. Documentazione di riferimento<br />
Di seguito è riportata la documentazione di riferimento utilizzata per la stesura di<br />
questi appunti e sulla quale si possono reperire maggiori informazioni sugli<br />
argomenti trattati:<br />
- Manuale per le indagini ambientali nei siti <strong>contaminati</strong> (APAT);<br />
- Linee guida per l’utilizzo di strumenti e la selezione di strategie di<br />
campionamento nelle matrici ambientali. (Provincia di Milano);<br />
- Proposta di guida tecnica sui metodi di <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>. (APAT);<br />
- Approvazione <strong>dei</strong> "Metodi ufficiali di <strong>analisi</strong> chimica del suolo". DM 248 del<br />
13 settembre 1999.<br />
- Pagine internet dell’ARPA Piemonte “Proposta di guida tecnica sui metodi di<br />
<strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>” (http://ctntes.arpa.piemonte.it/<br />
Raccolta%20Metodi%202003/home.htm).<br />
Tutti i documenti citati sono consultabili e prelevabili dalle pagine del materiale<br />
didattico del corso.<br />
S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />
25