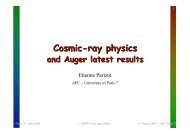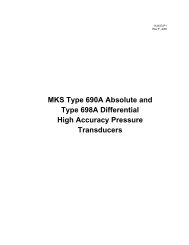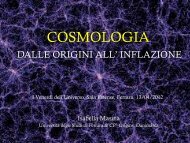Dimensione Acustica e Comunicazione Sonora - INFN Sezione di ...
Dimensione Acustica e Comunicazione Sonora - INFN Sezione di ...
Dimensione Acustica e Comunicazione Sonora - INFN Sezione di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I Venerdì dell’Universo 2012<br />
Dialogo nel buio:<br />
<strong>di</strong>mensione acustica e comunicazione sonora<br />
Roberto Pompoli<br />
roberto.pompoli@unife.it
Dialogo nel buio<br />
E’ un percorso nel buio assoluto con una guida molto particolare che<br />
insegna a muoversi nell’oscurità e a risvegliare gli altri sensi. La guida, il<br />
maestro invisibile, ma rassicurante, è un non vedente.<br />
Tra vedenti e non vedenti i ruoli si invertono, le barriere cadono. Il<br />
Dialogo nel buio non vincolato dall’apparire, dal giu<strong>di</strong>zio e dalla<br />
<strong>di</strong>scriminazione s’innalza, rivelandoci la realtà <strong>di</strong> chi non vede, <strong>di</strong>versa,<br />
ma non meno intensa del nostro mondo iper-visuale che sembra<br />
mascherare gli altri sensi.
Il dono oscuro<br />
John M. Hull - “Il dono oscuro: nel mondo <strong>di</strong> chi non vede - Garzanti<br />
“.. La cosa strana, comunque, era che si trattava <strong>di</strong> un mondo fatto <strong>di</strong><br />
azione e nient’altro. Ogni suono era prodotto da una sorgente in attività:<br />
dove non succedeva niente, invece, regnava il silenzio. A un tratto quella<br />
traccia <strong>di</strong> mondo è scomparsa, ha cessato <strong>di</strong> esistere ……..<br />
Il mondo acustico è un mondo dove ogni cosa prende e perde esistenza,<br />
in un alternarsi <strong>di</strong> sorprendente rapi<strong>di</strong>tà.<br />
Non posso impe<strong>di</strong>re che questi stimoli esterni mi sommergano e non<br />
posso far altro che starmene qui seduto…..<br />
Questa natura intermittente del mondo acustico è una delle sue<br />
caratteristiche più <strong>di</strong>stintive, perché nel mondo che viene percepito con<br />
la vista si incontrano, all’opposto, solo stabilità e continuità. Il mondo<br />
percepito attraverso la vista non può scomparire davanti ai tuoi occhi.
In ascolto<br />
“In ascolto” è una riflessione poetica e<br />
autobiografica sull’essenza e la<br />
consapevolezza del linguaggio,<br />
dell’acustica, della comunicazione e della<br />
comprensione da parte <strong>di</strong> una persona che<br />
vive in un mondo silenzioso e ha scoperto il<br />
suono del silenzio.<br />
Hannah Merker - In ascolto - Corbaccio E<strong>di</strong>tore -<br />
1992
Ascoltare- u<strong>di</strong>re / guardare-vedere<br />
All’inizio degli anni Settanta, a 39 anni, Hannah<br />
Merker è rimasta vittima <strong>di</strong> un incidente sulla<br />
neve che le ha provocato la per<strong>di</strong>ta totale e<br />
permanente dell’u<strong>di</strong>to.<br />
“In ascolto” è il resoconto commovente ed<br />
evocativo delle percezioni dell’autrice della<br />
per<strong>di</strong>ta e del ricordo del suono dopo l’incidente<br />
che ha causato la sua sor<strong>di</strong>tà.<br />
E’ la storia della sua esistenza ma anche un<br />
affascinante esame <strong>di</strong> cosa significhi sentire e<br />
<strong>di</strong> cosa sia un mondo improvvisamente immerso<br />
nel silenzio.
I sensi e la percezione del mondo esterno<br />
“Allegoria dei 5 sensi” [Theodor Rombouts XVII sec]
L’uomo comunica con il mondo esterno<br />
attraverso i sensi; convenzionalmente<br />
cinque:<br />
la vista,<br />
il gusto,<br />
il tatto,<br />
l’olfatto<br />
l’u<strong>di</strong>to.<br />
I sensi e la percezione del mondo esterno<br />
Il gusto e il tatto ci mettono in<br />
“contatto” con il mondo vicino, a<br />
“portata <strong>di</strong> mano”. La vista, l’olfatto e<br />
l’u<strong>di</strong>to con il mondo vicino e lontano.<br />
In tutti questi casi la comunicazione<br />
avviene attraverso uno scambio <strong>di</strong><br />
energia:<br />
elettromagnetica, chimica, termica,<br />
meccanica.
I “paesaggi sonori”<br />
E’ dunque l’u<strong>di</strong>to che ci permette <strong>di</strong><br />
ascoltare i suoni ed i rumori che sono<br />
presenti durante la giornata.<br />
I suoni e i rumori che accompagnano la<br />
nostra giornata, da quando ci alziamo a<br />
quando ci addormentiamo, descrivono<br />
l’”ambiente sonoro” o il “paesaggio sonoro”<br />
nel quale viviamo.<br />
Ciascuno <strong>di</strong> noi vive in un proprio paesaggio<br />
sonoro: chi vive in campagna è<br />
accompagnato da un paesaggio sonoro<br />
<strong>di</strong>verso da chi vive in città. E chi vive, per<br />
esempio, a Ferrara, avrà un paesaggio<br />
sonoro <strong>di</strong>verso da chi vive a Venezia, dove<br />
non ci sono auto ma solo imbarcazioni.
I “paesaggi sonori”<br />
Raymond Murray Schafer (Sarnia, Ontario,<br />
1933) musicista, compositore, scrittore ed<br />
ecologista canadese alla Simon Fraser<br />
University <strong>di</strong> Vancouver vara il World<br />
Soundscape Project, un innovativo progetto<br />
<strong>di</strong> ricerca sul paesaggio sonoro.<br />
In Schafer il paesaggio sonoro è letto in<br />
chiave fortemente estetica, "mira cioè<br />
ad insegnarci a porgere l'orecchio ai<br />
rumori del mondo, come se fossero<br />
un'enorme composizione musicale" : il<br />
senso <strong>di</strong> identità <strong>di</strong> un luogo è colto a<br />
partire dal suo patrimonio sonoro, nel<br />
quale si riflettono usi, tra<strong>di</strong>zioni,<br />
sensibilità, bisogni <strong>di</strong> tutta la comunità.
I “paesaggi sonori contemporanei”
I “paesaggi sonori” nell’antichità<br />
Lucio Anneo Seneca<br />
miniatura spagnola del secolo XIV<br />
Lucio Anneo Seneca<br />
(4 a.C - 65 d.C)<br />
“Lettere a Lucilio”<br />
Vol. Primo - Lettera 56<br />
“Non il silenzio esterno, ma il placarsi delle<br />
passioni dà la vera quiete”
I “paesaggi sonori nell’antichità”<br />
“Che io muoia, se il silenzio è tanto<br />
necessario,come sembra, al raccoglimento e<br />
allo stu<strong>di</strong>o.<br />
Ecco, mi circonda da ogni parte un chiasso<br />
in<strong>di</strong>avolato: abito proprio sopra uno<br />
stabilimento balneare.<br />
Immaginati ora ogni sorta <strong>di</strong> voci che<br />
possano frastornare le orecchie. Quando i<br />
campioni si allenano a sollevare palle <strong>di</strong><br />
piombo e si affaticano o fingono <strong>di</strong><br />
affaticarsi, io li sento gemere; e ogni volta<br />
che mettono fuori il fiato trattenuto, sento<br />
i sibili del loro respiro affannato.
I “paesaggi sonori nell’antichità”<br />
“Quando capita qualcuno più pigro, che si<br />
contenta <strong>di</strong> una comune frizione, io sento la<br />
mano che fa massaggi sulle spalle, con un<br />
suono <strong>di</strong>verso secondo che si muova aperta<br />
o concava. Se poi sopraggiungono coloro che<br />
giocano a palla e cominciano a contare i<br />
punti, è finita.<br />
Aggiungi ora l’attaccabrighe o il ladro colto<br />
sul fatto, o quello a cui piace sentire la<br />
propria voce durante il bagno: poi il<br />
fracasso provocato da quelli che saltano<br />
nella piscina”.
I “paesaggi sonori nell’antichità”<br />
“Oltre a questi, le cui voci, se non<br />
altro, sono normali, pensa al<br />
depilatore, che, per farsi notare,<br />
parla in falsetto e non sta mai zitto,<br />
se non quando depila le ascelle e<br />
costringe un altro a urlare in sua<br />
vece.<br />
Infine c’è il ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> bibite, con<br />
le sue esclamazioni sempre <strong>di</strong>verse,<br />
il salsicciaio e il pasticciere e tutti i<br />
garzoni delle bettole, ciascuno dei<br />
quali, per vendere i suoi prodotti, ha<br />
una caratteristica inflessione della<br />
voce”.
I “paesaggi sonori nell’antichità”<br />
“E che dunque? Non è meglio liberarsi una buona volta <strong>di</strong> tutto questo<br />
schiamazzo?” D’accordo: perciò lascerò questo luogo. Ho voluto mettere alla<br />
prova me stesso; ma ora perché dovrei continuare questo tormento, quando<br />
c’è un rime<strong>di</strong>o così facile, escogitato da Ulisse per i suoi compagni contro le<br />
stesse Sirene? Ad<strong>di</strong>o.
Peter Ackroyd<br />
“Londra: Biografia <strong>di</strong> una città<br />
E<strong>di</strong>zioni Frassinelli 2004<br />
I “paesaggi sonori” nella letteratura<br />
Cap.4: Un rumore perenne<br />
“..Un duca tedesco arrivò a Londra il 12<br />
Settembre 1602 e fu stupito dalla singolare<br />
caratteristica dei rumori della città > [The acoustic world<br />
of early modern england- Bruce R. Smith]
Dino Buzzati<br />
(1906 - 1972)<br />
I “paesaggi sonori” nella letteratura<br />
Suoni, rumori e silenzi nel<br />
romanzo <strong>di</strong> Dino Buzzati<br />
“Il deserto dei Tartari”<br />
Franca Longhini - Roberto Pompoli<br />
XXIV° Convegno Nazionale<br />
Associazione Italiana <strong>di</strong> <strong>Acustica</strong><br />
Trento, 12 - 14 Giugno 1996
I “paesaggi sonori” nella pittura<br />
“Il grido” 1883<br />
Edvard Munch 1863-1944<br />
“Rumore notturno” 1919<br />
Georg Sholz
<strong>Comunicazione</strong> sonora, voce e parola<br />
Soffermiamoci a riflettere sull’importanza della parola nella vita<br />
familiare e sociale <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> noi. Pensiamo a quanto tempo della<br />
nostra giornata trascorriamo a parlare ed ad ascoltare; a quante<br />
informazioni ci scambiamo attraverso questa via <strong>di</strong> comunicazione.<br />
Pensiamo al pro<strong>di</strong>gio della parola e del suo ascolto. Forse l’uso della<br />
parola è il carattere <strong>di</strong>stintivo dell’uomo in tutto il regno animale.<br />
Nella vita quoti<strong>di</strong>ana esistono molte cause che possono compromettere<br />
questa comunicazione e che riguardano la sorgente, la trasmissione o<br />
l’ascolto.<br />
Ogni impe<strong>di</strong>mento nella trasmissione dei segnali emessi dalla sorgente<br />
sonora che raggiungono l’ascoltatore costituiscono una barriera acustica<br />
che potrà essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso tipo: un rumore che interferisce nell’ascolto<br />
<strong>di</strong> un messaggio sonoro ( mascheramento), un ambiente dalle<br />
caratteristiche acustiche non idonee, una per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva,…...
<strong>Comunicazione</strong> sonora e voce<br />
ll Pianto: la forma <strong>di</strong> “voce” più semplice,<br />
innata. Sappiamo piangere senza che<br />
nessuno ce lo abbia insegnato ( come<br />
succhiare il latte, respirare, muovere le<br />
mani, ecc).<br />
E’ con questo pianto, quasi un urlo, che<br />
<strong>di</strong>ciamo al mondo intero: sono arrivato!!<br />
Adesso ci sono anch’io! Sono qui!<br />
E’ la nostra prima comunicazione con il<br />
mondo.<br />
E il pianto sarà per molti mesi l’unico modo<br />
<strong>di</strong> comunicare con gli altri.
<strong>Comunicazione</strong> sonora e parola<br />
E’ attraverso la parola che ciascuno <strong>di</strong> noi <strong>di</strong>aloga con gli altri. E’ con la<br />
parola che esprimiamo i nostri desideri, le nostre idee e necessità, i<br />
nostri sentimenti. La gioia, il dolore, la felicità, la tristezza, la paura, ecc.<br />
Ma è anche ascoltando le parole degli altri che entro in comunicazione con<br />
loro: conosco i loro pensieri, i loro sentimenti, le loro idee, ecc.<br />
Ascoltando la lettura <strong>di</strong> un libro entro<br />
in contatto con i pensieri <strong>di</strong> chi ha<br />
scritto quel libro. Una persona che non<br />
conosco, che vive lontano e che forse è<br />
vissuto tanti anni fa.
Parola e scrittura<br />
L’invenzione del romanzo: dall’oralità alla<br />
lettura silenziosa – Rosamaria Loretelli -<br />
Laterza E<strong>di</strong>tore<br />
“Il romanzo non esiste da sempre, ma è una forma<br />
narrativa che è stata “inventata” quando nel<br />
mondo occidentale si è <strong>di</strong>ffusa stabilmente la<br />
lettura silenziosa.<br />
E’ stato allora ( nel settecento) che è comparso il<br />
romanzo, che per la prima volta ha delegato alle<br />
sole parole stampate tutto il carico <strong>di</strong> significato<br />
che la lettura ad alta voce precedentemente<br />
affidava anche all’espressività dei toni, delle<br />
pause, e dei gesti.
Effetti del rumore: <strong>di</strong>sturbo e danno<br />
La definizione più accettata <strong>di</strong> rumore è quella <strong>di</strong> “suono non<br />
voluto”: occorre precisare che un suono può essere non voluto per il<br />
contenuto <strong>di</strong> informazioni che trasporta e per le caratteristiche<br />
fisiche che lo caratterizzano.<br />
Molto semplicemente si può <strong>di</strong>re che gli effetti del rumore possono<br />
essere <strong>di</strong> “<strong>di</strong>sturbo” e/o <strong>di</strong> “danno”<br />
Mentre è abbastanza facile valutare gli effetti <strong>di</strong> “danno”<br />
funzionale all’apparato u<strong>di</strong>tivo ( con una au<strong>di</strong>ometria, per esempio),<br />
più <strong>di</strong>fficile è valutare il “<strong>di</strong>sturbo”.<br />
Il danno da rumore produce per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva che determina poi<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> relazione interpersonale e isolamento.<br />
Danno e <strong>di</strong>sturbo del rumore sono il prodotto dell’inquinamento<br />
acustico
Inquinamento sonoro<br />
E’ vero inquinamento?
Trasmissione del suono in un ambiente chiuso<br />
S<br />
L’“<strong>Acustica</strong>” <strong>di</strong> una sala è la qualità che la rende più o meno idonea all’ascolto<br />
<strong>di</strong> un messaggio sonoro (parola o musica).<br />
L’acustica <strong>di</strong> una sala è un “bene culturale”<br />
A<br />
Fig. 16
Trasmissione del suono in un ambiente chiuso<br />
L’ “ecogramma” descrive in modo<br />
particolarmente efficace l’acustica <strong>di</strong><br />
una sala<br />
L’ascoltatore riceve inizialmente il<br />
“suono <strong>di</strong>retto” , successivamente le<br />
onde riflesse provenienti dalle sorgenti<br />
immaginarie via via più lontane.<br />
Queste riflessioni sono caratterizzate<br />
da una minore intensità dovuta sia al<br />
maggior percorso sia alla attenuazione<br />
che subiscono per l’impatto sulle pareti.<br />
Ecogramma
Trasmissione del suono in un ambiente chiuso<br />
Ecogramma<br />
In una grande sala, il numero <strong>di</strong> riflessioni che<br />
arrivano dopo i primi 80-100 ms è così elevato e <strong>di</strong><br />
debole intensità che non sono più <strong>di</strong>stinguibili: in un<br />
secondo arrivano circa 8000 riflessioni.<br />
NB: Per ogni posizione della sorgente e<br />
dell’ascolatore sarà definito uno specifico<br />
ecogramma.<br />
Le riflessioni che arrivano dopo 80-100 ms<br />
definiscono il “campo riverberante”: il suo<br />
deca<strong>di</strong>mento descrive il “Tempo <strong>di</strong><br />
riverberazione”. Quelle che arrivano prima<br />
definiscono il campo delle “Prime riflessioni” o<br />
“Riflessioni precoci” o “Riflessioni utili”.
Trasmissione del suono in un ambiente chiuso<br />
La figura evidenzia come ogni riflessione sia caratterizzata da un suo<br />
tempo <strong>di</strong> ritardo, una intensità ed è associata ad una specifica <strong>di</strong>rezione<br />
<strong>di</strong> provenienza.<br />
Onda <strong>di</strong>retta<br />
DTo<br />
DT1<br />
DTi<br />
Prima riflessione I1, DT1, q1<br />
Onda riflessa Ii, DTì, qi<br />
S<br />
S’<br />
Suono riflesso<br />
Il nostro u<strong>di</strong>to è particolarmente selettivo nell’interpretare questa<br />
ricchezza <strong>di</strong> informazioni.<br />
qi<br />
R
Modello semplice per la descrizione del suono in<br />
una sala<br />
Gli esperti si formano un giu<strong>di</strong>zio<br />
sull’acustica <strong>di</strong> una sala “a orecchio”<br />
ascoltando la risposta dell’ambiente<br />
causata da una battuta <strong>di</strong> mani.<br />
Corta Lunga<br />
E’ un suono<br />
piuttosto<br />
lungo…………..<br />
…..4 secon<strong>di</strong>???
La fenomenologia<br />
L’energia sonora della battuta <strong>di</strong> mani<br />
viaggia lungo molti cammini alla velocità del<br />
suono rimbalzando sui confini della sala.<br />
Pacchetti <strong>di</strong> energia raggiungono<br />
l’ascoltatore. Più lungo è il cammino<br />
percorso maggiore è il loro ritardo e la loro<br />
attenuazione.<br />
La sequenza e le <strong>di</strong>rezioni <strong>di</strong> arrivo dei<br />
pacchetti <strong>di</strong> energia sonora che giungono<br />
all’ascoltatore sono responsabili<br />
dell’impressione acustica della sala.
La risposta all’impulso<br />
La tecnologia moderna permette<br />
una misura oggettiva dell’ “impronta<br />
<strong>di</strong>gitale acustica” della trasmissione<br />
del suono tra il punto sorgente<br />
(battuta <strong>di</strong> mano) ed il punto<br />
ricevente (orecchio) in una sala.<br />
Il tracciato della pressione<br />
sonora nel tempo somiglia<br />
ad un albero <strong>di</strong> Natale<br />
rovesciato su un fianco.
Il quadrato della risposta all’impulso è una “buona<br />
rappresentazione” della sequenza <strong>di</strong> pacchetti <strong>di</strong> energia<br />
sonora che raggiungono l’ascoltatore.<br />
QUADRATO<br />
SIMILE
Due risposte all’impulso nel S. Carlo: appaiono e “suonano” <strong>di</strong>versamente<br />
p(t)<br />
p(t)
Chiaro<br />
e<br />
Spazioso<br />
Giu<strong>di</strong>zi<br />
soggettivi<br />
Forte<br />
e<br />
Vivo<br />
Intenso<br />
e<br />
Avviluppante<br />
Potente<br />
e<br />
Piacevole<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> laboratorio ed in campo hanno<br />
prodotto correlazioni tra <strong>di</strong>versi aspetti<br />
soggettivi dell’esperienza u<strong>di</strong>tiva in teatri e<br />
sale da concerto e parametri oggettivi<br />
ottenibili dalle risposte all’impulso misurate<br />
nelle sale.
Chiarezza<br />
La chiarezza della voce del<br />
cantante e della musica è un<br />
carattere acustico dominante nei<br />
teatri all’italiana. La chiarezza si<br />
riferisce a quanto <strong>di</strong>stintamente<br />
sono percepite note e parole in<br />
successione rapida.<br />
Utile per la parola<br />
Utile per la musica<br />
I descrittori oggettivi della chiarezza<br />
sono basati sul rapporto tra un’energia<br />
utile iniziale della risposta energetica ed<br />
una energia non utile per la chiarezza.
Chiarezza della voce: D (%) Desiderabile: D > 45 % -50 %<br />
D = 51 %<br />
D = 62 %<br />
D = 50%<br />
D = 66 %
Tempo <strong>di</strong> riverberazione<br />
La “vivezza” è legata alla durata del<br />
suono che segue una battuta <strong>di</strong> mani.<br />
Una dose corretta <strong>di</strong> vivezza<br />
“abbellisce” la musica e contribuisce<br />
alla sensazione <strong>di</strong> essere in una sala<br />
piuttosto che all’aperto.<br />
Descrittori oggettivi della vivezza<br />
sono il tempo <strong>di</strong> riverberazione RT<br />
ed il tempo <strong>di</strong> deca<strong>di</strong>mento iniziale<br />
EDT. Sono ottenuti dalla<br />
registrazione del deca<strong>di</strong>mento del<br />
livello sonoro dopo l’interruzione <strong>di</strong><br />
una sorgente <strong>di</strong> rumore nella sala o<br />
dalla risposta all’impulso.<br />
Usualmente, la vivezza nei teatri<br />
all’italiana è moderata. Il San Carlo è<br />
appena deficitario rispetto alla<br />
vivezza <strong>di</strong> teatri dello stesso stile e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni paragonabili.
La figura mostra un segnale<br />
sonoro come successione <strong>di</strong><br />
suoni <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa ampiezza e<br />
durata, intervallati da pause:<br />
rappresenta sia la voce sia la<br />
musica.<br />
Si noti, per esempio, che nel<br />
caso della voce l’intervallo tipico<br />
tra i suoni è <strong>di</strong> circa 4-5 suoni al<br />
secondo (4-5 Hz).<br />
Parole e musica
Riverberazione e segnali impulsivi<br />
Quando questi segnali, <strong>di</strong> tipo impulsivo, si trasmettono in un<br />
ambiente chiuso, vengono riflessi dalle pareti e subiscono gli effetti<br />
della “riverberazione”. Come si vede da queste figure ciascun suono si<br />
prolunga nel tempo con una pendenza che è data dal proprio tempo <strong>di</strong><br />
riverberazione.<br />
La figura mostra due riverberazioni: una bassa ed una più elevata. La prima<br />
(a) produce una elevata chiarezza dei segnali percepiti, la seconda (b)<br />
tende invece a mascherarli rendendo <strong>di</strong>fficile e confusa la comprensione:<br />
specialmente nel caso della voce.
Vivezza: RT (s) Desiderabile : 1,4 < RT < 1,6 s<br />
RT = 1,0 s<br />
RT = 1,0 s<br />
RT = 1,0 s<br />
RT =1,0 s
L’intensità percepita è l’attributo<br />
soggettivo corrispondente alla<br />
sensazione <strong>di</strong> quanto un suono è<br />
percepito forte o debole. Una sala<br />
può rinforzare l’intensità della voce<br />
e della musica rispetto alla stessa<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> sorgenti e ricevitori<br />
all’aperto.<br />
Il descrittore oggettivo G (In<strong>di</strong>ce della<br />
robustezza del suono) è basato sul<br />
livello sonoro causato da una sorgente<br />
non <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong> potenza nota.<br />
Suono percepito<br />
più debole<br />
Suono percepito<br />
più forte
Intensità della voce: G (dB) Desiderabile: G > 0 dB<br />
G = - 3,7 dB<br />
G = - 1,1 dB<br />
G = - 1,3 dB<br />
G = - 0,3 dB
Intensità della musica: G (dB) Desiderabile: G > 0 dB<br />
G = - 1,0 dB<br />
G = 1,6 dB<br />
G = - 1,2 dB<br />
G = - 0,1 dB
Equilibrio tra la voce del cantante e<br />
la musica dell’orchestra nella buca<br />
E’ una con<strong>di</strong>zione percettiva per la quale<br />
l’ascoltatore ha l’impressione che la voce<br />
del cantante gli giunge con una intensità<br />
“giusta” rispetto all’intensità della<br />
musica prodotta dall’orchestra nella<br />
buca.<br />
L’equilibrio <strong>di</strong>pende specialmente delle<br />
superfici intorno al palcoscenico ed<br />
alla fossa.<br />
Per quanto possibile, l’equilibrio è<br />
anche sotto il controllo del <strong>di</strong>rettore<br />
<strong>di</strong> orchestra.<br />
I compositori avevano in mente l’acustica<br />
dei teatri e,forse, tenevano conto - in un<br />
certo grado - degli effetti acustici che<br />
potevano esitare nella concomitanza del<br />
canto con la musica orchestrale.<br />
I parametri che descrivono<br />
l’equilibrio relativo al solo teatro<br />
sono basati sulla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />
valore <strong>di</strong> G quando una sorgente è<br />
posta sul palco e quello <strong>di</strong> G quando<br />
una sorgente che emette la stessa<br />
potenza sonora è posta nella fossa.
Equilibrio tra la voce del cantante e la musica dell’orchestra nella fossa<br />
Desiderabile: D = G cantante – G fossa ≈ 0 dB<br />
D = - 2,7 dB<br />
D = - 2,7 dB<br />
D = - 0,1 dB<br />
D = - 0,2 dB
La Spazialità è una qualità del suono elusiva.<br />
L’esperienza u<strong>di</strong>tiva evoca una sensazione <strong>di</strong><br />
spazio e <strong>di</strong>mensione. La mancanza <strong>di</strong> questa<br />
qualità in una sala è descritta come “......guardare<br />
all’evento da una finestra piuttosto che sentirsi<br />
all’interno dell’evento.”.<br />
Sono stati evidenziati due aspetti:<br />
l’Ampiezza apparente della sorgente<br />
ASW e l’Avviluppamento dell’ascoltatore<br />
LEV. Con una buona ASW la sorgente<br />
appare più estesa <strong>di</strong> quanto è giu<strong>di</strong>cata “ad<br />
occhio”. Un buon LEV suggerisce un senso<br />
<strong>di</strong> immersione nel suono.<br />
Descrittori <strong>di</strong> ASW sono:<br />
LF (Frazione laterale) e IACC<br />
(Coefficiente <strong>di</strong> correlazione mutua interaurale).
ASW per la musica: LF Desiderabile: LF > 0,15 – 0,20<br />
LF = 0,08<br />
LF = 0,09<br />
LF = 0,06<br />
LF = 0,19
ASW per la musica: LF Desiderabile: LF > 0,15 – 0,20<br />
LF = 0,10<br />
LF = 0,04<br />
LF = 0,01<br />
LF = 0,01
I gran<strong>di</strong> teatri concepiti nella<br />
tra<strong>di</strong>zione dei teatri all’italiana: il<br />
San Carlo a Napoli (1737) La Scala a<br />
Milano (1778), La Fenice a Venezia<br />
(1792), ed altri configurati nella<br />
stessa forma, hanno caratteri<br />
acustici generali non molto <strong>di</strong>ssimili.<br />
Tutti con<strong>di</strong>vidono qualche carenza<br />
visiva ed acustica.<br />
Teatro alla Scala<br />
Teatro <strong>di</strong> San Carlo<br />
Teatro La Fenice
Una caratteristica buona<br />
I parapetti, le colonne,<br />
gli stucchi, i rilievi ed<br />
altri ornamenti<br />
producono una<br />
<strong>di</strong>ffusione del suono<br />
rinviato verso la sala che<br />
è ritenuta un ingre<strong>di</strong>ente<br />
importante della<br />
piacevolezza acustica<br />
quando si assiste<br />
all’opera in teatri<br />
all’italiana.
Effetti <strong>di</strong> focalizzazione<br />
Come altri teatri dello stesso stile, il San<br />
Carlo è affetto da fenomeni <strong>di</strong><br />
focalizzazione a causa della curvatura delle<br />
pareti. Il suono iniziale tende ad accumularsi<br />
verso il fondo della sala. Ciò produce<br />
concentrazioni spaziali del suono ed il rischio<br />
<strong>di</strong> eco u<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> ritorno sul palcoscenico.<br />
Spostando la sorgente verso la parete<br />
laterale la concentrazione si accentua dando<br />
luogo ad una sorta <strong>di</strong> effetto <strong>di</strong> “galleria che<br />
sussurra”.
Il suono in un palco<br />
I palchetti come camerini separati<br />
sono tipici in <strong>di</strong>versi teatri all’italiana.<br />
Gli spettatori che non siedono in<br />
prossimità del parapetto soffrono <strong>di</strong><br />
inconvenienti per la visione e l’ascolto.<br />
Percepiscono un suono più debole e<br />
confuso.<br />
dB<br />
5<br />
3<br />
1<br />
-1<br />
-3<br />
-5<br />
-7<br />
-8<br />
-0.3<br />
2.1<br />
-4.3<br />
-0.1<br />
-7.0<br />
G<br />
C80<br />
-1.59<br />
Avanti In mezzo Dietro
Il teatro allìtaliana è stato un modello che ha ispirato i teatri costruiti in<br />
Italia ed in <strong>di</strong>verse parti del mondo, fin oltre l’inizio del ‘900.<br />
Teatro Argentina<br />
Roma (1732)<br />
Operà Garnier<br />
Parigi (1875)<br />
Semperoper<br />
Dresda (1838-41)<br />
Opera <strong>di</strong> Stato<br />
Vienna (1869)<br />
Teatro Colòn<br />
Buenos Aires (1904)<br />
Royal Opera House<br />
Londra (1732)
<strong>Acustica</strong> come bene culturale<br />
14-16 Ottobre 1996 – Teatro Regio<br />
<strong>di</strong> Torino – Convegno Internazionale<br />
“L’<strong>Acustica</strong> come bene culturale”<br />
4 Novembre 1998 – Ferrara –<br />
L’acustica dei teatri storici: un bene<br />
culturale”<br />
“Linee guida per le misurazioni<br />
dell’acustica dei teatri d’opera<br />
storici”<br />
“Carta <strong>di</strong> Ferrara: per la<br />
tutela, valorizzazione e<br />
fruizione del patrimonio<br />
acustico dei teatri storici<br />
italiani”
<strong>Acustica</strong> come bene culturale<br />
Spaces peack, are you listening?<br />
Experienging aural architecture<br />
Barry Blesser – Linda Ruth Salter<br />
MIT Press.<br />
“We experience spaces not only by seing<br />
but also by listening. We can navigate a<br />
room in the dark, and hear the<br />
emptiness of a house without furniture.<br />
Our experience of music in a concert<br />
hall depends on wether we sit in the<br />
front row or in the balcony. The unique<br />
acoustics of religious spaces acquire<br />
symbolic meaning. Social relationships<br />
are strongly influenced by the way that<br />
space changes sound.”
Le aule scolastiche<br />
Scuola Giovanni Pascoli (FE)
Le aule scolastiche<br />
Scuola Alda Costa (FE)
Le aule scolastiche<br />
Il Laboratorio <strong>di</strong> acustica del Dipartimento <strong>di</strong> ingegneria
Ma poi, è proprio così importante l’acustica?<br />
Come <strong>di</strong>menticare la “poetica” del palco?<br />
“Capitata nella fila delle carrozze, la carrozza dei<br />
Rostov si avvicinò lentamente al teatro, facendo<br />
stridere le ruote sulla neve. Natasa e Sonja<br />
balzarono fuori in fretta, tenendosi i vestiti;<br />
scese il conte, sostenuto dai servitori, e, fra le<br />
signore e gli uomini che entravano e i ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong><br />
programmi, tutti e tre penetrarono nel corridoio<br />
dei palchi <strong>di</strong> prim’or<strong>di</strong>ne. Dietro alle porte chiuse<br />
già si u<strong>di</strong>vano i suoni della musica.<br />
La maschera passò rispettosamente e in fretta<br />
davanti alle signore e aprì la porta del palco. La<br />
musica si udì più <strong>di</strong>stintamente, attraverso la<br />
porta aperta balenarono le file dei palchi<br />
illuminati, pieni <strong>di</strong> signore con le spalle e le<br />
braccia nude, e la platea rumorosa e scintillante<br />
<strong>di</strong> uniformi. Una signora che entrava nel palco<br />
vicino guardò Natasa con uno sguardo <strong>di</strong> invi<strong>di</strong>a<br />
femminile.<br />
The Bolshoi (Stone) Theatre<br />
on Carousel Square, designed by<br />
the architect Antonio Rinal<strong>di</strong>
Il sipario non s’era ancora alzato e<br />
intanto suonavano il prelu<strong>di</strong>o. Natasa<br />
entrò, accomodandosi il vestito,<br />
insieme con Sonja e sedette,<br />
guardando le file illuminate dei palchi<br />
<strong>di</strong> faccia.<br />
La sensazione, che da molto tempo ella non aveva provata, <strong>di</strong> sapere le sue<br />
braccia nude e il suo collo guardati da centinaia <strong>di</strong> persone, la prese a un<br />
tratto, piacevole e spiacevole insieme, richiamando un intero sciame <strong>di</strong><br />
ricor<strong>di</strong>, <strong>di</strong> desideri e <strong>di</strong> emozioni, attinenti a quella sensazione. …….. I suoi<br />
occhi neri guardavano la folla senza cercarvi nessuno e il suo braccio sottile.<br />
nudo fin sopra il gomito, era appoggiato al parapetto <strong>di</strong> velluto, mentre la<br />
sua mano, certo inconsciamente, a seconda del tempo del prelu<strong>di</strong>o, ora si<br />
stringeva, ora si apriva, sgualcendo il programma.<br />
-Guarda, l’Alenina, con la madre, mi pare – <strong>di</strong>sse Sonja.<br />
-Caspita! Michail Kirìlyc è ancora ingrassato, - <strong>di</strong>sse il vecchio conte.<br />
(Guerra e pace – Lev Tolstoj – cap VII – Einau<strong>di</strong> ed. – Trad. Enrichetta<br />
Carafa d’Andria)
L’U<strong>di</strong>to<br />
L’u<strong>di</strong>to è il senso che ci permette <strong>di</strong> comunicare con il mondo esterno<br />
grazie al trasferimento <strong>di</strong> energia meccanica trasportata dal suono.<br />
E’ attraverso il suono che percepiamo la presenza della sorgente, delle<br />
sue caratteristiche e della sua posizione: è ancora il suono che ci<br />
informa su situazioni piacevoli o pericolose, ecc.<br />
Il suono esiste solo nel momento in cui viene prodotto: poi si estingue<br />
rapidamente. Una sorgente sonora “esiste” solo nel momento in cui<br />
produce un segnale.<br />
Tutta la nostra vita è accompagnata da suoni e rumori. Senza<br />
interruzione: giorno e notte. Anche <strong>di</strong> notte continuiamo a percepire<br />
suoni e rumori. Solo la soglia <strong>di</strong> velia si è innalzata: ma basta un rumore<br />
un po’ più intenso per svegliarci.<br />
Moltissime informazioni che provengono dal mondo esterno ci giungono<br />
dunque attraverso l’u<strong>di</strong>to. E’ grazie all’u<strong>di</strong>to che può avvenire la<br />
comunicazione sonora
Il para<strong>di</strong>gma della comunicazione sonora<br />
In ogni sistema <strong>di</strong> comunicazione<br />
si possono <strong>di</strong>stinguere una<br />
“Sorgente”, una “Linea <strong>di</strong><br />
trasmissione” e un “Ascoltatore”<br />
La Sorgente è il luogo in cui si<br />
genera la comunicazione e quin<strong>di</strong><br />
l’informazione che si vuole<br />
trasmettere. L’informazione è in<br />
pratica energia, variabile nel tempo<br />
e in intensità, ma or<strong>di</strong>nata secondo<br />
un certo co<strong>di</strong>ce.<br />
La Trasmissione avviene nel mezzo<br />
acustico ( la materia) che deve<br />
esserci per poter parlare <strong>di</strong><br />
trasferimento <strong>di</strong> energia sonora.<br />
Nell’ Ascoltatore avviene la<br />
trasformazione dell’energia sonora<br />
in “percezione u<strong>di</strong>tiva” e la<br />
deco<strong>di</strong>fica del segnale <strong>di</strong> partenza