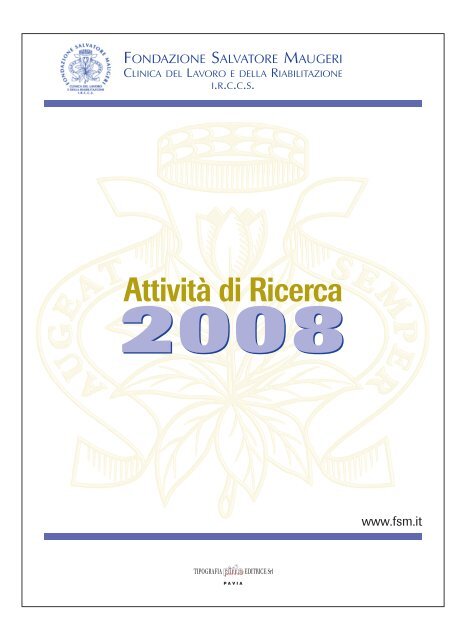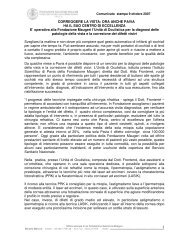Introduzione - Fondazione Salvatore Maugeri
Introduzione - Fondazione Salvatore Maugeri
Introduzione - Fondazione Salvatore Maugeri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI<br />
CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE<br />
I.R.C.C.S.<br />
Attività di Ricerca<br />
2008<br />
pime<br />
pime<br />
TIPOGRAFIA EDITRICE Srl<br />
PAVIA<br />
www.fsm.it
Elaborazione computerizzata del testo<br />
e della copertina a cura<br />
della Direzione Scientifica<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
IRCCS - Pavia<br />
Fotolito e stampa:<br />
Tipografia PI-ME Editrice S.r.l.<br />
27100 Pavia - Via Vigentina 136 A<br />
Tel. 0382.572169 - Fax 0382.572102<br />
E-mail: tipografia@pime-editrice.it<br />
www.pime-editrice.it
Indice<br />
<strong>Introduzione</strong> ........................................................................................................................................................................................................ 5<br />
La <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> .................................................................................................................................................................... 5<br />
Direzione Scientifica ............................................................................................................................................................................................... 6<br />
Il Centro Studi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> ............................................................................................................................................ 7<br />
Attività di Ricerca Scientifica .............................................................................................................................................................................. 15<br />
I Laboratori di Ricerca Sperimentale................................................................................................................................................................. 16<br />
Centro Studi e Ricerche ISPESL.......................................................................................................................................................................... 115<br />
Attività dei Dipartimenti.......................................................................................................................................................................................... 116<br />
I Libri della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> .................................................................................................................................................... 131<br />
Le Riviste della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> ............................................................................................................................................ 135<br />
Progetti di Ricerca Finalizzata ............................................................................................................................................................................. 136<br />
Clinical Trials Prospettici, Ricerche Multicentriche, Attività di Prevenzione, Osservatori Epidemiologici ............................. 138<br />
Redazione e Pubblicazione di Linee Guida e Protocolli Diagnostici e Terapeutici a Livello Internazionale e Nazionale .... 147<br />
Convenzioni e Collaborazioni della <strong>Fondazione</strong> con l’Università .......................................................................................................... 150<br />
Attività con altri Enti mediante partecipazione consortili o societarie ................................................................................................ 157<br />
Collaborazioni Scientifiche a Livello Internazionale e Nazionale .......................................................................................................... 159<br />
Convenzioni Operative con i Servizi Pubblici di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ....................................................... 179<br />
Convenzioni Operative con i Servizi Pubblici per l’Emergenza .............................................................................................................. 180<br />
Congressi Organizzati nel 2007 .......................................................................................................................................................................... 182<br />
Professori a Contratto ............................................................................................................................................................................................ 186<br />
Consuntivo dell’Attività Scientifica 2007 ......................................................................................................................................................... 190<br />
Istituti Scientifici (IRCCS) della <strong>Fondazione</strong> ......................................................................................................................... 191<br />
Istituto Scientifico di Pavia - Sede di Via <strong>Maugeri</strong> ...................................................................................................................................... 192<br />
Istituto Scientifico di Pavia - Sede di Via Boezio ......................................................................................................................................... 212<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Veruno .............................................................................................................................................. 215<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Montescano ................................................................................................................................... 223<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Cassano ........................................................................................................................................... 231<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Lumezzane ..................................................................................................................................... 237<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Telese-Campoli ............................................................................................................................. 243<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Genova-Nervi ................................................................................................................................ 249<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Tradate ............................................................................................................................................. 251<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Castel Goffredo ............................................................................................................................. 255<br />
Centro di Ricerche Ambientali - Padova ........................................................................................................................................................ 259<br />
Centro di Milano ...................................................................................................................................................................................................... 261<br />
Centro di Igiene Ambientale - Cassano Murge ........................................................................................................................................... 262<br />
Nuovi Progetti di Ricerca ........................................................................................................................................................................ 263<br />
Progetti di Ricerca in Corso di Svolgimento ......................................................................................................................... 431<br />
Pubblicazioni Scientifiche ...................................................................................................................................................................... 559<br />
Biblioteche della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> ....................................................................................................................................... 903<br />
Indice dei Nomi ............................................................................................................................................................................................... 909<br />
Indice Responsabili Progetti di Ricerca .......................................................................................................................................................... 909<br />
Indice Autori Pubblicazioni .................................................................................................................................................................................. 911<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 3
4<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
La <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
LA FONDAZIONE è sorta nel 1965 come “Clinica del Lavoro”, ente giuridico di diritto privato (DPR 991 del<br />
15/6/1965), ad opera del Prof. <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, al cui nome è ora intitolato (Decreto Ministeriale 30/5/1995)<br />
l’Istituto di Ricovero e Cura, riconosciuto a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale del 21/11/1969.<br />
In data 30 dicembre 2004 è stato riconfermato dal Ministero della Salute il carattere scientifico della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> per la disciplina “Medicina del Lavoro e della Riabilitazione” (G.U. N° 1 del 3/1/2005).<br />
Finalità dell’Istituto è operare nelle aree istituzionali della tutela della salute nel lavoro, individuando<br />
e prevenendo i rischi legati ad attività produttive, e della medicina riabilitativa, recuperando le capacità<br />
funzionali dei portatori di menomazioni neuromotorie, cardiorespiratorie e di patologie croniche<br />
polisistemiche disabilitanti; favorendo il reinserimento socio-produttivo del disabile e prevenendone<br />
l’handicap. L’attività assistenziale è di supporto alla ricerca le cui linee sono:<br />
1. Rischi occupazionali e ambientali da attività produttive<br />
2. Medicina riabilitativa neuromotoria<br />
3. Cardioangiologia<br />
riabilitativa<br />
4. Pneumologia<br />
riabilitativa<br />
5. Patologie croniche<br />
disabilitanti<br />
6. Riabilitazione<br />
integrativa<br />
del disabile<br />
e dell’anziano<br />
ed ergonomia<br />
occupazionale.<br />
Assistenza e ricerca sono reciprocamente<br />
collegate nella organizzazione<br />
degli Istituti dell’IRCCS e coordinate<br />
nel Comitato Tecnico Scientifico<br />
Centrale.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 5<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
1. DIREZIONE SCIENTIFICA CENTRALE<br />
Funzioni di cui è dotata:<br />
1.1. Segreteria scientifica<br />
6<br />
Gestione informatizzata della attività scientifica<br />
Raccolta dati<br />
Elaborazione Annuario attività scientifica<br />
Progetti e prodotti scientifici. Progetti multicentrici<br />
1.2. Unità di sviluppo e gestione Trials clinici<br />
1.3. Servizio di documentazione scientifica:<br />
Biblioteca scientifica centrale (http://bs.fsm.it)<br />
Banche dati<br />
Archiviazione Progetti Scientifici per l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche<br />
(numero di codice dell’Istituto: E169019A)<br />
Audiovisivi<br />
1.4. Attività editoriali<br />
Scientific Office della Rivista “Giornale Italiano<br />
di Medicina del Lavoro e Ergonomia”<br />
Managing Office della Rivista “Monaldi Archives<br />
for Chest Disease”, Serie Respiratoria e Serie Cardiologica<br />
Pubblicazione di:<br />
–“Libri della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>” (vedi pag. 131)<br />
– Advances in Occupational Medicine<br />
– Advances in Rehabilitation<br />
–Symposia<br />
– Manuali<br />
1.5. Ufficio Convegni scientifici; ECM<br />
1.6. Ufficio “application” scientifiche (per bandi Ministero<br />
Salute, MIUR, Ministero Welfare, U.E., Telethon, AIRC etc).<br />
e Brevetti<br />
Direzione Scientifica<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Il Centro Studi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
IL CENTRO STUDI<br />
Coniugare la pratica clinica con la ricerca scientifica<br />
qualificata e il costante aggiornamento professionale<br />
degli operatori sanitari sono obiettivi<br />
istituzionali della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione. Per dare<br />
maggior rilevanza a questi compiti, la <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> ha deciso di costituire un Centro Studi<br />
con il compito di presidiare queste aree di fondamentale<br />
importanza per lo sviluppo della scienza<br />
biomedica.<br />
Proseguendo sulla strada tracciata dal fondatore,<br />
il Centro Studi ha come scopo primario la promozione<br />
della conoscenza nelle aree di pertinenza<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>: la Medicina<br />
Preventiva, Riabilitativa-Occupazionale e<br />
delle Patologie Degenerative, la Medicina del Lavoro,<br />
la Tossicologia e l’Igiene Ambientale e Industriale.<br />
Attraverso l’attività di formazione professionale e<br />
aggiornamento scientifico, il Centro Studi si propone<br />
alle diverse professionalità sanitarie come luogo<br />
di incontro, discussione ed elaborazione di una<br />
cultura della salute moderna ed efficace, in sintonia<br />
con l’evoluzione scientifica e in accordo con gli<br />
standards richiesti dalle normative vigenti.<br />
IL PROGRAMMA<br />
Corsi di Formazione<br />
In qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere<br />
Scientifico, IRCCS, la <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
ha maturato, in oltre 35 anni di attività, una<br />
specifica esperienza in aree cliniche di particolare<br />
importanza e attualità.<br />
La Medicina Preventiva, Riabilitativa-Occupazionale<br />
e delle Patologie Degenerative, la Medicina<br />
del Lavoro, la Tossicologia e l’Igiene Ambientale e<br />
Industriale infatti rappresentano oggi settori in<br />
grande sviluppo, alla luce dei cambiamenti imposti<br />
dall’aumento della vita media, della maggiore incidenza<br />
delle patologie croniche, delle esigenze di<br />
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.<br />
L’attività di formazione svolta dal Centro Studi <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> intende offrire un contributo concreto<br />
alla qualificazione di tutti gli operatori coinvolti<br />
in queste discipline, avvalendosi per lo sviluppo<br />
didattico dell’apporto di professionalità interne<br />
ed esterne, mettendo a disposizione la propria rete<br />
di collaborazioni con il mondo scientifico nazionale<br />
e internazionale.<br />
Attività Congressuale<br />
Un ulteriore ambito di intervento del Centro Studi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> riguarda l’attività di divulgazione<br />
scientifica, che da sempre caratterizza il ruolo<br />
istituzionale degli IRCCS.<br />
Il confronto periodico tra i vari interlocutori coinvolti<br />
nel processo sanitario garantisce infatti la diffusione<br />
della conoscenza e l’affermazione di comuni<br />
modelli di riferimento.<br />
Scopo principale dell’attività convegnistica e congressuale<br />
sarà la definizione di momenti di dibattito<br />
scientifico qualificato, in linea con le più moderne<br />
metodologie della comunicazione in questo<br />
ambito.<br />
Formazione in Partnership<br />
Il Comitato Scientifico del Centro Studi <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, al quale partecipano autorevoli personalità<br />
delle discipline di riferimento, garantisce il costante<br />
collegamento con il network scientifico internazionale,<br />
stringendo rapporti di collaborazione<br />
finalizzati al continuo miglioramento delle attività<br />
proposte.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 7<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
EVENTI ACCREDITATI<br />
Anno 2007<br />
8<br />
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Corso interattivo di diagnosi e terapia del dolore 45 medico 4 5 8<br />
Promotore: Dr. C. Bonezzi, Dr. M. Buonocore<br />
05-09/02/2007; 12/03/2007; 16/04/2007; 26/11/2007<br />
Biopsia cutanea neurodiagnostica 4 (medico), medico, biologo, 1 10 29 31<br />
Promotore: Dr. M. Buonocore 4 (biologo), tecnico neurofisiopat.<br />
18/05/2007 5 (tecnico neurofisiopat.)<br />
New trends in chirurgia plastica, 10 medico, fisioterapista, 1 3 18 18<br />
ricostruttiva ed estetica infermiere prof.,<br />
Promotore: Prof.ssa A. Faga terapista occup.<br />
23/05/2007; 30/05/2007; 06/06/2007; 13/06/2007<br />
I seminari di <strong>Maugeri</strong> oncologia: 6 (medico), medico, infermiere prof. 1 15 115<br />
8 domande sui tumori del colon-retto, 6 (infermiere prof.)<br />
della mammella e della tiroide<br />
Promotore: Dr. A. Costa<br />
07-14-21/06/2007<br />
Corso teorico-pratico di BLS-D 7 medico, fisioterapista, 4 44 44<br />
(con l’uso del defibrillatore) infermiere prof.<br />
Promotore: AFD L. Nicola<br />
17-18/09/2007; 01-02/10/2007<br />
“Prendersi cura” di chi cura il soggetto mieloleso 5 (medico), medico, psicologo, 1 66<br />
in ambito riabilitativo 4 (psicologo), fisioterapista,<br />
Promotore: Dr.ssa C. Pistarini 4 (fisioterapista), infermiere prof.,<br />
05/10/2007 4 (infermiere prof.), terapista<br />
5 (terapista occup.)<br />
Sclerosi laterale amiotrofica. 5 (medico), medico, fisioterapista, 1 201<br />
La presa in carico globale dalla diagnosi 3 (psicologo), psicologo, infermiere prof.<br />
all’accompagnamento del fine vita: utopia o realtà? 3 (fisioterapista),<br />
Promotore: Dr. M. Melazzini 3 (infermiere prof.)<br />
14/12/2007<br />
Le risorse online accessibili dal sito 4 (medico) medico 1 1 5 5<br />
della biblioteca centrale<br />
Promotore: Dr.ssa C. Vercesi<br />
14/12/2007<br />
Istituto Scientifico di Montescano<br />
Significato ed importanza della fase pre analitica 1 infermiere 1 4 13 13<br />
nel laboratorio di analisi chimico cliniche<br />
e microbiologia<br />
Promotore: Dr.ssa A. Rezzani<br />
05/03/2007<br />
Rischio da agenti biologici e procedure 2 tutte le professioni 3 1 50 50<br />
post-esposizione<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli<br />
04/05/2007; 07/06/2007; 07/11/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Illustrazione del piano di emergenza e verifica 3 tutte le professioni 3 1 24 24<br />
pratica della sua attivazione<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli<br />
04/05/2007; 07/06/2007; 07/11/2007<br />
Corso di formazione per addetti alla prevenzione 14 tutte le professioni 1 21 21<br />
incendi a rischio di incendio elevato, lotta<br />
antincendio e gestione delle emergenze.<br />
D.Lgs 626/94 e D.M. 10/03/98<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli<br />
07-16/05/2007<br />
Anormalità respiratorie nel paziente 6 medico, tecnico 1 6 19 19<br />
con scompenso cardiaco cronico neurofisiopat.<br />
Promotore: Dr.ssa M.T. La Rovere<br />
28/05/2007<br />
Il ruolo dell’imaging in riabilitazione 5 varie figure 1 5 36 36<br />
Promotore: Dr. P. Poggi<br />
29/05/2007<br />
Modelli mentali per l’identificazione di immagini 6 (medico), medico, logopedista 1 43<br />
e per la denominazione: deficit neuropsicologici, 7 (logopedista)<br />
diagnosi e riabilitazione<br />
Promotore: Dr.ssa A. Contardi<br />
30/05/2007<br />
Gestione dell’urgenza: principi generali 6 tutte le professioni 2 6 58 58<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli<br />
06/06/2007; 11/10/2007<br />
La depressione in ambito riabilitativo 5 medico, psicologo, 1 8 18 18<br />
Promotore: Dr.ssa G. Majani fisioterapista, dietista<br />
14/06/2007<br />
Prevenzione e controllo della legionellosi, 3 medico, biologo, 2 4 45 45<br />
una problematica emergente fisioterapista,<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli infermiere prof., tecnico<br />
25/06/2007; 05/12/2007 sanitario radiologia med.<br />
Comunicare in modo assertivo: strategie 6 psicologo, dietista, 1 3 19 19<br />
e abilità interpersonali in riabilitazione fisioterapista, infermiere<br />
Promotore: Dr.ssa G. Majani prof., logopedista,<br />
06/09/2007 tecnico neurofisiopat.<br />
Valutazione e terapia riabilitativa di alterazioni 5 medico, fisioterapista, 1 2 40 40<br />
dell’equilibrio e della propriocezione tecnico neurofisiopat.,<br />
Promotore: Dr. G. Felicetti terapista occ.<br />
18/09/2007<br />
I disturbi psicologici e comportamentali 4 (medico); medico, psicologo, 1 24<br />
nelle demenze 3 (psicologo); fisioterapista<br />
Promotore: Dr.ssa G. Majani 3 (fisioterapista)<br />
24/09/2007<br />
La riabilitazione del paziente affetto da patologie 6 medico, biologo, 1 8 44 44<br />
respiratorie croniche: protocolli riabilitativi, dietista, fisioterapista,<br />
indici funzionali e indicatori di risultato infermiere prof., tecnico<br />
Promotore: Dr. C. Bruschi sanitario radiologia med.<br />
01/10/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 9<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
10<br />
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Il diabete mellito come comorbilità in pazienti 5 medico, dietista 1 4 24 24<br />
affetti da patologie croniche<br />
Promotore: Dr. R. Aquiliani<br />
02/10/2007<br />
L’embolia polmonare: criteri e strumenti diagnostici 4 medico, fisioterapista, 1 6 40 40<br />
e trattamenti farmacologici infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. C. Fracchia tecnico neurofisiopat.<br />
04/10/2007<br />
Riabilitazione senza dolore - HPH 9 medico, farmacista, 1 9 36 36<br />
Promotore: Dr. R. Casale psicologo, fisiot.,<br />
16 e 29/10/2007 infermiere prof.,<br />
tecnico neurofisiopat.,<br />
terapista occup.<br />
Allergologia nella quotidiana pratica clinica 6 medico, biologo, 1 5 27 27<br />
ospedaliera tecnico laboratorio,<br />
Promotore: Dr.ssa C. Pronzato infermiere<br />
30/10/2007<br />
Approccio riabilitativo al paziente con malattia 6 medico, fisioterapista, 1 5 35 35<br />
di Parkinson infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. R. Casale tecnico neurofisiopat.,<br />
12/11/2007 terapista occup.<br />
La movimentazione dei pazienti in ambiente 3 infermiere prof., 1 2 26 26<br />
ospedaliero fisioterapista<br />
Promotore: Dr. G. Bazzini<br />
14/11/2007<br />
La gestione della fibrillazione atriale nelle diverse 4 medico, fisioterapista, 1 6 39 39<br />
situazioni cliniche in ambito riabilitativo infermiere prof.<br />
e ruolo della terapia<br />
Promotore: Dr. O. Febo<br />
21/11/2007<br />
Evidence Based Practice 5 medico, fisioterapista, 1 1 30 30<br />
Promotore: Dr.ssa R. Vedovelli infermiere prof.<br />
28/11/2007<br />
PACS: lo stato dell’arte e le realtà dei centri 3 medico, infermiere prof., 1 31 31<br />
della FSM tecnico sanitario<br />
Promotore: Dr. P. Poggi radiologia med.<br />
04/12/2007<br />
Corso teorico pratico sull’utilizzo di nuove 5 medico, biologo, 1 17 17<br />
strumentazioni introdotte in laboratorio tecnico sanitario lab. biom.<br />
per la determinazione del NT PRO BNP<br />
Promotore: Dr. A. Demartini<br />
06/12/2007<br />
Prevenzione e controllo della legionellosi, 3 medico, biologo, 1 4 30 30<br />
una problematica emergente fisioterapista,<br />
Promotore: Dr.ssa P. Abelli infermiere prof., tecnico<br />
12/12/2007 sanitario radiologia med.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Il concetto di requisiti analitici per ottimizzare 3 varie figure 1 1 10 10<br />
i criteri di giudizio nei programmi di controllo<br />
interno di qualità<br />
Promotore: Ing. R. Colombo<br />
15/01/2007<br />
Corso di elettrocardiografia applicata. I e II Edizione 16 infermiere prof. 2 5 20 20<br />
Promotore: Dr. C. Marcassa<br />
13-23/03/2007 05-16/11/2007<br />
Il confezionamento di ortesi statiche in materiale 6 medico, fisioterapista 1 1 16 16<br />
termoplastico in ambito riabilitativo:<br />
corso di addestramento teorico-pratico<br />
Promotore: Dr. P. Giannuzzi<br />
15/05/2007<br />
Procedure infermieristiche 8 infermiere prof. 2 37 37<br />
Promotore: Dr.ssa E. Alliata<br />
22-23/05/2007; 12-13/06/2007<br />
Metodiche e protocolli di riabilitazione fisica 4 (medico); medico, fisioterapista 1 13 16 16<br />
in cardiologia 4 (fisioterapista)<br />
Promotore: Dr. P. Giannuzzi<br />
23/05/2007<br />
Esercizio fisico nell’anziano e nel paziente neurologico 4 medico, fisioterapista 1 5 32 32<br />
Promotore: Dr. A. Nardone<br />
24/05/2007<br />
La gestione del cardiopatico emiplegico in fase 11 fisioterapista 1 1 10 10<br />
post-acuta: corso di addestramento teorico-pratico<br />
in tema di posture, passaggi posturali e trattamento<br />
Promotore: Dr. P. Giannuzzi<br />
28/05/2007 e 01/06/2007<br />
Tecniche alternative alla tradizionale movimentazione 25 infermiere prof. 1 2 10 10<br />
manuale del paziente: la kinaesthetics<br />
Promotore: Dr. P. Giannuzzi<br />
31/05/2007 e 05/06/2007<br />
Rischio biologico e nozioni di base sul rischio chimico. 3 medico, biologo, 2 3 40 40<br />
I e II Edizione infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. P. Alciato tecnico sanitario lab. biom.<br />
21/09/2007 e 11/10/2007<br />
Paziente critico in riabilitazione multispecialistica 21 infermiere prof., 2 15 44 44<br />
e di alta specializzazione: assistenza infermieristica logopedista<br />
Promotore: Dr. P. Giannuzzi<br />
24-28/09/2007 e 03-07/12/2007<br />
I controlli di qualità sulle strumentazioni 10 medico, tecnico sanitario 1 1 5 5<br />
di medicina nucleare radiologia med.<br />
Promotore: Dr. O. Zoccarato<br />
03/10/2007 e 28/11/2007<br />
Il ventricolo asincrono: valutazione ed indicazione 4 medico 1 3 9 9<br />
alla terapia di resincronizzazione (CRT)<br />
Promotore: Dr. C. Marcassa<br />
09/10/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 11<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
12<br />
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Tecniche manuali di Soft Tissue Mobilization (STM) 7 medico, fisioterapista 1 2 31 31<br />
e di Augmented Soft Tissue Mobilization (ASTM)<br />
nel trattamento delle patologie minori dei tessuti molli<br />
Promotore: Dr.ssa E. Galante<br />
15 e 25/10/2007<br />
Reazioni avverse ai farmaci 4 medico, farmacista, 1 3 20 20<br />
Promotore: Dr. P. Alciato infermiere prof.<br />
16/10/2007<br />
La gestione multidisciplinare del paziente disfagico 6 medico, fisioterapista, 1 5 31 31<br />
adulto nei reparti di riabilitazione specialistica: infermiere prof.,<br />
corso teorico pratico logopedista<br />
Promotore: Dr. F. Cossa<br />
11/12/2007<br />
Gli aspetti nutrizionali nel paziente critico 4 (medico); medico, dietista, 1 44<br />
Promotore: Dr. F. Pisano 5 (dietista); infermiere, logopedista<br />
12/12/2007 5 (infermiere);<br />
4 (logopedista)<br />
Istituto Scientifico di Lumezzane<br />
Trials clinici 3 varie figure 1 2 52 70<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
09/03/2007<br />
Principi di ventilazione meccanica 3 varie figure 1 3 63<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
01/06/2007<br />
Telemedicina: stato dell’arte e novità 2 varie figure 1 2 48 70<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
21/09/2007<br />
Il dolore cronico non oncologico 3 varie figure 1 1 31 70<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
05/10/2007<br />
Cure di fine vita: la necessità di un approccio 2 varie figure 1 4 48 70<br />
integrato alle cure palliative<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
19/10/2007<br />
Sindrome da conflitto sotto acromiale della spalla: 2 varie figure 1 4 27 70<br />
trattamento con tecniche tradizionali e alternative<br />
Promotore: Dr.ssa S. Scalvini<br />
16/11/2007<br />
Istituto Scientifico di Telese Terme<br />
Le sfide della riabilitazione multispecialistica 7 (medico) medico, fisioterapista, 1 12 70 100<br />
Promotore: Prof. F. Rengo 8 (fisioterapista), infermiere<br />
25-26/10/2007 8 (infermiere)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
Istituto Scientifico di Tradate<br />
Facciamo il punto sulla sindrome delle apnee 2 medico, fisioterapista, 1 82 82<br />
del sonno (OSAS) in provincia di Varese infermiere<br />
Promotore: Dr.ssa M. Neri<br />
29/09/2007<br />
Corso teorico pratico di formazione sulla ventilazione 4 medico, fisioterapista, 3 1 28 28<br />
meccanica di tipo non invasivo infermiere<br />
Promotore: Dr. G. Mazzucchelli<br />
12/11/2007<br />
BLSD CAT.B 7 medico, fisioterapista, 1 15 15<br />
Promotore: Dr. Bettone infermiere<br />
12/11/2007<br />
Istituto Scientifico di Nervi<br />
Corso BLSD 4 medico, infermiere prof., 2 31 31<br />
Promotore: Dr. P. Sessarego psicologo, fisioterapista,<br />
28-29/09/2007 logopedista<br />
I disturbi respiratori durante il sonno come nuovo 4 medico, infermiere prof., 1 5 26 26<br />
marker di gravità dei pazienti affetti da ictus cerebri psicologo, fisioterapista,<br />
o lesioni midollari. Nuove prospettive riabilitative logopedista,<br />
Promotore: Dr. P. Sessarego tecnico neurofisiopat.<br />
27/10/2007<br />
Il ruolo delle scale di valutazione in medicina 5 medico, psicologo,<br />
riabilitativa fisioterapista,<br />
Promotore: Dr. P. Sessarego infermiere prof.,<br />
09-10/11/2007 logopedista 1 3 34 34<br />
Istituto Scientifico di Cassano Murge<br />
Assertività e operatori sanitari 11 (medico); medico, psicologo, 1 28<br />
Promotore: Dr.ssa M. Naimo 14 (psicologo); fisioterapista,<br />
24-25/01/2007 16 (fisioterapista); infermiere prof.<br />
14 (infermiere prof.)<br />
Misurazione dell’outcome e rieducazione 12 (medico); medico, psicologo, 1 52<br />
delle turbe comportamentali nel paziente 10 (psicologo); fisioterapista,<br />
con grave cerebrolesione acquisita 11 (fisioterapista); logopedista<br />
Promotore: Dr.ssa M. Del Prete 11 (logopedista)<br />
19-20/10/2007<br />
Possibilità e limiti della medicina nucleare 4 medico, biologo, chimico 1<br />
in riabilitazione<br />
Promotore: Prof. L. Ambrosi<br />
14/12/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 13<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Titolo Crediti ECM Categoria professionale Edizioni N. Relatori FSM N. Partec. FSM N. Partec. TOTALI<br />
14<br />
Istituto Scientifico di Castel Goffredo<br />
Diagnosi, clinica e trattamento del paziente 3 medico, biologo, 2 5 37 37<br />
osteoporotico fisioterapista, infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. L. Abdi Ali tecnico sanitario radiologia<br />
25/05/2007; 01/06/2007 med., tecnico lab. biomedico<br />
Rischio da agenti biologici e procedura 3 medico, biologo, 2 4 20 20<br />
post-esposizione fisioterapista, infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. G. Grioni tecnico sanitario radiologia<br />
14/06/2007; 21/06/2007 med., tecnico lab. biomedico<br />
Trattamento riabilitativo globale del paziente 3 medico, biologo, 2 3 19 19<br />
protesizzato d’anca fisioterapista, infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr.ssa L. Selletti tecnico sanitario radiologia<br />
28/09/2007 med., tecnico lab. biomedico,<br />
tecnico neurof.<br />
Corso Bobath Base 50 fisioterapista 1<br />
Promotore: Dr. G. Grioni<br />
12/10/2007; 16/12/2007<br />
Esercizio fisico e alimentazione 3 medico, biologo, 2 3 27 27<br />
Promotore: Dr.ssa L. Selletti fisioterapista, infermiere prof.,<br />
12/10/2007; 26/10/2007 tecnico sanitario radiologia<br />
med., tecnico lab. biomedico,<br />
tecnico neurof.<br />
Basi farmacologiche per il trattamento antibiotico 3 medico, biologo, 1 4 23 27<br />
Promotore: Dr.ssa L. Campostrini fisioterapista, infermiere prof.,<br />
14/11/2007 tecnico sanitario radiologia<br />
med., tecnico lab. biomedico,<br />
tecnico neurof.<br />
Diagnosi, clinica e trattamento del paziente 3 medico, psicologo, 2 5 34 34<br />
con trauma cranio-encefalico fisioterapista, infermiere prof.,<br />
Promotore: Dr. S. Avanzi tecnico sanitario radiologia<br />
22/11/2007; 29/11/2007 med., logopedista,<br />
tecnico neurof.<br />
Istituto Scientifico di Lissone<br />
Corso di drenaggio linfo-connettivale 9 medico, fisioterapista 1 19 19<br />
Promotore: Dr.ssa E. Giovannazzi<br />
27/10/2007; 17/11/2007<br />
TOTALE Crediti ECM Edizioni Relatori FSM Partec. FSM Partec. totali<br />
663 97 282 1949 2478<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Attività di Ricerca Scientifica<br />
L’IRCCS <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, “Clinica<br />
del Lavoro e della Riabilitazione”, opera nei campi<br />
istituzionali che riguardano essenzialmente i rischi<br />
da attività produttive e la riabilitazione, quest’ultima<br />
nella sua duplice accezione, di recupero funzionale<br />
specialistico in percorsi clinici differenziati,<br />
e di promozione della capacità di attività critiche e<br />
della qualità della vita dell’individuo disabile e prevenzione<br />
dell’handicap.<br />
OBIETTIVI LINEE<br />
SETTORI<br />
INTERAZIONE<br />
AMBIENTE<br />
LAVORO<br />
UOMO<br />
PATOLOGIE<br />
SOCIALI<br />
DISABILITANTI<br />
PERCORSI<br />
TERAPEUTICO-<br />
RIABILITATIVI<br />
FUNZIONALI<br />
E<br />
OCCUPAZIONALI<br />
MISURE DI<br />
QUALITÀ<br />
ATTIVITÀ<br />
INTEGRATIVE<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
RISCHI AMBIENTALI<br />
E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
MEDICINA RIABILITATIVA<br />
NEUROMOTORIA<br />
CARDIOANGIOLOGIA<br />
RIABILITATIVA<br />
PNEUMOLOGIA<br />
RIABILITATIVA<br />
PATOLOGIE CRONICHE<br />
E DEGENERATIVE<br />
RICERCA INTEGRATIVA<br />
POLIDISCIPLINARE<br />
FATTORI DI RISCHIO: Identificazione<br />
e misura - dosimetria<br />
ambientale e personale<br />
RISCHIO: Meccanismo di azione<br />
- Indicatori di esposizione<br />
e di effetto<br />
Ricerca di base<br />
(biomolecolare,<br />
cellulare,<br />
fisiopatologica)<br />
Sviluppo metodi<br />
di valutazione funzionale<br />
Clinica, epidemiologia,<br />
trials<br />
Recupero terapeutico funzionale<br />
Recupero occupazionale<br />
Misura di qualità e valutazioni<br />
di outcome riabilitativo<br />
Oncologia<br />
Nefrologia<br />
Metabolismo - Patologie<br />
degenerative<br />
Immunoallergologia<br />
Dolore cronico<br />
– ERGONOMIA: Studio della attività<br />
del DISABILE e del NORMALE<br />
(lavoratore, anziano, sportivo)<br />
– BIOINGEGNERIA:<br />
Biomeccanica - Segnali - Ausili<br />
– PSICOLOGIA: Stress, comportamento<br />
PAVIA<br />
Per l’attività di assistenza si vale di strutture cliniche<br />
specialistiche e generiche esistenti nei Centri<br />
Medici. La ricerca è sviluppata per linee e tematiche<br />
specifiche e per linee coinvolgenti più tematiche,<br />
alcune comuni ai due campi istituzionali,<br />
e che si valgono di competenze e di laboratori<br />
speciali.<br />
La tabella sinottica schematizza l’incrocio delle<br />
tematiche di ricerca.<br />
RICERCA: CLINICA SPERIMENTALE<br />
ISTITUTI CON UNITÀ ASSISTENZIALI, SERVIZI, LABORATORI PER RICERCA CLINICA ESEMPI DI LABORATORI<br />
CON SPECIFICO<br />
PERSONALE<br />
DI RICERCA<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 15<br />
MONTESCANO<br />
LISSONE<br />
TRADATE<br />
LUMEZZANE<br />
CASTEL<br />
GOFFREDO<br />
NERVI<br />
TELESE-<br />
CAMPOLI<br />
CASSANO<br />
VERUNO<br />
PADOVA<br />
VEDI CAPITOLO “I LABORATORI DI RICERCA SPERIMENTALE” NELLE PAGINE SUCCESSIVE<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
I Laboratori di Ricerca Sperimentale<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI OCCUPAZIONALI E AMBIENTALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
1. LABORATORIO DI IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE ....................... 17<br />
2. LABORATORIO DI MISURE AMBIENTALI E TOSSICOLOGICHE ............. 19<br />
3. LABORATORIO DI IMMUNOALLERGOLOGIA PROFESSIONALE ........... 22<br />
4. CENTRO RICERCHE DI TOSSICOLOGIA AMBIENTALE<br />
E TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE<br />
LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA - SERVIZIO ACCREDITATO<br />
DI TOSSICOLOGIA CLINICA (SMEL N. 861) ................................................. 24<br />
5. LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE DI BARI ....................................... 26<br />
6. CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI ............................................................... 28<br />
7. LABORATORIO PER LO STUDIO DEI DISTRUTTORI ENDOCRINI ........... 30<br />
8. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCHE IN MEDICINA<br />
AMBIENTALE E MEDICINA DEL LAVORO ..................................................... 33<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
1. LABORATORIO DI RICERCA SULLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE .. 35<br />
2. LABORATORIO DI BIOPSIA CUTANEA NEURODIAGNOSTICA ............... 37<br />
3. CSAM (CENTRO STUDI ATTIVITÀ MOTORIE) ............................................... 38<br />
4. DIAGNOSTICA E RIEDUCAZIONE NEUROMUSCOLARE E TERAPIA<br />
ISOCINETICA ............................................................................................................ 41<br />
5. LABORATORIO DI POSTURA E MOVIMENTO .............................................. 43<br />
6. LABORATORIO DI RIABILITAZIONE ROBOTIZZATA<br />
E DI BIOMECCANICA ............................................................................................ 45<br />
7. LABORATORIO PER LO STUDIO DEI DISTURBI AFASICI DEL<br />
LINGUAGGIO: ASPETTI METODOLOGICI E MODELLI COGNITIVI ......... 48<br />
8. LABORATORIO PER LO STUDIO DEI DISTURBI COGNITIVI ESITATI<br />
A LESIONE CEREBRALE FOCALE ...................................................................... 50<br />
9. LABORATORIO DI RICERCA PER I DISTURBI PSICOLOGICI E COGNITIVI<br />
NEL MORBO DI PARKINSON ............................................................................. 51<br />
10. LABORATORIO BIOPSIE CUTANEE .................................................................. 53<br />
11. LABORATORIO DI METODI QUANTITATIVI E MODELLI PER L’ANALISI<br />
DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA ........................................................... 55<br />
12. LABORATORIO PER LO STUDIO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE<br />
DELLA PAROLA CENTRO “PRIMO LANZONI” ............................................. 57<br />
13. LABORATORIO PER LO STUDIO DEI DISTURBI COGNITIVI IN PAZIENTI<br />
CON SEQUELE DI TRAUMA CRANICO ........................................................... 59<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
1. UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA MOLECOLARE<br />
AREA MEDICINA SPERIMENTALE .................................................................... 61<br />
16<br />
2. LABORATORIO DI CARDIOLOGIA NUCLEARE ............................................ 64<br />
3 LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCOLARE E CRU ....... 67<br />
4. LABORATORIO PER LO STUDIO INTEGRATO DEL SISTEMA NERVOSO<br />
AUTONOMO E DELL’ATTIVITÀ CARDIORESPIRATORIA ........................... 70<br />
5. LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RIMODELLAMENTO<br />
VENTRICOLARE E DELLA EMODINAMICA NON-INVASIVA ................... 72<br />
6. SERVIZIO AUTONOMO DI TELEMEDICINA ................................................... 74<br />
7. LABORATORIO PER L’ANALISI E MODELLIZZAZIONE DELLA<br />
VARIABILITÀ CARDIORESPIRATORIA .............................................................. 77<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
1. LABORATORIO PER LO STUDIO DELLO STATO DI SALUTE<br />
- QUALITÀ DELLA VITA NELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE ................... 79<br />
2. LABORATORIO DI MECCANICA POLMONARE E FUNZIONE<br />
MUSCOLARE RESPIRATORIA ............................................................................. 81<br />
3. LABORATORIO DI BIOLOGIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO<br />
RESPIRATORIO ........................................................................................................ 82<br />
4. CENTRO DI MEDICINA DEL SONNO AD INDIRIZZO<br />
CARDIO-RESPIRATORIO ...................................................................................... 85<br />
5. LABORATORIO DI CITO-IMMUNOPATOLOGIA DELL’APPARATO<br />
CARDIO-RESPIRATORIO ...................................................................................... 87<br />
6. LABORATORIO DELLO STUDIO E TRATTAMENTO<br />
DELLA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ......................................................... 90<br />
7. LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA DELLE TUBERCOLOSI<br />
E DELLE MALATTIE RESPIRATORIE ................................................................. 92<br />
8. LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA E MECCANICA RESPIRATORIA .. 95<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA DEL DISABILE<br />
E DELL’ANZIANO ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
1. LABORATORIO DELLA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ<br />
CLINICA ..................................................................................................................... 97<br />
2. LABORATORIO PER LO STUDIO DELL’AFFATICAMENTO MUSCOLARE .. 100<br />
3. LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA TERAPEUTICA .................................... 102<br />
4. LABORATORIO DI ROBOTICA PER LA RIABILITAZIONE<br />
E L’AUTONOMIA FUNZIONALE.......................................................................... 103<br />
5. CENTRO PER LA VALUTAZIONE FUNZIONALE IN MEDICINA<br />
RIABILITATIVA NEUROMOTORIA ..................................................................... 105<br />
6. LABORATORIO DI BIOINGEGNERIA DELLA RIABILITAZIONE ................ 108<br />
7. LABORATORIO DI COMUNICAZIONE E DOMOTICA ................................. 110<br />
8. LABORATORIO DEI METODI PER L’INDAGINE DELL’INTEGRAZIONE<br />
SENSORIMOTORIA E DEI FENOMENI DI PLASTICITÀ NEURONALE<br />
LABORATORIO SPERIMENTALE DI BIOINGEGNERIA<br />
E NEURORIABILITAZIONE ................................................................................... 112<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
1. LABORATORIO DI IGIENE<br />
INDUSTRIALE E AMBIENTALE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.592300<br />
e-mail: igamb@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Danilo Cottica<br />
L’Unità Operativa di Igiene Industriale e Ambientale è stata<br />
istituita dalla <strong>Fondazione</strong> nel settembre 2003 per razionalizzare,<br />
in funzione delle esigenze emerse nel campo dell’igiene<br />
industriale, le attività ed i compiti istituzionali svolti dall’originario<br />
“Laboratorio di Igiene Industriale” nato negli anni settanta<br />
a Pavia. L’Unità Operativa è costituita dalla sezione Polveri<br />
e Fibre; dai settori Igiene Industriale; Rischi Fisici; Coordinamento<br />
Centrale Servizi Prevenzione e Protezione. L’Unità<br />
Operativa di Igiene Industriale e Ambientale collabora con il<br />
Centro Ricerche Ambientali della Sede di Padova per le attività<br />
di campionamento, analisi strumentali, misura degli agenti fisici.<br />
Utenti abituali dell’Unità Operativa sono rappresentati da<br />
aziende private, ASL, laboratori privati e pubblici, Medici Competenti<br />
e Medici di Fabbrica, Igienisti Industriali, Responsabili<br />
della Sicurezza e Prevenzione negli ambienti di lavoro, gli Istituti<br />
Scientifici della <strong>Fondazione</strong> che richiedono misure ambientali<br />
e di monitoraggio biologico nell’ambito delle attività di<br />
vigilanza e prevenzione delle malattie professionali.<br />
Le attività e le prestazioni dei settori che compongono l’Unità<br />
Operativa, pur caratterizzate da diverse competenze professionali,<br />
sono caratterizzate da finalità di ricerca e servizio ai<br />
fini della prevenzione e tutela della salute.<br />
Le prestazioni della sezione “Polveri e Fibre” prevedono un<br />
iter consolidato per soddisfare le esigenze del cliente in materia<br />
di conoscenza, misura, valutazione degli agenti di rischio<br />
riferibili alle polveri e fibre. L’attività esterna prevede sopralluoghi<br />
in ambienti di lavoro, misure del particolato aerodisperso,<br />
campionamento di materiali massivi, valutazione dei<br />
rischi professionali; quella di laboratorio l’analisi su campioni<br />
inviati da clienti esterni; parallelamente vengono svolte attività<br />
di ricerca nel campo di competenza e di didattica (Corsi Universitari,<br />
formazione professionale, ecc.).<br />
Il settore Igiene Industriale fornisce consulenza nella valutazione<br />
e gestione dei rischi mediante indagini igienistico industriali<br />
che prevedono il campionamento e la misura degli<br />
agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di vita e di lavoro,<br />
emissioni, immissioni, acque, suoli. Agli utenti viene fornita<br />
una relazione che contiene la descrizione delle attività di<br />
monitoraggio svolte, il risultato delle determinazioni richieste,<br />
una loro valutazione qualitativa e quantitativa mediante il confronto<br />
con i limiti per le esposizioni occupazionali fissati dalle<br />
norme o dalle agenzie internazionali e, quando disponibili, con<br />
i valori forniti dalla casistica di riferimento per la popolazione<br />
generale; la relazione comprende suggerimenti per eventuali<br />
approfondimenti delle situazioni riscontrate o per interventi<br />
migliorativi per la prevenzione. Il settore opera in stretta collaborazione<br />
con i settori Rischi Fisici, Polveri e Fibre, con il<br />
Centro Ricerche Ambientali di Padova ed altre Unità Operative<br />
della <strong>Fondazione</strong> attive nei settori di competenza.<br />
L’attività in campo comporta pure attività di ricerca applicata<br />
allo sviluppo e messa a punto di metodiche di campionamento<br />
degli agenti chimici e biologici.<br />
Il settore Rischi Fisici svolge la sua attività mediante indagini<br />
negli ambienti di lavoro e di vita per la misura e la valutazione<br />
dei parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità<br />
aria; valutazione degli indici di stress, strain e comfort termico);<br />
indagini fotometriche negli ambienti di lavoro (illuminamento,<br />
luxmetria, ecc.); valutazioni ergonomiche delle postazioni<br />
di lavoro in genere e dei VDT; misura delle radiazioni<br />
ionizzanti e non ionizzanti (campo elettrico e/o magnetico); indagini<br />
fonometriche (esposizione professionale a rumore, rumorosità<br />
negli ambienti esterni e abitativi, livelli sonori degli<br />
impianti elettroacustici nei locali di pubblico spettacolo, misure<br />
d’impatto ambientale e zonizzazione acustica); misura e<br />
valutazione delle vibrazioni.<br />
Il settore Coordinamento Centrale Servizi Prevenzione e<br />
Protezione è uno specifico nucleo di lavoro per l’attuazione di<br />
quanto previsto in materia di igiene, prevenzione, salute e sicurezza<br />
sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 s.m.i. Il personale del settore<br />
svolge indifferentemente la funzione di RSPP (Responsabile Servizio<br />
Prevenzione Protezione) o di ASPP (Addetto Servizio Prevenzione<br />
Protezione) presso gli Istituti della <strong>Fondazione</strong> o<br />
aziende esterne; sviluppando a livello centralizzato specifiche tematiche<br />
in materia di salute e sicurezza, operando in équipe<br />
possono assicurare assistenza, consulenza e supporto ai Sistemi<br />
Sicurezza delle singole strutture. Il SPPC elabora procedure, documenti,<br />
“linee guida” omogenei da trasmettere alle diverse<br />
sedi; fornisce assistenza e consulenza tecnica, assicurando alle<br />
strutture l’aggiornamento normativo negli ambiti di competenza;<br />
provvede alla stesura e all’aggiornamento dei Documenti di Valutazione<br />
dei Rischi, dei Piani di Emergenza e di Evacuazione<br />
nonché agli altri adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 s.m.i.<br />
(sopralluoghi, monitoraggio infortuni, etc.); organizza i necessari<br />
processi di consultazione previsti dalla normativa (sopralluoghi<br />
congiunti, riunioni periodiche, etc.); collabora con le Direzioni<br />
e con i Medici Competenti nella gestione delle eventuali criticità;<br />
concorda con la Direzione Scientifica Centrale programmi<br />
e attività formative e informative di competenza; supporta le<br />
strutture, negli ambiti di competenza, per processi di accreditamento,<br />
certificazione e altri argomenti / attività diverse.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 17<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Attività di Ricerca<br />
Messa a punto di metodi e strategie di campionamento e<br />
misura degli agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti<br />
di lavoro, confinati e di vita.<br />
Studio e proposta di parametri di riferimento per l’inquinamento<br />
biologico negli ambienti di lavoro industriali e non.<br />
Identificazione e strategie di misura degli agenti biologici<br />
nei comparti produttivi (ospedali, depuratori, impianti di<br />
compostaggio, ecc.).<br />
Studio e verifica dell’applicabilità in campo di sistemi di<br />
campionamento per agenti chimici (vapori di solventi, monomeri,<br />
polveri a diversa granulometria, fibre minerali, di<br />
legno, sintetiche).<br />
Studio dell’applicabilità di un sistema di campionamento a<br />
diffusione per la misura del Radon.<br />
Progetto finalizzato per la valutazione dell’esposizione<br />
professionale e della popolazione a campi elettromagnetici.<br />
Implementazione dei programmi computerizzati per la<br />
mappatura dell’inquinamento acustico ai fini della zonizzazione<br />
in ambienti di lavoro e di vita.<br />
Applicazione e sviluppo di strategie di campionamento ai<br />
fini della misura degli agenti chimici secondo il D.Lgs.<br />
25/02.<br />
Progettazione e realizzazione di sistemi di taratura con atmosfere<br />
standard.<br />
Pubblicazioni<br />
G.B. Bartolucci, M. Bovenzi, F. Cassano, I. Cortesi, D. Cottica,<br />
G.M. Giachino, M. Manno, A. Mutti, G. Nano, E. Pira,<br />
M.L. Scapellato, L. Selis, L. Soleo, P. Apostoli. Linee Guida<br />
per la valutazione del rischio. Pime Editrice. Pavia 2004.<br />
C. Dacarro, P. Grisoli, G. Del Frate, S. Villani, E. Grignani, D.<br />
Cottica. Micro-organism and dust exposure in an italian<br />
grain mill. Journal of Applied Microbiology 2004.<br />
E. Galimberti, E. Grignani. Evoluzione dei sistemi e metodi<br />
di campionamento per gas e vapori. Atti del 21° Congresso<br />
Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti<br />
Industriali. Como 25-27 giugno 2003, 2003, pp. 118-126.<br />
A. Massola. Analisi DRX della SLC nel particolato aerodisperso<br />
e calibrazionedel metodo in funzione della relativa<br />
granulometria. Atti 11° Convegno AIDII “Le giornate di<br />
Corsara”. Corvara, 21-23 marzo 2005.<br />
V. Cervi, B. Lonardi, E. Grignani, C. Dacarro. Valutazione<br />
del rischio biologico in ambiente sanitario, Atti del 9° Convegno<br />
di Igiene Industriale. Corvara (BZ); 19-21 marzo<br />
2003, pp. 75-79.<br />
E. Grignani, C. Kullmann, F. Pastoni, C. Dacarro. Valutazioni<br />
microbiologiche per la definizione della salubrità<br />
degli ambienti di lavoro. Definizione di indici attendibili di<br />
contaminazione. Biologi Italiani, 2003, Anno XXXIII - n. 10,<br />
pp. 12-13.<br />
D. Cottica, E. Grignani, E. Galimberti. Il confronto con il valore<br />
limite nella valutazione dell’esposizione professionale.<br />
Atti del Convegno AIDII, Valori Limite di Esposizione e Applicazione<br />
nell’ambiente di lavoro e di vita: prospettive; in<br />
Ambiente e lavoro convention, Modena, 16-17 ottobre<br />
2003, pp. 37-46.<br />
P. Grisoli, M. Rodolfi, E. Grignani, D. Cottica, A.M. Picco, C.<br />
Dacarro. Utilizzazione di indici microbiologici per la valu-<br />
18<br />
tazione della salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro.<br />
L’igiene moderna 2003 (119), 283-298.<br />
D. Cottica, E. Grignani. Tecniche di campionamento ed<br />
analisi. Atti 23° Congresso Nazionale AIDII; Bologna 22°<br />
Convegno di Igiene Industriale. Corvara (BZ); 19-21 marzo<br />
2003.<br />
D. Cottica, E. Grignani. Microinquinanti e nanoparticelle:<br />
campionamento, analisi e prospettive. Atti 11° Convegno<br />
di Igiene Industriale. Corvara (BZ); marzo 2005.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Danilo Cottica, nato a Cremona il 23 maggio<br />
1949.<br />
Laurea in CHIMICA presso l’Università degli<br />
Studi di PV marzo1977.<br />
Abilitato alla professione, iscritto all’Albo professionale.<br />
Igienista Industriale Certificato dalla Associa<br />
zione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII).<br />
Dal maggio 1977 al marzo 1980 è Assistente poi Coadiutore<br />
del Direttore del Laboratorio d’Igiene Industriale della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS di Pavia (FSM).<br />
Dal 15 giugno 1997, con la qualifica di Direttore Tecnico, è Responsabile<br />
della U.O. d’Igiene Industriale del Laboratorio d’Igiene<br />
Ambientale e Tossicologia Industriale della FSM di Pavia.<br />
Dal giugno 2003 è Direttore del Centro Ricerche Ambientali<br />
della FSM in Padova.<br />
Dal Settembre 2003 è anche responsabile della U.O. di Igiene<br />
Industriale e Ambientale della FSM di Pavia.<br />
Dal 1984 è membro del Consiglio Direttivo dell’AIDII.<br />
Dal 1997 al 2000 Presidente AIDII; attualmente Past President.<br />
Responsabile di progetti di ricerca finalizzati nel campo dell’igiene<br />
industriale.<br />
Autore di circa 150 pubblicazioni e capitoli di libri su argomenti<br />
d’igiene industriale.<br />
Membro della Commissione Aria-Ambiente dell’UNICHIM<br />
per la stesura di metodiche per il monitoraggio ambientale.<br />
Coordinatore Responsabile del Gruppo di Lavoro 1/SC 2<br />
- ARIA per le emissioni convogliate e la qualità dell’aria -<br />
Commissione Ambiente dell’UNI.<br />
Membro del Gruppo di Lavoro “Valutazione dei Rischi” istituito<br />
dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale (Regione<br />
Lombardia) per la definizione di Linee Guida Applicative del<br />
D.L. 626/94. Già adottata dalla conferenza Stato/Regioni.<br />
Vice Presidente del “Board of the International Occupational<br />
Hygiene Association” (IOHA).<br />
Membro di Commissioni del “Bureau Communitaire de Reference”<br />
(BCR) per la certificazione di standards di riferimento<br />
in materia di ambienti di lavoro, emissioni, qualità<br />
dell’aria.<br />
Delegato Italiano nel “Comitato Europeo di Normalizzazione<br />
(CEN): ComitatoTecnico 137/WG2 General Requirements<br />
for Measuring Procedures”.<br />
Delegato italiano del CEN/TC 264 “Air Quality”.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Membro del “Working Group 5” dell’Health and Safety Executive<br />
(HSE) Inglese per l’applicazione e validazione dei<br />
campionatori a diffusione.<br />
Membro del Comitato di Redazione del “Giornale degli Igienisti<br />
Industriali”.<br />
Membro del Gruppo di lavoro della Sezione III del Consiglio<br />
Superiore di Sanità, Ministero della Salute, per le problematiche<br />
relative all’analisi e classificazione delle acque minerali<br />
naturali.<br />
Professore a Contratto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
dell’Università di PV;<br />
la Scuola di Specialità in Allergologia;<br />
la Scuola di Specialità in Medicina del Lavoro;<br />
Corso di Laurea per Tecnici d’Igiene Ambientale e del Lavoro.<br />
Professore a Contratto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
dell’Università di BS:<br />
Corso di Laurea per Tecnici d’Igiene Ambientale e del Lavoro.<br />
Docente accreditato dal Ministero dei Trasporti per corsi<br />
d’abilitazione al trasporto di merci pericolose (A.D.R.).<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
2. LABORATORIO DI MISURE AMBIENTALI<br />
E TOSSICOLOGICHE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.592300<br />
e-mail: claudio.minoia@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Claudio Minoia<br />
Il Laboratorio effettua misure di microinquinanti in diverse tipologie<br />
di matrici ambientali e biologiche, sviluppando e validando<br />
metodi di analisi, incluso il calcolo dell’incertezza di misura. Tra<br />
le matrici considerate: fluidi e tessuti biologici, alimenti o campioni<br />
di dieta totale, acque di falda, acque sotterranee, acque di<br />
scarico, acque minerali, aria ambiente e particolato ambientale,<br />
wipe-tests, pads, terreni, prodotti e materie prime industriali.<br />
Attività di Ricerca<br />
Le tematiche di ricerca del laboratorio sono le seguenti:<br />
1) studio dei valori di riferimento di xenobiotici e/o loro metaboliti<br />
in fluidi e tessuti biologici; 2) messa a punto e sviluppo<br />
di nuovi indicatori biologici di esposizione ambientale e in ambito<br />
occupazionale; 3) definizione di strategie nel monitoraggio<br />
ambientale e biologico dell’esposizione professionale a<br />
chemioterapici in ambito sanitario e industriale; 4) studi di<br />
Total Diet per la popolazione generale italiana (ad es. per policlorobifenili,<br />
polibrobifenili, polibromobifenileteri, elementi in<br />
traccia, fitofarmaci, ftalati, idrocarburi policiclici aromatici,<br />
altre sostanze con caratteristiche di interferenti endocrini);<br />
5) sviluppo e messa punto di metodi di analisi per campioni di<br />
acque destinate al consumo umano e minerali, acque superficiali<br />
e di scarico; 6) Allestimento di un data-base (V.A.R.I.E.D.)<br />
per interferenti endocrini; 7) Studi di farmacocinetica del platino<br />
(oxaliplatino) e antracicline caricate su microsfere (Hepasphere);<br />
8) Analisi del profilo di espressione di microRNA in<br />
popolazioni esposte a tossici ambientali e occupazionali; 9)<br />
Studio della correlazione tra i livelli di espressione genica e<br />
l’esposizione ai fattori ambientali (PCB e altri xenobiotici).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 19<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Attività Educazionale<br />
Il personale del laboratorio partecipa come relatore a corsi di<br />
informazione e formazione presso Istituto Superiore di Sanità,<br />
ISPESL, Scuola Permanente di Informazione e Formazione sui<br />
Rischi Lavorativi di Pratovecchio (AR) (in collaborazione con<br />
l’Azienda Sanitaria di Firenze e ISPESL). Nel corso del 2007 il<br />
Laboratorio ha partecipato anche a corsi di formazione con<br />
l’ASL di Perugia (Scuola Umbra) per la tutela della salute dei<br />
lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici.<br />
Il personale del laboratorio fornisce supporto e assistenza ai<br />
laureandi dei corsi di laurea (junior e magistrale) in Biologia,<br />
Tecnologie Chimiche per l’Ambiente e le Risorse, Biotecnologie,<br />
Farmacia per la preparazione e stesura della tesi.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
La disponibilità di metodi di analisi per la determinazione di<br />
chemioterapici antiblastici in fluidi biologici ha consentito<br />
l’applicazione di queste procedure allo studio e alla sperimentazione<br />
di nuovi farmaci antitumorali in fase I e II, attività<br />
svolta in collaborazione con centri oncologici nazionali e internazionali.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
RFPS-2006-4-336738. sotto progetto P7- Rischio individuale<br />
e collettivo, derivante da condizioni di esercizio incontrollate<br />
o anomale degli impianti industriali.<br />
Progetti di Ricerca in programmazione<br />
Progetto FIRB - Italia-Cina: Inquinamento da particolato e<br />
inquinanti ambientali persistenti: effetti clinici, biochimici<br />
e molecolari (coord. Unità di Ricerca Università di Pavia:<br />
Prof. M. Imbriani).<br />
Progetto PRIN prot. 2007Z8TZFF: Profili di esposizione per<br />
la gestione del rischio da antiparassitari in agricoltura<br />
(coord. Unità di Ricerca Università di Pavia: Prof. M. Imbriani).<br />
Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli di<br />
bioaccumulo di metalli e contaminanti organici persistenti<br />
in gruppi di popolazione a diverso rischio potenziale nelle<br />
aree di Augusta-Priolo e Gela (OMS - Centro Ambiente e<br />
Salute Roma).<br />
Pubblicazioni<br />
C. Minoia, B. Bocca, A. Ronchi, G. Forte, A. Pino, E. Finozzi,<br />
G. Catenacci, M.E. Conti. A. Alimonti. Reference values of<br />
47 Trace Elements in Whole Blood, Serum and Urine by<br />
DRC-ICP-MS and SF-ICP-MS in Two Italian Population<br />
Groups from Lombardia and Lazio Regions. In: The Seventh<br />
International Symposium on Biological Monitoring<br />
in Occupational & Environmental Health, 2007, September<br />
10-12, Beijing, China.<br />
R. Turci, R. Santamaria, A. Chiodini, C. Sommaruga, A.<br />
Mantovani, C. Colosio, C. Minoia. Exposure to Organohalogenated<br />
Pollulants in General Populations Groups Living<br />
in Italy. In: The Seventh International Symposium on Biological<br />
Monitoring in Occupational & Environmental<br />
Health, 2007, September 10-12, Beijing, China.<br />
20<br />
R. Turci, S. Gaiardi, N. Mazzotti, R. Coghi, M. Del Bianco,<br />
P. Pari, M. Gabellino, M. Patone, M. Zignani, M. Ghetti, C.<br />
Sottani, C. Minoia. Occupational Exposure to Antineoplastic<br />
Drugs: Assessing Compliance with Existing Guidelines<br />
in Seven Italian Hospitals. In: The Seventh International<br />
Symposium on Biological Monitoring in Occupational &<br />
Environmental Health, 2007, September 10-12, Beijing,<br />
China.<br />
C. Colosio, P. Basilicata. A. Chiodini, S. Fustinoni, N. Miraglia,<br />
R. Turci, A. Simonelli, C. Somaruga, N. Vitelli, C. Minoia,<br />
N. Cannolo. A Combined modelling and Monitoring<br />
approach to Pesticide Exposure Assesment. In: The Seventh<br />
International Symposium on Biological Monitoring<br />
in Occupational & Environmental Health, 2007, September<br />
10-12, Beijing, China.<br />
N. Vitelli, A. Chiodini, C. Somaruga, R. Turci, C. Minoia, C.<br />
Colosio. Biological Monitoring of Occupational and Environmental<br />
Exposure to Alide and Dicarboximide Pesticides.<br />
In: The Seventh International Symposium on Biological<br />
Monitoring in Occupational & Environmental Health,<br />
2007, September 10-12, Beijing, China.<br />
E. Corsini, I. Codecà, S. Mangiaratti, S. Birindelli, C. Minoia,<br />
R. Turci, B. Viviani, A. Facchi, N. Vitelli, L. Lucchi, C.L. Galli,<br />
M. Marinovich, C. Colosio. Immunomodulatory effects of<br />
the herbicide propanil on cytokine production in humans:<br />
In vivo and in vitro exposure. Toxicol Appl Pharmacol 2007<br />
Jul 15; 222 (2): 202-10.<br />
A. Pino, A. Alimonti, F. Botrè, C. Minoia, B. Bocca, M.E.<br />
Conti. Determination of twenty-five elements in lichens by<br />
sector field inductively coupled plasma mass spectrometry<br />
and microwave-assisted acid digestion. Rapid Commun<br />
Mass Spectrom 2007; 21 (12): 1900-6.<br />
C. Minoia, A. Ronchi, R. Gaggeri, G. Guzzi, G. Severi. Correlating<br />
blood mercury and dental amalgams. Sci Total<br />
Environ 2007 Aug 1; 381 (1-3): 331; author reply 332.<br />
C. Sottani, R. Turci, R. Schierl, R. Gaggeri, A. Barbieri, F.S.<br />
Violante, C. Minoia. Simultaneous determination of gemcitabine,<br />
taxol, cyclophosphamide and ifosfamide in wipe<br />
samples by high-performance liquid chromatography/<br />
tandem mass spectrometry: protocol of validation and uncertainty<br />
of measurement. Rapid Commun Mass Spectrom<br />
2007; 21 (7): 1289-96.<br />
C. Minoia, C. Sottani, A. Mantovani. Aspetti analitici e metodologici<br />
emergenti nella determinazione di folati nel<br />
siero In: Workshop Italiano Promozione Acido Folico: Prevenzione<br />
Primaria di Effetti Congeniti, 5 ottobre 2007, ISS,<br />
Roma.<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
1. Determinazione di PCB e pesticidi organoclorurati (DDT e<br />
suoi metaboliti, HCHs, aldrin, dieldrin, esaclorobenzene) in<br />
siero<br />
2. Determinazione simultanea di ciclofosfamide, ifosfamide,<br />
gemcitabina e taxolo in matrici ambientali (pads, wipe test)<br />
3. Determinazione di 25 elementi in traccia in licheni<br />
4. Determinazione di 3,4-dicloroanilina e 3,5-dicloroanilina in<br />
urina<br />
5. Determinazione di 5-fluorouracile in matrici ambientali<br />
(aria, pads, wipe test, guanti)<br />
6. Determinazione di acido perfluoroottanoico in siero<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
7. Determinazione di antracicline in matrici ambientali (aria,<br />
guanti)<br />
8. Determinazione di antracicline in urina<br />
9. Determinazione di ciclofosfamide in matrici ambientali<br />
(aria, pads, wipe test, guanti)<br />
10. Determinazione di ciclofosfamide in urina<br />
11. Determinazione di etilentiourea in urina<br />
12. Determinazione di gemcitabina e 2dFdU in urina<br />
13. Determinazione di gemcitabina in matrici ambientali (aria,<br />
pads, wipe test, guanti)<br />
14. Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in<br />
terreni<br />
15. Determinazione di ifosfamide in matrici ambientali (aria,<br />
pads, wipe test, guanti)<br />
16. Determinazione di ifosfamide in urina<br />
17. Determinazione di insetticidi piretroidi (e/o loro metaboliti)<br />
in urina<br />
18. Determinazione di insetticidi piretroidi in aria<br />
19. Determinazione di mercurio in urina<br />
20. Determinazione di metotrexate in matrici ambientali (aria,<br />
pads, wipe test, guanti)<br />
21. Determinazione di metotrexate in urina<br />
22. Determinazione di molibdeno in urina<br />
23. Determinazione di PCB in aria<br />
24. Determinazione di PCB in siero<br />
25. Determinazione di PCB in terreni<br />
26. Determinazione di PCB negli alimenti<br />
27. Determinazione di pesticidi negli alimenti<br />
28. Determinazione di platino in urina<br />
29. Determinazione di taxolo in matrici ambientali (aria, pads,<br />
wipe test, guanti)<br />
30. Determinazione di taxolo in plasma<br />
31. Determinazione di terre rare in urina<br />
32. Determinazione di alchilfosfati urinari<br />
33. Determinazione di ftalati (e/o loro metaboliti) in urina<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Claudio Minoia.<br />
Nato a Giussago (Pavia) il 30.09.1951.<br />
Diploma di Perito Chimico presso ITIS Casalpusterlengo<br />
(iscritto al Collegio dei Periti Industriali<br />
della Provincia di Pavia, n. 291).<br />
Laurea in Scienze Biologiche presso Università<br />
di Pavia (iscritto all’Ordine Nazionale dei<br />
Biologi, numero di iscrizione all’albo 033426).<br />
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in<br />
Medicina del Lavoro dell’Università di Pavia.<br />
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in<br />
Tossicologia Forense dell’Università di Pavia.<br />
Professore a Contratto presso la Scuola diretta a fini speciali<br />
per i Tecnici di Igiene Ambientale e del Lavoro dell’Università<br />
di Pavia.<br />
Dal 2003 al 2006 è stato docente nell’ambito dell’insegnamento<br />
di Chimica Farmaceutica Avanzata del Master in Progettazione<br />
e Sviluppo dei Farmaci (Università di Pavia). Incarico<br />
riconfermato nel 2007.<br />
Incarico di docenza al Master “Valutazione e controllo del Rischio<br />
Tossicologico da Inquinanti Ambientali” (a.a. 2004-<br />
2007) (Università di Pavia).<br />
Incarico di docenza al Master “Sicurezza e Igiene degli Alimenti”<br />
(Università di Pavia) nel 2005.<br />
Dipendente del Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia<br />
Industriale della <strong>Fondazione</strong> “<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>”, Clinica<br />
del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS di Pavia dal 1974; dal<br />
1993 con la qualifica di Direttore del Laboratorio di Igiene Ambientale<br />
e Tossicologia Industriale. Dal settembre 2003 Direttore<br />
del Laboratorio di Misure Ambientali e Tossicologiche<br />
della <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>.<br />
Presidente della Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR)<br />
dal 1993, rinnovato nella carica per il triennio 1998-2000. Attualmente<br />
Past President della SIVR. Igienista Industriale Certificato<br />
(IIC), n. 085. Presidente della Società Italiana di Tossicità<br />
della Riproduzione (SITOR) dal 2007. Componente del<br />
Gruppo di lavoro del Ministero della Sanità per l’Aggiornamento<br />
delle conoscenze sugli effetti sanitari connessi con l’esposizione<br />
a campi elettromagnetici. Componente del Gruppo<br />
di lavoro del Ministero della Sanità per lo studio del Coordinamento<br />
delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.<br />
Componente della Commissione Scientifica del Ministero<br />
della Sanità per la elaborazione di proposta di intervento legislativo<br />
in materia di inquinamento indoor.<br />
Componente del Gruppo di Lavoro del Ministero della Sanità<br />
sul National Environment Health Ambient Plan (NEHAP).<br />
Componente del Gruppo di lavoro della Regione Lombardia<br />
per la elaborazione di linee Guida per la manipolazione in Sicurezza<br />
dei Chemioterapici Antiblastici.<br />
Componente del Gruppo di lavoro ISPESL per l’elaborazione di<br />
Linee Guida applicative in merito al D.L.gs. 25/2002 “Attuazione<br />
delle D. 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza<br />
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici<br />
durante il lavoro”.<br />
Autore di circa 800 pubblicazioni scientifiche nel campo dell’Igiene<br />
Ambientale, Industriale e della Tossicologia. Autore di<br />
40 volumi relativi all’analisi di microinquinanti organici e di<br />
elementi in traccia in matrici ambientali e biologiche.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 21<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
3. LABORATORIO DI IMMUNOALLERGOLOGIA<br />
PROFESSIONALE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Centro Ricerche ISPESL<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921<br />
e-mail: gianna.moscato@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Gianna Moscato<br />
Il Laboratorio di Immunoallergologia Professionale del Centro<br />
Ricerche ISPESL - <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> svolge attività<br />
di ricerca sperimentale nel settore delle allergopatie professionali.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca del Laboratorio di Immunoallergologia Professionale<br />
verte sulle allergopatie professionali, sulle quali<br />
vengono in particolare condotti studi sull’infiammazione delle<br />
vie aeree, e sullo studio dei fattori ambientali e dei loro meccanismi<br />
d’azione nell’induzione di allergopatie professionali<br />
respiratorie e/o cutanee.<br />
Riguardo al primo aspetto, è noto come alla base dell’asma e<br />
della rinite professionale vi sia un meccanismo infiammatorio<br />
che vede coinvolte componenti cellulari diverse, in particolare<br />
eosinofili, linfociti T e mastcellule, e componenti umorali. L’attività<br />
di ricerca del Laboratorio è diretta in particolare allo<br />
studio dei linfociti e delle citochine da essi prodotte in campioni<br />
biologici di espettorato, di liquido di lavaggio bronchiale<br />
(BAL) e di liquido di lavaggio nasale di soggetti con asma e/o<br />
rinite indotte da agenti professionali.<br />
Lo studio dei fattori di rischio ambientali e lavorativi riguarda da<br />
una parte la messa a punto di nuove metodiche sperimentali<br />
per il campionamento e il dosaggio di allergeni aerodispersi,<br />
dall’altra lo studio dei meccanismi di interazione tra sostanze<br />
professionali ed organismo umano, con particolare riguardo<br />
alle sostanze chimiche a basso peso molecolare. Al momento<br />
22<br />
attuale sono in corso in particolare studi sui sali di persolfato<br />
implicati nelle allergopatie professionali dei parrucchieri.<br />
Attività Educazionale e Didattica<br />
L’attività educazionale del Laboratorio ha lo scopo di diffondere<br />
la cultura sulle allergopatie professionali e divulgare le<br />
basi della ricerca in campo biomedico.<br />
A tale scopo i risultati delle ricerche vengono divulgati oltreché<br />
in pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali<br />
peer-reviewed, anche in incontri formativi di aggiornamento<br />
per allergologi, medici del lavoro e medici di medicina<br />
generale.<br />
Sono in atto collaborazioni con centri di eccellenza nazionali<br />
(Sedi Universitarie Italiane e IRCCS) e internazionali (Department<br />
of Chest Medicine, Sacré-Cœur Hospital, Montreal, Canada;<br />
Division of Immunology, University of Cincinnati, Ohio,<br />
USA; Membri dell’Interest Group on Occupational Allergy dell’European<br />
Academy of Allergy and Clinical Immunology), con i<br />
quali sono attivi specifici progetti di ricerca e presso i quali i giovani<br />
ricercatori del Laboratorio conducono esperienze lavorative<br />
al fine di aumentare le loro conoscenze professionali e il livello<br />
qualitativo della ricerca condotta presso il Laboratorio stesso.<br />
Inoltre, una parte del personale del Laboratorio è titolare di<br />
contratti di insegnamento presso le Scuole di Specializzazione<br />
in Scuole di Specializzazione in Allergologia e Immunologia<br />
Clinica dell’Università di Pavia e in Medicina del Lavoro I e II.<br />
Gli specializzandi iscritti a queste Scuole svolgono pertanto il<br />
loro tirocinio pratico-teorico presso il Laboratorio.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Gli studi condotti nel Laboratorio sull’infiammazione delle vie<br />
aeree e sui meccanismi immunologici sottostanti alle allergopatie<br />
respiratorie professionali hanno anche l’obiettivo di mettere<br />
a punto metodiche da utilizzare nei percorsi diagnostici e<br />
nella sorveglianza sanitaria di queste patologie, secondo indicazioni<br />
che saranno oggetto di apposite Linee Guida prodotte<br />
anche in collaborazione con organismi nazionali.<br />
Gli studi sui fattori di rischio ambientali e lavorativi consentiranno<br />
di mettere a punto metodiche per i campionamenti e la<br />
valutazione di fattori ambientali implicati nelle allergopatie<br />
professionali, fornendo indicazioni per la prevenzione agli organismi<br />
ad essa deputati.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio dell’infiammazione bronchiale tramite espettorato<br />
indotto nella rinite e nell’asma occupazionale.<br />
Studi sui meccanismi di azione dell’Ammonio persolfato<br />
(AP) nell’induzione di patologie professionali respiratorie:<br />
Attività di attivazione su mastociti.<br />
Effetto di AP su proteine umane.<br />
Progetti di Ricerca in programmazione<br />
Valutazione della presenza di sIgG e sIgE verso proteine<br />
modificate da aammonio persolfato.<br />
Pubblicazioni<br />
Moscato G, Galdi E. Asthma and Hairdressers. Curr Opin<br />
Allergy Clin Immunol 2006; 6: 91-95.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Tarlo SM, Malo J-L and other Workshop members<br />
(…Gianna Moscato…). 100 key questions and needs in<br />
occupational asthma. An American Thoracic Society/European<br />
Thoracic Society Report. Eur Respir J 2006; 27:<br />
607-614.<br />
Siracusa A, Marabini A, Folletti I, Moscato G. Smoking and<br />
occupational asthma. Review. Clin Exp Allergy 2006 May;<br />
36 (5): 577-84.<br />
Pignatti P, Brunetti G, Moretto D, Yacoub MR, Fiori M,<br />
Balbi B, Balestrino B, Cervio G, Nava S, Moscato G. Role of<br />
the chemokine receptors CXCR3 and CCR4 in human pulmonary<br />
fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:<br />
310-317.<br />
Burge PS, Moscato G, Johnson A, Chan-Yeung M Physiological<br />
Assessment: Serial Measurements of Lung Function<br />
and Bronchial Responsiveness. In: Asthma in the<br />
Workplace, 3 rd Ed. Edited by IL Bernstein, M Chan-Yeung,<br />
J-L Malo, DI Bernstein. Taylor & Francis, New York, 2006,<br />
pag. 199-226.<br />
De Burbure C, Pignatti P, Corradi M, Malerba M, Clippe A,<br />
Dumont X, Moscato G, Mutti A, Bernard A. Uteroglobin-related<br />
protein 1 and Clara cell protein in induced sputum of<br />
patients with asthma and rhinitis. Chest 2007; 131; 172-<br />
179.<br />
Balbi B, Pignatti P, Corradi M, Baiardi P, Bianchi L, Brunetti<br />
G, Radaeli A, Moscato G, Mutti A, Spanevello A, Malerba<br />
M. Bronchoalveolar Lavage, Sputum And Exhaled Clinically<br />
Relevant Inflammatory Markers Values In Healthy<br />
Adults. Review. Eur Respir J 2007; 30: 769-781.<br />
Moscato G, Perfetti L, Pignatti P, Cappelli I. Occupational<br />
rhinitis due to sodium alendronate. Eur Respir J 2007; 30:<br />
S51: 156.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Gianna Moscato, nata a Gropello Cairoli<br />
(PV) nel 1950.<br />
Laureata a pieni voti in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università di Pavia nel 1974 con una<br />
tesi su “Alterazioni funzionali respiratorie e<br />
presenza della bronchite cronica in un<br />
gruppo di saldatori”. Specialista in Tisiologia<br />
e Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina<br />
del Lavoro Allergologia e Immunologia clinica. Ha svolto<br />
la sua carriera presso l’IRCCS <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>,<br />
dapprima come medico interno e borsista presso l’Istituto di<br />
Medicina del Lavoro, indi come assistente e aiuto presso la<br />
Divisione di Medicina Generale come Responsabile del Laboratorio<br />
di Allergologia Respiratoria. Dal 1996 è Direttore della<br />
Struttura Complessa Servizio di Allergologia e Immunologia<br />
Clinica, riconosciuto come Centro di riferimento della Regione<br />
Lombardia per l’Allergologia e Immunologia clinica.<br />
Dal 1981 ha contratti di insegnamento con le Scuole di Specializzazione<br />
in Allergologia e Immunologia Clinica, di cui è<br />
anche Coordinatore dei corsi, in Medicina del Lavoro e in Tossicologia<br />
Medica dell’Università di Pavia.<br />
È membro di numerose Società Scientifiche Nazionali e internazionali,<br />
per le quali è anche Coordinatore di Gruppi di Lavoro.<br />
Al momento attuale è membro del Consiglio Direttivo<br />
della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica;<br />
membro del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di<br />
Aerobiologia; Chair dell’Interest Group on Occupational Allergy<br />
of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology<br />
(EAACI); delegato della Società Italiana di Allergologia<br />
e Immunologia clinica presso la U.E.M.S., Section and Board<br />
for Allergology and Clinical Immunology; Membro della Faculty<br />
of 1000 Medicine; esperto del Ministero della Salute per<br />
il programma ECM; membro del Gruppo di Lavoro “Prevenzione<br />
ambientale delle allergie nelle scuole” del Ministero<br />
Della Salute.<br />
L’attività scientifica ha riguardato principalmente lo studio<br />
delle allergopatie respiratorie, asma e rinite, soprattutto nel<br />
settore della medicina del lavoro. In particolare, si è occupata<br />
di asma professionale negli aspetti dei meccanismi, diagnosi<br />
e gestione.<br />
Ha in attivo più di 300 lavori scientifici su riviste, dei quali 87<br />
peer-reviewed e 14 review, ed è autore di numerosi testi e capitoli<br />
di testi in italiano e in inglese.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 23<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
4. CENTRO RICERCHE DI TOSSICOLOGIA<br />
AMBIENTALE E TOSSICOLOGIA<br />
INDUSTRIALE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via Palestro, 26<br />
LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA<br />
- SERVIZIO ACCREDITATO DI<br />
TOSSICOLOGIA CLINICA (SMEL N. 861)<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921<br />
e-mail: luigi.manzo@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Luigi Manzo<br />
I principali settori di ricerca del Servizio di Tossicologia sono<br />
la tossicologia in vitro, la tossicologia cellulare e molecolare,<br />
la tossicovigilanza industriale, lo studio di indicatori precoci di<br />
effetti tossici e la validazione di nuovi test diagnostici.<br />
Il Centro Ricerche di Tossicologia Ambientale e Tossicologia<br />
Industriale è qualificato per l’attività di Ricerca a Contratto e<br />
accreditato tra i Centri Europei partecipanti ai programmi di<br />
validazione di test alternativi di tossicità coordinati dalla Commissione<br />
Europea (ECVAM).<br />
Il Laboratorio di Tossicologia - Servizio accreditato di Tossicologia<br />
Clinica è specializzato nell’applicazione di test per il riconoscimento<br />
precoce di effetti tossici (abuso di sostanze,<br />
tossicità di farmaci, pesticidi e inquinanti ambientali); il 60%<br />
delle richieste di esami proviene da fuori regione.<br />
L’attività di ricerca si articola in:<br />
Ricerca sperimentale<br />
Modelli in vitro: sviluppo, validazione e applicazione di<br />
metodi alternativi all’animale per lo screening e la caratterizzazione<br />
della tossicità d’organo. Tali metodi vengono<br />
24<br />
utilizzati per valutare l’azione di inquinanti ambientali e<br />
professionali e farmaci sul sistema nervoso, sul sistema<br />
ematopoietico e sull’apparato respiratorio.<br />
Modelli fisiologici per lo studio di inquinanti aerodispersi.<br />
Sviluppo e validazione in modelli animali di indicatori di<br />
danno cellulare: quest’area della ricerca mira a identificare<br />
in matrici biologiche periferiche biomarcatori di effetto, la<br />
cui positività anticipa nel tempo le manifestazioni cliniche<br />
delle malattie di causa tossica. In questo campo, il laboratorio<br />
partecipa a progetti volti ad individuare nuovi marker<br />
di tossicità di contaminanti alimentari.<br />
Ricerca traslazionale<br />
Indicatori biochimici di effetti tossici precoci da sostanze<br />
chimiche: quest’area di studio è volta all’applicazione clinica<br />
di biomarcatori di neurotossicità in casistiche selezionate<br />
di pazienti (es. soggetti alcol/tossicodipendenti, disturbi<br />
da deficit di attenzione e iperattività). Recentemente<br />
l’applicazione in ambito clinico ha riguardato la misurazione<br />
di MAO-B piastrinica in pazienti alcolisti e la misurazione<br />
di recettori colinergici muscarinici linfocitari in pazienti<br />
pediatrici affetti da ADHD, e in popolazioni del Nord<br />
Europa esposte ad inquinanti ambientali neurotossici.<br />
Validazione di test diagnostici: altri programmi riguardano<br />
la validazione di metodi biochimici utilizzabili in campo<br />
diagnostico: (i) per valutare precoci alterazioni neurologiche<br />
di origine tossica (es. misurazione dell’attività di secondi<br />
messaggeri nei linfociti), (ii) per la valutazione del<br />
tabagismo attivo e passivo (es. determinazione della cotonina<br />
urinaria in ELISA), (iii) per la diagnosi di abuso cronico<br />
di alcol (es. determinazione del CDT serico mediante<br />
analisi in HPLC) con specifica valutazione dei polimorfismi<br />
genetici. È attualmente in corso uno studio volto a valutare<br />
l’applicazione di questi metodi nel quadro di un’ampia casistica<br />
di pazienti afferenti al Servizio.<br />
Diagnosi tossicologica in urgenza: la ricerca di questi ultimi<br />
anni ha messo in evidenza l’utilità clinica della determinazione<br />
della alfa-amanitina urinaria quale strumento<br />
per la diagnosi precoce di avvelenamento da funghi<br />
(Amanita phalloides) in fase pre-sintomatica.<br />
Ricerca a contratto<br />
Il Centro Ricerche svolge attività di ricerca a contratto nel<br />
settore della tossicologia cellulare e molecolare intesa allo<br />
sviluppo, validazione e applicazione di metodi alternativi<br />
all’uso dell’animale di laboratorio secondo le direttive CEE.<br />
Risk assessment: è stato avviato un programma di validazione<br />
di batteria di test in vitro per predire la tossicità cellulare<br />
e molecolare delle sostanze chimiche, da utilizzarsi<br />
come alternativa all’animale di laboratorio, secondo<br />
quanto previsto dalla nuova legislazione europea in materia<br />
di risk assessment (REACH: Registration, Evaluation<br />
and Authorisation of Chemicals).<br />
I modelli cellulari in uso (linee stabilizzate, colture primarie<br />
di cellule, cellule isolate) sono rappresentativi di un’ampia<br />
varietà di organi e sistemi che costituiscono comune bersaglio<br />
di tossicità delle sostanze chimiche, in particolare<br />
sistema nervoso, midollo emopoietico, sangue ed epidermide.<br />
Vengono utilizzati (a) test di citotossicità generale e<br />
(b) test di tossicità organo-specifica, alcuni dei quali (es.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Episkin e il test di tossicità ematologica CFU-GM) condotti<br />
con metodi recentemente validati dalla Comunità Europea.<br />
Altri test in vitro consentono di valutare caratteristiche che<br />
hanno notevole importanza per la sicurezza di impiego dei<br />
nanomateriali, ad es. la capacità di permeare la barriera<br />
ematoencefalica (BBB test).<br />
Screening tossicologico di farmaci e altre sostanze: questo<br />
settore mira all’affinamento dei tradizionali metodi di<br />
studio usati in campo tossicologico per lo screening di sostanze<br />
di vario tipo (farmaci, pesticidi, inquinanti alimentari,<br />
etc.). Esempi di applicazione trasferibili sono quelli riguardanti<br />
(i) studio su progenitori di cellule ematiche per<br />
la caratterizzazione di composti mielotossici, (ii) la caratterizzazione<br />
di pattern metabolici di solventi e altri inquinanti<br />
chimici aerodispersi come supporto per l’interpretazione<br />
degli studi di monitoraggio biologico.<br />
Tossicovigilanza industriale: le attività di questo settore<br />
sono rivolte: (a) all’utilizzo di modelli computerizzati per la<br />
valutazione del rischio tossicologico, (b) all’informazione<br />
sui rischi chimici industriali e ambientali attraverso l’utilizzo<br />
di dati disponibili in rete e appositi database, (c) all’esecuzione<br />
di studi predittivi sulla pericolosità delle sostanze<br />
chimiche effettuati con tecniche QSAR.<br />
Ricerche in corso<br />
Diagnosi di abuso cronico di alcol: validazione intra- e<br />
inter-laboratorio del test CDT con HPLC-UV/VIS e comparazione<br />
con metodo ELISA (2008-2009).<br />
Predittività di marker periferici della neurotrasmissione<br />
nella diagnosi e monitoraggio farmacologico in pazienti<br />
pediatrici affetti da patologie neuropsichiatriche (2008-<br />
2009).<br />
Approccio metodologico integrato (in vitro - in silico) per la<br />
valutazione della permeabilità e dell’integrità della barriera<br />
emato-encefalica (2008-2009).<br />
Caratterizzazione chimico-fisica e profilo tossicologico in<br />
vitro e in vivo di nanoparticelle di silice e nanotubi di carbonio<br />
(2008-2009).<br />
Nanoparticelle prodotte nei processi di combustione: caratterizzazione<br />
chimica e valutazione della genotossicità<br />
(2007-2008).<br />
Allestimento di database sperimentali e clinici relativi all’esposizione<br />
ad agenti neurotossici e malattie neurodegenerative<br />
(2007-2008).<br />
Pubblicazioni<br />
Castoldi AF, Coccini T, Randine G, Hernandez-Viadel M,<br />
Felipo V, Manzo L. Lymphocyte cytochrome oxidase, cyclic<br />
GMP and cholinergic muscarinic receptors as peripheral<br />
indicators of carbon monoxide neurotoxicity after acute<br />
and repeated exposure in the rat brain. Life Sci 2006; 78:<br />
1915-1924.<br />
Coccini T, Randine G, Heinzow B, Grandjean P, Castoldi<br />
AF, Manzo L. Effects of developmental co-exposure to<br />
methylmercury and 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (PCB153)<br />
on cholinergic muscarinic receptors in rat brain. Neurotoxicology<br />
2006; 27: 468-477.<br />
Castoldi AF, Blandini F, Randine G, Samuele A, Coccini T,<br />
Manzo L. Brain monoaminergic transmission parameters<br />
in weanling rats after exposure to methylmercury and<br />
2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (PCB153). Brain Res 2006,<br />
1112: 91-98.<br />
Coccini T, Roda E, Castoldi AF, Goldoni M, Poli D, Bernocchi<br />
G, Manzo L. Perinatal co-exposure to methylmercury<br />
and PCB153 or PCB126 in rats alters the cerebral<br />
cholinergic muscarinic receptors at weaning and puberty.<br />
Toxicology 2007; 238: 34-48.<br />
Johansson C, Castoldi AF, Onishchenko N, Manzo L,<br />
Vahter M, Ceccatelli S. Neurobehavioural and molecular<br />
changes induced by methylmercury exposure during development.<br />
Neurotox Res 2007; 11: 241-260.<br />
Coccini T, Randine G, Castoldi AF, Acerbi D, Manzo L.<br />
Methylmercury interaction with lymphocyte cholinergic<br />
muscarinic receptors in developing rats. Environ Res 2007;<br />
103: 229-237.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof. Luigi Manzo. Professore ordinario nella<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Direttore<br />
della Scuola di Specializzazione in Tossicologia<br />
Medica e coordinatore del Master di II<br />
Livello “Valutazione e Controllo del Rischio<br />
Tossicologico da Inquinanti Ambientali” dell’Università<br />
degli Studi di Pavia. Membro della<br />
Commissione Referenti Scuole di Specializzazione<br />
di Area Sanitaria presso il Ministero dell’Università e<br />
della Ricerca Scientifica. Responsabile della Classe di Scienze<br />
Biomediche, Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia. Direttore<br />
del Servizio di Tossicologia, IRCCS <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>,<br />
Pavia.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 25<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
5. LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE<br />
DI BARI<br />
c/o UNIVERSUS CSEI<br />
Viale Japigia, 188 - Bari<br />
Tel. 080.5504970 - 080.5504985<br />
e-mail: luigi.ambrosi@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Luigi Ambrosi<br />
La struttura del Centro è fondamentalmente quella di un laboratorio<br />
di ricerca che opera anche nei luoghi di lavoro.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca svolta attualmente dal Centro, si articola su<br />
più linee che riguardano alcuni aspetti di Tossicologia occupazionale,<br />
l’Igiene Industria e l’esposizione della popolazione<br />
generale ai diversi fattori di rischio.<br />
In particolare, per ciò che riguarda gli aspetti relativi alla Tossicologia<br />
occupazionale, da circa dieci anni il Centro si occupa<br />
dello studio degli effetti cancerogeni di tipo epigenetico connessi<br />
alle alterazioni della comunicazione intercellulare mediata<br />
dalle Gap-Junction. Sono stati messi a punto dei modelli<br />
sperimentali che consentono lo studio delle funzionalità delle<br />
giunzioni cellulari (sia di tipo Gap che Tight) sia in vivo utilizzando<br />
embrioni di pollo che in vitro su culture di cheratinociti<br />
umani. In questo filone di ricerca vengono testate sostanze di<br />
largo uso, sia industriale che domestico e metalli.<br />
Per il prosieguo di questa linea di ricerca, si stanno mettendo<br />
a punto dei progetti mirati per:<br />
1. Verificare l’eventuale reversibilità spontanea o indotta,<br />
delle alterazioni funzionali delle giunzioni cellulari.<br />
2. Verificare l’entità dell’effetto in funzione della particolare<br />
specie chimica somministrata (questo effetto è stato evidenziato<br />
in maniera marcata per il mercurio somministrato<br />
come inorganico, monometile e dimetile); in particolare da<br />
tale tipo di studio potrebbero essere ottenuti dei dati utili<br />
alla comprensione del possibile meccanismo di azione che<br />
porta al blocco della comunicazione intercellulare.<br />
26<br />
3. Studiare l’entità degli effetti osservati non solo in relazione<br />
alla dose somministrata ma anche in relazione alla dose<br />
che effettivamente entra in contatto con la cellula a livello<br />
di parete cellulare e/o a livello di strutture interne alla cellula<br />
(dose assorbita).<br />
4. Studio dei mutamenti eventualmente indotti nel ciclo vitale<br />
delle cellule trattate a seguito dell’alterazione della loro capacità<br />
di comunicazione attraverso le Gap-Junction.<br />
Per ciò che attiene all’igiene industriale, gli aspetti maggiormente<br />
indagati riguardano le correlazioni dose esterna/indicatori<br />
di dose interna e le correlazioni dose-risposta a livello<br />
cellulare (aumento di micronuclei, aberrazioni cromosomiche,<br />
scambio di cromatidi, addotti al DNA) in relazione all’esposizione<br />
professionale ad inquinanti organici quali gli idrocarburi<br />
volatili e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Sono altresì<br />
oggetto di studio le esposizioni professionali e della popolazione<br />
generale a metalli in particolare per quanto riguarda il<br />
mercurio, il cromo e il piombo. Un aspetto particolare dello<br />
studio dell’esposizione a metalli della popolazione generale è<br />
quello che riguarda la definizione dei valori di eliminazione<br />
urinaria degli stessi metalli per la definizione dei rispettivi valori<br />
di riferimento.<br />
Un particolare settore di ricerca sul quale il Centro è impegnato<br />
da molto tempo, è quello relativo allo studio dell’esposizione<br />
professionale ad anestetici volatili in sala operatoria; in<br />
particolare gli aspetti studiati riguardano le correlazioni tra le<br />
caratteristiche strutturali delle sale operatorie, il tipo e la durata<br />
degli interventi e di livelli di protossido di azoto e/o anestetici<br />
alogenati presenti nei diversi ambienti che costituiscono<br />
il complesso operatorio nonché i livelli di esposizione<br />
delle diverse figure professionali che operano nei vari reparti<br />
chirurgici.<br />
Pubblicazioni<br />
Zefferino R, Elia G, Lasalvia M, Piccoli C, Boffoli D, Capitanio<br />
N, Ambrosi L. The study of Gap Junctional Intercellular<br />
Comunication in keratinocytes as screening of promoter<br />
effect induced by oindustrial and environmental<br />
toxic subsatnces. Med Lav 2005; 96: 3: 222-230.<br />
Cassano F, Bavaro P, De Marinis G, Aloise I. No-occupational<br />
exposure to noise. G Ital Med Lav Ergon 2005 Jan-<br />
Mar; 27 Suppl 1: 54-61.<br />
Bertossi M, Girolamo F, Errede M, Virgintino D, Elia G, Ambrosi<br />
L, Roncali L. Effects of methylmercury on the microvasculature<br />
of the developing brain. Neurotoxicology 2004<br />
Sep; 25 (5): 849-57.<br />
Ferri GM, Gallo A, Sumerano M, De Nicoli MR, Izzotti A,<br />
Conversano, M, Bailardi F, Antonelli G, Crescenzo R, Ricci<br />
V, Cassano F, De Marinis G, Elia G, Corrado V, Lo Izzo A,<br />
De Nichilo G, Ferranini A, Assennato G. Exposure to PAHs,<br />
urinary 1-pyrenol and DNA adducts in samples from a population<br />
living at diffent distances from a stel plant. G Ital<br />
Mec Lav Ergon 2003 Jul-Sep; 25 Suppl (3); 32-4.<br />
Zefferino R, L’Abbate N, Piccaluga S, Prezioso GM, Lasalvia<br />
M, Ambrosi L. Is the environmental and occupational<br />
cancer an immune mediated disease? Is it a game<br />
played by cytokines, epigenetic carcinogens and oxidant<br />
factors? 2 nd International Congress on Immune Mediated<br />
Diseases, September 10-15, 2007 Moscow, Russia Co-<br />
Sponsored by the University of Pittsburgh.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Zefferino R, Piccaluga S, Lasalvia M, D’Andrea G, Margaglione<br />
M, Ambrosi L. Role of tumour necrosis factor alpha<br />
and interleukin 1 beta in promoter effect induced by mercury<br />
in human keratinocytes. Int J Immunopathol Pharmacol<br />
2006 Oct-Dec; 19 (4 Suppl): 15-20.<br />
Ambrosi L. Between Occupational Medicine and Rehabilitation:<br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, precursor of a new health<br />
model of Excellence. G Ital Med Lav Ergon 2006 Jan-Mar;<br />
28 (1): 137-8.<br />
Zefferino R, Elia G, Lasalvia M, Piccoli C, Boffoli D, Capitanio<br />
N, Ambrosi L. The study of gap junctional intercellular<br />
communication in keratinocytes as screening of promoter<br />
effect induced by industrial and environmental toxic<br />
substances. Med Lav 2005 May-Jun; 96 (3): 222-30.<br />
Abbritti G, Apostoli P, Iavicoli S, Murgia N, Persechino B,<br />
Soleo L, Ambrosi L. Needs, education and accreditation in<br />
occupational medicine in Italy. Int Arch Occup Environ<br />
Health 2005 Feb; 78 (1): 75-8.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Prof. Luigi Ambrosi, nato a Bari il 2.6.1929,<br />
è Professore Ordinario di Medicina del Lavoro<br />
dell’Università di Bari dal 1 novembre<br />
1971.<br />
Ha costituito l’Istituto di Medicina del Lavoro<br />
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dotandolo<br />
di laboratori attrezzati di apparecchiature<br />
moderne ed avanzate. Ha costituito la<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Preventiva<br />
dei Lavoratori e Psicotecnica (nel 1976) trasformata<br />
quindi in Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e<br />
la Scuola per Tecnici di Igiene Ambientale e del Lavoro (nel<br />
1978) che hanno sede nell’Istituto.<br />
Nel 1979 ha istituito presso l’Istituto di Medicina del Lavoro,<br />
con la <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Pavia, il Centro di Igiene Ambientale<br />
che svolge notevole attività nel campo dell’Igiene<br />
degli ambienti di lavoro con interventi nel campo igienico-ambientale.<br />
Nel 1982, in collaborazione con l’Università di Milano, Parma<br />
e Pavia, ha istituito il Dottorato di Ricerca in Medicina del Lavoro<br />
ed Igiene Industriale con sede a Bari.<br />
È autore di circa 200 pubblicazioni (tra le quali due monografie)<br />
molte delle quali interessanti le molteplici problematiche<br />
della tossicologia industriale nel campo dei metalli e dei<br />
solventi, della oncologia professionale, dell’igiene industriale e<br />
delle pneumoconiosi.<br />
Dal 1977 al 1986 ha ricoperto la carica di Rettore dell’Università<br />
di Bari; durante questo periodo ha istituito la Comunità<br />
delle Università del Mediterraneo (CUM) della quale ne è il<br />
Presidente; la CUM conta attualmente 164 Università aderenti<br />
di tutti i Paesi del Mediterraneo e svolge intensa attività di cooperazione<br />
scientifica e culturale nel Bacino del Mediterraneo.<br />
Sin dal 1979 è Direttore Scientifico del Centro Medico di Riabilitazione<br />
di Cassano Murge della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Pavia, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nel<br />
quale ha ricoperto anche la carica di Primario della Divisione<br />
di Medicina del Lavoro. Da quell’epoca è componente del Con-<br />
siglio di Amministrazione della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Pavia.<br />
Nel 1993 gli è stata conferita dall’Università di Kaslik-Beirut la<br />
laurea honoris causa in Diritto.<br />
Nel 1996 ha dato alle stampe, per i tipi della editrice UTET un<br />
trattato di Medicina del Lavoro in collaborazione con Vito Foà,<br />
con una impostazione originale della materia e con molteplici<br />
argomenti profondamente innovativi.<br />
Dal 1 marzo 1996 è Direttore del Dipartimento di Medicina Interna<br />
e del Lavoro a Bari.<br />
Nel 1996 gli è stato conferito il Premio Internazionale “Buccheri<br />
La Ferla” 1996 per la Medicina del Lavoro.<br />
Dal 1/11/1999 è Ordinario di Medicina del Lavoro a Foggia<br />
dove attualmente svolge funzioni di Preside della Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia.<br />
I suoi studi vertono su molteplici campi della patologia da lavoro,<br />
sulla prevenzione e sulla patologia ambientale, soprattutto<br />
da inquinamento atmosferico.<br />
Particolarmente interessante appare il gruppo di ricerche sulla<br />
patologia da piombo (anemia, aspetti immunitari, neuropatie e<br />
nefropatie) che mettono in evidenza con osservazioni sperimentali<br />
e cliniche, il ruolo del sistema renina-angiotensina-aldosterone<br />
nel determinismo dell’ipertensione saturnina.<br />
Altro gruppo di ricerche è quello delle pneumoconiosi (silicosi<br />
ed asbestosi): ha segnalato su reperti anatomo-patologici le<br />
manifestazioni extrapolmonari della silicosi pubblicando in<br />
proposito una monografia sugli aspetti patogenetici ed anatomo-patologici<br />
della silicosi.<br />
Si è anche a fondo interessato delle broncopneumopatie croniche<br />
e dell’asma bronchiale.<br />
Ha fornito inoltre utili contributi in tema di patologia da cloruro<br />
vinile monomero, pesticidi, solventi organici, caprolattame.<br />
Nella produzione più recente, di rilievo sono gli studi sul comportamento<br />
della via metabolica del glutatione in tossicologia<br />
identificando per le sostanze esaminate i relativi acidi mercapturici<br />
che ritiene utili introdurre nella pratica come indicatori<br />
biologici.<br />
Recentemente inoltre, con i suoi collaboratori ha avviato ricerche<br />
sugli addotti del DNA utilizzando tale tecnica nei lavoratori<br />
delle cokerie.<br />
Ha dato inoltre un vasto contributo sui lavoratori addetti ai VDT.<br />
Dal 2000 al 2006 Presidente della Società Italiana di Medicina<br />
del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 27<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
6. CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI<br />
Via Svizzera, 16 - Padova<br />
Tel. 049.8064511<br />
e-mail: fsmpd@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Danilo Cottica<br />
Il Centro di Ricerche Ambientali di Padova, sorto nel 1978, è<br />
uno dei laboratori di Igiene Industriale e Ambientale della<br />
<strong>Fondazione</strong> che opera nelle aree istituzionali della Medicina<br />
del Lavoro e della tutela della salute. Il Centro svolge attività<br />
di ricerca per la Commissione Europea ed è di supporto tecnico<br />
e scientifico a numerose istituzioni pubbliche e private in<br />
Europa ed in alcuni Paesi extraeuropei. Il Centro collabora con<br />
l’Unità Operativa di Igiene Industriale e Ambientale dell’Istituto<br />
di Pavia per le attività di campionamento, analisi di polveri<br />
e fibre, misura degli agenti fisici.<br />
Utenti abituali del Centro sono rappresentati da aziende private,<br />
Aziende Sanitarie Locali, privati cittadini, laboratori pubblici<br />
e privati, Medici Competenti, Igienisti Industriali, Responsabili<br />
della Sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro,<br />
nonché gli Istituti Scientifici della <strong>Fondazione</strong>, che richiedono<br />
misure ambientali e di monitoraggio biologico nell’ambito delle<br />
attività di vigilanza e prevenzione delle malattie professionali.<br />
Il personale del Centro è essenzialmente impegnato sul versante<br />
della prevenzione, in particolare nel settore dei fattori di<br />
rischio derivanti dalle attività produttive e più in generale dalle<br />
attività umane. Le attività del Centro comprendono il settore<br />
“storico” dell’igiene industriale per la tutela della salute nei<br />
luoghi di lavoro e il settore dell’igiene ambientale, che riveste<br />
sempre maggiore importanza, per la crescita dei fattori di rischio<br />
presenti negli ambienti di vita, generati ad esempio dai<br />
mezzi di trasporto individuale e collettivo o dalle attività industriali,<br />
che sono sempre più a contatto con le aree residenziali.<br />
L’estensione del significato attribuito al concetto di salute, che<br />
comprende anche il “benessere” della persona, ha conferito<br />
sempre maggiore importanza al controllo della qualità dell’aria<br />
nei luoghi di vita, soprattutto negli ambienti confinati.<br />
28<br />
Il laboratorio ha acquisito esperienze specifiche nel campo del<br />
monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione professionale<br />
o extraprofessionale a gas e vapori inorganici, composti<br />
organici volatili e semivolatili, idrocarburi aromatici policiclici,<br />
gas e vapori anestetici, composti odorigeni.<br />
Nell’attività di igiene industriale ed ambientale una appropriata<br />
impostazione delle indagini riveste fondamentale importanza;<br />
pertanto, il Centro assiste il cliente, durante i contatti<br />
iniziali, nella raccolta delle informazioni preliminari, nella<br />
corretta definizione degli obiettivi dell’indagine e nella progettazione<br />
della strategia di monitoraggio. Il personale del Centro<br />
esegue gli interventi sul campo per l’identificazione e la misura<br />
dei fattori di rischio, la successiva analisi dei campioni, la<br />
valutazione dei risultati e l’indicazione delle eventuali misure<br />
preventive. Le attività di indagine sono costantemente supportate<br />
dalle attività di ricerca e messa a punto degli strumenti<br />
e dei metodi di misura più adatti agli obiettivi proposti.<br />
Il Centro è titolare del brevetto del sistema di campionamento<br />
a diffusione “radiello” utilizzato per il campionamento di<br />
agenti chimici aerodispersi negli ambienti di vita e di lavoro da<br />
Aziende Sanitarie ed Agenzie nazionali ed internazionali che<br />
hanno attivato convenzioni per la sorveglianza della qualità<br />
dell’aria.: gli Enti eseguono mediante “radiello” i campionamenti<br />
di benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) e eventuali<br />
altri inquinanti (come ad esempio formaldeide o ozono),<br />
secondo la loro specifica programmazione spazio-temporale<br />
ed il Centro assicura la necessaria qualità analitica dei dati.<br />
Attività di Ricerca<br />
Il Centro è stato impegnato nei seguenti progetti di ricerca:<br />
Coordinamento e responsabilità scientifica nel progetto<br />
europeo MACBETH per il monitoraggio in sei città europee<br />
dell’esposizione personale al benzene, della concentrazione<br />
urbana e di quella domestica.<br />
Sviluppo di un modello sperimentale di monitoraggio atmosferico<br />
ad alta risoluzione spaziale per la verifica della riduzione<br />
delle emissioni dei precursori dell’ozono prevista dal<br />
programma Auto-Oil (progetto europeo RESOLUTION).<br />
Sviluppo di un dispositivo sequenziale per il monitoraggio<br />
ad alta risoluzione temporale del benzene, 1,3-butadiene,<br />
metilterbutiletere ed altri COV in aria urbana (progetto<br />
ARTEMIDE).<br />
Collaborazione nel progetto europeo PEOPLE per stabilire<br />
la correlazione fra inquinamento atmosferico urbano ed<br />
esposizione della popolazione in dieci capitali europee.<br />
Messa a punto del protocollo sperimentale per la misura<br />
di composti organici volatili in aria indoor e partecipazione<br />
alla “Campagna nazionale abitazioni” dell’Observatoire de<br />
la Qualité de l’Air Interieur, attivato dai ministeri delle costruzioni,<br />
della sanità e dell’ecologia della repubblica<br />
Francese.<br />
Collaborazione nel progetto EDEN per lo studio dei livelli<br />
di esposizione a benzene ed altri composti organici volatili<br />
(toluene, tetracloroetilene, cloroformio, 2-butossietanolo)<br />
di una popolazione di donne incinte e degli effetti<br />
dell’esposizione sull’accrescimento fetale.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Messa a punto e validazione di un metodo di campionamento<br />
e analisi di monomeri fluorurati in ambiente di lavoro.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Studio sperimentale per la valutazione di alcuni indicatori<br />
biologici di esposizione a 1,3-butadiene in ambiente di lavoro<br />
e confronto della tecnica di campionamento diffusivo<br />
con il metodo attivo per la misura dell’esposizione professionale.<br />
Valutazione del rischio e degli effetti clinici dell’esposizione<br />
ad aldeidi negli ambienti di vita (ricerca ISPESL).<br />
Progetti di Ricerca futuri<br />
Progetto “Comuni”, per lo sviluppo di un modello di monitoraggio<br />
della qualità dell’aria e dell’esposizione dei cittadini<br />
agli inquinanti atmosferici, mediante tecniche di campionamento<br />
diffusivo.<br />
Test di laboratorio del campionatore diffusivo “radiello”<br />
per il campionamento di nuovi agenti chimici.<br />
Studio delle prestazioni di nuovi substrati adsorbenti per<br />
desorbimento termico nel campionamento diffusivo di<br />
composti organici.<br />
Sviluppo di metodi e brevetti<br />
Il Centro ha progettato, sviluppato e brevettato un dispositivo<br />
di campionamento innovativo, basato sulla diffusione gassosa<br />
(radiello ® ), che non richiede l’utilizzo di pompe né di energia<br />
elettrica. Questo campionatore, grazie alle sue originali caratteristiche<br />
costruttive, ha accresciuto grandemente le potenzialità<br />
della tecnica di campionamento diffusivo, rispetto a<br />
quelle offerte dai campionatori preesistenti. Recentemente<br />
sono stati presentate tre domande di brevetto di altrettante<br />
evoluzioni del dispositivo originale, che consentono rispettivamente<br />
di ridurre o eliminare l’interferenza del vapor d’acqua e<br />
dell’anidride carbonica, di misurare in continuo e registrare la<br />
temperatura di campionamento, di contenere all’interno del<br />
campionatore diffusivo mezzi assorbenti liquidi.<br />
Attività Educazionale<br />
Il Centro ha attivato convenzioni con alcuni istituti di istruzione<br />
secondaria superiore e Università per lo svolgimento di<br />
stage e tirocini nei campi della chimica ambientale, dell’igiene<br />
industriale ed ambientale. Il Centro ha organizzato e svolto un<br />
corso di formazione, articolato in un modulo base ed uno<br />
avanzato, rivolto ai tecnici della prevenzione dell’Azienda Sanitaria<br />
Unica della regione Marche. Alcuni ricercatori del<br />
Centro svolgono attività di docenza come professori a contratto<br />
presso le Università di Pavia, Brescia e Padova.<br />
Pubblicazioni<br />
H. Skov, B.T. Sørensen, M.S. Landis, M.S. Johnson, P.<br />
Sacco, M.E. Goodsite, C. Lohse, K.S. Christiansen. Performance<br />
of a new diffusive sampler for Hg 0 determination in<br />
the troposphere. Environmental Chemistry 2007, 4 (2), 75-80.<br />
P. Sacco, M. Carrieri, C. Boaretto, E. Grignani, F. Salamon,<br />
G.B. Bartolucci, D. Cottica. Confronto fra metodi di campionamento<br />
ad aspirazione forzata e tecniche diffusive a<br />
simmetria radiale: applicazioni in ambiente di lavoro e di<br />
vita. 13° Convegno di Igiene Industriale “Le giornate di<br />
Corvara”, Corvara, marzo 2007.<br />
P. Sacco, E. Grignani, D. Pagani, F. Quaglio, L. Zaratin.<br />
Measurement of 1,3-Butadiene and Isoprene in Workplace<br />
air by Diffusive Sampling and Thermal Desorption<br />
GC Analysis. American Industrial Hygiene Conference and<br />
Exhibition, Philadelphia, giugno 2007.<br />
C. Manning, D. Cottica, L.S. Coyne, F.T. Posey, M. Eide. Issues<br />
and concerns in diffusive sampling - Factors influencing<br />
performance. American Industrial Hygiene Conference<br />
and Exhibition, Philadelphia, giugno 2007.<br />
D. Cottica, E. Grignani. La valutazione del rischio associato all’esposizione<br />
lavorativa a particelle nanometriche (NC e UF)<br />
in una situazione di insufficienza dele informazioni necessarie.<br />
25° Congresso Nazionale AIDII, Ancona, giugno 2007.<br />
P. Sacco, D. Pagani, F. Quaglio, L. Zaratin, D. Cottica, E.<br />
Grignani. Studio preliminare per il campionamento diffusivo<br />
di composti organici cancerogeni aerodispersi in ambienti<br />
di lavoro. 25° Congresso Nazionale AIDII, Ancona,<br />
giugno 2007.<br />
L. Zaratin, P. Sacco, C. Cocheo, D. Cottica, E. Grignani.<br />
Setup of a protocol for the measurement of volatile organic<br />
compounds and aldehydes in indoor air by means of<br />
diffusive sampling. International Conference on Healthy<br />
Air - Better Work 2007, Helsinki, maggio 2007.<br />
C. Cocheo, F. Frigerio, G. Andreani. Applicazione del D.L.<br />
187/05 nella cantieristica navale. 25° Congresso Nazionale<br />
AIDII, Ancona, giugno 2007.<br />
R. Slama, O. Thiebaugeorges, V. Goua, P. Sacco, I. Annesi-<br />
Maesano, M. Charles et al. Maternal personal exposure to<br />
benzene during pregnancy and intra-uterine growth. 19 th<br />
Conference of International Society for Environmental Epidemiology<br />
(ISEE), Mexico City, settembre 2007.<br />
C. Cocheo. Mappatura della qualità dell’aria ad alta risoluzione<br />
spaziale e temporale. Giornata di Studio “Emissioni<br />
autoveicolari - qualità dell’aria e salute”. Pavia, ottobre 2007.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Danilo Cottica, nato a Cremona il 23 maggio<br />
1949.<br />
Laurea in CHIMICA presso l’Università degli<br />
Studi di PV marzo1977.<br />
Abilitato alla professione, iscritto all’Albo professionale.<br />
Igienista Industriale Certificato dalla Associa<br />
zione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII).<br />
Dal maggio 1977 al marzo 1980 è Assistente poi Coadiutore<br />
del Direttore del Laboratorio d’Igiene Industriale della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS di Pavia (FSM).<br />
Dal 15 giugno 1997, con la qualifica di Direttore Tecnico, è Responsabile<br />
della U.O. d’Igiene Industriale del Laboratorio d’Igiene<br />
Ambientale e Tossicologia Industriale della FSM di Pavia.<br />
Dal giugno 2003 è Direttore del Centro Ricerche Ambientali<br />
della FSM in Padova.<br />
Dal Settembre 2003 è anche responsabile della U.O. di Igiene<br />
Industriale e Ambientale della FSM di Pavia.<br />
Dal 1984 è membro del Consiglio Direttivo dell’AIDII.<br />
Dal 1997 al 2000 Presidente AIDII; attualmente Past President.<br />
Responsabile di progetti di ricerca finalizzati nel campo dell’igiene<br />
industriale.<br />
Autore di circa 150 pubblicazioni e capitoli di libri su argomenti<br />
d’igiene industriale.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 29<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Membro della Commissione Aria-Ambiente dell’UNICHIM<br />
per la stesura di metodiche per il monitoraggio ambientale.<br />
Coordinatore Responsabile del Gruppo di Lavoro 1/SC 2<br />
- ARIA per le emissioni convogliate e la qualità dell’aria -<br />
Commissione Ambiente dell’UNI.<br />
Membro del Gruppo di Lavoro “Valutazione dei Rischi” istituito<br />
dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale (Regione<br />
Lombardia) per la definizione di Linee Guida Applicative del<br />
D.L. 626/94. Già adottata dalla conferenza Stato/Regioni.<br />
Vice Presidente del “Board of the International Occupational<br />
Hygiene Association” (IOHA).<br />
Membro di Commissioni del “Bureau Communitaire de Reference”<br />
(BCR) per la certificazione di standards di riferimento<br />
in materia di ambienti di lavoro, emissioni, qualità<br />
dell’aria.<br />
Delegato Italiano nel “Comitato Europeo di Normalizzazione<br />
(CEN): ComitatoTecnico 137/WG2 General Requirements<br />
for Measuring Procedures”.<br />
Delegato italiano del CEN/TC 264 “Air Quality”.<br />
Membro del “Working Group 5” dell’Health and Safety Executive<br />
(HSE) Inglese per l’applicazione e validazione dei<br />
campionatori a diffusione.<br />
Membro del Comitato di Redazione del “Giornale degli Igienisti<br />
Industriali”.<br />
Membro del Gruppo di lavoro della Sezione III del Consiglio<br />
Superiore di Sanità, Ministero della Salute, per le problematiche<br />
relative all’analisi e classificazione delle acque minerali<br />
naturali.<br />
Professore a Contratto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
dell’Università di PV;<br />
la Scuola di Specialità in Allergologia;<br />
la Scuola di Specialità in Medicina del Lavoro;<br />
Corso di Laurea per Tecnici d’Igiene Ambientale e del Lavoro.<br />
Professore a Contratto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
dell’Università di BS:<br />
Corso di Laurea per Tecnici d’Igiene Ambientale e del Lavoro.<br />
Docente accreditato dal Ministero dei Trasporti per corsi<br />
d’abilitazione al trasporto di merci pericolose (A.D.R.).<br />
30<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
7. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEI DISTRUTTORI ENDOCRINI<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 8<br />
Tel. 0382.59-2729/2732<br />
e-mail: luca.chiovato@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Luca Chiovato<br />
Il laboratorio per lo Studio dei Distruttori Endocrini è stato istituito<br />
dalla <strong>Fondazione</strong> nel 2005 nell’ambito di un progetto di<br />
ricerca finanziato dal Ministero della Salute che, in collaborazione<br />
con l’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro<br />
(ISPESL), ha portato all’inaugurazione nel dicembre 2006 di un<br />
Centro di Riferimento Nazionale per i Distruttori Endocrini. Il<br />
personale del laboratorio, il cui reclutamento è stato completato<br />
agli inizi del 2007, comprende due contrattisti medici e<br />
una contrattista biologa. Il laboratorio è diretto dal Prof. Luca<br />
Chiovato, straordinario di Endocrinologia e Direttore della<br />
scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio<br />
dell’Università di Pavia.<br />
Attività di Ricerca<br />
La missione del laboratorio è lo studio degli effetti sulla salute<br />
di composti chimici definiti “Distruttori Endocrini” (Endocrine<br />
Disrupting Chemicals, EDC). Questi comprendono numerose<br />
sostanze prevalentemente di origine industriale che “interferiscono<br />
con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo,<br />
il legame, l’azione o l’eliminazione degli ormoni che nell’organismo<br />
mantengono l’omeostasi e regolano i processi di sviluppo”.<br />
La letteratura riguardante gli EDC ha posto l’attenzione<br />
sui possibili danni per l’ecosistema (soprattutto alcune<br />
specie animali selvatiche) e per la popolazione generale, quest’ultima<br />
interessata attraverso la catena alimentare. I livelli<br />
d’esposizione più elevati a molti EDC avvengono nell’ambiente<br />
di lavoro, sia quello interessato alla produzione sia quello<br />
coinvolto nell’utilizzo di queste sostanze. Le alterazioni del si-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
stema endocrino attribuite ai vari EDC comprendono: 1) riduzione<br />
della fertilità maschile e femminile; 2) menopausa precoce;<br />
3) maggior rischio di aborto o di perdita fetale; 4) difetti<br />
congeniti; 5) aumento del rischio per alcuni tumori dell’apparato<br />
riproduttivo maschile (prostata, testicolo) o femminile<br />
(mammella, ovaio); 6) alterazioni della funzione tiroidea che,<br />
nel corso della gravidanza e nella prima infanzia, possono<br />
avere conseguenze irreversibili sullo sviluppo neurocognitivo.<br />
La lista delle sostanze chimiche incriminate per un possibile<br />
effetto EDC è vastissima: idrocarburi aromatici policiclici, 1,3<br />
butadiene, isoprene, stirene, vinilcloexene (tossicità ovarica);<br />
fitoestrogeni, composti organici contenenti cloro (alterazioni<br />
riproduttive); erbicidi, insetticidi, fungicidi con azione xenoestrogenica<br />
(neoplasie dell’apparato riproduttivo maschile o<br />
femminile); composti organici contenenti cloro, pesticidi, diossina,<br />
metalli pesanti (tossicità testicolare); stirene, pesticidi,<br />
carbamati, composti organici contenenti cloro, organofosfati,<br />
piretroidi, tiocarbamati, tiouree, ftalati, composti polialogenati,<br />
derivati fenolici (alterazioni della funzione tiroidea).<br />
A fronte della vasta letteratura riguardante gli effetti degli EDC<br />
sulla fauna selvatica e sugli animali da esperimento, i dati sui<br />
possibili danni per la salute umana sono ancora limitati. In<br />
particolare, sono ancora da definire: 1) il meccanismo d’azione<br />
di molti EDC sui singoli assi endocrini; 2) i rischi reali di<br />
alterazione endocrina legati all’esposizione a singole sostanze<br />
o a miscele di sostanze diverse; 3) i livelli d’esposizione che<br />
possono provocare un’alterazione dei singoli assi endocrini<br />
nell’uomo; 4) i tempi d’esposizione necessari per provocare<br />
un’alterazione endocrina.<br />
Tra i vari composti chimici con effetto EDC, un rilievo particolare<br />
assumono i pesticidi. Per il massiccio impiego nell’agricoltura<br />
intensiva queste sostanze si accumulano nell’ecosistema<br />
e, entrando nella filiera alimentare, possono raggiungere<br />
tutti gli strati della popolazione. Gli effetti distruttivi endocrini<br />
attribuiti ai pesticidi sono: alterazioni nello sviluppo<br />
dell’apparato genito-urinario maschile (ipospadia, criptorchidismo),<br />
riduzione del numero degli spermatozoi e della fertilità;<br />
aumentata frequenza di aborto e di malformazioni congenite;<br />
alterazione del rapporto maschi/femmine alla nascita;<br />
precoce sviluppo sessuale, inibizione della lattazione e effetto<br />
favorente lo sviluppo del carcinoma mammario nel sesso femminile;<br />
azione gozzigena e possibile effetto favorente la carcinogenesi<br />
tiroidea in ambedue i sessi. Le principali informazioni<br />
sugli effetti EDC dei pesticidi derivano da osservazioni<br />
nella fauna selvatica. I dati nell’uomo sono molto meno circostanziati<br />
e spesso controversi. I meccanismi responsabili degli<br />
effetti distruttivi endocrini dei pesticidi consistono in un’azione<br />
estrogeno-simile e/o anti-androgena, e in un’azione anti-tiroidea.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Valutazione dell’esposizione a composti chimici con effetto<br />
di endocrine disruptors nell’ambiente di lavoro e definizione<br />
del rischio per i lavoratori esposti. Responsabili:<br />
Prof. Luca Chiovato, U.O. di Medicina Interna e Endocrinologia,<br />
Istituto di Pavia; Prof. M. Imbriani, Servizio di Fisiopatologia<br />
Respiratoria, Fisiologia del lavoro e Ergonomia,<br />
Istituto di Pavia. Linea di ricerca: Rischi occupazionali<br />
e ambientali da attività produttive. Tipo di Ricerca:<br />
Corrente.<br />
Effetto distruttivo endocrino e/o neurotossico di contaminanti<br />
industriali, erbicidi e pesticidi presenti nella filiera<br />
alimentare. Responsabile: Prof. Luca Chiovato, U.O. di Medicina<br />
Interna e Endocrinologia, Istituto di Pavia. Linea di<br />
Ricerca: Rischi occupazionali e ambientali da attività produttive.<br />
Tipo di Ricerca: Ricerca Strategica Finalizzata, Ministero<br />
della Salute.<br />
Effetto degli idrocarburi policiclici aromatici sulla funzione<br />
tiroidea in vigili urbani esposti a gas di scarico di autoveicoli.<br />
Responsabile: Prof. Luca Chiovato, U.O. di Medicina<br />
Interna e Endocrinologia, Istituto di Pavia. Linea di Ricerca:<br />
Rischi occupazionali e ambientali da attività produttive.<br />
Tipo di Ricerca: Ricerca Finalizzata ISPESL.<br />
Attività Educazionale<br />
Corsi ECM per Endocrinologi, Medici del Lavoro e Operatori<br />
della Sanità Pubblica sugli effetti dei Distruttori Endocrini e sui<br />
metodi utilizzati perla loro rilevazione.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Tutti i progetti di ricerca in corso si sviluppano nel concetto di<br />
traslazionalità che prevede il trasferimento delle nozioni ottenute<br />
nel laboratorio di ricerca in immunochimica, biologia cellulare<br />
e molecolare alla clinica e alla salute pubblica.<br />
Metodi messi a punto<br />
Test di inibizione del legame del 125-I TSH al recettore<br />
umano ricombinante del TSH (hrTSHR).<br />
Test di inibizione della adenilato-ciclasi TSH dipendente in<br />
cellule CHO transfettate stabilmente con il gene umano<br />
del recettore del TSH o in cellule FRTL-5.<br />
Test di inibizione della captazione dello ioduro (125-I) in<br />
cellule CHO transfettate stabilmente con il gene umano<br />
del cotrasportatore Sodio/Iodio (NIS) o in cellule FRTL-5.<br />
Test di inibizione della organificazione dello ioduro in follicoli<br />
tiroidei ricostituiti.<br />
Pubblicazioni<br />
Rotondi M, Netti GS, Rosati A, Mazzinghi B, Magri F, Ronconi<br />
E, Becherucci F, Pradella F, Salvadori M, Serio M, Romagnani<br />
P, Chiovato L. Pretransplant serum FT3 levels in<br />
kidney graft recipients are useful for identifying patients<br />
with higher risk for graft failure. Clin Endocrinol (Oxf).<br />
2007 Sep 4. [Epub ahead of print]<br />
Lazzeri E, Crescioli C, Ronconi E, Mazzinghi B, Sagrinati C,<br />
Netti GS, Angelotti ML, Parente E, Ballerini L, Cosmi L,<br />
Maggi L, Gesualdo L, Rotondi M, Annunziato F, Maggi E,<br />
Lasagni L, Serio M, Romagnani S, Vannelli GB, Romagnani<br />
P. Regenerative potential of embryonic renal multipotent<br />
progenitors in acute renal failure. J Am Soc Nephrol 2007;<br />
18: 3128-3138.<br />
Nappi RE, Albani F, Valentino V, Polatti F, Chiovato L, Genazzani<br />
AR Aging and sexuality in women. Minerva Ginecol<br />
2007 Jun; 59 (3): 287-98.<br />
Rotondi M, Chiovato L, Romagnani S, Serio M, Romagnani<br />
P. Role of chemokines in endocrine autoimmune diseases.<br />
Endocr Rev 2007 Aug; 28 (5): 492-520. Epub 2007 May 2.<br />
Tonacchera M, Banco ME, Montanelli L, Di Cosmo C,<br />
Agretti P, De Marco G, Ferrarini E, Ordookhani A, Perri A,<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 31<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Chiovato L, Santini F, Vitti P, Pinchera A. Genetic analysis<br />
of the PAX8 gene in children with congenital hypothyroidism<br />
and dysgenetic or eutopic thyroid glands: identification<br />
of a novel sequence variant. Clin Endocrinol (Oxf).<br />
2007 Jul; 67 (1): 34-40. Epub 2007 Apr 15.<br />
Rotondi M, Minelli R, Magri F, Leporati P, Romagnani P,<br />
Baroni MC, Delsignore R, Serio M, Chiovato L. Serum<br />
CXCL10 levels and occurrence of thyroid dysfunction in<br />
patients treated with interferon-alpha therapy for hepatitis<br />
C virus-related hepatitis. Eur J Endocrinol 2007 Apr; 156<br />
(4): 409-14.<br />
Chiovato L. Obesity and respiratory function. Monaldi<br />
Arch Chest Dis 2006 Jun; 65 (2): 67-8.<br />
Amabile G, Rotondi M, Chiara GD, Silvestri A, Filippo BD,<br />
Bellastella A, Chiovato L. Low-energy interstitial laser photocoagulation<br />
for treatment of nonfunctioning thyroid nodules:<br />
therapeutic outcome in relation to pretreatment and<br />
treatment parameters. Thyroid 2006 Aug; 16 (8): 749-55.<br />
Rotondi M, Precerutti S, Chiovato L. Maternal hypothyroidism<br />
in early gestation: possible preventive strategies. Clin<br />
Endocrinol (Oxf). 2006 May; 64 (5): 599-601.<br />
Dentice M, Cordeddu V, Rosica A, Ferrara AM, Santarpia<br />
L, <strong>Salvatore</strong> D, Chiovato L, Perri A, Moschini L, Fazzini C,<br />
Olivieri A, Costa P, Stoppioni V, Baserga M, De Felice M,<br />
Sorcini M, Fenzi G, Di Lauro R, Tartaglia M, Macchia PE.<br />
Missense mutation in the transcription factor NKX2-5: a<br />
novel molecular event in the pathogenesis of thyroid dysgenesis.<br />
J Clin Endocrinol Metab 2006 Apr; 91 (4): 1428-<br />
33. Epub 2006 Jan 17.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Nome e Cognome: Luca Chiovato.<br />
Data e luogo di nascita: 29 febbraio 1952,<br />
Pisa.<br />
Educazione superiore: Maturità Classica,<br />
Liceo Classico Galileo Galilei, Pisa, 1970.<br />
Educazione universitaria: Laurea in Medicina<br />
e Chirurgica (Università di Pisa, 1976).<br />
Specializzazione in Medicina Interna (Università<br />
di Pisa, 1982). Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrine e<br />
Metaboliche (Università di Firenze, 1988).<br />
Posizione attuale: Professore straordinario di Endocrinologia,<br />
Titolare della Cattedra di Endocrinologia dell’Università<br />
di Pavia (Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica);<br />
Direttore U.O. di Medicina Interna e Endocrinologia, <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> - I.R.C.C.S., Istituto di Pavia.<br />
Borse di studio: Wellcome Foundation Grant (1981-1983).<br />
Premi: 1° Premio CIS per la Ricerca RIA (1989).<br />
Soggiorni esteri: Visiting Research fellow, Department of<br />
Immunology, Middlesex Hospital Medical School (University<br />
of London) 1981-1983. Guest Professor, Department of Immunology,<br />
London Hospital Medical College (University of<br />
London), 1992; Vollum Institute of Neuroscience, University of<br />
Oregon, Portland, 2001.<br />
Società scientifiche: Società Italiana di Endocrinologia (dal<br />
1979); European Thyroid Association (dal 1984); International<br />
Society of Gynecological Endocrinology (dal 1992); Interna-<br />
32<br />
tional Society for Neonatal Screening (dal 1994); Endocrine<br />
Society (dal 1997); Società Italiana dell’Obesità (dal 2002).<br />
Insegnamenti: Immunology Course (Department of Immunology,<br />
Middlesex Hospital Medical School, University of<br />
London), 1982. Immunoendocrinologia (Scuola di Specializzazione<br />
in Endocrinologia, Università di Pisa, 1991-2001).<br />
Principali campi di ricerca: Autoimmuità tiroidea; fisiopatologia<br />
e clinica delle malattie tiroidee incluse ipotiroidismo<br />
congenito, oftalmopatia basedowiana, tiroidite autoimmune e<br />
carcinoma della tiroide; genetica dell’obesità; distruttori endocrini.<br />
Pubblicazioni: 147 lavori su riviste indicizzate da Pub<br />
Med/Medline; 82 capitoli in Trattati Italiani e Internazionali;<br />
28 lavori su riviste non indicizzate; più di 300 Abstract presentati<br />
a Congressi Nazionali e Internazionali. Lavori comparsi<br />
sulle riviste: Nature, Nature Genetics, Clinical Genetics,<br />
Lancet, Annals of Internal Medicine, Surgery, Neuropsychobiology,<br />
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,<br />
Endocrinology, Clinical Endocrinology, Acta Endocrinologica<br />
(European Journal of Endocrinology), Journal of Endocrinology,<br />
Journal of Endocrinological Investigations, Molecular Endocrinology,<br />
Thyroid, Molecular and cellular Endocrinology,<br />
Clinical and Experimental Immunology, Seminars in Immunology,<br />
Autoimmunity, Journal of Autoimmunity, Aging Clinical<br />
and Experimental Research, Journal of Biological Chemistry,<br />
Biochimie, European Journal of Biochemistry, Biochemical<br />
Biophysical Research Communications, International Journal<br />
of Obesity and Related Metabolic Disorders, Endocrinology<br />
and Metabolism Clinics of North America, Baillieres’ Clinics in<br />
Endocrinology and Metabolism, Experimental and Clinical<br />
Endocrinology and Diabetes, American Journal of Pathology,<br />
Endocrine Reviews.<br />
Impact factor totale: Oltre 500.<br />
Comitati editoriali: Journal of Clinical Endocrinology and<br />
Metabolism (1996-2001), Thyroid, Eating and Weight Disorders,<br />
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e Ergonomia,<br />
L’Endocrinologo.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
8. CENTRO INTERUNIVERSITARIO<br />
DI RICERCHE IN MEDICINA AMBIENTALE<br />
E MEDICINA DEL LAVORO<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Sede di Via Boezio, 24<br />
Tel. 0382.593701<br />
e-mail: mimbriani@fsm.it<br />
Direttore: Prof. Marcello Imbriani<br />
Il Centro Interuniversitario di Ricerche in Medicina Ambientale<br />
e in Medicina del Lavoro, in convenzione con la <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> di Pavia, è stato istituito dalla Università<br />
degli Studi di Pavia e dall’Università degli Studi di Foggia nell’anno<br />
2005 ed è convenzionato con la <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, Istituto scientifico di Pavia.<br />
Attualmente il personale del Centro è costituito da personale<br />
universitario (11 Professori, 3 Ricercatori, 1 tecnico, 1 borsista<br />
medico specialista in Medicina del lavoro, 1 collaboratore<br />
ad attività di ricerca dell’Università degli Studi di Pavia<br />
specialista in Medicina del lavoro) e da personale della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> (1 Medico specialista in Medicina del Lavoro,<br />
1 Chimico, 2 biologi, 1 tecnico di laboratorio).<br />
Il Consiglio Scientifico del Centro, coordinato dal Prof. Marcello<br />
Imbriani, è costituito dai Professori Giovanni Catenacci,<br />
Maria Teresa Tenconi (Dipartimento di Medicina Preventiva,<br />
Occupazionale e di Comunità dell’Università degli Studi di<br />
Pavia), Luca Chiovato, Gianmario Frigo (Dipartimento di Medicina<br />
interna e Terapia medica dell’Università degli Studi di<br />
Pavia), Pietro Fiore, Roberto Zefferino e dalla Dottoressa Rosa<br />
Prato (Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro dell’Università<br />
degli Studi di Foggia).<br />
Il Centro si caratterizza per la finalità di promuovere e svolgere<br />
attività di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della<br />
Medicina Ambientale e Occupazionale, finalizzata allo studio<br />
dei fattori di rischio e relativi rischi ambientali e occupazionali.<br />
In particolare, il Centro è impegnato in progetti di ricerca relativi<br />
a:<br />
Assorbimento, distribuzione e eliminazione di xenobiotici<br />
aeriformi, come i solventi e gli anestetici.<br />
Effetti della esposizione occupazionale a sostanze interferenti<br />
sul sistema endocrino, come i pesticidi.<br />
Valutazione del dispendio energetico mansionario.<br />
Valutazione di nuove metodiche per l’individuazione di indicatori<br />
biologici predittivi di effetti avversi, come la raccolta<br />
dell’aria espirata e l’analisi di composti organici volatili<br />
in situazioni di normalità e di patologia.<br />
Campionamento di matrici biologiche e dosaggio di inquinanti<br />
presenti nell’ambiente di vita e di lavoro, accumulati<br />
in diversi distretti dell’organismo e i cui effetti sono tuttora<br />
in corso di studio, come i composti perfluorati.<br />
Il Centro poggia su esperienze specifiche, già acquisite, nel<br />
campo del monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione<br />
occupazionale ed ambientale a solventi aromatici ed alifatici,<br />
gas anestetici, idrocarburi aromatici polinucleari, additivi<br />
per carburanti.<br />
Sono inoltre già stati messi a punto i metodi di laboratorio relativi<br />
a:<br />
dosaggio di sostanze tal quali nelle urine (solventi, anestetici);<br />
dosaggio di mercapturati specifici nelle urine;<br />
misura diretta e indiretta del stipendio energetico in situazioni<br />
lavorative diversificate.<br />
Pubblicazioni<br />
Imbriani M, Marraccini P, Saretto G, Abatangelo L, Ghittori<br />
S, Cavalleri A. Il dosaggio della N-metilformamide nella<br />
esposizione professionale a N,N-dimetilformamide. Med<br />
Lav 2000; 2: 114-124.<br />
Haufroid V, Buchet J, Gardinal S, Ghittori S, Imbriani M,<br />
Hirvonen A, Lison D. Importance of genetic polymorphisms<br />
of drug-metabolizing enzymes for the interpretation<br />
of biomarkers of exposure to styrene. Biomarkers<br />
99; 2001; 6-3: 236-249.<br />
Imbriani M, Niu Qiao, Negri S, Ghittori S. Trichloroethylene<br />
in urine as biological exposure index Industrial Health<br />
2001; 39: 225-230.<br />
Verdina A, Galati R, Falasca G, Ghittori S, Imbriani M,<br />
Tomei F, Marcellini L, Zijno A, Del Vecchio V, Crebelli R.<br />
Metabolic Polymorphisms and urinary biomarkers in<br />
subjects with low benzene exposure. J Toxicol Environ<br />
Health 2001; 64: 607-618.<br />
Imbriani M, Negri S, Ghittori S, Maestri L. Measurement of<br />
urinary N-acetyl-S- (N-methylcarbamoyl) cysteine by highperformance<br />
liquid chromatography with direct ultraviolet<br />
detection. J Chromatography B 2002; 778; 231; 236.<br />
Imbriani M, Maestri L, Marracini P, Saretto G, Alessio A,<br />
Negri S. Urinary determination of n-acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)cysteine<br />
an methylformamide in workers exposed<br />
to N,N-dimethylformamide. Int Arch Occup Environ<br />
Health 2002; 75, 7; 445; 452.<br />
Vodicka P, Tuimala J, Stetina R, Imbriani M, K. Hemminki.<br />
Cytogenetic markers, DNA single-strand breaks, urinary<br />
metabolites, and DNA repair rates in styrene-exposed lamination<br />
workers. Environmental Health Perspectives<br />
2004; 112 (8); 867; 871.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 33<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Imbriani M, Ghittori S, Maestri L. Occupational exposure<br />
of midwives to nitrius oxide on delivery suites. Occup Environ<br />
Med 2004; 69; 137.<br />
Imbriani M, Ghittori S, Maestri L. Occupational exposure<br />
of midwives to nitrius oxide on delivery suites. Occup Environ<br />
Med 2004; 61; 558; 559.<br />
Maestri L, Negri S, Ferrari M, Ghittori S, Imbriani M. Determination<br />
of urinary S-phenylmercapturic acid, a specific<br />
metabolite of benzene, by liquid chromatography/single<br />
quadrupole mass spectrometry. Rapid Communications in<br />
Mass Spectrometry 2005; 19; 1; 6.<br />
Negri S, Bono R, Maestri L, Ghittori S, Imbriani M. Highpressure<br />
liquid chromatographic-mass spectrometric determination<br />
of sorbic acid in urine: verification of formation<br />
of trans,trans-muconic acid. Chem Biol Interact 2005;<br />
30; 243; 246.<br />
CURRICULUM VITAE DEL DIRETTORE<br />
DEL CENTRO<br />
Nome e cognome: Marcello Imbriani<br />
Nazionalità: Italiana<br />
Data di nascita: 26 ottobre 1951<br />
Indirizzo (lavoro): Facoltà di Medicina, Università<br />
di Pavia - <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>,<br />
IRCCS - Via S. <strong>Maugeri</strong>, 4 - I - 27100 Pavia<br />
- Tel. 0039-0382-592990, Fax 0039-0382-<br />
592514 - e-mail: pfr@fsm.it<br />
Education<br />
Laureato in Medicina e Chirurgia, Università di Pavia, 1976.<br />
Specialista in Medicina del Lavoro, Università di Pavia, 1979.<br />
Specialista in Malattie dell’Apparato respiratorio, Università<br />
di Pavia, 1982.<br />
Incarichi attualmente ricoperti<br />
1. Direttore Scientifico della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRCCS.<br />
2. Professore Straordinario di Medicina del Lavoro presso<br />
l’Università di Pavia.<br />
3. Direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e<br />
Immunologia Clinica.<br />
4. Direttore del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale.<br />
5. Componente del Consiglio di Amministrazione della <strong>Fondazione</strong><br />
S. <strong>Maugeri</strong>, IRCCS.<br />
6. Direttore del Servizio accreditato di Fisiopatologia respiratoria<br />
ed Ergonomia attivato presso l’Istituto scientifico di<br />
Pavia della <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong> e Direttore del Servizio<br />
di Medicina Occupazionale e Medicina Ambientale attivato<br />
presso l’Istituto scientifico di Pavia della <strong>Fondazione</strong><br />
S. <strong>Maugeri</strong>.<br />
7. Componente del Consiglio direttivo della Società Italiana<br />
di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII).<br />
8. Componente del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio<br />
per la formazione in Medicina dello Sport”, costituito<br />
da Istituto Superiore di Sanità (ISS), Federazione Medico<br />
Sportiva Italiana (FMSI) e <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>,<br />
IRCCS.<br />
9. Amministratore delegato del “Consorzio per l’accreditamento<br />
e aggiornamento in Medicina del Lavoro”, costi-<br />
34<br />
tuito da Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene<br />
Industriale e <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>, IRCCS.<br />
10. Componente del Consiglio Direttivo del Centro di studio e<br />
di ricerca in Medicina di Comunità per la promozione della<br />
salute umana per il triennio accademico 2003-2006.<br />
11. Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio<br />
Pavese per Studi Postuniversitari nell’Area Sanitaria.<br />
12. Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio<br />
per le valutazioni biologiche e farmacologiche.<br />
13. Componente del Consiglio direttivo di “Alleanza contro il<br />
cancro” costituito da 11 IRCCS presso il Ministero della<br />
Salute.<br />
14. Editor e Direttore responsabile della rivista indicizzata<br />
“Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia”.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
1. LABORATORIO DI RICERCA<br />
SULLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921<br />
e-mail: gabriele.mora@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Gabriele Mora<br />
Il laboratorio ha come obiettivo primario quello di sviluppare<br />
una ricerca di base in stretta sinergia con l’attività clinica mirata<br />
allo studio delle patologie neurodegenerative. Gli scopi<br />
principali sono, da una parte quello di identificare dei marcatori<br />
biomolecolari selettivi che permettano una diagnosi precoce<br />
di queste malattie nell’uomo, dall’altra quello di individuare<br />
molecole bersaglio per lo sviluppo di farmaci o altre<br />
strategie terapeutiche.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca del laboratorio è attualmente mirata soprattutto<br />
allo studio della sclerosi laterale amiotrofica (SLA),<br />
una malattia che colpisce in modo selettivo i motoneuroni<br />
provocando la paralisi progressiva dei muscoli scheletrici e la<br />
morte prematura in individui adulti. Da molti anni la <strong>Fondazione</strong><br />
ha maturato, in alcuni dei suoi centri, un modello clinico<br />
assistenziale per questa patologia basato sull’approccio interdisciplinare<br />
che è tuttora di riferimento sia a livello nazionale<br />
che internazionale. Lo scopo delle ricerche è duplice: 1) quello<br />
di fornire parametri utili alla diagnosi precoce della malattia<br />
attraverso l’analisi di fattori potenzialmente neurotossici noti<br />
(es. citochine, chemochine, marcatori di stress ossidativo) e di<br />
fattori non noti identificabili mediante analisi proteomica, nel<br />
liquor e in tessuti periferici di pazienti affetti da SLA in confronto<br />
ad individui sani o affetti da altre malattie neurodegenerative;<br />
2) quello di capire i meccanismi patogenetici attraverso<br />
lo sviluppo di modelli cellulari ottenuti da tessuti periferici<br />
di pazienti affetti da SLA (es. colture primarie di linfociti e<br />
di fibroblasti) nei quali sia possibile indagare i meccanismi<br />
molecolari di morte cellulare in analogia con le ipotesi deri-<br />
vanti dagli studi sperimentali. Il riscontro di marker di malattia<br />
a livello periferico sarebbe di estrema importanza per la pianificazione<br />
e la valutazione dell’outcome nei trial clinici.<br />
Inoltre è in corso di allestimento una banca di campioni biologici<br />
ottenuti dai pazienti che comprende DNA, sieri e linee<br />
cellulari di fibroblasti da utilizzare per indagini epidemiologiche<br />
biochimiche e genetiche in collaborazione con centri di<br />
ricerca sulla SLA nazionali e internazionali.<br />
Collaborazioni Scientifiche<br />
Consulenza continuativa con il Dipartimento di Neuroscienze,<br />
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri<br />
di Milano (Dr.ssa Caterina Bendotti).<br />
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino.<br />
Dipartimento di Biologia, Università di Roma Tor Vergata.<br />
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.<br />
Sono inoltre in corso collaborazioni con organismi internazionali<br />
quali la World Federation of Neurology e lo European ALS<br />
Study Group.<br />
Attività Educazionale<br />
Attività di formazione per studenti e dottorandi in Biologia.<br />
Letture e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.<br />
Seminari e lezioni a corsi ECM.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Lo sviluppo di modelli cellulari da pazienti affetti da SLA, in<br />
confronto con individui sani, potrà fornire elementi utili all’identificazione<br />
di possibili marcatori diagnostici e target terapeutici.<br />
I risultati acquisiti potrebbero avere una ricaduta sullo<br />
sviluppo di test diagnostici e di nuove terapie e quindi essere<br />
brevettati.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Misurazione di fattori infiammatori nel liquor e nel siero di<br />
pazienti affetti da SLA a diversi stadi di malattia in confronto<br />
ad individui sani o affetti da altre patologie neurodegenerative.<br />
L’attivazione di meccanismi infiammatori ed<br />
immunitari è considerata uno dei processi attivamente<br />
coinvolti nella patogenesi della SLA. La recente acquisizione<br />
in laboratorio del Bioplex (Biorad), uno strumento<br />
per la misurazione in un solo campione di liquor o di siero<br />
di 27 diverse citochine e chemochine contemporaneamente,<br />
permette di delineare un profilo immuno-infiammatorio<br />
dei pazienti SLA durante la progressione di malattia.<br />
Tale profilo sarà utile non solo per identificare se e<br />
quali tra i fattori infiammatori considerati siano specificamente<br />
correlabili con la malattia ma anche per caratterizzare<br />
eventuali sottopopolazioni di pazienti.<br />
Analisi proteomica in PBMC (Peripheral Blood Mononuclear<br />
Cell) di pazienti SLA, in confronto ad individui sani<br />
per individuare proteine differenzialmente espresse correlabili<br />
con la progressione della malattia. L’indagine preliminare<br />
ha mostrato una differente espressione di varie<br />
proteine nei pazienti SLA rispetto ai controlli. Attualmente<br />
l’attenzione è focalizzata sullo studio della ciclofillina A,<br />
una proteina multifunzionale altamente presente nel sistema<br />
nervoso centrale così come nei linfociti ed eritrociti.<br />
In particolare nei PBMC di pazienti SLA ad uno stadio<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 35<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
meno grave di malattia è stata osservata l’alterazione specifica<br />
di un’isoforma di questa proteina similmente a<br />
quanto osservato nel midollo spinale di un modello murino<br />
di SLA familiare allo stadio presintomatico. Ulteriori studi<br />
sono in corso per capire il ruolo della ciclofillina A nella<br />
patogenesi della SLA.<br />
Valutazione dei livelli di nitrotirosina (NT) ed analisi proteomica<br />
delle proteine nitrate estratte da PBMC di pazienti<br />
con SLA in confronto a quelli di individui sani. Un aumento<br />
dei livelli di NT circolante libera o legata alle proteine è generalmente<br />
considerato un marker di formazione del perossinitrito,<br />
una molecola altamente reattiva che provoca<br />
un danno irreversibile di alcune proteine. Nei midolli spinali<br />
sia di pazienti con SLA che di modelli animali di degenerazione<br />
motoneuronale sono stati osservati elevati livelli<br />
di NT. Lo scopo di questo studio è quello di valutare<br />
se alterazioni di NT possano essere rilevate anche a livello<br />
periferico costituendo così un marker di progressione<br />
della patologia. Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento<br />
di Biochimica dell’Istituto Mario Negri si sta valutando<br />
mediante analisi proteomica eventuali differenze tra<br />
le proteine nitrate nei pazienti SLA rispetto ai controlli<br />
sani.<br />
Valutazione dell’effetto di sieri di pazienti SLA, in confronto<br />
a quelli di individui sani, sulla vulnerabilità di linee<br />
cellulari di neuroblastoma umano trasfettate con mutanti<br />
SOD1. Lo scopo di questo studio, in collaborazione con<br />
l’Università di Roma Tor Vergata, è quello di individuare<br />
possibili fattori tossici circolanti che possano rendere più<br />
suscettibili le cellule di origine neurale con predisposizione<br />
genetica alla degenerazione.<br />
Stesura del manoscritto che riporta i risultati dello studio<br />
delle caratteristiche e dello stato di attivazione di segnali<br />
intracellulari delle popolazioni linfocitarie isolate da pazienti<br />
affetti da SLA a diversi stadi di malattia in confronto<br />
ad individui sani. I risultati dimostrano che nei pazienti<br />
SLA c’è una significativa diminuzione della percentuale<br />
dei linfociti CD8 associata ad una diminuzione dei livelli<br />
della proteina antiapoptotica Bcl2. Al contrario la percentuale<br />
dei linfociti CD4 è significativamente aumentata.<br />
Sono state inoltre osservate alterazioni nelle percentuali<br />
dei linfociti T regolatori e dei monociti, indicando un profilo<br />
immunologico alterato in questi pazienti.<br />
Strumentazione<br />
La dotazione del Laboratorio si è arricchita di una nuova apparecchiatura<br />
donata dalla <strong>Fondazione</strong> Vialli e Mauro, il Bioplex.<br />
Questa nuova apparecchiatura, del valore di circa 60<br />
mila euro, permette in tempi rapidi e con un’unica, piccola<br />
quantità di campione biologico la quantificazione simultanea<br />
e ad alta sensibilità di un numero elevato (fino a 100) di molecole<br />
di interesse quali proteine, peptidi, acidi nucleici. Sarà<br />
così possibile ottenere importanti informazioni sia sulle interrelazioni<br />
delle molecole coinvolte nei meccanismi che portano<br />
al danno motoneuronale che caratterizza la SLA, sia sugli indicatori<br />
diagnostici della malattia.<br />
Pubblicazioni<br />
Schymick JC, Scholz SW, Hon-Chung Fung, Britton A,<br />
Sampath Arepalli, Gibbs JR, Lombardo F, Mar Matarin,<br />
36<br />
Kasperaviciute D, Hernandez DG, Crews C, Bruijn L, Rothstein<br />
J, Mora G, Restagno G, Chiò A, Singleton A, Hardy J,<br />
Traynor BJ. Genome-wide genotyping in amyotrophic lateral<br />
sclerosis and neurologically normal controls: first<br />
stage analysis and public release of data. Lancet Neurol<br />
2007; 6: 322-28.<br />
Peviani M, Cheroni C, Troglio F, Quarto M, Pelicci G, Bendotti<br />
C. Lack of changes in the PI3K/AKT survival pathway<br />
in the spinal cord motor neurons of a mouse model of familial<br />
amyotrophic lateral sclerosis. Mol Cell Neurosci<br />
2007; 34 (4): 592-602.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Gabriele Mora. Nato il 26 Marzo 1953 a<br />
Milano. Cittadinanza italiana.<br />
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università<br />
degli Studi di Milano (novembre<br />
1979). Specializzazione in Neurologia (novembre<br />
1983).<br />
Dal 1 Marzo 1985 al 31 Marzo 2004 ha lavorato in qualità di<br />
neurologo presso la Divisione di Neurologia dell’Istituto Scientifico<br />
di Veruno, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS, ove ricopriva<br />
l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice<br />
e di Coordinatore dell’Unità Multidisciplinare per lo Studio e<br />
l’Assistenza dei Pazienti con SLA.<br />
Dal 1 Aprile 2004 a tutt’oggi Dirigente di 1° livello della Unità<br />
Operativa di Neuroriabilitazione II dell’Istituto Scientifico di<br />
Pavia, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
È responsabile del Laboratorio di Ricerca Sperimentale sulle<br />
Malattie Neurodegenerative, con sede nello stesso Istituto.<br />
Dal 1 Gennaio 2005 è Direttore del Dipartimento Neuromotorio<br />
– Neuroscienze della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dal 10.4.2003 al 15.12.2003 è stato membro della Commissione<br />
Ministeriale per la Diagnosi, Cura e Assitenza ai Pazienti<br />
con Sclerosi Laterale Amiotrofica.<br />
Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale “Amyotrophic<br />
Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Disorders”.<br />
Membro della World Federation of Neurology, ALS Subcommittee,<br />
dell’Italian ALS Study Group e del European ALS/MND<br />
Study Group.<br />
Autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste censite internazionali<br />
e nazionali, capitoli di libri, e presentazioni a congressi internazionali.<br />
Dal 1987 la sua attività è mirata particolarmente allo studio<br />
della SLA. Coordina un team multidisciplinare che segue oltre<br />
50 pazienti ogni anno. Ha studiato l’impatto di nuove procedure,<br />
come la gastrostomia e la ventilazione non invasiva, sulla<br />
qualità della vita e la sopravvivenza. Durante questi anni ha<br />
compiuto trial clinici per valutare l’efficacia di nuove molecole,<br />
come aminoacidi a catena ramificata, deprenyl, ceftriaxone, interferone<br />
beta 1b, gabapentin, rhIGF1, ONO 2506PO.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
2. LABORATORIO DI BIOPSIA CUTANEA<br />
NEURODIAGNOSTICA<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.592021<br />
e-mail: michelangelo.buonocore@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Michelangelo Buonocore<br />
Il laboratorio di biopsia cutanea neurodiagnostica dell’Istituto<br />
di Pavia della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> è stato istituito nel 2005 in<br />
virtù dell’esperienza pluriennale maturata presso l’omologo<br />
laboratorio già presente presso l’Istituto di Telese della stessa<br />
<strong>Fondazione</strong>.<br />
L’inizio dell’attività di ricerca è però iniziato solo nel Maggio<br />
del 2006 quando è stato possibile valutare il primo paziente.<br />
L’attività del laboratorio è indirizzata essenzialmente allo<br />
studio dell’innervazione cutanea quale strumento di valutazione,<br />
oggettivo e sensibile, del danno nervoso periferico interessante<br />
il compartimento sensitivo.<br />
La biopsia cutanea neurodiagnostica appare particolarmente<br />
importante per lo studio di tutte le neuropatie periferiche, con<br />
particolare riferimento a quelle che interessano le fibre nervose<br />
di piccolo calibro, non valutabili con le comuni tecniche<br />
elettrodiagnostiche.<br />
Dal punto di vista pratico, dopo aver anestetizzato il derma<br />
mediante anestetico locale, viene effettuato un piccolo prelievo<br />
cutaneo usando un punch da 2 o 3 mm di diametro. Il cilindro<br />
di cute prelevato viene quindi crioconservato fino al<br />
momento in cui viene tagliato in sezioni di 50 um mediante un<br />
microtomo a slitta dotato di unità refrigerante.<br />
La visualizzazione delle fibre nervose è resa possibile dalle<br />
tecniche di immunofluorescenza indiretta. Tali tecniche prevedono<br />
che le sezioni ottenute vengano incubate prima con<br />
anticorpi primari, aventi come bersaglio le strutture cutanee<br />
che si vogliono visualizzare, e quindi con anticorpi secondari<br />
specie-specifici coniugati con fluorocromi. Alla fine del pro-<br />
cesso le sezioni sono fissate in agarosio e montate su vetrini<br />
allo scopo di essere osservate al microscopio a fluorescenza.<br />
Mediante tali procedure è possibile evidenziare non solo le<br />
fibre nervose intraepidermiche ma anche quelle che innervano<br />
il derma e i suoi annessi.<br />
La biopsia cutanea neurodiagnostica permette una valutazione<br />
non solo qualitativa, ma anche quantitativa dell’innervazione<br />
cutanea con particolare riferimento all’epidermide, la cui<br />
densità di innervazione può essere facilmente quantificata<br />
contando il numero di fibre nervose che attraversano la giunzione<br />
dermo-epidermica in rapporto alla lunghezza del segmento<br />
cutaneo esaminato.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca è rivolta all’acquisizione di informazioni riguardanti<br />
la fisiopatologia del sistema nervoso periferico, con<br />
particolare riferimento agli aspetti riabilitativi e al dolore neuropatico.<br />
Ricerche in corso<br />
Studio dell’innervazione cutanea nelle aree di allodinia tattile<br />
dei pazienti con nevralgia post-herpetica.<br />
Studio della densità di innervazione cutanea in pazienti<br />
con allodinia tattile dopo amputazione delle dita della mano.<br />
Studio del ruolo della biopsia cutanea neurodiagnostica<br />
nella diagnosi di neuropatia periferica in corso di ipotiroidismo.<br />
Studio delle possibilità neurodiagnostiche della biopsia cutanea<br />
nella diagnosi di nevralgia del trigemino secondaria.<br />
Monitoraggio degli effetti neurolesivi degli interventi antalgici<br />
sul ganglio di Gasser.<br />
Studio dell’innervazione della lingua in pazienti con sindrome<br />
della bocca bruciante (burning mouth syndrome).<br />
Studio dell’innervazione del corpo vertebrale in pazienti<br />
con dolore sottoposti a cifoplastica per crollo vertebrale.<br />
Ricerche in programmazione<br />
Studio degli effetti neurotossici della chemioterapia.<br />
Studio della densità di innervazione cutanea dell’arto inferiore<br />
in pazienti con patologie interessanti il primo neurone<br />
di moto.<br />
Studio dell’innervazione del tubo gastroenterico quale<br />
possibile strumento diagnostico in gastroenterologia.<br />
Pubblicazioni<br />
Buonocore M. Biopsia cutanea neurodiagnostica e dolore.<br />
Contro il dolore. Stato dell’arte Contro il Dolore, Stato dell’arte<br />
- Elsevier, Milano, 2006, monografia pp 1-16.<br />
Buonocore M, Bodini A. Il danno di recettore tissutale. Atti<br />
del 61° Congresso SIAARTI, Torino, 18-20 Ottobre 2007.<br />
Buonocore M, Bodini A, Gatti A. La biopsia di cute nel dolore<br />
neuropatico. Atti del Convegno: “Biopsia cutanea<br />
neurodiagnostica”, Pavia 18 Maggio 2007.<br />
Fanfani LC. Studio della densità di innervazione nelle aree<br />
di allodinia meccanica dinamica in pazienti con nevralgia<br />
post-herpetica. Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia,<br />
Università di Pavia, Anno accademico 2006-2007.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 37<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Michelangelo Buonocore. Nato a Buenos<br />
Aires nel 1958, coniugato con 2 figli.<br />
Nel 1984 si laurea in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università di Pavia.<br />
Nel 1988 si specializza in Neurofisiologia Clinica<br />
presso l’Università di Pavia.<br />
Nel 1992 si specializza in Fisioterapia, sempre<br />
presso l’università di Pavia.<br />
Dal 1986 al 1998 lavora presso il Servizio di Neurofisiopatologia<br />
dell’Istituto di Riabilitazione di Montescano (IRCCS <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>), prima come Assistente e poi, dal 1994, come Aiuto.<br />
Dal 1988 è membro della Società Italiana di Neurofisiologia<br />
Clinica (SINC).<br />
Dal 1991 è membro della Società Italiana di Medicina Fisica e<br />
Riabilitazione (SIMFER).<br />
Dal 1998 è Responsabile del Servizio di Neurofisiopatologia<br />
dell’Istituto di Pavia della stessa <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dal 1998 è docente in Neurofisiologia del Dolore presso l’Istituto<br />
di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche (ISAL) di Rimini.<br />
Dal 1998 è membro della Società Internazionale per lo Studio<br />
del Dolore (IASP).<br />
Dal 2000 al 2004 è stato coordinatore della Sezione “Il Dolore<br />
Cronico in Medicina Riabilitativa” della Società Italiana di Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione (SIMFER).<br />
Dal 2001 è docente a contratto presso l’Università di Pavia<br />
nella Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro I, con<br />
insegnamento dal titolo: “Patologie neurologiche correlate all’attività<br />
lavorativa: aspetti fisiopatologici”.<br />
Dal 2001 è docente a contratto presso l’Università di Pavia<br />
nella Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitazione,<br />
con insegnamento attuale dal titolo “Fisiopatologia del<br />
dolore in Riabilitazione”.<br />
Dal 2001 al 2007 è stato socio (fondatore) del Centro Studi e<br />
Cultura “Contro il Dolore” (onlus).<br />
Dal 2002 è membro del Comitato Didattico dell’Istituto di Ricerca<br />
e Formazione in Scienze Algologiche (ISAL) di Rimini.<br />
Dal Marzo 2003 al Maggio 2004 in associazione al ruolo di Responsabile<br />
del Servizio di Neurofisiopatologia, è stato aiuto<br />
corresponsabile nella Divisione di Medicina del Dolore dell’Istituto<br />
Scientifico di Pavia della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dal 2003 al 2006 ha fatto parte del Comitato di Edizione della<br />
rivista “MR. Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa”, della<br />
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER).<br />
Dal 2003 è co-direttore del “Corso teorico-pratico di diagnosi<br />
e terapia del dolore”, corso annuale che si tiene presso la <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Pavia.<br />
Dal 2003 è docente a contratto presso l’Università di Pavia<br />
nella Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro II, con<br />
insegnamento dal titolo ”Neurofisiopatologia professionale”.<br />
Dal 2003 è “Associate Editor” per la Neurologia della rivista “Italian<br />
Journal of The Management of the Pain & Palliative Care”.<br />
Dal 2004, 1° Ottobre, è primario del Servizio di Neurofisiopatologia<br />
dell’Istituto Scientifico di Pavia della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dal 2007 è reviewer del giornale Minerva Anestesiologica.<br />
È autore di più di duecento pubblicazioni, di cui 28 recensite<br />
su index medicus.<br />
È autore o co-autore di 6 libri e Co-editor di 6 Volumi.<br />
38<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
3. CSAM<br />
(CENTRO STUDI ATTIVITÀ MOTORIE)<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.59 2008/2004<br />
e-mail: marco.schieppati@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Marco Schieppati<br />
Lo CSAM studia il movimento umano e la sua plasticità in condizioni<br />
normali e patologiche, con particolare enfasi su equilibrio,<br />
controllo posturale, locomozione e movimento volontario, in condizioni<br />
di perturbazioni interne (per esempio fatica) ed esterne<br />
(vibrazione muscolare, spostamenti della base d’appoggio) ed in<br />
condizioni di deficit sensoriali o di disordini del movimento.<br />
Attività di Ricerca in corso<br />
L’attività di ricerca dello CSAM è orientata alla possibilità di<br />
trasferire i risultati nella pratica clinica, in particolare allo<br />
scopo di migliorare le prestazioni motorie, compreso il cammino<br />
ed il controllo dell’equilibrio, in tutte le patologie che direttamente<br />
od indirettamente portano a disabilità. Di seguito<br />
sono riportati i principali campi di ricerca:<br />
Individuazione delle strategie posturali messe in opera durante<br />
movimenti volontari destabilizzanti o durante la perturbazione<br />
della stazione eretta, nell’uomo sano e malato.<br />
Studio della modulazione del riflesso da stiramento durante<br />
l’esecuzione di attività motorie, e della specificità<br />
della modulazione in rapporto alle richieste funzionali del<br />
movimento, nell’uomo sano e nel paziente spastico.<br />
Studio del controllo dell’equilibrio dinamico in pazienti<br />
Parkinsoniani e della loro capacità di integrazione di informazioni<br />
sensoriali stabilizzanti.<br />
Studio del controllo dell’orientamento dei segmenti del<br />
corpo, da fermo e durante il cammino, a seguito di manipolazioni<br />
della informazione propriocettiva.<br />
Studio del controllo visivo dell’equilibrio.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Attrezzature presenti<br />
Sistema integrato per l’acquisizione e l’analisi del movimento<br />
umano, comprendente un sistema optoelettronico<br />
ELITE (BTS) dotato di otto telecamere e di due videocamere,<br />
e di un elettromiografo a 8 canali con trasmissione<br />
telemetrica del segnale.<br />
Piattaforme dinamometriche (2) (per la registrazione delle<br />
forze di reazione al suolo durante il cammino o la stazione<br />
eretta).<br />
Piattaforma mobile sul piano orizzontale (per produrre<br />
perturbazioni dell’equilibrio durante la stazione eretta in<br />
senso antero-posteriore e medio-laterale).<br />
Ergometro (nastro trasportatore modulabile in velocità e<br />
pendenza).<br />
Stimolatore Magnetico (per la stimolazione della corteccia<br />
cerebrale).<br />
Sistema di solette sensorizzate (Novel).<br />
Dinamometro isocinetico (Cybex).<br />
Strumento per la registrazione e l’analisi di segnali fisiologici<br />
(Biopac).<br />
Vibratori muscolo-tendinei programmabili.<br />
Collaborazioni Scientifiche in corso<br />
Laboratorio Postura e Movimento dell’Istituto Scientifico di<br />
Veruno della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dottorato di Ricerca in Fisiologia e Neuroscienze, Università<br />
di Pavia.<br />
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Pavia.<br />
Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Università di Pavia.<br />
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Pavia<br />
e <strong>Fondazione</strong> Casimiro Mondino (IRCCS).<br />
Corso di Laurea di Scienze Motorie, Università di Pavia.<br />
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova.<br />
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Genova.<br />
Università di Roma Tor Vergata e Istituto Scientifico Santa<br />
Lucia (IRCCS), Roma.<br />
Università di Perugina, Dipartimento di Medicina Interna,<br />
Perugia.<br />
Service de Rééducation Fonctionnelle, Faculté de Médecine,<br />
C.H.U. Timone, Marseille, France.<br />
Brain and Movement Laboratory, Université Laval, Québec<br />
City, Canada.<br />
Attività Educazionale<br />
I ricercatori dello CSAM operano in convenzione con l’Università<br />
di Pavia, e sono implicati nei corsi ufficiali di insegnamento<br />
di Fisiologia Umana e Fisiologia dello Sport, Bioingegneria,<br />
Biomeccanica di diverse Facoltà e Scuole di Specializzazione<br />
in diverse discipline, tra cui Neurologia e Terapia Fisica<br />
e Riabilitazione. Inoltre, partecipano con regolarità come<br />
docenti a Corsi ECM di aggiornamento. Presso lo CSAM svolgono<br />
la loro attività diversi studiosi per la preparazione di tesi<br />
di laurea o di dottorato.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Controllo dell’equilibrio in condizioni dinamiche: l’effetto<br />
della visione ed il tempo di integrazione dell’input visivo.<br />
Controllo dell’equilibrio in condizioni dinamiche in pazienti<br />
ipovedenti.<br />
L’effetto della acuità visiva sulla capacità di mantenere l’equilibrio<br />
in condizioni dinamiche.<br />
Programmazione e l’esecuzione del cammino lungo traiettorie<br />
non rettilinee: la generazione ed il controllo della<br />
forza centripeta.<br />
Ruolo delle informazioni propriocettive durante il cammino:<br />
assistenza al controllo della frequenza del passo e<br />
della direzione della traiettoria in pazienti parkinsoniani.<br />
Apprendimento di strategie motorie stabilizzanti l’equilibrio.<br />
Post-effetti di attività motorie coordinate sul mantenimento<br />
della stazione eretta.<br />
Pubblicazioni<br />
De Nunzio AM, Nardone A, Schieppati M. The control of<br />
equilibrium in Parkinson’s disease patients: delayed adaptation<br />
of balancing strategy to shifts in sensory set during<br />
a dynamic task. Brain Res Bull 2007 Sep 28; 74 (4): 258-70.<br />
Bensoussan L, Viton JM, Schieppati M, Collado H, Milhe de<br />
Bovis V, Mesure S, Delarque A. Changes in postural control<br />
in hemiplegic patients after stroke performing a dual<br />
task. Arch Phys Med Rehabil 2007 Aug; 88 (8): 1009-15.<br />
Schmid M, Nardone A, De Nunzio AM, Schmid M, Schieppati<br />
M. Equilibrium during static and dynamic tasks in<br />
blind subjects: no evidence of cross-modal plasticity. Brain<br />
2007 Aug; 130 (Pt 8): 2097-107.<br />
Nardone A, Schieppati M. Balance control under static<br />
and dynamic conditions in patients with peripheral neuropathy.<br />
G Ital Med Lav Ergon 2007 Jan-Mar; 29 (1): 101-4.<br />
Review.<br />
Zanetti C, Schieppati M. Quiet stance control is affected<br />
by prior treadmill but not overground locomotion. Eur J<br />
Appl Physiol 2007 Jun; 100 (3): 331-9.<br />
Bove M, Brichetto G, Abbruzzese G, Marchese R, Schieppati<br />
M. Postural responses to continuous unilateral neck<br />
muscle vibration in standing patients with cervical dystonia.<br />
Mov Disord 2007 Mar 15; 22 (4): 498-503.<br />
Nardone A, Galante M, Pareyson D, Schieppati M. Balance<br />
control in Sensory Neuron Disease. Clin Neurophysiol<br />
2007 Mar; 118 (3): 538-50.<br />
Bove M, Bonzano L, Trompetto C, Abbruzzese G, Schieppati<br />
M. The postural disorientation induced by neck muscle<br />
vibration subsides on lightly touching a stationary<br />
surface or aiming at it. Neuroscience 2006 Dec 28; 143 (4):<br />
1095-103.<br />
Courtine G, De Nunzio AM, Schmid M, Beretta MV,<br />
Schieppati M. Stance- and locomotion-dependent processing<br />
of vibration-induced proprioceptive inflow from multiple<br />
muscles in humans. J Neurophysiol 2007 Jan; 97 (1):<br />
772-9.<br />
De Nunzio AM, Schieppati M. Time to reconfigure balancing<br />
behaviour in man: changing visual condition while riding<br />
a continuously moving platform. Exp Brain Res 2007<br />
Mar; 178 (1): 18-36.<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
In collaborazione con il Laboratorio di Postura del Centro Medico<br />
di Veruno è stato messo a punto: a) Un metodo per la riabilitazione<br />
dell’equilibrio in condizioni dinamiche. Esso si basa<br />
sull’uso di una piattaforma mobile costruita con in contributo<br />
del Ministero della Salute. b) Un metodo per la misura della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 39<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
velocità di conduzione nell’uomo di fibre fusali di gruppo II.<br />
È stato messo a punto e brevettato un sistema di vibratori muscolari<br />
servo-controllati in grado di applicare treni di vibrazioni<br />
di diversa durata e frequenza (brevetto n. MI2006A001946).<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Marco Schieppati è nato a Milano nel 1948.<br />
È membro delle seguenti società scientifiche:<br />
Società Italiana di Fisiologia, Società Italiana<br />
di Neuroscienze, Società Italiana di Neurofisiologia<br />
Clinica, The Physiological Society,<br />
European Neuroscience Association, International<br />
Brain Research Organization, Association<br />
Posture Equilibre, International Society<br />
for Posture and Gait Research.<br />
1983-91 - Professore Associato di Fisiologia Umana presso<br />
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano.<br />
1991-94 - Professore Straordinario di Fisiologia Umana<br />
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università<br />
degli Studi di Genova.<br />
1994-00 - Professore Ordinario di Fisiologia Umana presso<br />
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi<br />
di Genova.<br />
1994-97 - Direttore dell’Istituto di Fisiologia Umana dell’Università<br />
di Genova.<br />
2000-… - Professore Ordinario di Fisiologia Umana, Facoltà<br />
di Medicina e Chirurgia, Università di Pavia.<br />
2001-… - Responsabile, Centro Studi Attività Motorie<br />
(CSAM), <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> (IRCCS), Pavia.<br />
Ha svolto ricerche nell’ambito della neurofisiologia e della biofisica,<br />
occupandosi della fisiologia della sensibilità somatica e<br />
del movimento, sia nell’animale da esperimento che nell’uomo.<br />
Argomenti di studio sono stati i seguenti: recettori<br />
muscolari, riflessi spinali, formazione reticolare del tronco e<br />
modulazione della trasmissione somatosensoriale, masticazione.<br />
Da alcuni anni si occupa della organizzazione e del<br />
controllo dei riflessi spinali, della stazione eretta, del cammino,<br />
e del movimento volontario nell’uomo, in soggetti sani ed in<br />
pazienti con disturbi della sensibilità e del movimento. È autore<br />
di 114 lavori originali pubblicati su riviste scientifiche indicizzate.<br />
È revisore per le seguenti rivista scientifiche: Electroencephalography<br />
and clinical Neurophysiology, Neuroscience Letters,<br />
Experimental Brain Research, Journal of Vestibular Research,<br />
Science et Motricité, Gait and Posture, Journal of Physiology<br />
(London), Brain Research, Human Movement Science, Neurophysiologie<br />
Clinique, European Journal of Applied Physiology<br />
and Occupational Physiology, Journal of Electromyography<br />
and Kinesiology, Brain, Journal of Neurophysiology,<br />
Journal of Applied Physiology, IEEE Trans Biomed Eng, European<br />
Journal of Neuroscience. Già membro del Consulting<br />
Board of Electroencephalography and clinical Neurophysiology.<br />
Section Editor di Human Movement Science. Membro<br />
dell’Editorial Board di Electromyography and Kinesiology, e<br />
Neurophysiologie Clinique.<br />
Ha svolto attività di esperto straniero per l’INSERM, il CNRS, il<br />
Wellcome Trust, la Swiss National Science Foundation, l’Università<br />
dell’Indiana (USA) e l’University College (Londra).<br />
40<br />
Progetti di Ricerca finanziati (ultimi 5 anni)<br />
2002 Ministero della Università - FIRB: Qualità della<br />
Vita, Neuroscienze, Conoscenza dei meccanismi molecolari<br />
e cellulari che regolano nel Sistema Nervoso Centrale i processi<br />
biologici e psicologici durante lo sviluppo, la maturità<br />
e l’invecchiamento (coordinatore nazionale).<br />
2002 Ministero della Salute - Prog Fin: Memoria e apprendimento<br />
motorio.<br />
2003 Ministero della Università - PRIN: Sistemi di riferimento<br />
per il movimento e loro modulazione da parte dell’informazione<br />
sensoriale l’invecchiamento (coordinatore<br />
nazionale).<br />
2005 Ministero della Salute - Prog Fin: Caratteristiche Precliniche<br />
e Modelli di Trattamento Non Farmacologico dei<br />
Disturbi Cognitivi e Motori della Malattia di Parkinson<br />
(coordinatore nazionale).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
4. DIAGNOSTICA E RIEDUCAZIONE<br />
NEUROMUSCOLARE E TERAPIA<br />
ISOCINETICA<br />
Istituto Scientifico di Montescano<br />
Via per Montescano<br />
Tel. 0385.2471<br />
e-mail: giuseppe.frazzitta@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Giuseppe Frazzitta<br />
L’unità svolge attività di ricerca di base ed applicata sulle patologie<br />
neurologiche, quali la Malattia di Parkinson, le polineuropatie,<br />
le paraparesi da lesione midollare vascolare/traumatica/infiammatoria<br />
e le emiparesi su base cerebrovascolare,<br />
ed ortopediche, in particolare quelle che interessano gli<br />
arti inferiori ed il tronco.<br />
Dal punto di vista clinico attua procedure diagnostiche e terapeutiche<br />
sia sui degenti che su pazienti di provenienza<br />
esterna (interni 150/anno, esterni 220/anno).<br />
Dotazione strumentale<br />
Apparecchiatura per l’allevio di carico Locomotor Training°<br />
(Biodex) che permette, mediante un software collegato con<br />
una pedana mobile, di effettuare delle valutazioni circa la velocità<br />
del passo, l’ampiezza del passo, il tempo di appoggio<br />
durante il passo ed il coefficiente di varianza.<br />
Apparecchiatura isocinetica CYBEX 6000, con possibilità di<br />
contrazione isocinetica concentrica, eccentrica, passiva assistita<br />
ed isometrica, collegata ad apparecchiatura di EMG di<br />
superficie a quattro moduli con la possibilità di acquisire il segnale<br />
in parallelo con quello di coppia di forza e di escursione<br />
articolare. Software dedicato all’elaborazione dei segnali descritti,<br />
alla memorizzazione dei medesimi per un successivo<br />
studio e comparazione.<br />
Apparecchiatura Pro-Kin TECNOBODY, costituita da una<br />
pedana mobile a pistoni oleodinamici collegata ad un computer.<br />
Il sistema è dotato di una scheda di acquisizione dati in<br />
grado di trasdurre elettronicamente tutti i minimi spostamenti<br />
angolari compiuti dalla pedana mobile. Quando il paziente<br />
muove, con l’arto o con il tronco in appoggio, questa pedana,<br />
la scheda di acquisizione dati converte ogni singolo movimento<br />
in impulsi elettrici inviandoli direttamente al computer.<br />
Gli impulsi elettrici elaborati dal software del sistema vengono<br />
visualizzati sul monitor sotto forma di un tracciato, che risulta<br />
strettamente relazionato al movimento della pedana mobile<br />
comandata dal paziente. Il paziente può disporre di un continuo<br />
feed-back visivo che gli consente di stabilire un rapporto<br />
di confronto tra ciò che percepisce a livello cinestesico e ciò<br />
che realmente produce a livello motorio.<br />
Apparecchiatura VECTOR DOC, con possibilità di contrazione<br />
a catena cinetica chiusa concentrica–eccentrica con resistenza<br />
elastica a resistenza pre-programmata.<br />
Attività Scientifica<br />
Le principali attività scientifiche del Laboratorio sono qui sintetizzate:<br />
Ricerca Scientifica<br />
Studio dell’efficacia della riabilitazione del cammino sui<br />
pazienti affetti da malattia di Parkinson.<br />
Valutazione dell’efficacia di metodiche propriocettive sui<br />
disturbi dell’equilibrio in pazienti affetti da malattia di<br />
Parkinson ed atassia sensitiva periferica e centrale.<br />
Studio mediante valutazione isocinetica delle patologie<br />
neurologiche piramidali ed extrapiramidali.<br />
Valutazione delle evoluzioni toniche muscolari nelle patologie<br />
neurologiche centrali.<br />
Studio delle applicazioni della metodica isocinetica, a<br />
scopo diagnostico e valutativo, nelle patologie ortopediche:<br />
nelle instabilità croniche di ginocchio, negli esiti di<br />
lesione legamento crociato anteriore, nelle meniscectomie<br />
e nelle displasie dell’apparato estensore di ginocchio.<br />
Valutazione dell’efficacia delle metodiche isocinetiche nel<br />
potenziamento muscolare in patologie ortopediche che<br />
determinano ipotrofia muscolare da non uso e/o post<br />
traumatica.<br />
Valutazione delle variazioni propriocettive in pazienti sottoposti<br />
ad intervento di artroprotesi totale d’anca e di ginocchio<br />
e in esiti di accidenti vascolari cerebrali, nonché<br />
studio delle modificazioni che avvengono in seguito a training<br />
riabilitativi specifici.<br />
Ricadute sull’Attività Clinica<br />
Definizione di protocolli riabilitativi per il recupero del disturbo<br />
della deambulazione in pazienti affetti da malattia<br />
di Parkinson.<br />
Definizione di protocolli riabilitativi per il recupero del disturbo<br />
dell’equilibrio in pazienti affetti da atassia sensitiva<br />
periferica e centrale (polineuropatie, deficit cerebellari e<br />
della sostanza bianca vascolari o infiammatori).<br />
Definizione di protocolli riabilitativi per il miglioramento<br />
del controllo del tronco in pazienti con lesioni midollari<br />
(vascolari, traumatiche, infettive).<br />
Definizione di protocolli valutativi isocinetici applicabili<br />
alle seguenti patologie: instabilità croniche di ginocchio,<br />
displasie apparato estensore, condropatie rotulee, cardiopatie,<br />
pneumopatie e vasculopatie periferiche.<br />
Definizione di protocolli terapeutici isocinetici applicabili<br />
alle seguenti patologie: postumi meniscectomie, postumi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 41<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
interventi di ricostruzione LCA, displasie apparato estensore,<br />
portatori AOCP.<br />
Definizione di protocolli valutativi e terapeutici propriocettivi<br />
in patologie ortopediche e neurologiche.<br />
Pubblicazioni<br />
G. Frazzitta, G. Grampa, I. La Spina, F. Reverberi, D. Uccellini,<br />
D. Porazzi. SPECT in the early diagnosis of Creutzfeldt-<br />
Jakob disease. Clinical Nuclear Medicine, 23, (4), 238-239,<br />
1998.<br />
G. Frazzitta, C. Fundaro, R. Casale. Ruolo della depressione<br />
sul recupero funzionale e sui costi di degenza dei apzienti<br />
con lesioni cerebrovascolari acute. G. Ital. Med. Lav. Erg.,<br />
25: 2, 161-164, 2003.<br />
R. Casale, A. La Manna, S. Salvini, M. Maini, F. Ceccherelli,<br />
G. Frazzitta. La riabilitazione delle neuropatie periferiche.<br />
Indicazioni per un percorso diagnostico-riabilitativo. G.<br />
Ital. Med. Lav. Erg., 25: 4, 456-464, 2003.<br />
R. Casale, G. Frazzitta, C. fundaro, P. Balbi, A. Del Rosso, L.<br />
Bertinotti, M. Matucci-Cerinic. Blink reflex discloses CNS<br />
dysfunction in neurologically asymptomatic patients with<br />
systemic sclerosis. Clinical Neurophysiology, 115, 1917-<br />
1920, 2004.<br />
R. Casale, P. Balbi, G. Frazzitta, C. Fundaro, F. Ceccherelli,<br />
G. Pinna. Rofecoxib and nimesulide differ in speed and magnitude<br />
of their antinociceptive effect: a randomized<br />
double-blind crossover neurophysiological study in normal<br />
subjects. The Pain Clinic, Vol. 16, N. 3, 253-260, 2004.<br />
G. Frazzitta. Inferenza del dolore nella riabilitazione del<br />
cranioleso: dolore e spasticità. Eur Med Phys, 40 (suppl. 1<br />
to N. 3): 385-386, 2004.<br />
G. Frazzitta, D. Uccellini, Vercesi, S. Moroni, G. Bertotti, R.<br />
Aquilani. Metodologia metabolica per la valutazione della<br />
riabilitazione della malattia di Parkinson. Book Abstract<br />
XXXV Congresso Nazionale SIMFER pag. 11, Ottobre 2007.<br />
R. Casale, S. Salvini, A. La Manna, S. Malaguti, E. Magnani,<br />
G. Frazzitta. Dolore e riabilitazione. In “Advances in Rehabilitation,<br />
Aggiornamenti in Medicina Riabilitativa”, Vol. 11,<br />
pag. 53-61. Pavia, <strong>Maugeri</strong> Foundation Books - I libri della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
R. Casale, G. Frazzitta, M. Maini, S. Carapelli, M. Matucci-<br />
Cerinic. La riabilitazione nei pazienti sclerodermici. In “La<br />
riabilitazione in reumatologia”, Cap. 11, pag. 73-82. Mattioli<br />
Editore.<br />
G. Frazzitta, G. Felicetti, D. Uccellini, E. Vercesi, S. Moroni, G.<br />
Bertotti, R. Aquilani. Metabolic methodology for evaluating<br />
the rehabilitation results in parkinsonian patients. Neurol<br />
Science, October 2007, Supplement Vol. 28, pag. S359.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
42<br />
Dr. Giuseppe Frazzitta. Nato a Marsala (TP) il<br />
7 Agosto 1962.<br />
Laurea in Medicina con il massimo dei voti;<br />
Specialità in Neurologia con il massimo dei<br />
voti e lode; Università degli Studi di Pavia..<br />
Dal 1999 ad oggi<br />
<strong>Fondazione</strong> “<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>” Istituto di<br />
Montescano (PV), IRCCS, Dirigente Medico<br />
di 1° livello Neurologo. Responsabile del progetto “Valutazione<br />
dell’efficacia di metodiche riabilitative in allevio di carico<br />
per pazienti con disabilità da emiplegia o mielolesione”.<br />
Già responsabile fino al 2004 del “Progetto Riabilitativo della<br />
Malattia di Parkinson”. Responsabile della riabilitazione dei<br />
pazienti affetti da Malattia di Parkinson presso il reparto di<br />
Neuroriabilitazione Motoria. Responsabile del laboratorio di<br />
Diagnostica e Rieducazione Neuromuscolare e Terapia Isocinetica.<br />
Dal 1993 al 1999<br />
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, Reparto di Neurologia,<br />
Dirigente Medico di 1° livello Neurologo. Responsabile dell’ambulatorio<br />
per le cefalee e dell’ambulatorio per la malattia di<br />
Alzheimer. Responsabile del SERT. Corresponsabile dell’ambulatorio<br />
di neurosonologia. Membro del comitato Provinciale per<br />
la malattia di Alzheimer della Provincia di Varese.<br />
Dal 1992 al 1999<br />
Ministero di Grazia e Giustizia, Casa circondariale di Pavia,<br />
Consulente neurologo. Responsabile della diagnosi e cura<br />
delle malattie neurologiche dei detenuti.<br />
Dal 1989 al 1990<br />
Ospedale Militare Milano, Sanitaria, Ufficiale medico. Valutazione<br />
clinica e legale delle lesioni neuroortopediche nei giovani<br />
di leva e nei militari dell’esercito e dei corpi equiparati.<br />
Dal 1988 al 1992<br />
Università di Pavia, IRCCS Istituto Neurologico “Mondino”, Specializzando.<br />
Vincitore di borsa di studio per il periodo della<br />
specializzazione.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
5. LABORATORIO DI POSTURA E MOVIMENTO<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884906<br />
e-mail: antonio.nardone@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Antonio Nardone<br />
Il Laboratorio di Postura e Movimento è noto a livello nazionale<br />
ed internazionale per gli studi condotti sul controllo dell’equilibrio<br />
nei soggetti normali e nei pazienti affetti da patologie<br />
neurologiche o vestibolari. Questi pazienti, dopo essere<br />
stati valutati con sistemi di analisi della postura, dell’equilibrio<br />
e del movimento, sono posti in trattamento utilizzando protocolli<br />
tratti dalla letteratura internazionale o protocolli originali<br />
sviluppati nel laboratorio stesso. Le metodiche riabilitative si<br />
avvalgono non solo di esercizi ma anche dell’utilizzo di pedane<br />
mobili atte a produrre destabilizzazioni controllate e ripetibili<br />
del paziente. Il personale del laboratorio è costituito<br />
dalla Dr.ssa Margherita Grasso, laureata in Scienze delle Professioni<br />
Sanitarie Tecnico-Diagnostiche.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività scientifica del Laboratorio di Postura e Movimento è<br />
riconducibile nell’ambito dell’obiettivo istituzionale della <strong>Fondazione</strong><br />
“<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>” che riguarda la Medicina Riabilitativa<br />
Neuromotoria che viene affrontata nelle tematiche di<br />
1) Ricerca di Base, 2) Sviluppo di Metodi di Valutazione Funzionale,<br />
3) Recupero Terapeutico Funzionale.<br />
Strumenti disponibili<br />
ll laboratorio è strutturato in tre locali attrezzati con apparecchiature<br />
consistenti in:<br />
1) pedane stabilometriche con sensori di forza atti a rilevare<br />
le oscillazioni del corpo durante la stazione eretta quieta,<br />
2) pedane mobili che permettono di indurre destabilizzazioni<br />
posturali del corpo in modo tale da rilevare le strategie posturali<br />
messe in atto dal soggetto per contrastare la perturbazione,<br />
3) tappeto baropodometrico per la quantificazione delle variabili<br />
spazio-temporali del cammino,<br />
4) otocalorimetro e videonistagmografo per la quantificazione<br />
dei riflessi labirintici attraverso la registrazione dei<br />
movimenti oculari,<br />
5) sistemi stereofotogrammetrici per l’analisi del movimento<br />
in tre dimensioni,<br />
6) stimolatori elettrici e magnetici,<br />
7) amplificatori di segnali biologici, in particolare del segnale<br />
elettromiografico.<br />
Collaborazioni Scientifiche in corso<br />
Il personale del laboratorio collabora assiduamente con il<br />
Centro Studi Attività Motorie dell’Istituto Scientifico di Pavia,<br />
diretto dal Prof. Marco Schieppati. Questa collaborazione dura<br />
da diversi anni e riguarda la fisiopatologia del controllo posturale<br />
e dell’equilibrio e dei riflessi spinali e sopraspinali.<br />
Sono inoltre in corso collaborazioni scientifiche con il Dipartimento<br />
di Medicina Sperimentale dell’Università di Pavia e con<br />
il Balance Disorders Laboratory di Portland nell’Oregon.<br />
Attività Educazionale<br />
Il responsabile del laboratorio è stato per sette anni Professore<br />
a Contratto di Neurofisiologia Applicata presso il Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia dell’Università di Genova. In seguito è<br />
stato per 5 anni Professore a Contratto di Riabilitazione Neurologica<br />
presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università<br />
di Novara. Dall’anno accademico 2007-2008 il responsabile<br />
è Ricercatore Universitario di Medicina Fisica e Riabilitativa<br />
presso l’Università del Piemonte Orientale di Vercelli. Il<br />
personale del laboratorio ha pubblicato capitoli di libro ed organizzato<br />
corsi ECM sia diretti ad esterni sia al personale dell’Istituto.<br />
La Dr.ssa Grasso ha curato l’addestramento di alcuni<br />
fisioterapisti dell’Istituto all’utilizzo degli strumenti del laboratorio<br />
a scopo valutativo e riabilitativo.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Lo studio dei circuiti riflessi alla base delle risposte posturali ha<br />
fornito metodiche in grado di dare informazioni sulle fibre afferenti<br />
periferiche e sui circuiti nervosi non studiabili con i comuni<br />
test elettrofisiologici, sui meccanismi fisiopatologici alla base<br />
dell’ipertonia spastica, sull’effetto di alcuni farmaci antispastici<br />
(tizanidina) su specifici circuiti riflessi. La misura della capacità<br />
dei pazienti ad adattarsi a condizioni perturbanti l’equilibrio ha<br />
fornito una metodica in grado di dare informazioni sulla prontezza<br />
del sistema nervoso centrale ad adattarsi a nuove situazioni<br />
ambientali e/o di esecuzione del compito posturale, sulla<br />
degradazione di questi meccanismi, sul loro recupero a fronte<br />
di interventi riabilitativi. Tali informazioni sono rilevanti in molte<br />
patologie ed in molti pazienti nei quali l’instabilità posturale è<br />
conseguenza della malattia e causa di complicazioni.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Progetto di Ricerca Finalizzata: Malattie neurodegenerative.<br />
Caratteristiche precliniche e modelli di trattamento<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 43<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
non farmacologico dei disturbi cognitivi e motori della malattia<br />
di Parkinson.<br />
Progetto di Ricerca Corrente: Il cammino lungo traiettorie<br />
lineari e curvilinee nelle malattie neuromotorie.<br />
Pubblicazioni<br />
Nardone A, Grasso M, Schieppati M. Balance control in<br />
peripheral neuropathy: Are patients equally unstable<br />
under static and dynamic conditions? Gait Posture 2006;<br />
23: 364-73.<br />
Nardone A, Schieppati M. Balance in Parkinson’s disease<br />
under static and dynamic conditions. Mov Disord 2006; 21:<br />
1515-20.<br />
Nardone A, Grasso M, Schieppati M. Balance control<br />
under static and dynamic conditions: the effect of somatosensory<br />
impairment. Abstracts of the 4 th International<br />
Posture Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 25 th -28 th<br />
June 2006, p 45.<br />
Schmid M, Nardone A, De Nunzio AM, Schieppati M. Vision<br />
cannot be replaced by other sensory information in<br />
blind subjects balancing on an oscillating platform. Abstracts<br />
of the 4 th International Posture Symposium, Smolenice<br />
Castle, Slovakia, 25 th -28 th June 2006, p 51.<br />
Nardone A. Fisiopatologia del controllo della postura e<br />
dell’equilibrio nella malattia cerebrovascolare. Atti VII<br />
Congresso della Società di Analisi del Movimento in Clinica,<br />
Vinci (FI), 18-21/10/2006, p 40.<br />
Nardone A, De Nunzio AM, Grasso M, Schieppati M. L’effetto<br />
della visione sul mantenimento della postura in condizioni<br />
dinamiche: la cinematica e l’attività EMG in pazienti<br />
parkinsoniani in equilibrio su di una pedana oscillante. Atti<br />
XXXIII Congresso Nazionale LIMPE, Stresa (VB), 15-<br />
17/11/2006, p 230.<br />
Nardone A. Quantification of gait and balance to measure<br />
treatment efficacy in Parkinson’s disease. Gait & Balance<br />
in Parkinson’s Disease, April 17-19, 2006, Oregon.<br />
Grasso M, Nardone A, Galante M, Schieppati M. Il controllo<br />
dell’equilibrio nei pazienti con neuronopatia sensitiva. Atti<br />
del Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia<br />
Clinica, Palermo, 24 -26 maggio 2007, p. 206.<br />
Nardone A, Galante M, Godi M, Grasso M, Schieppati M.<br />
Balance control is more severely affected in Sensory<br />
Neuron Disease (SND) than in diabetic polyneuropathy.<br />
Proceedings of the XVIII Congress of the International Society<br />
for Posture and Gait Research, Burlington, VT, 14-<br />
18/7/2007, TO-16, p. 156.<br />
Nardone A, Galante M, Godi M, Grasso M, Schieppati M.<br />
Ataxia in compressive cervical myelopathy: a role for longloop<br />
responses? Proceedings of the XVIII Congress of the<br />
International Society for Posture and Gait Research, Burlington,<br />
VT, 14-18/7/2007, TO-9, p. 37.<br />
Metodi messi a punto<br />
In collaborazione con il Centro Studi Attività Motorie (CSAM)<br />
dell’Istituto Scientifico di Pavia è stata progettata e costruita<br />
una pedana mobile avente un piano, sul quale sta in piedi il<br />
soggetto da esaminare, in grado di traslare sui due assi (anteroposteriore<br />
e laterolaterale rispetto al soggetto). L’ampiezza,<br />
la velocità ed il tipo di movimento (impulsivo o sinusoidale)<br />
è parametrizzabile in un ampio ambito. Lo strumento<br />
44<br />
è atto a produrre perturbazioni destabilizzanti in condizioni dinamiche<br />
ed a valutarne gli effetti sulle risposte elettromiografiche<br />
posturali e sulla cinematica del corpo. La pedana è assai<br />
utile anche per allenare nei pazienti i residui meccanismi normali<br />
di controllo dell’equilibrio e per sollecitare l’uso di strategie<br />
compensatorie. Inoltre, sempre con lo CSAM, è stato<br />
messo a punto un metodo per la misura della velocità di conduzione<br />
delle fibre fusoriali di gruppo II. Tale metodica appare<br />
di interesse per la valutazione delle alterazioni funzionali delle<br />
neuropatie periferiche.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Antonio Nardone, nato a Milano, il 6 marzo<br />
1959.<br />
Istruzione<br />
1985: Università degli Studi di Milano, Laurea<br />
in Medicina e Chirurgia.<br />
1989: Università degli Studi di Milano, Dottorato<br />
di Ricerca in Scienze Neurologiche.<br />
1992: Università degli Studi di Pavia, Specialità in Fisiatria.<br />
Attività Accademica<br />
Dal 1997 al 2004: Università degli Studi di Genova, Professore<br />
a contratto di Neurofisiologia Applicata presso il Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia.<br />
Dall’a.a. 2002-3: Università del Piemonte Orientale di Vercelli,<br />
Professore a contratto di Riabilitazione Neurologica I presso il<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia.<br />
Dall’a.a. 2007-8: Ricercatore Universitario di Medicina Fisica e<br />
Riabilitativa presso l’Università del Piemonte Orientale di Vercelli.<br />
Esperienza lavorativa<br />
Presso l’Istituto Scientifico di Veruno con diversi incarichi:<br />
1987/1989: Medico Contrattista.<br />
1989/1995: Assistente Medico.<br />
1995: Dirigente Medico di I livello.<br />
Dal 2000: Responsabile di struttura semplice (Laboratorio di<br />
Postura e Movimento).<br />
Incarichi Scientifici<br />
È stato Refeee per le seguenti riviste: Brain, European Journal<br />
of Applied Physiology, Experimental Brain Research, Neurological<br />
Sciences, Journal of Neurophysiology, Gait & Posture,<br />
Clinical Neurophysiology, Neuroscience Letters, Brain Research<br />
Bulletin, Europa Medicophysica, Human Movement<br />
Science, Motor Control.<br />
È stato revisore di progetti scientifici per la <strong>Fondazione</strong> Italiana<br />
Sclerosi Multipla e per il Netherlands Organisation for Health<br />
Research and Development (ZonMw).<br />
Dal 1996: Membro dell’Editorial Board di Gait & Posture.<br />
1999-2003: Membro del Comitato Direttivo della Società Italiana<br />
di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC).<br />
Dal 2004: Membro dell’Editorial Board di Europa Medicophysica.<br />
1998-99: Responsabile di ricerca finanziata da Telethon.<br />
2001-3: Responsabile di ricerca finanziata dal Ministero della<br />
Salute.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Premi e Riconoscimenti Scientifici<br />
Premio SIMFER n. 3/2004 (Allergan).<br />
Premio clinico Elsevier-SIAMOC (Società Italiana di Analisi del<br />
Movimento in Clinica) nel 2004.<br />
2007 Delsys Recognition for Best Presentation in Electromyography<br />
al XVIII Congresso della International Society for Posture<br />
and Gait Research, Burlington, VT.<br />
Attività Scientifica<br />
Il responsabile è autore di 44 lavori in extenso pubblicati su riviste<br />
scientifiche indicizzate, di numerosi capitoli di libri e di<br />
presentazioni a congressi nazionali ed internazionali. I suoi interessi<br />
scientifici principali comprendono la fisiologia e la fisiopatologia<br />
della postura, dell’equilibrio e del cammino<br />
nonché la loro riabilitazione. Ha pubblicato lavori scientifici su<br />
pazienti affetti da morbo di Parkinson, spasticità, neuropatie<br />
periferiche e vestibolopatie.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
6. LABORATORIO DI RIABILITAZIONE<br />
ROBOTIZZATA E DI BIOMECCANICA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884725<br />
e-mail: fabrizio.pisano@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Fabrizio Pisano<br />
1) Valutazioni elettromiografico-biomeccaniche all’arto superiore<br />
per la quantificazione delle alterazioni del tono<br />
muscolare al fine di ottimizzare l’efficacia dell’intervento<br />
terapeutico.<br />
2) Neuroriabilitazione robotizzata dell’arto superiore in pazienti<br />
affetti da lesioni del sistema nervoso centrale ed<br />
analisi elettromiografico-cinematica dei movimenti residui.<br />
Attività di Ricerca<br />
Il nostro gruppo di ricerca è impegnato nella valutazione e nel<br />
recupero neuromotorio di pazienti affetti da ictus cerebrale.<br />
Nell’ambito di un progetto finalizzato del Ministero della Salute<br />
abbiamo messo a punto un dispositivo robotizzato, grazie<br />
ad una collaborazione con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.<br />
La “robotica riabilitativa” utilizza macchine costruite per migliorare<br />
ed accelerare il recupero funzionale in pazienti affetti<br />
da deficit motori. Il nostro sistema MEMOS (Sistema MEccatronico<br />
per la riabilitazione MOtoria post ictuS dell’arto superiore)<br />
permette la realizzazione di movimenti di “reaching” in<br />
coordinate planari. Il paziente deve spostare un manipolatore,<br />
dotato di un sensore di forza, da un punto A ad un punto B<br />
(calcolati sulla base delle capacità residue) dello spazio di lavoro<br />
planare. Se durante l’esecuzione del compito motorio la<br />
forza applicata dal paziente risulta inferiore ad una soglia predeterminata,<br />
il sistema di controllo interviene per spostare il<br />
manipolatore e completare il compito motorio.<br />
Abbiamo fino ad oggi valutato e trattato una popolazione di<br />
soggetti emiparetici, sia in fase subacuta che cronica; i dati ottenuti<br />
sono stati oggetto di pubblicazioni su riviste indicizzate.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 45<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Attività Educazionale<br />
Il gruppo ha organizzato corsi per la formazione continua a<br />
medici neurologi, fisiatri, tecnici di neurofisiopatologia e tecnici<br />
della riabilitazione, sul “Contenimento della spasticità”. Il Dr.<br />
Pisano è stato invitato, nell’ambito del Gruppo Nazionale di<br />
Bioingegneria (Bressanone, 2003) ad esporre il razionale neurofisiologico<br />
per l’impiego di sistemi robotici e meccatronici<br />
per la riabilitazione. Nel maggio 2004 invitato, nell’ambito del<br />
XXV Corso Nazionale per Tecnici di Neurofisiopatologia ad<br />
esporre le tecniche neurofisiologiche di valutazione e trattamento<br />
riabilitativo robotizzato. Invitato nel maggio 2004, nell’ambito<br />
del XLIV Congresso Nazionale dei Neurologi Ospedalieri,<br />
nella giornata dedicata alle “Terapie e Tecnologie per la<br />
Qualità nel Disabile”, ad esporre le nostre esperienze con la<br />
neuroriabilitazione robotizzata negli esiti di stroke. Invitato a<br />
Pavia nel settembre 2004 (corso di formazione continua sulla<br />
stimolazione magnetica transcranica) a tenere una relazione<br />
sull’utilità dei potenziali evocati motori nella diagnosi delle malattie<br />
neurologiche. Invitato a Padova (gennaio 2005), nell’ambito<br />
del corso per la formazione continua “trattamento farmacologico<br />
del dolore centrale e periferico”, ad esporre sui rapporti<br />
tra dolore e riabilitazione. Nel gennaio 2005 invitato a Pisa<br />
(Scuola Superiore S. Anna) a tenere un seminario sul controllo<br />
motorio dell’arto superiore. Invitato, nell’ambito del Congresso<br />
Nazionale ANASMES (Chieti, 2005) ad esporre le metodiche<br />
necessarie per la valutazione elettromiografico-biomeccanica<br />
delle alterazioni del tono muscolare. Invitato a Pavia (settembre<br />
2005) nell’ambito del corso di formazione continua su “Potenziali<br />
Evocati in Riabilitazione” ad esporre sull’“Utilità e sui Limiti<br />
della Stimolazione Magnetica in Riabilitazione”.<br />
Nel corso del I Congresso SIRAS organizzato a Pavia (giugno<br />
2006) ha presentato il razionale legato ai meccanismi di plasticità<br />
neuronale su cui si basa il trattamento robotico nello<br />
stroke. Sempre a Pavia, il 14 novembre 2006 nella giornata dedicata<br />
a: Impiego di Nuove Tecnologie nei Trattamenti di Neuroriabilitazione<br />
ha illustrato gli sviluppi degli studi effettuati<br />
con il trattamento riabilitativo robotizzato.<br />
A Roma, il 19 marzo 2007, in occasione dell’International Workshop<br />
on Motor Learning in Stroke Recovery è stato invitato a<br />
parlare dell’utilità della tecnologia robotica nell’indagine del recupero<br />
motorio e il 26 maggio dello stesso anno al Congresso<br />
Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica ha illustrato<br />
le tecniche cinematiche e robotiche nello studio della<br />
funzione dell’arto superiore. Infine il 5 ottobre 2007, a Milano,<br />
ha esposto le problematiche e l’utilità delle indagini seriate in<br />
Neurofisiologia in occasione dell’incontro organizzato dalla Società<br />
Italiana di Neurofisiologia Clinica sezione NordOvest.<br />
Attività Traslazionale<br />
La ricaduta pratica di tali realizzazioni consiste nel poter somministrare<br />
un trattamento riabilitativo non convenzionale ad<br />
alta tecnologia a soggetti emiparetici, sia in fase acuta che<br />
cronica, tarando l’intervento sulle capacità residue ed ottenendo<br />
risultati più mirati in termini di incremento del range di<br />
movimento volontario nei segmenti intermedio-prossimali<br />
(gomito e spalla).<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Analisi delle modificazioni elettromiografiche dell’arto superiore<br />
che intervengono nel corso del trattamento robo-<br />
46<br />
tizzato degli arti paretici in pazienti con esiti di ictus cerebrale.<br />
Studio dell’apprendimento motorio e del controllo della<br />
forza durante trattamento robotizzato.<br />
Valutazione dell’efficacia del trattamento robotizzato di<br />
pazienti emiparetici in fase acuta.<br />
Valutazione dell’efficacia di un dispositivo robotizzato in<br />
uno spazio di lavoro a tre dimensioni (trattasi di sistema<br />
robotizzato basculante messo a punto dal Dipartimento di<br />
Informatica, Sistemi Telecomunicazioni dell’Università di<br />
Genova, e fornito nell’ambito di una collaborazione accesa<br />
nel corso di quest’anno).<br />
Pubblicazioni<br />
Pisano F, Miscio G, Delconte C, Pianca D, Candeloro E,<br />
Colombo R. Quantitative measures of spasticity in poststroke<br />
patients. Clin Neurophysiol (2000); 111: 1015-1022.<br />
Pisano F, Miscio G, Colombo R. Metodi di quantificazione<br />
della spasticità. In: G Megna e S Calabrese, eds. Riabilitazione<br />
Neuromotoria 2000. Advances in Rehabilitation. PI-<br />
ME Press, Pavia. 2000, vol 11, pp. 1-7.<br />
Miscio G, Pisano F, Delconte C, Pianca D, Colombo R, Schieppati<br />
M. The shortening reaction of forearm muscles: the influence<br />
of central set. (2001) Clin Neurophysiol; 112: 884-894.<br />
Pisano F, Pinelli P. Il problema della sclerosi laterale amiotrofica<br />
oggi. (2001) Nuova Rivista di Neurologia; 11, 1: 1-6.<br />
Dario P, Guglielmelli E, Carrozza MC, Di Pietro L, Pisano F. Sistemi<br />
robotici e meccatronici per la neuroriabilitazione. In:<br />
Atti della XXII Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria,<br />
Bressanone 22-25/09/03; Pàtron Ed. pp. 465-493.<br />
Miscio G, Delconte C, Pianca D, Colombo R, Panizza M,<br />
Schieppati M, Pisano F. Botulinum toxin in post-stroke patients:<br />
stiffness modifications and clinical implications.<br />
(2004) J Neurol; 251: 189.<br />
Colombo R, Pisano F, Micera S, Mazzone A, Delconte C,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Robot techniques for<br />
upper limb evaluation and rehabilitation of Stroke patients.<br />
(2005) IEEE Transactions on Neural Systems and<br />
Rehabilitation Engineeering. Vol 13, 3.<br />
Micera S, Carrozza MC, Guglielmelli E, Cappiello G, Zaccone<br />
F, Freschi C, Colombo R, Mazzone A, Delconte C, Pisano<br />
F, Minuco G, Dario P (2005). A simple robotic system<br />
for neurorehabilitation. Autonomous Robots; 19, 1-11.<br />
Miscio G, Pisano F, Delconte C, Colombo R, Schieppati M.<br />
Concurrent changes in shortening reaction latency and<br />
reaction time of forearm muscles in post.stroke patients.<br />
Neurol Sci; 26 (6): 402-10, 2006.<br />
Miscio G, Gukov B, Pisano F, Mazzini L, Baudo S, Salvadori A,<br />
Mauro A. The cortico-diaphragmatic pathway involvement in<br />
amyotrophic lateral sclerosis: neurophysiological, respiratory<br />
and clinical considerations. J Neurol Sci Oct 2006.<br />
Colombo R, Pisano F, Mazzone A, Delconte C, Micera S,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Design strategies to improve<br />
patient motivation during robot-aided rehabilitation.<br />
J Neuroengineering Rehabil; 2007, 4: 3 p. 1-12.<br />
Colombo R, Pisano F, Micera S, Mazzone A, Delconte C,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Assessing mechanisms<br />
of recovery during robot-aided neurorehabilitation of the<br />
upper limb, Neurorehabilitation and Neural Repair; 2007,<br />
10, 11: 934-941.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Metodi messi a punto<br />
Messa a punto di un sistema robotico a due gradi di libertà<br />
per la valutazione ed il trattamento dei movimenti intermedioprossimali<br />
dell’arto superiore (gomito e spalla).<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Fabrizio Pisano.<br />
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università<br />
di Milano (1981).<br />
Specializzazione in Neurologia, Università<br />
di Milano (1986).<br />
Dal 1983 presta servizio in qualità di Neurologo<br />
presso la Divisione di Neurologia<br />
dell’Istituto Scientifico di Veruno, <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> IRCCS.<br />
Responsabile fino al 31/12/2006 del Servizio aggregato di<br />
Neurofisiopatologia del suddetto Istituto.<br />
Primario della Divisione di Neurologia Riabilitativa dell’Istituto<br />
Scientifico di Veruno, <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, dal<br />
1/1/2007.<br />
Dal 1991 al 1997 Professore a contratto del corso di Elettromiografia<br />
nell’ambito della Scuola di Specialità di Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione dell’Università di Torino.<br />
Docente in vari Corsi di neurofisiologia e neuroriabilitazione<br />
tra cui: Rieducazione neuromotoria della mano, Ariccia,<br />
1987; Patologie di origine professionale, Bologna, 1987;<br />
Amplifon, Milano, 1990; Specializzazione Terapisti della Riabilitazione,<br />
Milano, 1996; Fatica muscolare, Torino, 1996;<br />
Movimento e Postura, Cuneo, 2001. Stimolazione Magnetica,<br />
Pavia, 2004. XXV Corso Nazionale AITN, Bari, 2004.<br />
XLIV Congresso Nazionale SNO, Vicenza, 2004. Corsi di<br />
Cultura in EMG e Neurofisiologia Clinica, Lido degli Estensi,<br />
dal 1998 al 2002.<br />
Relatore al Simposio “Clinical Neurophysiology, Neurosonology<br />
and Neuroimaging Procedures” nell’ambito della Seconda<br />
Conferenza Internazionale sull’Organizzazione ed<br />
Apertura di Servizi Neurologici – Neurology Update 2000,<br />
Atene, 24-26 ottobre 1996.<br />
Docente all’Educational Course del XVI Congresso Mondiale<br />
di Neurologia a Buenos Aires, 14-19 settembre 1997 sul<br />
tema: Conventional EMG and Nerve Conduction Studies.<br />
Responsabile Scientifico del progetto Biennale: “Analisi<br />
Quantitativa dell’Ipertonia Spastica” finanziato dall’Istituto<br />
Superiore di Sanità negli anni 1998-1999.<br />
Co-Responsabile Scientifico di un Progetto Triennale (1994-<br />
1995-1996) finanziato da Telethon sulla ricerca: Speech<br />
motor control in ALS: a search for an early marker of disease.<br />
Responsabile Scientifico clinico del Progetto INAIL “Osservatorio<br />
Permanente sulla Stimolazione Elettrica Funzionale”<br />
(2001).<br />
Responsabile dell’Unità Operativa di Neurofisiopatologia<br />
nell’ambito del Progetto Finalizzato 2001-2002 (Ministero<br />
della Salute): “Tecniche robotizzate per la valutazione ed il<br />
trattamento riabilitativo delle disabilità motorie dell’arto superiore”.<br />
Responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Istituto<br />
di Veruno nell’ambito del Progetto Finalizzato: “Interventi<br />
Nutrizionali nella SLA: Studio di efficacia nell’uomo e in modelli<br />
animali” (2006-2007).<br />
Ha organizzato i seguenti Corsi Nazionali di Aggiornamento<br />
in Neuroriabilitazione patrocinati dalle Società Nazionali di<br />
Neurologia, Neurofisiologia Clinica e Medicina Fisica e Riabilitazione:<br />
Le Proprietà Visco-Elastiche dei Muscoli Scheletrici:<br />
Valutazione agli Effetti Riabilitativi. Veruno (NO), 26-30<br />
maggio 1986. La Malattia dei Blocchi di Conduzione Multifocali<br />
Prossimali di Lewis-Sumner: Clinica e Diagnosi Differenziale.<br />
Veruno (NO), 14 novembre 1987. Rehabilitation<br />
and Restorative Neurology. Veruno (NO), 15 aprile 1988.<br />
Neuroriabilitazione e Neurologia Funzionale Terapeutica.<br />
Gargnano (BS), 30 aprile - 4 maggio 1990. Valutazione e Trattamento<br />
delle Compromissioni Motorie Centrali: Stato dell’Arte<br />
e Recenti Acquisizioni. Veruno (NO), 2-4 maggio<br />
1996. Spasticity: Mechanisms, Treatment and Rehabilitation.<br />
Arona (NO), 30 aprile - 1 maggio 1999. Le Malattie del<br />
Motoneurone: Approccio Multidisciplinare. Puntaldia (NU),<br />
8-10 giugno 2000. Il contenimento della spasticità: tossina<br />
botulinica e bendaggio funzionale. Veruno, marzo 2005. Le<br />
epilessie sintomatiche: dalla diagnosi alla terapia. Veruno,<br />
7 novembre 2007.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 47<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
7. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEI DISTURBI AFASICI DEL LINGUAGGIO:<br />
ASPETTI METODOLOGICI E MODELLI<br />
COGNITIVI<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884703<br />
e-mail: marcella.laiacona@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Marcella Laiacona<br />
In questo laboratorio i disturbi afasici sono l’oggetto principale<br />
dello studio che si estende anche all’aspetto riabilitativo. Oltre<br />
alla valutazione clinica e testistica dei pazienti, vengono programmate<br />
valutazioni più approfondite qualora si abbia il sospetto<br />
di un danno cognitivo più circoscritto.<br />
Collaborazioni Scientifiche<br />
Il laboratorio si avvale della collaborazione continuativa con<br />
l’Università di Milano (Prof. E. Capitani) sia per l’aspetto metodologico<br />
che per l’impostazione dei progetti di ricerca.<br />
Il laboratorio ha inoltre diverse occasioni di collaborazione sia<br />
a livello nazionale che Internazionale:<br />
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca<br />
(Prof. C. Luzzatti) per lo studio dei disturbi del linguaggio<br />
scritto.<br />
Centro Interdisciplinare Mente/Cervello, Università di<br />
Trento, Polo di Rovereto, Rovereto (TN) (Prof. G. Miceli e<br />
Dr.ssa R. Capasso) per lo studio dei disturbi semantico-lessicali<br />
nei pazienti colpiti da lesioni cerebrali ischemiche nel<br />
territorio di distribuzione delle arterie cerebrali posteriori.<br />
Clinica Neurologica dell’Università di Milano, Ospedale S.<br />
Paolo (Dr.ssa C. Rosci) per lo studio dell’evoluzione degli<br />
errori afasici nei pazienti acuti.<br />
Divisione di Riabilitazione e Recupero Funzionale dell’Ospedale<br />
S. Paolo di Milano (Dr.ssa R. Pagani) per la valutazione<br />
dei pazienti di P.S. affetti da ischemia cerebrale<br />
per occlusione delle arterie cerebrali posteriori.<br />
48<br />
Istituto Fatebenefratelli di Cernusco s/N - Milano (Dr. R.<br />
Barbarotto) per i disturbi di memoria semantica.<br />
Oviedo University, Oviedo, Spagna, Psychology Department<br />
(Prof. F. Cuetos) per lo studio delle variabili psicolinguistiche<br />
che influenzano la capacità di denominare.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca principalmente comprende:<br />
(i) Lo studio dei disturbi afasici del linguaggio, orale e scritto,<br />
e delle alterazioni neuropsicologiche frequentemente associate<br />
ad essi. Il comportamento dei pazienti afasici risulta<br />
utile per verificare la validità dei modelli cognitivi di<br />
riferimento e per contribuire ad un loro aggiornamento a<br />
livello teorico.<br />
(ii) Lo studio del tipo di errori della produzione afasica riesce<br />
ad individuare un percorso nel recupero del linguaggio sia<br />
nella fase acuta del disturbo che nella successiva fase subacuta.<br />
Ciò è utile anche per la validazione dell’efficacia<br />
del trattamento logoterapico ponendo attenzione all’aspetto<br />
qualitativo del miglioramento.<br />
(iii) Interpretazione delle alterazioni della memoria semantica.<br />
Lo studio mirato di questi disturbi è utile per formulare le<br />
ipotesi su come sono rappresentati nella nostra mente i<br />
concetti ed offre materiale per correlazioni anatomo-funzionali.<br />
Il dibattito teorico sottostante ipotizza o un’organizzazione<br />
concettuale diffusa basata su correlazioni tra le<br />
diverse caratteristiche dei singoli elementi o un’organizzazione<br />
dei concetti determinata dalle strutture neuroanatomiche<br />
importanti per le loro proprietà sensori-motorie o<br />
dalle categorie semantiche a cui appartengono.<br />
(iv) Allestimento di nuovi strumenti testistici. Viene particolarmente<br />
dato spazio al calcolo dei relativi dati normativi facendo<br />
riferimento a tecniche psicometriche originali.<br />
Questa metodica consente una maggiore affidabilità diagnostica.<br />
Attività formativa e didattica<br />
L’attività di formazione, qualora richiesta, mette a disposizione<br />
l’apporto di professionalità interne, nell’area clinica e di ricerca<br />
della Neuropsicologia.<br />
Lezioni a corsi ECM: Dr.ssa Laiacona e Prof. Capitani (Perugia,<br />
Milano, Veruno).<br />
Viene offerta inoltre la possibilità di tirocini a studenti, compatibilmente<br />
con il lavoro clinico svolto dal Servizio di Neuropsicologia.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
L’attività di ricerca che viene svolta ha importanti ricadute in<br />
ambito clinico. Più in generale, la messa a punto di prove testistiche<br />
con dati normativi teoricamente e quantitativamente<br />
robusti, sicuramente rende più affidabile l’attività diagnostica.<br />
Più in particolare, lo sviluppo e la conferma di modelli cognitivi<br />
di riferimento, suggerisce indirizzi terapeutici nei singoli<br />
pazienti. Questo approccio viene già largamente usato nel<br />
trattamento dei pazienti afasici.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Dissociazione delle conoscenze relative agli esseri viventi<br />
rispetto a quelle relative agli stimoli inanimati.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
L’evoluzione degli errori di denominazione in pazienti afasici<br />
fluenti in fase acuta e post-acuta.<br />
Disturbi di scrittura in pazienti afasici.<br />
Pubblicazioni<br />
Laiacona M, Caramazza A. (2004) The noun/verb dissociation<br />
in language production: Varieties of causes. Cognitive<br />
Neuropsychology, 21 (2/3/4), 103-123.<br />
Barbarotto R, Laiacona M, Capitani E. (2005) Objective<br />
versus estimated age of word acquisition: a study on 202<br />
Italian children. Behavior Research Methods, Instruments,<br />
& Computers, 37 (4), 644-650.<br />
Capitani E, Laiacona M. (2005) An illusory illusion? Comments<br />
on “Illusions of Normality” by Keith Laws. Cortex,<br />
41, 854-855.<br />
Laiacona M, Barbarotto R. (2005) On double dissociations,<br />
controls and gender: some neglected data about category<br />
specificity. Cortex, 41, 858-859.<br />
Laiacona M, Barbarotto R, Capitani E. (2005) Animals recover<br />
but plant life knowledge is still impaired 10 years<br />
after herpetic encephalitis: The long-term follow-up of a<br />
patient. Cognitive Neuropsychology, 22, 78-94.<br />
Mondini S, Luzzatti C, Saletta P, Allamano N, Semenza C.<br />
(2005) Mental representation of prepositional compounds:<br />
Evidence from Italian agrammatic patients. Brain and Language,<br />
94, 178-187.<br />
Laiacona M, Allamano N, Lorenzi L, Capitani E. (2006) A<br />
Case of Impaired Naming and Knowledge of Body Parts. Are<br />
Limbs a Separate Sub-category? Neurocase, 12, 307-316.<br />
Laiacona M, Barbarotto R, Capitani E. (2006) Human evolution<br />
and the brain representation of semantic knowledge:<br />
is there a role for sex differences? Evolution and<br />
Human Behaviour, 27, 158-168.<br />
Barbarotto R, Laiacona M, Capitani E. (in press) Does sex<br />
influence the age of acquisition of common names? A<br />
contrast of different semantic categories. Cortex, in press.<br />
Cuetos F, Rosci C, Laiacona M, Capitani E. (in press) Different<br />
variables predict anomia in different subjects: A<br />
longitudinal study of two Alzheimer’s patients. Neuropsychologia,<br />
in press.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Marcella Laiacona.<br />
Nata a Milano, Italia, 9-7-1954.<br />
1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso<br />
l’Università degli Studi di Milano.<br />
1985 - Specializzazione in Neurologia presso<br />
l’Università degli Studi di Pavia.<br />
Attività Clinica e di Ricerca post-laurea<br />
Dal 1980 collabora regolarmente alle attività di ricerca neuropsicologica<br />
svolte dalle Cattedre di Clinica Neurologica e di<br />
Neuropsicologia Clinica dell’Università di Milano.<br />
Dal Dicembre 1989 ricopre l’incarico di Neurologo presso il Servizio<br />
di Neuropsicologia della Divisione di Neurologia, Istituto<br />
Scientifico di Veruno, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS.<br />
È regolarmente iscritta alla Società Italiana di Neuropsicologia.<br />
Attività Didattica<br />
Dal 1982 al 1985: Lezioni di Anatomia e Clinica Neurologica al<br />
corso di perfezionamento in “Diagnosi e rieducazione dei disturbi<br />
afasici” tenuto presso la Clinica Neurologica dell’Università<br />
di Milano (Policlinico).<br />
Dal 1986 al 1999 supervisione di studenti per la preparazione<br />
della tesi di laurea in Neurologia della facoltà di Medicina e<br />
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, con la funzione<br />
di Correlatore.<br />
Pubblicazioni Scientifiche<br />
È autore di 152 pubblicazioni scientifiche in ambito neuropsicologico:<br />
88 sono ricerche sperimentali originali pubblicate su<br />
riviste (77 su riviste internazionali in lingua inglese e 11 su riviste<br />
italiane), 14 sono capitoli di libro o volumi e 50 sono<br />
estratti di Comunicazioni a Congressi (vedi come esempio le<br />
principali pubblicazioni scientifiche di articoli su riviste internazionali<br />
indicizzate sopra riportate). La maggior parte degli<br />
articoli è focalizzata sugli aspetti dei disturbi afasici del linguaggio,<br />
sui disturbi delle conoscenze semantiche e sui metodi<br />
psicometrici usati nella costruzione dei test e delle misure<br />
di normalità.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 49<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
8. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEI DISTURBI COGNITIVI ESITATI<br />
A LESIONE CEREBRALE FOCALE<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884730<br />
e-mail: clelia.marchetti@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Clelia Marchetti<br />
L’attività del laboratorio parte dalla valutazione clinica e testistica<br />
di pazienti portatori di cerebrolesioni acquisite per la<br />
precisazione delle sequele cognitive di queste. La descrizione<br />
precisa dei deficit cognitivi che i pazienti presentano a fronte<br />
delle abilità conservate permette di costruire un profilo cognitivo<br />
che sarà possibile confrontare con quello atteso in un<br />
soggetto di pari età e scolarità. Lo studio delle modificazioni<br />
delle funzioni cognitive indotte da eventi patologici permette<br />
inoltre di fare inferenze sul funzionamento del sistema cognitivo<br />
normale. Lo sviluppo di modelli permette ricadute cliniche<br />
importanti nella valutazione e nel trattamento riabilitativo dei<br />
pazienti. L’identificazione di marcatori neuropsicologici dell’evoluzione<br />
clinica di patologie di vario ambito permette un’intervento<br />
precoce e mirato anche di tipo farmacologico. Lo<br />
studio dell’outcome cognitivo di interventi neurochirurgici e<br />
cardiochirurgici può indirizzare verso scelte cliniche motivate.<br />
L’attività di ricerca si avvale di collaborazioni nazionali ed internazionali.<br />
È volta a studiare l’impatto di varie condizioni morbose sul sistema<br />
cognitivo e, identificando possibili dissociazioni, giungere<br />
ad ipotesi sul funzionamento normale di questo e sulle<br />
possibili correlazioni anatomo-funzionali. Si propone inoltre di<br />
identificare possibili marcatori neuropsicologici della presenza,<br />
della gravità e dell’evoluzione di diverse patologie e di<br />
suggerire ipotesi di intervento riabilitativo modellato sul deficit<br />
cognitivo identificato nel singolo paziente.<br />
Il laboratorio mette a disposizione l’apporto di professionalità interne<br />
nell’area clinica e di ricerca neuropsicologica. Viene inoltre<br />
offerta la possibilità di supervisione per tesi di laurea o per tiro-<br />
50<br />
cini a studenti o specializzandi e di periodi di frequenza per affiancamento<br />
nelle attività di clinica e ricerca a psicologi o neurologi<br />
che operano in questo campo e che ne facciano richiesta.<br />
Vengono svolte lezioni nell’ambito di corsi per la formazione<br />
continua in medicina (ECM).<br />
Attività di Ricerca<br />
Identificazione di elementi prognostici clinici e neuropsicologici<br />
in pazienti con cerebrolesione acquisita.<br />
Studio di modelli cognitivi per l’interpretazione dei deficit di<br />
programmazione ed esecuzione dei movimenti volontari.<br />
Studio di “casi singoli” con deficit cognitivi o sintomi comportamentali<br />
rari.<br />
Studio di deficit cognitivi esitati a diversi tipi di approccio<br />
operatorio a lesioni di interesse neurochirurgico ed identificazione<br />
di marcatori e predittori dell’outcome cognitivo.<br />
Studio dei deficit cognitivi in pazienti con scompenso cardiaco<br />
o con recente intervento cardiochirurgico: analisi<br />
dell’evoluzione del profilo cognitivo e ricerca di possibili<br />
connessioni tra l’outcome cardiologico e quello cognitivo.<br />
Costruzione di modelli di intervento riabilitativo mirato al<br />
deficit specifico rilevato nei singoli pazienti e controllo neuropsicologico<br />
dell’evoluzione nel tempo del deficit stesso.<br />
Studio di marcatori neuropsicologici e clinici per l’identificazione<br />
precoce di decadimento cognitivo.<br />
Studio integrato dei meccanismi neuropatogenetici della<br />
patologia neurodegenerativa: analisi dei processi infiammatori<br />
e immunitari per l’identificazione di nuovi target terapeutici.<br />
Pubblicazioni<br />
Marchetti C., Della Sala S. La mano anarchica. Sindrome<br />
del Dottor Stranamore. In: Il cervello ferito Della Sala, Beschin<br />
Eds Giunti 2006 Divisione di Neurologia Servizio aggregato<br />
di Neuropsicologia.<br />
Marchetti C. Il ruolo del neuropsicologo nella gestione<br />
delle gravi cerebrolesioni acquisite e delle demenze. Giornale<br />
Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia 2007;<br />
29: 1, 105-108.<br />
Perri R., Carlesimo G.A., Serra L., Caltagirone C. and the<br />
early diagnosis group of the Italian Interdisciplinary<br />
Network on Alzheimer’s disease (Marchetti C.). Characterization<br />
of memory profile in subjects with Amnesic Mild<br />
Cognitive Impairment. In Journal of Clinical and Experimental<br />
Neuropsychology 2005; 27: 1033-1055.<br />
Marchetti C., Carey D., Della Sala S. Crossed Right hemisphere<br />
syndrome following left thalamic stroke. Journal of<br />
Neurology 2005; 252, 403-411.<br />
Della Sala S., Marchetti C. Anarchic hand in Higher order<br />
motor disorders. From neuroanatomy and neurobiology to<br />
neurology. Oxfor University Press 2005.<br />
Rosci C., Sacco D., Laiacona M., Capitani E. The interpretation<br />
of a complex picture and its sensitivity to frontal damage.<br />
Neurological Sciences 2005; 25, 6, 322-330.<br />
Bartolo A., Cubelli R., Della Sala S., Drei S., Marchetti C.<br />
Double dissociation between meaningful and meaningless<br />
gesture Reproduction in apraxia Cortex 2001; 37, 696-699.<br />
Cubelli R., Marchetti C., Boscolo G., Della Sala S. Cognition<br />
in Action: testing a model of limb apraxia. Brain and Cognition<br />
2000, 44, 144-165.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Marchetti C., Della Sala S. Disentangling the Alien and<br />
Anarchic Hand Cognitive Neuropsychiatry 1998; 3, 3, 191-207.<br />
Della Sala S., Logie R., Trivelli C., Cubelli R., Marchetti C.<br />
Dissociation beetween Recency and Span: The Short and<br />
The long of it. Neuropsychology 1998; 12, 4, 533-545.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Clelia Marchetti, nata a Bergamo il 19<br />
Marzo 1959 ha ottenuto il diploma di Maturità<br />
Classica, si è laureata in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università degli Studi di Torino<br />
il 9 Luglio 1985. Abilitata all’esercizio della<br />
professione di Medico Chirurgo nella seconda<br />
sessione dell’anno 1985 ha conseguito<br />
il diploma di Specializzazione in Neurologia il<br />
29 Giugno 1990 presso l’Università degli studi di Parma.<br />
Attività Lavorativa Clinica e di Ricerca<br />
Lavora dal novembre 1985 presso la Divisione di Neurologia<br />
dell’Istituto Scientifico di Veruno della <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong><br />
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS dove ricopre<br />
dal 2004 il ruolo di responsabile del Servizio di Neuropsicologia.<br />
È responsabile dal 2000 dell’UVA (Unità Valutazione<br />
Alzheimer) dell’Istituto Scientifico di Veruno.<br />
È autore o coautore di numerosi lavori scientifici pubblicati su<br />
riviste nazionali ed internazionali.<br />
Appartenenza a Società scientifiche<br />
Dal 1988 Membro della L.I.M.P.E. Lega Italiana contro il<br />
Morbo di Parkinson e le Malattie Extrapiramidali.<br />
Dal 1989 membro della S.I.N. Società Italiana di Neurologia.<br />
Dal 1998 membro della SINP Società Italiana di Neuropsicologia<br />
Stage.<br />
Honorary Visiting Research Fellow presso il Dipartimento di<br />
Psicologia dell’Università di Aberdeen (Scozia) nel 1990.<br />
Attività Didattica<br />
Ha curato la supervisione di studenti per la preparazione di<br />
tesi di laurea in Medicina e Psicologia.<br />
Dal 2001 al 2005 professore a contratto presso la scuola di<br />
Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università di<br />
Torino.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
9. LABORATORIO DI RICERCA PER<br />
I DISTURBI PSICOLOGICI E COGNITIVI<br />
NEL MORBO DI PARKINSON<br />
Casa di Cura Major, Torino<br />
Via Santa Giulia, 60<br />
Tel. 011.81516309<br />
e-mail: federico.cossa@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Federico Maria Cossa<br />
L’attività di ricerca del Laboratorio, di carattere neuropsicologico<br />
e psicologico, viene svolta in modo integrato sulla<br />
stessa popolazione di pazienti, ossia Parkinsoniani cui è<br />
stato inserito il dispositivo per la stimolazione cerebrale<br />
profonda che vengono ricoverati presso la Casa di Cura<br />
Major. La terapia chirurgica della Malattia di Parkinson effettuata<br />
mediante stimolazione cerebrale profonda dei nuclei<br />
sub-talamici è una procedura innovativa che sta fornendo un<br />
grande contributo al trattamento della malattia. Consiste<br />
nella stimolazione con impulsi elettrici ad alta frequenza dei<br />
nuclei sub-talamici mediante elettrodi posizionati permanentemente<br />
ed alimentati da un generatore di impulsi collocato<br />
in area sottoclaveare e regolabile telemetricamente mediante<br />
uno programmatore esterno in funzione delle esigenze<br />
cliniche del paziente. La corretta selezione dei candidati<br />
è una delle variabili da cui dipende in modo cruciale l’efficacia<br />
della SCP. La selezione deve infatti tener conto di criteri<br />
anagrafici, clinici, psicologici e neuropsicologici, al fine<br />
di identificare i pazienti che potranno trarre il maggior beneficio<br />
dalla metodica.<br />
Il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino si occupa<br />
dal 1998 di terapia chirurgica della Malattia di Parkinson<br />
ed ha a disposizione una delle più ampie casistiche europee.<br />
In questo contesto è stata sviluppata da anni una collaborazione<br />
scientifico-assistenziale tra la Divisione di Riabilitazione<br />
Neuromotoria della Casa di Cura Major ed il Dipartimento di<br />
Neuroscienze dell’Università di Torino, onde procedere al<br />
follow-up clinico ed allo studio neuropsicologico dei pazienti<br />
operati e di avviarli ad idonei percorsi riabilitativi.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 51<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Concorrono all’attività di ricerca il Prof. Lopiano, del Dipartimento<br />
di Neuroscienze dell’Università di Torino ed il Prof. Geminiani,<br />
della Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino, in<br />
virtù delle convenzioni stipulate tra la <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong><br />
e l’Università di Torino. Nell’ambito delle attività sancite da<br />
dette convenzioni al Laboratorio afferiscono laureandi in Medicina<br />
e Chirurgia, laureandi in Psicologia, e specializzandi in<br />
Psicologia Clinica.<br />
Attività di Ricerca<br />
Ambito psicologico<br />
Scopo dell’attività di ricerca è quello di identificare i fattori<br />
coinvolti nell’elaborazione delle informazioni da parte del paziente<br />
riguardo alla malattia, al fine di valutare come l’informazione<br />
venga integrata dal paziente in una visione di insieme<br />
della malattia e come, infine, questa visione guidi la pianificazione<br />
delle strategie di coping influendo sull’outcome. I<br />
risultati raccolti sono utilizzati per arrivare ad una presa in carico<br />
del paziente e della famiglia modellata sulle reali necessità<br />
individuali.<br />
Ambito neuropsicologico<br />
Per quanto attiene alla ricerca in neuropsicologia ci si propone<br />
di valutare, mediante valutazioni longitudinali, l’impatto<br />
dello stimolatore sub-talamico su molteplici funzioni corticali,<br />
quali la programmazione del movimento, la funzionalità dei<br />
lobi frontali e dell’emisfero destro, e sulla capacità fonatorie e<br />
deglutitorie.<br />
I risultati raccolti, oltre che al miglioramento della conoscenza<br />
sugli effetti della stimolazione sub-talamica, possono essere<br />
utilizzati per l’affinamento delle procedure riabilitative neuromotorie<br />
e per affinare i criteri di selezione all’intervento.<br />
Ricerche in corso<br />
Allo stato attuale il Laboratorio è impegnato nel Progetto di<br />
Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute “Caratteristiche<br />
pre – cliniche e modelli di trattamento non – farmacologico<br />
dei disturbi cognitivi e motori della Malattia di Parkinson”,<br />
coordinato dal Prof. Marco Schieppati.<br />
Il contributo specifico al programma consiste: (i) nella valutazione<br />
neuropsicologica longitudinale dei pazienti affetti da<br />
malattia di parkinson e sottoposti a stimolazione cerebrale<br />
profonda, al fine di studiare le eventuali modificazioni della<br />
sfera cognitiva riconducibili all’elettrostimolazione, e (ii) nello<br />
studio dell’eventuale effetto indotto dalla stimolazione cerebrale<br />
profonda sulla velocità di esecuzione del movimento e<br />
sulla velocità della sua programmazione corticale, valutati mediante<br />
un test ad hoc basato sul paradigma sperimentale dei<br />
tempi di reazione visivi semplici e complessi.<br />
Questi gli scopi del progetto: ottimizzare i criteri neuropsicologici<br />
generali di selezione mediante l’analisi delle modificazioni<br />
indotte dalla SCP al profilo cognitivo pre-intervento; ottimizzare<br />
la procedura di stimolazione al fine di minimizzare le<br />
eventuali modificazioni in negativo del profilo cognitivo; acquisire<br />
conoscenze sui processi di programmazione corticale<br />
del movimento ed utilizzarle al fine di elaborare procedure riabilitative<br />
specifiche.<br />
52<br />
Ricerche in programmazione<br />
È attualmente in fase di progettazione una possibile collaborazione<br />
con la Divisione di Foniatria dell’Ospedale San Giovanni<br />
Battista di Torino per la comune valutazione dei disturbi fonatori<br />
e deglutitori indotti dalla stimolazione cerebrale profonda.<br />
Pubblicazioni<br />
Angelino E. Lost in translation: la prospettiva transculturale<br />
nella promozione della salute, non solo un problema<br />
di linguaggio. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed<br />
Ergonomia. Supplemento A, Psicologia. 2007; 29: A55-57.<br />
Angelino E. L’approccio riabilitativo al paziente parkinsoniano<br />
sottoposto a stimolazione del nucleo subtalamico:<br />
obiettivi dell’intervento psicologico. Giornale Italiano di<br />
Medicina del Lavoro ed Ergonomia. 2007; 29 (1): 109-111.<br />
Antonini A, Isaias IU, Canesi M, Zibetti M, Mancini F,<br />
Manfredi L, Dal Fante M, Lopiano L, Pezzoli G. Duodenal<br />
levodopa infusion for advanced Parkinson’s disease: 12month<br />
treatment outcome. Movement Disorders. 2007; 22<br />
(8): 1145-49.<br />
Benedetti F, Lanotte M, Lopiano L, Colloca L. When words<br />
are painful: unraveling the mechanisms of the nocebo effect.<br />
Neuroscience. 2007; 29 (147): 260-271.<br />
Di Fonzo A, Chien HF, Socal M, Giraudo S, Tassorelli C, Iliceto<br />
G, Fabbrini G, Marconi R, Fincati E, Abbruzzese G,<br />
Marini P, Squitieri F, Horstink MW, Montagna P, Libera<br />
AD, Stocchi F, Goldwurm S, Ferreira JJ, Meco G, Martignoni<br />
E, Lopiano L, Jardim LB, Oostra BA, Barbosa ER,<br />
The Italian Parkinson Genetic Network, Bonifati T.<br />
ATP13A2 missense mutations in juvenile parkinsonism<br />
and young onset Parkinson disease. Neurology. 2007; 68<br />
(19): 1157-62.<br />
Ferrarin M, Carpinella I, Rabuffetti M, Rizzone M, Lopiano<br />
L, Crenna P. Unilateral and bilateral subthalamic nucleus<br />
stimulation in Parkinson’s disease: effects on EMG signals<br />
of lower limb muscles during walking. IEEE Transactions<br />
on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2007;<br />
15 (2): 182-89.<br />
Tommasi G, Lopiano L, Zibetti M, Cinquepalmi A, Fronda<br />
C, Bergamasco B, Ducati A, Lanotte M. Freezing and hypokinesia<br />
of gait induced by stimulation of the subthalamic<br />
region. Journal of Neurological Sciences. 2007; 258<br />
(1): 99-103.<br />
Zibetti M, Torre E, Cinquepalmi A, Rosso M, Ducati A, Bergamasco<br />
B, Lanotte M, Lopiano L. Motor and Nonmotor<br />
Symptom Follow-Up in Parkinsonian Patients after Deep<br />
Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus. European<br />
Neurology. 2007; 58 (4): 218-23.<br />
Attività Educazionale<br />
I membri del Laboratorio di Ricerca svolgono da anni attività<br />
di docenza presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di<br />
Psicologia, per l’insegnamento relativo alla Neuropsicologia<br />
Clinica. Svolgono inoltre regolare attività di docenza in corsi di<br />
formazione aziendale.<br />
Partecipano inoltre in qualità di docente a corsi di formazione<br />
ECM organizzati dall’Associazione Gilberto Cominetta per le<br />
cure palliative in neurologia.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Federico Maria Cossa, nato a Milano il 16<br />
Novembre 1959, si è laureato in Medicina e<br />
Chirurgia presso l’Università degli Studi di<br />
Milano il 10 Aprile 1986, conseguendo la<br />
massima votazione con lode.<br />
Nel Luglio 1990 ha conseguito la Specialità in<br />
Neurologia presso l’Università di Pavia; nel<br />
Dicembre 2006 la specialità in Medicina Fisica<br />
e Riabilitazione presso l’Università di Torino.<br />
Dal 1983 si occupa dello studio delle patologie degenerative<br />
dementigene del Sistema Nervoso Centrale e dei deficit cognitivi<br />
secondari a trauma cranico in collaborazione con il<br />
Prof. Hans Spinnler, il Prof. Sergio Della Sala ed il Prof. Erminio<br />
Capitani.<br />
Dal 1988 è socio della Società Italiana di Neuropsicologia; dal<br />
1991 della Società Italiana di Neurologia.<br />
Lavora presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> dal 1989: dal<br />
Luglio 2007 è Primario della Divisione di Riabilitazione Neuromotoria<br />
della Casa di Cura Major, Torino, sede distaccata dell’Istituto<br />
Scientifico di Veruno (IRCCS, <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>).<br />
Collabora stabilmente con l’Università di Milano (Prof. Erminio<br />
Capitani), con l’Università di Torino (Prof. Giuliano Geminiani,<br />
Prof. Leonardo Lopiano) ed il CNR di Milano. È autore di 14<br />
articoli pubblicati su riviste internazionali, 11 articoli pubblicati<br />
su riviste nazionali, 14 capitoli di libro, 21 abstract di congressi<br />
nazionali ed internazionali. Ha curato come Editor la pubblicazione<br />
di 2 libri in italiano.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
10. LABORATORIO BIOPSIE CUTANEE<br />
Istituto Scientifico di Telese Terme<br />
Via Bagni Vecchi, 1<br />
Tel. 0824.909257<br />
e-mail: maria.nolano@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Maria Nolano<br />
Il laboratorio delle biopsie cutanee, coordinato dalla Dr.ssa<br />
Maria Nolano, unico nel Centro-Sud dell’Italia ed uno dei<br />
pochi in Europa si occupa dello studio dell’innervazione cutanea<br />
in patologie congenite ed acquisite del sistema nervoso<br />
periferico. Applicando tecniche di immunofluorescenza e la<br />
microscopia confocale su piccoli prelievi cutanei, è in grado di<br />
diagnosticare precocemente neuropatie sensitive e/o autonomiche<br />
e di studiare i processi di degenerazione e di rigenerazione<br />
delle fibre nervose nell’uomo nella patologia ed in modelli<br />
sperimentali.<br />
Il laboratorio ha effettuato ed effettua training per ricercatori<br />
di diversi istituti universitari e non per la introduzione allo<br />
studio immunoistochimico di campioni bioptici cutanei (prelievi,<br />
taglio, preparazione dei vetrini e acquisizioni immagini al<br />
microscopio). Grazie a questa attività educazionale nuovi laboratori<br />
sono stati allestiti o sono in via di allestimento presso<br />
l’Università di Bologna e di Genova. Inoltre nell’ambito della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> un nuovo laboratorio è stato allestito<br />
presso il Centro di Pavia. La collaborazione con il laboratorio<br />
di biopsie cutanee dell’Università del Minnesota (dove la<br />
Dr.ssa Nolano ha effettuato il suo percorso educazionale)<br />
continua e consente un continuo scambio di conoscenze<br />
scientifiche. La competenza specifica maturata dalla Dr.ssa<br />
Nolano ha portato inoltre alla sua inclusione nella task force<br />
che si è occupata della definizione delle linee guida europee<br />
sull’utilizzo della biopsia cutanea nelle neuropatie.<br />
Attività di Ricerca<br />
Neuropatie delle piccole fibre. La neuropatia delle piccole<br />
fibre è una condizione patologica relativamente frequente,<br />
che complica il decorso di malattie quali diabete mellito, im-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 53<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
munodeficienze da HIV, neoplasie, che può verificarsi quale<br />
complicanza di chemioterapia o più raramente riconosce<br />
cause genetiche o rimane idiopatica. La diagnosi di neuropatia<br />
delle piccole fibre sfugge alle routinarie indagini elettrofisiologiche<br />
e pertanto si avvale di tests psicofisici quali lo<br />
studio delle soglie termiche e dolorifiche che richiedono l’attiva<br />
collaborazione del paziente. La biopsia cutanea permette<br />
di dimostrare morfologicamente una sofferenza delle fibre<br />
sensitive di piccolo calibro. Presenta, rispetto alla biopsia del<br />
nervo surale, i seguenti vantaggi: 1. Minima invasività; 2. Possibilità<br />
di effettuare il prelievo nell’area maggiormente compromessa;<br />
3. Possibilità di ripetere il prelievo bioptico nel<br />
tempo valutando morfologicamente l’eventuale efficacia di<br />
trattamenti farmacologici.<br />
Il parametro generalmente utilizzato per diagnosticare una<br />
sofferenza delle piccole fibre con la biopsia cutanea è la densità<br />
di fibre nervose epidermiche.<br />
La presenza di fibre nervose nell’epidermide è stata dimostrata<br />
in maniera inconfutabile solo negli ultimi 10 anni grazie<br />
alla scoperta del marcatore pan-neuronale protein gene product<br />
(PGP) 9.5. Le fibre nervose epidermiche (ENF) originano<br />
dai neuroni dei gangli dorsali e rappresentano le ultime terminazioni<br />
di fibre C e probabilmente A-delta. Si tratta di fibre<br />
sottili che si staccano dal plesso nervoso sottoepidermico, e,<br />
una volta superata la membrana basale, perdono il rivestimento<br />
costituito da cellule di Schwann e entrano nell’epidermide<br />
attraversandola fino allo strato corneo come assoni nudi.<br />
La funzione di tali fibre è ancora sconosciuta. Si suppone che<br />
siano fibre sensitive e per la maggior parte rappresentino nocicettori<br />
polimodali.<br />
Disautonomie. Oltre alle fibre epidermiche, la biopsia cutanea<br />
permette di evidenziare una complessa rete nervosa<br />
sotto-epidermica e la ricca innervazione di strutture dermiche<br />
quali ghiandole sudoripare, vasi e follicoli piliferi, fornendo<br />
pertanto informazioni anche sul contingente di fibre autonomiche<br />
cutanee. Ciò consente di studiare neuropatie prevalentemente<br />
autonomiche (es. la sindrome di Ross) o sensitivoautonomiche<br />
(es. l’insensibilità congenita al dolore con anidrosi).<br />
Neuropatie delle grosse fibre. Estendendo lo studio dell’innervazione<br />
cutanea alla cute glabra (polpastrello) è possibile<br />
valutare la densità di meccanorecettori cutanei, quali i recettori<br />
di Meissner, e delle fibre mieliniche ad essi afferenti.<br />
Nelle neuropatie sensitive tipo dying-back, in fase subclinica,<br />
sono esclusivamente queste ultime terminazioni nervose ad essere<br />
coinvolte, ed in questo caso le comuni indagini elettrofisiologiche<br />
(VCS da stimolo elettrico) possono risultare normali.<br />
Appare evidente come la possibilità di osservare un danno<br />
delle fibre nervose precocemente possa determinare atteggiamenti<br />
terapeutici ed ambientali molto più efficaci.<br />
Lo studio dell’innervazione cutanea è pertanto utile anche<br />
quando il danno coinvolge le fibre di grosso calibro.<br />
Studi di correlazione morfo-funzionale. Accanto all’applicazione<br />
clinico-diagnostica la biopsia cutanea si presta a<br />
studi di correlazione morfo-funzionale finalizzati alla comprensione<br />
del ruolo delle fibre nervose epidermiche e dei diversi<br />
meccanorecettori cutanei nell’ambito delle varie modalità<br />
sensitive. A questo proposito nel nostro laboratorio i pazienti<br />
vengono sottoposti oltre alla valutazione clinica ed elettrofisiologia,<br />
allo studio quantitativo delle soglie termiche, tat-<br />
54<br />
tili e dolorifiche; allo studio della sudorazione (SIT e test di<br />
Minor); allo studio dei potenziali tattili.<br />
Inoltre la biopsia cutanea rappresenta uno strumento che per<br />
la scarsa invasività si presta a studi sperimentali nell’uomo<br />
sulla rigenerazione delle fibre nervose in piccole aree cutanee<br />
dove le fibre epidermiche possono essere danneggiate con<br />
mezzi chimici (capsaicina) o meccanici (blister).<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio della neuropatia nelle eredoatassie.<br />
Studio dei disturbi autonomici ed in particolare delle anidrosi<br />
generalizzate congenite ed acquisite.<br />
Studio delle neuropatie dolorose.<br />
Studio morfo-funzionale dei recettori cutanei.<br />
Studio della rigenerazione nervosa epidermica nei pazienti<br />
con Atassia di Friedreich mediante un modello di denervazione<br />
meccanica (blister).<br />
Studio della neuropatia in pazienti sclerodermici.<br />
Progetti di Ricerca in programmazione<br />
Studio del coinvolgimento sensitivo ed autonomico cutaneo<br />
nelle malattie neurodegenerative.<br />
Studio dell’innervazione trigeminale nei soggetti sani e nei<br />
soggetti affetti da nevralgia e neuropatia del trigemino.<br />
Pubblicazioni<br />
Nolano M, Provitera V, Perretti A, Stancanelli A, Saltalamacchia<br />
AM, Donadio V, Manganelli F, Lanzillo B, Santoro<br />
L. Ross syndrome: a rare or a misknown disorder of thermoregulation?<br />
A skin innervation study on 12 subjects.<br />
Brain. 2006 Aug; 129 (Pt 8): 2119-31.<br />
Donadio V, Nolano M, Provitera V, Stancanelli A, Lullo F,<br />
Liguori R, Santoro L. Skin sympathetic adrenergic innervation:<br />
an immunofluorescence confocal study. Ann Neurol.<br />
2006 Feb; 59 (2): 376-81.<br />
Provitera V, Nolano M, Pagano A. Acetylcholinesterase<br />
inhibition and orthostatic hypotension. Clin Auton Res.<br />
2006; 16 (2): 136.<br />
Santoro L, Manganelli F, Bruno R, Nolano M, Provitera V,<br />
Barbieri F. Sural nerve and epidermal vascular abnormalities<br />
in a case of POEMS syndrome. Eur J Neurol. 2006 Jan;<br />
13 (1): 99-102.<br />
Manganelli F, Perretti A, Nolano M, Lanzillo B, Bruni AC,<br />
De Michele G, Filla A, Santoro L. Electrophysiologic characterization<br />
in spinocerebellar ataxia 17. Neurology. 2006<br />
Mar 28; 66 (6): 932-4.<br />
<strong>Salvatore</strong> E, Varrone A, Sansone V, Nolano M, Bruni AC,<br />
De Rosa A, Santoro L, Pappata S, Filla A, De Michele G.<br />
Characterization of nigrostriatal dysfunction in spinocerebellar<br />
ataxia 17. Mov Disord. 2006 21 (6): 872-5.<br />
Provitera V, Nolano M, Pagano A, Caporaso G, Stancanelli<br />
A, Santoro L. Myelinated nerve endings in human skin.<br />
Muscle Nerve 2007; 35 (6): 767-775.<br />
Manganelli F, Iodice V, Provitera V, Pisciotta C, Nolano M,<br />
Perretti A, Santoro L. Small fiber involvement in spinalbulbar-muscular<br />
atrophy (Kennedy’s disease). Muscle<br />
Nerve 2007 Dec; 36 (6): 816-20.<br />
Provitera V, Nolano M, Pappone N, Lubrano E, Stancanelli<br />
A, Lanzillo B, Santoro L. Axonal degeneration in systemic<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
sclerosis can be reverted by factors improving tissue oxygenation.<br />
Reumathology 2007 Nov; 46 (11): 1739-41.<br />
Solari A, Laurà M, Salsano E, Radice D, Pareyson D; On<br />
behalf of the CMT-TRIAAL Study Group. Reliability of clinical<br />
outcome measures in Charcot-Marie-Tooth disease. Neuromuscul<br />
Disord. 2007 Oct 25; doi:10.1016/j.nmd.2007.09.006<br />
[Epub ahead of print]<br />
Altre Attività del Laboratorio<br />
La densità e la distribuzione delle fibre nervose epidermiche<br />
possono essere studiate con l’utilizzo di un metodo ancora<br />
meno invasivo della biopsia cutanea, il “blister”. Applicando<br />
una pressione negativa su una piccola area cutanea di 2-3<br />
mm di diametro, l’epidermide si separa dal derma senza danneggiare<br />
membrana basale e vasi dando luogo alla formazione<br />
di una bolla. Il tetto della bolla viene quindi rimosso e<br />
processato con il vantaggio di poter visualizzare le ENF nell’intero<br />
campione. Questa metodica non è dolorosa e pertanto<br />
non è necessario l’uso di anestetico locale, non lascia cicatrici<br />
e permette di valutare una superficie epidermica almeno 20<br />
volte più grande di quella valutabile su una singola sezione<br />
bioptica. Questa metodica è stata messa a punto dal prof.<br />
Kennedy e dalla Dr.ssa Nolano, durante il periodo da lei trascorso<br />
presso l’Università di Minneapolis.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Maria Nolano.<br />
Nata ad Acerra (NA) il 6-12-59.<br />
30-7-1985 Laurea in Medicina e Chirurgia<br />
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
dell’Università Federico II di Napoli con voti<br />
110 e lode/110.<br />
985 Abilitazione all’esercizio professionale presso l’università<br />
G. D’Annunzio di Chieti.<br />
1989-Specializzazione in Neurologia presso la Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli<br />
con voti 50/50 e lode.<br />
1991-1995 Corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze<br />
presso Le Università Consorziate “Federico II”, Napoli “Seconda”<br />
e di Bari conseguendo il titolo nel 1996 con una tesi<br />
dal titolo: “Sensibilità tattile della cute glabra nella mano<br />
dell’uomo: considerazioni anatomo-funzionali”.<br />
1995-1996 Research associate in Neurology presso il Dipartimento<br />
di Neurologia dell’Università del Minnesota,<br />
Minneapolis, USA.<br />
Dall’anno accademico 1997-1998 Docente a contratto presso<br />
la scuola per tecnici di Neurofisiopatologia della Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II”.<br />
1993 ad oggi Neurologo presso la Divisione di Riabilitazione<br />
Neuromotoria del Centro Medico di Campoli/Telese, <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, I.R.C.C.S.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
11. LABORATORIO DI METODI<br />
QUANTITATIVI E MODELLI PER L’ANALISI<br />
DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884747<br />
e-mail: andrea.giordano@fsm.it<br />
Responsabile: Ing. Andrea Giordano<br />
L’attività del Laboratorio di Bioingegneria della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> dedicato allo studio del movimento e della<br />
postura è focalizzata sullo sviluppo ed adozione di metodologie<br />
strumentali che forniscano elementi quantitativi rispondenti<br />
alla necessità di valutazioni diversificate ed obbiettive<br />
per la determinazione della gravità e natura della limitazione<br />
funzionale causate dalle patologie neuromotorie e dell’effetto<br />
su di esse del trattamento.<br />
Il Laboratorio, che afferisce al Dipartimento di Bioingegneria e<br />
Tecnologie Biomediche, opera in stretta collaborazione con la<br />
Divisione di Recupero e Rieducazione Funzionale, il Servizio di<br />
Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia, il Servizio di Neuroriabilitazione<br />
dell’Istituto Scientifico di Veruno ed il Centro Studi<br />
Attività Motorie dell’Istituto Scientifico di Pavia.<br />
Attività di Ricerca<br />
1) Quantificazione delle capacità posturali<br />
In questo ambito vengono progettati e realizzati sistemi originali<br />
e protocolli per la valutazione del sistema sensorimotorio<br />
preposto al mantenimento della posizione eretta.<br />
Tali sistemi si caratterizzano per l’integrazione in un unico<br />
quadro d’insieme dei dati provenienti dalla cattura in 3 dimensioni<br />
del movimento (“Motion capture”), dell’attività elettromiografica<br />
dei principali gruppi muscolari posturali e della<br />
reazione della superficie d’appoggio alle lievi oscillazioni del<br />
corpo durante la stazione eretta sia mentre il soggetto sta<br />
mantenendo la posizione eretta in condizioni non perturbate<br />
(posturografia statica), sia mentre si trova sottoposto in modo<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 55<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
inatteso a spostamenti della posizione della superficie d’appoggio<br />
(posturografia dinamica).<br />
Le conoscenze acquisite ed i metodi realizzati costituiscono<br />
l’infrastruttura del Laboratorio per la Postura e il Movimento<br />
della Divisione di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Istituto<br />
Scientifico di Veruno, nel quale i risultati conseguiti<br />
vengono impiegati nella routine clinica.<br />
Principali obbiettivi di ricerca raggiunti nel biennio<br />
SISTEMI ORIGINALI E PROTOCOLLI SVILUPPATI<br />
Sistema per la quantificazione del controllo motorio ottenuta<br />
tramite sensori wireless.<br />
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI<br />
Il movimento umano e l’integrazione sensorimotoria. Ridondanza,<br />
plasticità, apprendimento, memoria spaziale, degradazione,<br />
modelli (Finanziata MIUR - PNR 2003-2005, FIRB).<br />
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO<br />
Quantificazione della performance posturale tramite sistema<br />
portatile.<br />
PROGETTI DI RICERCA IN PROGRAMMAZIONE<br />
Quantificazione ambulatoriale della performance motoria<br />
e posturale tramite sistema indossabile.<br />
2) Quantificazione dell’attività motoria di lungo periodo<br />
Nata dalla necessità di documentare l’attività motoria svolta<br />
da un soggetto per lunghi periodi, per la verifica di ridotta attività<br />
motoria a domicilio e/o sul lavoro o per la determinazione<br />
di indicatori di outcome basati sull’analisi dell’attività<br />
motoria pre- post- intervento rieducativo, la ricerca in questo<br />
campo è stata focalizzata sul superamento degli approcci sin<br />
qui seguiti che vanno delle consuete tecniche clinimetriche<br />
all’impiego di complesse apparecchiature di analisi del movimento;<br />
la soluzione ideata prevede strumenti portatili e specifici<br />
algoritmi di classificazione in grado di documentare con<br />
precisione per lunghi periodi (ore, potenzialmente giorni) il<br />
tempo trascorso dal soggetto in esame nelle varie attività della<br />
vita quotidiana come camminare, salire o scendere le scale,<br />
andare in bicicletta, stare seduti o sdraiati.<br />
Il RAAM (Registratore Avanzato di Attività Motoria) si è dimostrato<br />
idoneo alla misura obbiettiva dell’attività motoria per la<br />
valutazione dell’effetto della patologia e dell’efficacia del trattamento<br />
riabilitativo non solamente in situazioni sperimentali<br />
e pertanto poco realistiche, ma anche nell’ambiente domiciliare<br />
del paziente.<br />
Principali obbiettivi di ricerca raggiunti nel biennio<br />
SISTEMI ORIGINALI E PROTOCOLLI SVILUPPATI<br />
Tecnica a doppia knowledge-base per la corretta classificazione<br />
dell’attività motoria dei soggetti con amputazione<br />
dell’arto inferiore a livello transfemorale tramite RAAM.<br />
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI<br />
Taratura del Registratore Avanzato di Attività Motorie<br />
(RAAM) per l’analisi della mobilità dell’amputato a livello<br />
transfemorale (INAIL, contr. ric., 2005-2006).<br />
Neurotossicità ambientale e rischio di malattia di<br />
Parkinson (Finanziata PF ex art 56).<br />
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO<br />
Valutazione dell’effetto di vari tipi di protesi di arto inferiore<br />
sulla performance del registratore di attività motoria<br />
RAAM (INAIL, contr. ric., 2006-2007).<br />
56<br />
PROGETTI DI RICERCA IN PROGRAMMAZIONE<br />
Continuità di cura nella Malattia di Parkinson attraverso il<br />
monitoraggio domiciliare dell’attività motoria (proposta ricerca<br />
finanziata ex art. 56).<br />
Collaborazioni Esterne<br />
Area Ricerca, Centro Protesi INAIL, Vigorso di Budrio (BO).<br />
Dipartimento di Tecnologie e Sanità, Istituto Superiore<br />
della Sanità.<br />
Pubblicazioni<br />
Giordano A, Colombo R, Minuco G. Nuove tecnologie nella<br />
valutazione e nei trattamenti riabilitativi. G Ital Med Lav<br />
Ergon. 2007 Jan-Mar; 29 (1): 56-61.<br />
Martignoni E, Giordano A, Franchignoni F, Artuso A, Pasetti<br />
C, Galante M. Aspetti della riabilitazione nella malattia<br />
di Parkinson. G Ital Med Lav Ergon. 2007 Jan-Mar; 29<br />
(1): 97-100.<br />
Franchignoni F, Ferriero G, Giordano A, Guglielmi V, Picco<br />
D. Rasch psychometric validation of the Impact on Participation<br />
and Autonomy questionnaire in people with Parkinson’s<br />
disease. Eura Medicophys. 2007 Apr 27; [Epub].<br />
Franchignoni F, Giordano A, Ferriero G, Orlandini D, Amoresano<br />
A, Perucca L. Measuring mobility in people with<br />
lower limb amputation: Rasch analysis of the mobility section<br />
of the prosthesis evaluation questionnaire. J Rehabil<br />
Med. 2007 Mar; 39 (2): 138-44.<br />
Gallagher P, Horgan O, Franchignoni F, Giordano A, MacLachlan<br />
M. Body image in people with lower-limb amputation:<br />
a Rasch analysis of the Amputee Body Image Scale.<br />
Am J Phys Med Rehabil. 2007 Mar; 86 (3): 205-15.<br />
Ferriero G, Franchignoni F, Giordano A, Picco D, Martignoni<br />
E. Validazione della versione italiana del Parkinson’s<br />
Disease Questionnaire a 8 item (PDQ-8). Malattia di<br />
Parkinson, Sindromi Extrapiramidali, Demenze, XXXIV<br />
Congresso Nazionale LIMPE 2007 - Roma.<br />
Giordano A, Franchignoni F. Strumenti per il monitoraggio<br />
a lungo termine dell’attività motoria.<br />
Argomenti di Terapia Occupazionale (Aracne Editrice),<br />
Volume II (Capitolo).<br />
Giordano A. Monitoraggio dell’attività motoria del paziente<br />
neurologico. Convegno “Impiego di Nuove Tecnologie nei<br />
Trattamenti di Neuroriabilitazione” 2006 - Pavia.<br />
Giordano A. Monitoraggio dell’attività motoria: strumenti<br />
ed applicazioni. Convegno “Aggiornamenti in Neuroriabilitazione”<br />
Istituto Auxologico Italiano, 5 Maggio 2006.<br />
Giordano A, Franchignoni F, Minuco G, Comazzi F, Nicita<br />
D, Davalli A, Orlandini D. Classification of activities in<br />
people with lower limb amputation through long-term activity<br />
recording. 15th European Congress of Physical and<br />
Rehabilitation Medicine, 2006 Madrid.<br />
Giordano A, Franchignoni F, Ferriero G, Minuco G, Orlandini<br />
D, Amoresano A. Measuring mobility in people with<br />
lower-limb amputation - a Rasch analysis of the Mobility<br />
Section of the Prosthesis Evaluation Questionnaire. 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine,<br />
2006 Madrid.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Ing. Andrea Giordano. Dal conseguimento<br />
della Laurea, in Ingegneria Elettronica, specializzazione<br />
in calcolatori, avvenuta presso<br />
l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1981,<br />
con tesi “Progetto e realizzazione di un sistema<br />
pluricanale intelligente programmabile<br />
per l’acquisizione di dati a media ed alta velocità:<br />
studio di sistema e specializzazione a<br />
problematiche biologiche”, è impiegato presso il Servizio di<br />
Bioingegneria della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>. Si è interessato<br />
di problematiche di analisi del movimento e di acquisizione<br />
ed elaborazione digitale di segnali biologici, ideando e<br />
sviluppando metodiche originali per la determinazione e lo<br />
studio delle fasi temporali del passo, delle risposte EMG a stimolazioni<br />
(meccaniche, di stiramento, proprio-nocicettive), di<br />
analisi del movimento e della postura tramite sensori dinamometrici<br />
ed optoelettronici. Ha progettato la strumentazione del<br />
Laboratorio di Postura e Movimento dell’Istituto Scientifico di<br />
Veruno, integrando in un unico ambiente operativo sistemi<br />
optoelettronici di cattura del movimento, pedane dinamometriche<br />
per la determinazione della reazione piede-suolo e rilevatori<br />
di segnali elettrofisiologici che consentono al personale<br />
del Laboratorio di svolgere una diversificata e proficua attività<br />
clinica e di ricerca. Si è interessato di Telematica, sia applicata<br />
alla gestione di dati clinici e sanitari che specificatamente alla<br />
Riabilitazione, in particolare ideando e sperimentando soluzioni<br />
di telemedicina applicata al collegamento tra Ospedale e<br />
Centri di Eccellenza, tra Centro di Eccellenza e domicilio del<br />
paziente, tra Centro di Eccellenza e strutture di Gestione delle<br />
Emergenze. Al momento, è interessato al monitoraggio domiciliare<br />
dell’attività motoria, svolto tramite soluzioni combinate<br />
biomeccaniche-telematiche. L’attività portata avanti si è svolta<br />
nell’ambito di numerosi progetti di Ricerca Corrente e Finanziata,<br />
in particolare dalla CEE, dal Ministero della Salute, dal<br />
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, da contratti<br />
di ricerca con Enti (INAIL), nei quali il ruolo svolto è stato<br />
quello di Responsabile di Unità Operativa. Autore e co-autore<br />
di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali,<br />
nonché di presentazioni e relazioni a Congressi nazionali<br />
ed internazionali, è Segretario Scientifico del Dipartimento<br />
di Bioingegneria e Tecnologie Biomediche della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>. Membro del Comitato Scientifico della 1 a<br />
Conferenza Internazionale sul monitoraggio ambulatoriale<br />
dell’attività fisica e del movimento.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
12. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEI PROCESSI DI PRODUZIONE<br />
DELLA PAROLA<br />
CENTRO “PRIMO LANZONI”<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: paolo.pinelli@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Paolo Pinelli<br />
Il Centro “Primo Lanzoni” per lo Studio dei Processi di Produzione<br />
della Parola è stato istituito per iniziativa del Prof. Paolo<br />
Pinelli nell’anno 1999 con lo scopo di combinare l’attività di ricerca<br />
e quella clinica nell’ambito dello studio delle funzioni<br />
cerebrali di controllo della parola, dei processi di invecchiamento<br />
cerebrale, dei disturbi dislessici e della neuroriabilitazione.<br />
Attualmente il Centro opera attraverso l’attività svolta<br />
nei laboratori della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> dell’Istituto<br />
di Veruno e in quello di Pavia.<br />
La missione del Centro è quella di promuovere le applicazioni<br />
e gli studi che hanno condotto allo sviluppo originale della<br />
metodologia di verbocronometria a reazioni multiple dilazionate<br />
(MDRV). Tali studi sono stati via via messi a punto in funzione<br />
neuroriabilitativa sia in campo di valutazione funzionale<br />
del decorso spontaneo e sotto trattamento delle diverse patologie<br />
neurologiche, sia ai fini di trovare per i singoli pazienti<br />
indicazioni per la prevenzione di scompensi legati a compromissione<br />
del sistema nervoso.<br />
Ambito di Ricerca<br />
La metodologia di studio impiegata dai Laboratori del Centro<br />
“Primo Lanzoni” è basata sulla misura dei tempi di reazione<br />
che viene largamente impiegata in neuropsicologia, psicologia,<br />
neurologia e foniatria, per indagare le prestazioni dei diversi<br />
processi cerebrali coinvolti nell’esecuzione di un compito<br />
richiesto o nella produzione di una risposta generata per<br />
mezzo di uno stimolo esterno.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 57<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
I disordini della parola sono un reperto molto frequente nei<br />
pazienti affetti da malattie neurologiche. Con la metodologia<br />
MDRV è possibile ottenere la valutazione quantitativa e qualitativa<br />
delle prestazioni motorie del sistema di produzione della<br />
parola, fornendo informazioni utili sia per una diagnosi precoce<br />
che per il monitoraggio a lungo termine di varie malattie<br />
nervose.<br />
È possibile ottenere informazioni sulle funzioni programmatorie<br />
ed esecutive per mezzo di compiti di reazione immediata<br />
e di reazione dilazionata. Le reazioni dilazionate implementate<br />
in questa metodica consentono di fornire informazioni quantitative<br />
anche sul controllo di altre prestazioni motorie finalistiche<br />
diverse dal parlare. Va soprattutto rilevato che a monte<br />
del canale specifico della parola, la verbocronometria permette<br />
di individuare i processi compito-indipendenti ed in particolare<br />
l’attività della working memory (attenzione finalistica).<br />
I principali settori di ricerca sono:<br />
Compromissioni del network prefrontale.<br />
Acinesia Parkinsoniana e sindromi discinetiche.<br />
Fasi precoci delle demenze.<br />
Disturbi mentali di tipo confusionale e psicotico.<br />
Correlazioni tra potenziali cerebrali evento-correlati e<br />
tempo degli atti mentali elementari.<br />
Neurotossicologia.<br />
Identificazione dei processi compito indipendenti meglio<br />
preservati in malati cronici e loro potenziamento con training<br />
personalizzati.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca del Centro Primo Lanzoni si avvia agli inizi<br />
del 1990 con una serie di ricerche ed applicazioni che si sono<br />
concretizzate in progetti di ricerca finalizzata del Ministero della<br />
Salute. La prima fase di attività è stata centrata sullo sviluppo e<br />
standardizzazione della metodica di misura verbocronometrica,<br />
ovvero su tematiche di Bioingegneria. La collaborazione con i<br />
laboratori di Bioingegneria dell’Istituto di Veruno è proseguita<br />
per la successiva messa a punto e validazione delle motodiche.<br />
Successivamente sono stati messi a punto i modelli anatomofunzionali<br />
dei processi di attenzione protratta e di controllo<br />
delle informazioni. In particolare è stato sviluppato il modello<br />
teorico dell’Evento Psicofisiologico Elementare sulla base<br />
delle registrazioni eseguite sia su soggetti normali che patologici.<br />
Infine sono stati elaborati i criteri di valutazione sia delle<br />
patologie neurologiche che di quelle psichiatriche.<br />
Principali obiettivi di Ricerca raggiunti<br />
Progettazione della strumentazione per realizzare il laboratorio<br />
per le misure verbocronometriche.<br />
Progettazione e realizzazione di un dispositivo medicale<br />
specifico che consente la valutazione quantitativa in ambito<br />
clinico.<br />
Studio di un dispositivo portatile per applicazione in ambito<br />
neurotossicologico-lavorativo.<br />
Messa a punto di appositi protocolli per lo studio di fenomeni<br />
di fatica centrale.<br />
Studio dell’applicazione della metodologia in diverse patologie<br />
neurologiche a scopo riabilitativo.<br />
Partecipazione a Progetti Finanziati<br />
“Cronometria dei processi neurali psicomotori ed esposizione<br />
cronica a solventi neurotossici: un test di compro-<br />
58<br />
missione precoce utilizzabile in campo”. Convenzione ICS<br />
57.3/RF94.117.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio del coinvolgimento delle aree prefrontali nelle reazioni<br />
dilazionate a stimoli multipli.<br />
Applicazione della metodologia nella valutazione dell’acinesia<br />
nel morbo di Parkinson.<br />
Studio di indici di prestazione motoria e di affaticamento<br />
centrale.<br />
Applicazione della metodologia in neurotossicologia e in<br />
soggetti con dipendenza alcoolica.<br />
Esame delle modalità di attenzione in soggetti normali all’analisi<br />
delle reazioni dilazionate e di test di stile mentale<br />
cognitivo.<br />
Controllo degli effetti del training effettuato con la suddetta<br />
metodologia.<br />
Attività Educazionale<br />
L’attività educazionale del laboratorio ha lo scopo di diffondere<br />
i risultati della ricerca svolta e le ricadute cliniche sia dal<br />
punto di vista valutativo che da quello terapeutico. tale attività<br />
viene svolta attraverso la comunicazione nell’ambito di corsi e<br />
convegni sia a livello nazionale che a livello internazionale.<br />
Il centro accoglie tesisti e specializzandi delle Università con<br />
cui il centro è in stretto contatto.<br />
Collaborazioni<br />
Università di Pavia - Istituto Neurologico “C. Mondino”.<br />
Ospedale Universitario S. Paolo di Milano - Reparti di<br />
Neurologia ed Epilettologia.<br />
Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto di Neurologia<br />
- Laboratorio di Potenziali Evocati Motori - Roma.<br />
Clinica Villa Salus Mestre - Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione.<br />
Centro INAIL di Cremona.<br />
Pubblicazioni<br />
Pinelli P. Integrative and facilitatory processes in premotor<br />
pathology and their application in training. Functional<br />
Neurology. 2004; 19 (2): 131-133.<br />
Pasetti C, Lualdi MM, Pinelli P. A paradoxical acute effect<br />
of levodopa in de novo parkinsonian patients: worsening<br />
of some bradykinetic components. Neurol Sci. 2003; 24:<br />
201-202.<br />
Ceriani F, Neromante I, Pinelli P. Corticomotor Excitability<br />
evaluated with Delayed Reactions in Parkinsonian Patients.<br />
In Proceedings of the 3 rd world congress of Neurological<br />
Rehabilitation, Venice, Apr 2-6, 2002.<br />
Pinelli P, Colombo R, Ceriani F, Pinelli M, Pinelli P. Sustained<br />
attention and information-processing vulnerability in the<br />
light of a new test: a target for cognitive psychotherapy. Psicoterapia<br />
Cognitiva e Comportamentale. 2000; 6, 1: 19-31.<br />
Pinelli P, Ceriani F, Colombo R, Pasetti C, Terazzi M, Castignoli<br />
G. Quantitative verbal reactions are specifically impaired<br />
in patients with schizophrenia. Int J Psychophysiol.<br />
2000; 37: 163-175.<br />
Pinelli P, Colombo R, Onorato S. Analisi dell’attenzione<br />
protratta nelle reazioni verbali. Advances in Rehabilitation.<br />
Vol. 1, N. 6, 1999 PIME Press Pavia (Book).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Colombo R, Minuco G, Pasetti C, Pinelli P. Delayed verbal<br />
reactions: technology and methodology. Int J Phycophysiol.<br />
1998; 22, 1-2; 16.<br />
Colombo R, Minuco G, Pasetti C, Pinelli P. Impairment of<br />
verbal delayed reactions in schizophrenics. Int J Phycophysiol.<br />
1998; 22, 1-2; 16.<br />
Ceriani F, Pinelli P, Piazzini A, Canger R, Canavesini MP,<br />
Colombo R. Impairment of delayed verbal reactions in epileptic<br />
patients. Int J Phycophysiol. 1998; 22, 1-2; 16.<br />
Colombo R, Spinatonda G, Minuco G, Miscio G, Pisano F,<br />
Pinelli P. Studio dei processi di produzione della parola:<br />
metodi di analisi ed applicazione in un gruppo di soggetti<br />
normali (Parte I). Giornale Italiano di Medicina del Lavoro<br />
ed Ergonomia. 1997; 19, 3: 80-84.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof. Paolo Pinelli.<br />
Professore Emerito di neurologia dell’Università<br />
di Milano fino al 1992.<br />
Ricercatore neurofisiologo presso l’Università<br />
di Copenaghen dal 1946 al 1950.<br />
Professore Associato di neurologia e Incaricato<br />
di psichiatria presso l’Università di Pavia<br />
dal 1950 al 1966.<br />
Professore di clinica delle malattie nervose e mentali all’Università<br />
Cattolica di Roma dal 1966 al 1972.<br />
Professore di neurologia presso all’Università di Pavia dal<br />
1972 al 1980.<br />
Attualmente è consulente di neurologia e ricercatore psicofisiologo<br />
presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRCCS, Istituto<br />
di Veruno.<br />
Membro onorario della ABN di Londra e delle Società di neurologia<br />
di Polonia e Spagna, vicepresidente della World Federation<br />
of Neurology dal 1976 al 1981 e membro del Comitato<br />
di biologia e medicina del CNR dal 1977 al 1983.<br />
Grazie alla sua vastissima esperienza sia in campo clinico che<br />
di ricerca è particolarmente interessato allo studio del controllo<br />
motorio umano soprattutto da un punto di vista psicofisiologico.<br />
Egli è autore di diversi saggi, di oltre 400 pubblicazioni a livello<br />
nazionale ed internazionale e di 18 libri, in campo neurologico,<br />
psicopatologico, antropologico e neuroriabilitativo.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
13. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEI DISTURBI COGNITIVI IN PAZIENTI<br />
CON SEQUELE DI TRAUMA CRANICO<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884703<br />
e-mail: marcella.laiacona@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Marcella Laiacona<br />
In questo laboratorio i disturbi cognitivi conseguenti ad un<br />
trauma cranico sono l’oggetto di studio principale. In particolare<br />
verranno allestite prove testistiche in grado di rilevare disturbi<br />
da disfunzione dei lobi frontali, frequentemente danneggiati<br />
in queste circostanze.<br />
Collaborazioni Scientifiche<br />
Il laboratorio si avvale della collaborazione continuativa con<br />
l’Università di Milano (Prof. E. Capitani) sia per l’aspetto metodologico<br />
che per l’impostazione dei progetti di ricerca.<br />
Il laboratorio ha inoltre diverse occasioni di collaborazione a<br />
livello nazionale:<br />
Il laboratorio continua a collaborare col Dr. F. Cossa, ora in<br />
servizio, come Responsabile della Divisione di Riabilitazione<br />
Neuromotoria, presso la sezione distaccata di Torino,<br />
per l’analisi dei protocolli già raccolti in passato<br />
presso questo Centro Medico di Veruno.<br />
Clinica Neurologica dell’Università di Milano, Ospedale<br />
S. Paolo (Dr.ssa C. Rosci e Dr.ssa M.C. Saetti) per la raccolta<br />
e l’analisi di dati relativi a nuovi progetti di ricerca.<br />
Istituto Fatebenefratelli di Cernusco s/N - Milano (Dr.<br />
R. Barbarotto) per la messa a punto di prove testistiche.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca principalmente comprende:<br />
(i) Studio dei disturbi neuropsicologici e più in particolare<br />
delle funzioni attentive nei pazienti che hanno subito un<br />
trauma cranico. Facendo riferimento a prove di fluenza<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 59<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
verbale, viene indagata la possibile differenza tra la rievocazione<br />
di parole solo su facilitazione fonologica e la rievocazione<br />
di parole usando similarità semantiche come<br />
facilitazione.<br />
(ii) Studio delle funzioni prefrontali: nello svolgere un compito,<br />
spesso viene contrastata la strategia che viene adottata<br />
per risolverlo ed una generale spinta ad iniziare a<br />
farlo. Queste due componenti possono essere presenti nei<br />
compiti di fluenza verbale ed è possibile osservare una<br />
loro dissociazione nei pazienti con danno prefrontale. Tuttavia<br />
solo un approccio multivariato nell’analisi del compito<br />
può distinguere queste due componenti. Dal punto di<br />
vista anatomico, in genere le strutture dorso-laterali vengono<br />
contrapposte a quelle mesiali.<br />
(iii) Le funzioni prefrontali sono necessarie per la comprensione<br />
di una scena complessa o di una situazione nella<br />
vita di tutti i giorni: occorre una esplorazione attiva di tutti<br />
gli elementi presenti, una selezione di quelli più importanti<br />
ed una elaborazione di ipotesi sul loro significato. Una disfunzione<br />
prefrontale rende meno efficiente questa esplorazione<br />
attiva. Il compito di ricostruire il significato di una<br />
scenetta raffigurata in un quadro è un esempio paradigmatico<br />
di questa attività mentale ed è stato introdotto in<br />
Italia a questo scopo clinico dal Prof. E. Bisiach. È stato<br />
scelto il quadro di Giacomo Favretto intitolato “Il sorcio”<br />
(esposto a Brera a Milano), per la sua semplicità. Questa<br />
prova è molto facile e veloce da proporre anche ai pazienti<br />
traumatizzati e sarebbe utile accertarne la sensibilità.<br />
(iv) Allestimento di nuovi strumenti testistici. Viene particolarmente<br />
dato spazio al calcolo dei relativi dati normativi facendo<br />
riferimento a tecniche psicometriche originali.<br />
Questa metodica consente una maggiore affidabilità diagnostica<br />
delle prove.<br />
Attività Didattica e Formativa<br />
L’attività di formazione, qualora richiesta, mette a disposizione<br />
l’apporto di professionalità interne, nell’area clinica e di ricerca<br />
della Neuropsicologia. Possibili lezioni a corsi ECM.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
L’attività di ricerca che viene svolta ha importanti ricadute in<br />
ambito clinico. Più in generale, la messa a punto di prove testistiche<br />
con dati normativi teoricamente e quantitativamente<br />
robusti, sicuramente rende più affidabile l’attività diagnostica.<br />
Ciò può essere considerato prioritario alla scelta degli indirizzi<br />
terapeutici nei singoli pazienti.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Disturbi attentivi in soggetti con esiti di trauma cranico.<br />
Mancata comprensione di una scena complessa in pazienti<br />
con danno prefrontale.<br />
Allestimento di dati normativi su coppie di test usati<br />
spesso in associazione tra loro in quanto indagano compiti<br />
simili sottesi però da abilità cognitive differenti.<br />
Pubblicazioni<br />
Pomati S, Farina E, Magni E, Laiacona M, Mariani C. (1996)<br />
Normative data for two Neuropsychological Tests sensitive<br />
60<br />
to frontal dysfunction. Italian Journal of Neurological<br />
Sciences, 17: 201-209.<br />
Giovagnoli AR, Del Pesce M, Laiacona M, Capitani E.<br />
(1996) Trail Making Test: normative values from 287 adult<br />
normal controls. Italian Journal of Neurological Sciences,<br />
17: 305-310.<br />
Capitani E and Laiacona M. (1997) Composite neuropsychological<br />
batteries and normative values. Standardisation<br />
based on Equivalent scores, with a review of published<br />
data. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology<br />
19, 795-809.<br />
Barbarotto R, Laiacona M, Frosio E, Vecchio L, Farinato A,<br />
Capitani E. (1998) A normative study on visual reaction<br />
times and two Stroop colour-word tests. Italian Journal of<br />
Neurological Sciences 19: 161-170.<br />
Capitani E, Laiacona M, Barbarotto R and Cossa FM.<br />
(1999) How can we evaluate interference in attentional<br />
tests? A study based on bi-variate non-parametric tolerance<br />
limits. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology,<br />
21: 216-228.<br />
Cossa FM, Fabiani M, Laiacona M, Capitani E. (1999) The<br />
preliminary Neuropsychological Battery. An instrument to<br />
grade the cognitive level of minimally responsive patients.<br />
Brain Injury, 13 (8): 583-592.<br />
Laiacona M, Inzaghi MG, De Tanti A, Capitani E. (2000)<br />
Wisconsin Card Sorting Test: a new global score, with Italian<br />
norms, and its relationship with the Weigl Sorting Test.<br />
Neurological Sciences, 21: 279-291.<br />
Rosci C, Sacco D, Laiacona M, Capitani E. (2005) Interpretation<br />
of a complex picture and its sensitivity to frontal damage:<br />
A reappraisal. Neurological Sciences, 25, 322-330.<br />
Reverberi C, Laiacona M, Capitani E. (2006) The quality of<br />
semantic fluency impairment in mesial and lateral frontal<br />
patients. Neuropsychologia, 44, 469-478.<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
Cossa FM, Farinato A, Laiacona M, Capitani E.: Batteria Neuropsicologica<br />
Preliminare (BNP): questa prova viene usata in<br />
pazienti in stato di Minima Responsività, stato che è caratteristico<br />
quando i pazienti emergono dallo stato di coma. Nel<br />
2001 è stato riconosciuto il brevetto nazionale della BNP<br />
(studio notarile Notarbartolo e Gervasi di Milano).<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Marcella Laiacona.<br />
Nata a Milano, Italia, 9-7-1954.<br />
1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso<br />
l’Università degli Studi di Milano.<br />
1985 - Specializzazione in Neurologia presso<br />
l’Università degli Studi di Pavia.<br />
Attività Clinica e di Ricerca post-laurea<br />
Dal 1980 collabora regolarmente alle attività di ricerca neuropsicologica<br />
svolte dalle Cattedre di Clinica Neurologica e di<br />
Neuropsicologia Clinica dell’Università di Milano.<br />
Dal Dicembre 1989 ricopre l’incarico di Neurologo presso il Servizio<br />
di Neuropsicologia della Divisione di Neurologia, Istituto<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Scientifico di Veruno, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS.<br />
È regolarmente iscritta alla Società Italiana di Neuropsicologia.<br />
Attività Didattica<br />
Dal 1982 al 1985: Lezioni di Anatomia e Clinica Neurologica al<br />
corso di perfezionamento in “Diagnosi e rieducazione dei disturbi<br />
afasici” tenuto presso la Clinica Neurologica dell’Università<br />
di Milano (Policlinico).<br />
Dal 1986 al 1999 supervisione di studenti per la preparazione<br />
della tesi di laurea in Neurologia della facoltà di Medicina e<br />
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, con la funzione<br />
di Correlatore.<br />
Pubblicazioni Scientifiche<br />
È autore di 152 pubblicazioni scientifiche in ambito neuropsicologico:<br />
88 sono ricerche sperimentali originali pubblicate su<br />
riviste (77 su riviste internazionali in lingua inglese e 11 su riviste<br />
italiane), 14 sono capitoli di libro o volumi e 50 sono<br />
estratti di Comunicazioni a Congressi (vedi come esempio le<br />
principali pubblicazioni scientifiche di articoli su riviste internazionali<br />
indicizzate, sopra riportate). Per quanto concerne<br />
questo laboratorio di ricerca, una parte delle sue pubblicazioni<br />
scientifiche è focalizzata sugli aspetti metodologici inerenti la<br />
costruzione di test neuropsicologici con le relative misure di<br />
normalità e sulla loro applicazione con pazienti affetti da esiti<br />
di trauma cranico.<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
1. UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA<br />
MOLECOLARE<br />
AREA MEDICINA SPERIMENTALE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921<br />
e-mail: silvia.priori@fsm.it<br />
Responsabile: Prof.ssa Silvia G. Priori<br />
L’unità operativa di Cardiologia Molecolare svolge attività clinica<br />
e attività di ricerca sia epidemiologica che sperimentale<br />
nel campo delle cardiopatie ereditarie e con particolare riguardo<br />
alle malattie aritmogene ed alla morte improvvisa, per<br />
le quali questa UO rappresenta un Centro di riferimento a livello<br />
Europeo.<br />
Aree di Attività Laboratori Cardiologia Molecolare<br />
Diagnosi Molecolare delle malattie aritmogene cardiache.<br />
Identificazione delle basi genetiche delle malattie aritmogene.<br />
Genomica funzionale dei geni implicati nelle aritmie cardiache.<br />
Elettrofisiologia Cellulare.<br />
Attività di Ricerca di base<br />
Le linee principali di ricerca del Laboratorio sono:<br />
Identificazione di nuovi geni malattia. Negli ultimi 5 anni<br />
sono stati identificati due nuovi geni malattia, il gene RyR2<br />
implicato nella tachicardia ventricolare catecolaminergica<br />
(CPVT), il gene CACNA1c nella sindrome di Timothy<br />
(aritmie QT prolungato e cardiopatie congenite) ed il gene<br />
KCNJ2 per la variante 3 di sindrome del QT corto (SQTS).<br />
Caratterizzazione in vivo ed in vitro delle conseguenze<br />
della mutazioni identificate nei pazienti. Gli studi in vitro si<br />
avvalgono di tecniche di mutagenesi ed espressione delle<br />
mutazioni in sistemi cellulari eterologhi. Gli studi in vivo<br />
consistono nello sviluppo ed analisi fenotipica di modelli<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 61<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
transgenici nei quali viene ricreata la patologia identificata<br />
in ambito clinico. Ad oggi i ricercatori della cardiologia<br />
molecolare hanno avuto successo nello sviluppare un modello<br />
di topo transgenico di CPVT, mentre un altro è in<br />
fase di realizzazione. Sia i modelli in vitro che quelli in vivo<br />
risultano particolarmente utili per la comprensione dei<br />
meccanismi fisiopatologici delle malattie oggetto di studio<br />
e per l’identificazione e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.<br />
A partire dal 2005 è stato inoltre intrapresa una nuova<br />
linea di ricerca finalizzata allo studio dei processi di differenziazione<br />
del substrato elettrofisiologico nelle cellule<br />
staminali embrionali di origine murina. Questo progetto è<br />
finalizzato alla comprensione dei meccanismi molecolari<br />
dell’attività elettrica cardiaca e allo sviluppo di tecniche di<br />
terapia molecolare delle aritmie.<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Il laboratorio di biologia molecolare afferente all’U.O. di Cardiologia<br />
Molecolare della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Pavia esegue analisi di ricerca di mutazione per le principali<br />
patologie aritmogene ereditarie: sindrome del QT lungo, sindrome<br />
di Brugada, Tachicardia ventricolare catecolaminergica,<br />
cardiomiopatia dilatativa con blocco AV, ed altre. Nell’ambito<br />
di questa attività vengono analizzati sia i campioni di<br />
DNA raccolti presso l’ambulatorio afferente alla stessa U.O.,<br />
sia campioni riferiti da Centri esterni provenienti da tutto il territorio<br />
Nazionale, da diversi paesi Europei, USA, Canada, Brasile<br />
e Giappone.<br />
La possibilità di raccogliere sia dati clinici che genetici ha permesso<br />
negli ultimi anni di compiere numerose osservazioni<br />
sui rapporti genotipo-fenotipo, sia di tipo prognostico di stratificazione<br />
del rischio, sia in termini di ottimizzazione delle<br />
strategie terapeutiche. Il successo di questa linea di ricerca è<br />
testimoniato pubblicate sulle principali riviste internazionali di<br />
cardiologia e di genetica. Attualmente nel data base integrato<br />
clinico-sperimentale dei laboratori è raccolta la più ampia casistica<br />
mondiale per singolo Centro di pazienti portatori di malattie<br />
aritmogene e difetto genetico noto, mentre la banca del<br />
DNA contiene oltre 8000 campioni di pazienti con patologie<br />
aritmogene ereditarie.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Oltre alle attività di “routine” (analisi molecolare, mantenimento<br />
dei database, espressione in vitro di mutazioni), sono<br />
attualmente in corso i seguenti progetti di ricerca specifici:<br />
Impiego del “candidate gene approach” per l’identificazione<br />
di nuovi geni causa di sindrome di Brugada.<br />
Creazione di un ceppo di topo transgenico portatore di un<br />
difetto del gene CASQ2 (calsequestrina).<br />
Valutazione fenotipica in vitro ed in vivo del primo modello<br />
transgenico di CPVT, un topo knock-in condizionale recentemente<br />
sviluppato presso i nostri laboratori.<br />
Studio degli analoghi della ranolazina per l’identificazione<br />
di una molecola per il blocco selettivo della corrente tardiva<br />
del sodio (I Nasus ), e valutazione della farmacologia<br />
mutazione-specifica dei bloccanti del canale del sodio<br />
cardiaco.<br />
Progetto “Control of intracellular Calcium and Arrhythmias”.<br />
Studio del ruolo delle alterazioni del calcio intra-<br />
62<br />
cellulare nelle aritmie cardiache e nella morte improvvisa.<br />
Studio “Terapie biologiche innovative per l’infarto del miocardio;<br />
Laboratorio FIRB di Scienze Cardiovascolari”. Progetto<br />
multicentrico italiano caratterizzato allo studio di<br />
tecniche innovative per l’impiego delle cellule staminali in<br />
campo cardiovascolare.<br />
“Strategie Innovative per la diagnosi ed il trattamento di<br />
patologie ad elevato rischio cardiovascolare”. Studio multicentrico<br />
finalizzato allo sviluppo di metodiche diagnostiche<br />
e metodologie di stratificazione del rischio in pazienti<br />
con patologie cardiovascolari ad alto rischio di<br />
morte improvvisa, quali i portatori di patologie ereditarie<br />
ed i pazienti con cardiomiopatia dilatativa.<br />
Attività Educazionale<br />
Oltre all’attività didattica svolta regolarmente dalla Prof.ssa<br />
Priori ed i Suoi collaboratori presso la scuola di specializzazione<br />
in Cardiologia ed il corso di laurea in Medicina, dell’università<br />
di Pavia un’attenzione particolare è rivolta allo svolgimento di<br />
attività educative sul territorio. L’attività educazionale dell’Unità<br />
Operativa ha lo scopo di diffondere la cultura sulle malattie genetiche<br />
cardiache e la conoscenza degli strumenti di biologia<br />
molecolare in campo cardiologico, e di sensibilizzare i cardiologi<br />
sul territorio a questo tipo di problematiche. Questo tipo di<br />
attività viene svolta sia a livello internazionale, con la pubblicazione<br />
di documenti derivanti dall’attività di Task Force specifiche<br />
(vedi elenco pubblicazioni), sia a livello locale con l’organizzazione<br />
di incontri di aggiornamento per i cardiologi, per i<br />
medici di medicina sportiva e per i medici di medicina generale.<br />
Il laboratorio e l’ambulatorio del servizio di Cardiologia Molecolare<br />
ospitano regolarmente testsi dei corsi di laurea di Medicina<br />
e Biologia e specializzandi in cardiologia.<br />
Infine, a partire dal Gennaio presso il Web Server della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> è stato creato un sito internet dedicato<br />
alle malattie aritmogene ereditarie (http://www.fsm.it/cardmoc).<br />
Negli anni questo sito, annoverato anche nelle attività ufficiali<br />
della Società Europea di Cardiologia, viene costantemente aggiornato<br />
dai ricercatori della Cardiologia Molecolare coordinati<br />
dal Dr. Napolitano, ed è diventato un punto di riferimento<br />
internazionale per tutti i laboratori che offrono il servizio di<br />
diagnostica genetica delle patologie aritmogene ereditarie.<br />
Brevetti<br />
L’attività di ricerca dei laboratori di cardiologia molecolare ha<br />
portato nel corso del biennio 2003-2005 alla realizzazione di<br />
due brevetti, uno in ambito clinico ed un nell’ambito della ricerca<br />
di base.<br />
In ambito clinico, sulla base dei dati di epidemiologie molecolare<br />
raccolti nel corso degli ultimi anni, abbiamo sviluppato<br />
una nuova metodologia di approccio all’analisi genetica della<br />
sindrome del QT lungo. Il brevetto, dal titolo “Mutazioni associate<br />
alla sindrome del QT lungo e loro uso diagnostico” è<br />
stato messo a punto nei primi mesi del 2005. La sua applicazione<br />
nell’ambito delle diagnostica molecolare potrà portare<br />
ad un rilevante abbattimento dei tempi di esecuzione dell’analisi<br />
e dei relativi costi.<br />
In ambito sperimentale è in corso di brevettazione il modello<br />
di topo transgenico portatore di una mutazione del gene RyR2<br />
(proteina chiave per il controllo dei livelli di calcio intracellu-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
lare) identificata in diversi pazienti affetti da tachicardia catecolaminergica.<br />
Il modello permetterà di ottenere dati fisiopatologici<br />
importanti sulla fisiopatologie del processo eccitazione-contrazione<br />
e delle aritmie mediate dal sovraccarico di<br />
calcio intracellulare come avviene nella CPVT (un una patologia<br />
aritmogena ereditaria altamente maligna) e, presumibilmente<br />
anche in corso di scompenso cardiaco. Il modello sarà<br />
inoltre utile per sperimentare eventuali tentativi di terapia genica<br />
dei disordini del ritmo cardiaco.<br />
Pubblicazioni<br />
Thygesen K, Alpert JS, White HD; Joint ESC/ACCF/<br />
AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial<br />
Infarction, Jaffe AS, Apple FS, Galvani M, Katus HA,<br />
Newby LK, Ravkilde J, Chaitman B, Clemmensen PM, Dellborg<br />
M, Hod H, Porela P, Underwood R, Bax JJ, Beller GA,<br />
Bonow R, Van der Wall EE, Bassand JP, Wijns W, Ferguson<br />
TB, Steg PG, Uretsky BF, Williams DO, Armstrong PW,<br />
Antman EM, Fox KA, Hamm CW, Ohman EM, Simoons ML,<br />
Poole-Wilson PA, Gurfinkel EP, Lopez-Sendon JL, Pais P,<br />
Mendis S, Zhu JR, Wallentin LC, Fernández-Avilés F, Fox<br />
KM, Parkhomenko AN, Priori SG, Tendera M, Voipio-<br />
Pulkki LM, Vahanian A, Camm AJ, De Caterina R, Dean V,<br />
Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemans I,<br />
Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera<br />
M, Widimsky P, Zamorano JL, Morais J, Brener S, Harrington<br />
R, Morrow D, Lim M, Martinez-Rios MA, Steinhubl<br />
S, Levine GN, Gibler WB, Goff D, Tubaro M, Dudek D, Al-<br />
Attar N. Universal definition of myocardial infarction. Circulation.<br />
2007; 116: 2634-53.<br />
Cerrone M, Noujaim SF, Tolkacheva EG, Talkachou A,<br />
O’Connell R, Berenfeld O, Anumonwo J, Pandit SV, Vikstrom<br />
K, Napolitano C, Priori SG, Jalife J. Arrhythmogenic mechanisms<br />
in a mouse model of catecholaminergic polymorphic<br />
ventricular tachycardia. Circ Res. 2007; 101: 1039-48.<br />
Ruan Y, Liu N, Bloise R, Napolitano C, Priori SG. Gating<br />
properties of SCN5A mutations and the response to mexiletine<br />
in long-QT syndrome type 3 patients. Circulation.<br />
2007; 116: 1137-44.<br />
Mohamed U, Napolitano C, Priori SG. Molecular and electrophysiological<br />
bases of catecholaminergic polymorphic<br />
ventricular tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol. 2007;<br />
18: 791-7.<br />
Napolitano C, Priori SG. Diagnosis and treatment of catecholaminergic<br />
polymorphic ventricular tachycardia. Heart<br />
Rhythm. 2007; 4: 675-8.<br />
Seth R, Moss AJ, McNitt S, Zareba W, Andrews ML, Qi M,<br />
Robinson JL, Goldenberg I, Ackerman MJ, Benhorin J,<br />
Kaufman ES, Locati EH, Napolitano C, Priori SG, Schwartz<br />
PJ, Towbin JA, Vincent GM, Zhang L. Long QT syndrome<br />
and pregnancy. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 1092-8.<br />
Sauer AJ, Moss AJ, McNitt S, Peterson DR, Zareba W, Robinson<br />
JL, Qi M, Goldenberg I, Hobbs JB, Ackerman MJ,<br />
Benhorin J, Hall WJ, Kaufman ES, Locati EH, Napolitano C,<br />
Priori SG, Schwartz PJ, Towbin JA, Vincent GM, Zhang L.<br />
Long QT syndrome in adults. J Am Coll Cardiol. 2007; 49:<br />
329-37.<br />
Vecchietti S, Grandi E, Severi S, Rivolta I, Napolitano C,<br />
Priori SG, Cavalcanti S. In silico assessment of Y1795C and<br />
Y1795H SCN5A mutations: implication for inherited<br />
arrhythmogenic syndromes. Am J Physiol Heart Circ Physiol.<br />
2007; 292: H56-65.<br />
Imboden M, Swan H, Denjoy I, Van Langen IM, Latinen-<br />
Forsblom PJ, Napolitano C, Fressart V, Breithardt G,<br />
Berthet M, Priori S, Hainque B, Wilde AA, Schulze-Bahr E,<br />
Feingold J, Guicheney P. Female predominance and transmission<br />
distortion in the long-QT syndrome. N Engl J<br />
Med. 2006; 355: 2744-51.<br />
Choe CU, Schulze-Bahr E, Neu A, Xu J, Zhu ZI, Sauter K,<br />
Bähring R, Priori S, Guicheney P, Mönnig G, Neapolitano<br />
C, Heidemann J, Clancy CE, Pongs O, Isbrandt D.C-terminal<br />
HERG (LQT2) mutations disrupt IKr channel regulation<br />
through 14-3-3epsilon. Hum Mol Genet. 2006; 15:<br />
2888-902.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof.ssa Silvia G. Priori. Nata a Torino nel<br />
1960, si è laureata in Medicina e Chirurgia<br />
nel 1985 all’Università degli Studi di Milano,<br />
specializzandosi “cum laude” in Cardiologia<br />
nel 1989, e conseguendo il Dottorato di Ricerca<br />
in Fisiopatologia Cardiovascolare nel<br />
1995. Dal 1997 lavora a Pavia presso la <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> ed il Dipartimento di Cardiologia<br />
dell’Ateneo Pavese.<br />
Oltre all’attività accademica, che la vede impegnata, come<br />
Professore Associato, nella formazione dei medici iscritti alla<br />
scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli<br />
Studi di Pavia, l’attività didattica della Prof.ssa Priori si esplicita<br />
anche nella formazione e nell’aggiornamento dei giovani<br />
ricercatori che costituiscono il suo staff e dal 2004 è diventata<br />
Adjunct Professor of Pharmacology presso il Dipartimento di<br />
Farmacologia della State University of New York, Upstate<br />
Medical University di Syracuse, New York.<br />
Grazie alle competenze acquisite in Italia e all’estero (1986-<br />
89) Stage di Elettrofisiologia alla St. Louis Washington Univ.<br />
degli Stati Uniti; 1996-1997 Sabbatico di ricerca in Biologia<br />
Molecolare presso l’Istituto TIGEM-Telethon Institute for Genetic<br />
and Medicine-Milano), nel 1997 la Prof.ssa Priori diventa<br />
Direttore dei Laboratori di Cardiologia Molecolare ed Elettrofisiologia,<br />
presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> di Pavia e<br />
nel 2000 ha assunto il ruolo di Primario della relativa Unità<br />
Operativa. In questa sede, con i suoi collaboratori, svolge attività<br />
clinico-genetica e sperimentale. L’attività clinica si basa<br />
sullo studio e la cura delle malattie aritmogene cardiache e<br />
sulla prevenzione della morte improvvisa.<br />
Attualmente la Prof.ssa Priori è impegnata in numerose iniziative<br />
scientifiche della Società Europea di Cardiologia (ESC):<br />
come per esempio il Progetto Unexplained Cardiac Arrest Registry<br />
of Europe, del Working Group on Arrhythmias, che raccoglie<br />
la più ampia di casistica mondiale di pazienti affetti da<br />
fibrillazione ventricolare idiopatica con follow up clinico. Dal<br />
1998 al 2002 è stata Chairman dello “Study Group of Molecular<br />
Bases of Arrhythmias”, mirato a diffondere la conoscenza<br />
delle malattie cardiache ereditarie in Europa. In tale<br />
ambito la Prof.ssa Priori ha costituito un “Data Base on-line”<br />
che raccoglie lo stato dell’arte sulle malattie aritmogene ereditarie<br />
(http://www.fsm.it/cardmoc). Dal 1999 è chairman di<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 63<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
della “Task Force sulla Morte Cardiaca Improvvisa”, che ha redatto<br />
il “testo guida” internazionale su questa tematica. (Eur<br />
Heart J. 2001; 22: 1374-1450).<br />
Dal 2002 al 2006 è stata membro del Board della Società Europea<br />
di Cardiologia e dal 2002 al 2006 è stata chairman del<br />
Committee for Practice Guidelines della stessa Società Europea<br />
di Cardiologia. Da Giugno 2005 a Giugno 2007 è stata<br />
eletta Presidente della European Heart Rhythm Association<br />
(EHRA), Associazione della Società Europea di Cardiologia il<br />
cui principale compito è di svolgere attività di ricerca e formazione<br />
scientifica in ambito aritmologico, di cui attualmente<br />
ricopre la carica di Pass-President e membro del Board È<br />
inoltre Membro della Task Force della Società Europea di Cardiologia<br />
per lo sviluppo di linee guida sulle malattie cardiovascolari<br />
in pazienti con Diabete e Responsabile del programma<br />
di studio sulle malattie cardiovascolari nelle donne della Società<br />
Europea di Cardiologia.<br />
La Prof.ssa Priori è inoltre stata membro della Heart Rhythm<br />
Society (NASPE) e ha fatto parte della Scientific and Clinical<br />
Documents Committee e della Education Committee.<br />
Per quanto riguarda l’attività editoriale è Revisore per riviste<br />
quali: Circulation; Circulation Research; JACC; Lancet; Nature<br />
Medicine; JCE; PACE e membro dell’editorial board delle più<br />
importanti riviste del settore: Circulation; Circulation Research;<br />
Cardiov Res; PACE; Italian Heart Journal; Deputy<br />
Editor per il Journal of Cardiac Electrophysiology; Associate<br />
Editor per Europace.<br />
La Prof.ssa Priori è stata insignita di numerosi premi internazionali<br />
tra cui: il titolo di Honorary Professor of Huazhong University<br />
of Science and Technology (HUST) at Wuhan, China<br />
(2007); la “Douglas and Joan Zipes visiting professorhip”<br />
krannert Research Center, Indiana, University- Indianapolis<br />
USA (2007); la “Henry H Neufeld” Memorial Lectrure of the<br />
Israel Society of Cardiology (2007); la “Douglas Zipes Lectureship<br />
Award” Heart Rhythm Society, Denver, USA (2007); la<br />
“Thomas W. Smith Memorial Lecture” of the American Heart<br />
Association (2006); la “Paul Wood Lecture” e corrispettiva medaglia<br />
della British Cardiac Society, Manchester UK (2005), la<br />
“The Michel Mirowski Lectureship” della John Hopkins University,<br />
Baltimora, USA (2004); The Harry & Ellen Steinbaum<br />
Visiting Professorship in Cardiac Electrophysiology presso il<br />
Cedar Sinai Hospital and University Los Angeles California<br />
USA (2003); la Sterling Visiting Professorship: SUNY University<br />
of Syracuse, NY, USA (2003), la “Scholar in Cardiology”<br />
della Società Italiana di Cardiologia (2002); l’Oustanding Research<br />
Award in Pediatric Cardiology dell’American Heart Association<br />
per la scoperta del nuovo gene RyR2 correlato alla<br />
Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolominergica (CPVT)<br />
(2001).<br />
64<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
2. LABORATORIO DI CARDIOLOGIA<br />
NUCLEARE<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884761<br />
e-mail: mednucl.ve@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Claudio Marcassa<br />
Il Laboratorio di Cardiologia Nucleare, unità funzionale della<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa e del Servizio di Medicina<br />
Nucleare, svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della<br />
valutazione non invasiva della perfusione miocardica e della<br />
funzione biventricolare nel campo della cardiopatia ischemica<br />
e della disfunzione ventricolare in generale.<br />
Il laboratorio rappresenta un centro di riferimento in Italia e in<br />
Europa per la ricerca metodologica e della valutazione del significato<br />
clinico degli studi di cardiologia nucleare in specifiche<br />
popolazioni.<br />
Aree di Attività<br />
Valutazione della distribuzione della perfusione miocardica<br />
a riposo e durante test provocativo.<br />
Valutazione della vitalità miocardica.<br />
Valutazione della funzione ventricolare sinistra e destra,<br />
sistolica e diastolica.<br />
Valutazione del sincronismo di contrazione interventricolare<br />
ed intraventricolare sinistro e destro mediante analisi<br />
di Fourier.<br />
Attività Clinica<br />
Vengono valutati circa 1500 pazienti/anno, sia degenti che<br />
provenienti dal territorio.<br />
La metodica principale è la Scintigrafia Miocardica di Perfusione<br />
ad Emissione di Fotone Singolo, con acquisizione sincronizzata<br />
con il segnale elettrocardiografico (metodica<br />
gated-SPECT), in prevalenza con l’utilizzo di traccianti di per-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
fusione tecneziati. Tale metodica consente la simultanea valutazione<br />
della distribuzione della perfusione regionale (con la<br />
quantizzazione della estensione e severità del difetto perfusorio<br />
e del miocardio vitale residuo) e della funzione ventricolare<br />
globale e regionale (ispessimento parietale). La metodica<br />
fornisce importanti indici quantitativi di valenza prognostica<br />
quali: funzione ventricolare sinistra, estensione dell’area di necrosi,<br />
entità del miocardio vitale, estensione dell’area ischemica,<br />
uptake polmonare del tracciante. Tali parametri rivestono<br />
particolare importanza per le successive scelte decisionali<br />
cliniche.<br />
Di particolare interesse per le possibili scelte terapeutiche<br />
(impianto di stimolatore biventricolare), la valutazione del sincronismo<br />
di contrazione interventricolare ed intraventricolare<br />
sinistro e destro mediante analisi di Fourier applicata alla ventricolografia<br />
radioisotopica all’equilibrio.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca si è sviluppata sia sul versante metodologico<br />
che sul piano della fisiopatologia e ricerca clinica.<br />
Sul piano metodologico, l’attività si è concentrata, in particolare,<br />
sulla ottimizzazione delle metodiche di ricerca del miocardio<br />
vitale e della quantizzazione della tomografia miocardica.<br />
Di recente, è stato sviluppato anche un data-base specifico<br />
per la valutazione della perfusione miocardica nei pazienti<br />
trapiantati.<br />
Sul piano della ricerca fisiopatologica e clinica, l’interesse si è<br />
concentrato, in particolare, sulla relazione tra miocardio vitale,<br />
ibernazione e rimodellamento ventricolare nel post-infarto.<br />
Sul versante dello studio della funzione ventricolare nelle cardiomiopatie,<br />
ischemiche e non, l’attenzione si è concentrata<br />
sui legami tra disfunzione ventricolare sistolica, funzione diastolica,<br />
sincronismo di contrazione interventricolare ed intraventricolare,<br />
riserva inotropa, e prognosi. Più di recente, lo<br />
studio della morfologia e della funzione cardiaca è stato<br />
esteso anche a patologie di pertinenza più strettamente endocrinologica<br />
(carenze di ormone della crescita e obesità essenziale).<br />
L’attività clinica e di ricerca si è sviluppata parallelamente ad<br />
una politica della qualità. Fedeli a questo concetto, nel 1996<br />
abbiamo promosso una attività di Verifica e Revisione della<br />
Qualità in cardiologia nucleare, progetto che ha ricevuto l’egida<br />
sia della Associazione Italia di Medicina Nucleare che<br />
della European Association of Nuclear Medicine, e che ha<br />
visto la partecipazione effettiva di circa 50 centri di Medicina<br />
Nucleare che svolgevano attività di cardiologia. Il progetto si è<br />
svolto in diverse fasi, con lo sviluppo di appositi algoritmi di<br />
codifica-decodifica dei dati scintigrafici per la portabilità su<br />
piattaforme diverse e con la successiva implementazione di<br />
un sistema per la gestione “on line” del progetto attraverso un<br />
portale dedicato. Abbiamo inoltre implementato una procedura<br />
interna per la verifica periodica della riproducibilità dell’interpretazione<br />
della scintigrafia miocardica perfusoria.<br />
Prospettive future. È in corso di valutazione l’utilizzo della<br />
meta-iodio-benzilguanidina (MIBG) per la valutazione del pattern<br />
di innervazione miocardico in pazienti con disfunzione<br />
ventricolare sinistra e candidati a impianto di ICD.<br />
È in corso di valutazione clinica e sperimentale (su fantoccio)<br />
l’utilizzo di un nuovo algoritmo di ricostruzione della SPECT<br />
miocardica, che consente di ottenere immagini di alta qualità<br />
con una riduzione dei tempi di acquisizione o una riduzione<br />
della attività di radio-farmaco somministrata, con una riduzione<br />
della dosimetria sia per il paziente che per il personale<br />
ed una ottimizzazione del tempo-macchina. I primi risultati<br />
sono stati oggetto di presentazione al Congresso Europeo di<br />
Medicina Nucleare.<br />
Sviluppo di Linee Guida<br />
Siamo stati coinvolti nello sviluppo dei seguenti documenti:<br />
“The role of scintigraphic perfusion imaging in the evaluation<br />
of patients before and after myocardial revascularization”<br />
(documento ANMCO-GICN) (G Ital Cardiol, 25; 1995).<br />
“The viable myocardium” (documento ANMCO-GICN) (G<br />
Ital Cardiol; 25, 1995).<br />
“Radionuclide Angiography: clinical indications” (documento<br />
ANMCO-GICN) (G Ital Cardiol; 25, 1995).<br />
“Myocardial Perfusion Scintigraphy with pharmacological<br />
stress” (documento AMNCO-GICN) (G Ital Cardiol; 25, 1995).<br />
Linee Guida ANMCO-SIC-GICN-AIMN sull’uso appropriato<br />
delle metodiche di medicina nucleare in cardiologia (documento<br />
ANMCO-SIC-AIMN-GICN) (G Ital Cardiol; 29, 1999).<br />
Linee Guida Metodologiche in Cardiologia Nucleare (documento<br />
AIMN).<br />
Linee Guida Metodologiche europee in Cardiologia Nucleare<br />
(documento congiunto EANM-ESC, Eur J Nucl Med,<br />
2005).<br />
Linee Guida Metodologiche europee sulla valutazione della<br />
funzione ventricolare con metodiche di medicina nucleare<br />
(documento congiunto EANM-ESC, in progress, 2008).<br />
Documento “Clinical Value, Cost-Effectiveness and Safety<br />
of Myocardial Perfusion Scintigraphy. A Position Statement”,<br />
Eur Heart J (in press, 2008), documento congiunto<br />
EANM-ESC.<br />
Task Force della ESC sulla gestione del dolore toracico<br />
acuto (Management of Acute Chest Pain) (Eur Heart J<br />
2002; 23: 1153-1176 e Italian Heart J, 2004; 5: 298-323).<br />
Attività Didattica<br />
L’attività didattica ha lo scopo di diffondere la cultura sull’impiego<br />
delle metodiche di cardiologia nucleare nella diagnosi<br />
di cardiopatia ischemica e nella stratificazione del rischio in<br />
popolazioni specifiche. Questa attività viene svolta sia con l’organizzazione<br />
a livello locale di incontri di aggiornamento per<br />
cardiologi e medici di medicina generale, sia con l’organizzazione<br />
e partecipazione a eventi formativi a livello nazionale e<br />
internazionale. Di recente siamo stati coinvolti nello sviluppo<br />
di un progetto per un corso e-Learning di Cardiologia Nucleare<br />
in collaborazione con la European Association of Nuclear<br />
Medicine (accessibile all’indirizzo www.eanm.org).<br />
Pubblicazioni<br />
Marcassa C, Bischof-Delaloye A, Cuocolo A, Hesse B,<br />
Kaufmann P, Knuuti J, Le Guludec D, Sochor H, Underwood<br />
R., Vassiliadis I, Bengel F, Bax J. The regulatory<br />
background of nuclear cardiology in Europe: a survey by<br />
the European Council of Nuclear Cardiology. Eur J Nucl<br />
Med Mol Imaging 2006; 33: 1508-12.<br />
Marcassa C, Campini R, Verna E, Ceriani L, Giannuzzi P.<br />
Assessment of cardiac asynchrony by radionuclide phase<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 65<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
analysis. Correlation with ventricular function in patients<br />
with narrow or prolonged QRS Interval. Eur J Heart Failure<br />
2007; 9: 484-490.<br />
Marzullo P, Marcassa C, Campini R, Eleuteri E, Minocci A,<br />
Sartorio A, Vettor R, Liuzzi A, Grugni G. Conditional cardiovascular<br />
response to GH therapy in adult patients with<br />
Prader-Willi Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:<br />
1364-71.<br />
Marcassa C., Bax JJ, Bengel F, Hesse B, Petersen CL,<br />
Reyes E, Underwood SR. Clinical Value, Cost-Effectiveness<br />
and Safety of Myocardial Perfusion Scintigraphy. A Position<br />
Statement. Eur Heart J (in press, 2008).<br />
Hesse1 B (editor), Lindhardt2 TB (editor), Acampa W,<br />
Anagnostopoulos C, Ballinger J, Bax JJ, Edenbrandt L, Flotats<br />
A, Germano G, Gmeiner Stopar T, Franken P, Kelion A,<br />
Kjaer1 A, LeGuludec D, Ljungberg M, Maenhout AF, Marcassa<br />
C, Marving J, McKiddie F, Schaefer W, Stegger L,<br />
Underwood R. EANM/ESC Guidelines for Radionuclide<br />
Imaging of Cardiac function. Eur J Nucl Med Mol Imaging<br />
(in press 2008).<br />
Zoccarato O, Campini R, Marcassa C, Calza P. Comparison<br />
between filtered back projection SPECT reconstruction<br />
and a new iterative reconstruction algorithm: an antropomorphic<br />
cardiac phantom study. Eur J Nucl Med Mol Imag<br />
2007; suppl 2: S280.<br />
Zoccarato O, Campini R, Marcassa C, Calza P. Comparison<br />
between filtered back projection SPECT reconstruction and<br />
a new iterative reconstruction algorithm: preliminary clinical<br />
evaluation. Eur J Nucl Med Mol Imag 2007; suppl 2: S280.<br />
Zoccarato O, Campini R, Marcassa C, Calza P. Comparison<br />
between filtered back projection SPECT reconstruction<br />
and a new iterative reconstruction algorithm: a phantom<br />
study. Eur J Nucl Med Mol Imag 2007; suppl 2: S237.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Claudio Marcassa<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: claudio.marcassa@fsm.it<br />
Nato a San Remo nel 1958, nel 1983 si Laurea<br />
in Medicina e Chirurgia con Lode, presso la<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università<br />
di Pisa. Nel 1986 consegue la Specializzazione in Malattie<br />
dell’Apparato Cardiovascolare, presso la Facoltà di Medicina e<br />
Chirurgia dell’Università di Pisa, e nel 1989 la Specializzazione<br />
in Medicina Nucleare, sempre presso la Facoltà di Medicina e<br />
Chirurgia dell’Università di Pisa. Nel 1994 partecipa al Corso<br />
di Perfezionamento in Bioetica, presso il Dipartimento di<br />
Scienze e tecnologie biomediche dell’Ospedale San Raffele,<br />
Università di Milano.<br />
Dal 1999 Membro del Cardiovascular Commettee della European<br />
Association of Nuclear Medicine.<br />
Dal 1999 Membro del Working Group for Nuclear Cardiology<br />
and Cardiac CT (WG 5) della European Society of Cardiology.<br />
Biennio 2000-2001: Chairman del Gruppo Italiano di Cardiologia<br />
Nucleare e Membro dell’International Council of Nuclear<br />
Cardiology.<br />
66<br />
Dal gennaio 2000 al giugno 2004 Associate Co-editor dell’Italian<br />
Heart Journal.<br />
Dal gennaio 2004 membro dell’Editorial Board del Journal of<br />
Nuclear Cardiology.<br />
Dal 5/2000 Fellow dell’ANMCO per l’area Culturale, scientifica,<br />
didattica.<br />
Membro della Commissione AIMN (Associazione Italiana di<br />
Medicina Nucleare) per la revisione delle linee guida procedurali<br />
in cardiologia nucleare.<br />
Membro della Commissione della European Association of<br />
Nuclear Medicine per la stesura delle linee guida procedurali<br />
per la cardiologia nucleare.<br />
Dal 2000 al 2004 membro del Comitato G8-Cardio ANMCO<br />
per la parte di cardiologia nucleare.<br />
Dal luglio 2005 membro dell’European Council of Nuclear<br />
Cardiology (organo congiunto della European Society of Cardiology,<br />
Working Group on Nuclear Cardiology and cardiac<br />
CT, e della European Association of Nuclear Medicine, Cardiovascular<br />
Committee).<br />
Dal 2007 membro della Task Force della European Society of<br />
Cardiology per la definizione delle Sottospecialità in Cardiologia.<br />
Dal 1/2008 Membro dell’Editorial Board dell’European Journal<br />
of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.<br />
Attività Formativa e Lavorativa<br />
Dal Dicembre 1979 al Dicembre 1981 allievo interno presso l’Istituto<br />
di Patologia Generale dell’Università di Pisa. Dal Gennaio<br />
1982 al Giugno 1990, ha svolto attività assistenziale di reparto,<br />
ambulatoriale, di diagnostica non invasiva e di ricerca<br />
presso l’Istituto di Fisiologia Clinica, Reparto Coronarico, del<br />
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Direttore Prof.<br />
Luigi Donato). Dal Giugno 1990 dipendente della divisione di<br />
Cardiologia Riabilitativa dell’Istituto Scientifico di Veruno,<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, Pavia, Istituto di Ricovero<br />
e Cura a Carattere Scientifico, dove svolge attività assistenziale,<br />
ambulatoriale, di diagnostica non invasiva, e di ricerca.<br />
Referente per la Qualità della Divisione di Cardiologia Riabilitativa,<br />
Istituto Scientifico di Veruno.<br />
Attività Scientifica<br />
L’attività scientifica è indirizzata alle problematiche relative<br />
alla valutazione funzionale della cardiopatia ischemica cronica<br />
e della disfunzione ventricolare sinistra, in particolare: valutazione<br />
del significato funzionale della coronaropatia e stratificazione<br />
prognostica del paziente con cardiopatia ischemica<br />
cronica, con particolare riguardo alla fisiopatologia della evoluzione<br />
temporale della perfusione e del recupero contrattile<br />
dopo infarto acuto: miocardio stordito e ibernato; effetti sull’ischemia<br />
residua e sul processo di rimodellamento ventricolare;<br />
approccio multiparametrico alla identificazione della vitalità<br />
miocardica residua in pazienti con funzione ventricolare<br />
depressa e follow-up clinico e strumentale; valutazione del<br />
sincronismo di contrazione biventricolare ed effetti della terapia<br />
di resincronizzazione.<br />
Attività Didattica<br />
L’attività didattica è stata dedicata sia all’aggiornamento del<br />
personale interno di Istituto che all’esterno, ed è testimoniata<br />
dalla partecipazione come relatore a numerosi corsi di aggiornamento<br />
e convegni, sia nazionali (acreditati ECM) che in-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
ternazionali (accreditati EACME), in particolare gli eventi CME<br />
all’interno del congresso Europeo di Medicina Nucleare. Coinvolto<br />
nello sviluppo di un programma educazionale<br />
E-learning della European Association of Nuclear Medicine.<br />
Revisore Scientifico delle seguenti riviste: American<br />
Journal of Cardiology, Journal of Nuclear Medicine, European<br />
Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Journal<br />
of Nuclear Cardiology, Journal of Cardiovascular Medicine.<br />
Revisore Scientifico delle seguenti Società: Associazione<br />
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Società Italiana di<br />
Cardiologia, European Association of Nuclear Medicine.<br />
Pubblicazioni<br />
Primo autore o co-autore di >200 lavori scientifici di tipo<br />
“Peer-reviewed” pubblicati su riviste recensite da Science Citation<br />
Index.<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
3. LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA<br />
CARDIOVASCOLARE E CRU<br />
Istituto Scientifico di Lumezzane<br />
Via Mazzini, 129<br />
Tel. 030.8253011<br />
e-mail: roberto.ferrari@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Roberto Ferrari<br />
Il Laboratorio di Fisiopatologia Cardiovascolare è una Unità<br />
Operativa collocata presso il Centro Medico di Gussago della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRCCS dal 1992 diretta dal<br />
Prof. Roberto Ferrari, Professore Ordinario di Cardiologia<br />
presso l’Università di Ferrara. Le aree di cui l’attività del Laboratorio<br />
di Fisiopatologia Cardiovascolare si occupa sono<br />
quelle della ricerca cardiovascolare di base e della ricerca clinico-epidemiologica<br />
dove è comune interesse lo studio di patologie<br />
quali lo scompenso cardiaco e la cardiopatia ischemica.<br />
L’obiettivo principale è l’identificazione e lo studio meccanismi<br />
fisiopatologici, biologici e molecolari coinvolti nello<br />
sviluppo di tali patologie al fine di proporre interventi terapeutici<br />
efficaci nel prevenire e limitare la progressione del<br />
processo patologico.<br />
Negli ultimi anni l’attività di ricerca di base si è integrata con<br />
l’attività di ricerca clinica secondo diversi disegni sperimentali:<br />
1) studio parallelo di una specifica molecola “bradicardizzante”<br />
in ambito di ricerca preclinica e di ricerca di base<br />
(Studio BEAUTIFUL e progetto Scompenso nell’animale da<br />
esperimento); 2) valutazioni ematiche di supporto e di integrazione<br />
alla ricerca clinica (Dosaggi nell’ambito del Sottostudio<br />
BEAUTIFUL, Echo-NT-proBNP); 3) gestione di un sottostudio<br />
multicentrico (Sottostudio BEAUTIFUL, Echo-NT-proBNP).<br />
L’organico del Laboratorio di Fisiopatologia Cardiovascolare è<br />
costituito da personale strutturato di diversa formazione:<br />
1 biologo, 1 farmacologo, 1 amministrativo e 7 tecnici di laboratorio<br />
(tra cui un borsista).<br />
Inoltre all’Unità di Ricerca Clinica (CRU) afferiscono 1 biologo<br />
ed 1 amministrativo presenti a Gussago ed 1 medico dislocato<br />
presso il Centro Trials Clinici con sede a Ferrara. Sono inoltre<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 67<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
presenti altre figure a contratto (1 amministrativo), consulenti<br />
esterni e monitors dislocati in diversi paesi Europei sostenuti<br />
anche da finanziamenti extra <strong>Fondazione</strong>. si occupano dell’attività<br />
sperimentale.<br />
Ricerca di Base e Ricerca Clinica<br />
L’attività di ricerca si è rivolta alla comprensione dei meccanismi<br />
che sottostanno al rimodellamento ventricolare sinistro<br />
e ne regolano la progressione verso lo scompenso cardiaco<br />
nell’animale da esperimento infartuato. In particolare è<br />
stata testata la potenziale efficacia di una molecola bradicardizzante<br />
– quale l’ivabradina – nel ridurre lo sviluppo del rimodellamento<br />
post-infartuale da un punto di vista morfologico,<br />
molecolare ed elettrofisiologico.<br />
In questo contesto è stato concluso il progetto dal titolo “Effetti<br />
del trattamento cronico con ivabradina sulla progressione dello<br />
scompenso cardiaco in ratti sottoposti a legatura coronaria” (in<br />
allegato) che ha visti impegnati 2 tecnici ed 1 laureato.<br />
L’area di ricerca pre-clinica del Laboratorio di Fisiopatologia<br />
Cardiovascolare nell’ambito dello scompenso è finalizzata<br />
alla determinazione plasmatica e/o tessutale dei principali<br />
fattori neurormonali ed infiammatori in pazienti con patologie<br />
cardiovascolari diverse. Quest’area di ricerca supporta:<br />
a) gli studi epidemiologico-clinici, b) le collaborazioni con altri<br />
centri della <strong>Fondazione</strong> Stessa o con l’Università, e c) le richieste<br />
di servizi da parte delle Ditte Farmaceutiche.<br />
L’attività principale in questo ambito è quella di organizzare,<br />
gestire e coordinare il Sottostudio BEAUTIFUL, Echo-NTproBNP:<br />
attività attualmente condivisa da 4 tecnici strutturati<br />
e 1 tecnico borsista. Sino alla prima settimana di novembre il<br />
Sottostudio ha reclutato 590 pazienti ed effettuato 1450 letture<br />
su esami ecocardiografici (da parte del Centro Trials Clinici<br />
con sede a Ferrara) e 1294 valutazioni di BNP (svolte presso il<br />
Centro di Gussago). Nei centri sperimentali coinvolti è in corso<br />
la terza ed ultima visita sui pazienti (la seconda di follow-up).<br />
Su tali visite residue rimangono ancora da effettuarsi le valutazioni<br />
analitiche (BNP) e le letture ecocardiografiche, quindi<br />
da ultimo, ad attività concluse, la spedizione di referti e reperti<br />
ai centri coinvolti nonché la stesura del Report finale. Si ritiene<br />
il progetto possa verosimilmente concludersi non prima del<br />
prossimo giugno 2008.<br />
Progetto (2006)<br />
EFFETTI DEL TRATTAMENTO CRONICO CON IVABRADINA<br />
SULLA PROGRESSIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO IN<br />
RATTI SOTTOPOSTI A LEGATURA CORONARICA<br />
Responsabili: Ferrari R, Agnoletti L., Cargnoni A., Comini L.<br />
Periodo di svolgimento: 2006-2007<br />
Tipo di ricerca: Corrente<br />
Parole chiave: Cardiomiopatia ischemica, ivabradina<br />
Collaborazioni: Di Marcello M. (Clinica Veterinaria, Cellatica, BS);<br />
Ceconi C., Cattedra di Cardiologia, Ferrara; Mugelli A, Centro<br />
di Medicina Molecolare, Università di Firenze<br />
Stato: Concluso<br />
Risultati ottenuti: Il rimodellamento ventricolare conseguente<br />
ad infarto del miocardio è un fenomeno cruciale di adattamento/maladattamento<br />
che produce cambiamenti nella<br />
morfologia, ultrastruttura ed elettrofisiologia del muscolo cardiaco.<br />
Con questo studio abbiamo voluto valutare se un far-<br />
68<br />
maco antiaritmico e non inotropo quale l’ivabradina potesse<br />
essere in grado di modulare – attraverso la riduzione della frequenza<br />
cardiaca – i processi di rimodellamento ultrastrutturali<br />
ed elettrofisiologici.<br />
I risultati sono i seguenti: a tre mesi dal trattamento con ivabradina<br />
gli animali mostravano una frequenza cardiaca significativamente<br />
ridotta rispetto agli animali infartuati non trattati. I volumi<br />
tele-sistolico (LV ESV) e tele-diastolico (LV EDV) aumentavano<br />
significativamente dopo infarto e conseguentemente la<br />
frazione di eiezione (EF) si riduceva. Il trattamento con ivabradina<br />
migliorava significativamente LV EDV ed EF (+15%) rispetto<br />
al gruppo di animali non trattati, così come i livelli plasmatici<br />
di ANP (-37%, vs. infarto non trattato) ed i contenuti tissutali<br />
(ventricolo sinistro) di idrossiprolina (-39%, vs. infarto non<br />
trattato). Si osservava inoltre una influenza positiva del trattamento<br />
sul metabolismo energetico del ventricolo sinistro volta<br />
al mantenimento dei contenuti di fosfati altamente energetici<br />
[creatin-fostato (CP)]. Esperimenti di patch clamp sul miocita<br />
isolato da cuori appartenenti ad animali infartuati in trattamento<br />
con ivabradina mostravano una riduzione della durata del potenziale<br />
d’azione ed un incremento nella densità dei transienti<br />
della corrente del potassio, I to un marcatore elettrofisiologico di<br />
rimodellamento, se comparati a miociti isolati dal gruppo di animali<br />
infartuati. L’analisi del genoma attraverso la tecnica del microarrays<br />
non evidenziava sostanziali differenze nella modulazione<br />
genica in seguito al trattamento con ivabradina.<br />
Lo studio consente di trarre le seguenti conclusioni: l’ivabradina<br />
– farmaco in grado di inibire selettivamente e specificamente<br />
la corrente If – induce un adattamento positivo nel fenotipo<br />
del ventricolo sinistro non influenzando la trascrizione<br />
genica ma migliorando il bilancio energetico,<br />
il rimodellamento elettrofisiologico e strutturale. Questi risultati<br />
rinforzano il potenziale terapeutico dell’ivabradina nel prevenire<br />
la progressione della patologia verso lo scompenso<br />
cardiaco.<br />
I risultati sono stati finalizzati in un report e sono oggetto della<br />
stesura di due manoscritti per la pubblicazione su riviste<br />
scientifiche internazionali.<br />
Pubblicazioni<br />
Bartnik M, Rydén L, Malmberg K, Ohrvik J, Pyörälä K, Standl<br />
E, Ferrari R, Simoons M, Soler-Soler J; Euro Heart Survey Investigators.<br />
Oral glucose tolerance test is needed for appropriate<br />
classification of glucose regulation in patients<br />
with coronary artery disease: a report from the Euro Heart<br />
Survey on Diabetes and the Heart. Heart 2007; 1: 72-77.<br />
Valgimigli M, Bolognese L, Anselmi M, Campo G, Rodriguez<br />
AE, De Cesare N, Cohen DJ, Sheiban I, Colangelo S,<br />
Pasquetto G, et al. Two-by-two factorial comparison of<br />
high-bolus-dose tirofiban followed by standard infusion<br />
versus abciximab and sirolimus-eluting versus bare-metal<br />
stent implantion in patients with acute myocardial infarction.<br />
American Heart Journal 2007; 1: 39-45.<br />
Schinkel AF, Bax JJ, Poldermans D, Elhendy A, Ferrari R,<br />
Rahimtoola SH. Hibernating myocardium: diagnosis and<br />
patient outcomes. Current Problems in Cardiology 2007; 7:<br />
375-410.<br />
Notarstefano P, Pratola C, Toselli T, Baldo E, Ferrari R. Sedation<br />
with midazolam for electrical cardioversion. Pacing<br />
and Clinical Electrophysiology: PACE 2007; 5: 608-611.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Agnoletti L, Curello S, Malacarne F, Airò P, Cargnoni A,<br />
Valgimigli M, Ferrari R. Immune Activation in severe heart<br />
failure. Does etiology play a role. European Heart Journal<br />
2007; supplement F: F22-F29.<br />
Agnoletti G, Cargnoni A, Agnoletti L, Di Marcello M, Balzarini<br />
P, Gitti L, Martina Ps, Grigolato PG, Ferrari R. Percutaneous<br />
coronary injection of bone marrow cells in small<br />
experimental animals: small is not too small. Pathology -<br />
Research and Practice 2007; 11: 801-808.<br />
Comini L, Bachetti T, Cargnoni A, Bastianon D, Gitti GL,<br />
Ceconi C, Ferrari R. Therapeutic modulation of the nitric<br />
oxide: all ace inhibitors are not equivalent. Pharmacological<br />
Research 2007; 1: 42-48.<br />
Valgimigli M, Campo G, Arcozzi C, Malagutti P, Carletti R,<br />
Ferrari F, Barbieri D, Parrinello G, Percoco G, Ferrari R. Two<br />
year clinical follow-up after sirolimus eluting versus bare<br />
metal stent implantation assisted by systematic glycoprotein<br />
IIb/IIa inhibitor infusion in patients with myocardial infarction.<br />
Journal of the American College of Cardiology<br />
2007; 50: 138-145.<br />
Gaston A, Rodriguez-Granillo, Jeroen Vos, Bruining N,<br />
Garcia-Garcia H, De Winter S, Lightart J, Deckers J, Bertrand<br />
M, Simoons M, et al. Long-term effect of perindopril<br />
on coronary atherosclerosis progression (from the perindopril’s<br />
prospective effect on coronary atherosclerosis by<br />
angiography and intravascular ultrasound evaluation.<br />
American Journal of Cardiology 2007; 159-163.<br />
Gemmati D, Federici F, Campo G, Tognazzo S, Serino ML,<br />
De Mattei M, Valgimigli M, Malagutti P, Guardigli G, Ferraresi<br />
P, et al. Factor xiiia-v341 and factor xiiib-h95r gene<br />
variants: effects on survival in myocardial infarction patients.<br />
Molecular Medicine 2007; 1-2: 112-120.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Roberto Ferrari, MD, Ph.D. FACC, FESC.<br />
Professore di Cardiologia.<br />
Nato il 10 Giugno del 1950. Coniugato, una figlia.<br />
Titoli professionali<br />
Professore Ordinario di Cardiologia, Università<br />
di Ferrara.<br />
Direttore del Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
“<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>”, dell’omonima<br />
<strong>Fondazione</strong> Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Gussago,<br />
Brescia.<br />
PhD sul metabolismo cardiaco, Università di Londra.<br />
Indirizzo di Corrispondenza<br />
Cattedra di Cardiologia, Università di Ferrara<br />
Corso Giovecca 203 - 44100 Ferrara, Italy<br />
Tel. 0532.202 143 - Fax 0532/241 885 - E-mail: fri@dns.unife.it<br />
Qualifiche<br />
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode, Università di Bologna:<br />
1969-1974.<br />
Specializzato in Cardiologia, Università di Parma: 1974-<br />
1976.<br />
Specializzato in Radiologia, Università di Bologna: 1977-1980.<br />
PhD all’Università di Londra: 1982.<br />
Aree di interesse specifico e specializzazioni<br />
Caratterizzazione dei meccanismi molecolari del miocardio<br />
ischemico e scompensato.<br />
Trattamento clinico dell’ischemia miocardica e dello scompenso<br />
cardiaco.<br />
Interesse particolare negli studi interdisciplinari e collaborativi,<br />
così come nell’insegnamento, come parte integrante delle<br />
varie attività di ricerca.<br />
Cariche in Società Scientifiche Cardiologiche<br />
Società Europea di Cardiologia<br />
Vice Presidente e Chairman dell’Association e Working<br />
Group, 2004-.<br />
Chairman dell’Education Committee, 2002-2004.<br />
Chairman dell’Working Group on Cellular Biology 1994-1996.<br />
International Society for Heart Research<br />
Presidente della “World Section dell’International Society for<br />
Heart Research”, 2004-2007.<br />
Tesoriere, 1994-2002.<br />
Società Italiana di Cardiologia<br />
Consigliere, 1996-2000.<br />
Membro del Comitato Scientifico, 1996-2002.<br />
Federazione Italiana di Cardiologia (FIC)<br />
Membro del Consiglio, 1996-1999.<br />
Editorial Boards<br />
Editore di:<br />
European Heart Journal Supplement, 1996-2004.<br />
Dialogues in Cardiovascular Medicine, 1996-.<br />
Pubblicazioni<br />
Oltre 700 lavori (I.F. più di 2000) su vari aspetti che includono<br />
ricerca di base, fisiopatologia e sperimentazione clinica<br />
nell’area della cardiopatia ischemica e dello scompenso<br />
cardiaco.<br />
Comitato Direttivo<br />
Coinvolto nel Comitato Direttivo di diversi trial multicentrici<br />
quali: EUROPA, PREAMI, SENIORS, S18886, PACMAN,<br />
BEAUTiFUL and STRATEGY.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 69<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
4. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
INTEGRATO DEL SISTEMA NERVOSO<br />
AUTONOMO E DELL’ATTIVITÀ<br />
CARDIORESPIRATORIA<br />
Istituto Scientifico di Montescano<br />
Via per Montescano<br />
Tel. 0385.247.330<br />
e-mail: mariateresa.la rovere@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Maria Teresa La Rovere<br />
La missione del Laboratorio è quella di sviluppare le conoscenze<br />
cliniche in merito al ruolo fisiopatologico e prognostico<br />
dell’attività del sistema autonomo e delle sue alterazioni,<br />
nonché delle relazioni fra sistema nervoso autonomo e differenti<br />
pattern respiratori, nell’ambito della patologie cardiovascolari,<br />
con particolare riferimento alla cardiopatia ischemica<br />
e dello scompenso cardiaco.<br />
L’attività del Laboratorio si fonda sulla registrazione ed analisi<br />
dei segnali cardiorespiratori. I segnali cardiorespiratori vengono<br />
registrati sia nel corso di specifiche condizioni controllate<br />
che nel corso delle 24 ore e vengono analizzati sulla base<br />
di algoritmi noti o in via di sperimentazione e quindi correlati<br />
con i dati clinici di data-base appartenenti alla struttura. Il Laboratorio<br />
si avvale pertanto della stretta collaborazione con il<br />
Servizio di Bioingegneria per lo sviluppo di sistemi di acquisizione,<br />
registrazione ed analisi dei suddetti segnali e con il Laboratorio<br />
di Polisonnografia per l’integrazione dei segnali cardiorespiratori<br />
con i segnali elettroencefalografici.<br />
Il Laboratorio svolge anche attività di analisi di segnali registrati<br />
nel contesto di studi multicentrici, sia nazionali che internazionali,<br />
sia per quanto riguarda aspetti di ordine prognostico<br />
che di ordine fisiopatologico (ad es effetto dei farmaci o<br />
dell’attività fisica sull’attività del sistema nervoso autonomo).<br />
Nell’ambito della attività di ricerca il Laboratorio collabora con<br />
Istituzioni internazionali (II Department of Cardiology, Medical<br />
University of Gdansk, Polonia; University of California San<br />
Francisco, USA; John Radcliffe Hospital, Oxford, UK;<br />
Department of Internal Medicine, University of Stellenbosch,<br />
70<br />
South Africa) e nazionali (Centro Studi ANMCCO; Istituto di<br />
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”; Cattedra di Cardiologia,<br />
Università di Pavia; Istituto di Fisiologia Clinica, CNR,<br />
Pisa; Department of Clinical Medicine, Prevention and Applied<br />
Biotechnologies, University of Milano-Bicocca).<br />
Attività di Ricerca<br />
Le attività di ricerca del Laboratorio si sviluppano nei seguenti<br />
ambiti:<br />
Studio della fisiopatologia delle alterazioni dell’equilibrio<br />
neurovegetativo in merito alle patologie di interesse cardiologico.<br />
Valutazione del significato prognostico dei parametri relativi<br />
al bilancio neurovegetativo.<br />
Studio delle interazioni cardiorespiratorie in pazienti soggetti<br />
ad anormalità del pattern respiratorio (scompenso<br />
cardiaco, sindrome delle apnee ostruttive).<br />
Valutazione dell’efficacia di misure terapeutiche sia di ordine<br />
farmacologico che riabilitativo (es training fisico).<br />
Validazione di metodologie di analisi.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio del potere prognostico e correlati clinici dell’analisi<br />
della sensibilità barocettiva in pazienti con scompenso<br />
cardiaco cronico in epoca beta-bloccante.<br />
Disturbi del pattern respiratorio nel paziente con scompenso<br />
cardiaco cronico: correlazioni fra stato di veglia e riposo<br />
notturno.<br />
Effetto degli n-3 PUFA su alternanza dell’onda T ed indici<br />
non invasivi di rischio aritmico in pazienti con infarto miocardio<br />
acuto e disfunzione ventricolare sinistra.<br />
UNEXPECTED (AUtonomic ToNE and RefleXes in Unex-<br />
PEcted Cardiac EvenTs PrEDiction).<br />
GISSI-HF arrhythmic and autonomic pattern substudy protocol.<br />
Riproducibilità delle alterazioni del pattern respiratorio ottenute<br />
in registrazioni di breve durata nelle ore diurne in<br />
pazienti con scompenso cardiaco cronico.<br />
Pubblicazioni<br />
La Rovere MT, Pinna GD, Raczak G. Baroreflex sensitivity:<br />
measurement and clinical implications. Ann Noninvasive<br />
Electrocardiol. 2008; 13 (2): 191-207.<br />
Schwartz PJ. Vanoli E, Crotti L, Spazzolini C, Ferrandi C,<br />
Goosen A, Hedley P, Heradien M, Bacchini S, Turco A, La<br />
Rovere MT, Batoli A, Gorge AL, Brink PA. Neural control of<br />
heart rate is an arrhythmia risk modifier in long QT syndrome.<br />
J Am Coll Cardiol. 2008; 51 (3): 920-929.<br />
Hoyer D, Maestri R, La Rovere MT, Pinna GD. Autonomic<br />
response to cardiac dysfunction in chronic heart failure -<br />
a risk predictor based on autonomic information flow. Pacing<br />
Clin Electrophysiol. 2008; 31 (2): 214-220.<br />
Olmetti F, La Rovere MT, Robbi E, Taurino AE, Fanfulla F.<br />
Nocturnal cardiac arrhythmias in patients with obstructive<br />
sleep apnea. Sleep Med. 2007; Nov 15; [Epub ahead of print].<br />
La Rovere MT, Pinna GD, Maestri R, Robbi E, Mortara A,<br />
Fanfulla F, Febo O, Sleight P. Clinical relevance of shortterm<br />
day-time breathing disorders in chronic heart failure<br />
patients. Eur J Heart Fail. 2007; 9 (9): 949-954.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Pinna GD, Maestri R, Torunski A, Danilowicz-Szymanowicz<br />
L, Szwoch M, La Rovere MT, Raczak G. Heart Rate<br />
Variability measures: a fresh look at reliability. Clin Sci.<br />
(Lond). 2007; 113 (3): 131-140.<br />
Casaleggio A, Maestri R, La Rovere MT, Rossi P, Pinna GD.<br />
Prediction of sudden death in heart failure patients: a<br />
novel perspective from the assessment of the peak ectopy<br />
rate. Europace. 2007; 9 (6): 385-390.<br />
Pinna GD, Maestri R, La Rovere MT, Gobbi E, Fanfulla F.<br />
Effect of paced breathing on ventilatory and cardiovascular<br />
variability parameters during short-term investigations<br />
of autonomic function. Am J Physiol Heart Circ Physiol.<br />
2006; 290 (1): H424-433.<br />
Sarzi-Braga S, La Rovere MT, Pedretti RF. Baroreflex sensitivity<br />
normalization after resynchronization therapy. Int J<br />
Cardiol. 2006; 109 (1): 118-20.<br />
Maestri R, Pinna GD, Balocchi R, D’Addio G, Ferrario M,<br />
Porta A, Sassi R, Signorini MG, La Rovere MT. Clinical correlates<br />
of non-linear indices of heart rate variability in chronic<br />
heart failure patients. Biomed Tech (Berl). 2006; 51<br />
(4): 220-3.<br />
Altre Attività del Laboratorio<br />
Attività Didattica<br />
Il Laboratorio per lo Studio del Sistema Nervoso Autonomo ha<br />
svolto attività di divulgazione delle conoscenze e delle metodiche<br />
sviluppate sia verso gli specializzandi della Scuola di<br />
Cardiologia dell’Università di Pavia che ospitando medici di<br />
altre strutture nazionali e internazionali.<br />
Attività Clinica<br />
Il Laboratorio fornisce prestazioni diagnostiche sia per pazienti<br />
ospedalizzati, che per pazienti ambulatoriali. In particolare,<br />
vengono effettuati consulenze, analisi della variabilità<br />
della frequenza cardiaca e pressione arteriosa sia in condizioni<br />
basali che dopo tilting, nell’ambito della diagnostica delle<br />
neuropatie periferiche e della sincope.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
La Dr.ssa Maria Teresa La Rovere ha conseguito<br />
la Laurea in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università degli Studi di Milano ed<br />
ha successivamente ottenuto Diplomi di Specializzazione<br />
in Cardiologia ed in Fisiopatologia<br />
Respiratoria. Ha conseguito inoltre titoli<br />
di studio presso Istituzioni straniere: nel 1987<br />
è stata Visiting Physician presso il Cardiac<br />
Department del John Radcliffe Hospital di<br />
Oxford (UK), nel 1989 è stata Visiting Research Scientist alla<br />
Columbia University di New York, e nel 1998 ancora Visiting<br />
Physician presso il Laboratorio di Elettrofisiologia del St<br />
George Hospital di Hamburg (GE).<br />
Nel 1981 è entrata a far parte della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>. Attualmente, accanto all’attività clinica si occupa<br />
del coordinamento dei Servizi Ambulatoriali e dell’attività del<br />
Laboratorio di Emodinamica. Dal Novembre 2006 ricopre il<br />
ruolo di Direttore Scientifico dell’Istituto Scientifico di Montescano.<br />
Dal 1989 è Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia dell’Università degli Studi di Pavia ed<br />
è titolare dei corsi di insegnamento ”Sistema nervoso autonomo<br />
e stratificazione prognostica del post-infarto” e “Elettrocardiografia<br />
dinamica”.<br />
Dal 1993, è Fellow della European Society of Cardiology e<br />
membro del Working Group on Arrhythmias della European<br />
Society of Cardiology e della European Heart Rhythm Association.<br />
Dal 1999, è membro del Working Group on Heart Rate<br />
and Blood Pressure Variability of the European Society of Hypertension,<br />
e dal 2007 partecipa al board della International<br />
Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.<br />
È inoltre membro dell’Editorial Board e Revisore di numerose<br />
riviste internazionali di cardiologia, tra cui Circulation, JAMA,<br />
Journal of the American College of Cardiology, Clinical<br />
Science, Journal of Cardiovascular Electrophysiology etc.<br />
L’attività editoriale comprende oltre 50 capitoli di libro e oltre<br />
120 articoli originali.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 71<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
inea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
5. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DEL RIMODELLAMENTO VENTRICOLARE<br />
E DELLA EMODINAMICA NON-INVASIVA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: pierluigi.temporelli@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Pier Luigi Temporelli<br />
Il Laboratorio per lo Studio del Rimodellamento Ventricolare e<br />
della Emodinamica Non-invasiva, unità funzionale della Divisione<br />
di Cardiologia Riabilitativa, svolge attività clinica e di ricerca<br />
prevalentemente nell’ambito del paziente con cardiopatia<br />
ischemica, rivascolarizzato o meno, e scompenso cardiaco.<br />
In tale contesto, il Laboratorio rappresenta un Centro di<br />
riferimento nazionale ed è scientificamente riconosciuto a livello<br />
internazionale per lo studio del rimodellamento ventricolare<br />
sinistro e per la valutazione totalmente non-invasiva del<br />
profilo emodinamico.<br />
Aree di Attività dell’Unità Operativa<br />
Diagnostica avanzata mediante imaging ecografico.<br />
Studio della funzione cardiaca e del rimodellamento ventricolare.<br />
Monitoraggio emodinamico non-invasivo.<br />
Vitalità ed ischemia residua.<br />
Asincronia di contrazione.<br />
Riserva coronarica e microcircolo.<br />
Funzione endoteliale.<br />
Valutazione di interventi farmacologici e non-farmacologici.<br />
Attività Clinica<br />
Vengono valutati circa 3300 pazienti/anno, sia degenti che<br />
come esterni provenienti dal territorio. A prescindere dalla patologia<br />
di base in ogni paziente l’imaging con ultrasuoni fornisce<br />
irrinunciabili informazioni circa le dimensioni delle cavità<br />
cardiache, gli spessori parietali, la funzione sistolica glo-<br />
72<br />
bale e segmentaria del ventricolo sinistro, la funzione diastolica,<br />
la funzione globale del ventricolo destro, la morfologia e<br />
la funzionalità degli apparati valvolari, lo stato del pericardio,<br />
la presenza di formazioni trombotiche intracavitarie. Tali informazioni<br />
sono di particolare utilità nella gestione clinica dei pazienti,<br />
in particolare per le ulteriori scelte decisionali diagnostico-terapeutiche.<br />
Di fatto, in casi selezionati, l’approfondimento<br />
con ecocardiografia da stress o con la metodica transesofagea<br />
permette di meglio stratificare i pazienti o di dirimere<br />
quesiti diagnostici.<br />
Obbiettivi raggiunti<br />
In considerazione della tipologia di pazienti che afferiscono<br />
alla Struttura di Cardiologia Riabilitativa, l’attività di ricerca si<br />
è sviluppata con caratteristiche di eccellenza sul tema del rimodellamento<br />
ventricolare sinistro nell’ambito della cardiopatia<br />
ischemica e della valutazione emodinamica non-invasiva<br />
nello scompenso cardiaco.<br />
Il processo di rimodellamento ventricolare è alla base della<br />
natura progressiva dell’insufficienza cardiaca. All’origine del<br />
fenomeno vi è un’estrema varietà di stimoli fisiopatologici, su<br />
tutti l’infarto miocardico, accomunati dalla capacità di agire<br />
negativamente sulle dimensioni e sulla funzione contrattile<br />
miocardica globale, con sfavorevoli conseguenze emodinamiche<br />
che possono manifestarsi più tardivamente con segni e<br />
sintomi di scompenso cardiaco. L’ecocardiografia ha acquisito<br />
un ruolo di primo piano nel monitoraggio del processo, fornendo<br />
dati affidabili e ripetibili in termini di dimensioni e funzione<br />
ventricolare ma anche di rigurgito valvolare mitralico e<br />
stima non invasiva delle pressioni del piccolo circolo, parametri<br />
correlati e condizionati dal processo di rimodellamento.<br />
Abbiamo documentato, grazie ad uno studio multicentrico nazionale,<br />
la natura eterogenea del processo in termini temporali<br />
(rimodellamento precoce e tardivo) e quantitativi. Abbiamo<br />
evidenziato le correlazioni tra rimodellamento e parametri<br />
elettrocardiografici da un lato, ed indici di funzione diastolica<br />
dall’altro. Inoltre, il Laboratorio ha coordinato studi<br />
multicentrici nazionali attraverso i quali è stato chiaramente<br />
dimostrato l’effetto protettivo del training fisico sul rimodellamento<br />
sia nel post-infarto che nel paziente con scompenso<br />
cardiaco cronico.<br />
La conoscenza dei parametri emodinamici, su tutti le pressioni<br />
di riempimento ventricolare sinistro, riveste un ruolo cruciale<br />
nella gestione del paziente con scompenso cardiaco. Attraverso<br />
studi per certi aspetti pionieristici (avviati durante una<br />
esperienza americana presso l’Università La Jolla di San<br />
Diego) basati sulla valutazione contemporanea ecocardiografica<br />
ed emodinamica in pazienti con disfunzione ventricolare<br />
sinistra e scompenso cardiaco, il Laboratorio ha contribuito in<br />
modo significativo ad arricchire le evidenze a favore della possibilità<br />
di valutare non-invasivamente mediante ecocardiografia<br />
Doppler il profilo emodinamico. In tale ambito, il Laboratorio<br />
viene riconosciuto come riferimento nazionale, ed alcune<br />
pubblicazioni prodotte vengono frequentemente citate<br />
come “pietre miliari” nella letteratura scientifica.<br />
Attività di Ricerca<br />
Il Laboratorio per lo Studio del Rimodellamento Ventricolare e<br />
della Emodinamica Non-invasiva della Divisione di Cardiologia<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> di Veruno studia si-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
stematicamente l’evoluzione del rimodellamento ventricolare<br />
in pazienti cardiopatici ischemici con disfunzione ventricolare<br />
sinistra (frazione d’eiezione
INTRODUZIONE<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Pier Luigi Temporelli, nato a Veruno nel<br />
1957, si è laureato in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università di Torino nel 1984, specializzandosi<br />
in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare<br />
presso la 2a Università di Napoli nel<br />
1989. Dal 1989 lavora a Veruno presso la Divisione<br />
di Cardiologia Riabilitativa della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> come dirigente 1° livello.<br />
Attività svolte: Attività clinica di reparto con particolare<br />
orientamento al “disease management” e alle strategie di prevenzione<br />
secondaria; attività presso il Laboratorio di ergospirometria.<br />
Da circa 20 anni si occupa prevalentemente di imaging<br />
cardiovascolare, dedicando ampio spazio allo studio<br />
non-invasivo dei parametri emodinamici nel paziente con disfunzione<br />
ventricolare sinistra e scompenso cardiaco, ed al<br />
monitoraggio del rimodellamento ventricolare nel paziente<br />
cardiopatico ischemico, argomenti per i quali sono stati raggiunti<br />
autorevoli riconoscimenti scientifici internazionali (vedi<br />
lista pubblicazioni). Per le specifiche competenze fisiopatologiche<br />
sul rimodellamento ventricolare e sulla funzione diastolica<br />
è stato coinvolto nello steering committee di studi multicentrici<br />
nazionali e internazionali (GISSI-3 Echo; BRING-UP 2,<br />
EAMI, ELVD, MeRGE).<br />
Socio ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi<br />
Ospedalieri), GICR (Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa<br />
e Preventiva) ed European Working Group of Exercise Physiology<br />
and Cardiac Rehabilitation (WG1). Past Deputy Editor<br />
dell’Italian Heart Journal; attualmente membro dello Scientific<br />
Board. Past Tesoriere del GICR. Membro dello Scientific Board<br />
del Monaldi Archives. Reviewer per: Journal of the American<br />
College of Cardiology; Circulation; European Journal of Cardiovascular<br />
Prevention and Rehabilitation, Journal of Cardiovascular<br />
Medicine e Italian Heart Journal. Membro del CdA di<br />
Heart Care Foundation, <strong>Fondazione</strong> ONLUS dell’ANMCO.<br />
74<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
6. SERVIZIO AUTONOMO DI TELEMEDICINA<br />
Istituto Scientifico di Lumezzane<br />
Via Mazzini, 129 - piano 3<br />
Tel. 030.8253161-152<br />
e-mail: simonetta.scalvini@fsm.it<br />
Responsabile: Dr.ssa Simonetta Scalvini<br />
Il Servizio Autonomo di Telemedicina, attraverso le nuove applicazioni<br />
in sanità dell’Information and Communication Technology,<br />
svolge attività di clinica e ricerca in ambito multispecialistico<br />
con particolare riguardo agli aspetti epidemiologici,<br />
sperimentali e organizzativi di nuovi modelli di “disease management”<br />
del territorio.<br />
L’attività ha preso l’avvio nel 1998 sulla scorta dell’esigenza di<br />
monitorare i parametri fisiologici dei pazienti domiciliari in attesa<br />
di trapianto cardiaco provenienti da ogni parte d’Italia.<br />
Sviluppatosi dapprima esclusivamente all’interno della Divisione<br />
di Cardiologia e dell’istituto di Gussago, è ora presente<br />
presso gli altri Istituti della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, inglobando<br />
altre specialità quali la Pneumologia, Neurologia e Psicologia.<br />
Successivamente, utilizzando le esperienze nate e sviluppatesi<br />
in <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, attraverso le nuove tecnologie dell’ICT<br />
e la messa a punto di innovativi modelli clinico-organizzativi di<br />
disease management sul territorio è stato realizzato un<br />
network di utenti, professionali e non (strutture ospedaliere ed<br />
universitarie, medici di medicina generale, pazienti), che accedono<br />
ai servizi multispecialistici di teleconsulto e teleassistenza<br />
“on line”.<br />
Il Servizio di Telemedicina in collaborazione con la Società<br />
Health Telematic Network di Brescia (HTN) contribuisce allo<br />
sviluppo, implementazione e sperimentazione di sistemi di telemedicina<br />
in ambito nazionale ed europeo. Il Servizio si avvale<br />
delle competenze scientifico-organizzative della <strong>Fondazione</strong> e<br />
del supporto tecnologico-operativo della centrale operativa di<br />
ascolto del Centro Servizi di Telemedicina di HTN specificamente<br />
strutturato per erogare prestazioni di telemedicina a favore<br />
di strutture sanitarie, medici di medicina generale, specialisti<br />
e i loro pazienti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Aree di Attività<br />
Centro Servizi di Telemedicina<br />
Il Centro Servizi è una centrale operativa, un hub di smistamento-chiamate<br />
e monitoraggio-utenti; è nel contempo un<br />
call-center (servizi principalmente in voce) e un contact center<br />
(web-services, fax, e-mail, video). Con un’avanzata piattaforma<br />
tecnologica web-based dedicata (hardware+software) è attivo<br />
nei servizi di risposta all’utente 24/24 ore per l’intero anno attraverso<br />
un team di risorse umane “formate ed esperte”, in<br />
grado di offrire diverse tipologie di servizi sanitari a seconda<br />
dei bisogni. È assimilabile ad un ASP, Application Service Provider<br />
che, in modalità-outsourcing, gestisce in tempo reale le<br />
esigenze (in voce, dati, immagini) di un network di utenti (pazienti,<br />
medici di medicina generale, specialisti, ospedali pubblici,<br />
università). Il Centro Servizi offre all’utenza teleconsulti/videoconsulti<br />
multispecialistici, second opinion, telenursing<br />
e triage infermieristico, refertazione di prestazioni strumentali<br />
(online, store and forward) tenendone traccia in un<br />
database protetto e sicuro.<br />
Il sistema di risposta è flessibile ed ottimizza “on line” i tempi<br />
di interfaccia con l’utenza mediante il ricorso al “telelavoro”<br />
che consente di remotizzare la parte professionale specialistica<br />
e di triage infermieristico.<br />
Servizi in “outsourcing” per strutture<br />
ospedaliere/universitarie<br />
Vengono allestite presso Strutture ospedaliere e/o universitarie<br />
postazioni di telemedicina per “dimissioni protette” di pazienti<br />
degenti. La postazione remota presso una Divisione<br />
ospedaliera è funzionalmente collegata in banda larga con il<br />
Centro Servizi e specificamente configurata per condividere<br />
gli applicativi di centrale mediante licenze di terminal server<br />
“on site/on line”. L’effettuazione di prestazioni di telemedicina<br />
da parte della Divisione ospedaliera verso i propri utenti è solo<br />
tecnologicamente mediata dal Centro Servizi in quanto l’attività<br />
sanitaria medico-infermieristica viene gestita direttamente<br />
dal proprio personale dipendente mentre il Servizio di<br />
Telemedicina fornisce, attraverso la propria piattaforma informatica,<br />
il supporto tecnologico ed organizzativo per l’erogazione<br />
delle prestazioni (con l’eventuale servizio di back-up<br />
professionale). Tutte le cartelle cliniche dei pazienti, generate<br />
dal terminale allocato presso la Divisione ospedaliera sono<br />
gestibili “a video” on site per ricerca ed elaborazioni statistiche.<br />
Pragmatica è l’ipotesi che le attuali amministrazioni<br />
ospedaliere possano giovarsi dei risparmi gestionali generati<br />
dal ricorso ad attività di outsourcing, in tempo reale, delle risorse<br />
tecnologico-organizzative di Centri Servizi sanitari d’eccellenza.<br />
La dimissione protetta per pazienti con patologie<br />
croniche: Teleassistenza e Telemonitoraggio<br />
I pazienti con patologie croniche invalidanti o che hanno avuto<br />
problematiche particolari durante la degenza ospedaliera, vengono<br />
dimessi in modo “protetto” in quanto affidati ad un Infermiere<br />
Tutor. In pratica, alla dimissione, viene loro fornito un dispositivo<br />
per la registrazione di segnali biologici di pratico e facile<br />
utilizzo ed a trasmissione transtelefonica. L’Infermiere<br />
Tutor attraverso un calendario di appuntamenti predefiniti (telemonitoraggio)<br />
e con l’interfaccia del call center, tiene i contatti<br />
con loro attraverso la ricezione dei segnali biologici regi-<br />
strati e la comunicazione verbale (sono disponibili il triage ed<br />
il teleconsulto per le informazioni del caso, sia programmati<br />
che occasionali). I pazienti in qualunque momento, 24/24 ore<br />
365 giorni all’anno, in presenza di sintomi, possono chiamare il<br />
centro servizi (teleassistenza) e parlare con il personale infermieristico;<br />
il Medico di Medicina Generale e lo Specialista del<br />
Centro Ospedaliero di riferimento vengono informati ed aggiornati<br />
dal personale infermieristico sull’andamento del paziente,<br />
potendo intervenire in qualsiasi momento per aggiustamenti<br />
diagnostico-terapeutici. Attualmente sono attivi:<br />
Servizi per la Cardiologia: Telesorveglianza domiciliare<br />
per lo scompenso cardiaco medio-grave; Ospedalizzazione<br />
domiciliare post cardiochirurgia; diagnostica per il<br />
cardiopalmo accessionale; dimissione protetta post ricovero<br />
riabilitativo.<br />
Servizi per la Pneumologia: Telesorveglianza domiciliare<br />
per il paziente pneumopatico; telesorveglianza domiciliare<br />
per pazienti ventilati domiciliarmene.<br />
Servizi per la Neurologia: Telesorveglianza domiciliare<br />
per il paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica.<br />
Servizio di Telepsicologia<br />
Il servizio di telepsicologia, nell’ambito della telemedicina, ha<br />
lo scopo di offrire continuità dell’intervento psicologico iniziato<br />
durante la degenza nel nostro Istituto per contenere il disagio<br />
emozionale e le problematiche legate alla accettazionegestione<br />
della malattia.<br />
Inoltre, risponde alla necessità di consulenza quando al domicilio<br />
sorgessero nuovi bisogni determinati alla progressione<br />
della malattia, che implicano un difficile adattamento individuale<br />
e familiare. Usufruiscono della telepsicologia i pazienti<br />
affetti da patologia cardiologica, pneumologica e neurologica<br />
e i familiari che manifestano segni di disagio psicologico.<br />
Second opinion multispecialistica per il Medico<br />
di Medicina Generale<br />
I Medici di Medicina Generale (MMG) sono dotati di apparati<br />
(es. ecg, saturimetri, spirometri etc.) in grado di registrare un<br />
segnale biologico ed inviarlo per via transtelefonica, con telefono<br />
fisso o cellulare, al Centro Servizi dove, in tempo reale,<br />
uno specialista provvede al teleconsulto, all’interpretazione<br />
del tracciato, all’attivazione di una consulenza interattiva diagnostica<br />
e all’orientamento verso i successivi provvedimenti<br />
terapeutici.<br />
L’efficace teleconsulto che, mediato dall’invio del segnale biologico,<br />
si attiva tra i due professionisti, lo specialista “esperto”<br />
ed il MMG che conosce in modo approfondito il proprio paziente,<br />
orienta e facilita in modo corretto il decision making di<br />
entrambi. L’ottimizzazione di questo rapporto professionale<br />
consente alla telemedicina di aspirare ad un’effettiva riduzione<br />
degli accessi impropri alle strutture sanitarie, alla razionalizzazione<br />
delle richieste di diagnostica strumentale ed alla<br />
deospedalizzazione di molte prestazioni terapeutiche. Attualmente<br />
sono attivi i servizi di second opinion cardiologica,<br />
pneumologica, diabetologica, reumatologica e dermatologica.<br />
Servizio di Telediagnosi<br />
Il cardiopalmo (inteso come palpitazione o sensazione di battito<br />
mancato) è un sintomo comune a molti pazienti e può essere<br />
di difficile documentazione ma soprattutto rende necessario<br />
l’approfondimento diagnostico con indagini strumentali<br />
non invasive tipo l’ecg dinamico secondo Holter. La telecar-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 75<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
diologia permette oggi di registrare e trasmettere in tempo<br />
reale una traccia elettrocardiografica del fenomeno clinico avvertito<br />
dal paziente mediante dispositivi (Event e Loop Recorder)<br />
che vengono affidati al paziente per quando occasionalmente<br />
si verifica il sintomo. Premendo un pulsante si registrano<br />
trenta secondi di ritmo cardiaco che viene memorizzato<br />
nel dispositivo. Questa registrazione della traccia elettrocardiografica<br />
viene poi inviata, per via transtelefonica, alla centrale<br />
operativa d’ascolto presidiata 24 ore/24 da operatori di<br />
call center, infermieri professionali e cardiologi risponditori. La<br />
metodica è risultata essere in grado di documentare in modo<br />
definitivo il sintomo cardiopalmo nel doppio dei casi rispetto<br />
all’Holter, evidenziando od escludendo la sottostante aritmia<br />
cardiaca.<br />
Attività Educazionale<br />
Esiste dall’anno 2000 una realtà didattico/formativa rivolta ai<br />
medici di medicina generale, agli specialisti ed agli infermieri<br />
e finalizzata a trasmettere le conoscenze tecnico-organizzative<br />
dei nuovi modelli di disease management del territorio attraverso<br />
la telemedicina. Tale attività si inserisce nel contesto<br />
dell’educazione continua in medicina ed ha conseguito l’accreditamento<br />
da parte del Ministero della Sanità.<br />
Ricerche in corso<br />
TELEMACO - TELEMedicina Ai piccoli Comuni lombardi.<br />
Fattibilità ed efficacia di programmi di prevenzione cardiovascolare<br />
mediante sistemi di telemedicina avanzati.<br />
Integrazione dei servizi sanitari del territorio “ISOLA” TO.<br />
Continuità assistenziale. Arcipelago Salute.<br />
WASP - Wirelessly Accesible Sensor populations.<br />
Gestione domiciliare dell’ingombro bronchiale nel paziente SLA.<br />
Ricerche in programmazione<br />
Isole 3 “Assistenza ed ospedalizzazione a domicilio in territori<br />
isolati”.<br />
Sperimentazione di un modello di telesorveglianza domiciliare<br />
nel paziente post-ictus.<br />
Modelli di riabilitazione intensive cardiorespiratoria di alta<br />
specializzazione: implementazione ed indicatori di risultato.<br />
Continuità di cura nel cardiopatico: una rete tra unità ospedaliera,<br />
specialisti e territorio.<br />
Studio di fattibilità, sicurezza ed efficacia di un programma<br />
di riabilitazione, basato su un sistema di telemonitoraggio<br />
ospedale-territorio nei pazienti anziani.<br />
Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio<br />
di pazienti con patologie.<br />
Pubblicazioni<br />
A Giordano, S Scalvini, E Zanelli, U Corrà, GL §ongobardi,<br />
VA Ricci, P Baiardi, F Glisenti. Multicenter randomised trial<br />
on home based telemanagement to prevent hospital readmission<br />
of patients with chronic heart failure. International<br />
Journal of Cardiology (in stampa).<br />
S Scalvini, M Mazzù, A Giordano, E Zanelli, C Piemontese,<br />
F Fedele and F Glisenti. A review of seven years’ telecardiology<br />
experience. Journal of Telemedicine and Telecare<br />
Vol. 13, Suppl 1, 2007: 50-52.<br />
M Vitacca, G Assoni, P Pizzocaro, A Guerra, L Marchina, S<br />
Scalvini, F Glisenti, A Spanevello, L Bianchi, L Barbano, A<br />
76<br />
Giordano, B Balbi. A pilot study of nurse-led, home monitorinG<br />
for patients with chronic respiratory failure and with<br />
mechanical ventilation assistance. Journal of Telemedicine<br />
and Telecare 2006; 12 (7): 337-342.<br />
S Scalvini, E Zanelli, L Paletta, M Benigno, D Domenighini,<br />
F De Giuli, A Giordano, Glisenti F. Chronic heart failure<br />
home-based management with a telecardiology system: a<br />
comparison between patients followed by general pratictioners<br />
and by a cardiology department. Journal of Telemedicine<br />
and Telecare 2006; 12 (Suppl. 1): 46-48.<br />
M Vitacca, S Scalvini, A Spanevello, B Balbi. Telemedicine<br />
and home care: controversies and opportunities. Breathe<br />
2006; 3 (2): 149-158.<br />
S Scalvini, A Giordano, F Glisenti. The boario home care<br />
project. Healthcare It Management 2006; 1: 34-35, 42.<br />
S Scalvini, E Zanelli, A Cinelli, F Vigliani, F Boglioni, F De<br />
Giuli, M Mazzù, A Giordano. Telesorveglianza domiciliare<br />
nei pazienti con scompenso cardiaco cronico: importanza<br />
della classe NYHA, Giornale Italiano di Cardiologia Vol. 8<br />
(5): Suppl. 2, 2007.<br />
M Penna, S Verdirosi, G Martinelli, D Baratti, E Zanelli, S<br />
Scalvini, A Giordano. Ospedalizzazione domiciliare riabilitativa<br />
post cardiochirurgia (OD): valutazione dei costi di<br />
farmaci e dispositivi. Giornale Italiano di Cardiologia Vol. 8<br />
(5): Suppl. 2, 2007.<br />
E Zanelli, S Scalvini, D Baratti, L Marchina, C Piemontese,<br />
A Giordano. Ospedalizzazione domiciliare (OD) per il paziente<br />
post-cardiochirurgico: il progetto CRITERIA (confronto<br />
fra reti integrate tecnologiche per gestire al domicilio<br />
pazienti post-acuti e cronici-ricerca apllicata). Giornale<br />
Italiano di Cardiologia Vol. 8 (5): Suppl. 2, 2007.<br />
L Marchina, D Baratti, G Martinelli, G Assoni, E Zanelli, F<br />
Rivadossi, S Scalvini, A Paini, ML Muiesan. Fattibilità ed<br />
efficacia diprogrammi di prevenzione cardiovascolare mediante<br />
sistemi di telemedicina avanzati. Giornale Italiano di<br />
Cardiologia Vol. 8 (5): Suppl. 2, 2007.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr.ssa Simonetta Scalvini.<br />
Nata a Brescia il 9/4/1959, cittadinanza italiana.<br />
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università<br />
di Brescia il 23/7/8.<br />
Abilitata all’esercizio della professione Medica<br />
nella seconda sessione dell’anno 1985<br />
presso l’Università di Brescia.<br />
Specializzata in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia respiratoria<br />
presso l’Università di Pavia il 12/7/88.<br />
Specializzata in Cardiologia presso l’Università di Brescia il 10/7/92.<br />
Dal 2006 - AD OGGI: Direttore della Direzione Scientifica di<br />
Istituto.<br />
DAL 2003 - AD OGGI: Responsabile del Servizio Autonomo di<br />
Telemedicina.<br />
Dal 1994 - AD OGGI: Cardiologo con mansioni principali di attività<br />
di degenza in regime di day-hospital, ospedalizzazione<br />
domiciliare e servizi ambulatoriali. Coordinamento e gestione<br />
del personale medico ed infermieristico.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Dal 1994 - 2002: Nascita, organizzazione e successiva direzione<br />
della struttura di day hospital riabilitativo e dell’attività<br />
ambulatoriale con possibilità di svolgere terapia isotropa infusiva<br />
nei pazienti con scompenso cardiaco cronico. Nel 1998<br />
partecipa alla costituzione del Servizio Autonomo di Telemedicina<br />
sia nella parte tecnologica che nella organizzazione dei<br />
vari servizi.<br />
Dal 1986 - 1994: Assistente del reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria.<br />
Si è occupata prevalentemente dell’attività di reparto con particolare<br />
interesse alle interazioni cuore-polmone strutturando<br />
la fase di ricerca su questi aspetti; ha partecipato alla fase iniziale<br />
di apprendimento delle tecniche ventilatorie invasive e<br />
non invasive applicate anche allo svezzamento dei pazienti<br />
cardiopatici post-intervento cardiochirurgico, o al trattamento<br />
ventilatorio non invasivo della fase acuta dello scompenso<br />
cardiaco. Con la successiva scissione del reparto ha iniziato<br />
l’attività nel reparto di cardiologia riabilitativa, dove si è occupata<br />
della normale attività di reparto comprendente anche<br />
l’attività riabilitativa, in cui sono state predominanti patologie<br />
quali infarto miocardico, recente intervento di rivascolarizzazione<br />
miocardia, scompenso cardiaco cronico con particolare<br />
riguardo alle forme complicate (presenza di terapia intensiva<br />
e disunità intensiva per lo scompenso cardiaco.<br />
Capacità e competenze relazionali: Buone capacità e competenze<br />
relazionali; da sempre dedita al coordinamento ed alla<br />
gestione delle risorse umane dapprima nel reparto di cardiologia,<br />
successivamente nel Servizio Autonomo di Telemedicina;<br />
all’interno della Direzione Scientifica svolge attività di relazioni<br />
esterne ed interne; relatore a numerosissimi convegni internazionali<br />
e nazionali.<br />
Relatore per il settore “Chronic Care” per la Commissione<br />
Europea ICT for Health.<br />
Capacità e competenze organizzative: Nel 1995, ha organizzato<br />
la nascita del day hospital cardiologico e degli ambulatori<br />
dedicati. Dal 1997, si è dedicata all’organizzazione di<br />
tutte le attività della Divisione di Cardiologia. Dal 1999 si è dedicata<br />
alla nascita, alla strutturazione e all’organizzazione del<br />
servizio di telemedicina.<br />
All’interno della Direzione Scientifica organizza tutte le attività<br />
di formazione aziendale ed istituzionali; organizza e promuove<br />
l’attività di ricerca del Centro; partecipa come membro alla<br />
Conferenza di Organizzazione del Centro di Lumezzane.<br />
Capacità e competenze tecniche: Buona capacità all’utilizzo<br />
di programmi semplici quali windows XP (word, excel,<br />
powerpoint).<br />
Utilizzo di software applicati a piattaforme complesse per i<br />
servizi di telemedicina.<br />
Utilizzo di apparecchiature specifiche in uso presso le Divisioni<br />
di Cardiologia e Pneumologia quali: elettrocardiografo,<br />
ergonometro, ecg sec.holter, apparecchiature per la valutazione<br />
del sistema neurovegetativo, apparecchiature per la fisiopatologia<br />
respiratoria (spirometro, emogasanalizzatore,<br />
pletismografo.<br />
Autore e Coautore di numerose pubblicazioni scientifiche<br />
recensite su riviste nazionali ed internazionali, Abstract per<br />
congressi nazionali ed internazionali, Capitoli di libro.<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
7. LABORATORIO PER L’ANALISI<br />
E MODELLIZZAZIONE DELLA<br />
VARIABILITÀ CARDIORESPIRATORIA<br />
Istituto Scientifico di Montescano<br />
Via per Montescano<br />
Tel. 0385.2471<br />
e-mail: giandomenico.pinna@fsm.it<br />
Responsabile: Ing. Gian Domenico Pinna<br />
La missione del Laboratorio è quella di sviluppare metodologie<br />
innovative di analisi e di modellizzazione matematica dei<br />
segnali di variabilità cardiaca e respiratoria atte ad estendere<br />
ed integrare le conoscenze correnti su 1) la fisiologia e patofisiologia<br />
del controllo autonomico del sistema cardiovascolare,<br />
2) i meccanismi patofisiologici di generazione delle alterazioni<br />
del pattern respiratorio (respiro periodico, apnee notturne),<br />
3) le interazioni cardiorespiratorie relative ai punti 1 e<br />
2. Parte integrante delle attività del laboratorio sono la validazione<br />
sperimentale delle metodologie sviluppate e la loro applicazione<br />
in ambito clinico.<br />
Il Laboratorio si occupa primariamente di patologie croniche<br />
sia cardiovascolari (scompenso cardiaco, post-trapianto) che<br />
più propriamente cardio-respiratorie (sindrome da apnee notturne<br />
centrali e/o ostruttive). Per loro natura, le attività di ricerca<br />
vengono sviluppate con un approccio eminentemente<br />
interdisciplinare, attraverso una stretta relazione con il Laboratorio<br />
per lo studio del sistema neurovegetativo e con il Laboratorio<br />
per lo studio del sonno.<br />
Attività di Ricerca<br />
Le attività di ricerca del Laboratorio si sviluppano all’interno di<br />
4 linee principali fortemente interagenti tra di loro.<br />
Studio della fisiopatologia delle alterazioni dell’equilibrio neurovegetativo<br />
con enfasi verso le metodologie non-invasive.<br />
Sviluppo di metodi e sistemi per l’acquisizione ed analisi<br />
poliparametrica dei segnali di variabilità cardiorespiratoria<br />
e relativa validazione.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 77<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Studio delle interazioni cardiorespiratorie in pazienti soggetti<br />
ad anormalità del pattern respiratorio (respiro periodico,<br />
apnee centrali e/o ostruttive).<br />
Sviluppo e validazione di modelli matematico-statistici dei<br />
sistemi di controllo cardiovascolare e respiratorio.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio del potere prognostico e correlati clinici di indici<br />
nonlineari di variabilità della frequenza cardiaca in pazienti<br />
con scompenso cardiaco cronico.<br />
Sviluppo e validazione di un modello computazionale del<br />
respiro periodico orientato al singolo paziente (patient<br />
specific) per il supporto ai clinici nell’identificazione della<br />
migliore strategia di trattamento delle apnee centrali notturne<br />
nei pazienti con scompenso cardiaco.<br />
Valutazione strumentale dello stato di veglia in pazienti<br />
con scompenso cardiaco cronico e respiro periodico durante<br />
registrazioni short-term di laboratorio.<br />
Pubblicazioni<br />
Hoyer D, Maestri R, La Rovere MT, Pinna GD. Autonomic<br />
response to cardiac dysfunction in chronic heart failure -<br />
a risk predictor based on autonomic information flow. Pacing<br />
Clin Electrophysiol. 2008; 31 (2): 214-220.<br />
Angelini L, Maestri R, Marinazzo D, Nitti L, Pellicoro M,<br />
Pinna GD, Stramaglia S, Tapputi SA. Multiscale analysis of<br />
short term heart beat interval, arterial blood pressure and<br />
instantaneous lung volume time series. Artif Intell Med.<br />
2007; 41 (3): 237-250.<br />
La Rovere MT, Pinna GD, Raczak G. Baroreflex sensitivity:<br />
measurement and clinical implications. Ann Noninvas<br />
Electro. 2008; 13 (2): 191-207.<br />
Maestri R, Pinna GD, Accardo A, Allegrini P, Balocchi R,<br />
D’Addio G, Ferrario M, Menicucci D, Porta A, Sassi R, Signorini<br />
MG, La Rovere MT, Cerutti S. Nonlinear indices of<br />
heart rate variability in chronic heart failure patients: redundancy<br />
and comparative clinical value. J Cardiovasc<br />
Electrophysiol. 2007; 18: 425-433.<br />
Maestri R, Pinna GD, Porta A, Balocchi R, Sassi R, Signorini<br />
MG, Dudziak M, Raczak G. Assessing nonlinear properties<br />
of Heart Rate Variability from short-term recordings:<br />
are these measurements reliable? Physiological<br />
Measurement. 2007; 28: 1067-1077.<br />
La Rovere MT, Pinna GD, Maestri R, Robbi E, Mortara A,<br />
Fanfulla F, Febo O, Sleight P. Clinical relevance of shortterm<br />
day-time breathing disorders in chronic heart failure<br />
patients. Eur J Heart Fail. 2007; 9 (9): 949-954.<br />
Pinna GD. Assessing baroreflex sensitivity by the transfer<br />
function method: what are we really measuring? J Appl<br />
Physiol. 2007; 102 (4): 1310-1311.<br />
Pinna GD, Maestri R, Torunski A, Danilowicz-Szymanowicz<br />
L, Szwoch M, La Rovere MT, Raczak G. Heart Rate<br />
Variability measures: a fresh look at reliability. Clin Sci<br />
(Lond). 2007; 113 (3): 131-140.<br />
Casaleggio A, Maestri R, La Rovere MT, Rossi P, Pinna GD.<br />
Prediction of sudden death in heart failure patients: a<br />
novel perspective from the assessment of the peak ectopy<br />
rate. Europace. 2007; 9 (6): 385-390.<br />
Pinna GD, Maestri R, Andrews D, Witkowski T, Capomolla<br />
S, Scanferlato JL, Gobbi E, Ferrari M, Ponikowski P, Sleight<br />
78<br />
P, Mortara A, Johnson P. Home Telemonitoring of Vital<br />
Signs and Cardiorespiratory Signals in Heart Failure Patients:<br />
system architecture and feasibility of the HHH<br />
model. Int J Cardiol. 2007; 120 (3): 371-379.<br />
Collaborazioni<br />
Nell’ambito dello studio del controllo autonomico del sistema<br />
cardiovascolare sono in corso collaborazioni scientifiche con:<br />
Dipartimento di Fisica di Bari, Centro di Eccellenza per<br />
studi interdisciplinari TIRES (Tecnologie Innovative per la<br />
Rivelazione e l’Elaborazione dei Segnali).<br />
Leiden University Medical Center, Department of Cardiology<br />
Leiden; Netherlands.<br />
II Department of Cardiology, Gdansk School of Medicine,<br />
Gdansk, Poland.<br />
Dipartimento di Cardiologia, Università di Pavia e Policlinico<br />
S. Matteo.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
L’ing. Gian Domenico Pinna ha conseguito la<br />
Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università<br />
degli Studi di Pavia e nel 1980 ha iniziato<br />
la sua attività presso il Servizio di Bioingegneria<br />
dell’Istituto Scientifico di Montescano,<br />
<strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>, IRCCS. Dal<br />
1992 riveste il ruolo di Direttore del Servizio<br />
medesimo. Ha maturato una lunga esperienza<br />
nella gestione della strumentazione<br />
biomedica, nella creazione e valutazione di sistemi per misure<br />
fisiologiche e nell’analisi digitale dei segnali biologici, prevalentemente<br />
nelle aree cardiologica, pneumologica e neurofisiologica.<br />
In qualità di responsabile della Unità di Statistica<br />
dell’Istituto Scientifico di Montescano, esegue o coordina<br />
analisi statistiche su dati provenienti da trials clinici o studi<br />
sperimentali. Partecipa attivamente in qualità di ricercatore<br />
responsabile o collaboratore allo sviluppo interdisciplinare di<br />
progetti di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
1. LABORATORIO PER LO STUDIO DELLO<br />
STATO DI SALUTE - QUALITÀ DELLA VITA<br />
NELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884789<br />
e-mail: mauro.carone@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Mauro Carone<br />
Il Laboratorio per la valutazione dello Stato di Salute (Qualità<br />
della Vita) dei pazienti affetti da patologie respiratorie croniche<br />
valuta l’impatto delle malattie croniche e delle loro terapie<br />
sullo stato di benessere dei pazienti, nonché esamina gli<br />
indicatori di risultato (outcome) dei trattamenti effettuati nei<br />
pazienti ricoverati. Il Laboratorio ha ideato il <strong>Maugeri</strong> Foundation<br />
Respiratory Failure Questionnaire (MRF26) brevettato in<br />
Italia e tradotto in varie lingue straniere.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di Ricerca del Laboratorio è incentrata sullo sviluppo<br />
e applicazione di questionari atti a valutare lo stato di salute<br />
(qualità della vita) dei pazienti affetti da malattie respiratorie<br />
croniche. Inoltre ha focalizzato l’interesse anche sulla valutazione<br />
del risultato (outcome) dei trattamenti riabilitativi effettuati<br />
durante la degenza in ospedale dei pazienti.<br />
A tale scopo è iniziata da tempo una collaborazione con il<br />
Prof. Paul W. Jones della St. George’s Hospital Medical School<br />
di Londra, il più autorevole esperto internazionale di Qualità<br />
della Vita e Stato di Salute. Da ciò è inizialmente scaturita la<br />
traduzione e validazione in Italiano del St. George’s Respiratory<br />
Questionnaire (SGRQ), il questionario comunemente accettato<br />
come il migliore per valutare lo Stato di Salute dei pazienti<br />
affetti da asma o BPCO. Il Prof. Jones ha riconosciuto il<br />
Dr. Mauro Carone come il referente nazionale per le autorizzazioni<br />
all’uso del SGRQ e per la sua interpretazione.<br />
Come secondo momento è stato sviluppato e di validato un<br />
nuovo questionario, utile a misurare lo stato di salute e la Qualità<br />
di Vita dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica.<br />
Questo lavoro ha prodotto presentazioni a congressi in-<br />
ternazionali, nonché la pubblicazione del lavoro di validazione<br />
del questionario noto come “<strong>Maugeri</strong> Foundation Respiratory<br />
Failure Questionnaire - MRF28”. Il questionario MRF28 è attualmente<br />
riconosciuto a livello internazionale come il questionario<br />
di riferimento nei pazienti con insufficienza respiratoria<br />
cronica. Ha avuto traduzioni in Ceco, Francese, Francese Canadese,<br />
Giapponese, Inglese Americano, Inglese Britannico, Portoghese<br />
Brasiliano, Spagnolo, Tedesco. Il questionario MRF28 è<br />
oggetto di un progetto multicentrico internazionale che coinvolge<br />
23 Istituti in 9 nazioni differenti (Argentina, Brasile, Canada,<br />
Giappone, Italia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca,<br />
USA), il “Quality of Life Evaluation and Survival Study - QuESS”.<br />
Il QuESS ha come scopo quello di valutare la storia naturale<br />
dell’insufficienza respiratoria cronica, i suoi fattori prognostici di<br />
mortalità e di utilizzo di risorse sanitarie. Per far ciò sono stati<br />
arruolati 442 pazienti in Ossigenoterapia a Lungo Termine o in<br />
Ventilazione Meccanica Notturna, con l’intento di seguirne l’andamento<br />
clinico-funzionale per 3 anni. Sinora sono stati presentati<br />
dati preliminari a vari congressi Europei e Nord-Americani.<br />
È stato pubblicato il primo lavoro per esteso. L’Istituto di<br />
Veruno è riconosciuto come il centro leader dove sono centralizzati<br />
e analizzati i dati raccolti da tutti i ricercatori.<br />
Grazie al contributo scientifico del Laboratorio, recentemente<br />
è stato pubblicato un lavoro scritto a nome dei partecipanti al<br />
Dipartimento di Pneumologia Riabilitativa sull’efficacia della<br />
riabilitazione respiratoria anche nei pazienti affetti da insufficienza<br />
respiratoria cronica.<br />
Ricerche in corso o in programmazione<br />
È attualmente in corso uno studio sui fattori prognostici di mortalità<br />
nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica.<br />
Insieme al Dipartimento di Pneumologia Riabilitativa si stanno<br />
valutando nuovi ambiti di ricerca.<br />
Pubblicazioni<br />
M. Carone, C.F. Donner. Impact of long-term ventilation on<br />
patients’ health status. Chronic Respir Dis 2005; 2: 29-33.<br />
M. Carone, P.W. Jones. Impact of health status (‘quality of<br />
life’) issues in chronic lung disease. In: Pulmonary Rehabilitation.<br />
C.F. Donner, N. Ambrosino, R. Goldstein eds.<br />
Hodder Arnold, London, 2005, pp 143-149.<br />
M. Carone, N. Ambrosino, G. Balzano, C.F. Donner, C.<br />
Fracchia, S. Nava, M. Neri, A. Patessio, A. Spanevello. Improvements<br />
in health status, dyspnea, and exercise endurance<br />
after pulmonary rehabilitation in patients with chronic<br />
respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med 2005;<br />
2: A799.<br />
M. Carone, C.F. Donner. L’Asthma Control Test (ACT), un<br />
efficace indice di valutazione del controllo dell’asma bronchiale.<br />
Aria, Ambiente & Salute 2005; 2: 9-12.<br />
G. Bertolotti, M. Carone, G. Vidotto, M. Neri, F. Arpinelli, R.<br />
Testi, V. Bellia, C.F. Donner, P.W. Jones. Simple logistic<br />
models in the development of a quality of life questionnaire<br />
specific for patients with chronic obstructive pulmonary<br />
disease. Eur Respir J 2005; 26 (suppl 49): 360S.<br />
M. Carone, N. Ambrosino, G. Balzano, C.F. Donner, C.<br />
Fracchia, S. Nava, M. Neri, A. Patessio, A. Spanevello. Pulmonary<br />
rehabilitation in patients with chronic respiratory<br />
failure improves exercise endurance, dyspnea, and quality<br />
of life. Eur Respir J 2005; 26 (suppl 49): 528S.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 79<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
I. Sampablo Lauro, M. Carone, F. Ioli, S. Zaccaria, C.F.<br />
Donner. Liquid long-term oxygen therapy (LTOT) improves<br />
health status in patients with chronic obstructive pulmonary<br />
disease (COPD). Eur Respir J 2005; 26 (suppl 49): 709S.<br />
M. Carone. Qualità di vita. Misurazione dello stato di salute<br />
respiratoria e comorbidità. In: Rapporto sulla Broncopneumopatia<br />
Cronica Ostruttiva (BPCO) 2005. M. De<br />
Palma, L. Fabbri eds. Federazione Italiana contro le Malattie<br />
Polmonari Sociali e la Tubercolosi. GPAnet, Milano,<br />
2005, pp 158-167.<br />
M. Carone, N. Ambrosino, B. Balbi, G. Balzano, C. Fracchia,<br />
S. Nava, M. Neri, A. Patessio, P. Baiardi, E. Pozzi, A. Spanevello.<br />
In patients with chronic respiratory failure, the<br />
<strong>Maugeri</strong> respiratory failure questionnaire (MRF28) is more<br />
sensitive to changes than the St. George’s respiratory questionnaire<br />
(SGRQ). Eur Respir J 2006; 28 (S50): 69S.<br />
G. Vidotto, G. Bertolotti, M. Carone, F. Arpinelli, V. Bellia,<br />
P.W. Jones, C.F. Donner. The Italian Health Status Questionnaire.<br />
A new questionnaire specifically designed for<br />
patients affected by chronic obstructive pulmonary disease.<br />
Respir Med. 2006; 100: 862-870.<br />
Attività Educazionale<br />
Il Laboratorio ha partecipato come referente scientifico al progetto<br />
multicentrico nazionale Edu-Care, il primo studio che ha<br />
valutato l’efficacia delle attività educazionali nella Broncopneumopatia<br />
Cronica Ostruttiva.<br />
Attualmente il Laboratorio valuta in tutti i pazienti ricoverati gli<br />
indicatori di risultato/efficacia (outcome) dei programmi riabilitativi/educazionali<br />
forniti ai pazienti. In particolare vengono<br />
valutati all’ingresso ed in fase di dimissione i livelli di dispnea,<br />
di capacità ad eseguire esercizio fisico e di qualità della vita.<br />
In tal modo è possibile misurare l’efficacia riabilitativa del ricovero<br />
ospedaliero.<br />
Attività Traslazionale<br />
I questionari per la valutazione dello stato di salute e della qualità<br />
di vita sviluppati dal Laboratorio o validati in italiano dallo<br />
stesso sono utilizzati nella pratica clinica per valutare l’efficacia<br />
di trattamenti e terapie nei pazienti affetti da patologie respiratorie<br />
croniche. Questo utilizzo non è limitato ai Centri della<br />
<strong>Fondazione</strong>, in quanto l’autorizzazione all’uso viene richiesta<br />
da molte Divisioni di Pneumologia italiane ed estere.<br />
Brevetti<br />
QUESTIONARIO DELLA FONDAZIONE “SALVATORE MAUGERI” PER L’IN-<br />
SUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA (MRF-28) ® (registrazione<br />
SIAE n° 0104721).<br />
M. Carone, G. Bertolotti, A.M. Zotti, C.F. Donner, P.W. Jones.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
80<br />
Dr. Mauro Carone<br />
Data di nascita: 06/11/1960.<br />
Educazione<br />
1. Scuola Superiore: Liceo Scientifico “Gobetti”,<br />
Omegna (NO).<br />
2. Laurea: Facoltà di Medicina, Università di<br />
Milano, 107/110.<br />
3. Internati: Divisione di Anestesia e Rianimazione, Ospedale<br />
“Madonna del Popolo”, Omegna (NO).<br />
4. Specialità: Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria,<br />
Università di Pavia, 50/50 “con lode”.<br />
5. Fellowships: a) Division of Physiological Medicine, St<br />
George’s Hospital - Medical School, London (Prof. PW<br />
Jones) - Settembre-Ottobre 1992 e Maggio-Giugno 1996;<br />
b) Division of Pulmonary Disease, Hospital Clinic I Provincial,<br />
University of Barcelona, Spain (Prof R Rodriguez-<br />
Roisin) - Gennaio-Marzo 1994.<br />
Esperienze professionali<br />
1. 1984-1988 Assistente volontario, Divisione di Anestesia<br />
e Rianimazione, Ospedale “Madonna del Popolo”,<br />
Omegna (NO).<br />
2. 1988-89 Vincitore di una delle 3 Borse di Studio presso<br />
l’Università di Pavia, Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia<br />
e Fisiochinesiterapia Respiratoria.<br />
3. 1989 Vincitore Borsa di Studio presso <strong>Fondazione</strong> “<strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>”, IRCCS, Divisione di Pneumologia, Istituto<br />
Scientifico di Veruno (NO).<br />
4. 1989-1994 Assistente Pneumologo Incaricato, <strong>Fondazione</strong><br />
“<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>”, IRCCS, Divisione di Pneumologia,<br />
Istituto Scientifico di Veruno (NO).<br />
5. 1994-1996 Assistente Pneumologo di Ruolo a seguito di<br />
Concorso (dove è risultato vincitore al primo posto su 5 posti<br />
a disposizione), <strong>Fondazione</strong> “<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>”, IRCCS, Divisione<br />
di Pneumologia, Istituto Scientifico di Veruno (NO).<br />
6. 1996 ad oggi Aiuto Pneumologo (attualmente Dirigente<br />
Medico), <strong>Fondazione</strong> “<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>”, IRCCS, Divisione<br />
di Pneumologia, Istituto Scientifico di Veruno (NO).<br />
Attività Clinica e di Ricerca<br />
Gli interessi fondamentali dell’attività clinica e di ricerca sono<br />
stati improntati a:<br />
a) aspetti riabilitativi delle patologie respiratorie croniche<br />
(BPCO - Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, Asma<br />
Bronchiale, Interstiziopatie Polmonari);<br />
b) disturbi respiratori del sonno;<br />
c) aspetti valutativi ed implicazioni terapeutiche dell’esercizio<br />
fisico nella patologia respiratoria;<br />
d) valutazione dello Stato di Salute e Qualità di Vita (QoL) dei<br />
pazienti in ossigenoterapia a lungo termine (LTOT) o in<br />
assistenza ventilatoria domiciliare.<br />
Il Dr. Carone è l’autore della versione Italiana del “St. George’s<br />
Respiratory Questionnaire”, il più noto e diffuso questionario<br />
di stato di salute.<br />
È inoltre l’autore del “<strong>Maugeri</strong> Foundation” Respiratory Failure<br />
Questionnaire (MRF28) e della sua versione ridotta a 26 domande<br />
(MRF26), il primo questionario di stato di salute specifico<br />
per i pazienti con insufficienza respiratoria cronica. Il questionario<br />
è stato tradotto in diverse lingue tra cui Ceco, Francese,<br />
Giapponese, Inglese Britannico, Inglese Americano,<br />
Spagnolo, Tedesco.<br />
È inoltre il coordinatore internazionale del progetto ‘Quality of<br />
Life Evaluation and Survival Study (QUESS)’, uno studio di 3 anni<br />
atto a studiare la storia naturale dell’insufficienza respiratoria<br />
cronica ed i predittori di outcome in Argentina, Brasile, Canada,<br />
Italia, Giappone, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, USA.<br />
È autore di più di 220 tra pubblicazioni in esteso ed abstracts<br />
di congressi.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
2. LABORATORIO DI MECCANICA<br />
POLMONARE E FUNZIONE MUSCOLARE<br />
RESPIRATORIA<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921 - 0382.592812 - 0382.592806<br />
e-mail: stefano.nava@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Stefano Nava<br />
Il laboratorio di meccanica polmonare e funzione muscolare respiratoria<br />
svolge attività clinica ed attività di ricerca all’interno<br />
della Unità Operativa di Riabilitazione Pneumologica. Il laboratorio<br />
rappresenta un centro di riferimento a livello mondiale per<br />
i seguenti campi di interesse clinico-scientifico: svezzamento<br />
dalla ventilazione meccanica invasiva, interazione pazienteventilatore<br />
e valutazione delle disfunzioni diaframmatiche.<br />
Attività di Ricerca<br />
Dal 2000, anno di apertura della Unità Operativa di Riabilitazione<br />
Pneumologica, il laboratorio è inserito all’interno della<br />
Divisione e pertanto non ha locazione “fisica” identificabile.<br />
Dal punto di vista strumentale il laboratorio è composto da<br />
una “working station” che comprende un pneumotacografo, 3<br />
trasduttori di pressione e 3 canali di elettromiografia. Le registrazioni<br />
vengono effettuate principalmente sui pazienti ricoverati,<br />
anche se è possibile accedere anche a prestazioni di<br />
tipo ambulatoriale.<br />
L’attività di ricerca si ispira per continuità ed integrazione a<br />
progetti di ricerca già avviati presso la Mc-Gill University nella<br />
metà degli anni ’80, proseguiti poi presso l’Istituto Scientifico<br />
di Montescano ed infine presso il New England Medical<br />
Center, Tufts University di Boston. Essa si concentra soprattutto<br />
su cinque linee: 1) fattori predittivi calcolati dalle misure<br />
di meccanica respiratoria di svezzamento dalla ventilazione<br />
meccanica invasiva e/o fattori predittivi di svezzamento dalla<br />
cannula tracheotomia; 2) studio dell’interazione paziente/ventilatore<br />
durante ventilazione meccanica non-invasiva; 3) valutazione<br />
della funzionalità diaframmatici e degli altri muscoli<br />
respiratori; 4) studio dell’adattamento del paziente con sindrome<br />
delle apnee notturne al ventilatore durante la notte;<br />
5) studio del carico elastico e resistivo respiratorio nei pazienti<br />
con ipertensione polmonare pre e post trattamento.<br />
Ricerche in corso<br />
In corso numerosi studi. Si segnalano in particolare gli studi<br />
fisiologici sulle modificazioni del pattern respiratorio e della<br />
funzione dei muscoli respiratori durante il trial di svezzamento<br />
più comunemente impiegato (trial con tubo a T), le modificazioni<br />
del rapporto tra forza e carico registrate quando il paziente<br />
è ancora dipendente dalla protesi meccanica e quando<br />
invece raggiunge la completa autonomia ed infine lo sviluppo<br />
di un algoritmo in grado di monitorare in maniera non-invasiva<br />
le anomalie nell’interazione paziente/ventilatore. È in<br />
corso inoltre uno studio multicentrico internazionale, di cui il<br />
laboratorio di meccanica respiratoria è il centro coordinatore,<br />
sull’uso della ventilazione meccanica non-invasiva come trattamento<br />
palliativo nel paziente con tumore solido in fase terminale.<br />
Pubblicazioni<br />
Pignatti P, Brunetti G, Moretto D, Yacoub MR, Fiori M,<br />
Balbi B, Balestrino A, Cervio G, Nava S, Moscato G. Role of<br />
the Chemokine Receptors CXCR3 and CCR4 in Human<br />
Pulmonary Fibrosis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006;<br />
173: 310-317.<br />
Vitacca M, Paneroni M, Bianchi L, Clini E, Vianello A, Ceriana<br />
P, Barbano L, Balbi N, Nava S. Maximal inspiratory<br />
and expiratory pressure measurement in tracheotomised<br />
patients. Eur. Respir. J. 2006; 27: 343-349.<br />
Nava S, Navalesi P, Conti G. Time of non-invasive ventilation.<br />
Intensive Care Med. 2006; 32: 361-370.<br />
Andrews P, Azoulay E, Antonelli M, Brochard L, Brun-<br />
Buisson C, de Backer D, Dobb G, Fagon JY, Gerlach H,<br />
Groeneveld J, Mancebo J, Metnitz P, Nava S, Pugin J,<br />
Pinsky M, Radermacher P, Richard C, Tasker R. Year in review<br />
in intensive care medicine. 2005. I. Acute respiratory<br />
failure and acute lung injury, ventilation, hemodynamics,<br />
education, renal failure. Intensive Care Med. 2006; 32:<br />
207-216.<br />
Andrews P, Azoulay E, Antonelli M, Brochard L, Brun-<br />
Buisson C, de Backer D, Dobb G, Fagon JY, Gerlach H,<br />
Groeneveld J, Mancebo J, Metnitz P, Nava S, Pugin J,<br />
Pinsky M, Radermacher P, Richard C, Tasker R. Year in review<br />
in intensive care medicine. 2005. II. Infection and sepsis,<br />
ventilator-associated pneumonia, ethics, haematology<br />
and haemostasis, ICU organisations and scoring,<br />
brain injury. Intensive Care Med 2006; 32: 361-370.<br />
Andrews P, Azoulay E, Antonelli M, Brochard L, Brun-<br />
Buisson C, de Backer D, Dobb G, Fagon JY, Gerlach H,<br />
Groeneveld J, Mancebo J, Metnitz P, Nava S, Pugin J,<br />
Pinsky M, Radermacher P, Richard C, Tasker R. Year in review<br />
in intensive care medicine 2005. III. Nutrition, pediatric<br />
and neonatal critical care, and experimental. Intensive<br />
Care Med 2006; 32: 490-500.<br />
Nava S, Cuomo AM. Noninvasive ventilation and dyspnea<br />
in palliative medicine. Chest 2006; 125: 1391-1392.<br />
Nava S, Barbarito N, Piaggi G, De Mattia E, Cirio S. Physiological<br />
response to intrapulmonary percussive ventila-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 81<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
tion in stable COPD patients. Respir Med. 2006 Sep; 100:<br />
1526-33.<br />
Ceriana P, Carlucci A, Navalesi P, Prinianakis G, Fanfulla F<br />
Delmastro, M, Nava S. Physiological responses during a Tpiece<br />
weaning trial with a deflated tube. Intensive Care<br />
Med. 2006; 32: 1399-1403.<br />
Frutos-Vivar F, Ferguson N, Esteban A, Epstein SK, Arabi<br />
Y, Apezteguia C, Gonzales M, Hill NS, Nava S, D’Empaire<br />
G, Anzueto A. Risk factors for extubation failure in patients<br />
following a successful spontaneous breathing trial. Chest<br />
2006; 130: 1664-1671.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Stefano Nava, nato a Crema nel 1956 si<br />
è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università<br />
degli Studi di Pavia, dove ha ottenuto<br />
anche le specialità di Malattie dell’Apparato<br />
Respiratorio ed Anestesia e Rianimazione.<br />
Dal 1988 lavora presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>,<br />
dapprima presso l’Istituto Scientifico di<br />
Pavia e poi presso quello di Pavia. Grazie alle<br />
conoscenze acquisite all’estero (1985-1999<br />
post-graduate fellow presso i laboratori Meakins-Christie<br />
della Mc-Gill University, Montreal, Canada; visting professor<br />
presso il laboratorio di funzionalità respiratoria dell’Università<br />
di Leuven in Belgio nel 1993), il Dr. Nava è stato nominato<br />
professore a contratto presso varie scuole di specialità negli<br />
atenei di Pavia, Ferrara e Sassari.<br />
I campi di ricerca di principale interesse sono: svezzamento<br />
dalla ventilazione meccanica, ventilazione non invasiva, muscoli<br />
respiratori, farmacologia applicata ed etica dell’“end of<br />
life decision”.<br />
È attualmente reviewer delle maggiori riviste internazionali del<br />
settore, editore Associato di Intensive Care Medicine e<br />
Breathe e precedentemente di Thorax. Da cinque anni è<br />
inoltre membro del comitato scientifico del congresso American<br />
Thoracic Society Annual meeting.<br />
Attuale Head dell’ASSEMBLY n. 2 “Intensive Care” dell’European<br />
Respiratory Society e Chairman elected della Assemblea<br />
Critical Care dell’American Thoracic Society.<br />
Ha partecipato a numerose iniziative scientifiche organizzate<br />
da varie società scientifiche Europee e Nord Americane ed in<br />
particolare alla stesura delle Consensus Conference sulla<br />
“ventilazione meccanica non-invasiva” (2000) e sullo “svezzamento<br />
dalla ventilazione meccanica” (2005), organizzate da<br />
American Thoracic Society, American Society of Critical Care<br />
Medicine, European Respiratory Society, European Society of<br />
Intensive Care Medicine. Attualmente chairman della taskforce<br />
della European Respiratory Society sulla “end-of-life”<br />
decision e membro di quella “rehabilitation in ICU”, sempre<br />
organizzata dalla stessa società.<br />
Autore di circa 210 pubblicazioni di cui >140 su riviste indicizzate<br />
con sistema di “peer-review” e di 13 capitoli di libri in<br />
lingua straniera.<br />
82<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
3. LABORATORIO DI BIOLOGIA<br />
E FISIOLOGIA DELL’APPARATO<br />
RESPIRATORIO<br />
Istituto Scientifico di Cassano delle Murge<br />
Via per Mercadante Km. 2<br />
Tel. 080.7814111<br />
e-mail: antonio.spanevello@fsm.it<br />
Responsabile: Prof. Antonio Spanevello<br />
L’attività scientifica della Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
è rivolta alla messa a punto di programmi di ricerca di valenza<br />
traslazionale ed allo sviluppo di specifiche aree di eccellenza,<br />
finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca<br />
stessa all’attività assistenziale. Fulcro principale di tale attività<br />
è il Laboratorio di Biologia e Fisiologia dell’Apparato Respiratorio<br />
i cui interessi si focalizzano sull’approfondimento degli<br />
aspetti Biologici, e Fisiologici delle maggiori patologie respiratorie<br />
quali l’Asma e la BPCO.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività del Laboratorio di Biologia e Fisiologia dell’Apparato<br />
Respiratorio si ispira per continuità ed integrazione a progetti<br />
di ricerca già avviati presso Istituto Scientifico di Tradate in collaborazione<br />
con l’Hammersmith Hospital di Londra. Tale collaborazione<br />
ha avuto come obiettivo prioritario la messa a punto<br />
e la conseguente validazione di una metodica non-invasiva capace<br />
di monitorare l’andamento della flogosi bronchiale in patologie<br />
croniche ostruttive quali l’Asma e la Broncopneumopatia<br />
Cronica Ostruttiva (BPCO), nella fattispecie della “Metodica<br />
dell’Espettorato Indotto”. Come punto di partenza di<br />
questo innovativo filone di ricerca è stata dimostrata l’inappropriatezza<br />
del Lavaggio Broncoalveolare (BAL) nel monitoraggio<br />
clinico dell’infiammazione delle vie aeree, in quanto tecnica<br />
altamente invasiva e poco sicura a causa della sua scarsa<br />
tollerabilità e del potenziale verificarsi di eventi avversi. Successivamente<br />
è stata validata la tecnica dell’espettorato indotto<br />
attraverso un intenso lavoro di standardizzazione che ha permesso<br />
sia di dimostrarne la riproducibilità, negli adulti e nei<br />
soggetti in età pediatrica, che di ottenere, attraverso lo studio<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
di un adeguato campione di soggetti di varie fasce di età, dei<br />
dati circa i “valori di normalità”. Una ulteriore validazione della<br />
Metodica stessa è stata poi ottenuta sia dal confronto fra diverse<br />
metodiche 4 sia dimostrando la correlazione tra l’infiammazione<br />
delle vie aeree, ottenuta mediante l’analisi dell’espettorato<br />
indotto, appunto, e quella ottenuta attraverso lo studio<br />
della reattività bronchiale a stimoli aspecifici (metacolina). Ulteriori<br />
lavori hanno poi indagato prima l’utilizzo della metodica<br />
nella valutazione dell’efficacia della terapia antinfiammatoria<br />
nella BPCO, poi la possibilità di studiare i meccanismi patogenetici<br />
alla base della BPCO e della Sindrome delle Apnee del<br />
Sonno (OSAS). Gli studi di correlazione tra la metodica biologica<br />
dell’espettorato indotto e lo studio dell’iperreattività bronchiale<br />
ha promosso (dato impulso) studi di meccanica respiratoria<br />
con l’analisi dell’inspirazione profonda.<br />
Attualmente è avviata una stretta collaborazione con l’Istituto<br />
di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Foggia<br />
ed il Department of Respiratory Disease dell’Università di<br />
Leiden. Con questi due Istituti si sta proseguendo nella validazione<br />
e nell’utilizzo di metodiche non invasive per lo studio<br />
dell’infiammazione bronchiale (studio del gas esalati e del<br />
“naso elettronico”) e per lo studio della patogenesi del tumore<br />
del polmone.<br />
Inoltre, come ben noto l’Asma e la BPCO sono due malattie<br />
croniche delle vie aeree caratterizzate dall’infiammazione della<br />
parete bronchiale che ha come conseguenza il rimodellamento<br />
strutturale del tessuto connettivo della parete bronchiale. I<br />
meccanismi sottostanti tale anormalità sono poco conosciuti, è<br />
proprio questo il campo d’indagine del settore Fisiologico del<br />
laboratorio. La rete di collaborazioni nazionali ed internazionali<br />
mantenuta dall’Istituto ha consentito di validare e confrontare<br />
i risultati con altri laboratori in particolare con i Meakins Christie<br />
Laboratories della McGill University di Toronto.<br />
Attività Educazionale<br />
Il Laboratorio di Biologia e Meccanica dell’Apparato Respiratorio<br />
si è fatto promotore, nel corso dell’ultimo quinquennio, di<br />
numerosi eventi ECM sull’utilizzo della metodica dell’Espettorato<br />
Indotto, (come ad es. il Workshop on “Update on Sputum<br />
Induction and its Clinical Applications”), e sulle problematiche<br />
relative all’infiammazione e reattività bronchiale, (come ad es.<br />
il Workshop: Iperreattività ed Infiammazione Bronchiale). Per<br />
ciò che concerne l’attività didattico-divulgativa si è collaborato<br />
alla stesura di un atlante sull’Espettorato indotto: “An Atlas of<br />
induced Sputum. An Aid for Research and Diagnosis” particolarmente<br />
adatto alla didattica per la sua ricca iconografia.<br />
Attività Traslazionale<br />
La standardizzazione della Metodica dell’Espettorato Indotto,<br />
in termini di validità, ripetibilità, riproducibilità e valori di normalità,<br />
ha permesso il suo utilizzo, anche nel percorso diagnostico<br />
e nel monitoraggio (controllo e sorveglianza nel<br />
tempo) delle patologie bronchiali infiammatorie. In particolare<br />
la metodica è utilizzata routinariamente nella Divisione di<br />
Pneumologia dell’Istituto Scientifico di Cassano delle Murge<br />
(Ba) sia per la definizione dell’infiammazione eosinofilica in<br />
soggetti asmatici, relativamente alla sua evoluzione e al monitoraggio<br />
clinico, che per caratterizzare gli stessi pazienti in<br />
termini di compliance al trattamento corticosteroideo e quindi<br />
di verificarne l’efficacia.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Sono numerose le tematiche di ricerca avviate presso il laboratorio<br />
di Biologia e Fisiologia dell’Apparato Respiratorio. Fra<br />
queste figurano studi sull’“espettorato indotto”, sullo “stress ossidativo”,<br />
sul “condensato di aria espirata” e sulla “mucosa bronchiale”<br />
nelle patologie respiratorie delle alte e basse vie aeree.<br />
Inflammation, Oxidative Stress and Systemic Effects in Mild<br />
Copd.<br />
Ageing and Airway Inflammation.<br />
Organ Specific Asthma and Atopy Suscettibility: Microsatellites<br />
Alterations.<br />
The Role of Osas and Obesity in Determining Leptin in the<br />
Exhaled Breath Condensate.<br />
Il-6, Il-4, 8-Isosprostane in Exhaled Breath Condensate in<br />
Patients with Nasal Polyposis.<br />
Exhaled PH, Exhaled NO and Induced Sputum Cellularity in<br />
Obese Subjects with Osas.<br />
Protocollo AIFA: Valutazione dell’Effetto della sospensione<br />
dell’Antibiotico Guidata dalla Pro-Calcitoninemia nel Trattamento<br />
di Pazienti ricoverati per Riacutizzazione di Broncopneumopatia<br />
Cronica Ostruttiva (BPCO).<br />
Protocollo AIFA: Confronto fra Terapia Regolare e Terapia<br />
solo al bisogno della Associazione Budesonide/Formoterolo<br />
nell’Asma Moderato Persistente.<br />
Pubblicazioni<br />
Carpagnano GE, Resta O, Gelardi M, Spanevello A, Di<br />
Gioia G, Giliberti T, Depalo A, Foschino Barbaro MP.<br />
Exhaled inflammatory markers in aspirin-induced asthma<br />
syndrome. Am J Rhinol. 2007; 21 (5): 542-547.<br />
Salerno FG, Pinelli V, Pini L, Tuma B, Iozzo RV, Ludwig MS.<br />
Effect of PEEP on induced constriction is enhanced in decorin-deficient<br />
mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.<br />
2007; 293 (5).<br />
Carpagnano GE, Foschino-Barbaro MP, Spanevello A,<br />
Resta O, Carpagnano F, Mulè G, Pinto R, Tommasi S, Paradiso<br />
A. 3p Microsatellite Signature in Exhaled Breath<br />
Condensate and Tumor Tissue of Lung Cancer Patients.<br />
Am J Respir Crit Care Med. 2007; In Press.<br />
Carpagnano GE, Spanevello A, Curci C, Salerno F, Palladino<br />
GP, Resta O, Di Gioia G, Carpagnano F, Foschino Barbaro MP.<br />
IL-2, TNF-alpha, and leptin: local versus systemic concentrations<br />
in NSCLC patients. Oncol Res. 2007; 16 (8): 375-81.<br />
Ventura MT, Toungoussova O, Barbaro MP, Resta O, Carpagnano<br />
GE, Dragonieri S, Migliori GB, Neri M, Spanevello<br />
A. Validity and reproducibility of morphologic analysis of<br />
nasal secretions obtained using ultrasonic nebulization of<br />
hypertonic solution. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;<br />
99 (3): 232-5.<br />
Balbi B, Pignatti P, Corradi M, Baiardi P, Bianchi L, Brunetti<br />
G, Radaeli A, Moscato G, Mutti A, Spanevello A, Malerba<br />
M. Bronchoalveolar lavage, sputum and exhaled clinically<br />
relevant inflammatory markers: values in healthy adults.<br />
Eur Respir J. 2007; 30 (4): 769-81.<br />
Valerio G, Salerno FG, Bracciale P. The i.v. infusion of mannitol<br />
decreases airway responsiveness to methacholine in<br />
asthma. Respir Physiol Neurobiol. 2007; 156 (3): 374-7.<br />
Toungoussova O, Foschino Barbaro MP, Esposito LM, Carpagnano<br />
GE, Salerno FG, Dal Negro RW, Spanevello A.<br />
Brittle asthma. Monaldi Arch Chest Dis. 2007; 67 (2): 102-5.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 83<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Dragonieri S, Schot R, Mertens BJ, Le Cessie S, Gauw SA,<br />
Spanevello A, Resta O, Willard NP, Vink TJ, Rabe KF, Bel<br />
EH, Sterk PJ. An electronic nose in the discrimination of<br />
patients with asthma and controls. J Allergy Clin Immunol.<br />
2007; 120 (4): 856-62.<br />
Toungoussova O, Migliori GB, Foschino Barbaro MP,<br />
Esposito LM, Dragonieri S, Carpagnano GE, Salerno FG,<br />
Neri M, Spanevello A. Changes in sputum composition<br />
during 15 min of sputum induction in healthy subjects and<br />
patients with asthma and chronic obstructive pulmonary<br />
disease. Respir Med. 2007; 101 (7): 1543-8.<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
Il Laboratorio ha collaborato alla stesura delle Linee Guida<br />
della “Metodica dell’Espettorato Indotto”, la cui standardizzazione<br />
è stata valutata in uno studio multicentrico internazionale<br />
operato da una Task Force afferente all’European Respiratory<br />
Society, occupandosi, in particolar modo della parte relativa<br />
alla processazione del campione biologico 1 .<br />
1. Efthimiadis A, Spanevello A, Hamid Q et al. Methods of sputum<br />
processing for cell counts, immunocytochemistry and in situ hybridisation.<br />
Eur Respir J Suppl. 2002; 37: 19s-23s.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof. Antonio Spanevello, nato a Milano il<br />
23-11-1958.<br />
Formazione<br />
1978-1985, Università Pavia, Laurea in Medicina<br />
e Chirurgia.<br />
1985-1989, Università Pavia, Specializzazione<br />
in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio.<br />
Posizione Professionale<br />
1983-1985, Studente interno, Divisione di Pneumologia,<br />
Ospedale Multizonale di Varese.<br />
1985-1988, Interno specializzando, Divisione di Pneumologia,<br />
Ospedale Multizonale di Varese.<br />
1988-1991, Assistente Divisione di Pneumologia, <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, Tradate.<br />
1991-1997, Aiuto Divisione di Pneumologia, <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, Tradate.<br />
1997-1999, Primario Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa,<br />
Centro Italiano Studi e Ricerche Patologia del Lavoro<br />
e dello Sport, Ospedale Chiarenzi, Zevio (Verona).<br />
Dal 01.9.2000 ad oggi, Primario Divisione di Pneumologia<br />
Riabilitativa, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, Istituto Scientifico<br />
di Cassano delle Murge.<br />
Dal 01.11.2003 ad oggi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia<br />
Riabilitativa, <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> - IRCCS.<br />
Dal 01.01.2005 ad oggi, Direttore dell’Istituto Scientifico di<br />
Cassano delle Murge - <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Dal 31.10.2005 ad oggi, Professore Associato di Malattie<br />
dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Foggia.<br />
Attività Clinica<br />
Attività Assistenziale come Responsabile, di un Reparto di<br />
Pneumologia Riabilitativa di degenza ordinaria di 50 Posti<br />
letto, incluso:<br />
84<br />
Ambulatorio di Pneumologia.<br />
Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria.<br />
Laboratorio di Biologia dell’Apparato Respiratorio.<br />
Laboratorio di Broncoscopia.<br />
Laboratorio di Polisonnografia.<br />
Attività Didattica<br />
1990-1994, Professore a contratto di Microbiologia presso<br />
la Scuola Infermieri Ospedale di Tradate.<br />
dal 1995 al 2005, Professore a contratto presso la Scuola di<br />
Specialità di “Statistica Sanitaria ed Epidemiologia” dell’Univesità<br />
di Pavia.<br />
dal 1997 al 2005, Professore a contratto presso la Scuola di<br />
Specialità di “Allergologia ed Immunologia Clinica” dell’Univesità<br />
di Pavia.<br />
Attività Editoriale<br />
Co-Editor “Monaldi Archives for Chest Disease”.<br />
Membro dell’Editorial Board di “Respiratory Medicine”.<br />
Responsabile di Sezione Scientifica di “Rassegna di<br />
Patologia dell’Apparato Respiratorio”.<br />
Esperto della valutazione degli Eventi formativi nell’ambito<br />
del “Programma di Educazione Medica Continua in<br />
Medicina (ECM)”.<br />
Revisore delle seguenti riviste:<br />
– Allergy.<br />
– European Respiratory Journal.<br />
– Pulmonary Pharmacology & Therapeutics.<br />
– Respiration.<br />
– Respiratory Medicine.<br />
– The American Journal Respiratory and Critical Care<br />
Medicine.<br />
Attività Scientifica e Campi di Ricerca<br />
Flogosi ed iperreattività delle patologie ostruttive delle vie<br />
aeree.<br />
Riabilitazione Malattie dell’Apparato Respiratorio.<br />
Farmacologia Clinica.<br />
Società Scientifiche<br />
ERS (European Respiratory Society).<br />
AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri).<br />
SIMeR (Società Italiana Medicina Respiratoria).<br />
American College and Chest Disease.<br />
Membership<br />
Coordinatore per le Attività relative all’Asma Bronchiale dell’Organizzazione<br />
Mondiale della Sanità (WHO) - “WHO Collaborating<br />
Centre for Control of Tuberculosis and Lung<br />
Diseases in Europe”.<br />
Segreterio del Gruppo di Studio ERS “Airway pharmacology<br />
and treatment”.<br />
Componente della Commissione Scientifica della <strong>Fondazione</strong><br />
Pneumologia UIP-ONLUS.<br />
Attività di Aggiornamento Professionale<br />
Stage all’estero - 1994-1995, Research Fellow, Respiratory<br />
Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK.<br />
Partecipazione a Congressi - Partecipazione, in qualità di<br />
Relatore e/o Responsabile Scientifico, a numerosi Corsi di<br />
Aggiornamento e Convegni Scientifici Pneumologici sia a<br />
carattere nazionale che internazionale.<br />
Numerose Pubblicazioni su Riviste recensite nazionali<br />
ed internazionali<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
4. CENTRO DI MEDICINA DEL SONNO<br />
AD INDIRIZZO CARDIO-RESPIRATORIO<br />
Istituto Scientifico di Riabilitazione di Pavia<br />
e Montescano<br />
Tel. 0385.2471<br />
e-mail: francesco.fanfulla@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Francesco Fanfulla<br />
lI Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo cardio-respiratorio<br />
svolge attività clinica e attività di ricerca nel campo dei<br />
disturbi respiratori primitivi durante il sonno, della funzione<br />
respiratoria durante il sonno in corso di altre patologie respiratorie<br />
o sistemiche, principalmente cardiache, neurologiche e<br />
neuromuscolari, e nel campo della ventilazione meccanica<br />
non invasiva. Il Laboratorio attualmente è centro di riferimento<br />
nazionale per i disturbi respiratori durante il sonno. L’attività<br />
del Centro di medicina del sonno viene svolta nei due laboratori<br />
di Polisonnografia afferenti rispettivamente all’Istituto<br />
Scientifico di Pavia e Montescano.<br />
Aree di Attività dell’Unità Operativa<br />
Ambulatorio sui disturbi respiratori durante il sonno.<br />
Attività diagnostica sui disturbi respiratori durante il<br />
sonno.<br />
Valutazione funzionale respiratoria su pazienti affetti da<br />
obesità di vario grado.<br />
Valutazione funzionale respiratoria su pazienti affetti da<br />
patologie neurologiche e neuromuscolari.<br />
Valutazione funzionale respiratoria su pazienti affetti da<br />
scompenso cardiaco cronico.<br />
Impostazione terapia ventilatoria non-invasiva su pazienti<br />
affetti da disturbi respiratori durante il sonno, ipoventilazione<br />
alveolare durante il sonno da varie cause, insufficienza<br />
respiratoria cronica ipercapnica.<br />
Attività Clinica<br />
L’attività clinica è svolta quotidianamente presso il laboratorio<br />
di polisonnografia e presso un ambulatorio dedicato. Al<br />
Centro di Medicina del sonno afferiscono pazienti ambulatoriali<br />
o degenti presso gli Istituti Scientifici di Pavia e Montescano.<br />
I pazienti vengono sottoposti ad una valutazione clinica,<br />
ad una completa valutazione respiratoria durante il<br />
sonno con indagini polisonnografiche di varia complessità,<br />
alla registrazione dello stato di vigilanza/sonnolenza diurna<br />
(ove necessario) e, successivamente alla impostazione della<br />
strategia terapeutica più opportuna.<br />
L’iter diagnostico può completarsi con altre indagini funzionali,<br />
quali valutazione psicologica e neuropsicologica, valutazione<br />
metabolico-nutrizionale, studio della collassabilità delle<br />
vie aeree superiori, test di reattività dei centri respiratori allo<br />
stimolo ipossico o ipercapnico, indagini neurofisiologiche o<br />
cardiologiche.<br />
Lo schema terapeutico, sempre individualizzato, prevede il ricorso<br />
alle seguente opzioni, spesso in combinazione:<br />
Terapia comportamentale con particolare riferimento all’igiene<br />
del sonno e al comportamento alimentare.<br />
Terapia posizionale.<br />
Terapia con protesi endo-orali.<br />
Terapia ventilatoria meccanica non invasiva nelle varie<br />
modalità (CPAP, PSV, PCV, AVAPS, ASV), eventualmente<br />
associata a concomitante O2-terapia. La titolazione dei<br />
parametri di ventilazione viene effettuata durante il sonno<br />
del paziente mediante indagine polisonnografica completa<br />
notturna.<br />
Terapia riabilitativa.<br />
L’efficacia della terapia viene verificata sia durante il ricovero<br />
ospedaliero che successivamente mediante un appropriato ed<br />
individualizzato protocollo di follow-up, anche in modalità telematica.<br />
Gli outcome di efficacia sono: la compliance alla terapia<br />
dei disturbi respiratori durante il sonno, la risoluzione<br />
degli eventi patologici durante il sonno, la risoluzione della<br />
sintomatologia soggettiva (in particolare la sonnolenza<br />
diurna), la riduzione del peso corporeo, il mantenimento di<br />
una adeguata attività fisica giornaliera ed, infine, la riduzione<br />
dei fattori di rischio.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca del Centro di Medicina del sonno è orientata<br />
verso i seguenti settori:<br />
I disturbi respiratori durante il sonno come nuovo fattore<br />
determinante per lo sviluppo di insufficienza respiratoria o<br />
alterazioni del sistema cardiovascolare: progetto europeo<br />
COST B26.<br />
Analisi discriminante dei fattori responsabili delle alterazioni<br />
dello scambio gassoso nei pazienti affetti da sindrome<br />
delle apnee durante il sonno.<br />
L’interazione paziente/ventilatore meccanico durante il sonno.<br />
Definizione di nuovi protocolli riabilitativi domiciliare da<br />
affiancare al percorso iniziato durante la degenza ospedaliera<br />
per i pazienti affetti da disturbi respiratori durante il<br />
sonno e obesità severa: il controllo telematico dei risultati<br />
e dall’aderenza al trattamento.<br />
I meccanismi fisiopatologici delle alterazioni ventilatorie<br />
durante il sonno in corso di scompenso cardiaco cronico.<br />
Le alterazioni dell’attività fonatoria nei pazienti affetti da<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 85<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
malattie neuromuscolari dell’età evolutiva: marker precoce<br />
di alterazione della funzione respiratoria?<br />
Nuove misure del grado di sonnolenza diurna.<br />
Pubblicazioni<br />
S Nava, C Gregoretti, F Fanfulla, E Squadrone, M Grassi, A<br />
Carlucci, F Beltrame, and P Navalesi. Noninvasive ventilation<br />
to prevent respiratory failure after extubation in highrisk<br />
patients. Crit Care Med 2005; 33: 2465-70.<br />
P Ceriana, A Carlucci, P Navalesi, G Prinianakis, F Fanfulla,<br />
M Delmastro, S Nava. Physiological responses during a<br />
T-piece weaning trial with a deflated tube. Intensive Care<br />
Med 2006; 32: 1399-403.<br />
C Zocchi, A Rovetta, F Fanfulla. Physiological Parameters<br />
Variation During Driving Simulations. International Journal<br />
of Mechanics and Control (JoMaC) 2006; 7: 21-28. ISSN:<br />
1590-8844.<br />
F Fanfulla, A E Taurino, N D’Artavilla Lupo, R Trentin, C<br />
D’Ambrosio, S Nava. Effect of sleep on patient/ventilator<br />
asynchrony in patients undergoing chronic non-invasive<br />
mechanical ventilation. Respiratory Medicine 2007 Aug;<br />
101 (8): 1702-7.<br />
Q Mulqueeny, P Ceriana, A Carlucci, F Fanfulla, M Delmastro,<br />
Nava S. Automatic detection of ineffective triggering<br />
and double triggering during mechanical ventilation. Intensive<br />
Care Med 2007 Jul 5; [Epub ahead of print].<br />
MT La Rovere, GD Pinna, R Maestri, E Robbi, A Mortara, F<br />
Fanfulla, O Febo, P Sleight. Clinical relevance of shortterm<br />
day-time breathing disorders in chronic heart failure<br />
patients. Eur J Heart Fail 2007; 9: 949-54.<br />
A Alonderis, F Barbe, M Bonsignore, P Calverley, W De<br />
Backer, K Diefenbach, V Donic, F Fanfulla, I Fietze, K<br />
Franklin, L Grote, J Hedner, P Jennum, J Krieger, P Levy, W<br />
McNicholas, J Montserrat, G Parati, M Pascu, T Penzel, R<br />
Riha, D Rodenstein, A Sanna, R Schulz, E Sforza, P<br />
Sliwinski, Z Tomori, P Tonnesen, G Varoneckas, J Zielinski,<br />
K Kostelidou; COST Action B-26. Medico-legal implications<br />
of sleep apnoea syndrome: Driving license regulations<br />
in Europe. Sleep Med 2007 Aug 30; [Epub ahead of<br />
print].<br />
F Olmetti, MT La Rovere, E Robbi, AE Taurino, F Fanfulla.<br />
Nocturnal cardiac arrhythmia in patients with obstructive<br />
sleep apnea. Sleep Medicine in press.<br />
F Fanfulla, M Grassi, AE Taurino, L D’Artavilla, R Trentin.<br />
The relationship of daytime hypoxemia and nocturnal hypoxia<br />
in obstructive sleep apnea syndrome. Sleep in press.<br />
A Pierobon, A Giardini, S Callegari, G Majani, F Fanfulla.<br />
Why a multidimensional assessment of obese patients<br />
with obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS): a study<br />
of psychological, neuropsychological and clinical relationships<br />
in a disabling multifaceted disease. Sleep Medicine<br />
(in press).<br />
Attività Educazionale<br />
L’attività educazione del Centro di Medicina del Sonno ha lo<br />
scopo di diffondere la cultura sulle malattie respiratorie durante<br />
il sonno. Questa attività viene svolta con la pubblicazione<br />
di documenti derivanti dall’attività di specifiche Task<br />
Force nominate dalle Società Scientifiche di riferimento (European<br />
Respiratory Society, Associazione Italiana Pneumologi<br />
86<br />
Ospedalieri, Associazione Italiana di Medicina del Sonno) che<br />
con l’organizzazione diretta di interi congressi o di specifiche<br />
sessioni. Il centro di Medicina del Sonno è stato riconosciuto<br />
dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno come centro<br />
di riferimento nazionale per il training degli aspiranti Medici<br />
esperti in medicina del sonno.<br />
Il Centro accoglie ogni anno tesisti, specializzandi, giovani ricercatori<br />
o aspiranti esperti in medicina del sonno, provenienti<br />
da diverse regioni italiane o dall’estero, per perfezionare la<br />
loro formazione sulle alterazioni respiratorie durante il sonno.<br />
Una specifica attività educazione è rivolta ai pazienti afferenti<br />
al centro, volta alla migliore comprensione della patologia,<br />
della strategia terapeutica e del mantenimento dei presidi<br />
ventilatori prescritti.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Francesco Fanfulla è nato a Vibo Valentia<br />
il 30 Luglio 1963.<br />
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia<br />
110/110 con Lode - Università di Pavia nel<br />
1988. Tesi sperimentale dal titolo “Valutazione<br />
della funzionalità respiratoria in veglia<br />
e durante sonno notturno in pazienti<br />
affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne”.<br />
1992 - Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie<br />
dell’Apparato Respiratorio, 50/50 con Lode - Università di<br />
Pavia.<br />
Assegnatario di un contratto di ricerca per lo “Studio della<br />
funzione respiratoria in veglia e durante sonno notturno in<br />
pazienti affetti da malattie neuromuscolari: valutazione dell’efficacia<br />
della terapia con protesi ventilatorie a pressione<br />
positiva intermittente con maschera nasale”.<br />
Gennaio 1995 - Luglio 2007 - Dirigente medico presso la Divisione<br />
di Pneumologia dell’Istituto Scientifico di Montescano.<br />
Luglio 2007 - Dirigente Medico con presso la Divisione di<br />
Pneumologia dell’Istituto Scientifico di Pavia. Attualmente è<br />
responsabile del Centro di Medicina del sonno ad indirizzo<br />
cardio-respiratorio organizzato nei due laboratori di polisonnografia<br />
afferenti agli Istituti Scientifici di Montescano e Pavia.<br />
1989 - Vincitore del Concorso Nazionale “Premio Littman”<br />
per la proposta di ricerca “Impiego dei supporti ventilatori a<br />
pressione negativa e positiva nei pazienti affetti da BPCO in<br />
corso di insufficienza respiratoria riacutizzata”.<br />
Componente del gruppo di Pavia dell’indagine europea “EC<br />
Respiratory Health Survey” sullo studio dell’asma bronchiale.<br />
Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Pavia<br />
per la valutazione dell’efficacia degli apparecchi di ventilazione<br />
meccanica domiciliare nei pazienti affetti da Distrofia<br />
Muscolare di Duchenne e da Atrofia Muscolo Spinale di<br />
tipo II.<br />
Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Pavia<br />
nell’ambito del sottoprogetto SP2 “Ambiente e Salute” del<br />
progetto finalizzato FATMA del Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche.<br />
Co-responsabile del progetto di ricerca TELETHON 1125C.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Membro del gruppo di ricerca COST ACTION B-26 della Comunità<br />
Europea sulla Sindrome delle Apnee durante il<br />
sonno.<br />
Membro dal 1993 della European Respiratory Society all’interno<br />
della quale è membro dell’assemblea di Fisiologia Clinica<br />
(indirizzo Disturbi respiratori durante sonno notturno e<br />
ventilazione non invasiva).<br />
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Coordinatore<br />
del gruppo di studio su “Disturbi respiratori durante sonno<br />
notturno”; membro del gruppo di studio di “Fisiopatologia<br />
Respiratoria” della stessa associazione. Membro della commissione<br />
didattica e docente del Corso nazionale “Disturbi<br />
Respiratori durante il sonno” sin dalla sua prima edizione.<br />
Docente all’interno dei Corsi di Aggiornamento e Formazione<br />
nell’ambito della Fisiopatologia Respiratoria e della<br />
Terapia Intensiva Respiratoria.<br />
Membro dell’Associazione Italiana di Medicina del sonno<br />
(AIMS) all’interno della quale svolge il ruolo di commissario<br />
di esame per il riconoscimento di “Medico Esperto in Medicina<br />
del Sonno”. Docente del corso residenziale di Bertinoro<br />
(corso generale ed ORL) dal 2000 ad oggi. Co-presidente<br />
del XIV Congresso Nazionale (2004).<br />
Revisore ad invito di European Respiratory Medicine, Intensive<br />
Care, Sleep Medicine, International Journal of Cardiology,<br />
Sleep Medicine Review, Monaldi Archives of Chest Diseases,<br />
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio.<br />
Autore di 14 capitoli di libri editi a stampa di interesse<br />
pneumologico, di 47 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali<br />
indicizzate, di 19 pubblicazioni su riviste scientifiche<br />
nazionali, di 17 atti di congresso nazionali-internazionali,<br />
e di oltre 200 comunicazioni scientifiche a congressi<br />
nazionali ed internazionali.<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
5. LABORATORIO DI<br />
CITO-IMMUNOPATOLOGIA<br />
DELL’APPARATO CARDIO-RESPIRATORIO<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: armando.capelli@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Armando Capelli<br />
Laboratorio di ricerca e diagnostica delle patologie dell’apparato<br />
cardio-respiratorio, in attività da circa 20 anni, inizialmente<br />
si è occupato di patologie dell’apparato respiratorio allargando<br />
gli interessi, negli ultimi 3 anni alle patologie cardiovascolari<br />
ed in particolare allo scompenso cardiaco cronico. Il<br />
laboratorio utilizza principalmente due metodiche di prelievo<br />
di materiale biologico: lavaggio broncoalveolare e biopsie<br />
bronchiali; recentemente ha iniziato a trattare anche porzioni<br />
di tessuto cardiaco prelevato da cuori espiantati; dal 2007 il laboratorio<br />
ha avviato la raccolta di campioni di esalato condensato<br />
e broncoaspirato per lo svolgimento di progetti di ricerca.<br />
Sempre nel 2007 il laboratorio è stato attrezzato per<br />
l’effettuazione di ricerche mediante colture cellulari attualmente<br />
in fase di messa a punto.<br />
Il Laboratorio di cito-immunopatologia dell’apparato cardiorespiratorio<br />
è costituito da tre locali adibiti a laboratorio (laboratorio<br />
di lavaggio broncoalveolare ed immunoistochimica,<br />
laboratorio di colture cellulari, laboratorio di microscopia e lettura<br />
dei preparati) dove svolgono la loro attività a tempo parziale<br />
ed in qualità di esperti, due medici (Dr. Bruno Balbi e Dr.<br />
Capelli Armando) ed un biologo (Dr. Di Stefano Antonino), a<br />
tempo determinato un biologo borsista (Dr. Carbone Marco)<br />
ed una laurenda in Biologia (Dr.ssa Chiara Vicari) ed a tempo<br />
pieno una tecnica di laboratorio (Sig.ra Gnemmi Isabella).<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività di ricerca del Laboratorio si occupa principalmente di<br />
patologie dell’apparato respiratorio: le broncopneumopatie<br />
croniche ostruttive, l’insufficienza respiratoria cronica e le interstiziopatie<br />
polmonari, e di patologia cardio-vascolare:<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 87<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
scompenso cardiaco cronico. In particolare vengono approfonditi<br />
aspetti patogenetici ed evolutivi di questi gruppi di<br />
malattie utilizzando tecniche di citologia, istologia, immunocitochimica,<br />
immunoistochimica, ELISA, biologia molecolare<br />
(western blot, dosaggio del mRNA) e di colture cellulari (in<br />
fase di avvio).<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Per quanto concerne i progetti di ricerca di segnalano i seguenti:<br />
Alterazioni infiammatorie, meccanismi patogenetici ed<br />
evolutivi della fibrosi polmonare idiopatica, della sarcoidosi<br />
polmonare.<br />
Alterazioni infiammatorie, meccanismi patogenetici ed<br />
evolutivi delle broncopneumopatie croniche ostruttive e<br />
dell’insufficienza respiratoria cronica (in collaborazione<br />
con Heart and Lung Institute del Brompton Hospital di<br />
Londra, Centro Ricerche su Asma e BPCO dell’Università<br />
di Ferrara, Cattedra di Malattie dell’Apparato respiratorio<br />
dell’Università di Torino).<br />
Studio di pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica<br />
portatori di tracheostomia mediante prelievo di esalato<br />
condensato, broncoaspirato e siero al fine di valutare<br />
le interazioni tra fattori dell’infiammazione e colonizzazione<br />
batterica. (in collaborazione con Servizio di Allergologia<br />
ed Immunologia Clinica dell’Istituto Scientifico di<br />
Pavia e con ISPEL e Medicina del Lavoro dell’Università di<br />
Parma).<br />
Alterazioni infiammatorie, stress nitrosattivo, meccanismi<br />
patogenetici ed evolutivi nello scompenso cardiaco cronico<br />
(CHF) (in collaborazione con l’Istituto di Anatomia<br />
Umana dell’Università di Palermo).<br />
Ricerche in programmazione<br />
Isolamento e coltura di cellule mesenchimali di origine<br />
bronchiale o alveolare per studi sulla differenziazione.<br />
Coltura e studio di cellule endoteliali cardiache.<br />
Attività Educazionale<br />
Il laboratorio fin dai primi anni ha svolto anche un’attività educazionale,<br />
organizzando Corsi e Convegni e più recentemente<br />
Seminari all’interno dell’Istituto anche nell’ambito dell’Educazione<br />
Continua in Medicina per tutte le figure professionali<br />
sanitarie.<br />
Le metodiche applicate nel laboratorio non sono rivolte solo<br />
alla ricerca scientifica ma esiste un’attività traslazionale infatti<br />
il lavaggio broncoalveolare è utilizzato nella diagnostica routinaria<br />
della Divisione per lo studio delle pneumopatie interstiziali<br />
(Sarcoidosi, Fibrosi Polmonare, Alveolite allergica estrinseca,<br />
Pneumoconiosi ecc.) e degli addensamenti polmonari di<br />
n.d.d. (forme infettive, bronchioliti, neoplasie ecc.). Lo studio<br />
della flogosi nelle biopsie bronchiali viene utilizzato nella diagnostica<br />
differenziale delle tossi di n.d.d. e nelle forme sovrapposte<br />
dubbie tra bronchite cronica ostruttiva ed asma<br />
bronchiale.<br />
Il laboratorio inoltre è punto di riferimento per le strutture<br />
ospedaliere della zona per la metodica del lavaggio broncoalveolare<br />
applicato alla diagnostica.<br />
88<br />
Pubblicazioni<br />
A. Capelli, C.F. Donner. I fluorchinoloni nel trattamento<br />
delle riacutizzazioni di bronchite cronica: la plurifloxacina.<br />
Multidisciplinary Respiratory Medicine 2006; Suppl 1: 3-16.<br />
F.L.M. Ricciardolo, A. Di Stefano, F. Sabatini, G. Folkerts.<br />
Reactive nitrogen species in the respiratory tract. European<br />
Journal of Pharmacology 2006; 533: 240-252.<br />
G. Caramori, K. Ito, M. Contoli, A. Di Stefano, S.L. Johnston,<br />
I.M. Adcock, A. Papi. Molecular Mechanisms of Respiratory<br />
Virus-Induced Asthma and COPD Exacerbations and<br />
Pneumonia. Current Medicinal Chemistry 2006; 13: 2267-<br />
2290.<br />
F. Cappello, A. Di Stefano, S. David, F. Rappa, S.E. D’Anna,<br />
F. Magno, C. F. Donner, G. Zummo. Hsp60 and Hsp10<br />
downregulation predicts bronchial epithelial carcinogenesis.<br />
Eur Respir J. September 2006; 28, Suppl. 50: 191s.<br />
F. Magno, G. Sivverini, I. Gnemmi, A. Capelli, S.E. D’Anna,<br />
F. Cappello, P. Balbo, P. Brun, C.F. Donner, F.L.M. Ricciardolo,<br />
A. Di Stefano. Epithelial overexpression of interleukin-8<br />
in bronchial biopsies from patients with COPD.<br />
Eur Respir J. September 2006; 28, Suppl. 50: 673s.<br />
F. Sabatini, F. Luppi, A. Di Stefano, A. Van Schadewijk, P.S.<br />
Hiemstra, P.J. Sterk, L.M. Fabbri, G.A. Rossi, F.L.M. Ricciardolo.<br />
Expression and activity of bradykinin B2 receptor<br />
(B2R) in human airway fibroblast (HAFbs): a role in<br />
asthma remodeling. Eur Respir J. September 2006; 28,<br />
Suppl. 50: 748s.<br />
F. Cappello, A. Di Stefano, S. David, F. Rappa, R. Anzalone,<br />
G. La Rocca, S.E. D’Anna, F. Magno, C.F. Donner, B. Balbi,<br />
G. Zummo. Hsp60 and Hsp10 downregulation predicts<br />
bronchial epithelial carcinogenesis in smokers with COPD.<br />
Cancer 2006; 107 (10): 1217-24.<br />
M. Silvestri, M. Bontempelli, M. Giacomelli, M. Malerba,<br />
G.A. Rossi, A. Di Stefano, A. Rossi, F.L.M. Ricciardolo. High<br />
serum levels of tumour necrosis factor-a and interleukin-<br />
8 in severe asthma: markers of systemic inflammation?<br />
Clin Exp Allergy 2006; 36: 1373-81.<br />
O. Capelli, A. Capelli, G. Formoso, N. Magrini. Two Major<br />
Bias in this Study. Annals of Internal Medicine 2006; www.<br />
annals. org/cgi/eletters/143/5/317.<br />
Leonardi, P. Brun, A. Di Stefano, L. Motterle, G. Abatangelo.<br />
Matrix metalloprotease in vernal Keratoconjunctivitis,<br />
nasal polyps and allergic asthma. Clin and Exp Allergy<br />
2007; 37: 872-879.<br />
A. Di Stefano, F. Magno, I. Gnemmi, M. Carbone, F. Sabatini,<br />
G. A. Rossi, C. Usai, P. Brun, A. Capelli, S.E. D’Anna,<br />
F.L.M. Ricciardolo, B. Balbi. Increased neutrophil adhesion<br />
in bronchial biopsies from patients with severe COPD. Eur<br />
Respir J. September 2007; 30, Suppl. 51, 136s.<br />
A. Di Stefano, I. Gemmi, M. Carbone, E. Eleuteri, A. Capelli,<br />
F.L.M. Ricciardolo, M. Colombo, P. Giannuzzi, B. Balbi. Similarities<br />
and discrepancies in oxidative and nitrosative<br />
stress in severe COPD and post-infarction chronic heart<br />
failure. Eur Respir J. September 2007; 30, Suppl. 51, 137s.<br />
F. Sabatini, I. Gnemmi, V. De Rose, G.A. Rossi, B. Balbi, A.<br />
Di Stefano, F. L. M. Ricciardolo. Expression of bradykinin<br />
B2 receptor (B2R) and vascular endothelial growth factor<br />
(VEGF) in asthma and COPD. Eur Respir J. September<br />
2007; 30, Suppl. 51: 138s.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Armando Capelli è nato a Teramo il 25<br />
settembre 1960.<br />
1979 - Maturità professionale con la votazione<br />
di 60/60.<br />
26 Luglio 1985 - Laurea in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università di Modena con la<br />
votazione di 110/110 con lode.<br />
Ha poi conseguito il diploma di abilitazione alla professione di<br />
Medico-Chirurgo con la votazione di 85/90.<br />
20 Giugno 1989 - Diploma di Specializzazione in Tisiologia e<br />
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università di Modena<br />
con il punteggio di 50/50 con lode.<br />
Dal 1982 al 1985 allievo interno dell’Istituto di Tisiologia e Malattie<br />
dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Modena.<br />
Nell’aprile del 1986 è stato chiamato, in qualità di borsista,<br />
presso la Divisione di Pneumologia del Centro Medico di Riabilitazione<br />
di Veruno della <strong>Fondazione</strong> Clinica del Lavoro, oggi<br />
“<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>” di Pavia I.R.C.C.S., per collaborare alla<br />
creazione ed allo sviluppo del laboratorio di Cito-immunopatologia<br />
e biochimica dell’Apparato Respiratorio.<br />
Il 1 Aprile 1987 è stato incaricato a contratto annuale come<br />
Assistente a tempo pieno e dal 1 Luglio 1988 a tempo indeterminato<br />
presso la stessa struttura ospedaliera.<br />
Dal Gennaio del 1993 ha ricevuto l’incarico a tempo indeterminato<br />
di Aiuto della stessa Divisione di Pneumologia.<br />
Dal 2001 Dirigente Medico, ha assunto il ruolo di Medico con<br />
incarichi professionali ad alta specializzazione che tuttora ricopre.<br />
Oltre alla ricerca scientifica, il Dr. Capelli si occupa di endoscopia<br />
respiratoria, assistenza ai malati, ambulatori specialistici<br />
di Pneumologia e di sostituzione di cannule tracheostomiche.<br />
Attività Scientifica<br />
Nel periodo gennaio 1984 - aprile 1986 presso l’Istituto di Tisiologia<br />
e Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di<br />
Modena si è attivamente occupato di vari aspetti della Tisiopneumologia<br />
ed in particolare ha collaborato allo sviluppo<br />
delle ricerche sul lavaggio bronco-alveolare. In particolare<br />
sulle interstiziopatie e sulle pneumopatie da lavoro.<br />
A partire dall’aprile 1986 ad oggi presso la Divisione di Pneumologia<br />
del Centro Medico di Riabilitazione di Veruno ha proseguito<br />
gli studi della patologia pneumoconiotica e delle altre<br />
interstiziopatie allargando gli interessi anche verso le broncopneumopatie<br />
croniche ostruttive sempre mediante metodica<br />
del lavaggio bronco-alveolare e contemporaneamente ha iniziato<br />
valutazioni biochimiche ed immunologiche anche sulle<br />
secrezioni bronchiali.<br />
Attualmente partecipa attivamente ai seguenti filoni di ricerca:<br />
fattori patogenetici e markers di evoluzione fibrosante nelle<br />
interstiziopatie polmonari con particolare riguardo alla fibrosi<br />
polmonare ed alla sarcoidosi;<br />
indici biologici sistemici e locali di progressione del danno<br />
funzionale nelle BPCO;<br />
studi di struttura-funzione della mucosa bronchiale nella<br />
patogenesi della bronchite cronica e nell’asma bronchiale:<br />
interazioni tra infiammazione e colonizzazione batterica nell’insufficienza<br />
respiratoria cronica di portatori di protesi tracheale.<br />
Tale attività di ricerca ha portato il Dr. Capelli alla produzione<br />
di oltre 230 pubblicazioni scientifiche (delle quali oltre 80<br />
peer-reviewed) su riviste nazionali ed internazionali; alla partecipazione<br />
a numerosi congressi sia nazionali che internazionali<br />
anche in qualità di relatore.<br />
Infine è componente dell’Editorial Advisory Board della Rivista<br />
Internazionale Current Respiratory Medicine Reviews.<br />
Revisore su invito di Riviste Nazionali ed Internazionali: Rassegna<br />
di Patologia dell’Apparato Respiratorio, Monaldi Archives<br />
for Chest Disease, European Respiratory Journal, Respiration,<br />
Lung, Sarcoidosis, Chest, Current Respiratory Medicine<br />
Reviews, Experimental Lung Researches.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 89<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
6. LABORATORIO DELLO STUDIO<br />
E TRATTAMENTO DELLA<br />
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA<br />
Istituto Scientifico di Lumezzane<br />
Via Mazzini, 129<br />
Tel 030.8253168<br />
e-mail: michele.vitacca@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Michele Vitacca<br />
Il laboratorio dello “studio e trattamento della Insufficienza respiratoria”<br />
è inserito all’interno della Divisione di Pneumologia<br />
Riabilitativa della <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong> di Gussago/Lumezzane<br />
opera sul territorio bresciano da più di 20 anni. La divisione<br />
di Pneumologia consta di 30 letti + 3 letti di day hospital<br />
con all’interno una struttura di 4 letti di degenza intensiva di<br />
livello intermedio (post-intensiva respiratoria).<br />
Attività di Ricerca<br />
Scopo del laboratorio è quello di orientare la ricerca verso un approccio<br />
interdisciplinare di valutazione, trattamento e assistenza<br />
del paziente con insufficienza respiratoria acuta e cronica.<br />
Il nostro laboratorio è concentrato nelle attività clinico/scientifica<br />
come di seguito:<br />
IRA in ambito intensivologico<br />
Tecniche e protocolli per prolungati e difficoltosi svezzamenti<br />
dalla protesi meccanica di pazienti con patologia<br />
cronica o pazienti post-chirurgici.<br />
Trattamento della insufficienza respiratoria cronica riacutizzata<br />
tramite la ventilazione meccanica non invasiva.<br />
Ricerca orientata nei programmi di riallenamento allo<br />
sforzo con utilizzo di programmi di FKT in ambito intensivologico.<br />
Attività di ricerca orientata, con forte valenza applicativa,<br />
allo studio di nuove metodiche di ventilazione a supporto<br />
parziale, allo studio della qualità del sonno dei pazienti in<br />
terapia intensiva e alla fattibilità del trattamento con ven-<br />
90<br />
tilazione non-invasiva vs terapia medica, tradizionalmente<br />
impiegata nell’Insufficienza Respiratoria Acuta.<br />
IRC in ambito ospedaliero<br />
Inquadramento dei pattern fisiopatologici specifici delle<br />
diverse cause di insufficienza respiratoria cronica (IRC).<br />
Inquadramento di metodiche per la corretta diagnosi e<br />
monitoraggio della IRC.<br />
Sviluppo di un approccio al trattamento fisioterapico nelle<br />
malattie con IRC.<br />
Utilizzo di nuove modalità di riallenamento allo sforzo nel<br />
paziente severo con IRC.<br />
Utilizzo di scale di triage riabilitativo nel paziente severo<br />
con IRC.<br />
Misura e monitoraggio dei muscoli respiratori a riposo e<br />
sotto sforzo.<br />
Ricerca orientata alla valutazione degli “outcomes” in riabilitazione<br />
del paziente con IRC.<br />
IRC in ambito domiciliare<br />
Sviluppo di sistemi di follow up della IRC.<br />
Programmi di telemedicina e telecontrollo per pazienti con<br />
IRC.<br />
Programmi di riabilitazione domiciliare telesorvegliati.<br />
sviluppo dell’attività educazionale e self management del<br />
paziente con IRC.<br />
Misura e monitoraggio delle attività della vita quotidiana<br />
nel paziente severo con IRC.<br />
Profili di assistenza domiciliare di pazienti con patologia<br />
cronica.<br />
Ricerca orientata alla organizzazione di programmi di assistenza<br />
domiciliare (utilizzo domiciliare di una protesi<br />
meccanica non invasiva).<br />
Ricerca orientata alla identificazione di metodiche funzionali<br />
e di score clinico, per l’identificazione di pazienti da<br />
sottoporre ad esame polisonnografico.<br />
IRC nelle malattie non respiratorie<br />
Monitoraggio delle implicazioni respiratorie delle malattie<br />
neuromuscolari.<br />
Monitoraggio della funzione respiratoria nello scompenso<br />
cardiaco cronico.<br />
Ricerca orientata al trattamento di pazienti e familiari che<br />
devono convivere con patologie del motoneurone (SLA).<br />
Il laboratorio è inserito in rapporti di collaborazione scientifica<br />
con Università italiane,<br />
Centri del CNR, Istituto Superiore di Sanità, Rete AIPO di Terapia<br />
Intensiva Respiratoria,<br />
Rete AIPO Riabilitazione Respiratoria.<br />
Attività Educazionale<br />
Diffusione delle conoscenze sulla IRC.<br />
Partecipazione in qualità di docenti a corsi e convegni per<br />
medici e personale non medico.<br />
Realizzazione di position paper dedicate alla IRC nelle malattie<br />
neuromuscolari.<br />
Realizzazione di numerose tesi di laurea in Medicina e<br />
Chirurgia e Fisioterapia.<br />
Realizzazione di capitoli di libri in lingua inglese e italiana.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Il laboratorio collabora con:<br />
La divisione di Pneumologia dell’ospedale Bellvitge di Barcelona.<br />
La divisione di Pneumologia Ospedale di Oporto.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Valutazione della qualità degli ultimi mesi di vita nei pazienti<br />
ventilati al domicilio Valutazione variazioni epidemiologica<br />
malati ammessi in un centro di svezzamento<br />
UTIR.<br />
Valutazione della efficacia di nuovi sistemi per il drenaggio<br />
delle secrezioni.<br />
Valutazione della funzionalità respiratoria nelle malattie<br />
neuromuscolari.<br />
Relazione tra disfagia e riduzione della tosse.<br />
Utilizzo della telesorveglianza nella malattia del motoneurone.<br />
Utilizzo di programmi riabilitativi domiciliai nella malattia<br />
del motoneurone.<br />
Valutazione attività fisica domiciliare dei pazienti severi<br />
con IRC.<br />
Utilizzo di nuove metodiche di allenamento degli arti superiori<br />
in pazienti con IRC.<br />
Pubblicazioni<br />
M. Paneroni, M. Sarvà, M. Vitacca. Case study: treatment<br />
protocol for prolonged weaning. RT The Journal for Respiratory<br />
Care practioners; may 2004: 26-27.<br />
M. Vitacca, B. Lanini, S. Nava, L.Barbano, R. Porta, E. Clini,<br />
N. Ambrosino. Inspiratory muscle workload due to dynamic<br />
intrisic PEEP in stable COPD patients: Effects of two<br />
different settings of non-invasive pressure-support ventilation.<br />
Monaldi Arch Chest Dis 2004; 61: 2.<br />
M. Vitacca, L. Bianchi, E. Zanotti, A. Vianello, M. Zigliani,<br />
L. Barbano, R. Porta, E. Clini. Assessment of physiological<br />
variables and subjective comfort under different levels of<br />
pressure support ventilation. Chest 2004; 126: 851-859.<br />
João Carlos Winck, Michele Vitacca, Antle VitaccaWinck,<br />
ti, A. Vianello, M. Zigliani, L. Barbano, R. Porta, E. Clini. Assessment<br />
of physiological variables and subjective<br />
comfort under different levels of pressure support ventilation.<br />
Chest 2004; 126: 851-859. Monaldi Arch Chest Dis<br />
2004; 126: 774-780.<br />
S. Scalvini, M. Vitacca, L. Paletta, A. Giordano, B. Balbi. Telemedicine:<br />
a new frontier for effective healthcare services.<br />
Monaldi Arch Chest Dis 2004; 61: 4, 226-233.<br />
A. Corrado, N. Ambrosino, A. Cavalli, M. Gorini, P. Navalesi,<br />
M. Confalonieri, M. Vitacca, C. Mollica Sturani. Unità<br />
di terapia intensiva respiratoria: update. Rassegna di Patologia<br />
dell’Apparato Respiratorio 2004; 19: 18-34.<br />
M. Vitacca, G. Callegari, L. Barbano, A. Tramacere, E. Clini.<br />
Impatto sanitario aziendale e territoriale dopo riduzione di<br />
posti letto dedicati a difficoltoso svezzamento. Rassegna<br />
di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2004; 19: 141-147.<br />
M. Vitacca, M. Paneroni, D. Fiorenza, R. Porta, A. Micheli,<br />
S. Scolari, G. Galardi, N. Ambrosino, B. Balbi. Alterazioni<br />
neurofisiologiche in pazienti ammessi in una terapia in-<br />
tensiva intermedia respiratoria. Rassegna di Patologia dell’Apparato<br />
Respiratorio 2004; 19: 88-94.<br />
R. Porta, M. Vitacca, L. Sonia Gilè, E. Clini, L. Bianchi, E.<br />
Zanotti, L. Barbano, N. Ambrosino. Supported arm-training<br />
in patients recently weaned from mechanical ventilation.<br />
Chest 2005; 128: 2511–2520.<br />
M. Vitacca, G. Callegari, M. Sarvà, L. Bianchi, L. Barbano,<br />
B. Balbi, N. Ambrosino. Physiological effects of meal in difficult-to<br />
wean tracheotomised patients with chronic obstructive<br />
pulmonary disease. Intensive Care Medicine<br />
2005; 31: 236-242.<br />
Metodi e brevetti messi a punto<br />
Utilizzo di una carta del rischio (triage) del paziente con IRC<br />
da applicare telefonicamente a pazienti in telesorveglianza.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Michele Vitacca è nato a Napoli il<br />
26/01/1961, laureato in Medicina e Chirurgia<br />
presso l’Università degli studi di Brescia. Specialista<br />
in Anestesia e Rianimazione e Malattie<br />
Apparato Respiratorio. Dopo una breve<br />
attività lavorativa presso il II Servizio di Anestesia<br />
e Rianimazione degli Spedali Civili di<br />
Brescia, dal gennaio 1989 ad oggi lavora presso la Divisione<br />
di Pneumologia del centro di Riabilitazione Respiratoria di<br />
Gussago (BS) prima e Lumezzane ora (BS) della <strong>Fondazione</strong><br />
S. <strong>Maugeri</strong> IRCCS di Pavia.<br />
Dal 2006 a tutt’oggi è incaricato come responsabile dirigente<br />
livello II Divisione di Pneumologia e Terapia post intensiva polifunzionale.<br />
Docente presso il corso di Diploma Universitario di Fisioterapista<br />
e presso la Scuola di specialità di Anestesia e Rianimazione<br />
dell’Università degli studi di Brescia, presso il Master di<br />
Fisioterapia dell’Università degli studi di Trieste e di Milano.<br />
Membro della European Respiratory Society e Associazione<br />
Italiana Pneumologi Ospedalieri con esperienza di reviewer<br />
presso numerose riviste internazionali. Membro attivo nella<br />
commissione ventilazione domiciliare ASL Brescia.<br />
Ha tenuto e tiene seminari in Italia e all’estero partecipando<br />
come docente invitato a corsi di aggiornamento.<br />
Ha partecipato in qualità di relatore invitato a 110 Congressi<br />
Italiani e 40 Congressi Internazionali.<br />
Ha partecipato alla stesura di linee guida sullo svezzamento<br />
dalla ventilazione meccanica (2005) organizzate dalle società<br />
ATS, ASCCM, ERS, ESICM.<br />
Ha pubblicato più di 200 lavori dei quali 71 lavori originali (in<br />
stampa) su riviste indexate internazionali e di 8 capitoli di libri<br />
in lingua inglese.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 91<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
7. LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA<br />
CLINICA DELLE TUBERCOLOSI<br />
E DELLE MALATTIE RESPIRATORIE<br />
Istituto Scientifico di Tradate<br />
Via Roncaccio, 16<br />
Tel. 0331.829.111<br />
e-mail: giovannibattista.migliori@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Giovanni Battista Migliori<br />
L’attività scientifica del “Servizio di epidemiologia clinica<br />
delle Malattie Respiratorie” (impegnato in attività di assistenza<br />
tecnica ai paesi in via di sviluppo) è rivolta alla definizione<br />
di programmi di ricerca a valenza traslazionale, con l’obiettivo<br />
di trasferire i risultati della ricerca stessa all’attività di<br />
prevenzione, diagnosi e controllo della Tubercolosi e delle<br />
malattie respiratorie.<br />
Fulcro principale di tale attività è il Laboratorio di epidemiologia<br />
clinica delle Tubercolosi e delle Malattie Respiratorie.<br />
L’attività educazionale e formativa è imperniata sul WHO Collaborating<br />
Centre for TB and Lung Diseases che afferisce al<br />
medesimo laboratorio. Essa è focalizzata sulla formazione di<br />
esperti nel controllo della tubercolosi e dell’HIV/AIDS. Il laboratorio<br />
ha sviluppato l’unico corso pratico esistente a livello<br />
mondiale, organizzato in collaborazione con la World Health<br />
Organization. Dal 2001, 44 edizioni del corso sono state organizzate<br />
a Sondalo, in Africa (Addis Abeba, Ethiopia), in Russia<br />
(Mosca e San Pietroburgo) ed in Egitto (Cairo), con formazione<br />
di oltre 800 esperti proveniente dai Paesi prioritari dei 4<br />
continenti.<br />
Il laboratorio ha sviluppato, in collaborazione con la World<br />
Health Organization, il manuale in 3 volumi (R.A. Lopez, G.B.<br />
Migliori, P.Y. Norval, K. Bergstrom et al. Management of<br />
TB/HIV Collaborative activities: training for managers at the<br />
national and subnational levels. Manual for participants; Manual<br />
for facilitators and Manual for Course Directors. Geneva<br />
2006: WHO/HTM/TB/2005.359a – WHO/HIV/2005.10 a, b and c<br />
in Versione Inglese, Francese, Spagnola e Portoghese) che<br />
oggi costituisce il testo di base per la formazione degli opera-<br />
92<br />
tori a livello mondiale. Il laboratorio contribuisce inoltre alla<br />
formazione di esperti nel controllo di TB e HIV/AIDS in Italia.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività del Laboratorio di epidemiologia clinica delle Tubercolosi<br />
e delle Malattie Respiratorie si ispira, per continuità ed<br />
integrazione, a progetti di ricerca avviati fin dalla fine degli<br />
anni 80 in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e la<br />
Cooperazione allo sviluppo. Tale collaborazione aveva come<br />
obiettivo lo sviluppo e la valutazione di un programma di controllo<br />
di AIDS e tubercolosi nel Distretto di Arua, Uganda, attraverso<br />
il potenziamento del centro regionale antitubercolare,<br />
l’apertura di unità antitubercolari periferiche, la periferalizzazione<br />
pilota dei servizi sanitari, una campagna educazionale<br />
pilota per AIDS, tubercolosi e malattie prevenibili/vaccinabili e<br />
la creazione di modello pilota di sistema informativa. Si tratta<br />
della prima evidenza in letteratura di una collaborazione tra i<br />
2 programmi (Tubercolosi ed AIDS). Tale collaborazione è<br />
oggi parte integrante della strategia WHO. È stato inoltre eseguito<br />
uno studio (“baseline survey”) sull’accesso alle strutture<br />
sanitarie e all’acqua potabile. Tali attività hanno avuto valenza<br />
traslazionale, e sono state “esportate” a livello nazionale in<br />
Uganda. Il sistema sanitario Ugandese è riconosciuto attualmente<br />
come uno dei più efficienti di tutta l’Africa sub-Sahariana.<br />
Successivamente, nei primi anni 90 è stata avviata l’attività<br />
di ricerca nei due Paesi prioritari dell’Europa Orientale<br />
(in termini di incidenza di casi di Tubercolosi e numero di<br />
casi), Russia e Romania. Il laboratorio ha coordinato l’implementazione<br />
della strategia di controllo della World Health Organization<br />
in Russia ed in Romania. In entrambi i Paesi sono<br />
stati eseguite valutazione economica dell’impatto della nuova<br />
strategia DOTS in confronto con l’approccio tradizionale, è<br />
stata avviata la valutazione dei risultati del trattamento e lo<br />
studio della prevalenza di resistenze ai farmaci antitubercolari.<br />
Il Laboratorio ha successivamente avviato progetti di ricerca<br />
in Kosovo (valutazione campagna educazionale ed informativa<br />
relativa al controllo di AIDS e Tubercolosi) e in Estonia<br />
(valutazione del programma di trattamento dei casi Multiresistenti).<br />
Nuovi progetti di ricerca sono stati avviati in Mozambico,<br />
Ethiopia e Burkina Faso. In Italia il laboratorio ha avviato<br />
ed attualmente coordina la valutazione dei risultati del trattamento<br />
e la sorveglianza ai farmaci antitubercolari. Inoltre sono<br />
in corso studi sull’utilizzo dei nuovi test-interferon per la diagnosi<br />
di infezione tubercolare latente, l’utilizzo di nuovi farmaci<br />
per il trattamento della tubercolosi multiresistente e per<br />
lo studio delle mutazioni in grado di determinare resistenza ai<br />
farmaci. Il laboratorio svolge la funzione di segreteria del<br />
TBNET, un consorzio di oltre 160 ricercatori da 26 Paesi costituitosi<br />
come Task Force dell’ERS (European Respiratory Society)<br />
per l’esecuzione di clinical trias sulla tubercolosi.<br />
Il laboratorio collabora strettamente con la World Health Organization,<br />
da cui ha ricevuto la nomina a “WHO Collaborating<br />
Centre for Tuberculosis and Lung Diseases” nel 2000, con rinnovo<br />
nel 2004. Il laboratorio collabora inoltre con il Ministero<br />
Affari Esteri del governo Italiano, da cui è stato nominato<br />
Centro di Eccellenza per le attività internazionali di controllo<br />
della Tubercolosi (insieme con l’Istituto Superiore di Sanità e<br />
l’Università di Brescia). Il laboratorio fornisce consulenza tecnica<br />
al Ministero della Salute, attraverso il CCM (Centro di<br />
Controllo delle Malattie). Il laboratorio rappresenta un centro<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
di riferimento a livello mondiale per i seguenti campi di interesse<br />
tecnico-scientifico: formazione di esperti nel controllo<br />
della Tubercolosi e dell’AIDS; assistenza tecnica ai programmi<br />
di controllo TB e HIV/AIDS; economia sanitaria; monitoraggio<br />
delle resistenze ai farmaci antitubercolari.<br />
Tra le attività di ricerca traslazionale ricordiamo lo sviluppo<br />
delle linee guida ERS per il controllo della tubercolosi in Europa<br />
(di cui il laboratorio coordina la revisione 2009), la definizione<br />
dei protocolli di intervento per la Sorveglianza, la gestione<br />
del paziente immigrato, la valutazione degli outcomes<br />
del trattamento, la sorveglianza delle resistenze (attività che<br />
hanno costituito la base delle Linee Guida Italiane G.U. 18<br />
Febbraio 1999, N° 40) e l’edizione 2007/riedizione 2008 degli<br />
International Standards for Tuberculosis Care che rappresentano<br />
lo strumento più idoneo a modificare l’approccio clinico<br />
a livello globale. Infine, il laboratorio sta sviluppando insieme<br />
a WHO e USAID uno strumento per la valutazione della capacità<br />
dei Paesi a rispondere al problema della multiresistenza<br />
(casi MDR ed XDR).<br />
Ricerche in corso<br />
L’attività di ricerca si concentra soprattutto su 4 linee:<br />
1) Sorveglianza delle resistenze e controllo di qualità della<br />
rete di laboratori (in Italia, e nei Paesi cui si offre assistenza<br />
tecnica). In Italia l’attività prosegue sia sul versante<br />
speculativo (studio della trasmissione dell’infezione mediante<br />
tecniche di epidemiologia molecolare) sia sul versante<br />
della sorveglianza (nell’ambito di un progetto finalizzato<br />
del CCM, Centro di Controllo delle Malattie, volto a<br />
coordinare l’attività della rete esistente con quella delle<br />
reti regionali). Nei Paesi in via di Sviluppo prosegue l’attività<br />
di messa in controllo di qualità e di valutazione di prevalenza<br />
delle resistenze. Un nuovo filone è stato attivato<br />
nel 2007, disegnato per studiare i casi MDR con resistenza<br />
anche ai chinolonici e ad almeno un iniettivo di seconda<br />
linea (Amicacina, Kanamicina e Capreomicina). Il laboratorio<br />
ha pubblicato nel 2007 3 lavori relativi a questi casi<br />
(denominati XDR), tra cui la prima descrizione di due casi<br />
resistenti a tutti gli antibiotici conosciuti. È stato creato<br />
uno speciale database con raccolta di tutti questi casi provenienti<br />
da Russia, Estonia, Germania ed Italia.<br />
2) Valutazione economica dell’impatto delle attività di controllo<br />
nei paesi in cui si esegue assistenza tecnica più Italia<br />
e Germania. È in corso la valutazione finale della costo-efficacia<br />
del controllo della TB in Europa Orientale, e si prevede<br />
poi di realizzare tale valutazione in Africa. Si sta<br />
inoltre eseguendo valutazione economica dell’utilizzo di<br />
Linezolid nella terapia dei casi MDR/XDR.<br />
3) Valutazione nuovi farmaci nel controllo della Tubercolosi<br />
multiresistente (Moxifloxacina, Linezolid) e nuovi test diagnostici<br />
(infezione tubercolare latente). È in corso la valutazione<br />
di efficacia e tollerabilità della Linezolid in trattamento<br />
continuativo, in associazione, per oltre 6 mesi, nel<br />
trattamento di pazienti multiresistenti o con effetti collaterali<br />
ai farmaci di prima linea in Italia e Germania.<br />
Prosegue la valutazione su diverse popolazioni bersaglio<br />
del test ELISPOT in confronto a intradermoreazione secondo<br />
Mantoux. Il Laboratorio è inoltre impegnato a coordinare<br />
la stesura delle nuove linee guida ERS per l’Europa,<br />
previste per il 2007.<br />
4) Valutazione dei determinanti sociali di infezione e malattia<br />
tubercolare. Tale progetto si avvale delle informazioni provenienti<br />
dai Paesi beneficiari dell’assistenza tecnica e permetterà<br />
di rispondere a quesiti scientifici ad oggi senza risposta.<br />
I 4 filoni di ricerca utilizzano una rete informatica collegata ai<br />
centri di raccolta dati dei Paesi con cui è in atto attività di assistenza<br />
tecnica (Russia, Romania, Moldova, Estonia, Turchia,<br />
Kosovo, Ukraina Mozambico, Egitto, Burkina Faso) e dai centri<br />
afferenti al TBNET.<br />
Ricerche in programmazione<br />
Sono in preparazione attività di ricerca sul controllo di TB e<br />
HIV in Burkina, Mozambico ed Ucraina.<br />
Lo strumento disegnato per valutare la capacità dei paesi di<br />
rispondere alla TB multiresistente verrà testato in Italia,<br />
Ucraina, Kosovo, Montenegro, Cambogia, Kenya, Tanzania e<br />
Sud Africa.<br />
Pubblicazioni<br />
Piana F, Codecasa LR, Besozzi G, Migliori GB, Cirillo D.<br />
Use of commercial interferon-g assays in immunocompromised<br />
patients for tuberculosis diagnosis. Am J Resp Crit<br />
Care Med 2006; 173 (1): 130.<br />
Codecasa LR, Ferrara G, Migliori GB et al. Long-term<br />
moxifloxacin in complicated tuberculosis patients with adverse<br />
reactions or resistance to first line drugs. Respir<br />
Med 2006; 100 (9): 1566-1572.<br />
Hopewell PC, Migliori GB, Raviglione MC. Tuberculosis<br />
care and control. Bull WHO 2006; 84 (6): 428.<br />
Tuberculosis Coalition for Technical Assistance. International<br />
Standards for Tuberculosis Care (ISTC). The Hague:<br />
Tuberculosis Coalition for Technical Assistance, 2006.<br />
Piana F, GB Migliori, D Cirillo, Codecasa LR et al. Use of a<br />
T-cell-based test for detection of tuberculosis infection<br />
among immunocompromised patient. Eur Resp J 2006; 28<br />
(1): 31-34.<br />
Miotto P, Migliori GB, Cirillo D et al. Use of genotype<br />
MTBDR assay for molecular detection of rifampin and isoniazid<br />
resistance in Mycobacterium tuberculosis clinical<br />
strains isolated in Italy. J Clin Microbiol 2006; 44 (7): 2485-<br />
2491.<br />
Migliori GB, Hopewell PC, Raviglione M et al. Improving<br />
the TB case management: the International standards for<br />
tuberculosis care. Eur Resp J 2006; 28 (4): 687-690.<br />
Kliiman K, Centis R, Migliori GB, Floyd K et al. Cost-effectiveness<br />
and clinical effectiveness of different treatment<br />
strategies for multidrugresistant tuberculosis. Eersti Arst<br />
2006; 85 (3): 148-154.<br />
Hopewell PC, Pai M, Maher D, Uplekar M, Raviglione MC<br />
(GB Migliori as a member of the Steering committee). International<br />
standards for tuberculosis care. Lancet Infect<br />
Dis 2006; 6: 710-725.<br />
Migliori GB, Loddenkemper R, Blasi F, Raviglione MC. 125<br />
years after Robert Koch’s discovery of the tubercle bacillus:<br />
the new XDR-TB threat. Is “science” enough to<br />
tackle the epidemic? Eur Resp J 2007; 29 (3): 423-427.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 93<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
Il laboratorio ha contribuito alla preparazione delle linee guida<br />
europee (Migliori GB, Raviglione MC et al. Tuberculosis management<br />
in Europe. Eur Respir J 1999; 14: 978-992) e americane<br />
(American Thoracic Society, Centers for Disease Control<br />
and Prevention. Targeted tuberculin testing and treatment of<br />
latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med 2000;<br />
161, 4: S221-S247) per il controllo della tubercolosi. Il laboratorio<br />
ha inoltre contribuito alla stesura degli International<br />
Standards for Tuberculosis Care (ISTC) (Tuberculosis Coalition<br />
for Technical Assistance. International Standards for Tuberculosis<br />
Care (ISTC). The Hague: Tuberculosis Coalition for<br />
Technical Assistance, 2006.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Giovanni Battista Migliori<br />
Nato a Sondrio il 26.6.1960.<br />
Training<br />
Laurea con lode, 18.10.1985, Università di<br />
Pavia; Specialità (lode) in Tisiologia malattie<br />
App. Resp. (1989) e Statistica medica<br />
(1995), Università di Pavia.<br />
Post-Graduate Corse in Tropical Medicine (Padova, 1986-<br />
87); Auditor Sistema di Qualità UNI EN ISO 9000 e Vision<br />
2000 (Milano, 2002).<br />
Attività professionali<br />
1987-1989: Responsabile (Assistente a tempo pieno, Cooperazione<br />
Medica del Min. Esteri), del programma di controllo<br />
di AIDS e tubercolosi nel Distretto di Arua, Uganda.<br />
Dal 1989, Assistente, dal 1994 Aiuto, (Divisione di Pneumologia),<br />
e dal 2003: Primario (Servizio di Epidemiologia Clinica<br />
delle Malattie Respiratorie) presso il Centro di Tradate<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRRCS.<br />
Dal 2000: Direttore, Centro di Collaborazione OMS per la<br />
Tubercolosi e le Malattie Respiratorie, presso il Centro di<br />
Tradate.<br />
Dal 1994: Collaboratore di OMS/WHO, Comunità Europea e<br />
GFATM (Fondo Globale) in: Russia, Romania, Moldova,<br />
Estonia, Turchia, Kosovo, Ukraina Mozambico, Egitto,<br />
Burkina Faso.<br />
Dal 2000: Segretario Generale, e dal 2007 Presidente, IUATLD,<br />
Europe Region.<br />
Dal 2001: Responsabile Gruppo di Studio Tubercolosi, AIPO<br />
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri e membro<br />
(nomina Ministero Salute) sottocommissione Prevenzione e<br />
Controllo della Tubercolosi, CCM (Centro nazionale per la<br />
prevenzione ed il Controllo delle Malattie).<br />
Dal 2002: Membro del Gruppo di lavoro OMS/WHO relativo<br />
alla DOTS Expansion.<br />
Dal 2003 Membro del TAG (Technical Advisory Group),<br />
WHO Euro.<br />
Dal 2004: Membro Direttivo Stop TB Italia (affiliata StopTB<br />
International).<br />
Dal 2005: Chairman, Gruppo di Studio Tuberculosi, European<br />
Respiratory Society.<br />
94<br />
Dal 2006: Membro del Comitato Scientifico dell’EDCTP (European<br />
& Developing Countries Clinical Trials Partnership)<br />
e Segretario di TBNET, network europeo per la gestione di<br />
Clinical Trials.<br />
Attività di Ricerca<br />
Sorveglianza, controllo ed epidemiologia della tubercolosi e<br />
delle malattie respiratorie.<br />
Economia sanitaria.<br />
Dal 1996: Responsabile Scientifico di tre Progetti Finalizzati<br />
e coordinatore del Progetto SMIRA (monitoraggio nazionale<br />
resistenze agli antitubercolari), nell’ambito del Progetto Tubercolosi<br />
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero<br />
della Salute.<br />
Dal 2002: Responsabile del Progetto Mozambico (Ministero<br />
Affari Esteri).<br />
Attività Didattiche<br />
Dal 1998: Professore a Contratto presso la Scuola di Specialità<br />
in Statistica Sanitaria dell’Università di Pavia e docente<br />
presso l’Università di Brescia del corso di Medicina<br />
Tropicale (riconosciuto CEE).<br />
Dal 1997: Docente al corso internazionale OMS per National<br />
TB Programme Managers di Varsavia.<br />
Dal 1999: Docente alla European School of Respiratory Medicine<br />
(ERS).<br />
Dal 2001: Direttore corsi di formazione per “Consultants” internazionali<br />
nel Controllo della Tubercolosi OMS/WHO di<br />
Sondalo (44 organizzati ad oggi a Sondalo, Addis Abeba,<br />
Cairo, Ginevra e Mosca).<br />
Società Scientifiche<br />
Membro attivo di società scientifiche nazionali (AIPO;<br />
SIMeR, Società Italiana di Medicina Respiratoria; SIMET,<br />
Società Italiana di Medicina Tropicale) ed internazionali<br />
(IUATLD; ERS, European Respiratory Society).<br />
Relatore per invito a Gruppi di Studio e Congressi American<br />
Thoracic Society and European Respiratory Society.<br />
Section editor e reviewer dei contributi scientifici di riviste nazionali<br />
(Rass Pat App Resp) ed internazionali (Int J Tuberc<br />
Lung Dis, Bull WHO, Eur J Epidemiol, Respiration, Monaldi<br />
Arch Chest Dis, Emerging Infectious Diseases, Am J Resp Crit<br />
Care Med, Lancet Infect Dis). Associate Editor Eur Respir J.<br />
Parla e scrive correttamente in lingua francese ed inglese.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
8. LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA<br />
E MECCANICA RESPIRATORIA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: antonio.patessio@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Antonio Patessio<br />
Il laboratorio è realizzato all’interno del Servizio di Fisiopatologia<br />
Respiratoria della Divisione di Pneumologia diretta dal<br />
Dr. Bruno Balbi.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’ambito di ricerca è circoscritto alla fisiopatologia dell’esercizio<br />
fisico ed alla meccanica respiratoria del paziente critico.<br />
Le linee principali di ricerca hanno riguardato e riguardano la<br />
fisiologia dei muscoli respiratori durante esercizio fisico, le risposte<br />
fisiologiche all’allenamento in pazienti affetti da broncopneumopatia<br />
cronica, le problematiche inerenti l’attività<br />
dell’ambulatorio di Fisiopatologia, le interazioni tra l’attività dei<br />
muscoli respiratori e varie modalità di supporto ventilatorio<br />
meccanico, la fisiopatologia dell’insufficienza respiratoria<br />
acuta su cronica. Per quanto riguarda le collaborazioni<br />
esterne, il laboratorio intrattiene rapporti continuativi con i<br />
gruppi facenti capo al Prof. Marco V. Ranieri (Cattedra di Anestesiologia<br />
e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università di Torino), al Dr. A. Rossi (U.O. di Pneumologia,<br />
Ospedali Riuniti di Bergamo), al Prof. F. Dalla Corte (Cattedra<br />
di Anestesiologia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università del Piemonte Orientale), al Prof. R. Casaburi<br />
(Division of Respiratory and Critical Care Medicine and Physiology,<br />
Harbor UCLA Medical Center, Los Angeles, USA, al<br />
Dr. A. Purro (Dipartimento di Emergenza, Ospedale Gradenigo,<br />
Torino).<br />
Attività educazionale<br />
1) Il Dr. Lorenzo Appendini è stato Lettore nel contesto dell’Insegnamento<br />
di Semeiotica e Metodologia Clinica della<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
dell’Università di Torino per gli anni accademici<br />
1994-1995, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003,<br />
2003-2004, 2004-2005.<br />
2) Il Dr. Antonio Patessio ed il Dr. Lorenzo Appendini sono<br />
stati Tutor del dottorato di ricerca (Ph.D.) della D.ssa<br />
Marta Gudjonsdottir dal titolo: “The role of respiratory muscle<br />
load-capacity balance in health and disease” istituito<br />
dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Islanda, diretto<br />
dal Prof. Stefan B. Sigurdsson e svolto presso l’Istituto<br />
Scientifico di Veruno della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia nel<br />
periodo Ottobre 1995 – Ottobre 2001.<br />
3) Il Dr. Lorenzo Appendini è stato ed è tutt’ora Docente a<br />
contratto presso la I Scuola di Specializzazione in Anestesia<br />
e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università di Torino per l’insegnamento “Anestesiologia e<br />
Rianimazione 3, Area “G” Rianimazione e Terapia Intensiva”<br />
del IV anno di Corso a partire dall’Anno Accademico<br />
2001-2002.<br />
4) Il Dr. Lorenzo Appendini è stato ed è tutt’ora Docente a<br />
contratto presso la I Scuola di Specializzazione in Anestesia<br />
e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università di Torino per l’insegnamento “Terapia Intensiva<br />
1, Area “D” Anestesia e Terapia Intensiva nelle Specialità,<br />
del II anno di Corso a partire dall’Anno Accademico 2003-<br />
2004.<br />
5) Il Dr. Lorenzo Appendini è stato Docente a contratto<br />
presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione,<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli<br />
Studi del Piemonte Orientale per il II e III anno di Corso<br />
nell’Anno Accademico 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.<br />
6) Dall’Istituzione dell’Istituto di Educazione Continua in Medicina<br />
(ECM), Il Dr. Antonio Patessio ed il Dr. Lorenzo Appendini<br />
hanno partecipato attivamente in qualità di docenti<br />
ai corsi interni ECM organizzati per il personale medico<br />
ed infermieristico dell’Istituto Scientifico di Veruno.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
In corso numerosi studi tra cui si segnalano:<br />
Progetto di ricerca Dipartimentale. Raccolta di dati Dipartimentali<br />
relativa alle valutazioni di parametri di meccanica<br />
respiratoria raccolti nei vari Istituti. In particolare, oltre a<br />
Veruno, sicuramente Pavia (Dr. Nava) e forse anche Lumezzane<br />
(Dr. Vitacca) potrebbero fornire dati per analisi<br />
che comunque andranno a riferirsi a casistiche sia numericamente<br />
che qualitativamente importanti.<br />
In collaborazione con il Prof. Marco V. Ranieri (Cattedra di<br />
Anestesiologia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università di Torino) sono in corso progetti di ricerca<br />
sull’ottimizzazione delle interfacce non invasive per<br />
la ventilazione meccanica, sulle modalità di ventilazione<br />
meccanica impiegate per lo svezzamento dal ventilatore e<br />
su nuove modalità di ventilazione meccanica.<br />
In collaborazione con il Dr. A. Rossi (U.O. di Pneumologia,<br />
Ospedali Riuniti di Bergamo) è in corso un progetto di ricerca<br />
sull’implementazione di un monitoraggio ondine dei<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 95<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
parametri di meccanica respiratoria durante ventilazione<br />
meccanica assistita.<br />
In collaborazione con il Prof. F. Dalla Corte (Cattedra di<br />
Anestesiologia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia,<br />
Università del Piemonte Orientale) è in corso uno<br />
studio sul potere prognostico dei parametri di meccanica<br />
respiratoria nei pazienti colpiti da paralisi diaframmatica<br />
post-cardiochirurgia.<br />
In collaborazione con il Dr. A. Purro (Dipartimento di<br />
Emergenza, Ospedale Gradenigo, Torino) è in corso uno<br />
studio sulle alterazioni della meccanica respiratoria nei pazienti<br />
in insufficienza respiratoria acuta ventilati meccanicamente<br />
e non, ricoverati nel Dipartimento di Emergenza.<br />
Pubblicazioni<br />
R. Porta, L. Appendini, M. Vitacca, L. Bianchi, C.F. Donner,<br />
R. Poggi, N. Ambrosino. Mask proportional assist vs pressure<br />
support ventilation in patients in clinically stable condition<br />
with chronic ventilatory failure. Chest 2002; 122:<br />
479-488.<br />
L. Appendini, C.F. Donner. L’insufficienza respiratoria<br />
acuta. In: Trattato Italiano di Pneumologia, Vol. III. C.F.<br />
Donner, C.M. Sanguinetti eds. Edi-Aipo Scientifica S.c.r.l.,<br />
Pisa, 2002.<br />
L. Appendini. Proportional assist ventilation: back to the<br />
future? Respiration 2003; 70: 345-346.<br />
F. Racca, L. Appendini, C. Gregoretti, E. Stra, A. Patessio,<br />
C.F. Donner, V.M. Ranieri. Effectiveness of mask and<br />
helmet interfaces to deliver noninvasive ventilation in a<br />
human model of resistive breathing. J. Appl. Physiol. 2005;<br />
99 (4): 1262-71.<br />
A. Rossi, L. Appendini, S. Nava. Ventilazione meccanica:<br />
ruolo della pressione positiva continua (CPAP). In: I quaderni<br />
della BPCO - Il volto della BPCO che cambia. Vol. 5.<br />
C. Giuntini, L.M. Fabbri, V. Grassi. Eds. UTET, Torino, 2005:<br />
105-109.<br />
L. Appendini, A. Patessio, C.F. Donner. Exacerbations od<br />
COPD: the role of invasive mechanical ventilation. In:<br />
Yearbook of intensive care and emergency medicine. J.L.<br />
Vincent ed. Springer, Berlin, 2005: 3-9.<br />
L. Appendini, M. Gudjonsdottir, A. Rossi. Lung function<br />
and respiratory mechanics assessment. In: Pulmonary<br />
rehabilitation. C.F. Donner, N. Ambrosino, R.S. Goldstein<br />
eds. Hodder Arnold, London, 2005, 57-68.<br />
R. Poggi, L. Appendini, G. Polese, R. Colombo, C.F. Donner,<br />
A. Rossi. Noninvasive proportional assist ventilation and<br />
pressure support ventilation during arm elevation in patients<br />
with chronic respiratory failure. A preliminary, physiologic<br />
study. Respir Med. 2006; 100 (6): 972-9.<br />
S. Khirani, G. Polese, L. Appendini, A. Rossi. Mechanical<br />
ventilation in COPD. In: M. Tobin ed. Principles & Practice<br />
of Mechanical Ventilation. 2nd edition, McGraw-Hill, Inc.,<br />
New York, NY. 2006; part IX, ch. 33, 663-679.<br />
K. Bosma, G. Ferreyra, C. Ambrogio, D. Pasero, L. Mirabella,<br />
A. Braghiroli, L. Appendini, L. Mascia, V.M. Ranieri. Patientventilator<br />
interaction and sleep in mechanically ventilated<br />
patients: pressure support versus proportional assist ventilation.<br />
Crit. Care Med. 2007 Apr; 35 (4): 1048-54.<br />
S. Zanaboni, L. Appendini, B. Schönhofer. Hemidiaphragmatic<br />
paralysis after cardiac surgery in a 62-year-old<br />
96<br />
COPD patient. In: C.F. Donner, M. Carone eds. Clinical<br />
Challenges in COPD. Clinical publishing Oxford ed.,<br />
Oxford, 2007: pp. 191-198.<br />
Metodi messi a punto / Brevetti<br />
In collaborazione con l’Ing. Roberto Colombo del Servizio di<br />
Bioingegneria dell’Istituto, il Laboratorio di Fisiopatologia e<br />
Meccanica Respiratoria ha messo a punto un sistema semiautomatizzato<br />
per la valutazione della meccanica respiratoria<br />
nei pazienti in respirazione spontanea/assistita (PULMOLAB)<br />
utilizzabile su computers che operano in ambiente Windows.<br />
PULMOLAB, essendo uno strumento di acquisizione di segnali<br />
fisiologici multicanale, permette inoltre la stima di tutte<br />
le variabili di meccanica respiratoria che implicano la misurazione<br />
di flussi, volumi e pressioni respiratorie. Infine, un sottoprogramma<br />
apposito permette una semplice archiviazione dei<br />
dati registrati in un apposito data base come pure la stampa<br />
di reports clinici. Questo sistema è stato diffuso presso altri<br />
Istituti Scientifici della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRCCS<br />
(Pavia, Montescano, Gussago).<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Il Dr. Antonio Patessio è nato a Saronno il<br />
14/07/1954, ha conseguito la maturità classica<br />
presso il Liceo “Daniele Crespi” di Saronno<br />
(Varese) nel 1973 e si è quindi iscritto<br />
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università<br />
di Milano.<br />
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia<br />
il 4/9/1979 con il massimo dei voti e<br />
lode: durante il corso di laurea ha frequentato, in qualità di<br />
studente interno, l’Istituto di Clinica Medica (1977-79). Ha<br />
realizzato la propria tesi sperimentale di laurea dal titolo<br />
“Studio policardiografico e ecocardiografico della miocardiopatia<br />
diabetica in fase preclinica”. Nella II Sessione dell’anno<br />
1979 ha superato l’esame di abilitazione professionale e si è<br />
quindi iscritto all’Albo Professionale dei Medici-Chirurghi<br />
della provincia di Varese a decorrere dal 29/1/1980.<br />
Ha conseguito in seguito presso l’Università di Pavia la specializzazione<br />
in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria il<br />
22/6/83 con il massimo dei voti e lode, e presso l’Università di<br />
Parma la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato<br />
Respiratorio il 15/11/1989 con il massimo dei voti.<br />
Dal 1/3/80 al 31/8/80 ha prestato il tirocinio pratico ospedaliero<br />
nella disciplina di Medicina Interna presso l’Ospedale di<br />
Saronno e dal 1/4/82 al 30/9/82 nella disciplina di Fisiopatologia<br />
Respiratoria presso il Centro Medico di Veruno.<br />
L’1/7/83 gli è stata conferita la supplenza di assistente presso<br />
il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del Centro Medico di<br />
Veruno, <strong>Fondazione</strong> Clinica del Lavoro, Istituto di Ricovero e<br />
Cura a Carattere Scientifico: dal 1/4/84 è divenuto assistente<br />
incaricato e quindi di ruolo.<br />
L’1/4/1989 gli è stato conferito l’incarico di Aiuto presso la Divisione<br />
di Pneumologia del Centro Medico di Veruno.<br />
È responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria e<br />
svolge attività di ricerca e clinica (pazienti degenti nel reparto<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
di Pneumologia e pazienti degenti in Unità di Terapia Subintensiva).<br />
Per quanto riguarda l’attività di ricerca gli interessi fondamentali<br />
sono stati i seguenti: a) basi fisiopatologiche e metodologia<br />
della riabilitazione nelle broncopneumopatie croniche,<br />
b) aspetti valutativi ed implicazioni terapeutiche dell’esercizio<br />
fisico nella patologia respiratoria, c) ossigenoterapia a lungo<br />
termine ed assistenza ventilatoria meccanica in unità di terapia<br />
intensiva. Gli studi condotti in questi ambiti hanno finora<br />
portato alla pubblicazione di oltre 100 lavori scientifici di cui<br />
parte consistente su riviste di livello internazionale.<br />
Ha collaborato per diversi anni con il Prof. K. Wasserman ed il<br />
Prof. R. Casaburi della UCLA (Università della California-Los<br />
Angeles) in ricerche volte ad esplorare le basi fisiopatologiche<br />
degli effetti della riabilitazione respiratoria, ed in particolare<br />
del riallenamento allo sforzo in pazienti affetti da broncopneumopatia<br />
cronica ostruttiva.<br />
Ha partecipato dal 1983 ad oggi in qualità di relatore a oltre<br />
100 Congressi nazionali ed internazionali.<br />
Ha partecipato alla stesura delle linee guida dell’European Respiratory<br />
Society (ERS) sulla standardizzazione ed interpretazione<br />
dei test ergometrici.<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
1. LABORATORIO DELLA VALUTAZIONE<br />
DELLA COMPLESSITÀ CLINICA<br />
Istituto Scientifico di Telese Terme<br />
Via Bagni Vecchi, 1<br />
Tel. 0824.909.111<br />
e-mail: francesco.cacciatore@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Francesco Cacciatore<br />
L’alta prevalenza di soggetti con patologie cronico-degenerative<br />
e disabilitanti, indotta dalla rivoluzione epidemiologica documentata<br />
alla fine dell’ultimo secolo, ha notevolmente aumentato<br />
il carico assistenziale negli Istituti di riabilitazione e<br />
ne ha condizionato sensibilmente i risultati clinici.<br />
Il laboratorio della “Valutazione della Complessità Clinica”<br />
analizza la complessità clinica, definita dalla comorbilità, disabilità<br />
e fragilità, di pazienti ricoverati in riabilitazione intensiva<br />
specialistica. Si tratta, in particolare, di valutare globalmente il<br />
singolo paziente o intere casistiche dal punto di vista della salute<br />
fisica e mentale, della condizione socio-economica e della<br />
situazione ambientale, definendo le caratteristiche cliniche, il<br />
peso della comorbidità, la valutazione della disabilità e fragilità,<br />
identificando specifici percorsi clinico-riabilitativi, orientati<br />
dalla valutazione della complessità clinica. In tal modo, saremo<br />
in grado di caratterizzare oggettivamente la tipologia dei<br />
nostri assistiti, assegnarli al livello assistenziale più idoneo per<br />
razionalizzare le risorse, orientarli su percorsi riabilitativi individualizzati<br />
e, se necessario, innovativi e prevederne lo “outcome”<br />
clinico.<br />
Attività di Ricerca<br />
Malattie cardiovascolari e cognitività<br />
Il deterioramento delle funzioni cognitive è una condizione<br />
sempre più frequentemente osservata con l’invecchiamento<br />
della popolazione. Questo aspetto, tradizionalmente, è stato<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 97<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
oggetto di interesse da parte della neuro-psichiatria, venendo<br />
sostanzialmente trascurato dalla medicina interna e dalle altre<br />
specialità mediche.<br />
La letteratura, fino all’inizio degli anni ’90, non aveva individuato<br />
condizioni cliniche predittive di deficit delle funzioni cognitive,<br />
ove si escluda l’età, il sesso femminile, la bassa scolarità<br />
e le patologie neurologiche. Più recentemente, è stato dimostrato<br />
che importanti patologie cronico-degenerative di<br />
tipo internistico, senza evidenza di malattie neurologiche,<br />
sono in grado di condizionare il deterioramento cognitivo,<br />
espresso dal punteggio del Mini Mental State Examinatiom<br />
(MMSE), che può modificarsi con il miglioramento o il peggioramento<br />
clinico della malattia. D’altra parte, è noto che<br />
anche in dementi di lieve o media gravità con comorbilità la<br />
cognitività è condizionata, oltre che dal danno neurologico,<br />
dalle patologie concomitanti quali la broncopneumopatia cronica<br />
ostruttiva, l’insufficienza cardiaca, il diabete scompensato,<br />
gli squilibri idro-elettrolitici, le reazioni avverse a farmaci, etc.<br />
Il nostro gruppo di ricerca ha sinora studiato in particolare il<br />
ruolo esercitato dall’ipertensione e dall’insufficienza cardiaca<br />
sul deficit delle funzioni cognitive e sulla prognosi in tre studi<br />
epidemiologici di cui lo “Osservatorio Epidemiologico Campano”,<br />
condotto su popolazione generale della Regione Campania,<br />
il “CHF Italian Study 1” ed il “CHF Italian Study 2”, condotto<br />
su popolazione ricoverata in n. 40 Divisioni di Medicina<br />
Interna o Geriatria italiane.<br />
Su questa scorta, si è realizzata una cartella clinica informatizzata<br />
che ci permetterà di pesare i rapporti tra le patologie<br />
cardiovascolari e le turbe della cognitività in termini di qualità<br />
della vita e di prognosi.<br />
Malattie cardiovascolari e disturbi dell’umore<br />
Sempre maggiori sono le evidenze che condizioni patologiche<br />
dello stato emozionale (depressione-ansia), indipendentemente<br />
dalla patologia cardiovascolare, sono in grado di condizionare<br />
la prognosi. Infatti, è stata dimostrata un’aumentata<br />
incidenza/prevalenza di eventi cardiovascolari in presenza di<br />
depressione nella popolazione generale, un’aumentata prevalenza<br />
di depressione dopo infarto miocardico come fattore di<br />
rischio indipendente di ridotta capacità funzionale e di aumentata<br />
mortalità/morbilità, un’aumentata prevalenza di depressione<br />
dopo ictus come fattore di rischio indipendente per<br />
ridotto recupero funzionale e mortalità/morbilità.<br />
Il nostro intento è quello di valutare la prevalenza di disturbi<br />
dell’umore nella popolazione in riabilitazione intensiva specialistica,<br />
i rapporti di questi ultimi con l’outcome riabilitativo e<br />
stabilire l’efficacia del trattamento antidepressivo.<br />
Comorbilità e disabilità<br />
In tutti questi anni, in cui la medicina riabilitativa si è andata<br />
imponendo nelle sue valenze specialistiche, nessun peso è<br />
stato dato alla comorbilità nella valutazione clinica, ove si<br />
escluda la descrizione dei fattori di rischio per le diverse categorie<br />
di pz inviate ad un programma riabilitativo. Il motivo di<br />
questa lacuna è fondamentalmente legato al fatto che in passato<br />
la casistica dei reparti di riabilitazione presentava un’età<br />
media intorno ai 50-60 anni, allorché la prevalenza di comorbilità<br />
risulta piuttosto modesta. Negli ultimi 20 anni, per<br />
contro, abbiamo assistito al fenomeno dell’invecchiamento<br />
della popolazione nei paesi industrializzati, che ha realizzato<br />
una vera e propria rivoluzione epidemiologica caratterizzata,<br />
appunto, dalla comorbilità e dalla disabilità.<br />
98<br />
Misure di fragilità<br />
La fragilità rappresenta l’estremo della complessità clinica e<br />
descrive lo stato di instabilità di un soggetto ad alto rischio di<br />
eventi avversi quali cadute, disabilità, ospedalizzazione e<br />
morte. La fragilità definisce uno stato di ridotta riserva funzionale<br />
multiorgano, che si accompagna a comorbilità e ridotta<br />
abilità ad eseguire le attività di base della vita quotidiana, condizionato<br />
da modificazioni funzionali neuro-muscolari, endocrine<br />
e del sistema immunitario e che necessita dei diversi<br />
“setting” riabilitativi.<br />
Tuttavia, non c’è ancora un univoco criterio, universalmente<br />
accettato, per identificare il soggetto fragile anche se, utilizzando<br />
differenti strumenti di screening, è stato dimostrato che<br />
la fragilità è correlata con la durata della degenza ospedaliera,<br />
l’istituzionalizzazione e la mortalità.<br />
Noi stessi, abbiamo affrontato questa problematica in pazienti<br />
cardiopatici suddivisi in tre classi, utilizzando lo score adottato<br />
da Lachs MS et al. per la fragilità, che ha manifestato una<br />
maggiore capacità di previsione prognostica della fragilità rispetto<br />
alla classe funzionale NYHA.<br />
Il nostro interesse consiste nella definizione di uno strumento<br />
capace di pesare la fragilità e che trovi una sua validazione<br />
nella correlazione con numerosi items quali l’ospedalizzazione,<br />
gli outcome riabilitativi, parametri bioumorali e la mortalità.<br />
Attività Educazionale<br />
Il laboratorio si pone come palestra di informazione e formazione<br />
per gli Istituti Scientifici della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, con l’obiettivo: a) di realizzare o scegliere strumenti<br />
capaci di valutare la complessità clinica di pazienti in riabilitazione;<br />
b) di realizzare banche dati raccolte con gli strumenti di<br />
valutazione della complessità clinica in riabilitazione; c) di formare<br />
il personale medico, tecnico e paramedico alla conoscenza<br />
e valutazione globale del paziente complesso in riabilitazione;<br />
d) di definire i percorsi riabilitativi multispecialistici<br />
integrati per il paziente complesso; e) di adeguare la struttura<br />
assistenziale riabilitativa alla tipologia di pazienti disabili complessi.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Il laboratorio è impegnato nello sviluppo di numerosi progetti<br />
di ricerca per i quali mantiene attive collaborazioni con diversi<br />
Istituti nazionali ed esteri tra cui:<br />
Progetto di ricerca finalizzata ordinario per gli aa 2007-<br />
2009: Riabilitazione cardiologica intensiva e continuità assistenziale<br />
nel paziente fragile dopo evento cardiovascolare.<br />
Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari<br />
ed Immunologiche dell’Università di Napoli “Federico II”.<br />
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Napoli<br />
“Federico II”.<br />
Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, dell’Università<br />
di Firenze.<br />
Istituto Superiore di Sanità.<br />
I filoni di ricerca attualmente seguiti sono:<br />
Realizzazione di un data-base per studi osservazionali su pazienti<br />
complessi in riabilitazione intensiva multispecialistica.<br />
Malattia di Alzheimer e fattori fragilità-correlati in grado di<br />
condizionare il profilo cognitivo del paziente anziano.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Determinanti del deficit cognitivo in pazienti con BPCO:<br />
ruolo del sistema nervoso e cardiovascolare. Effetti della<br />
riabilitazione per la programmazione dell’assistenza e dell’ottimizzazione<br />
delle risorse.<br />
Strategie di prevenzione per le patologie cronico-degenerative<br />
disabilitanti legate alla fragilità età-dipendente.<br />
Individuazione di predittori di disabilità e di risultato riabilitativo:<br />
ruolo della comorbilità nel paziente anziano disabile<br />
in riabilitazione.<br />
Ruolo della depressione nel paziente anziano in riabilitazione.<br />
Markers biologici predittori di disabilità motoria e di recupero<br />
funzionale.<br />
Pubblicazioni<br />
F. Cacciatore, P. Abete, N. Ferrara, G. Paolisso, L. Amato,<br />
S. Canonico, S. Maggi, M. Varricchio, F. Rengo. The role of<br />
blood pressure in cognitive impairment in elderly population.<br />
Journal of Hypertension 15: 135-142, 1997.<br />
L. Amato, G. Paolisso, F. Cacciatore, N. Ferrara, P. Ferrara,<br />
S. Canonico, M. Varricchio, F. Rengo. Congestive heart failure<br />
predicts the development of non-insulin diabetes<br />
mellitus in the elderly. Diabetes and Metabolism 23: 213-<br />
218, 1997.<br />
F. Cacciatore, C. Gallo, N. Ferrara, P. Abete, G. Paolisso, S.<br />
Canonico, G. Signoriello, C. Terracciano, C. Napoli, M. Varricchio,<br />
F. Rengo. Morbidity patterns in aged population in<br />
southern Italy. A survey sampling. Arch Gerontol Geriatrics<br />
26: 201-213, 1998.<br />
F. Cacciatore, P. Abete, N. Ferrara, C. Calabrese, C. Napoli,<br />
S. Maggi, M. Varricchio, F. Rengo. Congestive heart failure<br />
and cognitive impairment in an older population. Osservatorio<br />
Geriatrico Campano Study Group. Journal of American<br />
Geriatric Society 46: 1343-1348, 1998.<br />
C. Napoli, A. Liguori, F. Cacciatore, F. Rengo, G. Ambrosio,<br />
P. Abete. “Warm-up” phenomenon detected by electrocardiographic<br />
ambulatory monitoring in adult and older<br />
patients. Journal of American Geriatric Society 47: 1-4,<br />
1999.<br />
F. Cacciatore, C. Napoli, P. Abete, E. Marciano, M. Triassi,<br />
F. Rengo. Quality of life determinants and hearing function<br />
in an elderly population. Results from a cross-sectional<br />
study. Gerontology 45: 323-328, 1999.<br />
P. Abete, A. Cioppa, C. Calabrese, I. Pascucci, F. Cacciatore,<br />
C. Napoli, V. Carnovale, N. Ferrara, F. Rengo.<br />
Ischemic threshold and myocardial stunning in the aging<br />
heart. Experimental Gerontology 34: 875-884, 1999.<br />
P. Abete, C. Calabrese, N. Ferrara, A. Cioppa, P. Pisanelli,<br />
F. Cacciatore, C. Napoli, F. Rengo. Exercise training restores<br />
ischemic preconditioning in the aging heart.<br />
Journal of American College of Cardiology, 36: 643-650,<br />
2000.<br />
A. Liguori, P. Abete, J.M. Hayden, F. Cacciatore, F. Rengo,<br />
G. Ambrosio, D. Bonaduce, M. Condorelli, P.D. Reaven, C.<br />
Napoli. Effect of glicaemic control and age on low-density<br />
lipoprotein susceptibility on oxidation in diabetes mellitus<br />
type 1. Eur Heart Journal 22: 2075-84, 2001.<br />
P. Abete, N. Ferrara, F. Cacciatore, E. Sagnelli, M. Manzi, V.<br />
Carnovale, C. Calabrese, D. De Santis, G. Testa, G. Longobardi,<br />
C. Napoli, F. Rengo. High level of physical activity<br />
preserves the cardioprotective effect of preinfarction angina<br />
in elderly patients. Journal of American College of<br />
Cardiology 38: 1357-65, 2001.<br />
Metodi messi a punto<br />
Identificazione degli strumenti di valutazione della complessità<br />
clinica in Cardiologia Riabilitativa per realizzare una banca<br />
dati informatizzata.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Francesco Cacciatore<br />
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università<br />
degli Studi di Napoli “Federico II” con voti<br />
110/110 e lode 1991.<br />
Specializzazione in Geriatria, Università<br />
degli Studi di Napoli “Federico II” con voti<br />
70/70 e lode, 1995.<br />
Visiting Fellow, Department of Biostatistics,<br />
School of Hygiene and Public Health, The<br />
Johns Hopkins University, Baltimore MD, da marzo a giugno<br />
1994.<br />
Fellow Dipartimento di Biostatistica - Reparto Epidemiologia<br />
malattie croniche. Istituto Superiore di Sanità, Roma,<br />
gennaio 1996 - febbraio 1997.<br />
Dottore di Ricerca in Medicina di Comunità, Università degli<br />
Studi di Padova, XI ciclo 1996-1998.<br />
Coordinatore dell’Osservatorio Epidemiologico Geriatrico<br />
della Regione Campania, 1992-2000.<br />
Coordinatore Unità Operativa di Ricerca di Napoli dello<br />
studio SARA (SAlute Respiratoria Anziano) 1996-2001, Cattedra<br />
di Geriatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.<br />
Incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il<br />
Dipartimento della Protezione civile del COM (Centro Operativo<br />
Misto) - Funzione 2 Sanità di Larino in occasione del<br />
Sisma del 31 ottobre e 1 novembre 2002. L’incarico è stato<br />
ricoperto fino al 2 gennaio 2003.<br />
Dirigente Medico di II livello presso l’Unità Dipartimentale di<br />
Riabilitazione Intensiva <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, 14<br />
Luglio 2000-31 Luglio 2003.<br />
Titolare finanziamento Ministeriale 2003 Progetto IPREA<br />
(Italian Project Epidemiology Alzheimer) coordinato dall’Istituto<br />
Superiore Sanità.<br />
Dirigente Medico di II livello presso l’Unità Operativa di Cardiologia<br />
del Centro Medico di Telese - <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, 1 Agosto 2003 a tutt’oggi.<br />
Professore a Contratto Facoltà Scienze del Benessere, Università<br />
degli Studi del Molise, anni accademici 2006-2007 e<br />
2007-2008. insegnamento specialistico di Metodiche e Tecniche<br />
di riabilitazione motaria in soggetti con disabilità cardiovascolare.<br />
Titolare ricerca Finalizzata anno 2007: Progetto Riabilitazione<br />
cardiologica intensiva e continuità assistenziale nel paziente<br />
fragile dopo evento cardiovascolare.<br />
Revisore delle seguenti riviste scientifiche: Aging Clin Exp<br />
Res, Journal of American Geriatrics Society, Gerontology,<br />
Journal of Epidemiology.<br />
Autore di 100 pubblicazioni di cui 36 in estenso su riviste<br />
con I.F. (IF = 129.2).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 99<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
2. LABORATORIO PER LO STUDIO<br />
DELL’AFFATICAMENTO MUSCOLARE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.5921<br />
e-mail: remo.lombardi@unipv.it<br />
Responsabile: Prof. Remo Lombardi<br />
Presso gli Istituti Scientifici di Pavia e Castel Goffredo si svolge ricerca<br />
di base e applicata nel campo della Bioingegneria Riabilitativa.<br />
Gli obbiettivi dell’attività di questi laboratori, afferenti al Dipartimento<br />
di Bioingegneria e Tecnologie Biomediche, sono il miglioramento<br />
delle capacità diagnostiche e l’ideazione di nuovi<br />
strumenti terapeutici nell’ambito della Medicina Riabilitativa<br />
Neuromotoria. Supporto essenziale per il perseguimento dei citati<br />
obbiettivi è la progettazione e realizzazione di strumenti per<br />
l’esecuzione di studi legati all’attività lavorativa, al recupero del<br />
disabile, alla valutazione funzionale dell’anziano, dello sportivo e<br />
anche del paziente con piccoli traumi da carico, alla definizione<br />
del protocollo riabilitativo, al follow-up dello stesso e lo studio di<br />
materiali innovativi per applicazioni in riabilitazione.<br />
Attività di Ricerca<br />
Principali obbiettivi di Ricerca raggiunti<br />
SISTEMI ORIGINALI E PROTOCOLLI SVILUPPATI<br />
Studio del design ergonomico di vari prodotti proposti per<br />
rendere più confortevole la guida e di conseguenza aumentare<br />
i livelli di sicurezza durante il trasporto nel settore<br />
automobilistico e motociclistico. Determinazione della la<br />
correlazione tra gli organi meccanici dei mezzi e i movimenti<br />
del pilota e dei passeggeri.<br />
Effetti dovuti all’introduzione di materiali innovativi in ambito<br />
calzaturiero e le conseguenze sulla postura e sul benessere.<br />
100<br />
Test su prodotti per sportivi, per migliorarne la praticità e<br />
l’adattabilità al soggetto, per aumentare le prestazioni in<br />
caso d’applicazioni anche in competizioni d’alto livello.<br />
Valutazione del corretto posizionamento della colonna vertebrale<br />
su vari tipi di materasso per valutarne il comfort.<br />
Praticità e comfort per l’arredamento da ufficio: analisi<br />
degli effetti e proposte di nuovi elementi di design.<br />
Progetti di Ricerca in corso<br />
Studio dell’affaticamento muscolare su calciatori.<br />
Realizzazione di un piede robotico per lo studio dei parametri<br />
meccanici di manti in erba sintetica.<br />
Progetti di ricerca futuri<br />
Valutazione della risposta elastica delle piste d’atletica, finalizzata<br />
allo studio delle performance dell’atleta.<br />
Valutazione dell’allenamento sportivo utilizzando strumenti<br />
non invasivi per la misura dell’apporto di ossigeno.<br />
Studio dei movimenti del capo-collo in piloti di go-kart.<br />
Studio dell’equilibrio conseguente all’affaticamento, mediante<br />
posturografia e test di Tinetti.<br />
Il laboratorio dispone di strumenti hardware e software per<br />
l’acquisizione e l’elaborazione di grandezze fisiologiche originali,<br />
in particolare:<br />
strumento portatile per l’acquisizione ed il trasferimento in<br />
tempo reale di parametri bio-meccanici;<br />
strumento per la verifica dell’aggregazione emoglobinica,<br />
finalizzata allo studio della fatica muscolare;<br />
strumento per la verifica della fatica attraverso l’analisi<br />
spettrale del S-EMG;<br />
caschetto per lo studio dei movimenti del capo;<br />
tuta sensorizzata e relativo software per la ricostruzione<br />
3D dei movimenti dei segmenti corporei.<br />
Collaborazioni<br />
NINDS, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.<br />
Brain & Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology,<br />
Boston, USA.<br />
IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia.<br />
Clin Neurophysiology, <strong>Fondazione</strong> “Istituto Neurologico<br />
C. Mondino” - IRCCS, Pavia.<br />
Aurion srl, Milano.<br />
EBNeuro SpA, Firenze.<br />
Medtronic A/S, Skovlunde, Denmark.<br />
Pubblicazioni<br />
Amadio S, Panizza M, Pisano F, Maderna L, Miscio C,<br />
Nilsson J, Volonté MA, Comi G, Galardi G. Transcranial<br />
magnetic stimulation and silent period in spasmodic torticollis.<br />
Amer Jour Phys Med & Rehab 79 (4): 361-368, 2000.<br />
Buizza A, Schmid M, Secco EL, Lombardi R, Gandolfi R.<br />
Head and trunk movements during upright stance in normals,<br />
Gait Posture 16: S143-S144, 2002.<br />
Buizza A, Ferraris P, Gandolfi R, Lombardi R. Multi-segmental<br />
measurement of body sway during undisturbed<br />
upright stance in normals. Proc. XXIII Int. Congress Barany<br />
Soc, 2004, J Vestibular Res 14: 238-239.<br />
Buizza A, Ferraris P, Gandolfi R, Lombardi R. The effect of<br />
vision on the statistics of body sway during quiet unperturbed<br />
stance as measured at different body levels, Proc.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
2nd Int. Symp. Measurement, Analysis and Modelling of<br />
Human Function & 1st Mediterranean Conf. Measurement,<br />
PG Morasso, GB Rossi eds., pp. 27-30. June 14-16<br />
2004, Genoa, I.<br />
Buizza A, Lombardi R, Schmid M. Strumentazione per la<br />
valutazione della disabilità motoria. In Le scale di valutazione<br />
in riabilitazione, a cura di L. Panella. Milano:<br />
Edi.Ermes, in corso di stampa 2005.<br />
Casale R, Rainoldi A, Nilsson J, Bellotti P. Can continuous<br />
physical training counteract ageing effect on myelectric<br />
fatique?: A sEMG study application. Arch Phys Med<br />
Rehabil 84 (4): 513-517, 2003. Abstract/PDF<br />
Coldani G, Ghidetti P, Lombardi R, Corazza I, Cannoli R. An<br />
Instrument to Measure Velocità Profile byMeans of Ultrasound<br />
Techniques, Journal of Mechanics in Medicine and<br />
Biology Vol 3, N. 1, Marzo 2003.<br />
Bertolotti GM, Ghidetti P, Lombardi R, Buizza A. A Multi-<br />
Sensor Portable Acquisition System Applied To Telemedicine,<br />
(Pavia, Italy) MEDICON and HEALTH TELEMATICS<br />
2004, Health in the Information Society, X Mediterranean<br />
Conference on Medical and Biological Engineering,<br />
IFBME Proceedings, Volume 6, Ischia (NA), 2004.<br />
Bertolotti GM, Lombardi R, Paradiso R, Verni G. Realization<br />
of a piezoresistive felt sensor for pressure measurements on<br />
lower limb prosthesis, Gait & Posture (OLANDA) vol. 16,<br />
Supp. 1, p. 220, 2002.<br />
Bertolotti GM, Lombardi R. Experiments with sensing fabrics<br />
for biomedical applications, MEDINF 2003, the 1st<br />
MEDINF International Conference on Medical Informatics<br />
& Engineering, Craiova (Romania), 2003.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof. Remo Lombardi.<br />
L’attività scientifica del triennio 2002-2005 del<br />
Prof. Remo Lombardi ha riguardato soprattutto<br />
lo sviluppo di strumentazione, basata su<br />
microprocessore e/o DSP, per applicazioni in<br />
ambito biomedico; inoltre ha svolto attività organizzative,<br />
di direzione di gruppi di Ricerca e<br />
di coordinamento di iniziative in campo didattico<br />
e scientifico.<br />
Ricopre l’incarico istituzionale di: Direttore del Centro Interdipartimentale<br />
di Studi e Ricerche sulla Disabilità ed da ricoperto<br />
gli incarichi istituzionali di membro della commissione giudicatrice<br />
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in<br />
Ingegneria Elettronica, Informatica ed Elettrica, presso la facoltà<br />
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia e del titolo<br />
di dottore di ricerca in Bioingegneria e Bioelettronica<br />
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di<br />
Genova. È stato Co-tutore ed è attualmente Tutore di Dottorandi<br />
di Ricerca. In data 24 ottobre 2003 è stata depositata domanda<br />
internazionale di brevetto N. PCT/IT03/00660 relativa a<br />
“Sistema per test motorio”.<br />
È responsabile delle attività che si svolgono presso il Laboratorio<br />
di Microcalcolatori, Sezione Strumentazione Elettromedicale<br />
e del Laboratorio Didattico di Tecnologie Biomediche,<br />
Elettronica Industriale e Progetto di Sistemi Digitali, del Dipartimento<br />
di Informatica e Sistemistica dell’Università degli Studi<br />
di Pavia. È inoltre responsabile scientifico del laboratorio ErgovisionLAB<br />
del Parco Scientifico e Tecnologico della Valle<br />
Scrivia località Rivalta Scrivia, Tortona (AL).<br />
Revisore per la rivista IEEE Transactions on Instrumentation<br />
and Measurements, è responsabile dei seguenti Contratti di<br />
Ricerca:<br />
FAR (2002 - 2003 - 2004);<br />
Aprilia SpA (2004 - 2005);<br />
Mondo Spa (2005);<br />
Centro INAIL di Vigorso di Budrio (2002 - 2003 - 2004);<br />
Parco Scientifico e Tecnologico della Valle Scrivia (2003 -<br />
2004 - 2005).<br />
Autore e co-autore di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali<br />
ed internazionali, ha partecipato con comunicazioni e<br />
relazioni a congressi nazionali ed internazionali, oltre ad aver<br />
organizzato eventi accreditati ECM, in particolare il convegno<br />
nazionale “Ricerca, Assistenza e Integrazione” 3 Luglio 2003,<br />
Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino 1 e il convegno nazionale<br />
“Disabilità e Lavoro” 24-25 Settembre 2004, Sala Congressi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10 - Pavia.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 101<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
3. LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA<br />
TERAPEUTICA<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
Tel. 0382.592062/4/5<br />
e-mail: egherard@mrc-lmb.cam.ac.uk<br />
Responsabile: Prof. Ermanno Gherardi<br />
Questo nuovo laboratorio ha l’obiettivo generale di produrre<br />
anticorpi per applicazioni cliniche. Sono trascorsi oltre venti<br />
anni dalla scoperta degli anticorpi monoclonali (Kohler, G. &<br />
Milstein, C Nature 256, 495-7, 1975) alle prime applicazioni terapeutiche<br />
cliniche importanti di queste proteine. In questi<br />
venti anni sono stati sviluppati procedimenti che consentono di<br />
‘umanizzare’ anticorpi monoclonali murini e di produrre direttamente<br />
frammenti di anticorpi monoclonali umani in sistemi<br />
di espressione basati su batteriofagi e cellule procariotiche.<br />
Queste tecnologie, per quanto complesse, sono oggigiorno<br />
‘mature’ nel senso che, in generale, è possibile portare a termine<br />
con successo esperimenti di umanizzazione degli anticorpi<br />
o di selezione di nuovi cloni da genoteche di batteriofagi.<br />
Attività di Ricerca<br />
Il Laboratorio di Immunologia Terapeutica intende perseguire<br />
i propri obiettivi in due modi. Il primo è attraverso un proprio<br />
programma di ricerca che coinvolgerà la produzione di anticorpi<br />
nei confronti di recettori di membrana per alcuni fattori<br />
di crescita. Le applicazioni di questi anticorpi sono duplici.<br />
Anticorpi in grado di bloccare l’attività dei recettori in questione<br />
verranno caratterizzati ai fini di valutarne la possibile<br />
applicazione nella terapia di quei tumori in cui i recettori sono<br />
attivati, per esempio a causa di aumentata espressione dei recettori<br />
stessi o dei loro ligandi. Anticorpi in grado invece di attivare<br />
i recettori verranno caratterizzati anche dal punto di<br />
102<br />
vista di possibili applicazioni in patologie croniche e degenerative<br />
in cui l’attivazione di questi recettori può indurre processi<br />
di regenerazione del tessuto.<br />
Il secondo modo in cui il Laboratorio intende perseguire i<br />
propri obiettivi è attraverso progetti in collaborazione con altre<br />
Unità di ricerca presenti presso l’Istituto Scientifico di Pavia.<br />
Un esempio di queste interazioni è un progetto di ricerca, attualmente<br />
in fase di discussione e che coinvolge il Laboratorio<br />
di Malattie Neurodegenerative (Gabriele Mora e Caterina<br />
Bendotti).<br />
Attività di Ricerca traslazionale<br />
Tutta la attività del Laboratorio di Immunologia Terapeutica<br />
costituisce ricerca traslazionale.<br />
Ricerche in corso<br />
Produzione di anticorpi monoclonali diretti contro il fattore di<br />
crescita HGF/SF e il recettore MET. Questo sistema segnale ha<br />
ruoli fondamentali non solo nel corso dello sviluppo embrionale<br />
ma anche nel corso della rigenerazione dei tessuti e nella<br />
crescita tumorale, in particolare di tumori solidi di origine epiteliale.<br />
Gli anticorpi diretti nei confronti di HGF/SF e MET sono<br />
quindi passibili di molteplici usi in clinica.<br />
Produzione di anticopri monoclonali diretti contro il fattore di<br />
crescita MSP e il recettore RON. Il ruolo di questo secondo sistema<br />
segnale nella rigenerazione dei tessuti è meno chiaro<br />
ma il ruolo di queste molecole nei tumori del colon e della<br />
ghiandola mammaria è molto importante. Verranno prodotti<br />
anticorpi diretti nei confronti di MSP e RON, pertanto, con attività<br />
bloccante e per un possibile impiego nella terapia antitumorale.<br />
Pubblicazioni<br />
Zerbini A, Pilli M, Fagnoni F, Pelosi G, Pizzi MG, Schivazappa<br />
S, Laccabue D, Cavallo C, Schianchi C, Ferrari C,<br />
Missale G. Increased immunostimulatory activity conferred<br />
to antigen presenting cells by exposure to antigen<br />
extract from Hepatocellular Carcinoma after Radiofrequency<br />
Thermal Ablation. Journal of Immunotherapy,<br />
2008; 31: 271-282.<br />
Fagnoni FF, Zerbini A, Pelosi G, Missale G. Combination of<br />
radiofrequency ablation and immunotherapy. Frontiers in<br />
Bioscience, 2008; 13: 369-381.<br />
Varchetta S, Gibelli N, Oliviero B, Nardini E, Gennari R,<br />
Gatti G, Santos Silva L, Villani L, Tagliabue E, Ménard S,<br />
Costa A, Fagnoni FF. Elements related to heterogeneity of<br />
Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity (ADCC) in patients<br />
under trastuzumab therapy for primary operable breast<br />
cancer overexpressing Her2. Cancer Research, 2007; 67:<br />
11801-11809.<br />
Sansoni P, Vescovini R, Fagnoni F, Biasini C, Zanni F, Zanlari<br />
L, Telera A, Lucchini G, Passeri G, Monti D, Franceschi<br />
C, Passeri M. The immune system in extreme longevity. Experimental<br />
Gerontology, 2008; 43: 61-65. Epub 2007 Jul 4.<br />
Vescovini R, Biasini C, Fagnoni FF, Telera AR, Zanlari L, Pedrazzoni<br />
M, Bucci L, Monti D, Medici MC, Chezzi C, Franceschi<br />
C, Sansoni P. Massive load of functional effector<br />
CD4+ and CD8+ T cells against cytomegalovirus in very<br />
old subjects. Journal of Immunology, 2007; 179: 4283-4291.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Prof. Ermanno Gherardi<br />
Data e Luogo di Nascita: 26.10.1952, Pavullo<br />
nel Frignano.<br />
Educazione Superiore: Liceo Classico San<br />
Carlo, Modena (Italy).<br />
Educazione Universitaria: Laurea in Medicina<br />
e Chirurgia (Università di Modena,<br />
1977), PhD in Biologia Molecolare (Università di Cambridge,<br />
1987).<br />
Posizione Attuale: Staff Member del Medical Research<br />
Council (Cambridge, UK) e Professore a tempo definito presso<br />
l’Università di Pavia.<br />
Insegnamenti: Corso di Immunologia presso la Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia.<br />
Interessi di Ricerca: I miei interessi di ricerca sono nel<br />
campo della Biologia Molecolare e dell’Ingegneria Genetica. I<br />
miei studi di dottorato e degli anni successivi sono stati sugli<br />
anticorpi monoclonali e nel campo della maturazione dell’affinità<br />
degli anticorpi nel laboratorio di Cesar Milstein. Un secondo<br />
tema di ricerca che ho sviluppato negli ultimi anni è lo<br />
studio di determinati fattori di crescita e dei loro recettori. Ho<br />
sviluppato nuove metodiche per l’ingegneria genetica di anticorpi<br />
e di proteine in generale e intendo applicare queste metodiche<br />
all produzione di anticorpi ad uso terapeutico.<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
4. LABORATORIO DI ROBOTICA<br />
PER LA RIABILITAZIONE<br />
E L’AUTONOMIA FUNZIONALE<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884749<br />
e-mail: roberto.colombo@fsm.it<br />
Responsabile: Ing. Roberto Colombo<br />
Il Laboratorio di Robotica per la Riabilitazione e l’Autonomia<br />
Funzionale è stato istituito nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria<br />
Biomedica e Tecnologie Biomediche nell’anno 2001.<br />
La missione del laboratorio è quella di sviluppare dispositivi<br />
innovativi per il trattamento e la promozione dell’autonomia<br />
funzionale dei pazienti che afferiscono alle unità di Neurorologia<br />
Riabilitativa e di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
della <strong>Fondazione</strong>. I dispositivi sviluppati vengono proposti a<br />
supporto ed integrazione dell’attività del terapista che quindi<br />
li utilizza come uno strumento in grado di potenziare la sua attività<br />
nell’ambito del piano di trattamento individuale. Grazie<br />
all’impiego di queste tecnologie è possibile migliorare la prestazione<br />
motoria alla dimissione, abbreviare i tempi necessari<br />
per la riabilitazione e fornire parametri oggettivi per la valutazione<br />
del paziente.<br />
Il laboratorio opera presso l’Istituto di Veruno in stretta collaborazione<br />
con università, centri di ricerca e aziende esterne<br />
che operano nel settore della robotica.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’ambito di ricerca del laboratorio è quello del trattamento riabilitativo<br />
basato sull’apprendimento motorio che deriva dalla<br />
ripetizione prolungata di movimenti specifici. In pratica il paziente<br />
si trova a sperimentare un’esperienza sensoriale e mo-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 103<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
toria in cui deve eseguire dei compiti motori assegnati. Per<br />
fare ciò i dispositivi si avvalgono di tecnologie robotiche, meccatroniche<br />
e di realtà virtuale. Il dispositivo robotico valuta interattivamente<br />
il movimento e la forza esercitati dal paziente e<br />
se necessario lo aiuta a portare a termine il compito motorio<br />
assegnato. È evidente che per rispondere alle esigenze di uno<br />
spettro piuttosto ampio di patologie questi sistemi devono essere<br />
nello stesso tempo versatili e specializzati. Pertanto un<br />
altro ambito di ricerca è proprio lo studio delle diverse modalità<br />
di somministrazione dei compiti motori, di interazione con<br />
il paziente e di diversificazione delle esperienze sensorialimotorie<br />
proposte. L’impiego di tecniche di realtà virtuale consente<br />
di mettere a disposizione del paziente ambienti di simulazione<br />
interattivi e multidimensionali. Grazie ad una serie di<br />
interfacce visuali che includono monitors, display indossabili,<br />
interfacce aptiche e dispositivi di tracking del movimento in<br />
tempo reale è possibile creare ambienti virtuali che consentono<br />
al paziente di interagire con oggetti virtuali che in<br />
qualche modo riproducono quelli della vita reale. Questi sistemi<br />
consentono di fornire un intervento terapeutico mirato e<br />
modulato sulle reali capacità del paziente grazie alla somministrazione<br />
di esercizi orientati al compito motorio, alla volontarietà<br />
e alla ripetitività del movimento.<br />
L’attività di ricerca del laboratorio si concretizza in genere nell’ambito<br />
di progetti di ricerca finanziata sia a livello nazionale<br />
che a livello internazionale. In questa prima fase l’attività si è<br />
indirizzata prevalentemente al trattamento riabilitativo dell’arto<br />
superiore con la realizzazione di due dispositivi per il<br />
trattamento del polso e di spalla e gomito.<br />
Principali obiettivi di Ricerca raggiunti:<br />
Progettazione e realizzazione di un dispositivo robotizzato<br />
a 1 grado di libertà per il trattamento dell’articolazione del<br />
polso.<br />
Progettazione e realizzazione di un dispositivo robotizzato<br />
a 2 gradi di libertà per il trattamento delle articolazioni di<br />
spalla e gomito.<br />
Messa a punto di un sistema per la somministrazione di<br />
compiti motori.<br />
Messa a punto di un software per l’analisi della prestazione<br />
motoria ottenuta durante i trattamenti di riabilitazione<br />
robotizzata.<br />
Messa a punto di un sistema per l’analisi del movimento<br />
dell’arto superiore.<br />
Studio dell’efficacia del trattamento robotizzato mediante<br />
la valutazione di scale cliniche e di parametri quantitativi.<br />
PARTECIPAZIONI A PROGETTI FINANZIATI<br />
Tecniche robotizzate per la valutazione ed il trattamento<br />
riabilitativo delle disabilità motorie dell’arto superiore”,<br />
2001-175 finanziato dal Ministero della Salute.<br />
Tools per la Riabilitazione: Riabilitazione Robotizzata e Teleriabilitazione,<br />
finanziato dal Ministero della Salute.<br />
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO<br />
Studio dell’apprendimento motorio e del controllo della<br />
forza durante trattamento con tecniche robotizzate.<br />
Studio di dispositivi per il trattamento robotizzato in uno<br />
spazio di lavoro a 3 dimensioni.<br />
Studio di un dispositivo basato su tavoletta grafica per l’incremento<br />
dell’autonomia funzionale dell’arto superiore.<br />
Sviluppo di un’architettura di tele-riabilitazione per la riabilitazione<br />
robotizzata.<br />
104<br />
PROGETTI DI RICERCA FUTURI<br />
“Messa a punto di nuove metodologie per la Tele-Riabilitazione<br />
Neuromotoria” (Ricerca Strategica MIUR).<br />
Sistemi di trattamento basati sull’impiego di tecnologie di<br />
realtà virtuale.<br />
Studio del recupero delle sinergie muscolari mediante valutazione<br />
quantitativa del segnale EMG.<br />
Attività Educazionale<br />
L’attività educazionale del laboratorio ha lo scopo di diffondere<br />
l’attività svolta, i risultati della ricerca ed in generale la<br />
cultura relativa alle tematiche trattate attraverso la comunicazione<br />
nell’ambito di corsi e convegni sia a livello nazionale che<br />
a livello internazionale.<br />
Il Laboratorio accoglie tesisti e specializzandi della facoltà di<br />
Ingegneria del Politecnico di Milano e delle altre facoltà universitarie<br />
con cui mantiene stretti rapporti.<br />
Nell’anno 2006 è stato organizzato il convegno internazionale:<br />
“Impiego di nuove tecnologie nei trattamenti di Neuroriabilitazione”<br />
che ha visto l’attenta partecipazione di numerosi Riabilitatori,<br />
Terapisti e Tecnici del settore.<br />
Collaborazioni<br />
Department of Cybernetics - University of Reading (UK).<br />
ARTSLAB Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa.<br />
Dipartimento di Informatica, Sistemi e Telecomunicazioni -<br />
Università di Genova.<br />
Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale -<br />
Università di Padova<br />
Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di<br />
Pavia.<br />
Pubblicazioni<br />
Colombo R, Pisano F, Mazzone A, Delconte C, Micera S,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Design strategies to improve<br />
patient motivation during robot-aided rehabilitation.<br />
J Neuroengineering Rehabil. 2007 Feb 19; 4: 3.<br />
Colombo R, Pisano F, Micera S, Mazzone A, Delconte C,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Assessing Mechanisms<br />
of Recovery During Robot-Aided Neurorehabilitation of<br />
the Upper Limb” in Neurorehabilitation and Neural Repair<br />
(NNR). 2007 Jul 11; [Epub ahead of print].<br />
Pisano F, Delconte C, Mazzone A, Pianca D, Micera S, Carrozza<br />
MC, Dario P, Colombo R. Rehabilitation treatment<br />
with robotics in stroke. G Ital Med Lav Ergon. 2007 Jan-<br />
Mar; 29 (1): 90-6. Italian.<br />
Giordano A, Colombo R, Minuco G. New technologies in<br />
assessment and rehabilitation treatments. G Ital Med Lav<br />
Ergon. 2007 Jan-Mar; 29 (1): 56-61. Italian.<br />
Miscio G, Pisano F, Del Conte C, Colombo R, Schieppati M.<br />
Concurrent changes in shortening reaction latency and<br />
reaction time of forearm muscles in post-stroke patients.<br />
Neurol Sci. 2006 Feb; 26 (6): 402-10.<br />
Pisano F, Delconte C, Mazzone A, Minuco G, Carrozza MC,<br />
Micera S, Dario P, Colombo R. Usefulness of Robotic Technology<br />
for assessing Motor Recovery and improving<br />
Neurorehabilitation. Int. Workshop on Motor Learning in<br />
Stroke Recovery, Trigoria, Roma, 19-20 Marzo 2007.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Colombo R, Pisano F, Mazzone A, Delconte C, Minuco G.<br />
Development of a Systems Architecture for Robot-Aided<br />
Telerehabilitation. In Proceedings of Int. Conf. on Rehabilitation<br />
Robotics, Noordwijk aan Zee, The Netherland 13-<br />
15/06, 2007.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Ing. Roberto Colombo. Si è laureato in Ingegneria<br />
Elettronica presso il Politecnico di Milano<br />
nel 1980. È in ruolo presso il Servizio di<br />
Bioingegneria della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> - Istituto Scientifico di Veruno dal<br />
1981. Dal giugno 2007 è responsabile del Laboratorio<br />
di Bioingegneria della Riabilitazione<br />
dell’Istituto Scientifico di Pavia. Nell’ambito di<br />
questa consistente esperienza ha collaborato con le divisioni<br />
di Cardiologia, Pneumologia, Fisiatria e Neurologia dell’Istituto<br />
nello sviluppo di numerosi progetti di ricerca a carattere nazionale<br />
ed internazionale. Dal 1998 al 2001, è stato partner del<br />
progetto EC “Prevention of muscular disorders in operation of<br />
computer input devices (PROCID). Dal 2001 al 2004, è stato<br />
responsabile del progetto di ricerca finalizzata “Tecniche robotizzate<br />
per la valutazione ed il trattamento riabilitativo delle<br />
disabilità motorie dell’arto superiore”, 2001-175, finanziato dal<br />
Ministero della Salute. I principali temi di ricerca che lo vedono<br />
coinvolto sono: studio del controllo cardiovascolare per<br />
mezzo di tecniche di analisi spettrale del segnale di variabilità<br />
del ciclo cardiaco, studio della valutazione dei parametri di<br />
meccanica respiratoria, studio del tono muscolare e valutazione<br />
della spasticità, studio della forza muscolare e dell’affaticamento,<br />
studio dei processi di produzione della parola, neuroriabilitazione<br />
mediante dispositivi robotizzati. Ha insegnato<br />
nell’ambito di diversi corsi a livello nazionale nel campo della<br />
neuroriabilitazione ed è autore di oltre 40 pubblicazioni recensite<br />
e co-editore di un libro sui meccanismi di produzione<br />
della parola. Promotore e organizzatore di eventi scientifici nazionali<br />
e internazionali è reviewer per alcune riviste scientifiche<br />
internazionali. Attualmente è Senior Member della IEEE<br />
Engineering Society e della IEEE Engineering in Medicine and<br />
Biology Society, e membro della Società Italiana di Riabilitazione<br />
di Alta Specializzazione (SIRAS).<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
5. CENTRO PER LA VALUTAZIONE<br />
FUNZIONALE IN MEDICINA<br />
RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884711<br />
e-mail: franco.franchignoni@fsm.it<br />
Responsabile: Dr. Franco Franchignoni<br />
Questa unità operativa di ricerca ha sede presso il Servizio di<br />
Fisiatria Occupazionale e Ergonomia dell’Istituto Scientifico di<br />
Veruno e svolge attività tesa a costituire un polo di riferimento<br />
nell’area connessa alle problematiche di misurazione in Medicina<br />
Riabilitativa, in particolare applicate all’uso di apparecchiature,<br />
tecnologie, test e scale per la valutazione funzionale<br />
di tipo neuromotorio in soggetti disabili o a rischio di disabilità<br />
(e più specificamente agli indicatori di risultato / “outcome”).<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività del Centro prevede non solo la scelta e l’analisi comparativa<br />
di prodotti già esistenti ma anche lo sviluppo e la validazione<br />
di indicatori funzionali innovativi e più in generale<br />
mira a selezionare gli strumenti più idonei per un miglioramento<br />
continuo dell’attività clinica e gestionale di tipo riabilitativo<br />
e per processi di verifica e revisione di qualità del settore.<br />
In questi ambiti, i principali settori oggetto di recenti ricerche,<br />
molte delle quali ancora in corso, sono stati:<br />
Adattamento transculturale e/o validazione (con metodiche<br />
psicometriche classiche e con modelli di Rasch) di<br />
scale di indipendenza funzionale, equilibrio, mobilità,<br />
paura di cadere, qualità di vita, attività e partecipazione in<br />
differenti popolazioni di pazienti con disabilità.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 105<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Analisi della mobilità nel lungo periodo e dell’equilibrio tramite<br />
registratori avanzati di attività motorie, in pazienti neurologici,<br />
ortopedici, vascolari e con disturbi cardio-respiratori.<br />
Analisi in funzione del trattamento riabilitativo di disturbi<br />
dell’equilibrio, dei passaggi posturali e della marcia nella<br />
malattia di Parkinson.<br />
Valutazione del recupero funzionale dell’amputato di arto<br />
superiore e inferiore in corso di protesizzazione e riabilitazione,<br />
e studi sui fattori legati all’utilizzazione di una protesi<br />
tibiale o femorale (progetti in collaborazione con<br />
INAIL e con Centri stranieri).<br />
Problematiche relative alla metodologia ed alla valutazione<br />
della ricerca in Medicina Riabilitativa.<br />
Tali attività sono svolte sia tramite propri progetti (ricercando<br />
le necessarie interazioni e risorse) sia fornendo guida e/o supporto<br />
ad altri ricercatori, sia interni che esterni alla <strong>Fondazione</strong>,<br />
in Italia e all’estero (anche tramite collaborazioni multicentriche<br />
con unità negli Stati Uniti, in Svizzera, Francia, Gran<br />
Bretagna, Spagna, Irlanda, Slovenia, Grecia ed Israele).<br />
Collateralmente, l’Unità punta a potenziare il trasferimento di<br />
know-how tecnico-scientifico in campo neuromotorio-funzionale,<br />
curando gli aspetti di trasferibilità dei prodotti selezionati,<br />
non solo all’interno della <strong>Fondazione</strong> ma anche ad altri<br />
utenti, tra i quali il SSN (secondo gli obiettivi del Piano Sanitario<br />
Nazionale e come richiesto anche dalla legge sul riordino<br />
dell’organizzazione degli IRCCS).<br />
Inoltre, l’Unità promuove — nell’area di competenza — iniziative di<br />
formazione continua ed aggiornamento (anche di tipo editoriale e<br />
congressuale) nei confronti di personale sia interno che esterno<br />
(italiano e straniero), è sede di tirocinio per Corsi di Laurea in Fisioterapia<br />
e Terapia Occupazionale, e Specializzazione in Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione, e svolge didattica presso:<br />
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo<br />
Avogadro’, Novara - Corso di Laurea per Fisioterapista<br />
(Corsi di “Metodologia e tecniche della riabilitazione motoria<br />
speciale”, “Tecniche di riabilitazione con la metodica<br />
isocinetica”, “Metodologia generale della riabilitazione<br />
motoria e fisioterapia strumentale”, “Metodologia della Ricerca<br />
e Consultazione Banche Dati”);<br />
Università degli Studi di Pavia - Corso di Laurea per Terapisti<br />
Occupazionali (Corsi di “Tecniche di terapia occupazionale”<br />
e “Scale di valutazione in terapia occupazionale”);<br />
in precedenza anche presso l’Università Tor Vergata di<br />
Roma e quella degli Studi di Genova.<br />
Pubblicazioni<br />
Franchignoni F, Orlandini D, Ferriero G, Moscato TA. Reliability,<br />
validity and responsiveness of the Locomotor Capabilities<br />
Index in adults with lower-limb amputation undergoing prosthetic<br />
training. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85 (5): 743-8.<br />
Ferriero G, Brunetto A, Sartorio F, Vercelli S. Severe humeral<br />
erosion in a bedridden patient: a comprehensive intervention<br />
to prevent bone fracture. Am J Phys Med<br />
Rehabil 2004; 83: 931-933.<br />
Ferriero G, Dughi D, Orlandini D, Moscato TA, Nicita D,<br />
Franchignoni F. Measuring long-term outcome in people<br />
with lower limb amputation: cross-validation of the Italian<br />
versions of the Prosthetic Profile of the Amputee and Prosthesis<br />
Evaluation Questionnaire. Eura Medicophys 2005;<br />
41 (1): 1-6.<br />
106<br />
Franchignoni F, Martignoni E, Ferriero G, Pasetti C. Balance<br />
and fear of falling in Parkinson’s disease. Parkinsonism<br />
Relat Disord 2005; 11: 427-33.<br />
Negrini S, Boccardi S, Franchignoni F, Di Benedetto P,<br />
Oliaro A. Short history of Europa Medicophysica: 41 years<br />
of contributions to the scientific roots of the Speciality of<br />
Physical and Rehabilitation Medicine. Eura Medicophys<br />
2005; 4: 219-22.<br />
Franchignoni F, Velozo CA. Use of the Berg Balance Scale<br />
in rehabilitation evaluation of patients with Parkinson’s disease.<br />
Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 2225-6.<br />
Bonaiuti D, Arioli G, Diana G, Franchignoni F, Giustini A,<br />
Monticone M, Negrini S, Maini M. SIMFER Rehabilitation<br />
treatment guidelines in postmenopausal and senile osteoporosis.<br />
Eura Medicophys 2005; 41: 315-37.<br />
Sartorio F, Vercelli S, Ferriero G, D’Angelo F, Migliario M,<br />
Franchignoni M. [Work-related musculoskeletal diseases<br />
in dental professionals. 1. Prevalence and risk factors] G<br />
Ital Med Lav Ergon 2005; 27: 165-9.<br />
Sartorio F, Franchignoni F, Ferriero G, Vercelli S, Odescalchi<br />
L, Augusti D, Migliario M. [Work-related musculoskeletal<br />
disorders in dentistry professionals. 2. Prevention,<br />
ergonomic strategies and therapeutic programs] G Ital<br />
Med Lav Ergon 2005; 27: 442-8.<br />
Franchignoni F, Ring H. Measuring change in rehabilitation<br />
medicine. Eura Medicophys 2006; 42: 1-3.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Dr. Franco Franchignoni.<br />
Dal 1/1/1995 al 31/12/1998 è stato coordinatore<br />
del Gruppo Scientifico per la Riabilitazione<br />
Neuromotoria della FSM.<br />
Dal 1/1/1999 al 31/12/2001 è stato Responsabile<br />
del Dipartimento di Medicina<br />
Riabilitativa Neuromotoria - Settore Fisiatrico<br />
della FSM.<br />
Dal 1/1/2005 è Responsabile del Dipartimento Ergonomia e<br />
Terapia Occupazionale della FSM.<br />
Attività Scientifica<br />
Ha pubblicato 162 lavori scientifici: 86 su riviste, di cui 46 censite<br />
dall’Index Medicus o dal Science Citation Index, e 76 su<br />
volumi (atti di convegni e capitoli di libri). Inoltre, ha al suo attivo<br />
molti abstracts e un numero elevato di relazioni (vedi<br />
oltre), comunicazioni e poster.<br />
Insegnamenti<br />
DOCENTE al Corso per Massofisioterapisti dell’USSL 51 Novara<br />
per la materia “Anatomia” nel 1985/86.<br />
DOCENTE alla Scuola Superiore per Terapisti della Riabilitazione<br />
dell’USSL 51 Novara per la materia “Massoterapia”<br />
nel 1981/82, 1982/83, 1988/89; per la materia “Terapia Occupazionale”<br />
nel 1991/92; per la materia “Biomeccanica”<br />
nel 1993/1994.<br />
DELEGATO PER LA DIDATTICA AGGIUNTIVA presso la<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
dell’Università di Torino per la materia “Neuropatologia”<br />
nel 1990/91.<br />
PROFESSORE A CONTRATTO presso la Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro dell’Università di Pavia, per<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
la materia “Rischi da lavoro manuale: prevenzione e valutazione”,<br />
dal 1991/92 al 1993/94 e per la materia “Rischi da<br />
postura: prevenzione e valutazione” dal 1994/95 al 1998/99.<br />
PROFESSORE A CONTRATTO presso la Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di<br />
Genova, per la materia “Medicina Fisica e Riabilitazione” dal<br />
1996 al 2002.<br />
PROFESSORE A CONTRATTO presso la Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di<br />
Roma “Tor Vergata”, per il Corso Integrato “La ricerca in<br />
Medicina Riabilitativa” dell’insegnamento di Cinesiologia 2,<br />
per gli a.a. 2000/2001 e 2001/02.<br />
Dal 1991 ad oggi PROFESSORE A CONTRATTO presso la<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
dell’Università di Torino, per la materia “Neuropsicologia<br />
clinica e Riabilitazione” (1991/92) e per la materia “Cinesiologia”<br />
dal 1992/93 ad oggi.<br />
Dal 1998 ad oggi DOCENTE presso il Corso di Laurea (già<br />
Diploma Universitario) per Fisioterapista dell’Università “A.<br />
Avogadro” del Piemonte Nord-Orientale in Novara, Insegnamento<br />
di “Medicina Fisica e Riabilitativa 1”, Corso integrato<br />
di “Metodologia Generale della Riabilitazione Motoria<br />
e Fisioterapia Strumentale”.<br />
Dal 2001 ad oggi PROFESSORE A CONTRATTO presso il<br />
CdL per Terapisti Occupazionali dell’Università di Pavia -<br />
a.a. 2001/2002: Corso integrativo “Scale di valutazione in terapia<br />
occupazionale” (1° anno) nel corso Scienze della Terapia<br />
Occupazionale (1° anno); a.a. 2002/2003: Corso integrativo<br />
“Scale di valutazione in terapia occupazionale” nel<br />
corso Scienze della Terapia Occupazionale (1° anno) e<br />
Corso integrativo “Tecniche di terapia occupazionale” nel<br />
corso Medicina Fisica e Riabilitativa - Terapia Occupazionale<br />
(2° anno); dall’a.a. 2003/2004 ad oggi: Corso integrativo<br />
“Tecniche di terapia occupazionale” nel corso Medicina<br />
Fisica e Riabilitativa - Terapia Occupazionale (2° anno).<br />
Incarichi in Società Scientifiche<br />
Vicepresidente Nazionale delegato all’aggiornamento<br />
scientifico della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
(SIMFER) (1990-93) e Membro del Consiglio Nazionale<br />
della stessa Società (1990-96), poi Proboviro<br />
(1996-99) e quindi Revisore dei Conti (1999-2002).<br />
Membro della Segreteria Regionale Piemontese della<br />
SIMFER: delegato per l’attività scientifica e l’aggiornamento<br />
professionale (1990-96) e cooptato per la ricerca scientifica<br />
(dal 2002 ad oggi).<br />
Membro (per cooptazione) dell’Académie Européenne de<br />
Médecine de Réadaptation dal 1999 e membro del suo Consiglio<br />
Direttivo e del Comitato per la Ricerca dal 2003.<br />
Rappresentante della SIMFER alla International Society of<br />
Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) dal 2002 e<br />
membro del By-Laws Committee della ISPRM dal 2006.<br />
Rappresentante della SIMFER alla UEMS (Union Européenne<br />
des Medicins Specialistes) - PRM section (European<br />
Board of Physical and Rehabilitation Medicine) dal<br />
2004 e Vice-Presidente dell’UEMS European Board of<br />
PRM dal 2006.<br />
Attività editoriale<br />
Rivista Europa Medico-Physica, organo Ufficiale della<br />
SIMFER e della Federazione Europea di Medicina Fisica e<br />
Riabilitazione, censito da Excerpta Medica: Assistant<br />
Editor (1986-1991); Associate Editor (1991-1992); Chief<br />
Editor (Redattore Capo) (1992-1995); Senior Editor (già<br />
Honorary Consulting Editor) (1995-oggi).<br />
Rivista Journal of Rehabilitation Medicine (già Scandinavian<br />
Journal of Rehabilitation Medicine), censita da Index Medicus<br />
e Science Citation Index: Membro del Board di Redazione<br />
dal gennaio 2001 e anche Membro dell’Editorial<br />
Committee (Consiglio ristretto di Redazione) dal 2003. Dal<br />
2006 Associate Editor della rivista.<br />
Rivista Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia,<br />
censita da Index Medicus: Membro del Comitato<br />
di Redazione dal 1996 ad oggi.<br />
Ha curato la pubblicazione di 11 volumi (in italiano e in inglese)<br />
di interesse riabilitativo.<br />
Altri incarichi professionali<br />
Responsabile di un’Unità Operativa di Progetto Finalizzato<br />
Tecnologie Biomediche e Sanitarie del CNR e Responsabile<br />
di Progetti e di Unità Operative nell’ambito di Ricerche<br />
Finalizzate del Ministero della Salute.<br />
Membro di Commissioni del Ministero della Sanità, riunite<br />
su problematiche relative alla riabilitazione dell’età evolutiva<br />
(Commissione “Doman”) e sull’organizzazione della MedicinaRiabilitativa<br />
in Italia (Sottocommissione degli IRCCS relativa<br />
al progetto “Linee-guida per la riabilitazione”).<br />
Qualificato alla pratica della Specialità di “Physical Medicine<br />
and Rehabilitation” dal European Board of Physical<br />
Medicine and Rehabilitation (certif. n. 1059) (dal 1995).<br />
Membro del Consiglio Direttivo della Scuola Universitaria<br />
di Psicologia Applicata dell’Università di Torino (1992-2001).<br />
Membro della Giuria internazionale della <strong>Fondazione</strong><br />
belga Van Goethem-Brichant (établissement d’utilité publique,<br />
Rue d’Egmont 11, Bruxelles) (2001-2002).<br />
Esperto del Ministero della Salute per il programma<br />
ECM, per la valutazione culturale e scientifica degli eventi<br />
formativi e dei progetti formativi aziendali, gestito dalla Commissione<br />
Nazionale per la Formazione Continua (DAL 2002).<br />
Ha partecipato a numerose Riunioni Scientifiche (nazionali ed<br />
internazionali, in Italia ed all’estero), sia come Membro di Comitato<br />
Scientifico, Presidente di Sessione, Moderatore /<br />
Chairmen, sia in qualità di Relatore / Invited Speaker / Keynote<br />
Lecturer. Si segnalano negli ultimi anni relazioni ad invito al 4th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine<br />
(2002), al 2nd World Congress of the International Society<br />
of Physical and Rehabilitation Medicine (2003), al 7th (2003)<br />
and 9th (2006) Panhellenic Congress of Physical and Rehabilitation<br />
Medicine ed al 14th European Congress of Physical and<br />
Rehabilitation Medicine (2004), al I Meeting Italo-tedesco delle<br />
Società di Medicina Fisica e Riabilitazione (2005), alla Euro-<br />
Mediterranean P&RM School (2005, 2006), al 6th Mediterranean<br />
Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (2006),<br />
alla Escuela Fisioterapia Univ. Complutense Madrid (2006), al<br />
4-Laender Treffen - Incontro quadrangolare di Società Nazionali<br />
di Medicina Fisica e Riabilitazione (2007), alle VIII giornate<br />
internazionali di Medicina Fisica e Riabilitativa di Porto (2007),<br />
alla European School of Marseille on Motor disabilities (2007).<br />
Ha organizzato manifestazioni scientifiche, tra le quali un Congresso<br />
Nazionale ed il 5° e il 9° Corso di Aggiornamento Nazionale<br />
della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 107<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
6. LABORATORIO DI BIOINGEGNERIA<br />
DELLA RIABILITAZIONE<br />
Istituto Scientifico di Pavia<br />
Via S. <strong>Maugeri</strong>, 10<br />
tel. 0382.5921<br />
e-mail: roberto.colombo@fsm.it<br />
Responsabile: Ing. Roberto Colombo<br />
Presso L’istituto Scientifico di Pavia si svolge ricerca di base e<br />
applicata nel campo della Bioingegneria Riabilitativa. I particolare<br />
l’attività svolta si riferisce alle seguenti tematiche principali:<br />
Metodi di Assessment Neurofisiologico mediante Stimolazione<br />
Magnetica.<br />
Robotica per la Riabilitazione e l’Autonomia Funzionale.<br />
Elaborazione ed Analisi dei Segnali Biologici.<br />
Gli obbiettivi dell’attività di questo laboratorio, afferente al Dipartimento<br />
di Bioingegneria e Tecnologie Biomediche, sono il<br />
miglioramento delle capacità diagnostiche e l’ideazione di<br />
nuovi strumenti terapeutici nell’ambito della Medicina Riabilitativa<br />
Neuromotoria. Supporto essenziale per il perseguimento<br />
dei citati obbiettivi è la progettazione e realizzazione di<br />
strumenti per l’esecuzione di studi legati all’attività lavorativa,<br />
al recupero del disabile, alla valutazione funzionale dell’anziano,<br />
dello sportivo e anche del paziente con piccoli traumi<br />
da carico, alla definizione del protocollo riabilitativo, al followup<br />
dello stesso e lo studio di materiali innovativi per applicazioni<br />
in riabilitazione.<br />
Attività di Ricerca<br />
Metodi per l’indagine dell’integrazione sensorimotoria<br />
e dei fenomeni di plasticità neuronale<br />
(Resp. Ing. Jan Nilsson)<br />
Scopo di questo tema di ricerca è quello di sviluppare metodi<br />
di applicazione della stimolazione magnetica transcranica per<br />
108<br />
l’indagine dell’integrazione sensorimotoria e dei fenomeni di<br />
plasticità neuronale per la terapia del dolore e lo studio del<br />
controllo motorio durante il movimento umano.<br />
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO<br />
Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva per la terapia<br />
del dolore: applicazione terapeutica.<br />
Tecnica di registrazione con elettrodi di superficie durante<br />
la stimolazione tattile in pazienti diabetici.<br />
Metodiche cliniche e Neurofisiologiche per la quantificazione<br />
e “understanding of the physiology” del dolore.<br />
Misure obiettive per la valutazione della Neuroriabilitazione.<br />
Stimolazione magnetica durante il cammino.<br />
Stimolazione magnetica (rTMS) in Neuropsicologia.<br />
2° Workshop - La stimolazione magnetica: 20 anni di<br />
esperienza.<br />
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI<br />
Stimolazione Magnetica Transcranica Ripetitiva (SMTr) in neuropsichiatria:<br />
applicazioni terapeutiche (MinSan 2001-2003).<br />
PROGETTI DI RICERCA FUTURI<br />
Creazione di programmi dedicati all’applicazione di nuove<br />
metodiche quantitative nell’ambito della neuroriabilitazione.<br />
Studio dei fenomeni di plasticità neuronale correlabili alle<br />
tecniche riabilitative utilizzate, inclusa l’eccitabilità della<br />
corteccia motoria durante la fase riabilitativa.<br />
Creazione dei programmi dedicati all’applicazione delle<br />
nuove metodiche robotiche per la neuroriabilitazione.<br />
Tecniche Robotizzate per la Riabilitazione<br />
e l’Autonomia Funzionale (Resp. Ing. R. Colombo)<br />
Scopo di questo tema di ricerca è quella di sviluppare dispositivi<br />
innovativi per il trattamento clinico e la promozione dell’autonomia<br />
funzionale dei pazienti che afferiscono alle unità<br />
di Neuroriabilitazione, di Recupero e Rieducazione Funzionale,<br />
e di Terapia Occupazionale ed Ergonomia dell’Istituto. In<br />
particolare nei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite<br />
quali ictus e traumi cranici viene proposta una tecnica di riabilitazione<br />
sensoriale-motoria ottenuta mediante dispositivi<br />
robotizzati. Essa viene utilizzata in supporto alle tradizionali<br />
tecniche riabilitative e può migliorare la prestazione motoria<br />
alla dimissione, abbreviare i tempi necessari per la riabilitazione<br />
e fornire parametri oggettivi per la valutazione del paziente.<br />
Inoltre vengono studiati dispositivi anche per i pazienti<br />
che pur conservando delle discrete capacità di movimento<br />
nello spazio necessitano di incrementare la qualità del movimento<br />
soprattutto durante l’esecuzione di movimenti che prevedono<br />
l’azione coordinata di più muscoli come accade durante<br />
l’esecuzione di movimenti funzionali. Un ulteriore sviluppo<br />
di queste tecnologie è quello della loro applicazione in<br />
ambito remotizzato mediante lo studio e la validazione di sistemi<br />
e protocolli di teleriabilitazione. Questo laboratorio<br />
agisce congiuntamente a quello già presente presso il Servizio<br />
di Bioingegneria di Veruno per lo sviluppo di dispositivi che<br />
vengono proposti a supporto ed integrazione dell’attività del<br />
terapista della riabilitazione per potenziare la sua attività nell’ambito<br />
del piano di trattamento individuale.<br />
L’attività di ricerca del laboratorio si concretizza in genere nell’ambito<br />
di progetti di ricerca finanziata sia a livello nazionale<br />
che a livello internazionale. In questa prima fase l’attività si è<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
indirizzata prevalentemente al trattamento riabilitativo dell’arto<br />
superiore con la realizzazione di due dispositivi per il<br />
trattamento del polso e di spalla e gomito.<br />
Principali obiettivi di Ricerca raggiunti:<br />
Realizzazione ed applicazione di un dispositivo robotizzato<br />
a 2 gradi di libertà per il trattamento delle articolazioni di<br />
spalla e gomito.<br />
Messa a punto di un sistema per la somministrazione di<br />
compiti motori.<br />
Messa a punto di un software per l’analisi della prestazione<br />
motoria ottenuta durante i trattamenti di riabilitazione<br />
robotizzata.<br />
Messa a punto di un sistema per l’analisi del movimento<br />
dell’arto superiore.<br />
Studio dell’efficacia del trattamento robotizzato mediante<br />
la valutazione di parametri cinematici.<br />
PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI<br />
Tools per la Riabilitazione: Riabilitazione Robotizzata e Teleriabilitazione.<br />
Progetto finanziato dal Ministero della Salute.<br />
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO<br />
Studio del controllo della forza durante riabilitazione robotizzata.<br />
Sviluppo di un’architettura di tele-riabilitazione per la riabilitazione<br />
robotizzata.<br />
Utilizzo di tecniche robotiche per la riabilitazione del deficit<br />
motorio distale dell’arto superiore nei pazienti con<br />
esiti di stroke.<br />
Sviluppo di un algoritmo di controllo per la riabilitazione<br />
robotizzata delle sinergie muscolari e della coordinazione<br />
dell’arto superiore.<br />
PROGETTI DI RICERCA FUTURI<br />
Tecnologie innovative per la riabilitazione della disabilità<br />
motoria a seguito di patologia oncologica.<br />
Impiego di tecniche robotizzate per la neuroriabilitazione<br />
del paziente oncologico disabile.<br />
Studio di un dispositivo robotizzato per il trattamento della<br />
mano.<br />
Sistemi di trattamento basati sull’impiego di tecnologie di<br />
realtà virtuale.<br />
Studio del recupero delle sinergie muscolari mediante valutazione<br />
quantitativa del segnale EMG.<br />
Elaborazione ed analisi dei segnali Biologici<br />
Questo tema è dedicato allo sviluppo di procedure software<br />
per l’acquisizione, l’elaborazione ed analisi dei segnali biologici<br />
provenienti dai pazienti che partecipano ai diversi progetti<br />
di ricerca dell’Istituto. In particolare al momento sono già attive<br />
collaborazioni scientifiche nell’ambito dello studio dei<br />
processi di produzione della parola con applicazione alla neurotossicologia<br />
e nell’ambito dell’analisi automatica dei parametri<br />
di meccanica respiratoria.<br />
PROGETTI DI RICERCA FUTURI<br />
Studio multicentrico per l’analisi automatica dei parametri<br />
di meccanica respiratoria.<br />
Attività Educazionale<br />
L’attività educazionale del laboratorio ha lo scopo di diffondere<br />
l’attività svolta, i risultati della ricerca ed in generale la<br />
cultura relativa alle tematiche trattate attraverso la comunicazione<br />
nell’ambito di corsi e convegni sia a livello nazionale che<br />
a livello internazionale.<br />
Il Laboratorio accoglie tesisti e specializzandi della facoltà di<br />
Ingegneria dell’Università di Pavia. Nell’anno 2006 è stato organizzato<br />
il convegno internazionale: “Impiego di nuove tecnologie<br />
nei trattamenti di Neuroriabilitazione” che ha visto<br />
l’attenta partecipazione di numerosi Riabilitatori, Terapisti e<br />
Tecnici del settore.<br />
Collaborazioni<br />
ARTSLAB Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa.<br />
Dipartimento di Informatica, Sistemi e Telecomunicazioni<br />
- Università di Genova.<br />
Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Università di<br />
Pavia.<br />
Brain & Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of<br />
Technology, Boston, Usa.<br />
Pubblicazioni<br />
Colombo R, Pisano F, Mazzone A, Delconte C, Micera S,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Design strategies to improve<br />
patient motivation during robot-aided rehabilitation.<br />
J Neuroengineering Rehabil. 2007 Feb 19; 4: 3.<br />
Colombo R, Pisano F, Micera S, Mazzone A, Delconte C,<br />
Carrozza MC, Dario P, Minuco G. Assessing Mechanisms<br />
of Recovery During Robot-Aided Neurorehabilitation of<br />
the Upper Limb. In Neurorehabilitation and Neural Repair<br />
(NNR). 2007 Jul 11; [Epub ahead of print].<br />
Zanaboni S, Krauss B, Buscaglia R, Montagnini C, Gratarola<br />
A, Gualino J, Colombo R, Corte FD. Changes in respiratory<br />
and hemodynamic parameters during low-dose<br />
propofol sedation in combination with regional anesthesia<br />
for herniorrhaphy and genitourinary surgery in children.<br />
Paediatr Anaesth 2007 Oct; 17 (10): 934-41.<br />
Pisano F, Delconte C, Mazzone A, Pianca D, Micera S, Carrozza<br />
MC, Dario P, Colombo R. Rehabilitation treatment<br />
with robotics in stroke. G Ital Med Lav Ergon. 2007 Jan-<br />
Mar; 29 (1): 90-6. Italian.<br />
Giordano A, Colombo R, Minuco G. New technologies in<br />
assessment and rehabilitation treatments. G Ital Med Lav<br />
Ergon. 2007 Jan-Mar; 29 (1): 56-61. Italian.<br />
Miscio G, Pisano F, Del Conte C, Colombo R, Schieppati M.<br />
Concurrent changes in shortening reaction latency and<br />
reaction time of forearm muscles in post-stroke patients.<br />
Neurol Sci 2006 Feb; 26 (6): 402-10.<br />
Mezzani A, Corra U, Sassi B, Colombo R, Giordano A,<br />
Giannuzzi P. Maximal accumulated oxygen deficit in patients<br />
with chronic heart failure. Med Sci Sports Exerc<br />
2006 Mar; 38 (3): 424-32.<br />
Poggi R, Appendini L, Polese G, Colombo R, Donner CF,<br />
Rossi A. Noninvasive proportional assist ventilation and<br />
pressure support ventilation during arm elevation in patients<br />
with chronic respiratory failure. A preliminary, physiologic<br />
study. Respir Med 2006 Jun; 100 (6): 972-9.<br />
Nilsson J, De Nunzio AM, Grasso M, Nardone A, Schieppati<br />
M. Effect of alternating trains of vibration applied on<br />
muscle tendons. Comparison of postural responses in patients<br />
with Parkinson’s disease and healthy controls. Clin<br />
Neurophys 2007.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 109<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Nilsson J, Tommolillo B, Bazzani M, Panizza M. Surface recorded<br />
tactile evoked responses: A non-invasive technique<br />
that increases the diagnostic yield in patients with<br />
diabetes. Journal of the Peripheral Nervous System 2007:<br />
12: 164-165.<br />
Nilsson J, Panizza M. Magnetic stimulation of peripheral<br />
nerve and roots. Funct Neurol 2006; 21 (2): 110-111.<br />
Nilsson J, Panizza M, Farina M, Assente R. Motor evoked<br />
potentials recorded via surface electrodes and wireless<br />
EMG system during magnetic stimulation. Funct Neurol<br />
2006; 21 (2): 123.<br />
Mognaschi ME, Alfonsi E, Nilsson J, Moglia A. Experimental<br />
results on excitability of peripheral motor axons by<br />
means of a magnetic stimulus. Funct Neurol 2006; 21 (2):<br />
119-120.<br />
Nilsson J, Panizza M. Magnetic stimulation: Physics and<br />
basic principles of nerve activation. Fisica in Medicina<br />
(AIFM) 2006; 1: 7-24.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Ing. Roberto Colombo. Si è laureato in Ingegneria<br />
Elettronica presso il Politecnico di Milano<br />
nel 1980. È in ruolo presso il Servizio di<br />
Bioingegneria della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> - Istituto Scientifico di Veruno dal<br />
1981. Dal giugno 2007 è responsabile del Laboratorio<br />
di Bioingegneria della Riabilitazione<br />
dell’Istituto Scientifico di Pavia. Nell’ambito di<br />
questa consistente esperienza ha collaborato con le divisioni<br />
di Cardiologia, Pneumologia, Fisiatria e Neurologia dell’Istituto<br />
nello sviluppo di numerosi progetti di ricerca a carattere nazionale<br />
ed internazionale. Dal 1998 al 2001, è stato partner del<br />
progetto EC “Prevention of muscular disorders in operation of<br />
computer input devices” (PROCID). Dal 2001 al 2004, è stato<br />
responsabile del progetto di ricerca finalizzata “Tecniche robotizzate<br />
per la valutazione ed il trattamento riabilitativo delle<br />
disabilità motorie dell’arto superiore”, 2001-175, finanziato dal<br />
Ministero della Salute. I principali temi di ricerca che lo vedono<br />
coinvolto sono: studio del controllo cardiovascolare per<br />
mezzo di tecniche di analisi spettrale del segnale di variabilità<br />
del ciclo cardiaco, studio della valutazione dei parametri di<br />
meccanica respiratoria, studio del tono muscolare e valutazione<br />
della spasticità, studio della forza muscolare e dell’affaticamento,<br />
studio dei processi di produzione della parola, neuroriabilitazione<br />
mediante dispositivi robotizzati. Ha insegnato<br />
nell’ambito di diversi corsi a livello nazionale nel campo della<br />
neuroriabilitazione ed è autore di oltre 40 pubblicazioni recensite<br />
e co-editore di un libro sui meccanismi di produzione<br />
della parola. Promotore e organizzatore di eventi scientifici nazionali<br />
e internazionali è reviewer per alcune riviste scientifiche<br />
internazionali. Attualmente è Senior Member della IEEE<br />
Engineering Society e della IEEE Engineering in Medicine and<br />
Biology Society, e membro della Società Italiana di Riabilitazione<br />
di Alta Specializzazione (SIRAS).<br />
110<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
7. LABORATORIO DI COMUNICAZIONE<br />
E DOMOTICA<br />
Istituto Scientifico di Veruno<br />
Via per Revislate, 13<br />
Tel. 0322.884900<br />
e-mail: marco.caligari@fsm.it<br />
Responsabile: Ft. Marco Caligari<br />
Il Laboratorio di Comunicazione e Domotica (LCD) è noto su<br />
tutto il territorio nazionale per le consulenze tecniche che fornisce<br />
nell’ambito della Comunicazione Facilitata a pazienti ed<br />
operatori, e per la realizzazione di strumenti per la comunicazione<br />
ed il controllo ambientale (Domotica), rivolti principalmente<br />
a malati affetti da SLA. Da anni collabora con il Centro<br />
d’ascolto dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale<br />
Amiotrofica) nel fornire informazioni e consigli riguardo agli<br />
ausili per la comunicazione a centinaia di pazienti. Presso il laboratorio<br />
è presente un’area espositiva (Ausilioteca della Comunicazione<br />
e della Domotica) dove i pazienti possono testare<br />
i dispositivi ad alta tecnologia.<br />
Attività di Ricerca<br />
L’attività del Laboratorio di Comunicazione Facilitata e Domotica<br />
è riconducibile nell’ambito dell’obbiettivo istituzionale<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, che riguarda il recupero<br />
delle menomazioni funzionali conseguenti a patologie.<br />
Strumenti disponibili<br />
1) Personal Computer equipaggiati con software di comunicazione<br />
facilitata e di controllo ambientale.<br />
2) Dispositivi di accesso facilitato (testiere con scudo, slitte<br />
articolate, sistemi di puntamento tramite i movimenti della<br />
testa, touch screen, ecc.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
3) Telecomandi di controllo IR e radiofrequenza.<br />
4) Sistemi di chiamata d’emergenza senza fili ad accesso facilitato.<br />
5) Apparecchi elettrici comuni della vita quotidiana a controllo<br />
domotico tramite PC: lampade regolabili in luminosità,<br />
ventilatore, radio, apriporta elettrico, aspiratore da cucina;<br />
ed elettrodomestici controllati tramite raggi infrarossi:<br />
televisione LCD, videoregistratore, DVD.<br />
Attività Educazionale<br />
Il laboratorio fornisce consulenza telefonica riguardo gli strumenti<br />
di comunicazione aumentativa alternativa e di domotica<br />
per le gravi disabilità motorie e fonoarticolatorie, a pazienti,<br />
caregiver, personale medico e tecnico che giornalmente chiamano<br />
da tutta Italia.<br />
Presso il Laboratorio effettuano tirocinio allievi fisioterapisti<br />
provenienti dall’Università del Piemonte Orientale di Novara e<br />
dall’Università dell’Insubria di Varese e allievi Terapisti Occupazionali<br />
provenienti dall’Università Cattolica di Moncrivello<br />
(VC) e dall’Università degli Studi di Pavia.<br />
Attività Traslazionale<br />
La realizzazione di sistemi di comunicazione ad accesso facilitato<br />
basati sul PC (a basso costo), ha permesso a molti pazienti<br />
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica di tornare a comunicare<br />
anche in condizioni motorie estremamente compromesse.<br />
La possibilità di gestire autonomamente semplici operazioni<br />
di interazione con l’ambiente domestico, come per<br />
esempio: accendere o spegnare le luci; accendere la TV e<br />
cambiare canale o variare il volume; chiamare aiuto in caso<br />
d’emergenza tramite un campanello senza fili ad accesso facilitato,<br />
ha conferito ai pazienti nuova autonomia e dignità ed<br />
ha sgravato i caregiver da continui e ripetitivi interventi. Grazie<br />
ai sistemi a basso costo realizzati, si è data la possibilità a<br />
molti malati di usufruire di importanti ausili tecnologici non<br />
ancora previsti dal nomenclatore tariffario.<br />
Progetti in via di definizione<br />
Progetto di ricerca finalizzata ordinaria del Ministero della<br />
Salute: Realizzazione di un ausilio di comunicazione e di<br />
controllo ambientale ad accesso facilitato per pazienti con<br />
gravi disabilità motorie.<br />
Progetto di Ricerca finanziato dalla Comunità Europea:<br />
“ITC 4 ALL: Solutions for Information & Communication<br />
Technologies accessible to everyone”.<br />
Metodi messi a punto<br />
È stato progettato e messo a punto un software di comunicazione<br />
alternativa con sintesi vocale e controllo ambientale<br />
(a raggi infrarossi e protocollo X10) ad accesso<br />
facilitato. Il sistema è gestibile da pazienti affetti da gravi<br />
disabilità motorie attraverso la pressione di un solo pulsante<br />
di comando o altre metodiche facilitate.<br />
È stato progettato e costruito un pulsante di comando ad<br />
alta sensibilità per gestire il sistema di comunicazione e<br />
domotica quando configurato per l’accesso “a scansione”<br />
e la relativa interfaccia di collegamento col PC.<br />
È stato realizzato un campanello di chiamata d’emergenza<br />
senza fili (ricetrasmittente) accessibile tramite un pulsante<br />
di comando ad alta sensibilità.<br />
È stato progettato e realizzato un sistema di fissaggio per<br />
i pulsanti di comando ad alta sensibilità, compatibile con i<br />
braccetti MANFROTTO, utile per assicurare saldamente il<br />
pulsante al letto, o alla carrozzina del paziente.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
Ft. Marco Caligari.<br />
Nato ad Arona il 27-04-1970.<br />
Istruzione<br />
Diploma Universitario in Terapista della Riabilitazione<br />
(20/06/1996) presso l’Università<br />
degli studi di PAVIA (votazione di 50/50 e<br />
LODE). Titolo della Tesi di Diploma: “La riabilitazione<br />
del paziente traumatizzato cranio-encefalico grave in<br />
fase sub-acuta”.<br />
Laurea in Fisioterapia (22/06/2004) presso l’Università degli<br />
Studi dell’Insubria di Varese (votazione di 110 e LODE). Titolo<br />
della Tesi di Laurea: “Realizzazione di un ausilio informatico di<br />
comunicazione per pazienti affetti da gravi disabilità motorie e<br />
fonoarticolatorie”.<br />
Esperienza lavorativa<br />
Dal 20/07/1996 al 20/03/1997 e dal 12/05/1997 Incarico presso<br />
<strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong> - Veruno (No) reparto di R.R.F. in qualità<br />
di fisioterapista. 14/05/1998 variazione in contratto a<br />
tempo indeterminato.<br />
Attività Educazionale<br />
Relatore: “La sclerosi laterale amiotrofica i disturbi del linguaggio<br />
e della deglutizione” Tavola rotonda di aggiornamento<br />
e sensibilizzazione sulla malattia. “Il ruolo dell’esperto<br />
negli ausili informatici per la comunicazione”. Piombino<br />
(LI) 8 maggio 2006.<br />
Relatore: Il nursing del paziente critico in riabilitazione multispecialistica<br />
e di alta specializzazione: corso teorico-pratico.<br />
Sistemi di comunicazione alternativa in pazienti affetti da<br />
gravi disabilità. <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> I.R.C.C.S. Veruno<br />
(NO) 29, 30, 31 Maggio 2006.<br />
Relatore: La presa in carico del paziente affetto da Sclerosi<br />
Laterale Amiotrofica (SLA): dall’approccio diagnostico agli<br />
stadi avanzati. La comunicazione nei vari stadi della malattia:<br />
sistemi di comunicazione alternativa. <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> I.R.C.C.S. Veruno (NO) 08 Giugno 2006.<br />
Relatore: Sclerosi Laterale Amiotrofica: un approccio globale<br />
per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.<br />
La gestione della comunicazione. <strong>Fondazione</strong> Don C.<br />
Gnocchi ONLUS - Salice Terme 27 Maggio 2006.<br />
Presentazione poster: “La Comunicazione Aumentativa Alternativa<br />
nelle gravi disabilità motorie”. Le Frontiere della Riabilitazione<br />
Multispecialistica 1° Congresso della Società Italiana<br />
di Riabilitazione di Alta Specializzazione (SIRAS) Pavia<br />
- Centro Studi - <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> I.R.C.C.S.<br />
26-27 giugno 2006.<br />
Relatore: “La Sclerosi Laterale Amiotrofica: lo stato dell’arte”<br />
- L’utilità degli ausili di comunicazione ad alto contenuto<br />
tecnologico. AISLA ONLUS (Milano) 21 aprile 2007.<br />
Relatore: Convegno UILDM - Unione Italiana Lotta Distrofia<br />
Muscolare: “Domotica ed ausili”. La DOMOTICA applicata<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 111<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
alle gravi disabilità motorie. 25-26 settembre 2007, Sottomarina<br />
di Chioggia - VE.<br />
Relatore: “La Sclerosi Laterale Amiotrofica: aspetti clinici e<br />
riabilitativi” - La Comunicazione Aumentativa Alternativa e la<br />
Domotica nella SLA. AISLA, Sezione Provinciale di Palermo.<br />
Centro Regionale di Riferimento per le Malattie dei Motoneuroni-SLA,<br />
Policlinico Universitario di Palermo. <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> - Presidio Ospedaliero “S. <strong>Salvatore</strong>” Mistretta,<br />
ASL 5 Messina. Palermo, 28-29 settembre 2007.<br />
Relatore: “VII Workshop Nazionale SLA - Sclerosi Laterale<br />
Amiotrofica”. La Comunicazione Aumentativa Alternativa e la<br />
Domotica nella SLA. Università di Torino. Torino, 17 novembre<br />
2007.<br />
Relatore: Convegno Nazionale - “Sclerosi Laterale Amiotrofica<br />
la presa in carico globale dalla diagnosi all’accompagnamento<br />
del fine vita: utopia o realtà?” Il ruolo dell’esperto<br />
nlela Comunicazione Aumentativa Alternativa e la Domotica<br />
nella SLA. <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> I.R.C.C.S. Pavia, 14<br />
dicembre 2007.<br />
Pubblicazioni<br />
Aprile 2004. M. Caligari, M. Burattin, R. Deambrogio, E. Pastore,<br />
M. Tinivella, N. Allamano, L. Lorenzi. Manuale di autoriabilitazione<br />
a domicilio del paziente affetto da Malattia<br />
di Parkinson. 1a edizione.<br />
Giugno 2006. M. Caligari, M. Burattin, R. Deambrogio, E. Pastore,<br />
M. Tinivella, N. Allamano, L. Lorenzi, G. Ferriero. Manuale<br />
di autoriabilitazione a domicilio del paziente affetto da<br />
Malattia di Parkinson. 2a edizione.<br />
Dicembre 2006. M. Caligari, CD-ROM. “Multiclick & Multiscan”<br />
- Software di Comunicazione Aumentativa Alternativa<br />
ad accesso facilitato. 1a edizione - FSM IRCCS Istituto<br />
Scientifico di Veruno.<br />
Ft Marco Caligari, Ft. Simone Guglielmetti. Studio preliminare<br />
di un ausilio informatico di comunicazione a scansione,<br />
con tastiera standard e tastiera ridotta, per pazienti<br />
con gravi disabilità motorie e fonoarticolatorie: confronto tra<br />
le due modalità. Riabilitazione Oggi, 10 (2006) 13-17.<br />
“Assistive Technology: Sistemi di Comunicazione Aumentativa-Alternativa,<br />
Accesso al Computer e Controllo dell’Ambiente”.<br />
Capitolo in Argomenti di Terapia occupazionale.<br />
M. Imbriani, G. Bazzini, F. Franchignoni. Vol 2. Aracne 2007.<br />
In press: “Gli ausili per comunicare nella SLA”. M. Caligari.<br />
AISLA - ONLUS (2007).<br />
Incarichi particolari<br />
Membro Commissione Ministeriale per la Sclerosi Laterale<br />
Amiotrofica dal 5 gennaio 2007 in qualità di esperto di sistemi<br />
di comunicazione per disabili.<br />
Membro Sottogruppo della Commissione Ministeriale SLA-<br />
LEA dal novembre 2007 in qualità di esperto di sistemi di<br />
comunicazione e domotica per disabili.<br />
Membro CTS (Comitato Tecnico Scientifico) FSM - Veruno<br />
(NO) dal 2003.<br />
Membro del Centro d’ascolto dell’AISLA (Associazione Italiana<br />
Sclerosi Laterale Amiotrofica) dal 2003, specializzato<br />
in sistemi di Comunicazione Alternativa-Aumentativa e domotica<br />
per pazienti affetti da gravi disabilità motorie e fonoarticolatorie.<br />
112<br />
Linea di Ricerca N. 5 e N. 6<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
ED ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
8. LABORATORIO DEI METODI<br />
PER L’INDAGINE DELL’INTEGRAZIONE<br />
SENSORIMOTORIA E DEI FENOMENI<br />
DI PLASTICITÀ NEURONALE<br />
LABORATORIO SPERIMENTALE<br />
DI BIOINGEGNERIA<br />
E NEURORIABILITAZIONE<br />
Istituto Scientifico di Castel Goffredo<br />
Via Ospedale, 36<br />
Tel. 0376.7747430<br />
e-mail: jan.nilsson@fsm.it<br />
Responsabile: Ing. Jan Nilsson<br />
L’applicazione di metodiche di bioingegneria rappresenta uno<br />
degli obiettivi più importanti nello sviluppo delle scienze neuroriabilitative.<br />
Il possibile contributo bioingegneristico riguarda<br />
sia il miglioramento delle capacità diagnostiche che<br />
l’ideazione di nuovi strumenti terapeutici.<br />
La Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), la stimolazione<br />
transcranica con corrente continua (tDCS) e la terapia<br />
riabilitativa sostenuta per mezzo di robot rappresentano alcune<br />
delle tecnologie chiave del futuro della Neuroriabilitazione.<br />
Per esempio, nel caso di pazienti colpiti da ictus cerebrale,<br />
queste tecnologie vengono utilizzate sia per la valutazione<br />
funzionale delle capacità neuromotorie che per le terapie<br />
riabilitative. Queste tecnologie ci permetteranno, in un<br />
immediato futuro, di comprendere approfonditamente i meccanismi<br />
di plasticità neuronale e di conseguenza lo sviluppo di<br />
sempre più efficienti metodologie neuroriabilitative.<br />
Attività di Ricerca<br />
Creazione di programmi dedicati all’applicazione di nuove<br />
metodiche quantitative nell’ambito della neuroriabilitazione.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Studio dei fenomeni di plasticità neuronale correlabili alle tecniche<br />
riabilitative utilizzate, inclusa l’eccitabilità della corteccia<br />
motoria (circuiti inibitori ed eccitatori) durante la fase neuroriabilitativa.<br />
ELENCO DELLE RICERCHE IN CORSO<br />
Effetto di treni di vibrazione muscolo-tendinea applicata in<br />
modo alternato a muscoli posturali.<br />
La sicurezza per l’operatore e per il paziente sottoposto a<br />
TMS.<br />
Stimolazione transcranica per la terapia del dolore: applicazione<br />
terapeutica.<br />
Tecnica di valutazione funzionale e outcome di neuroriabilitazione<br />
del paziente emiplegico ottenuta mediante fisioterapia<br />
“occlusivo” (CIMT) dell’arto inferiore.<br />
Risposte tattili registrate con elettrodi di superficie: una<br />
tecnica non invasiva che aumenta la possibilità diagnostica<br />
in pazienti diabetici.<br />
ELENCO DELLE RICERCHE IN PROGRAMMAZIONE<br />
1. Tecnica di riabilitazione sensoriale-motoria ottenuta<br />
mediante dispositivi robotizzati.<br />
Lo scopo principale di questo progetto è l’implementazione e<br />
la valutazione delle possibilità di utilizzo di protocolli di neuroriabilitazione<br />
assistita da robot. La ricerca sarà focalizzata sull’applicazione<br />
e lo sviluppo di un sistema di neuroriabilitazione<br />
robotizzata per l’arto superiore, inoltre verrà studiato come<br />
l’intervento del robot possa determinare una ottimizzazione<br />
del procedimento riabilitativo per mezzo dell’attivazione contemporanea<br />
delle proiezioni cortico-spinali verso muscoli distali<br />
e prossimali. Ulteriore scopo di questa ricerca è di studiare<br />
gli effetti dell’applicazione della terapia neuroriabilitativa<br />
“robotizzata” durante la fase acuta della malattia. In pratica, la<br />
terapia verrà applicata non appena il paziente sarà stabilizzato.<br />
La fase acuta rappresenta il momento di maggiore plasticità<br />
neurale e, quindi, la fase ottimale in cui intervenire per<br />
ottenere il recupero del paziente.<br />
Gli esercizi previsti dal protocollo sperimentale saranno suddivisi<br />
in tre gruppi e focalizzati al miglioramento di pattern di<br />
movimento della mano, del gomito e della spalla. La terapia<br />
legata alla movimentazione della mano sarà somministrata<br />
durante le prime 2-3 settimane, seguita dalla terapia per il recupero<br />
dei movimenti della mano e del polso (di durata pari a<br />
2-3 settimane), nelle ultime 2-3 settimane verrà somministrata<br />
la terapia per il recupero di gomito e spalla. La terapia sarà<br />
realizzata grazie all’utilizzo del robot “MIT-Manus” composto<br />
dai moduli InMotion2, InMotion3 e “Hand motion” quest’ultimo<br />
specifico per la riabilitazione della mano. I pazienti si sottoporranno<br />
ad una serie di 35-40 sessioni riabilitative durante<br />
le quali eseguiranno, con l’aiuto del robot, almeno 2100 ripetizioni<br />
di movimenti verso un target.<br />
La valutazione della bontà della terapia riabilitativa verrà eseguita<br />
comparando i dati cinematici e cinetici acquisiti dal<br />
robot stesso con i miglioramenti funzionali ottenuti dalla neuroriabilitazione.<br />
Lo scopo di questa ricerca è, inoltre, quello di<br />
provare che la terapia “robotizzata”, volta al miglioramento<br />
delle capacità motorie dei pazienti, riduce i tempi necessari al<br />
recupero motorio e contemporaneamente permette di ottenere<br />
degli indici oggettivi correlati al miglioramento del paziente;<br />
indici estratti dall’analisi dei dati cinematici e cinetici<br />
acquisiti dal robot durante le sessioni riabilitative.<br />
2. La stimolazione transcranica come terapia del dolore<br />
(applicazioni terapeutiche). Metodi Clinici e<br />
Neurofisiologici volti alla comprensione della fisiologia<br />
del dolore.<br />
Grazie agli studi precedentemente effettuati dal nostro gruppo di<br />
lavoro abbiamo dimostrato che l’applicazione per 20 minuti di<br />
una stimolazione magnetica transcranica ripetuta, alla frequenza<br />
di 10 Hz (rTMS), fosse in grado di ridurre, per circa 10 giorni, il<br />
dolore cronico facciale. Quindi possiamo pensare che la rTMS induce<br />
un cambiamento delle capacità di trasmissione sinaptica a<br />
seguito di meccanismi di long-term potentiation and depression<br />
(Haung et al., 2005; Fregni et al., 2006). È stato inoltre dimostrato<br />
che, al pari della rTMS, la stimolazione transcranica con corrente<br />
continua (tDCS) permette di modulare l’attività del cervello in<br />
maniera non invasiva. Ci prefiggiamo, quindi, di esaminare gli effetti<br />
della tDCS su pazienti affetti da dolore cronico. Verrà previsto<br />
un protocollo “double-blind” della durata di 10 giorni in cui<br />
i pazienti, divisi in due gruppi, saranno sottoposti alla stimolazione<br />
con corrente anodica continua centrata a livello della corteccia<br />
motoria primaria, oppure sottoposti ad una stimolazione<br />
fittizia. Verranno eseguite scale di “pain-rating”, test neuro-psicologici<br />
e verrà determinato il periodo silente (TMS).<br />
Alcuni dei nostri scopi sono:<br />
lo sviluppo di uno stimolatore elettrico per la stimolazione<br />
transcranica con corrente continua (tDCS);<br />
lo sviluppo di diversi test di tipo neurofisiologico atti alla<br />
valutazione oggettiva dell’efficacia della terapia neuromotoria;<br />
lo sviluppo di protocolli di ricerca volti allo studio della fisiologia<br />
del dolore e per la terapia del dolore stesso.<br />
3. Sviluppo di uno stimolatore tattile per migliorare le<br />
capacità diagnostiche nella patologia diabetica.<br />
È stata precedentemente sviluppata dal nostro gruppo di lavoro<br />
un’accurata tecnica non invasiva per la rivelazione di alterazioni<br />
premature della velocità di conduzione sensitiva dei<br />
nervi distali. Questa tecnica prevedeva la registrazione e l’analisi<br />
dei potenziali d’azione compositi di tipo sensitivo a seguito<br />
della stimolazione meccanica delle dita. La tecnica è<br />
stata utilizzata su di un gruppo di pazienti diabetici determinando<br />
un miglioramento delle capacità diagnostiche della<br />
malattia. Lo scopo di questo ulteriore studio è quello di sviluppare<br />
un dispositivo di facile utilizzo che permetta di ottenere<br />
in modo semiautomatico una diagnosi precoce sulla possibile<br />
alterazione della velocità di conduzione nervosa distale.<br />
Collaborazioni<br />
NINDS, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.<br />
Brain & Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology,<br />
Boston, USA.<br />
Laboratorio di Microcalcolatori e Strumentazione Elettromedicale<br />
Dipartimento di Informatica e Sistemistica, University<br />
of Pavia, Italy.<br />
EBNeuro SpA, Firenze, Italy.<br />
Alpine Biomed ApS, Skovlunde, Denmark.<br />
Pubblicazioni<br />
Nilsson J, De Nunzio AM, Grasso M, Nardone A, Schieppati M.<br />
Effect of alternating trains of vibration applied on muscle tendons.<br />
Comparison of postural responses in patients with<br />
Parkinson’s disease and healthy controls. Clin Neurophys, 2007.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 113<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Nilsson J, Tommolillo B, Bazzani M, Panizza M. Surface recorded<br />
tactile evoked responses: A non-invasive technique<br />
that increases the diagnostic yield in patients with<br />
diabetes. Journal of the Peripheral Nervous System, 12:<br />
164-165, 2007.<br />
Nilsson J, Panizza M. Magnetic stimulation of peripheral<br />
nerve and roots. Funct Neurol, 21 (2): 110-111, 2006.<br />
Nilsson J, Panizza M, Farina M, Assente R. Motor evoked<br />
potentials recorded via surface electrodes and wireless<br />
EMG system during magnetic stimulation. Funct Neurol,<br />
21 (2): 123, 2006.<br />
Mognaschi ME, Alfonsi E, Nilsson J, Moglia A. Experimental<br />
results on excitability of peripheral motor axons by<br />
means of a magnetic stimulus. Funct Neurol, 21 (2): 119-<br />
120, 2006.<br />
Nilsson J, Panizza M. Magnetic stimulation: Physics and<br />
basic principles of nerve activation. Fisica in Medicina<br />
(AIFM), 1: 7-24, 2006.<br />
CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE<br />
DEL LABORATORIO<br />
114<br />
L’Ing. Jan Nilsson ha conseguito il BSEE in<br />
Ingegneria Elettronica nel 1977 presso l’Engineering<br />
College di Copenhagen (Københavns<br />
Teknikum), Denmark, con la specialità di<br />
Bioingegneria (Biomedical Engineering).<br />
Dal 1977 al 1982 è stato “Research Assistant”<br />
presso il laboratorio di ricerca del Professor<br />
Fritz Buchthal, Neuromuscular Research Laboratory, University<br />
Hospital (Rigshospitalet) di Copenhagen (“postgraduation<br />
training” nella neurofisiologia clinica).<br />
Dal 1982 al 1983 è stato “Visiting Guest Worker” al National<br />
Institute of Neurological and Communicative Disorders and<br />
Stroke (NINCDS), Laboratory of Electromyography, National<br />
Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA.<br />
Dal 1983 al 1988 è stato “Visiting Associate” presso il Medical<br />
Neurology Branch and the Human Motor Control Section,<br />
NINCDS, NIH, Bethsda, MD, USA.<br />
Dal 1988 al 1991 è stato Bioingegnere presso l’Istituto Scientifico<br />
di Campoli Monte Taburno (BN) della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, IRCCS.<br />
Attualmente è in ruolo presso i servizi di Bioingegneria della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, IRCCS, di Pavia e di Castel<br />
Goffredo (MN). Nell’ambito di questa esperienza si è interessato<br />
di stimolazione magnetica sia per quanto riguarda la valutazione<br />
che il trattamento, di analisi quantitativa del segnale<br />
elettromiografico e di studio dell’affaticamento muscolare.<br />
Ing. Nilsson è autore di 39 pubblicazioni, di cui 26 lavori in extenso<br />
su riviste internazionali indicizzate (Impact factor globale:<br />
65.9); e numerose presentazioni a convegni e corsi sia a<br />
livello nazionale che internazionale.<br />
È membro della Institutes of Electrical and Electronic Engineers<br />
(IEEE) e della IEEE Engineering in Medicine and Biology<br />
Society - EMBS (Membro: 1982 - Membro Senior: 1995).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
CENTRO STUDI E RICERCHE ISPESL<br />
Presso la <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong><br />
Sede di Pavia – Via <strong>Maugeri</strong> 4<br />
L’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza<br />
sul Lavoro), ente di diritto pubblico, istituzionalmente<br />
promuove e svolge programmi di studio<br />
e ricerca, oltre che direttamente, anche in collaborazione<br />
con le altre strutture del Servizio Sanitario<br />
Nazionale, con l’ISS, con Istituti di Ricovero e Cura<br />
a carattere scientifico (IRCCS).<br />
In tale ambito, è stato inaugurato, in data 12 dicembre<br />
2006, il “Centro Studi e Ricerche ISPESL”<br />
presso la sede di Pavia (via <strong>Maugeri</strong> 4) della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>.<br />
Programmi e linee di ricerca 2008-2010<br />
1. Effetti sulla salute della esposizione ad interferenti endocrini<br />
(Responsabile: L. Chiovato, <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong>)<br />
Comprende 2 linee di ricerca:<br />
L1: Studio sui meccanismi molecolari di interazione degli interferenti endocrini con l’organismo<br />
L2: Analisi dei livelli di interferenti endocrini in fluidi biologici e ambiente ed effetti sulla salute<br />
2. Patologie allergologiche e respiratorie in ambiente di lavoro<br />
(Responsabile: G. Moscato, <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>)<br />
Comprende 3 linee di ricerca:<br />
L1: Studio dei meccanismi infiammatori delle allergopatie in ambito occupazionale<br />
L2: Meccanismi d’azione degli agenti causali delle allergopatie professionali<br />
L3: Valutazione clinica delle patologie respiratorie croniche negli ambienti di lavoro<br />
3. Organizzazione del lavoro, salute e sicurezza<br />
(Responsabile: S. Signorini, ISPESL)<br />
Linea di ricerca: Competitività delle imprese e salute al lavoro<br />
Il Coordinamento scientifico del Centro è stato<br />
congiuntamente affidato, per la <strong>Fondazione</strong><br />
S. <strong>Maugeri</strong>, al Direttore Scientifico Centrale protempore<br />
e per l’ISPESL al Dr. Stefano Signorini,<br />
nominato dal Presidente ISPESL.<br />
È inoltre stato nominato un Comitato Scientifico<br />
ISPESL - <strong>Fondazione</strong> S. <strong>Maugeri</strong> per le politiche di indirizzo<br />
ed attuazione delle attività di ricerca. Il Comitato<br />
scientifico provvede anche a raccordarsi con la Direzione<br />
Generale della Ricerca scientifica e Tecnologica e<br />
della Vigilanza sugli Enti dell’ex Ministero della Salute.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 115<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Attività dei Dipartimenti<br />
DIPARTIMENTO DI MEDICINA<br />
OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE<br />
L’attività scientifica delle Unità Operative del Dipartimento<br />
di Medicina Occupazionale ed Ambientale è<br />
imperniata sul tema tradizionale della linea di ricerca<br />
1 della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>: l’identificazione<br />
e la quantificazione dei fattori di rischio nell’ambiente<br />
di lavoro e di vita e lo studio dei loro meccanismi<br />
d’azione. L’evidenziazione ed il controllo della<br />
presenza di xenobiotici a livello ambientale e/o biologico<br />
in ambito lavorativo/occupazionale e nell’ambiente<br />
di vita, nonché lo studio sperimentale, clinico<br />
ed epidemiologico delle modalità di azione a livello<br />
dell’organismo umano costituisce infatti il filo conduttore<br />
di tutti i progetti di ricerca del Dipartimento,<br />
il fine ultimo dei quali è la messa a punto di indicatori<br />
di esposizione e/o di effetto e di valori di riferimento<br />
utilizzabili in Medicina del Lavoro e in Medicina<br />
Ambientale per il controllo di popolazioni a rischio.<br />
Tale impostazione presuppone una stretta collaborazione<br />
tra le diverse Unità Operative con utilizzazione<br />
reciproca di dati e metodologie operative e<br />
un continuo confronto sulla progressione delle ricerche.<br />
In ambito sperimentale si collocano essenzialmente<br />
le ricerche impostate dal Laboratorio del Servizio di<br />
Tossicologia, le quali si sono rivolte verso i seguenti<br />
settori:<br />
1) Valutazione degli effetti dell’esposizione perinatale<br />
a contaminanti ambientali neurotossici quali<br />
il metilmercurio (MeHg) e alcuni bifenilipoliclorurati<br />
(PCB), quali il PCB153 e il PCB126, normalmente<br />
co-presenti negli alimenti. La modulazione<br />
in maniera differente della risposta a tali stimoli<br />
tossici ha sottolineato ancora una volta la necessità<br />
di mettere a punto e standardizzare un pannello<br />
di test in vitro e in vivo atti a svelare effetti<br />
cellulari e molecolari, che sono alla base di possibili<br />
sinergismi o antagonismi, da impiegarsi nella<br />
valutazione del rischio chimico.<br />
Nell’anno in corso è stato pianificato uno studio<br />
che intende valutare la permeabilità e l’integrità<br />
della Barriera Emato Encefalica (BBB) ad alcuni<br />
farmaci/sostanze chimiche modello utilizzando un<br />
approccio integrato di studio che applica test<br />
complementari (in vitro mediante cellule in coltura<br />
e in silico). Lo studio avrà le seguenti fasi:<br />
116<br />
determinazione degli effetti delle sostanze test<br />
sull’integrità della BBB;<br />
caratterizzazione dell’abilità delle sostanze test<br />
di attraversare la BBB;<br />
verifica dei meccanismi d’interazione dei composti<br />
con la proteina carrier PgP, in presenza o<br />
assenza di un inibitore specifico della stessa.<br />
2) Messa a punto di nuovi marker neurochimici misurabili<br />
in cellule ematiche, come surrogati di alterazioni<br />
del sistema nervoso, che vengono applicati<br />
in specifiche casistiche cliniche di pazienti<br />
adulti e pediatrici affetti da patologie neuropsichiatriche<br />
o da alcolismo. Gli studi servono a definire<br />
il significato e il valore predittivo di tali indicatori<br />
biologici periferici nella diagnosi della patologia<br />
e nel monitoraggio farmacologico. La ricerca<br />
prevede l’applicazione clinica di biomarcatori di<br />
neurotossicità in casistiche selezionate di pazienti.<br />
Il programma intende approfondire i dati ottenuti<br />
in pazienti pediatrici con Disturbo da Deficit di Attenzione<br />
e Iperattività (ADHD) infantile relativamente<br />
alla misurazione di due biomarcatori<br />
(MAO-B piastrinica e recettori colinergici muscarinici<br />
linfocitari). Tali studi hanno evidenziato che i<br />
valori dei suddetti parametri neurochimici, misurati<br />
a livello periferico nei pazienti con ADHD al<br />
momento della prima visita clinica di arruolamento,<br />
risultano significativamente inferiori a<br />
quelli riscontrati in una popolazione di controllo. Il<br />
programma comporta la valutazione di biomarcatori<br />
neurochimici (MAO-B piastrinica e recettori<br />
colinergici muscarinici linfocitari) in relazione alla<br />
terapia farmacologia (es. atomoxetina) e alla risposta<br />
individuale ad essa nei bambini affetti da<br />
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività.<br />
3) Un settore della ricerca sperimentale è volto allo<br />
sviluppo, validazione e applicazione di modelli<br />
idonei a migliorare la fattibilità e il valore predittivo<br />
dei test tossicologici in vitro in uso per la valutazione<br />
del rischio chimico. Tali metodi, alternativi<br />
all’uso dell’animale di laboratorio secondo le direttive<br />
CEE, vengono applicati nell’ambito dell’attività<br />
di ricerca a contratto, nel settore della tossicologia<br />
cellulare e molecolare. Particolare interesse<br />
è rivolto allo sviluppo di test in vitro capaci<br />
di predire la ematotossicità in vivo. Gli effetti mielotossici<br />
delle aflatossine B1 (AFB1) e M1 sono<br />
stati studiati sulle cellule progenitrici di diverse<br />
linee ematiche avvalendosi di cellule di midollo<br />
osseo/sangue di cordone ombelicale umano e<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
cellule di midollo osseo murino. I dati in vitro sottolineano<br />
la moderata suscettibilitià delle cellule<br />
murine all’AFB1, in linea con la ridotta sensibilità<br />
del topo agli effetti mielotossici in vivo dell’AFB1. I<br />
risultati sono in fase di pubblicazione.<br />
4) Validazione (intra- e inter-laboratorio) del test<br />
“CDT” (transferrina desialata) con HPLC-UV/VIS<br />
da utilizzarsi nella diagnosi di abuso cronico di<br />
alcol. La tecnica in HPLC è in grado di rilevare le<br />
varianti genetiche e permette di conseguenza di<br />
valutare attraverso i polimorfismi genetici eventuali<br />
falsi positivi. Ciò riveste particolare importanza<br />
in considerazione anche della valenza medico-legale<br />
del test. La ricerca comporta:<br />
la messa a punto del metodo analitico<br />
(scambio anionico) in HPLC con rivelazione in<br />
luce ultravioletta e visibile (HPLC-UV/VIS) per<br />
la determinazione serica della CDT;<br />
la comparazione dei risultati ottenuti con<br />
HPLC vs. quelli ottenuti con metodo ELISA;<br />
lo studio della CDT in una popolazione di alcolisti<br />
e di controlli.<br />
5) Valutazione del profilo tossicologico e biocinetico<br />
di alcuni nanomateriali modello, con il fine di sviluppare<br />
una strategia di ricerca multidisciplinare<br />
per l’accurata valutazione delle caratteristiche di<br />
sicurezza dei nanomateriali. Quali materiali-modello<br />
saranno impiegati nanotubi di carbonio<br />
(CNT) disponibili commercialmente e nanoparticelle<br />
di silice (SiO2 ), che saranno sintetizzate ad<br />
hoc, ovvero secondo caratteristiche prestabilite<br />
per quanto concerne dimensioni e proprietà chimico-fisiche.<br />
Studi di tossicologia sperimentale sono pure in corso<br />
presso il Laboratorio di Tossicologia occupazionale<br />
del Centro di Cassano Murge in particolare attraverso<br />
la valutazione degli effetti a livello cellulare (aumento<br />
dei micronuclei, aberrazioni cromosomiche,<br />
scambio di cromatidi fratelli, alterazione delle gapjunction)<br />
di alcuni xenobiotici.<br />
Per quanto riguarda le ricerche svolte nel settore di<br />
studi sull’esposizione a fattori di rischio chimici o fisici<br />
negli ambienti di lavoro e di vita le ricerche hanno<br />
comportato:<br />
1) Studi di correlazione tra i livelli di espressione genica<br />
e l’esposizione a xenobiotici negli ambienti di<br />
lavoro e di vita, nell’ipotesi che variazioni interindividuali<br />
nella sequenza di geni coinvolti nel me-<br />
tabolismo di composti tossici o allergizzanti siano<br />
in grado di modificare significativamente il rischio<br />
individuale di sviluppare patologie. Tali ricerche<br />
comportano:<br />
identificazione di soggetti particolarmente suscettibili<br />
agli effetti dell’esposizione ambientale<br />
a fattori di rischio in grado di provocare allergie,<br />
intossicazioni, tumori;<br />
attuazione, nei confronti degli stessi, di appropriate<br />
misure preventive in ambiente di lavoro.<br />
2) Sviluppo di metodologie analitiche riguardanti la<br />
determinazione in matrici biologiche di:<br />
a) farmaci antiblastici;<br />
b) metalli tossici (in sangue e urine di intossicati<br />
acuti e cronici);<br />
c) inquinanti ubiquitari (PCB, DDT, Pb, Cd, Ni, Hg)<br />
nel liquido amniotico di gruppi di popolazione<br />
generale non professionalmente esposta.<br />
3) Studio caso-controllo sull’eventuale influenza dell’esposizione<br />
ambientale e/o professionale a interferenti<br />
endocrini (PCB, pesticidi organo-clorurati,<br />
ecc.) nella patogenesi delle neoplasie testicolari<br />
comprensivo del dosaggio biologico di tali sostanze<br />
e di analisi spermatiche.<br />
4) Studi di dieta totale con dosaggio di elementi in<br />
traccia sia tossici sia essenziali con definizione<br />
dell’intake alimentare di tali analiti anche in rapporto<br />
all’ADI (acceptable daily intake) quando disponibile.<br />
5) Monitoraggio ambientale e biologico di esposti<br />
professionalmente a pesticidi (propanil, triazine,<br />
alaclor) nelle colture di riso e mais allo scopo di:<br />
identificare i profili di rischio per tipologia di trattamento<br />
in ambito regionale lombardo;<br />
validare un algoritmo per la valutazione del rischio<br />
specifico.<br />
6) Dosaggio di composti organici volatili nella saliva<br />
di soggetti non esposti professionalmente.<br />
7) Studio della qualità dell’aria in 4 città campione<br />
(PD, PV, PA, RM) con monitoraggi ad alta risoluzione<br />
dell’inquinamento da benzene, toluene, xileni,<br />
etilbenzene (estate-inverno) e ozono (stagione<br />
estiva).<br />
8) Applicazione di campionatori passivi ad adsorbimento<br />
su carbone attivo (radiello ® ) per misurazioni<br />
di concentrazioni di radon.<br />
9) Misurazione di campi elettromagnetici prodotti da<br />
apparecchi elettromedicali.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 117<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Infine per quanto riguarda il settore degli studi clinico<br />
epidemiologici sono da segnalare le seguenti attività:<br />
1) Nell’ambito della Tossicovigilanza industriale, attuazione<br />
di un programma atto alla definizione e<br />
sperimentazione di nuovi modelli operativi di tossicovigilanza<br />
industriale per la collaborazione con<br />
le industrie chimiche nel quadro degli adempimenti<br />
previsti dal Regolamento REACH (CE n.<br />
1907/2006). Gli obiettivi di tali ricerche sono:<br />
analisi degli adempimenti previsti dal Regolamento<br />
REACH;<br />
definizione di modelli operativi per la collaborazione<br />
con le industrie chimiche;<br />
sperimentazione dei modelli individuati con un<br />
gruppo di aziende pilota;<br />
analisi dei risultati e validazione dei modelli.<br />
2) Studio di valutazione clinica dell’efficacia dell’intervento<br />
riabilitativo cardiologico sulla ripresa dell’attività<br />
lavorativa, finalizzato al pieno recupero<br />
dell’autonomia, dell’abilità fisica e del controllo dei<br />
fattori di rischio. Lo studio prevede lo sviluppo di<br />
un modello di valutazione qualitativo e quantitativo,<br />
basato su criteri clinici e funzionali, circa le<br />
indicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa (specifica<br />
o generica) in una popolazione colpita da<br />
un evento cardiaco acuto e sottoposta a regime<br />
riabilitativo specialistico in ambito cardiologico.<br />
3) Studio dell’infiammazione cronica nella rinite e<br />
nell’asma di origine professionale per mezzo dell’analisi<br />
dell’espettorato indotto e dell’aria esalata<br />
(studio delle popolazioni cellulari, dosaggio dei<br />
mediatori dell’infiammazione e dell’ossido nitrico).<br />
DIPARTIMENTO DI MEDICINA RIABILITATIVA<br />
NEUROMOTORIA - NEUROSCIENZE<br />
Le finalità dell’attività del Dipartimento di Medicina<br />
Riabilitativa Neuromotoria – Neuroscienze sono volte<br />
all’ampliamento delle conoscenze in campo epidemiologico,<br />
al perfezionamento delle metodiche di valutazione<br />
funzionale, all’applicazione di percorsi terapeutici<br />
innovativi, allo svolgimento di studi di efficacia<br />
su procedure e interventi farmacologici, e alla misurazione<br />
dell’outcome in tutte le principali patologie<br />
neuromotorie di interesse riabilitativo. A questi campi<br />
di studio si sono affiancate specifiche ricerche di<br />
base, finalizzate all’individuazione dei meccanismi fisiopatogenetici<br />
responsabili del danno in pazienti<br />
con malattie neurologiche acute e croniche. La<br />
stretta collaborazione con gli altri Dipartimenti della<br />
118<br />
<strong>Fondazione</strong>, e le consolidate sinergie con Istituti di ricerca<br />
nazionali e internazionali garantisce la realizzazione<br />
di progetti multicentrici, oltre che favorire la formazione<br />
e la didattica.<br />
Le linee di ricerca corrente del Dipartimento di Medicina<br />
Riabilitativa Neuromotoria – Neuroscienze<br />
possono essere così suddivise: ricerca clinica, ricerca<br />
di base, analisi del controllo motorio, neurofisiologia<br />
e bioingegneria applicata, neuropsicologia.<br />
Ricerca clinica<br />
I principali temi dell’attività di ricerca clinica vertono<br />
su: a) definizione di modalità di impiego nella pratica<br />
riabilitativa del ICF in pazienti con esiti di stroke, artroprotesi,<br />
osteoporosi, dolore cronico, malattie respiratorie<br />
ostruttive; b) studio delle alterazioni metabolico-nutrizionali<br />
in patologie neuromotorie di interesse<br />
riabilitativo, in particolare stroke e malattia di<br />
Parkinson; c) definizione e miglioramento di procedure<br />
riabilitative per disabilità secondarie a patologie<br />
ortopedico-traumatologiche; d) studio di alterazioni<br />
del metabolismo osseo in disabilità secondarie a patologie<br />
neuromotorie e respiratorie di interesse riabilitativo;<br />
e) studio delle applicazioni valutative e terapeutiche<br />
della riabilitazione propriocettiva; f) studio<br />
prospettico su fattori prognostici significativi in pazienti<br />
con lesioni midollari; g) trial clinici sperimentali.<br />
Un studio per esempio si propone di valutare la sicurezza<br />
e la tollerabilità di ripetute somministrazioni di<br />
G-CSF nell’autoinduzione di cellule staminali ematopoietiche<br />
in pazienti con SLA; h) applicazione di<br />
nuove tecnologie che prevedono un monitoraggio<br />
domiciliare dello stato di salute dei pazienti.<br />
Ricerca di base<br />
L’attività di ricerca sperimentale è mirata principalmente<br />
allo studio dei fattori genetici, biologici e tossico-ambientali<br />
che stanno alla base delle malattie<br />
neurodegenerative, con particolare attenzione alla<br />
malattia di Parkinson e alla SLA, patologie in cui la<br />
<strong>Fondazione</strong> ha maturato da molto anni grande esperienza<br />
sia sul piano clinico-assistenziale basato sull’approccio<br />
interdisciplinare che nello studio dei meccanismi<br />
patogenetici. Gli obiettivi delle ricerche mirano<br />
a: a) identificare dei marcatori biomolecolari nei<br />
tessuti periferici per fornire parametri utili alla diagnosi<br />
precoce di queste malattie e di capirne i meccanismi<br />
patogenetici; b) indagare in modelli cellulari,<br />
come i linfociti e i fibroblasti cutanei, le variazioni dei<br />
meccanismi cellulari e verificare se alcune alterazioni<br />
riscontrate nel tessuto nervoso siano rilevabili anche<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
a livello periferico e possano costituire perciò degli<br />
indicatori di malattia utili per la pianificazione e il monitoraggio<br />
dei trial clinici. Dalla banca del DNA si<br />
prevede inoltre di poter indagare con studi di “wide<br />
genome analysis” i polimorfismi genetici associati a<br />
un aumentato o diminuito rischio di sviluppare le malattie<br />
neurodegenerative.<br />
Analisi del controllo motorio<br />
I progetti sullo studio del movimento umano e della<br />
sua plasticità in condizioni normali e patologiche vertono<br />
su: a) controllo di un movimento volontario<br />
complesso: effetti della fatica di un gruppo muscolare<br />
posturale sulla coordinazione tra arto superiore<br />
ed arto inferiore; b) controllo della stazione eretta in<br />
condizioni non perturbate: ruolo delle variazioni di<br />
eccitabilità del riflesso monosinaptico; c) controllo<br />
dell’equilibrio in condizioni dinamiche: l’effetto della<br />
visione ed il tempo di integrazione dell’input visivo; d)<br />
controllo dell’equilibrio in condizioni dinamiche in pazienti<br />
ipovedenti. Prosegue anche lo sviluppo di ricerche<br />
sull’analisi del cammino, in particolare la programmazione<br />
e l’esecuzione del cammino lungo<br />
traiettorie non rettilinee e il ruolo delle informazioni<br />
propriocettive durante il cammino.<br />
Neurofisiologia<br />
Tra le nuove applicazioni in ambito riabilitativo spiccano<br />
le tecniche di riabilitazione robotica e la telemedicina.<br />
Lo studio delle tecniche di neuroriabilitazione<br />
robotica stanno acquistando sempre maggiore<br />
importanza. La “robotica riabilitativa” infatti<br />
utilizza macchine costruite per migliorare ed accelerare<br />
il recupero funzionale in pazienti affetti da deficit<br />
motori e/o cognitivi. Gli studi in corso mirano a<br />
confermare l’efficacia di tali tecniche per il recupero<br />
dell’arto superiore in pazienti affetti da stroke. La telemedicina<br />
offre la possibilità di favorire l’assistenza<br />
sanitaria domiciliare con la finalità di mettere a<br />
punto nuove metodologie che integrano con l’attività<br />
di tutte le figure professionali per perfezionare la<br />
continuità assistenziale dalla fase di ricovero al ritorno<br />
al domicilio. Altra recente applicazione in ambito<br />
riabilitativo è la biopsia cutanea neurodiagnostica<br />
con particolare riferimento allo studio dell’innervazione<br />
cutanea, per a) diagnosticare precocemente<br />
e quantificare le lesioni nervose periferiche;<br />
b) quale indice di avvenuta reinnervazione dopo lesione<br />
nervosa periferica; c) quale substrato patogenetico<br />
delle allodinie cutanee invalidanti.<br />
Neuropsicologia<br />
Le ricerche di interesse neuropsicologico vertono su<br />
a) studio dei disturbi lessicali e semantici nella malattia<br />
di Alzheimer; b) validazione dell’efficacia del<br />
trattamento logoterapico nei pazienti afasici e valutazione<br />
quantitativa dell’evoluzione del disturbo afasico;<br />
c) identificazione di elementi prognostici clinici<br />
e neuropsicologici in pazienti con esiti di trauma cranico;<br />
f) identificazione di marcatori neuropsicologici<br />
per la diagnosi precoce di malattia di Alzheimer.<br />
DIPARTIMENTO DI CARDIOANGIOLOGIA<br />
RIABILITATIVA<br />
L’attività di ricerca del Dipartimento si sviluppa in un<br />
contesto generale di applicazione di programmi ad<br />
elevato contenuto clinico-assistenziale e di alta specializzazione<br />
rivolti a pazienti cardiopatici nella fase<br />
post-acuta di un evento cardiovascolare. In coerenza<br />
con gli obiettivi proposti dal Piano Sanitario Nazionale,<br />
la ricerca è finalizzata allo sviluppo delle conoscenze<br />
e alla implementazione di protocolli diagnostici<br />
e programmi riabilitativi nell’ambito di patologie<br />
di grande rilevanza epidemiologica e ad elevato assorbimento<br />
di risorse, come la cardiopatia ischemica<br />
post-acuta e cronica, gli esiti di cardiochirurgia e lo<br />
scompenso cardiaco.<br />
Tali obiettivi si realizzano attraverso progetti specifici<br />
nei seguenti ambiti:<br />
a) Ricerca di base, sul versante della genetica e<br />
della biologia molecolare delle cardiopatie ereditarie<br />
con particolare attenzione alle cardiopatie<br />
aritmogene per le quali l’attività di <strong>Fondazione</strong><br />
rappresenta il Centro di riferimento a livello Europeo<br />
e l’unico Centro Italiano in grado di offrire<br />
ai pazienti con patologie aritmogene ereditarie ad<br />
alto rischio di morte improvvisa un servizio di assistenza<br />
clinica specializzata e di puntuale diagnosi<br />
genetica. Sono stati identificati nuovi polimorfismi<br />
genetici responsabili e conclusi studi<br />
epidemiologici e di genotipo – fenotipo delle principali<br />
patologie aritmogene ereditarie. Sono in<br />
corso programmi per la applicazione della genetica<br />
molecolare alla gestione clinica delle aritmie<br />
cardiache con particolare riferimento alla stratificazione<br />
del rischio su base genetica e alla possibile<br />
terapia genica delle tachicardie ventricolari.<br />
b) Fisiopatologia cellulare cardiovascolare, rivolta<br />
alla comprensione dei meccanismi fisiopato-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 119<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
120<br />
logici che sottendono l’insorgenza e la progressione<br />
della cardiopatia ischemica, dello scompenso<br />
cardiaco e, più in generale, del danno vascolare<br />
e miocardico, con particolare riferimento<br />
allo studio del metabolismo energetico cellulare,<br />
al ruolo dei radicali liberi dell’ossigeno, all’attivazione<br />
neuroumorale, e al grado di coinvolgimento<br />
di alcuni sistemi di particolare interesse quali la<br />
disfunzione endoteliale, l’ossido nitrico, lo stress<br />
ossidativo, il sistema delle citochine, i fattori che<br />
mediano l’ipertrofia e il rimodellamento, fino ai<br />
meccanismi molecolari che regolano l’attivazione<br />
dei processi di morte (apoptosi) e/o sopravvivenza<br />
cellulare. Particolarmente interessante è la<br />
dimostrazione della associazione o relazione tra<br />
cellule progenitrici endoteliali circolanti e scompenso<br />
cardiaco che si realizza attraverso l’azione<br />
mielosoppressiva delle citochine.<br />
c) Ricerca clinica, in stretta connessione con le tematiche<br />
della ricerca di base e di fisiopatologia<br />
sperimentale, orientata allo sviluppo e applicazione<br />
di innovazioni tecnologiche e strumentali<br />
per la diagnosi precoce, valutazione e stratificazione<br />
prognostica delle cardiopatie, alla sperimentazione<br />
di programmi riabilitativi, alla ottimizzazione<br />
della terapia e alla prevenzione secondaria.<br />
Le tematiche di maggiore interesse comprendono:<br />
l’assetto neuroendocrino e il bilancio<br />
simpatovagale, l’analisi dei segnali biologici e dei<br />
disturbi del respiro durante il sonno, la fisiopatologia<br />
dell’esercizio, lo studio dei fattori che regolano<br />
o condizionano l’evoluzione clinica delle<br />
principali cardiopatie (con particolare riferimento<br />
alla cardiopatia ischemica e allo scompenso cardiaco),<br />
e dei fattori che influenzano l’outcome in<br />
riabilitazione. Significativi sono gli studi sulla fisiopatologia<br />
dell’esercizio fisico, tolleranza allo sforzo<br />
e funzione ventricolare nello scompenso, nel cardioperato<br />
e nell’anziano, sul potere prognostico<br />
aggiuntivo a medio e lungo termine di parametri<br />
clinici ergospirometrici e dei segnali cardiorespiratori<br />
nello scompenso, nonché sulla valutazione<br />
del rischio di disabilità associato o relato al rischio<br />
cardiovascolare.<br />
d) Ricerca epidemiologica applicata nell’ambito<br />
di trials clinici, sperimentazione e valutazione<br />
di modelli assistenziali, orientata al coordinamento<br />
e/o conduzione di studi epidemiologici, alla<br />
sperimentazione farmacologica e di modelli assi-<br />
stenziali innovativi in ambito cardiologico. Attenzione<br />
speciale è rivolta allo sviluppo di modelli assistenziali<br />
e di interventi riabilitativi di alta specializzazione,<br />
differenziati in rapporto al grado di disabilità<br />
e comorbidità e allo sviluppo di sistemi di<br />
teleassistenza cardiologica applicati sia sul territorio<br />
che in ambito di programmi riabilitativi a<br />
lungo termine per il cardiopatico cronico.<br />
L’attività scientifica del Dipartimento si realizza attraverso<br />
una fitta rete di collaborazioni interne, tra i Dipartimenti<br />
e gli Istituti di <strong>Fondazione</strong>, ed esterne con<br />
altri Istituti di Ricerca italiani e stranieri, particolarmente<br />
utile ed efficace nella conduzione di progetti a<br />
valenza multidisciplinare.<br />
Il Dipartimento favorisce la formazione, la didattica e<br />
gli scambi culturali attraverso iniziative di cooperazione<br />
con Istituti Universitari ed altri Enti di Ricerca.<br />
DIPARTIMENTO DI PNEUMOLOGIA<br />
RIABILITATIVA<br />
L’attività di Ricerca del Dipartimento di Pneumologia<br />
Riabilitativa, espressa attraverso i contributi delle singole<br />
Divisioni che ad esso afferiscono è da considerarsi<br />
sede elettiva di una medicina basata sul continuo<br />
dialogo multidirezionale e multidisciplinare tra<br />
ricerca di base, ricerca applicata e ricerca clinica in<br />
ambito pneumologico. Questa, pur articolandosi,<br />
com’è nella tradizione scientifica di questo Dipartimento,<br />
attraverso diversi ambiti di ricerca che vanno<br />
dalla Riabilitazione Polmonare alla Farmacologia Clinica<br />
in ambito respiratorio, è caratterizzata da una<br />
stretta connessione con l’attività clinico-assistenziale,<br />
in un rapporto interattivo, tanto che se da un lato i<br />
dati clinici costituituiscono la base di partenza degli<br />
Lavori scientifici, dall’altro la ricerca, finalizzata allo<br />
sviluppo di conoscenze dedicate alla verifica, al miglioramento<br />
dei protocolli diagnostici ed allo sviluppo<br />
di specifiche aree di eccellenza nel campo delle malattie<br />
respiratorie, fornisce le proposte di sperimentazione<br />
mirate al trasferimento dei risultati ottenuti<br />
nella pratica clinica.<br />
In quest’ottica il Dipartimento ha così consolidato la<br />
sua attività lungo le seguenti linee di ricerca:<br />
Riabilitazione dell’Insufficienza Respiratoria<br />
delle Malattie Croniche Ostruttive. Afferiscono<br />
a questo filone di ricerca tematiche dedicate alla<br />
valutazione dei parametri clinico funzionali indicativi<br />
del danno respiratorio, allo studio dei fattori di<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
ischio e delle possibilità di prevenzione delle<br />
complicanze delle malattie respiratorie ed in particolar<br />
modo al recupero delle disabilità che ne<br />
deriva. Tra le modalità di trattamento non farmacologico<br />
emerge, raccomandata da forti evidenze<br />
scientifiche che ne documentano l’efficacia, la<br />
Riabilitazione Polmonare (RP), che se integrata<br />
nel trattamento individualizzato del paziente, è in<br />
grado di ridurre i sintomi, ottimizzare lo stato funzionale,<br />
aumentare la performance fisica, recuperando,<br />
quindi, i pazienti ad uno stile di vita indipendente<br />
e produttivo, attraverso la stabilizzazione<br />
della malattia o invertendo le manifestazioni<br />
sistemiche della stessa. Resta, pertanto, grande<br />
l’interesse dei ricercatori del Dipartimento, impegnati<br />
come sono nella messa a punto di programmi<br />
globali di trattamento della patologia respiratoria<br />
comprendenti aspetti riabilitativi e nutrizionali,<br />
in un costante monitoraggio della progressione<br />
tramite strumenti avanzati per la valutazione<br />
degli “outcomes”, soprattutto riguardo a<br />
problemi ancora aperti sugli effetti della RP, il suo<br />
impatto su outcomes importanti, quali l’utilizzo<br />
delle risorse sanitarie o la sopravvivenza, gli effetti<br />
su malattie polmonari non ostruttive, la struttura<br />
ideale e le componenti essenziali di un programma<br />
riabilitativo, il miglior modo di valutare i<br />
risultati e l’impatto economico sul Sistema Sanitario.<br />
Notevole interesse riveste, poi, per il Dipartimento<br />
di Pneumologia, il campo della telemedicina<br />
che grazie alla disponibilità di nuove tecnologie<br />
e programmi di telesorveglianza per patologie<br />
croniche invalidanti, quali la BPCO e la IRC,<br />
permette di seguire adeguatamente l’evoluzione<br />
di tali patologie, ottimizzando l’accesso a strutture<br />
sanitarie senza perdere in qualità di assistenza.<br />
Infine, Grande attenzione è anche rivolta allo<br />
studio delle malattie rare, in particolar modo lo<br />
studio del deficit di alfa-1 antitripsina.<br />
Disturbi Respiratori del Sonno. I disturbi respiratori<br />
del sonno rappresentano una percentuale<br />
non trascurabile delle patologie dell’Apparato Respiratorio.<br />
Pertanto, negli ultimi anni si è osservato<br />
un interesse sempre crescente del Dipartimento<br />
verso questa particolare classe di patologie ed i<br />
percorsi diagnostici ad essa relativi. La capacità di<br />
diagnosticare patologie sonno-correlate è di fondamentale<br />
importanza nell’impostazione di Programmi<br />
Riabilitativi anche per le possibilità terapeutiche<br />
con ossigenoterapia e/o ventilazione<br />
notturna, in particolare in soggetti IRC o a limite<br />
per tale patologia. Pertanto le direttrici principali<br />
di ricerca in quest’ambito sono rivolti a studi dedicati<br />
alla identificazione di metodiche funzionali e<br />
di score clinico per l’identificazione di pazienti da<br />
sottoporre ad esame polisonnografico.<br />
Terapia Intensiva. L’interesse dei ricercatori del<br />
Dipartimento per questo filone di ricerca è confermato<br />
dai numerosi studi in corso mirati ad una migliore<br />
ottimizzazione dell’utilizzo della ventilazione<br />
meccanica, la cui efficacia ha già evidenza clinica,<br />
in diverse tipologie di pazienti e nel trattamento<br />
dell’Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) sostenuta<br />
da varie patologie ed in particolare nei soggetti<br />
affetti da Broncopneumopatia Cronica<br />
Ostruttiva (BPCO). In particolar modo, notevole interesse<br />
ha rivestito lo studio della NIV nell’IRA che<br />
si è dimostrata in grado di ridurre il numero di intubazioni<br />
endotracheali, la ventilazione meccanica<br />
invasiva, le successive complicanze e la mortalità.<br />
I vantaggi di questo trattamento sono tutt’ora in<br />
studio per poterne mettere in luce le potenzialità in<br />
particolari situazioni cliniche critiche, quali ad es. il<br />
trattamento della patologia respiratoria in uno<br />
stadio avanzato o nel facilitare lo svezzamento dal<br />
ventilatore, definendo i tempi ed i modi dell’applicazione,<br />
in particolare, dello stesso trattamento.<br />
Fisiopatologia e Meccanica Respiratoria. Gli<br />
orientamenti dell’attività di ricerca in questo settore<br />
sono direttamente collegati alle attività cliniche,<br />
infatti, alcune tematiche di ricerca nel<br />
campo della meccanica respiratoria nel soggetto<br />
critico sono state sviluppate producendo interessanti<br />
risultati, principalmente riguardo alle modalità<br />
di ventilazione meccanica e/o di svezzamento<br />
dal ventilatore. In particolar modo sono state studiate<br />
risposte fisiologiche durante un processo di<br />
svezzamento in soggetti trachostomizzati, l’aggiunta<br />
di ventilazione a percussione intrapolmonare<br />
al normale ciclo fisioterapico, (riscontrando<br />
un miglioramento degli scambi gassosi e della<br />
meccanica polmonare), ed alcune tecniche di<br />
svezzamento in casi di ventilazione proporzionale<br />
assistita in soggetti BPCO.<br />
Indagini Biologiche in Pneumologia. L’attività di<br />
ricerca in questo settore, supportata da una specialistica<br />
attività di laboratorio, ha come scopo<br />
principale quello di conoscere le basi biologiche<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 121<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
122<br />
dell’Asma e della Broncopneumopatia Cronica<br />
Ostruttiva (BPCO), esplorando approcci preventivi<br />
e terapeutici sperimentali, in particolar modo attraverso<br />
l’identificazione di nuove metodiche non<br />
invasive che possano permettere il riconoscimento<br />
e il monitoraggio dell’infiammazione delle vie<br />
aeree, da sempre uno degli obiettivi della ricerca in<br />
campo pneumologico. La tecnica dell’Espettorato<br />
Indotto si è rivelata appunto una delle metodiche<br />
più adatte a questo scopo. Essa è in grado di fornire<br />
informazioni dirette circa il grado di infiammazione<br />
bronchiale e quindi in grado di aumentare le<br />
possibilità di diagnosi e di monitoraggio della patologia<br />
respiratoria. Infatti, utilizzando tale metodiche,<br />
che permette la misurazione di indicatori di<br />
attivazione cellulare, viene valutato il tipo e il grado<br />
di infiammazione bronchiale allo scopo di definire<br />
i meccanismi fisiopatologici e l’efficacia del trattamento<br />
farmacologico.<br />
Farmacologia Clinica. Va sottolineato, inoltre,<br />
l’attività di ricerca dipartimentale nell’area farmacologica,<br />
infatti il Dipartimento si è rivelato in<br />
grado di attrarre, con la sua organizzazione in termini<br />
di procedure scientifiche definite e validate<br />
dal Comitato Etico e dalla Direzione Scientifica<br />
Centrale, finanziamenti privati dall’Industria farmaceutica<br />
per l’esecuzione di Trials Clinici farmacologici<br />
multicentrici nazionali ed internazionali. Sono<br />
molteplici gli approcci terapeutici nel trattamento<br />
delle patologie respiratorie, aventi come obiettivo<br />
principale quello di prevenire e controllare i sintomi,<br />
ridurre la frequenza e la gravità delle riacutizzazioni,<br />
con conseguente riduzione di ricoveri<br />
ospedalieri, migliorare la Qualità di Vita (QdV) e la<br />
tolleranza allo sforzo. Un ruolo fondamentale è rivestito<br />
dalla terapia farmacologia. A questo proposito<br />
si sono conclusi alcuni protocolli di ricerca<br />
multicentrici interdipartimentali su tematiche quali<br />
l’aderenza al trattamento nell’Asma, l’immunoterapia<br />
sublinguale per l’allergia all’acaro nella Rinite<br />
moderata e la necessità di un approccio basato<br />
sull’evidenza clinica nella riacutizzazione di BPCO.<br />
Nell’attuare i programmi di ricerca sperimentale e clinica<br />
il Dipartimento ha instaurato una fitta rete di<br />
collaborazioni con Istituti universitari ed Istituti di ricerca<br />
nazionali ed internazionali. La sua attività di ricerca<br />
favorisce, inoltre, una proficua attività didattica<br />
e formativa; peculiare la sua capacità di inserirsi in<br />
rete sia con l’attività scientifica degli altri Dipartimenti<br />
che con altri Istituti di Ricerca, per la produzione di<br />
progetti specifici e multidisciplinari.<br />
Va inoltre menzionata l’attività scientifica di molti ricercatori<br />
afferenti al Dipartimento in qualità:<br />
relatori e/o organizzatori di convegni scientifici di<br />
livello nazionale ed internazionale<br />
revisori ECM<br />
membri di comitati editoriali<br />
revisori di riviste scientifiche di carattere nazionale<br />
ed internazionale.<br />
L’attività formativa, infine, si è esplica anche attraverso<br />
l’attività editoriale del “Monaldi Archives for<br />
Chest Disease”, unica rivista nazionale recensita del<br />
settore.<br />
DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE<br />
INTEGRATIVA DELL’ANZIANO<br />
Il Dipartimento di Riabilitazione Integrativa dell’Anziano,<br />
nel suo ruolo di consulenza per gli altri Dpt<br />
scientifici della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>, per<br />
quanto attiene gli aspetti gerontologico-geriatrici<br />
della riabilitazione specialistica, ha svolto nel corso<br />
del 2007 la seguente attività scientifica clinica e sperimentale<br />
e formativa:<br />
1.0 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE<br />
1.1 Comorbilità e mortalità per insufficienza<br />
cardiaca cronica a 12 anni: ruolo dell’indice di<br />
Charlson<br />
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la<br />
relazione tra indice di Charlson e mortalità a 12 anni<br />
per insufficienza cardiaca cronica (CHF) nella popolazione<br />
di ultra65-enni arruolati nell’Osservatorio Geriatrica<br />
Campano. Dall’analisi si evince che l’indice di<br />
Charlson risulta predittivo sia in presenza che in assenza<br />
di patologie come la broncopneumopatia cronica,<br />
le malattie neurologiche e le vasculopatie periferiche<br />
mentre perde tale ruolo in presenza di diabete<br />
e soprattutto di CHF. Si conclude, pertanto, che<br />
l’indice di Charlson non è predittivo di mortalità in<br />
presenza di CHF indicando come tale patologia,<br />
anche isolatamente, possa influenzare in maniera<br />
drammatica la prognosi nel paziente anziano.<br />
(Russo S, Montuori C, Panza G, Loffredo F, Abbruzzese<br />
R, Rossetti M, Langellotto A, Avolio D, De Rosa<br />
G, Visconti C, Mazzella F, Cacciatore F, Abete P,<br />
Rengo F. Comorbilità e mortalità per insufficienza<br />
cardiaca cronica a 12 anni: ruolo dell’indice di<br />
Charlson. G Gerontol 2007; 55: 638).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
2.0 CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA NEL-<br />
L’ANZIANO<br />
2.1 An active lifestyle improves outcome of primary<br />
angioplasty in elderly patients with acute<br />
myocardial infarction<br />
È stato approfondito il ruolo dell’attività fisica pregressa<br />
nel condizionare la prognosi a 30 gg e ad 1<br />
anno dopo angioplastica primaria in soggetti anziani<br />
ultra-70enni con IMA, dimostrando che l’elevata<br />
mortalità riscontrata nell’intera casistica a 30 gg di<br />
oltre il 13%, se viene stratifica per livelli di attività fisica<br />
sale al 23,1% nei sedentari per scendere al<br />
18.2% nei soggetti con attività moderata ed al 4% nei<br />
soggetti con attività fisica più elevata. Analogo trend<br />
si riscontra dopo 1 anno dall’angioplastica primaria<br />
(Rengo G, Galasso G, Piscione F, Golino L, Fortunato<br />
F, Zincarelli C, Cassese S, Abete P, Chiariello M,<br />
Rengo F, Leosco D. An active lifestyle improves outcome<br />
of primary angioplasty in elderly patients with<br />
acute myocardial infarction. Am Heart J 2007; 154<br />
(2): 352-360).<br />
2.2 Malnutrizione in pazienti anziani ammessi in<br />
un setting di riabilitazione cardiologica<br />
Abbiamo condotto uno studio prospettico su una<br />
coorte di soggetti ammessi tra Febbraio 2003 e Dicembre<br />
2005 dopo intervento di cardiochirurgia. La<br />
percentuale di pazienti classificati come malnutriti,<br />
usando i 5 diversi parametri (BMI
INTRODUZIONE<br />
nale, diabete insulino-dipendente e BPCO, i cardiopatici<br />
con CHF dimostrano livelli maggiori di potassio,<br />
urea, creatinina, bilirubinemia totale, acido<br />
urico, neutrofili mentre il sodio, il colesterolo totale, le<br />
protrine totali, l’emoglobina ed i linfociti dimostrano<br />
livelli minori. La sopravvivenza è stata di 865.9±375.5<br />
giorni nell’intera popolazione, di 924±333,3 giorni nei<br />
pazienti CVD e di 721,7±431,5 giorni nei pazienti CHF<br />
(P
3.2 Vascular Risk Factors in Mild Cognitive Impairment<br />
Subtypes. Findings from the ReGAl<br />
Project<br />
Abbiamo investigato il ruolo dei fattori di rischio vascolari<br />
in differenti sottotipi di Mild Cognitive impairment<br />
(MCI) afferenti ad uno studio clinico multicentrico<br />
trasversale: 207 soggetti MCI sono stati<br />
studiati, di cui 33 con “single non-memory MCI”<br />
(snmMCI), 42 con “multiple-domain amnestic MCI”<br />
(mdMCI-a) and 132 con “amnestic MCI” (aMCI). I<br />
pazienti “snmMCI” dimostrano una più alta frequenza<br />
di cardiopatia ischemica (CAD) e di<br />
TIA/stroke, un più alto score di Hachinski e maggiore<br />
frequenza di leucoaraiosi alla risonanza magnetica<br />
rispetto ai soggetti “aMCI”. I soggetti<br />
“mdMCI” dimostrano caratteristiche cliniche simili a<br />
quelli “aMCI” ove si escluda una più elevata frequenza<br />
di storia di TIA/stroke, concludendo che<br />
“snmMCI” può essere considerato un disordine cognitivo<br />
su base vascolare.<br />
(Mariani E, Monastero R, Ercolani S, Mangialasche F,<br />
Caputo M, Feliziani FT, Vitale DF, Senin U, Mecocci P.<br />
Vascular Risk Factors in Mild Cognitive Impairment<br />
Subtypes. Findings from the ReGAl Project. Dement<br />
Geriatr Cogn Disord 2007; 24 (6): 448-456).<br />
3.3 Screening of Depressive Symptoms in<br />
Young-Old Hemodialysis Patients: Relationship<br />
between Beck Depression Inventory and 15-<br />
Item Geriatric Depression Scale<br />
Abbiamo valutato la relazione tra la Beck Depression<br />
Inventory (BDI) e la 15-item Geriatric Depression<br />
Scale (GDS-15) in soggetti anziani emodializzati<br />
o ospedalizzati. Nel gruppo ospedalizzato la<br />
presenza di sintomi depressivi (BDI≥14; GDS-15≥6)<br />
si riscontrava rispettivamente nel 29 e 32% mentre<br />
nel gruppo emodializzato era rispettivamente del 61<br />
e 58%, utilizzando i due diversi strumenti. Una correlazione<br />
significativa tra BDI e GDS-15 si osserva<br />
nei soggetti ospedalizzati (r=0.808; p
INTRODUZIONE<br />
3.6 L’aumentata suscettibilità al danno ischemico<br />
cerebrale nel cervello invecchiato è correlata<br />
ai piu bassi livelli di e-PKC<br />
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare se<br />
il cervello di ratto invecchiato è più suscettibile all’ischemia<br />
in relazione a livelli più bassi di e-PKC. Nonostante<br />
la maggiore severità di insulto ischemico ai<br />
quali erano stati sottoposti i ratti giovani ed adulti, all’analisi<br />
istologica il numero dei neuroni vivi nella<br />
zona CA1 dell’ippocampo non differiva tra i tre differenti<br />
gruppi di ratti (giovani = 1133±31; adulti =<br />
917±62; invecchiati = 964±72). Nessuna differenza<br />
statisticamente significativa è stata osservata nei livelli<br />
di γ-PKC, α-PKC ed e-PKC nella frazione cellulare<br />
solubile o citosolica dei neuroni di ippocampo.<br />
Nella frazione cellulare particolata o di membrana i<br />
valori di e-PKC nel cervello dei ratti invecchiati erano<br />
più bassi del 21% e del 30% rispetto ai livelli di e-PKC<br />
nel cervello di ratti giovani ed adulti (p
vità della malattia. Inoltre, è stato dimostrato che l’esistenza<br />
di una correlazione tra il deficit cognitivo e la<br />
dipendenza fisita (BADL, IADL).<br />
(Antonelli-Incalzi R, Corsonello A, Trojano L, Acanfora<br />
D, Spada A, Izzo O, Rengo F. Correlation between cognitive<br />
impairment and dependence in hypoxemic<br />
COPD. J Clin Exp Neuropsychol 2007 Jun 21: 1-10).<br />
5.2 Screening of cognitive impairment in<br />
chronic obstructive pulmonary disease<br />
In soggetti affetti da COPT con ipossiemia, nei quali è<br />
stata confermata una correlazione tra BPCO e deficit<br />
cognitivo, è stato valutato il potere predittivo della<br />
“Mental Deterioration Battery-MDB-” vs il MMSE, dimostrando<br />
che il MMSE in presenza di 1 IADLpersa<br />
possiede un potere maggiore rispetto alla MDB.<br />
(Antonelli-Incalzi R, Corsonello A, Trojano L, Pedone<br />
C, Acanfora D, Spada A, Izzo O, Rengo F. Screening<br />
of cognitive impairment in chronic obstructive pulmonary<br />
disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2007;<br />
23 (4): 264-70. Epub 2007 Mar 12).<br />
6.0 ONCOLOGIA<br />
6.1 Massive load of functional effector CD4+<br />
and CD8+ T cells against cytomegalovirus in<br />
very old subjects<br />
È stato valutato la risposta delle Tcells a 2 proteine<br />
immunogeniche, pp65 e IE-1, in 65 soggetti con infezioni<br />
croniche di età compresa tra 25-100 anni, sulla<br />
ipotesi che un basso stato proinfiammatorio sistemico<br />
e progressivo rappresenti la maggiore caratteristica<br />
dell’immunosenescenza. Lo studio ha dimostrato<br />
che CMV rappresenta un importante induttore<br />
dell’attivazione immunologica nel paziente anziano e<br />
che un rimarchevole impatto del CD4 e CD8+Tcells<br />
sono necessari per proteggere l’anziano dalla reazione<br />
endogena CMV.<br />
(Vescovini R, Biasini C, Fagnoni FF, Telera AR, Zanlari<br />
L, Pedrazzoni M, Bucci L, Monti D, Medici MC, Chezzi<br />
C, Franceschi C, Sansoni P. Massive load of functional<br />
effector CD4+ and CD8+ T cells against cytomegalovirus<br />
in very old subjects. J Immunol 2007;<br />
179: 4283-91).<br />
7.0 ATTIVITÀ CONGRESSUALE<br />
7.1 2°Congresso della Società Italiana di Riabilitazione<br />
di Alta Specializzazione (SIRAS)<br />
Nell’ambito del Congresso, tenutosi a Benevento dal<br />
25-26 ottobre 2007, precisamente nella sessione de-<br />
dicata alla “Riabilitazione molecolare” e alla “Riabilitazione<br />
del cardiopatico complesso”, sono stati<br />
esposti i percorsi assistenziali del cardiopatico anziano<br />
affetto da comorbilità, i quali prevedono l’indispensabilità<br />
di una valutazione multidimensionale<br />
per definire il programma terapeutico-riabilitativo di<br />
questa tipologia di paziente. I risultati raggiunti sono<br />
stati possibili attraverso una intensa collaborazione<br />
tra il Dpt di Cardiologia riabilitativa ed il Dpt di Riabilitazione<br />
integrativa dell’anziano.<br />
RIABILITAZIONE INTEGRATIVA<br />
DEL DISABILE E DELL’ANZIANO<br />
E ERGONOMIA OCCUPAZIONALE<br />
I principali filoni che sono stati sviluppati nel corso<br />
dell’anno corrente rimangono in continuità con gli<br />
studi condotti negli scorsi anni e si riferiscono alla seguenti<br />
tematiche:<br />
1) Argomenti di Riabilitazione Occupazionale e<br />
Ergonomia, applicate alla clinica riabilitativa.<br />
2) Misurazione dell’outcome in Medicina Riabilitativa<br />
e Occupazionale.<br />
Molte ricerche si svolgono in stretta collaborazione<br />
con le Unità Operative della nostra <strong>Fondazione</strong> afferenti<br />
alle altre linee di ricerca specialistiche settoriali.<br />
Entrambi i filoni di ricerca si inseriscono nei concetti<br />
ispiratori del documento OMS “International Classification<br />
of Functioning, Disability and Health (ICF)”<br />
che enfatizza soprattutto l’analisi di attività funzionali<br />
e della partecipazione come aspetti fondamenti per la<br />
descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.<br />
1) Argomenti di Riabilitazione Occupazionale e<br />
Ergonomia, applicate alla clinica riabilitativa<br />
Su questi temi le principali ricerche sono state le seguenti:<br />
Valutazione funzionale multi-dimensionale e riabilitazione<br />
mirata del paziente con malattia di<br />
Parkinson, con particolare riguardo per disturbi<br />
dell’equilibrio, dei passaggi posturali e della<br />
marcia e paura di cadere.<br />
Valutazione del recupero funzionale e del reinserimento<br />
dell’amputato protesizzato di arto inferiore<br />
sottoposto a trattamento riabilitativo (inclusi<br />
studi sui fattori legati all’utilizzazione a lungo termine<br />
di apparecchiature protesiche e analisi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 127<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
comparative di questionari patologia-specifici) e<br />
del paziente cardiopatico critico.<br />
Studi sugli effetti di un programma di allenamento<br />
fisico nei soggetti della terza età (over 65 e over<br />
75) su prestazioni muscolari, equilibrio, massa<br />
ossea, abilità funzionale globale, stile di vita ecc.<br />
Disturbi muscolo-scheletrici a genesi lavorativa a<br />
livello dell’arto superiore e del rachide, dalla prevenzione<br />
al reinserimento (con particolare riguardo<br />
alla messa a punto di metodologie per la<br />
quantificazione del rischio da movimentazione<br />
manuale di pazienti da parte di personale ospedaliero).<br />
Interventi per la riduzione dell’inabilità temporanea<br />
assoluta dell’infortunato sul lavoro fino al<br />
reinserimento lavorativo.<br />
Studi sull’appropriatezza del ricovero riabilitativo<br />
in regime di day-hospital.<br />
Fra le tematiche interdipartimentali, svolte in stretta<br />
collaborazione con le altre Unità Operative della nostra<br />
<strong>Fondazione</strong>, afferenti alle linee di ricerca specialistiche<br />
settoriali, riportiamo inoltre:<br />
il progetto di collaborazione nazionale e internazionale,<br />
in corso presso alcuni nostri Centri, per la<br />
validazione di strumenti derivati dall’ICF e definiti<br />
ICF Core Set che raccolgono una lista di categorie<br />
ICF prevedibilmente rilevanti e significative in<br />
certe condizioni patologiche. In base a considerazioni<br />
epidemiologiche, sanitarie e socio-assistenziali,<br />
sono stati individuati dal progetto come significativi<br />
per il contesto sanitario e riabilitativo<br />
del nostro Paese i 4 Core set relativi a ictus cerebrale,<br />
osteoporosi, dolore cronico e malattie respiratorie<br />
ostruttive croniche;<br />
l’analisi della mobilità nel lungo periodo (24-48<br />
ore), tramite apparecchiature portatili non invasive<br />
di registrazione avanzate di attività motorie e<br />
di costo energetico, con la creazione di software<br />
dedicati, applicate a pazienti con diverse patologie<br />
disabilitanti di varia natura (cardio-respiratoria,<br />
angiologica, nefrologica, ecc.) in fase riabilitativa.<br />
2) Misurazione dell’outcome in Medicina Riabilitativa<br />
e Occupazionale<br />
Il settore di ricerca relativo alla misurazione del risultato<br />
terapeutico (“outcome”) focalizza la propria attenzione<br />
alla quantificazione di gesti e attività motorie,<br />
variabili psico-comportamentali, capacità re-<br />
128<br />
sidue e potenziali dei pazienti, oltre che all’analisi di<br />
variabili prognostiche rispetto alla disabilità e dipendenza<br />
funzionale. Sono analizzati e perfezionati questioni,<br />
scale, test e apparecchiature per la valutazione<br />
funzionale, anche ai fini di una ottimale gestione clinica<br />
del paziente e di processi di verifica e revisione<br />
di qualità.<br />
I principali temi di ricerca sono relativi a:<br />
Validazione sia con metodiche psicometriche<br />
classiche sia con modelli di Rasch (con adattamento<br />
transculturale) di scale di valutazione funzionale,<br />
equilibrio, mobilità, paura di cadere, immagine<br />
corporea, attività, partecipazione e qualità<br />
di vita, in differenti popolazioni di pazienti con<br />
grave disabilità acquisita (in particolare malattia di<br />
Parkinson e amputati di arto inferiore o superiore).<br />
Analisi comparativa di metodi di rilevazione della<br />
sincerità di sforzi massimali in condizioni isocinetiche.<br />
Sviluppo e uso clinico di metodologie strumentali<br />
per la valutazione delle capacità funzionali e delle<br />
limitazioni in soggetti affetti da malattie neurologiche<br />
con grave disabilità, in relazione ad attività<br />
domiciliari ed eventualmente anche lavorative.<br />
Questo filone di ricerca affronta il problema sia<br />
tramite registrazione prolungata di attività motorie,<br />
sia tramite la quantificazione dell’impegno<br />
psicofisico e del costo energetico durante attività<br />
quotidiane nelle 24-48 ore. Lo scopo finale di<br />
questi studi è la valutazione delle capacità residue<br />
e dell’outcome del disabile quando reinserito nel<br />
proprio ambiente sociale, ai fini della realizzazione<br />
di percorsi rieducativi individuali, della prescrizione<br />
della “finestra terapeutica” utile in questi<br />
pazienti, della comparazione fra capacità residue<br />
e richieste energetiche domiciliari e/o lavorative, e<br />
della somministrazione di programmi rieducativi<br />
in piena sicurezza e in continuità assistenziale per<br />
ogni pazienti.<br />
Le ricerche condotte in questi anni nei due settori<br />
precedentemente esposti hanno anche portato a significative<br />
pubblicazioni didattiche, quali:<br />
l’avvio di una collana editoriale dedicata ad “Argomenti<br />
di Terapia Occupazionale”, che ha già visto<br />
la realizzazione di 2 volumi;<br />
la stesura di 2 importanti capitoli, sull’outcome e<br />
sull’ergonomia, in un noto “Trattato di Medicina<br />
Riabilitativa”;<br />
la collaborazione alla stesura delle Linee-Guida<br />
SIMLII sulla movimentazione dei pazienti in am-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
iente sanitario-assistenziale e la connessa organizzazione<br />
di corsi su tale argomento;<br />
la preparazione del capitolo su “Ergonomia e progettazione<br />
dell’ambiente lavorativo” di un volume<br />
di riferimento italiano sugli ausili.<br />
DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA<br />
E TECNOLOGIE BIOMEDICHE<br />
Afferiscono al Dipartimento i Servizi di Bioingegneria<br />
degli Istituti Scientifici di Castel Goffredo, Montescano,<br />
Telese, Veruno e Pavia.<br />
Attività<br />
L’attività dei Servizi di Bioingegneria della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> è finalizzata a fornire al<br />
Riabilitatore nuove metodiche strumentali ad alto<br />
contenuto tecnologico e/o matematico-ingegneristico<br />
per l’indagine ed il recupero delle capacità<br />
funzionali di portatori di menomazioni neuromotorie,<br />
cardiorespiratorie e di patologie croniche sistemiche<br />
disabilitanti.<br />
Il raggiungimento di tali obbiettivi si esplica attraverso<br />
il supporto, la qualificazione e l’incremento<br />
della ricerca scientifica applicata che l’Ente persegue<br />
nelle linee di attività istituzionali di Riabilitazione Cardiologica,<br />
Pneumologica, Neuromotoria.<br />
La presenza del Servizio di Bioingegneria come unità<br />
operativa all’interno dell’Istituto di Riabilitazione, peculiarità<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>, ha prodotto sin<br />
dalle origini una stretta integrazione tra il Servizio e le<br />
Unità Cliniche che consente da un lato una presenza<br />
ed un coinvolgimento costante nelle problematiche<br />
sanitarie di personale con competenze tecniche, dall’altro<br />
l’immediato trasferimento dei risultati ottenuti<br />
dalla ricerca all’attività sanitaria, sia essa clinica o gestionale.<br />
Il livello della ricerca svolta è tale da attrarre finanziamenti<br />
da programmi nazionali e internazionali (contratti<br />
di ricerca con la Comunità Europea, le Regioni,<br />
il Ministero della Salute, dell’Istruzione Università e<br />
Ricerca, o di altri Enti).<br />
Il Servizi di Bioingegneria si incaricano inoltre di coadiuvare<br />
il personale sanitario nelle problematiche che<br />
coinvolgano la tecnologia in ambiente sanitario.<br />
Le competenze specifiche delle Unità Operative afferenti<br />
al Dipartimento sono:<br />
Tecniche di rilevazione dei segnali bioelettrici, trasduttori<br />
e condizionatori di segnale; sistemi di acquisizione<br />
dati.<br />
Modellizzazione matematica e ‘Digital Signal Processing’.<br />
Biomeccanica e robotica.<br />
Informatica clinica, sistemistica e telecomunicazioni.<br />
Bioimmagini (Image processing, multimedia e<br />
video).<br />
Biostatistica.<br />
Ingegneria clinica.<br />
Tematiche di ricerca dipartimentali e progetti<br />
specifici (2006-2007)<br />
Le tematiche di ricerca coordinate nel Dipartimento<br />
di Bioingegneria e Tecnologie Biomediche ed i principali<br />
progetti ad esse riferite sono:<br />
Metodi per la valutazione ed il trattamento riabilitativo<br />
delle disabilità motorie<br />
– Applicazione di terapia robot-assistita in Neuroriabilitazione.<br />
– Tecniche robotizzate per la riabilitazione e l’autonomia<br />
funzionale.<br />
– Sviluppo di una metodologia obiettiva per la<br />
misura e verifica del recupero indotto da Neuroriabilitazione,<br />
in particolare della CIMT (‘Costraint<br />
Induced Motor Training’) dell’arto inferiore.<br />
Analisi del movimento e della postura<br />
– Studio dell’influenza delle afferente sensoriali<br />
sul cammino.<br />
– Effetto della stimolazione magnetica transcranica<br />
sul cammino.<br />
– Induzione artificiale di patterns locomotori tramite<br />
vibrazione ritmata dei muscoli posturali.<br />
– Valutazione dell’impatto dell’amputazione dell’arto<br />
inferiore sulla mobilità e sulla qualità di<br />
vita.<br />
– Un Registratore Avanzato di Attività Motoria<br />
per l’analisi della mobilità del paziente affetto<br />
da Malattia di Parkinson.<br />
Telemedicina<br />
– Messa a punto di nuove metodologie per la<br />
Teleriabilitazione neuromotoria.<br />
– Architetture e sistemi per la trasmissione di<br />
immagini ecocardiografiche su reti a larga<br />
banda.<br />
– Valutazione di sistemi per il telemonitoraggio<br />
domestico di pazienti cronici.<br />
Metodi quantitativi e modelli per lo studio dei segnali<br />
biologici in ambito cardiologico, pneumologico<br />
e neuromotorio<br />
– Indagine sui meccanismi di azione sul dolore<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 129<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva<br />
e della stimolazione elettrica transcranica<br />
con corrente continua diretta.<br />
– Studio della eccitabilità dei fibre motoria durante<br />
stimolazione magnetica e stimolazione<br />
elettrica.<br />
– Studio sulla sicurezza per l’operatore e per il<br />
paziente sottoposto a stimolazione magnetica<br />
transcranica (TMS).<br />
– Studio dei parametri di meccanica respiratoria.<br />
– Studio dei processi di produzione della parola.<br />
– Studio della fisiopatologia delle alterazioni dell’equilibrio<br />
neurovegetativo, in particolare mediante<br />
metodologie non-invasive.<br />
– Studio delle interazioni cardiorespiratorie in<br />
pazienti soggetti ad anormalità del pattern respiratorio<br />
(respiro periodico, apnee centrali e/o<br />
ostruttive).<br />
– Sviluppo e validazione di modelli matematicostatistici<br />
dei sistemi di controllo cardiovascolare<br />
e respiratorio.<br />
– Ritmi cardiorespiratori nei pazienti con scompenso<br />
cardiaco cronico: caratterizzazione temporale<br />
e spettrale, analisi delle interrelazioni tra<br />
i segnali, valutazione dei modelli interpretativi<br />
correnti.<br />
– Valutazione del sistema nervoso autonomo<br />
post stroke, nella BPCO, nei disturbi cognitivi e<br />
nei soggetti obesi con tecniche lineari e non lineari<br />
(Mappe di Poincarè) di variabilità della<br />
frequenza cardiaca.<br />
Metodi di analisi statistica per l’analisi di dati clinici<br />
e sperimentali<br />
– Implementazione ed applicazione di metodologie<br />
innovative di analisi statistica multivariata<br />
per l’identificazione di indici prognostici di outcome<br />
riabilitativo e mortalità.<br />
– Implementazione ed applicazione di metodologie<br />
innovative per la valutazione di accuratezza<br />
di misure cliniche e strumentali.<br />
– Applicazione di metodologie avanzate per la<br />
determinazione della validità psicometrica di<br />
scale cliniche.<br />
Coordinamento ricerche finanziate<br />
Ministero della Salute<br />
Tools per la Riabilitazione: Riabilitazione Robotizzata<br />
e Teleriabilitazione.<br />
MIUR<br />
Messa a punto di nuove metodologie per la Tele-<br />
Riabilitazione Neuromotoria (Veruno).<br />
130<br />
INAIL<br />
Taratura del Registratore Avanzato di Attività Motorie<br />
(RAAM) per l’analisi della mobilità dell’amputato<br />
a livello transfemorale.<br />
Definizione di una batteria di test per la valutazione<br />
delle capacità funzionali dell’infortunato sul<br />
lavoro.<br />
La valutazione della sincerità dello sforzo massimale<br />
in ergometria: confronto tra differenti indici<br />
e protocolli di valutazione.<br />
Comunità Europea<br />
Studio “Home or Hospital in Heart Failure” (HHH<br />
- QLGA-CT-2001-02424) Comparazione tra la pratica<br />
clinica usuale e tre strategie di telemonitoraggio<br />
domestico a complessità incrementale in<br />
relazione a: riospedalizzazioni per scompenso,<br />
mortalità e qualità della vita (Montescano, coordinamento<br />
tecnico).<br />
Partecipazione a ricerche finanziate<br />
Ministero della Salute<br />
Tele-ecocardiografia sul territorio: studio di fattibilità,<br />
accuratezza diagnostica e analisi del rapporto<br />
costo/efficacia di un servizio di teleconsulto ecocardiografico<br />
per il Medico di Medicina Generale.<br />
Neurotossici ambientali e rischio di Malattia di<br />
Parkinson.<br />
MIUR<br />
Il movimento umano e l’integrazione sensorimotoria.<br />
Ridondanza, plasticità, apprendimento, memoria<br />
spaziale, degradazione, modelli.<br />
Collaborazioni scientifiche attive<br />
Nell’ambito della convenzione con l’Università di<br />
Pavia per la Ricerca in Bioingegneria per la Riabilitazione,<br />
tirocinio sull’argomento: “Stimolatore<br />
elettrica trancranica con corrente continua diretta<br />
per la terapia del dolore”.<br />
Convenzione con il Dipartimento di Informatica,<br />
Sistemistica e Telematica dell’Università di Genova<br />
per l’attivazione di progetti comuni nell’ambito<br />
della robotica in riabilitazione.<br />
Convenzione con il Centre de Recherche Hopital<br />
du Sacré Coeur de Montreal per lo Studio del Sistema<br />
Nervoso Autonomo.<br />
Iniziative<br />
Convegno “Impiego di nuove tecnologie nei trattamenti<br />
di neuroriabilitazione”, Pavia 14 Novembre<br />
2006.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
I Libri della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
LA FONDAZIONE PUBBLICA:<br />
1. I “Quaderni di Medicina del Lavoro e Medicina<br />
Riabilitativa” con i quali si propone di rendere<br />
disponibile in forma organica argomenti e<br />
problemi attuali in Medicina del Lavoro e Riabilitazione,<br />
di presentare elaborazioni di materiale informativo<br />
e didattico riguardante i vari settori di attività<br />
della <strong>Fondazione</strong>.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. G. Pezzagno: Rischio da Benzene. 1989<br />
2. G. Franco: Attività umane e rischio per la salute. 1990<br />
3. M. Imbriani, S. Ghittori, G. Pezzagno, E. Capodaglio:<br />
Esposizione professionale ad anestetici per inalazione.<br />
1990<br />
4 F. Franchignoni: Aggiornamenti in Riabilitazione 2.<br />
1990<br />
5. E. Capodaglio, L. Manzo: Esposizione a Stirene. 1990<br />
6. G. Pezzagno, E. Capodaglio: Criteri di valutazione<br />
energetica delle attività fisiche. 1991<br />
7. G. Franco: Acidi biliari e xenobiotici. 1991<br />
8. S. Cerutti, G. Minuco: Spectral Analysis of Heart Rate<br />
Variability Signal. Methodological and Clinical<br />
Aspects. 1991<br />
9. F. Franchignoni: Aggiornamenti in Riabilitazione 3.<br />
1991<br />
10. M. Imbriani, A. Di Nucci: Effetti della interazione tra<br />
etanolo e solventi. 1991<br />
11. F. Cupella, R. Turpini: La riabilitazione in gastroenterologia.<br />
1991<br />
12. L. Manzo, M. Imbriani, L.G. Costa: Current Issues in<br />
Alcoholism. 1992<br />
13. C. Rampulla, N. Ambrosino: Muscoli respiratori e patologia:<br />
valutazione e trattamento. 1992<br />
14. S. Della Sala, M. Laiacona: Laboratorio di Neuropsicologia.<br />
1992<br />
15. F. Franchignoni: Aggiornamenti in Riabilitazione 4.<br />
1992<br />
16. E. De Rosa, G.B. Bartolucci, V. Cocheo: Atti 11° Congresso<br />
Nazionale A.I.D.I.I. 1992<br />
17. B. Carù, R. Tramarin: New trends in cardiac rehabilitation.<br />
1992<br />
18. L. Manzo, D.F. Weetman: Toxicology of combustion<br />
products. 1992<br />
19. C. Minoia, E. Sabbioni, P. Apostoli, A. Cavalleri: Valori di<br />
riferimento di elementi in traccia in tessuti umani. 1992<br />
20. D. Cottica, G.F. Peruzzo: Atti 12° Congresso Nazionale<br />
A.I.D.I.I. 1993<br />
21. G. Pezzagno: Strategie di campionamento ambientale.<br />
Alcune applicazioni statistiche per lo studio<br />
degli inquinanti ambientali. 1993<br />
22. M. Casacchia, R. Casale, E. Ferrari, C. Setacci: Stress.<br />
Riunione operativa sottoprogetto stress - Progetto<br />
finalizzato CNR - FATMA. 1993<br />
23. G. Moscato: Asma professionale. 1993<br />
24. A. Cavalleri, G. Catenacci: Obbligo di referto e malattie<br />
professionali. 1993<br />
25. G. Bazzini: Nuovi approcci alla riabilitazione industriale.<br />
1993<br />
26. P. Pinelli, G. Minuco: Il controllo motorio della mano<br />
e della parola: teoria e applicazioni. 1993<br />
27. F. Candura, G. Sardo: L’Ispettorato Medico Centrale<br />
del Lavoro in Italia:<br />
storia e prospettive.<br />
1994<br />
28. G. Bertolotti, E. Sanavio,<br />
G. Vidotto, A.M.<br />
Zotti: Un modello di<br />
valutazione psicologica<br />
in Medicina Riabilitativa.<br />
1994<br />
29. D. Cottica, M. Imbriani:<br />
Atti 13° Congresso<br />
Nazionale A.I.D.I.I<br />
1994<br />
30. S. Della Sala, A.M.<br />
Zotti: Psicologia dell’invecchiamento ed epidemiologia<br />
della demenza: uno studio di popolazione.<br />
1994<br />
31. A. Cavalleri: Lavanderie a secco: rivalutazione del rischio<br />
da solventi. 1994<br />
32. G.D. Pinna, R. Maestri: Spectral analysis of cardiovascular<br />
variability signals. 1995<br />
33. R. Casale, A. Tango: Le algodistrofie. Dalla diagnosi<br />
alla prevenzione. 1995<br />
34. D. Cottica, V. Prodi, M. Imbriani: Atti 14° Congresso<br />
Nazionale A.I.D.I.I. 1995<br />
35. C. Rampulla, A. Patessio, A. Rizzo, F. Iodice: Valutazione<br />
funzionale del danno respiratorio. 1995<br />
36. R.F.E. Pedretti, P. Della Bella: Le Tachiaritmie Ventricolari<br />
Maligne dopo Infarto Miocardico. 1995<br />
37. K. Foglio: La ventiloterapia domiciliare nei pazienti<br />
broncopneumatici con insufficienza respiratoria<br />
cronica. 1996<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 131<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
38. L. Riboldi, C. Ravalli: Lo stress nel mondo del lavoro:<br />
quali soluzioni per un problema in espansione. 1996<br />
39. A. Molfese: Piattaforme Petrolifere. Igiene, Sanità e<br />
Sicurezza a bordo. 1996<br />
40. R. Gibellini, A. Ferrari Bardile, M. Zambelli, M. Fanello:<br />
La riabilitazione in angiologia. 1996<br />
41. S. Binaschi: Medicina del Lavoro. 1997<br />
2. I “Documenti” della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, nei quali vengono pubblicati gli Atti di<br />
Convegni di particolare interesse organizzati dagli<br />
Istituti della <strong>Fondazione</strong>.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. C. Passerino: La nuova riforma sanitaria. 1995<br />
2. Serials with an Institute for Scientific Information<br />
(ISI). Impact Factor. 1995<br />
3. F. Candura: Atti del Convegno: Metodologia di indagine<br />
sul danno ambientale. Inquinamento atmosferico<br />
e acustico nel territorio di Pavia. 1995<br />
4. N. Ambrosino, G. Bazzini, F. Cobelli, F. Franchignoni,<br />
P. Giannuzzi, C. Rampulla, M. Vitacca: Percorsi<br />
valutativi e terapeutici in Medicina Riabilitativa.<br />
1995<br />
5. G. Franco: Rischi lavorativi in ambiente sanitario:<br />
patologia da guanti. 1996<br />
6. G.B. Bartolucci, D. Cottica, M. Imbriani: Atti 15° Congresso<br />
Nazionale A.I.D.I.I. 1996<br />
7. E. Capodaglio, C. Passerino: Atti del Convegno: Sistemi<br />
classificativi dei<br />
pazienti in degenza<br />
riabilitativa. 1996<br />
8. A. Borgo: L’analisi in<br />
componenti principali<br />
come studio di correlazioni.<br />
1996<br />
9. F. Pisano: Valutazione<br />
e trattamento delle<br />
compromissioni motorie<br />
centrali: stato<br />
dell’arte e recenti acquisizioni.<br />
1996<br />
10. G. Vittadini, I. Giorgi:<br />
Dalla cibernetica dell’io all’approccio ecologico: alcolismo<br />
e servizi nell’ottica sistemica. 1996<br />
11. N. Ambrosino, G. Bazzini, F. Cobelli, F. Franchignoni,<br />
P. Giannuzzi, C. Rampulla, M. Vitacca: Percorsi valutativi<br />
e terapeutici in Medicina Riabilitativa. 1997<br />
12. C. Minoia, G. Scansetti, G. Piolatto, A. Massola: L’amianto:<br />
dall’ambiente di lavoro all’ambiente di vita.<br />
Nuovi indicatori per futuri effetti. 1997<br />
132<br />
13. A.M. Cirla, G. Catenacci: Organizzazione dell’emergenza<br />
sanitaria e del primo soccorso nei luoghi di<br />
lavoro. 1997<br />
14. G.B. Bartolucci, D. Cottica, M. Imbriani, D. Sordelli:<br />
Atti 16° Congresso Nazionale A.I.D.I.I. 1997<br />
15. G. Catenacci, G.B. Bartolucci, P. Apostoli: III Congresso<br />
Nazionale di Medicina Preventiva dei Lavoratori<br />
della Sanità. 1998<br />
16. D. Cottica, G.B. Bartolucci, M. Imbriani, E. Grignani,<br />
D. Sordelli: Atti 17° Congresso Nazionale A.I.D.I.I.<br />
1998<br />
3. “Advances in Occupational Medicine &<br />
Rehabilitation” “Aggiornamenti in Medicina<br />
Occupazionale e Riabilitazione”, rivista quadrimestrale.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. G. Bazzini: Efficacia e qualità in riabilitazione motoria.<br />
1995<br />
2. M. Imbriani, S. Ghittori, G. Pezzagno E. Capodaglio:<br />
Update on Benzene. 1995<br />
3. M.R. Strada, G. Bernardo: Interventi riabilitativi in<br />
Oncologia. 1996<br />
4. J. Nilsson, M. Panizza, F. Grandori: Advances in Magnetic<br />
Stimulation. 1996<br />
5. S. Della Sala, C. Marchetti, O.H. Turnbull: An interdisciplinary<br />
approach to the rehabilitation of the neurological<br />
patient: A cognitive perspective. 1996<br />
6. P. Capodaglio, G. Bazzini: L’attività motoria degli arti<br />
superiori: aspetti in medicina occupazionale e riabilitativa.<br />
1997<br />
7. G. Pezzagno, M. Imbriani: Cinetica e Monitoraggio<br />
Biologico dei Solventi Industriali. 1997<br />
8. L. Manzo, J. Descotes, J. Hoskins: Volatile Organic<br />
Compounds in the Environment. Risk Asses<br />
sment and Neurotoxicity.<br />
1997<br />
9. P. Capodaglio, M.V. Narici:<br />
Muscle Atrophy:<br />
Disuse and Disease.<br />
1998<br />
10. G. Moscato: Allergia<br />
respiratoria. 1998<br />
11. G. Miscio, P. Pinelli:<br />
Prefrontal cortex, Working<br />
memory and Delayed<br />
reactions: from<br />
the theory to the clinical<br />
application. 1998<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
4. “Advances in Rehabilitation” “Aggiornamenti<br />
in Medicina Riabilitativa”.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. F.M. Cossa, L. Mazzini: Assistenza clinica e ricerca<br />
scientifica: validità dell’approccio multidisciplinare<br />
al traumatizzato cranico. 1999<br />
2. P. Capodaglio, M.V. Narici: Physical Activity in the<br />
Elderly. 1999<br />
3. G. Miscio, F. Pisano: Spasticity: mechanisms, treatment<br />
and rehabilitation. 1999<br />
4. M. Buonocore, C. Bonezzi: Il dolore neurogeno: dalla<br />
definizione alla terapia. 1999<br />
5. A. Salvadeo: Insufficienza renale acuta. 1999<br />
6. P. Pinelli, R. Colombo, S. Onorato: Analisi dell’attenzione<br />
protratta nelle reazioni verbali. Sistema prefrontale<br />
e Processi riverberanti. Le reazioni dilazionate<br />
in Neuropsichiatria (with an English Outline). 1999<br />
7. N. Ambrosino, C.F. Donner, C. Rampulla: Topics in<br />
Pulmonary Rehabilitation. 1999<br />
8. A.M. Zotti, G. Bertolotti, P. Michielin, E. Sanavio, G. Vidotto:<br />
Linee guida per lo screening di tratti di personalità,<br />
cognizioni e comportamenti avversi alla salute.<br />
Manuale d’uso per il CBA Forma Hospital. 2000<br />
9. P. Capodaglio, M.V. Narici: The ageing motor system<br />
and its adaptations to training. 2000<br />
10. F. Rengo, R. O. Bonow, M. Gheorghiade: Heart Failure<br />
in the Elderly. Implication for Rehabilitation. 2000<br />
11. G. Megna, S. Calabrese: Riabilitazione neuromotoria<br />
2000. 2000<br />
12. P. Pinelli & Coll.: Freud in a Psychophysiological<br />
Framework or About Unconscious and Soul. 2001<br />
13. F. Rengo, R.O. Bonow, M. Gheorghiade: Chronic<br />
Heart Failure In The Elderly. The Evolution Of Chronic<br />
Heart Failure. 2002<br />
14. G. Bazzini: ll Day-Hospital Riabilitativo. 2003<br />
15. M. Buonocore, C. Bonezzi. Il dolore nelle neuropatie<br />
periferi-che post-traumatiche. 2003<br />
16. M. Barat, F. Franchignoni.<br />
Assessment in<br />
Physical Medicine and<br />
Rehabilitation. Views<br />
and Perspectives. 2004<br />
17. P. Giannuzzi, F. Rengo.<br />
Dall’Eccellenza all’Alta<br />
Specializzazione in<br />
Cardiologia Riabilitativa.<br />
2005<br />
5. “Advances in Occupational Medicine”<br />
“Aggiornamenti in Medicina Occupazionale”.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. L. Alessio, P.A. Bertazzi, A. Forni, G. Gallus, M. Imbriani:<br />
Il monitoraggio<br />
biologico dei lavoratori<br />
esposti a tossici<br />
industriali. Aggiornamenti<br />
e sviluppi. 2000<br />
2. L. Ambrosi, L. Soleo,<br />
S. Ghittori, L. Maestri,<br />
M. Imbriani: Mercapturic<br />
Acids as Biomarkers<br />
of Exposure<br />
to Industrial Chemicals.<br />
2000<br />
3. C. Meloni, M.T. Querciolli,<br />
S. Verdirosi, M.<br />
Imbriani: Aggiornamenti in Scienze Infermieristiche.<br />
2002<br />
6. “Symposia” “I Congressi della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>”.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. D. Cottica, F. Benvenuti, E. Grignani, M. Casciani, M.<br />
Imbriani: Il rischio microbiologico negli ambienti di<br />
lavoro: approccio, valutazione, interventi. Convegno<br />
AIDII - ISPESL, Centro Congressi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>. Pavia, 29 ottobre 1998. 1999<br />
2. L. Soleo, P. Apostoli, D. Cavallo, D. Cottica, G. Nano,<br />
L. Ambrosi: II Congresso Europeo di Igiene Industriale<br />
- I Congresso Mediterraneo di Igiene Industriale<br />
- Convegno AIDII, Centro Internazionale<br />
Congressi. Bari, 30 giugno - 3 luglio 1999. 2000<br />
3. M. Buonocore, C. Bonezzi: La gestione del paziente<br />
con dolore neuropatico: indicazioni diagnostiche e<br />
terapeutiche. II incontro sul dolore neurogeno.<br />
Pavia, 12 maggio 2000. 2000<br />
4. D. Cottica, G.B. Bartolucci, G. Nano, M. Imbriani: Atti<br />
18° Congresso Nazionale AIDII. Trento, 21-24 giugno<br />
2000. 2000<br />
5. C. Minoia, R. Turci, G.B. Bartolucci, S. Signorini, P.<br />
Apostoli: Progressi nella valutazione del rischio<br />
espositivo da chemioterapici antiblastici. Convegno<br />
Nazionale, Centro Congressi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>. Pavia, 14-15 ottobre 1999. 2000<br />
6. C. Bonezzi, M. Buonocore: Dolori radicolari e pseudoradicolari:<br />
indicazioni diagnostiche e terapeutiche.<br />
Centro Congressi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
Pavia, 4 maggio 2001. 2001<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 133<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
7. M. Buonocore, C. Bonezzi: Sindromi algodistrofiche:<br />
dall’inquadramento diagnostico al trattamento riabilitativo.<br />
Centro Congressi <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>. Pavia, 17 maggio 2002. 2002<br />
8. Simposio in occasione dell’80° compleanno del Prof.<br />
Paolo Pinelli: Funzioni<br />
nervose e processi<br />
mentali. Centro Congressi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>. Pavia,<br />
16 dicembre 2001. 2003<br />
9. A. Estraneo, L. Manzo,<br />
L. Santoro: Gestione e<br />
recupero del traumatizzato<br />
cranico. Sala<br />
Convegni dell’Ospedale<br />
G. Vietri - Larino<br />
(CB), 24-26 ottobre<br />
2002. 2003<br />
7. “I Manuali della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>”.<br />
Volumi pubblicati:<br />
1. L. Bianchi, S. Nava, E. Zampogna: Manuale dei Metodi<br />
e delle Procedure Fisioterapiche in Riabilitazione<br />
Respiratoria. 2002<br />
2. E. Banco, B. Cattani, G. Fugazza: I disturbi di deglutizione.<br />
Opuscolo informativo per pazienti e familiari. 2002<br />
3. M. Schmid, S. Compiano: Degenerazione maculare:<br />
nuove strategie. Informazioni utili a persone anziane<br />
con degenerazione maculare. 2002<br />
4. E. Zanotti, C. Bizzarri con la collaborazione di R.<br />
Grasso, L. Govoni, P. Mombaruzzo, M. Piran, L. Zocchi:<br />
Le malattie polmonari croniche ostruttive: conoscere,<br />
curare, convivere. Manuale pratico per il<br />
paziente. 2004<br />
5. <strong>Maugeri</strong> - Ricerca. I Laboratori di Ricerca della<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> IRCCS. 2005<br />
6. P. Pinelli, M. Gianesella: <strong>Introduzione</strong> alla NeuroPsicoCronometria<br />
di Veruno e Training della VOLONTÀ<br />
in Neuroriabilitazione. With an Outline of Prefrontal<br />
processes in normal and pathological conditions. 2006<br />
134<br />
7. P. Pinelli, A. Giordano,<br />
M. Gianesella, N. Maffini:<br />
Training della Working<br />
Memory. Processi<br />
binari e processi<br />
fuzzy nella logica e<br />
nel funzionamento cerebrale.<br />
2006<br />
8. G. Fizzotti, I. Giorgi, M.<br />
Manera, M. Marchioni,<br />
R. Mauri, A. Meneghini,<br />
O. Nervi, G. Olivieri,<br />
A. Saade, M. Secone -<br />
Presentazione di C. Pistarini:<br />
La mielolesione:<br />
conoscerla e viverla.<br />
2007<br />
9. G. Majani, A. Pierobon,<br />
A. Giardini, S. Callegari:<br />
Valutare e favorire<br />
l’aderenza alle prescrizioni<br />
in riabilitazione<br />
cardiologica e<br />
pneumologica. 2007<br />
10. P. Ceriana, I. Springhetti:<br />
La cannula tracheotomica.<br />
Istruzioni<br />
per l’uso. 2007<br />
11. P. Pinelli - con prefazione<br />
di G. Berlucchi:<br />
Training della Working<br />
Memory. Analisi<br />
dei fattori influenti su<br />
vari tipi di sequenze.<br />
2007<br />
12. P. Pinelli: Neurosequenze.<br />
L’Io, il suo<br />
ruolo, i suoi recuperi.<br />
2007<br />
13. A. Mezzani, F. Cacciatore,<br />
P. Giannuzzi.<br />
Manuale delle metodiche<br />
e delle procedure di Riabilitazione Fisica in<br />
Cardiologia. 2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Le Riviste della <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
“Giornale Italiano<br />
di Medicina<br />
del Lavoro<br />
ed Ergonomia”<br />
Rivista trimestrale<br />
di Prevenzione,<br />
Patologia, Ergonomia<br />
e Riabilitazione<br />
“Giornale Italiano<br />
di Medicina<br />
del Lavoro<br />
ed Ergonomia”<br />
Supplemento<br />
di Psicologia Applicata<br />
alla Medicina del Lavoro<br />
e della Riabilitazione<br />
“Monaldi<br />
Archives for<br />
Chest Disease”<br />
Pulmonary<br />
Medicine and<br />
Rehabilitation<br />
Series<br />
Rivista scientifica<br />
internazionale<br />
di Riabilitazione<br />
respiratoria<br />
“Monaldi<br />
Archives for<br />
Chest Disease”<br />
Cardiac<br />
Rehabilitation<br />
and Prevention<br />
Series<br />
Rivista scientifica<br />
internazionale<br />
di Cardiologia<br />
riabilitativa<br />
“I Manuali della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong>”<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 135<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA<br />
- MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Titolo: Strategie di intervento e prevenzione in<br />
popolazioni ad elevato rischio cardiovascolare -<br />
Progetto Malattie Neurodegenerative - Ex Art. 56<br />
Responsabile: Giannuzzi P.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2004<br />
Titolo: Rete per l’ottimizzazione della prevenzione<br />
e del trattamento delle complicanze<br />
cardiovascolari nell’obesità e nella sindrome<br />
metabolica<br />
Responsabile: Chiovato L.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Caratteristiche precliniche e modelli di<br />
trattamento non farmacologico dei disturbi<br />
cognitivi e motori della malattia di Parkinson<br />
Responsabile: Schieppati M.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Interventi nutrizionali nella SLA: studio<br />
di efficacia nell’uomo e in modelli animali<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Modelli di riabilitazione intensiva cardiorespiratoria<br />
di alta specializzazione: implementazione<br />
ed indicatori di risultato - Ex Art. 56<br />
Responsabile: Giannuzzi P.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Studio multicentrico randomizzato controllato<br />
sull’uso della ventilazione non invasiva<br />
nel trattamento dei pazienti con SLA ed<br />
altre patologie neuromuscolari in fase di insufficienza<br />
respiratoria acuta - Ex Art. 56<br />
Responsabile: Nava S.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Ruolo dei disturbi dell’umore nel condizionare<br />
gli outcomes riabilitativi nell’anziano<br />
fragile in riabilitazione intensiva neuromotoria<br />
e cardiologica - Ex Art. 56<br />
Responsabile: Trojano L.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
136<br />
Progetti di Ricerca Finalizzata<br />
Titolo: Tools per la riabilitazione: riabilitazione<br />
robotizzata e teleriabilitazione - Ex Art. 56<br />
Responsabile: Minuco G.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Progetto di formazione a distanza.<br />
“E-learning per la qualità della vita e la sicurezza<br />
nell’ambiente di lavoro”<br />
Responsabile: Mazzoleni M.C.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2005<br />
Titolo: Approccio socio-assistenziale alle problematiche<br />
del paziente oncologico anziano<br />
/ Progetto oncologico<br />
Responsabile: Strada M.R.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Qualità della vita e ICF in pazienti oncologici<br />
/ Progetto oncologico<br />
Responsabile: Majani G.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Sperimentazione di modelli innovativi di<br />
integrazione tra servizi sanitari e sociali basato<br />
su servizi di Telemedicina avanzati<br />
Responsabile: Giordano A.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Definizione di un modello di percorso<br />
riabilitativo multidisciplinare e costituzione di<br />
un osservatorio nazionale di riabilitazione oncologica<br />
- Progetto oncologico<br />
Responsabile: Springhetti I.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Riabilitazione cardiologica intensiva e<br />
continuità assistenziale nel paziente fragile<br />
dopo evento cardiovascolare - Ex Art. 12<br />
Responsabile: Cacciatore F.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Modificazioni della funzione sistolica e<br />
diastolica indotte da una corsa di durata<br />
(mezza maratona) e valutate con metodica<br />
ultrasonografica. Correlazione con biomarcatori<br />
di danno miocardio - Ricerca farmaci<br />
Responsabile: Traversi E.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Titolo: “Rete nazionale telepatologia (TESEO)”<br />
Integrazione delle attività di ricerca attraverso la<br />
costituzione di strutture e reti di collaborazione<br />
interistituzionale - Alleanza contro il cancro<br />
Responsabile: Scelsi M.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2006<br />
Titolo: Coordinamento degli interventi sanitari<br />
per le intossicazioni acute nell’ambito della<br />
gestione della scorta nazionale antidoti atta a<br />
fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria<br />
per la popolazione civile conseguenti ad atti<br />
di natura terroristica con impiego di armi non<br />
convenzionali<br />
Responsabile: Locatelli C.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
Titolo: Portale web e progettazione di corsi<br />
E-learning per informazione/formazione sul<br />
danno derivante dall’utilizzo di sostanze dopanti<br />
Responsabile: Traversi E.<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
Titolo: Genetic markers of susceptibility to<br />
sudden cardiac death in inherited arrhythmogenic<br />
diseases: from targeted SNP analysis to<br />
genome wide-screening<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Istituto di Pavia<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
Titolo: Multiple approaches for improving the<br />
diagnosis, assessment and treatment of patients<br />
affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis.<br />
A clinical and experimental study<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Istituto di Lissone<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
Titolo: Real exposure to xenobiotics in an Italian<br />
population group and risk characterization<br />
Responsabile: Minoia C.<br />
Istituto di Pavia<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
PROGETTI TELETHON<br />
Titolo: Characterization of a knock-in mouse<br />
model of genetically determined sudden cardiac<br />
death: insights for the management of<br />
patients with catecholaminergic polymorphic<br />
ventricular tachycardia (CPVT)<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Istituto di Pavia<br />
PROGETTI MIUR<br />
Titolo: Messa a punto di nuove metodologie<br />
per la teleriabilitazione neuromotoria<br />
Responsabile: Minuco G.<br />
Istituto di Pavia<br />
Titolo: Messa a punto topico innovativo per la<br />
prevenzione e la cura delle lesioni da decubito<br />
Responsabile: Imbriani M.<br />
Istituto di Pavia<br />
Titolo: Network scientifico e tecnologico per la<br />
realizzazione di farmaci innovativi basati sulla<br />
biologia dei recettori delle neurotrofine<br />
Responsabile: Imbriani M.<br />
Istituto di Pavia<br />
PROGETTI ISPESL<br />
Titolo: Sviluppo dei programmi e delle attività<br />
per la promozione della salute e la prevenzione<br />
nei luoghi di lavoro<br />
Responsabili: Signorini S., Imbriani M.<br />
Istituto di Pavia<br />
Titolo: Valutazione del rischio espositivo e<br />
degli effetti clinici ad agenti chimici (aldeidi)<br />
negli ambienti di vita<br />
Responsabile: Cottica D.<br />
Centro di Padova<br />
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ<br />
Titolo: Infant botulism<br />
Responsabile: Locatelli C.<br />
Istituto di Pavia<br />
Codice progetto/anno: Anno 2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 137<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
138<br />
Clinical Trials Prospettici, Ricerche Multicentriche,<br />
Attività di Prevenzione, Osservatori Epidemiologici<br />
Linea di Ricerca N. 1<br />
RISCHI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI<br />
DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
Tipo di attività: Attività di prevenzione<br />
Titolo: Identificazione dei fattori di rischio per<br />
le intossicazioni acute<br />
Ente organizzatore: IRCCS <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong><br />
<strong>Maugeri</strong>, Istituto di Pavia, Centro Nazionale di Informazione<br />
Tossicologica - Centro Antiveleni di Pavia<br />
Responsabile: Manzo L., Locatelli C.<br />
Tipo di attività: Attività di prevenzione<br />
Titolo: Emergenze tossicologiche e tossicovigilanza<br />
industriale in ambito petrolchimico<br />
Ente organizzatore: ENI Refining & Marketing<br />
Responsabile: Manzo L.<br />
Tipo di attività: Attività di prevenzione<br />
Titolo: Emergenze trasporti sul territorio nazionale<br />
Ente organizzatore: Servizio emergenza trasporti (protocollo<br />
d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
- Dipartimento Protezione Civile e Federchimica)<br />
Responsabile: Manzo L., Locatelli C.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Emergenze tossicologiche e tossicovigilanza<br />
industriale in ambito petrolchimico<br />
Ente organizzatore: ENI Refining & Marketing<br />
Responsabile: Manzo L.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Emergenza trasporti sul territorio nazionale<br />
Ente organizzatore: Servizio emergenza trasporti (protocollo<br />
d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
- Dipartimento Protezione Civile e Federchimica)<br />
Responsabile: Manzo L., Locatelli C.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Intossicazioni acute da pesticidi nell’uomo<br />
Ente organizzatore: Istituto Superiore di Sanità<br />
Responsabile: Locatelli C.<br />
Linea di Ricerca N. 2<br />
MEDICINA RIABILITATIVA NEUROMOTORIA<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: CLE-12911-021 - Studio osservazionale<br />
di coorte per valutare il profilo basale di<br />
donne in postmenopausa trattate per l’osteoporosi<br />
secondo l’attuale pratica medica e l’adesione<br />
al trattamento e la tollerabilità in<br />
donne trattate con ranelato di stronzio durante<br />
un follow up a lungo termine. Coordinatore:<br />
A.O. Università Careggi di Firenze<br />
Ente organizzatore: Institut de Recherches International<br />
Servier, IRIS, CRO MDS Fharma<br />
Responsabile: Saviola G., De Cicco D.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Efficacia e sicurezza del Neridronato intramuscolare<br />
nel trattamento dell’osteoporosi<br />
da steroidi in pz reumatologici<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Responsabile: Saviola G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Il controllo dell’equilibrio nei pazienti<br />
Parkinsoniani: la reazione allo spostamento<br />
continuo della base d’appoggio<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Pavia<br />
Responsabile: Schieppati M.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Ruolo dei disturbi dell’umore nel condizionare<br />
gli outcomes riabilitativi nell’anziano<br />
fragile in riabilitazione intensiva neuro-motoria<br />
e cardiologica<br />
Ente organizzatore: Ministero della Salute<br />
Responsabile: Trojano L.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Uno studio multicentrico, randomizzato,<br />
in doppio cieco, controllato con placebo, a<br />
gruppi paralleli per investigare l’efficacia e la<br />
sicurezza di ONO-2506PO rispetto al placebo<br />
in presenza di Riluzolo, in pz con diagnosi di<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) che hanno<br />
manifestato insorgenza di debolezza muscolare<br />
nei 14 mesi precedenti la randomizzazione<br />
Ente organizzatore: Ono Pharma, Pra International,<br />
Parexel<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Registro Regionale di Piemonte e Valle<br />
d’Aosta per la sclerosi laterale amiotrofica<br />
Ente organizzatore: Dipartimento Neuroscienze,<br />
Università di Torino<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Registro Regionale Lombardo per la<br />
sclerosi laterale amiotrofica<br />
Ente organizzatore: Istituto di Ricerche Farmacologiche<br />
Mario Negri<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Linea di Ricerca N. 3<br />
CARDIOANGIOLOGIA RIABILITATIVA<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Effetti emodinamici di un elettrostimolatore<br />
applicato sulla loggia anteriore della<br />
gamba per la prevenzione della trombosi venosa<br />
profonda; identificazione del tempo<br />
massimo tollerato<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Responsabile: Salerno M.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Italian Network on Heart Failure on line<br />
(IN-HF online cod. prot. K4) e Italian Network<br />
on Heart failure outcome (IN-HF outcome<br />
cod. Prot. K5)<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> Italiana per la Lotta<br />
alle Malattie Cardovascolari<br />
Responsabile: Giordano A., Febo O.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
doppio cieco, controllato con placebo per valutare<br />
la sicurezza e l’efficacia di SCH 530348<br />
in aggiunta allo standard di terapia in soggetti<br />
con anamnesi di patologia aterosclerotica:<br />
Antagonista del Recettore per la Trombina<br />
nella Prevenzione secondaria degli eventi<br />
ischemici aterotrombotici (Thrombin Receptor<br />
Antagonist - TRA 2°P - TIMI 50)<br />
Ente organizzatore: Schering Plough - Icon<br />
Responsabile: Giordano A., Morini R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: VALERIA - Valutazione degli effetti centrali<br />
e periferici del training aerobico nei pz<br />
con scompenso cardiaco cronico mediante<br />
analisi della cinetica-on del consumo d’ossigeno<br />
durante lo sforzo di intensità moderata<br />
Ente organizzatore: Studio spontaneo FSM<br />
Responsabile: Mezzani A.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A large scale clinical trial testing the effects<br />
of n. 3 PUFA and Rosuvastatin on mortality/morbidity<br />
of patients with symptomatic<br />
congestive heart failure (GISSI-HF)<br />
Ente organizzatore: Centro Studi ANMCO, Osp.<br />
Mario Negri Milano<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Effetto del candesartan cilexetil vs. terapia<br />
standard sui livelli sierici del peptide natriuretico<br />
cerebrale in pazienti con insufficienza<br />
cardiaca cronica con funzionalità sistolica<br />
ridotta e conservata (CANDHEART)<br />
Ente organizzatore: Farma Resa, Takeda Italia Farmaceutici<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio clinico sull’associazione n. 3<br />
PUFA e statina: effetti su infiammazione e su<br />
quadro lipidico<br />
Ente organizzatore: Istituto di Ricerche Farmacologiche<br />
Mario Negri Milano<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio in doppio cieco controllato verso<br />
placebo a bracci paralleli, per la valutazione<br />
dell’efficacia di dronedarone 400 mg BID<br />
nella prevenzione dell’ospedalizzazione per<br />
cause cardiovascolari o della morte per qualsiasi<br />
causa in pazienti con fibrillazione/flutter<br />
atriale (AF/AFL) ATHENA-EFC5555<br />
Ente organizzatore: Sanofi Aventis S.p.A.<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 139<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio internazionale,multicentrico, randomizzato,<br />
in doppio cieco, a due bracci, controllato<br />
versus placebo, a gruppi paralleli, con<br />
rimonabant 20 mg in singola somministrazione<br />
giornaliera nella prevenzione degli<br />
eventi cardiovascolari maggiori in pazienti<br />
con obesità addominale e fattori di rischio<br />
Ente organizzatore: Sanofi Aventis S.p.A.<br />
Responsabile: Perotti M.R.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato in<br />
doppio cieco, controllato con placebo, sull’uso<br />
del Valsartan, un antagonista dei recettori<br />
dell’angiotensina II, nella prevenzione<br />
delle recidive di fibrillazione atriale (GISSI-AF)<br />
Ente organizzatore: IRFMN, Gruppo GISSI<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
doppio cieco, verso placebo, per valutazione<br />
dell’efficacia e della sicurezza a lungo termine<br />
nella somministrazione orale Tolvaptan (OPC-<br />
41062) compresse nei soggetti ricoverati in<br />
ospedale con scompenso cardiaco congestizio<br />
in fase di peggioramento (EVEREST)<br />
Ente organizzatore: Parexel Internationl S.r.l.<br />
Responsabile: Opasich C.<br />
140<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio randomizzato, in doppio cieco,<br />
controllato verso placebo multicentrico per<br />
valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia<br />
darbepoetina alfa nel ridurre la mortalità e la<br />
morbidità dei pazienti affetti da insufficienza<br />
cardiaca con disfunzione sistolica del ventricolo<br />
sinistro e anemia. AMGEN<br />
Ente organizzatore: Amgen S.p.A., Quintiles S.p.A.<br />
Responsabile: Cobelli F.<br />
Linea di Ricerca N. 4<br />
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Influenza dei tratti ansioso e depressivo<br />
sul controllo dell’asma valutato “riferito” mediante<br />
il questionario “Asthma Control Test”<br />
Ente organizzatore: Università Studi di Milano,<br />
Studio Osservazionale<br />
Responsabile: Neri M.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio internazionale randomizzato in<br />
aperto volto a confrontare l’efficacia e il rapporto<br />
costo efficacia di Symbicort quale terapia<br />
di mantenimento e al bisogno (acronimo in inglese:<br />
SMART - Symbicort Maintenance And<br />
Releiver Therapy) nel trattamento dell’asma<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
persistente utilizzando un dosaggio di mantenimento<br />
pari a 1 o 2 inalazioni due volte al<br />
giorno di Symbicort 160/4.5 ug. EUROSMART<br />
Ente organizzatore: Hyperphar<br />
Responsabile: Moscato G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio prospettico, randomizzato e controllato<br />
eseguito in singolo cieco che coinvolge<br />
18 Centri di Pneumologia sparsi su tutto<br />
il territorio nazionale<br />
Ente organizzatore: A.O. Policlinico di Modena<br />
Responsabile: Spanevello A.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: TELEBPMET - Controllo pressorio e aderenza<br />
alla terapia nel pz iperteso con sindrome<br />
metabolica: studio basato sulla teletrasmissione<br />
interattiva dei valori di pressione<br />
arteriosa automisurati a domicilio e sulle determinanti<br />
psicologiche della compliance<br />
Ente organizzatore: Bracco<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Valutazione nei pazienti tracheostomizzati<br />
della flogosi bronchiale e dell’influenza<br />
della flora batterica attraverso lo studio del<br />
broncoaspirato e dell’esalato condensato<br />
Ente organizzatore: FSM Veruno<br />
Responsabile: Balbi B.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Sorveglianza prevalenza resistenze ai<br />
farmaci antitubercolari<br />
Ente organizzatore: Istituto Superiore Sanità/OMS<br />
Responsabile: Migliori G.B.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Sorveglianza risultati trattamento tubercolosi<br />
Ente organizzatore: Istituto Superiore Sanità/OMS<br />
Responsabile: Migliori G.B.<br />
Linea di Ricerca N. 5<br />
PATOLOGIE CRONICHE DISABILITANTI<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: 2005-005968-90 - STUDIO TORCH -<br />
Studio internazionale multicentrico randomiz-<br />
zato di fase III che valuta Erlotinib in I linea di<br />
terapia seguito da una II linea con Cisplatino<br />
+ Gemcitabina vs Cisplatino + Gemcitabina in<br />
I linea seguita da una II linea con Erlotinib nel<br />
tumore del polmone non a piccole cellule in<br />
stadio avanzato<br />
Ente organizzatore: Istituto Nazionale Tumori di Napoli,<br />
Roche<br />
Responsabile: Fregoni V.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: 2006-002768-24 Prot. 156-04-251 - A<br />
phase 3, multicentre, double-blind, placebocontrolled,<br />
parallel-arm trial to determine<br />
long-arm safety and efficacy of oral tolvaptan<br />
tablet regimens in adults subjects with autosomal<br />
dominant polycystic kidney disease.<br />
Coordinatore: Ospedali Riuniti di Bergamo<br />
Ente organizzatore: Otsuka Maryland Research Institute,<br />
CRO Parexel<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: 2006-004693-27 - A6181064 - Studio di<br />
fase III randomizzato con Docetaxel in associazione<br />
a Sunitinib versus Docetaxel nella<br />
prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma<br />
mammario in fase avanzata. Coordinatore:<br />
Istituto Nazionale per la ricerca sul<br />
cancro di Genova<br />
Ente organizzatore: Pfizer<br />
Responsabile: Bernardo G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: BEATRICE - Sperimentazione internazionale<br />
multicentrica in aperto a due bracci di<br />
Fase III trial su bevacizumab come adiuvante<br />
nel tumore mammario triplo negativo<br />
Ente organizzatore: F. Hoffmann, La Roche Ltd<br />
Responsabile: Pavesi L., Bernardo G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: BO 20652 - Uno studio osservazionale<br />
degli eventi cardiaci in pazienti con carcinoma<br />
mammario in fase precoce HER2 positivo<br />
trattato con Herceptin<br />
Ente organizzatore: Roche, Quintiles, Studio Osservazionale<br />
Responsabile: Pavesi L., Bernardo G.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 141<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Campioni di sangue prelevati da donne<br />
di coppie infertili al fine di convalidare i metodi<br />
bioanalitici per il monitoraggio della possibile<br />
immunogenicità di nuovi farmaci<br />
Ente organizzatore: Organon Italia, Akzo Nobel<br />
Responsabile: Nappi R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Effects of Ivabradine on cardiovascular<br />
events in patients with moderate to severe chronic<br />
heart failure and left ventricular systolic<br />
dysfunction. A three year randomised doubleblind<br />
placebo-controlled international multicentre<br />
study<br />
Ente organizzatore: Institut de Recherches Internationales<br />
Servier - Iris<br />
Responsabile: La Rovere M.T.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: EURAS - HRT - Studio europeo di sorveglianza<br />
attiva su donne che assumono HRT<br />
Ente organizzatore: Zeg Berlino, Studio Osservazionale<br />
Responsabile: Nappi R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: First Adiuvant Trial on all Aromatase<br />
Inhibitors In Early Breast Cancer. Studio di<br />
fase III di confronto tra Anastrazolo, Letrozolo<br />
ed Exemestane e tra strategia sequenziale (2<br />
anni di terapia con Tamoxifen seguiti da 3 anni<br />
di terapia con inibitori delle aromatasi) nel<br />
trattamento adiuvante del carcinoma mammario<br />
ormono-responsivo in pz in postmenopausa<br />
Ente organizzatore: Università Federico II di Napoli<br />
Responsabile: Bernardo G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Prevalenza di iperostosi scheletrica idiopatica<br />
diffusa in un gruppo di pazienti affetti<br />
da patologie cardiovascolari.<br />
Ente organizzatore: Wyeth Pharmaceuticals<br />
Responsabile: Pappone N.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: RT 65 AND OVER - Studio clinico randomizzato<br />
multicentrico di confronto tra chirurgia<br />
conservativa con o senza radioterapia<br />
142<br />
in pz con carcinoma mammario di età superiore<br />
a 65 anni<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Responsabile: Tinterri C.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Sicurezza ed efficacia del cerotto medicato<br />
di lidocaina 5% verso pregabalin, nel dolore<br />
da nevralgia posterpetica e polineuropatia<br />
diabetica<br />
Ente organizzatore: Prodotti Formenti, Hyperphar<br />
Responsabile: Casale R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: SPD490-301 - Studio in aperto, di fase<br />
IIIb, multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli,<br />
per la valutazione dell’efficacia e della<br />
sicurezza di tre schemi posologici di DYNEPO<br />
per via sottocutanea, in pz adulti con anemia<br />
associata a malattia renale cronica, in predialisi<br />
o che necessitino di dialisi peritoneale o di<br />
emodialisi<br />
Ente organizzatore: Icon, Shire Pharmaceutical<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: STUDIO ALTITUDE - Studio randomizzato,<br />
in doppio cieco, controllato verso placebo,<br />
a gruppi paralleli, per determinare se<br />
Aliskiren, aggiunto alla terapia convenzionale,<br />
in pazienti con diabete mellito di tipo 2 e a rischio<br />
elevato di eventi cardiovascolari e renali,<br />
può ridurre la morbilità e la mortalità cardiovascolare<br />
e renale<br />
Ente organizzatore: Novartis Farma, Opis<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: STUDIO ARANESP - Studio multicentrico,<br />
randomizzato, in doppio cieco, per valutare<br />
la somministrazione di Darbepoetina alfa<br />
una volta al mese (QM) de novo, per la correzione<br />
dell’anemia in soggetti affetti da insufficienza<br />
renale cronica non dializzati<br />
Ente organizzatore: Amgen<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio di fase III, multicentrico randomizzato,<br />
controllato da placebo per valutare<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
l’efficacia e la sicurezza del trattamento con<br />
Bevacizumab in combinazione con il regime<br />
chemioterapico in soggetti con tumore metastatico<br />
della mammella precedentemente<br />
trattato<br />
Ente organizzatore: Quintiles per Genentech<br />
Responsabile: Pavesi L.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio di fase III, randomizzato, in<br />
doppio cieco, controllato con placebo, sull’impiego<br />
di AST-120 nella prevenzione della<br />
progressione della insufficienza renale cronica<br />
(CKD) nei pazienti con CKD da moderata<br />
a grave<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Corporation<br />
e Kureha Corporation, Pharmanet<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio Europeo della durata di 24 settimane,<br />
randomizzato, doppio cieco, controllato<br />
verso placebo, per valutare la sicurezza e<br />
l’efficacia di Flibanserina 50 mg al giorno e<br />
100 mg al giorno in donne in premenopausa<br />
affette da disturbo da desiderio sessuale<br />
ipoattivo<br />
Ente organizzatore: Boehringer Ingelheim<br />
Responsabile: Nappi R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio in aperto con Bevacizumab (Avastin)<br />
in combinazione con un regime chemioterapico<br />
contenente platino per il trattamento<br />
di prima linea in pazienti con carcinoma polmonare<br />
non a piccole cellule (NSCLC) ad<br />
istotipo non squamoso, in stadio avanzato o in<br />
ricaduta<br />
Ente organizzatore: Roche, Opis<br />
Responsabile: Bernardo G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: STUDIO MAGNOLIA - Studio europeo a<br />
28 settimane, in aperto, per valutare la sicurezza<br />
di Flibanserina da 50 mg al giorno a 100<br />
mg al giorno in donne in premenopausa affette<br />
da disturbi del desiderio sessuale ipoattivo<br />
Ente organizzatore: Boehringer Ingelheim, Opis<br />
Responsabile: Nappi R.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multcentrico - Disturbi del sonno<br />
in menopausa<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Responsabile: Russo G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico di fase III, condotto<br />
in aperto a dosi flessibili finalizzato a valutare<br />
la sicurezza a lungo termine di MCI-196 nei<br />
pz in dialisi per malattia renale cronica allo<br />
stadio V con iperfosfatemia concomitante (incorpora<br />
un confronto con sevelamer)<br />
Ente organizzatore: Azienda Ospedaliera di Lecco<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico di proseguimento<br />
in aperto per valutare la sicurezza e l’efficacia<br />
di Lacosamide in soggetti con neuropatia diabetica<br />
dolorosa distale, con sottostudio satellite<br />
in doppio cieco, randomizzato per valutare<br />
il time point del ritiro dallo studio<br />
Ente organizzatore: Schwarz Pharma<br />
Responsabile: Bonezzi C.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico randomizzato, in<br />
doppio cieco, di fase III, finalizzato a confrontare<br />
la sospensione di MCI-196 rispetto al<br />
placebo nei soggetti in dialisi per malattia renale<br />
cronica allo stadio V con iperfosfatemia<br />
concomitante (incorora un periodo di titolazione<br />
della dose di 12 settimane, in aperto,<br />
randomizzato a MCI-196 o Sevelamer)<br />
Ente organizzatore: Azienda Ospedaliera di Lecco<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico, in aperto, di fase<br />
IV, sulla sicurezza e l’efficacia a lungo termine<br />
di Dynepo somministrato per via sottocutanea<br />
in pazienti adulti con anemia associata a malattia<br />
renale<br />
Ente organizzatore: Shire Pharmaceutical Ltd<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 143<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
doppio cieco, controllato verso placebo e<br />
verso farmaco attivo, a gruppi paralleli, di definizione<br />
della dose, per valutare l’efficacia e<br />
la sicurezza di LCZ696 in confronto a Valsartan<br />
e di AHU377 in confronto a placebo,<br />
dopo 8 settimane di trattamento, in pazienti<br />
con ipertensione arteriosa essenziale<br />
Ente organizzatore: Novartis Farma, Opis<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
doppio cieco, di fase IIb, per valutare l’efficacia<br />
e la tollerabilità di Sorafenib rispetto a<br />
placebo quando somministrato con chemioterapia<br />
e/o ormonoterapia in pazienti con carcinoma<br />
mammario localmente recidivato o<br />
metastatico<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> Michelangelo<br />
Responsabile: Pavesi L.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
doppio cieco, verso placebo, di fase III, mirato<br />
a confrontare il trattamento con MCI-196 in<br />
più dosi fisse rispetto a placebo nei soggetti<br />
in dialisi per malattia renale cronica allo<br />
stadio V con iperfosforemia e dislipidemia<br />
concomitanti (incorpora due gruppi paralleli<br />
ad alto dosaggio)<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Corporation,<br />
i3Research<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio osservazionale - Poor or good<br />
functional and health outcomes in rheumatoid<br />
and psoriatic arthritis treated with etanercept:<br />
role of comorbidity<br />
Ente organizzatore: Wyeth Lederle<br />
Responsabile: Lubrano di Scorpaniello E.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio osservazionale sulla terapia medica<br />
adiuvante in pazienti anziane operate per<br />
carcinoma della mammella<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> Michelangelo,<br />
Studio Osservazionale<br />
Responsabile: Pavesi L.<br />
144<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio osservazionale UPGRADE -<br />
Studio multicentrico, in aperto, non randomizzato,<br />
non interventistico, osservazionale sulla<br />
sicurezza in soggetti che utilizzano Insulina<br />
Aspart o Insulina Solubile Umana per il trattamento<br />
del diabete mellito<br />
Ente organizzatore: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.A.<br />
Responsabile: De Cata P.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio randomizzato di fase III, in<br />
doppio cieco, per gruppi paralleli, controllato<br />
mediante placebo, per valutare la dose flessibile<br />
di MCI-196 in combinazione con un legante<br />
del fosfato a base di calcio nei pazienti<br />
affetti da insufficienza renale cronica in stadio<br />
V, con iperfosfatemia, sottoposti a dialisi<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Europe<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio randomizzato per valutare la durata<br />
del trattamento con il regime Folfox-4 (3<br />
verso 6 mesi) ± Bevacizumab come terapia<br />
adiuvante per pazienti con tumore del colon<br />
stadio II ad alto rischio /III<br />
Ente organizzatore: <strong>Fondazione</strong> Giscad<br />
Responsabile: Zambelli A.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio randomizzato, in doppio cieco,<br />
controllato verso placebo e farmaco attivo a<br />
bracci paralleli, di fase III, con aggiustamento<br />
controllato della dose, per valutare l’efficacia<br />
e la sicurezza di CG5503 a rilascio prolungato<br />
(RP) in pz con dolore cronico da moderato a<br />
severo da osteoartrosi al ginocchio<br />
Ente organizzatore: Prodotti Formenti, GB Pharma<br />
Service & Consulting<br />
Responsabile: Miotti D.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio randomizzato, multicentrico, in<br />
aperto, di fase III con Lapatinib, Trastuzumab,<br />
la loro sequenza e la loro combinazione in<br />
adiuvante, in pazienti con carcinoma mammario<br />
primario HER2/Erb2 positivo<br />
Ente organizzatore: Glaxo, Opis<br />
Responsabile: Pavesi L.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: STUDIO RIMON_R_00961_PRADO -<br />
Studio Pan Europeo randomizzato, a gruppiparalleli,<br />
a due bracci controllato con placebo,<br />
in doppio cieco, multicentrico con Rimonabant<br />
20 mg una volta al giorno nel trattamento<br />
dei pazienti con obesità addominale con alterata<br />
glicemia a digiuno con o senza altre comorbidità<br />
Ente organizzatore: Sanofi Aventis<br />
Responsabile: Masnaghetti S.<br />
Tipo di attività: Clinical trial prospettico<br />
Titolo: Studio sulla sicurezza, tollerabilità ed<br />
immunogenicità del Vaccino Ricombinante<br />
Anti Epatite B ottenuto mediante una procedura<br />
modificata in pz in predialisi renale e<br />
dialisi<br />
Ente organizzatore: Merck & Co, Icon<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: A Prospective, Immunogenicity Surveillance<br />
Registry (PRIMS) to Estimate the Incidence<br />
of Erythropoietin Antibody-Mediated<br />
Pure Red Cell Aplesia Among Subjects With<br />
Chronic Renal Failure and Subcutaneous Exposure<br />
to Recombinant Erythropoieetin Products”<br />
Protocol Number: EPO-ANE-4014<br />
Ente organizzatore: Ortho-Biotech<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Osservatorio epidemiologico<br />
Titolo: Studio di indicatori di risultato multipli<br />
SIR-SIN (epidemiologia dell’insufficienza renale<br />
cronica in Italia) - Protocollo DB 02 03<br />
(Versione finale del 19 febbraio 2004)<br />
Ente organizzatore: Società Italiana di Nefrologia<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A Multicenter, Double blind, Placebo<br />
Controlled, Parallel-arm Study to Determine<br />
the Long term Safety and Efficacy of an Oral<br />
Drug Regimen in Subjects with Autosomal<br />
Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)<br />
Ente organizzatore: Outsuka<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A Multicenter, Randomized, Double-<br />
Blind Study Evaluating De Novo Once Monthly<br />
Darbepoetin Alpha Dosing for the Correction<br />
of Anemia in Subjects with Chronic Kidney Disease<br />
Not Receiving Dialysis - Studio<br />
20060163 - Codice Eudract 2006-003173-27<br />
Ente organizzatore: Amgen S.p.A.<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A phase III, Double-blind, Multicentre,<br />
Randdomized, Parallel Group design, Placebo<br />
controlled, flexibile dose study of MCI-196 in<br />
combination with a calcium-based Phosphate<br />
binder inChronic Kidney Disease stage V<br />
subjects on dialysis with Hyperphosphataemia<br />
- Clinical study MCI-196-E09 - Cod<br />
Eudract 2006-003324-11<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Europe<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A phase III, Multi-centre, Double-blind,<br />
Randdomized, Placebo controlled, Multiple<br />
Fixed dose study of MCI-196 versus Placebo<br />
in Chronic Kidney Disease stage V subjects<br />
on dialysis with Hyperphosphataemia and Dyslipidemia<br />
(incorporating two parallel High<br />
Dose Groups) - Clinical study MCI-196-E08 -<br />
Cod Eudract 2006-006535-53<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Europe<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: A Study in renal predialysis and dialysis Patients<br />
of the Safety, Tolerability and Immunogenicity<br />
of Recombinant Hepatitis B Vaccine Manufactured<br />
with a Modified Procedd - Protocol<br />
V 232, 060-01 - Cod Eudract 2006-003650-20<br />
Ente organizzatore: Merck<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: An open-label, multi-center study to document<br />
the efficacy, safety and tolerability of<br />
long-term administration of Ro0503821 in patients<br />
with chronic renal anemia - Secondo il<br />
protocollo BH18387<br />
Ente organizzatore: Roche S.p.A.<br />
Responsabile: Villa G.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 145<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Controllo pressorio e aderenza alla terapia<br />
nel paziente iperteso con sindrome metabolica:<br />
studio basato sulla teletrasmissione<br />
interattiva dei valori di pressione arteriosa automisurati<br />
a domicilio e sulle determinanti<br />
psicologiche della compliance<br />
Ente organizzatore: Bracco<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Efficacy and safety of Olmesartan in elderly<br />
patients with mild to moderate hypertension<br />
- Eudract n° 2004 - 001616 - 31<br />
Ente organizzatore: Laboratori Guidotti S.p.A.<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio multicentrico di fase III, condotto in<br />
aperto a dosi flessibili, finalizzato a valutare la sicurezza<br />
a lungo termine di MCI - 196 nei pazienti<br />
in dialisi per malattia renale cronica allo stadio V<br />
con iperfosforemia concomitante (incorpora<br />
un confronto con Sevelamer) MCI - 196 - 10<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Europe<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, di<br />
fase III, finalizzato a confrontare la sospensione<br />
MCI - 196 rispetto al placebo nei soggetti<br />
in dialisi per malattia renale cronica allo<br />
stadio V con iperfosfatemia concomitante (incorpora<br />
un periodo di titolazione della dose di<br />
12 settimane, in aperto, randomizzato a MCI<br />
196 e Sevelamer) Studio MCI - 196-07<br />
Ente organizzatore: Mitsubishi Pharma Europe<br />
Responsabile: Villa G.<br />
146<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio multicentrico, randomizzato, in<br />
doppio cieco, per valutare la sicurezza e la<br />
tollerabilità di Vildagliptin (50 mg od o 100 mg<br />
od), in confronto a placebo, dopo 24 settimane<br />
di trattamento in pazienti con diabete<br />
mellito di tipo 2 e insufficienza renale moderata<br />
- Protocollo CLAF237A23137 - Codice<br />
Eudract 2007-003723-21<br />
Ente organizzatore: Novartis<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: Studio randomizzato, in aperto, multicentrico,<br />
a gruppi paralleli per dimostrare l’efficacia<br />
di RO0503821 somministrato sottocute<br />
una volta al mese, in pazienti con malattia<br />
renale cronica non ancora in dialisi -<br />
Protocollo NH20052 - Eudract N° 2006 -<br />
001434 - 41<br />
Ente organizzatore: Roche S.p.A.<br />
Responsabile: Villa G.<br />
Tipo di attività: Ricerca multicentrica<br />
Titolo: The purpose of the study is to evaluate<br />
the efficacy (blood pressure lowering effect)<br />
and safety of aliskiren when administered<br />
alone and in combination with amlodipine in<br />
patients with essential hypertension (mean<br />
office sitting diastolic blood pressure<br />
[msDBP] > 95 mmHg and < 110 mmHg). This<br />
study is being conducted to support registration<br />
of the fixed dose combination of aliskiren<br />
and amlodipine for the treatment of hypertension.<br />
Ente organizzatore: Novartis<br />
Responsabile: Villa G.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Redazione e Pubblicazione di Linee Guida e Protocolli Diagnostici<br />
e Terapeutici a Livello Internazionale e Nazionale<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Task Force on occupational rhinitis<br />
Ente organizzatore: European Academy of Allergy<br />
and Clinical Immunology (EAACI)<br />
Responsabile: Moscato G.<br />
Linea di ricerca: Rischi occupazionali e ambientali<br />
da attività produttive<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Valutazione, prevenzione e correzione<br />
degli effetti nocivi dello stress da lavoro<br />
Ente organizzatore: Consorzio per l’Accreditamento<br />
in Medicina del Lavoro<br />
Responsabile: Ambrosi L., Imbriani M.<br />
Linea di ricerca: Rischi occupazionali e ambientali<br />
da attività produttive<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Linee guida per la sorveglianza sanitaria<br />
degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni<br />
in ambienti di lavoro<br />
Ente organizzatore: Consorzio per l’Accreditamento<br />
in Medicina del Lavoro<br />
Responsabile: Ambrosi L., Imbriani M.<br />
Linea di ricerca: Rischi occupazionali e ambientali<br />
da attività produttive<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Programma Nazionale per le Linee<br />
Guida. Linea Guida. Prevenzione delle cadute<br />
da incidente domestico negli anziani. Ministero<br />
della Salute, Istituto Superiore di Sanità,<br />
Roma. Documento 13 maggio 2007<br />
Ente organizzatore: Programma Nazionale per le<br />
Linee Guida, Ministero della Salute, Istituto Superiore<br />
di Sanità<br />
Responsabile: Locatelli C., Petrolini V.<br />
Linea di ricerca: Rischi occupazionali e ambientali<br />
da attività produttive<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Linee guida per la diagnosi e il trattamento<br />
della sclerosi laterale amiotrofica<br />
Ente organizzatore: Ministero della Salute<br />
Responsabile: Mora G.<br />
Linea di ricerca: Medicina Riabilitativa Neuromotoria<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the<br />
management of patients with atrial fibrillation-executive<br />
summary<br />
Ente organizzatore: European Society of Cardiology<br />
American Heart Association and American college<br />
of cardiology<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Diagnostica aritmologia non invasiva<br />
Ente organizzatore: Associazione Italiana Aritmologia<br />
e Cardiostimolazione<br />
Responsabile: Pedretti R.F.E. (coordinatore)<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: European guidelines on cardiovascular<br />
disease prevention in clinical practice: executive<br />
summary<br />
Ente organizzatore: European Society of Cardiology<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: European guidelines on cardiovascular<br />
disease prevention in clinical practice: full<br />
text. Fourth Joint Task Force of the European<br />
Society of Cardiology and other societies on<br />
cardiovascular disease prevention in clinical<br />
practice<br />
Ente organizzatore: European Society of Cardiology<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Guidelines on diabetes, pre-diabetes,<br />
and cardiovascular diseases: executive summary.<br />
The Task Force on Diabetes and Cardiovascular<br />
Diseases of the European Society of<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 147<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Cardiology (ESC) and of the European Association<br />
for the Study of Diabetes (EASD)<br />
Ente organizzatore: European Society of Cardiology<br />
American Heart Association and American college<br />
of cardiology<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Official document on cardiopulmonary<br />
exercise testing in chronic heart failure due to<br />
left ventricular dysfunction-recommendations<br />
for performance and interpretation<br />
Ente organizzatore: Italian Working Group on Cardiac<br />
Rehabilitation and Prevention (Gruppo Italiano<br />
di Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione,<br />
GICR), endorsed by Working Group on Cardiac<br />
Rehabilitation and Exercise Physiology of the European<br />
Society of Cardiology<br />
Responsabile: Corrà U.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Struttura e organizzazione funzionale<br />
della aritmologia<br />
Ente organizzatore: Federazione Italiana di Cardiologia<br />
Responsabile: Pedretti R.F.E.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
148<br />
F S M Centro Studi<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Universal definition of myocardial infarction<br />
Ente organizzatore: European Society of Cardiology<br />
and American Heart Association<br />
Responsabile: Priori S.G.<br />
Linea di ricerca: Cardioangiologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Allergic rhinitis and its impact on asthma<br />
Ente organizzatore: ARIA<br />
Responsabile: Moscato G.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Prevenzione ambientale dei fattori di rischio<br />
indoor per allergia e asma. Programma<br />
specifico di prevenzione nelle scuole<br />
Ente organizzatore: Ministero della Salute, Direzione<br />
Generale della Prevenzione Sanitaria<br />
Responsabile: Moscato G.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Internationals standards for tuberculosis<br />
care<br />
Ente organizzatore: OMS, Stop TB partnership,<br />
American Thoracic Society<br />
Responsabile: Migliori G.B.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia riabilitativa<br />
GIORNALE ITALIANO DI<br />
MEDICINA DEL LAVORO<br />
ED ERGONOMIA<br />
ON-LINE<br />
Rivista di Medicina del Lavoro (Medicina occupazionale,<br />
Igiene del lavoro e ambientale, Tossicologia occupazionale) ed<br />
Ergonomia (Valutazione del rapporto uomo/lavoro, Riabilitazione<br />
occupazionale, Psicologia del lavoro, Bioingegneria).<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Progetti Mondiali ASMA, BPCO e Rinite<br />
- Aggiornamento 2007 delle Linee Guida<br />
LIBRA<br />
Ente organizzatore: Università degli Studi di Modena<br />
e Reggio Emilia, Policlinico di Modena, Clinica<br />
di Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
Responsabile: Neri M.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia Riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Revisione delle Linee Guida per la refertazione<br />
della polisonnografia<br />
Ente organizzatore: AIMS<br />
Responsabile: Braghiroli A.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia Riabilitativa<br />
Tipo di attività: Protocollo diagnostico<br />
Titolo: Reference Values of Inflammatory Biomarkers<br />
in Bronchoalveolar Lavage, induced<br />
Sputum and Exhaled Air in adult subjects<br />
Ente organizzatore: European Respiratory Society<br />
Responsabile: Balbi B.<br />
Linea di ricerca: Pneumologia Riabilitativa<br />
Tipo di attività: Linea guida<br />
Titolo: Linee Guida 2007 su Rinite, Asma e<br />
BPCO - Progetti Mondiali Aria, Gina e GOLD/ATS/<br />
ERS<br />
Ente organizzatore: Università degli Studi di Modena<br />
e Reggio Emilia<br />
Responsabile: Spanevello A.<br />
Linea di ricerca: Patologie croniche disabilitanti<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 149<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
150<br />
Convenzioni e Collaborazioni della <strong>Fondazione</strong><br />
con l’Università<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Allergologia e Immunologia<br />
Clinica<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Geriatria<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie<br />
del Ricambio<br />
per la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Gastroenterologia e Endoscopia<br />
Digestiva<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina dello Sport<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Oncologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Interna<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Otorinolaringoiatria (Pavia e<br />
Montescano)<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Tossicologia Medica<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Patologia Clinica<br />
per utilizzo strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia<br />
per utilizzo strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
Nefrologia<br />
per utilizzo strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
Psicologia del Ciclo di Vita<br />
per utilizzo strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Medicina<br />
Legale<br />
per l’attività scientifica e assistenziale dell’Istituto<br />
di Medicina del Lavoro, ora Sezioni I e II di<br />
Medicina del Lavoro del Dipartimento di Medicina<br />
Preventiva, Occupazionale e di Comunità<br />
per l’attività scientifica del Centro Ricerche di<br />
Fisiopatologia e Sicurezza del Lavoro<br />
per il Centro Studi e Ricerche sulla Oncologia<br />
Professionale<br />
per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia<br />
Plastica e Ricostruttiva<br />
per lo svolgimento delle attività di laboratorio e<br />
di tirocinio per il corso del Diploma universitario<br />
in Ingegneria Biomedica attivato presso la Facoltà<br />
di Ingegneria<br />
Corso di Laurea in Scienze Motorie<br />
per la sorveglianza sanitaria sul personale dell’Università<br />
ai sensi del D. Lgs. 626/94 e 242/96<br />
per lo svolgimento del tirocinio pratico post lauream<br />
per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione<br />
all’esercizio della professione di psicologo<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
per utilizzo di strutture extra universitarie ai fini<br />
didattici integrativi della Scuola di Specializzazione<br />
in Microbiologia e Virologia<br />
per la realizzazione di un Polo Scientifico-Didattico<br />
operante nelle aree delle Scienze del<br />
Movimento della Bioingegneria e dell’Informatica<br />
Medica<br />
per una collaborazione scientifica del Laboratorio<br />
di Misure Ambientali e Tossicologiche<br />
per una collaborazione scientifica con il Dipartimento<br />
di Chimica Generale<br />
Convenzione con il C.U.S. dell’Università degli<br />
Studi di Pavia e il Centro Interdisciplinare di Biologia<br />
e Medicina dello Sport.<br />
Convenzione con il Centro Interuniversitario di<br />
Ricerche Ambientali e in Medicina del Lavoro per<br />
lo svolgimento di ricerca scientifica biomedica nel<br />
campo della Medicina Ambientale e della Medicina<br />
Occupazionale.<br />
Con l’Università Cattolica S. Cuore di Milano<br />
tirocinio presso l’U.O. di Igiene Ambientale e<br />
Tossicologia Industriale di Pavia di laureandi in<br />
Scienze dell’Educazione<br />
tirocinio pratico post-lauream per ammissione<br />
esame di stato per abilitazione alla professione<br />
di psicologo<br />
Con l’Università degli Studi di Milano<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera<br />
per l’utilizzo di strutture extra-universitarie ai<br />
fini didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Fisica Sanitaria<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini<br />
del tirocinio applicativo di I livello in Fisioterapia<br />
e Riabilitazione Respiratoria<br />
per l’attivazione di un tirocinio formativo presso<br />
il Centro Antiveleni<br />
per lo svolgimento di attività di ricerca di Neuropsicologia<br />
Clinica e Sperimentale con il Dipartimento<br />
di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria<br />
Con il Politecnico di Milano<br />
Convenzione con il Politecnico di Milano per attività<br />
di Tirocinio di studenti, laureati e/o diplomati<br />
Con l’Università degli Studi di Pisa<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per l’utilizzo di strutture sanitarie da parte della<br />
Facoltà di Psicologia per tirocinio di esperienze<br />
pratiche guidate<br />
Dipartimento di Neuroscienze e la <strong>Fondazione</strong><br />
Giovanni e Ottavia Ferrero D’Alba ONLUS per<br />
una collaborazione scientifica nell’ambito delle<br />
attività di ricerca in Neuroscienze<br />
Con l’Universitè de Bourgogne - Groupe d’Analyse<br />
du Mouvement<br />
per una cooperazione scientifica con lo C.S.A.M.<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASSANO MURGE<br />
Con l’Università degli Studi di Bari<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Cardiologia<br />
per la Scuola diretta a fini speciali per Terapisti<br />
della Riabilitazione<br />
per il Servizio di Epidemiologia e Statistica Medica<br />
per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche<br />
per l’attivazione del Tirocinio pratico valutativo<br />
di Medicina e Chirurgia, per l’abilitazione all’esercizio<br />
professionale<br />
per il Corso di Laurea nella professione di Fisioterapista<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 151<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Con l’Università degli Studi di Urbino<br />
per Tirocinio di formazione ed orientamento per<br />
l’abilitazione all’esercizio della professione di<br />
Psicologo<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per la Scuola di Specializzazione in Psicologia<br />
per attività di tirocinio ed attività di esperienze<br />
pratico-guidate<br />
Con l’Università degli Studi di Palermo<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi ai fini della costruzione della<br />
rete formativa della Scuola di Specializzazione<br />
in Geriatria<br />
Con l’Università degli Studi di Catania<br />
per lo svolgimento del tirocinio per la formazione<br />
degli specializzandi della Scuola di Specializzazione<br />
in malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CAMPOLI-TELESE<br />
Con l’Università degli Studi di Salerno<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera<br />
Con la II Università degli Studi di Napoli<br />
per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione<br />
per la formazione medica specialistica<br />
della Scuola di Reumatologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Geriatria<br />
152<br />
Con l’Università degli Studi di Napoli Federico II<br />
per l’attuazione del protocollo d’intesa ex art. 6<br />
D. Lgs 502/92 e successive modificazioni relativa<br />
alla Scuola di Specializzazione in Geriatria<br />
per l’attuazione del protocollo d’intesa ex art. 6<br />
D. Lgs 502/92 e successive modificazioni relativa<br />
alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia<br />
per l’attuazione del protocollo d’intesa ex art. 6<br />
D. Lgs 502/92 e successive modificazioni relativa<br />
alla Scuola di Specializzazione in Neurologia<br />
per l’attuazione del protocollo d’intesa ex art. 6<br />
D. Lgs 502/92 e successive modificazioni relativa<br />
alla Scuola di Specializzazione in Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione<br />
per collaborazione scientifica con il Dipartimento<br />
di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari<br />
ed Immunologiche<br />
per la frequenza degli Specializzandi della<br />
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica<br />
Con l’Università degli Studi del Molise<br />
per attività di un tirocinio di formazione ed<br />
orientamento<br />
Con l’Università degli Studi di Perugia<br />
per lo svolgimento di un tirocinio di formazione<br />
e orientamento - Facoltà di Scienze della Formazione<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI MONTESCANO<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Allergologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Cardiologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina del Lavoro<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Otorinolaringoiatria<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione di Gastroenterologia ed Endoscopia<br />
Digestiva<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Psicologia del Ciclo della Vita<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina dello Sport<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Geriatria<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie<br />
del Ricambio<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Radiodiagnostica<br />
per lo svolgimento di tirocinio per il Corso di<br />
Laurea in Scienze Motorie - Educazione Fisica<br />
e Tecnica Sportiva - Educazione Motoria Preventiva<br />
ed Adattata<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio<br />
per lo svolgimento dell’attività di tirocinio didattico<br />
e di tirocinio orientativo per il Corso di<br />
Laurea in Scienze Motorie, Educazione Fisica e<br />
Tecniche Sportive, Educazione Motoria Preventiva<br />
e Adattata<br />
per collaborazione con il Dipartimento di Psicologia<br />
della Facoltà di Lettere e Filosofia nel<br />
campo dell’attività scientifica<br />
Con l’Università degli Studi di Padova<br />
per collaborazione scientifica e didattica di Psicologia<br />
didattica nel campo della riabilitazione<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per Scuola di Specializzazione in Psicologia per<br />
attività di tirocinio ed attività di esperienze pratico-guidate<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI VERUNO<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per l’utilizzo di strutture sanitarie da parte della<br />
Scuola di Specializzazione in Cardiologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
per l’attività didattica della Facoltà di Medicina<br />
e Chirurgia<br />
per il Corso di Laurea in Psicologia<br />
per la Scuola Universitaria di Psicologia Applicata<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina del Lavoro<br />
per attività di ricerca sullo scompenso respiratorio<br />
acuto del paziente con bronco-pneumopatia<br />
cronico-ostruttiva (Dipartimento di Discipline<br />
Medico Chirurgiche - Sezione di Anestesia<br />
e Rianimazione)<br />
per una collaborazione scientifica nell’ambito<br />
delle attività di ricerca in Neuroscienze<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Terapia Fisica e Riabilitazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione<br />
per regolamentazione dei rapporti intercorrenti<br />
per il funzionamento dell’Istituto di Medicina<br />
del Lavoro<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 153<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Convenzione quadro per lo sviluppo di attività<br />
di ricerca in Bioingegneria per la Riabilitazione.<br />
Con l’Università degli Studi del Piemonte<br />
Orientale “A. Avogadro”<br />
per l’utilizzo delle strutture sanitarie da parte<br />
della Scuola di Specializzazione in Ginecologia<br />
e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
- a.a. 2005/2006<br />
per l’attivazione ed il funzionamento di un Servizio<br />
di Neuroriabilitazione e Disordini del Movimento<br />
per attività di ricerca su Fisiopatologia e trattamento<br />
della sindrome delle apnee ostruttive del<br />
sonno<br />
per lo svolgimento del tirocinio di formazione e<br />
orientamento degli studenti del Corso Interfacoltà<br />
di Biotecnologie<br />
per la frequenza al tirocinio degli studenti<br />
iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia della<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
per lo svolgimento del tirocinio di formazione e<br />
orientamento degli studenti del Corso di Laurea<br />
in Servizio Sociale, Corso di Laurea Interfacoltà<br />
in Educazione Professionale e Corso di Laurea<br />
specialistica in Programmazione e Direzione<br />
delle Politiche e dei Servizi Sociali<br />
per lo svolgimento del tirocinio di studenti del<br />
Corso di Laurea Infermieristica - a.a. 2006/2007<br />
Con l’Università degli Studi di Milano Bicocca<br />
per lo svolgimento di un tirocinio Post-Laurea /<br />
Facoltà di Psicologia (Settore della Rieducazione<br />
del Linguaggio)<br />
per lo svolgimento di un tirocinio per gli studenti<br />
dei Corsi di Laurea e Post Laurea-Master<br />
in Statistica Sanitaria<br />
per la formazione degli studenti del Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia<br />
Con l’Università degli Studi di Genova<br />
per una collaborazione nel campo della Ingegneria<br />
della Riabilitazione<br />
154<br />
per una collaborazione nel campo dell’attività<br />
scientifica e dell’assistenza per i soggetti affetti<br />
da patologie Neurologiche<br />
Con l’Università degli Studi dell’Insubria<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
per lo svolgimento di tirocinio di formazione e di<br />
orientamento degli studenti del Corso di Laurea<br />
in Infermieristica<br />
CASA DI CURA MAJOR DI TORINO<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per collaborazione didattica con la Facoltà di<br />
Psicologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in per la Scuola di Specializzazione<br />
di Neurologia<br />
per l’utilizzo di Strutture sanitarie da parte della<br />
Scuola di Specializzazione in Cardiologia<br />
per l’utilizzo di Strutture sanitarie da parte della<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e<br />
Riabilitazione<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TRADATE<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Cardiologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
(Facoltà di Medicina)<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Statistica Sanitaria (Facoltà<br />
di Medicina)<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
(Facoltà di Medicina)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Radiodiagnostica (Facoltà di Medicina)<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi della Scuola di Specializzazione<br />
in Allergologia ed Immunologia Clinica<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi della Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi Scuola di Specializzazione<br />
Medicina Interna<br />
Con l’Università degli Studi dell’Insubria<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Interna (Facoltà di<br />
Medicina)<br />
per utilizzo strutture extrauniversitarie a fini didattici<br />
integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia<br />
per il Corso di Diploma Universitario per Terapisti<br />
della Riabilitazione<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per il Corso di Laurea in Psicologia<br />
per Scuola di Specializzazione in Psicologia per<br />
attività di tirocinio ed attività di esperienze pratico-guidate<br />
Con l’Università degli Studi di Padova<br />
per Tirocinio post-lauream - Facoltà di Psicologia<br />
Libera Università degli Studi di Scienze Umane<br />
e Tecnologiche di Lugano Pazzallo (Svizzera)<br />
per l’utilizzazione del potenziale dei servizi di<br />
riabilitazione della Clinica ai fini del tirocinio<br />
pratico di orientamento degli studenti iscritti al<br />
Corso di Diploma di Fisioterapista<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI LUMEZZANE<br />
Con l’Università degli Studi di Brescia<br />
per la Scuola di Specializzazione in Cardiologia<br />
per attività di ricerca scientifica con il Dipartimento<br />
di Scienze Biomediche e Biotecnologie<br />
per attività di ricerca scientifica con la Cattedra<br />
di Cardiologia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Neurologia<br />
Con l’Università degli Studi di Ferrara<br />
per attività di ricerca nel settore della Fisiopatologia<br />
Cardiovascolare<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
Con l’Università degli Studi di Parma<br />
Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in<br />
Psicologia per lo svolgimento di attività pratica<br />
integrativa del tirocinio pratico per l’ammissione<br />
agli esami di stato di abilitazione professionale<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per Scuola di Specializzazione in Psicologia per<br />
attività di tirocinio ed attività di esperienze pratico-guidate<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 155<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI GENOVA-NERVI<br />
Con l’Università degli Studi di Genova<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione<br />
per lo svolgimento di un tirocinio di formazione<br />
ed orientamento per il Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
Libera Università degli Studi di Scienze Umane<br />
e Tecnologiche di Lugano Pazzallo (Svizzera)<br />
per l’utilizzazione del potenziale dei servizi di<br />
riabilitazione della Clinica ai fini del tirocinio<br />
pratico di orientamento degli studenti iscritti al<br />
Corso di Diploma di Fisioterapista<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASTEL GOFFREDO<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Radiodiagnostica<br />
156<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di Specializzazione<br />
in Terapia Fisica e Riabilitazione<br />
Con l’Università degli Studi di Torino<br />
per Scuola di Specializzazione in Psicologia per<br />
attività di tirocinio ed attività di esperienze pratico-guidate<br />
Con l’Università degli Studi di Bologna<br />
per il Tirocinio Post-Lauream laureati in Psicologia<br />
Con l’Università degli Studi di Brescia<br />
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini<br />
didattici integrativi da parte della Scuola di<br />
Specializzazione in Reumatologia<br />
Con l’Università degli Studi di Padova<br />
per lo svolgimento di un tirocinio pratico del<br />
Master in Neuropsicologia relativo ai disturbi<br />
cognitivi acquisiti<br />
CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI<br />
DI PADOVA<br />
Con l’Università Cà Foscari di Venezia<br />
per stages e tirocini di studenti<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Attività con altri Enti mediante partecipazione<br />
consortili o societarie<br />
La <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> partecipa:<br />
1 ASSOCIAZIONE PER LE NEUROSCIENZE CLINICHE E RIABILITATIVE<br />
Associazione con sede in Roma, presso il Ministero della Salute - Dipartimento della Innovazione,<br />
si propone di realizzare e gestire una rete di ricerca e sviluppo favorendo la collaborazione tra<br />
IRCCS di diritto pubblico e privato nel contesto delle Neuroscienze cliniche e riabilitative<br />
comprensive delle patologie del binomio sistema nervoso-mente.<br />
Fanno parte dell’Associazione i seguenti IRCCS: Oasi Maria SS-Onlus, San Raffaele Pisana,<br />
<strong>Fondazione</strong> S. Lucia, Istituto Neurologico Carlo Besta, Istituto Auxologico Italiano, E. Medea,<br />
<strong>Fondazione</strong> Stella Maris, Centro S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, Istituto di Cura S. Camillo,<br />
<strong>Fondazione</strong> Don Carlo Gnocchi-Onlus, <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> - Clinica del Lavoro e della<br />
Riabilitazione, Istituto Neurologico C. Mondino, Istituto Neurologico Mediterraneo-Neuromed,<br />
Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.<br />
2 ALLEANZA CONTRO IL CANCRO<br />
Associazione costituita (presso la Direzione Generale della Ricerca del Ministero della Salute)<br />
dai 7 IRCCS Oncologici, dall’IRCCS “C. Besta” e dalla <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong>.<br />
3 CONSORZIO PAVESE PER STUDI POST-UNIVERSITARI NELL’AREA SANITARIA<br />
Promosso dall’Università degli Studi di Pavia.<br />
Ha per scopo lo studio, la promozione e la realizzazione di iniziative rivolte alla formazione del<br />
personale di Aziende Sanitarie pubbliche e private.<br />
4 CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE<br />
Costituito con l’Università degli Studi di Pavia.<br />
Ha per scopo la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca nell’ambito di attività di ordine<br />
biologico, farmacologico, normativo e regolatorio.<br />
Il Consorzio collabora inoltre alle iniziative della Scuola di Specializzazione in Discipline Regolatorie<br />
dell’Università degli Studi di Pavia.<br />
5 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE<br />
Costituito con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, l’A.O. San Gerardo di Monza S.r.l., il<br />
C.A.M. Centro Analisi Monza S.r.l.<br />
Ha per oggetto lo sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale nei suoi aspetti di ricerca<br />
ed applicativi.<br />
6 CONSORZIO PER LA RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI DI TELEMEDICINA<br />
Promosso da <strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> e H.T.N. S.p.A. Health Telematic Network.<br />
Ha per scopo la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca nell’ambito di attività di<br />
progettazione, sviluppo di sistemi integrati di Telemedicina, di aggiornamento del personale<br />
sanitario e di conduzione di ricerche epidemiologiche e di farmacoeconomia.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 157<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
7 CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRANUOVA BRACCIOLINI S.p.A.<br />
Società mista a prevalente partecipazione pubblica costituita con la Azienda USL 8 di Arezzo, la<br />
Banca di Credito Cooperativo del Valdarno e l’Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta IRCCS.<br />
Ha per oggetto l’attività di recupero e di riabilitazione di soggetti portatori di disabilità e di sportivi<br />
con trattamenti in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.<br />
8 AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A.<br />
Società mista a prevalente partecipazione pubblica costituita con la Azienda USL 5 di Pisa, la<br />
<strong>Fondazione</strong> Cassa di Risparmio di Volterra, il Comune di Volterra, i Comuni della Val di Cecina e la<br />
Comunità Montana della Val di Cecina.<br />
Ha per oggetto la gestione di servizi riabilitativi cardiologici e neurologici e più in generale la<br />
realizzazione e gestione, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati operanti nel settore<br />
socio sanitario, di un Centro di Riabilitazione multispecialistico nel Presidio Ospedaliero di Volterra.<br />
9 CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA<br />
Fanno parte l’Università degli Studi di Pavia, l’Istituto Neurologico Mondino - IRCCS, il Policlinico<br />
S. Matteo - IRCCS, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS, Agilent Technologies Italia SpA,<br />
gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRCCS, l’A.O. Ospedale di Circolo “<strong>Fondazione</strong> Macchi”.<br />
10 CENTRO DI ECONOMIA SANITARIA<br />
Con l’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito del Consorzio Pavese per studi post-universitari<br />
nell’area economico-aziendale.<br />
11 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA<br />
Promosso dal mondo bancario ed imprenditoriale, avente per oggetto la costituzione,<br />
l’organizzazione e la gestione di strutture cliniche, sanitarie, scientifiche per la cura e prevenzione<br />
dei tumori, per la ricerca oncologica e per le connesse attività scientifiche e didattiche.<br />
12 CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO - IRCCS<br />
158<br />
Società di proprietà dell’Istituto Europeo di Oncologia che svolge attività clinico-scientifica in<br />
campo cardiologico.<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Collaborazioni Scientifiche a Livello Internazionale<br />
e Nazionale<br />
Collaborazioni Scientifiche<br />
a Livello Internazionale<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASSANO MURGE<br />
Ente con cui si collabora: Organizzazione Mondiale della<br />
Sanità (WHO), “WHO Collaboration Centre for Control<br />
of Tuberculosis and Lung Diseases in Europe”<br />
Tema della collaborazione: Coordinazione per le Attività<br />
relative all’Asma Bronchiale<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: McGill University, Meakins<br />
Christie Laboratories, Canada<br />
Tema della collaborazione: Esecuzione di progetti di ricerca<br />
di meccanica respiratoria con particolare riguardo<br />
ai meccanismi fisiopatogenetici dell’asma<br />
bronchiale<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: Pulmonology - Leiden University<br />
Medical Center Leiden, The Netherlands (Prof. Sterk P.)<br />
Tema della collaborazione: Exaled breath collection by<br />
electronic nose: met hods of measurements<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: ERS - European Respiratory Society<br />
Tema della collaborazione: Inflammatory Airways Diseases<br />
and Clinical Allergy Assembly - “Airway<br />
pharmacology and treatment”<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: American College of Chest<br />
Physicians (ACCP)<br />
Tema della collaborazione: Patologie Croniche dell’Apparato<br />
Respiratorio<br />
Pneumologia<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASTEL GOFFREDO<br />
Ente con cui si collabora: Department of Brain and Cognitive<br />
Sciences, MIT, Boston, U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Robot-aided Neurorehabilitation<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI LUMEZZANE<br />
Ente con cui si collabora: Service de Cardiologie Pediatrique,<br />
Group Hospitalier Necker, Parigi, Francia<br />
Tema della collaborazione: Consulenza clinica/sperimentale<br />
sulla cardiomiopatia dilatativa<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI MONTESCANO<br />
Ente con cui si collabora: Department of Neurological<br />
Science, Section of Clinical Neurophysiology, University<br />
of Goteborg, Sweden<br />
Tema della collaborazione: Alterazioni del sistema nervoso<br />
vegetativo in riabilitazione<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: University of California San<br />
Francisco, U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Baroreflex sensitivity in risk<br />
stratification for sudden death prevention<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: S. Luc Hospital Bruxelles, Belgio<br />
Tema della collaborazione: Comunità Europea. Gruppo<br />
di lavoro. Problematiche medico-legali della sindrome<br />
delle apnee durante il sonno<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa: Laboratorio di Polisonnografia<br />
Ente con cui si collabora: II Department of Cardiology,<br />
Medical University of Gdansk, Polonia<br />
Tema della collaborazione: Effetti del training fisico in<br />
soggetti normali<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: John Radcliffe Hospital, Oxford, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Home or Hospital in Heart<br />
failure (Progetto HHH). Sistema nervoso autonomo<br />
e apparato cardiovascolare<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Pneumologia, Dublino,<br />
Irlanda<br />
Tema della collaborazione: Progetto Cost B26 Comunità<br />
Europea. Gruppo di lavoro Complicanze car-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 159<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
diovascolari della Sindrome delle apnee durante il<br />
sonno<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa: Laboratorio di Polisonnografia<br />
Ente con cui si collabora: National Institute of Occupational<br />
Health (NIOH)<br />
Tema della collaborazione: Protocolli clinici ed attività<br />
scientifica inerenti la medicina del lavoro e la medicina<br />
riabilitativa, in particolare sull’analisi multifattoriale<br />
delle mansioni lavorative<br />
Servizio di Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia<br />
Ente con cui si collabora: University of Oxford, John Radcliffe<br />
Hospital, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Studio del controllo autonomico<br />
del sistema cardiovascolare<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: II Department of Cardiology,<br />
Gdansk School of Medicine, Gdansk, Poland<br />
Tema della collaborazione: Studio del controllo autonomico<br />
del sistema cardiovascolare in soggetti<br />
patologici e normali<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Leiden University Medical<br />
Center, Department of Cardiology, Leiden, Olanda<br />
Tema della collaborazione: Sviluppo di tecniche di weighted-averaging<br />
per migliorare la stima del riflesso<br />
barocettivo mediante il metodo della Transfer<br />
Function<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Department of Internal Medicine,<br />
University of Stellenbosch, South Africa<br />
Tema della collaborazione: The neural control of heart<br />
rate in modifying the arrhythmic risk of Long QT<br />
Syndrome<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI<br />
DI PADOVA<br />
Ente con cui si collabora: Airparif, Paris, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano a Parigi e nell’Île de France e<br />
valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ASPA, Strasbourg, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
160<br />
atmosferico urbano in Alsazia e valutazione del livello<br />
di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Qualitair Corse, Corte, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano in Corsica e valutazione del livello<br />
di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Airfobep, Martigues, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nei dipartimenti Etang de<br />
Berre e ovest Bouches-du-Rhône e valutazione<br />
del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Atmosf’Air Bourgogne, Dijon<br />
(Francia)<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nel centro-nord della Borgogna<br />
e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente,<br />
Principato di Andorra, Andorra La Vella, Andorra<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nel territorio del Principato di<br />
Andorra e valutazione del livello di rischio per la<br />
popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Air Normand, Le Havre, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nell’Alta Normandia e valutazione<br />
del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Aircom, Herouville St. Clair,<br />
Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella Bassa Normandia e valutazione<br />
del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ORA Guyane, Pointe Buzaré,<br />
Cayenne, Guiana francese<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella Guiana francese e valutazione<br />
del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Ente con cui si collabora: Atmo Champagne Ardenne,<br />
Reims, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Champagne Ardenne<br />
e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Air Pays de la Loire, Nantes,<br />
Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione dei paesi della<br />
Loira e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: AIRAQ, Bordeaux, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione dell’Aquitania e<br />
valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Air Breizh, Rennes, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione della Bretagna e<br />
valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Air Languedoc Roussillon,<br />
Montpellier, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Linguadoca-<br />
Rossiglione e valutazione del livello di rischio per<br />
la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ORAMIP, Colomiers, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Midi-Pyrénées e<br />
valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ESPOL, L’Hôpital, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Moselle Est e<br />
valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ATMO Nord Pas de Calais, Euralille,<br />
Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Nord - Pas de<br />
Calais e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ARPAM, Bart, Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Nord della<br />
Franca Contea e valutazione del livello di rischio<br />
per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: ATMO Poitou Charentes, Périgny,<br />
Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nella regione Poitou-Charentes<br />
e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Atmo Rhône Alpes, Grenoble,<br />
Francia<br />
Tema della collaborazione: Misura dell’inquinamento<br />
atmosferico urbano nelle regioni di Lione e di Grenoble<br />
e valutazione del livello di rischio per la popolazione<br />
Ricerche Ambientali<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA<br />
Ente con cui si collabora: Department of Physiology and<br />
Cell Biology, Davis Heart and Lung Research Institute,<br />
Ohio State University, Columbus, U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Calcium handling abnormalities<br />
in autosomal recessive CPVT: in vitro cellular<br />
characterization<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: SUNY Upstate Medical University<br />
Tema della collaborazione: Caratterizzazzione dei<br />
meccanismi aritmogeni nelle patologie da accumulo<br />
cronico di calcio intracellulare mediante<br />
mappaggio ottico<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: Wales Heart Research Institute<br />
Department of Cardiology, University of Wales, College<br />
of Medicine, Cardiff, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Characterization of abnormal<br />
intracellular Calcium handling and arrhythmogenesis<br />
Cardiologia Molecolare<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 161<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: Service de Rééducation Fonctionnelle,<br />
Faculté de Médecine, C.H.U. Timone, Marseille, France<br />
Tema della collaborazione: Il controllo posturale nei<br />
pazienti emiplegici<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Barolat Institute, Lone Tree, Colorado,<br />
U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Monitoraggio neurofisiologico<br />
della neurostimolazione spinale<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Heart and Research Follow up<br />
Program, University of Rochester Medical Center, Rochester,<br />
U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Registro epidemiologico internazionale<br />
della sindrome del QT lungo<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: Brain and Movement Laboratory,<br />
Université Laval, Québec City, Canada<br />
Tema della collaborazione: Ruolo della corteccia motoria<br />
negli aggiustamenti posturali associati ai<br />
movimenti volontari<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: NIH - Bethesda, U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Studio dei polimorfismi genici<br />
nella sclerosi laterale amiotrofica<br />
Neuroriabilitazione 2<br />
Ente con cui si collabora: Sanofi Aventis S.p.A.<br />
Tema della collaborazione: Studio in doppio cieco controllato<br />
verso placebo a bracci paralleli, per la valutazione<br />
dell’efficacia di dronedarone 400 mg BID<br />
nella prevenzione dell’ospedalizzazione per cause<br />
cardiovascolari o della morte per qualsiasi causa<br />
in pazienti con fibrillazione/flutter atriale (AF/AFL)<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Sanofi Aventis S.p.A.<br />
Tema della collaborazione: Studio internazionale, multicentrico,<br />
randomizzato, in doppio cieco, a due<br />
bracci, controllato versus placebo, a gruppi paralleli,<br />
con rimonabant 20 mg in singola somministrazione<br />
giornaliera nella prevenzione degli<br />
eventi cardiovascolari maggiori in pazienti con<br />
obesità addominale e fattori di rischio. EFC5826<br />
CRESCENDO<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Duke University Medical Center,<br />
Department of Medicine<br />
Tema della collaborazione: Valutazione funzionale dei<br />
162<br />
difetti genetici del canale del sodio associati a fenotipo<br />
misto<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: General Electric Medical System<br />
Europe<br />
Tema della collaborazione: Valutazione sul piano clinico<br />
dell’innovazione tecnologica in termini di<br />
hardware e di applicativi per l’acquisizione di immagini<br />
cardiache dirette alla valutazione non-invasiva<br />
del circolo coronarico mediante tomografia<br />
computerizzata multistrato<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: New England Medical Center,<br />
Tufts University Boston, MA, USA<br />
Tema della collaborazione: Ventiloterapia non-invasive<br />
- Ipertensione polmonare post-tromboembolica<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TELESE-CAMPOLI<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Neurologia,<br />
Università del Minnesota, Minneapolis (MN) U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Allestimento di una metodica<br />
non invasiva per lo studio delle fibre nervose<br />
periferiche sensitive e delle loro alterazioni morfofunzionali<br />
in patologie neurologiche e sistemiche<br />
Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
Ente con cui si collabora: CNR (National Research<br />
Council) Targeted Project on Aging (Prof.ssa Maggi S.)<br />
Tema della collaborazione: Epidemiologia dello scompenso<br />
cardiaco<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: National Institute of health, National<br />
Institute of Aging, Epidemiology, Demography,<br />
and Biometry Program, Bethesda Maryland U.S.A. NIH<br />
(Dr.ssa Harris T.)<br />
Tema della collaborazione: Epidemiologia dello scompenso<br />
cardiaco<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Wake Forest University School<br />
of Medicine Winston - Salem, North Carolina, Cattedra<br />
di Cardiologia / Dipartimento di Medicina Interna (Rich<br />
M.W.)<br />
Tema della collaborazione: Fattori precipitanti dello<br />
scompenso cardiaco dell’anziano<br />
Cardioangiologia Riabilitativa<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Ente con cui si collabora: Northwestern University Medical<br />
School, Chicago, Illinois, U.S.A. (Prof. Bonow R.O.,<br />
Prof. Gheorghiade M.)<br />
Tema della collaborazione: Trattamento dello Scompenso<br />
Cardiaco<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Center for Translation Medicine<br />
Thomas Jefferson University, Philadelphia, U.S.A. (Koch W.J.)<br />
Tema della collaborazione: Valutazione delle modificazioni<br />
del signaling Beta - Recettoriale indotte dal<br />
training fisico in pazienti con recente infarto del<br />
miocardio<br />
Cardioangiologia Riabilitativa<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TRADATE<br />
Ente con cui si collabora: Center of Psychooncology &<br />
Palliative Care Research, Dana-Farber Cancer Institute,<br />
Yale University (Prof. Holly G. Prigerson Ph.D)<br />
Tema della collaborazione: Adattamento del questionario<br />
“Prolonged Grief Disorder” (PG-12)<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization),<br />
Copenhagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr.<br />
Zaleskis R.)<br />
Tema della collaborazione: Attività di training e controllo<br />
della tubercolosi in Europa Orientale<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: PATH e USAID (Dr. Bloom A.,<br />
Mrs D’Arcy Richardson)<br />
Tema della collaborazione: Creazione di uno strumento<br />
per la valutazione della capacità dei Paesi a rispondere<br />
al problema della tubercolosi MDR e XDR<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: StopTB Partnership - World<br />
Health Organization, Ginevra (Dr. Espinal)<br />
Tema della collaborazione: Creazione StopTB Italy e<br />
collaborazione alle attività globali di ricerca, training<br />
e controllo della Tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: EMGO Institute, VU University<br />
Medical Center Amsterdam, The Netherlands (Dr.<br />
Mokkink L.B.)<br />
Tema della collaborazione: Definizione di standard di riferimento<br />
per la costruzione di questionari di misura<br />
dello stato di salute / qualità di vita - COnsensusbased<br />
Standards for the selection of health Measurement<br />
Instruments (COSMIN) Questionnaires<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: TBNET (Tubercolulosis Network<br />
in Europe Trialsgroup) (Dr. Lange C.)<br />
Tema della collaborazione: Disegno, realizzazione,<br />
analisi ed esecuzione di clinical trials multicentrici<br />
sulla tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: IUATLD (International Union<br />
Against Tubercolosis and Lung Diseases) Regione Europa<br />
(Prof. Loddenkemper R.) ed Headquarters (Prof.<br />
Enarson D.)<br />
Tema della collaborazione: Formazione per le attività di<br />
controllo della tubercolosi nei Paesi dell’Europa<br />
Orientale<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: FIND (Foundation for Innovative<br />
New Diagnostics), Executive Director (Dr. Rosigno G.)<br />
Tema della collaborazione: Identificazione nuovi diagnostici<br />
promettenti e sviluppo di trials nei Paesi<br />
in Via di Sviluppo<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: Rehabilitation Research Unit<br />
Astley Ainslie Hospital, Edinburgh<br />
Tema della collaborazione: Manuale del Cuore<br />
Psicologia - Cardiologia<br />
Ente con cui si collabora: World Health Organization, Ginevra;<br />
Stop TB Department (Dr. Raviglione M.)<br />
Tema della collaborazione: Partecipazione PPM Sub-<br />
Group (coinvolgimento private sector) afferente al<br />
DOTS Expansion Group<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization)<br />
- Copenhagen, Ufficio per la Regione Europa (Dr.<br />
Zaleskis R.)<br />
Tema della collaborazione: Partecipazione Technical<br />
Advisory Group (TAG) per controllo della tubercolosi<br />
in Europa<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 163<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization),<br />
NHI (National Health Institute)<br />
Tema della collaborazione: Periodica revisione ed aggiornamento<br />
della versione italiana delle linee<br />
guida GOLD e GINA<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: REC Regional Environmental<br />
Center<br />
Tema della collaborazione: Prevenzione malattie respiratorie<br />
in relazione all’inquinamento ambientale<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: EFA (European Federation for<br />
Asthma and Allergy Associations)<br />
Tema della collaborazione: Progetto educazionale globale<br />
di gestione del paziente asmatico<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization),<br />
Copenhagen; Ufficio per la Regione Europa (Dr.<br />
Zaleskis R.)<br />
Tema della collaborazione: Ricerca operativa nei seguenti<br />
campi: Sorveglianza delle resistenze, Controllo,<br />
Analisi Economica delle Attività di Controllo<br />
della tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization),<br />
Copenhagen; Ufficio per la Regione Europa (Dr.<br />
Zaleskis R.); Stop TB Department (Dr. Raviglione M.)<br />
Tema della collaborazione: Stesura Linee Guida Tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: WHO (World Health Organization),<br />
Copenhagen; Ufficio per la Regione Europa (Dr.<br />
Zaleskis R.); Stop TB Department (Dr. Raviglione M.)<br />
Tema della collaborazione: Training (Formazione consulenti<br />
per il controllo a livello globale della tubercolosi)<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: DOW (Doctors of the World,<br />
U.S.A.), Ufficio per i Balcani (Dr. Dev A.)<br />
Tema della collaborazione: Training e partecipazione<br />
comune a progetti di controllo della tubercolosi<br />
nei Balcani<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
164<br />
Ente con cui si collabora: MSH (Management Sciences for<br />
Health, Washington, DC, U.S.A.) (Dr. Zagorsky A.)<br />
Tema della collaborazione: Training e partecipazione<br />
comune a progetti di controllo finanziati da USAID<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI VERUNO<br />
Ente con cui si collabora: Klinic fur Innere Medizin -<br />
Schwerpunkt Pneumologie<br />
Tema della collaborazione: Analisi dei marcatori dell’infiammazione<br />
delle vie aeree su campioni biologici<br />
ottenuti da metodiche non-invasive<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Department of Pulmonology,<br />
Leiden University Medical Center, The Netherlands<br />
Tema della collaborazione: Aumentata attivazione<br />
della STAT-4 in biopsie bronchiali di fumatori con<br />
BPCO - Proliferazione e infiammazione nell’epitelio<br />
bronchiale dopo Challenge allergenico in<br />
asmatici atopici<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Krankenhaus Kloster Grafschaft,<br />
Zentrum für Pneumologie, Beatmungs-und Schlafmedizin,<br />
57392 Schmallenberg-Grafschaft, Germany<br />
Tema della collaborazione: Caratterizzazione del carico<br />
meccanico e del bilancio forza/carico nella<br />
storia naturale della broncopneumopatia cronica<br />
ostruttiva (BPCO)<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Department of Thoracic Medicine,<br />
National Heart and Lung Institute, London, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Caratterizzazione della flogosi<br />
in soggetti con bronchite cronica ostruttiva e<br />
iperreattività bronchiale - Studio della flogosi<br />
bronchiale in soggetti con diverso grado di ostruzione<br />
cronica irreversibile delle vie aeree mediante<br />
lavaggio e biopsie della mucosa bronchiale<br />
- Studio della Flogosi in Lavaggio Bronchiale e<br />
Biopsie Bronchiali di soggetti con Asma Allergico<br />
e Asma Intrinseco, uno studio comparativo - Analisi<br />
dei Polimorfismi genetici di proteine infiammatorie<br />
nella Broncopneumopatia cronica ostruttiva<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: The Cochrane Collaboration,<br />
London, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Cochrane Airways Group,<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
per revisione sistematica della letteratura sulla<br />
patologia delle vie aeree - Health related quality of<br />
life methods group, per revisione sistematica della<br />
letteratura sull’argomento<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Respiratory Research<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione editoriale<br />
con rivista internazionale online; editors in chief:<br />
Barnes P.J., Brigham K.L.<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Edimburgo, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Disturbi del movimento - Disturbi<br />
visuo-spaziali - Deficit di memoria - Demenze<br />
Divisione di Neurologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Dip. di Cardiologia, Università di<br />
S. Diego, U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Equilibrio neuro-vegetativo<br />
e sue implicazioni nello scompenso cardiaco<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: School of Education James Cook<br />
University, Australia<br />
Tema della collaborazione: Family Strain Questionnaire<br />
- Versione per MMG con Rasch Analisys<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: Depart. of Psychology, Freie Universitat,<br />
Berlin, Germany<br />
Tema della collaborazione: General Self-efficacy Scale<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: St. George Hospital, Medical<br />
School Division of Psychological Medicine, London, UK.<br />
Depart. of Epidemiology and Public Health, University<br />
College, London, U.K.<br />
Tema della collaborazione: Health Behaviour Survey<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: Hospital Sagrat Cor, Barcelona,<br />
Spain<br />
Tema della collaborazione: “Health Status” in pazienti<br />
BPCO in regime di ossigeno terapia a lungo termine<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Pneumologia, Università<br />
di Friburgo, Germania<br />
Tema della collaborazione: Pneumopatie diffuse interstiziali<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Instituto de Pesquisa&Deesenvolvimento-IP&D,<br />
Universidade do Vale do Paraiba<br />
(UNIVAP), Sao Iosè dos Campos, Sao Paulo, Brazil<br />
Tema della collaborazione: Respiro notturno di<br />
CHEYNE-STOKES in pazienti con insufficienza cardiaca<br />
congestizia - Meccanica respiratoria, pattern<br />
respiratorio e studio del sonno in pazienti con<br />
insufficienza cardiaca congestizia - Disturbi durante<br />
il sonno nella Sclerosi Laterale Amiotrofica<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Balance Disorders Laboratory,<br />
Portland (OR)<br />
Tema della collaborazione: Rieducazione della postura<br />
e dell’equilibrio<br />
Divisione di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
Ente con cui si collabora: Faculty of Medicine, University<br />
of Iceland, Reykjavik, Iceland<br />
Tema della collaborazione: Ruolo del carico meccanico<br />
respiratorio nell’esercizio fisico e nella patologia<br />
respiratoria - Analisi automatizzata Off-line in<br />
soggetti in respiro spontaneo<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Mayo Clinic Rochester, Minnesota,<br />
U.S.A.<br />
Tema della collaborazione: Sleep in Heart Failure<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: University Hospital Maastricht<br />
Tema della collaborazione: Standardizzazione ed ottimizzazione<br />
delle metodiche invasive e non invasive<br />
nella diagnosi delle malattie respiratorie<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Department of Lung Diseases,<br />
University Hospital, Essen, Germany<br />
Tema della collaborazione: Standardizzazione ed ottimizzazione<br />
delle metodiche invasive e non invasive<br />
per la valutazione dell’infiammazione broncopolmonare<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Centre de Recherche, Hopital du<br />
Sacré Coeur de Montreal, Canada<br />
Tema della collaborazione: Studio del controllo cardiovascolare<br />
da parte del SNA e la sua relazione con<br />
le fasi del sonno in soggetti con insonnia<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: The University of Auckland,<br />
Auckland, New Zealand. Meta-analysis Researk Group<br />
in Echocardiography (MeRGE)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 165<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Tema della collaborazione: Studio del ruolo prognostico<br />
del profilo restrittivo in pazienti con infarto<br />
miocardico e scompenso cardiaco<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: St. George’s Hospital Medical<br />
School, London<br />
Tema della collaborazione: Valutazione stato di salute<br />
e qualità della vita dei pazienti con insufficienza<br />
respiratoria cronica - Sviluppo questionari - Produzione<br />
linee-guida<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Psychology Department, Oviedo,<br />
Spagna<br />
Tema della collaborazione: Variabili psicolinguistiche<br />
che influenzano la capacità di denominare<br />
Laboratorio per lo studio dei disturbi afasici<br />
Collaborazioni Scientifiche<br />
a Livello Nazionale<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASSANO MURGE<br />
Ente con cui si collabora: SIMeR - Società Italiana di Medicina<br />
Respiratoria<br />
Tema della collaborazione: Allergologia ed Immunologia<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Foggia<br />
(Prof.ssa Foschino M.P.)<br />
Tema della collaborazione: Gruppo di Studio su “Iperreattività<br />
e Infiammazione Bronchiale”<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: AIPO - Associazione Italiana<br />
Pneumologi Ospedalieri<br />
Tema della collaborazione: Indagini Biologiche in<br />
Pneumologia - Asma ed Allergologia - Disturbi respiratori<br />
del sonno<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: AReS - Agenzia Regionale Sanitaria<br />
Tema della collaborazione: Protocolli di assistenza e<br />
procedure diagnostiche sulle Malattie Rare in<br />
Puglia<br />
Pneumologia<br />
166<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASTEL GOFFREDO<br />
Ente con cui si collabora: Federazione Italiana Atletica<br />
Leggera<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Bologna, Scuola di<br />
Specializzazione in Psicologia<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Brescia, Scuola di<br />
Specializzazione di Fisioterapisti<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Brescia, Scuola di<br />
Specializzazione in Reumatologia<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. S. di Riab. Specialistica Reumatologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Padova, Master in<br />
Neuropsicologia<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Pavia, Scuola di<br />
Specializzazione in Radiodiagnostica<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Pavia, Scuola di<br />
Specializzazione in Terapia Fisica Riabilitazione<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università di Torino, Scuola di<br />
Specializzazione in Psicologia<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
Ente con cui si collabora: Università La Sapienza di Roma,<br />
Dipartimento di Chimica<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
U.O. di Riab. Specialistica Neurologica<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI GENOVA-NERVI<br />
Ente con cui si collabora: Dip. Neurologia ASL Genova<br />
(Dr. Solaro C.). Centro Med. Dolore Osp. S. Martino<br />
(Dr. Nicoscia)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Tema della collaborazione: Definizione qualitativa del<br />
dolore somatico e neuropatico attraverso focus<br />
groups e realizzazione di un questionario per la rilevazione<br />
del dolore in una popolazione affetta da<br />
sclerosi multipla<br />
Divisione R.R.F.<br />
Ente con cui si collabora: Unità Operativa di Recupero e<br />
Rieducazione Funzionale dell’Ospedale “La Colletta” di<br />
Arenzano (ASL3 Genovese)<br />
Tema della collaborazione: Follow up del paziente fratturato<br />
di femore dopo ricovero riabilitativo<br />
Divisione R.R.F.<br />
Ente con cui si collabora: Polo Riabilitativo del Levante Ligure,<br />
<strong>Fondazione</strong> Don Gnocchi, Sarzana (SP). S.C. Recupero<br />
Funzionale E.O. Ospedali Galliera di Genova.<br />
U.O. Territoriale di Riabilitazione Distretto 2 ASL3 Genovese.<br />
U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale<br />
Colletta, Arenzano (GE). Università degli Studi di<br />
Genova<br />
Tema della collaborazione: Progetto di studio per la validazione<br />
di uno score complessivo di funzionalità<br />
posturale su pedana stabilometrica<br />
Recupero e Rieducazione Neuromotoria<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI LUMEZZANE<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Zooprofilattico della<br />
Lombardia e dell’Emilia Romagna<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione per la gestione<br />
temporanea degli animali da esperimento<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: Associazione Nazionale ALFA1-AT<br />
Tema della collaborazione: Deficit di Alfa1-antitripsina<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Medicina Interna, Università<br />
di Brescia<br />
Tema della collaborazione: Deficit di Alfa1-antitripsina<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Nazionale per la Sicurezza<br />
Occupazionale e Centro di Ricerca<br />
Tema della collaborazione: Effetto di un programma<br />
riabilitativo respiratorio di allenamento fisico sulla<br />
concentrazione di prodotti di lipoperossidazione<br />
nel condensato dell’aria espirata di pazienti affetti<br />
da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: ASL Brescia<br />
Tema della collaborazione: Indicazioni, prescrizione e<br />
monitoraggio della ventilazione meccanica domiciliare<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Medicina del Lavoro,<br />
Università di Parma<br />
Tema della collaborazione: Marcatori dell’ossidazione<br />
e dell’infiammazione in campioni biologici ottenuti<br />
con metodiche non invasive<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Medicina del Lavoro,<br />
Università di Parma<br />
Tema della collaborazione: Marcatori dell’ossidazione<br />
e dell’infiammazione in campioni biologici ottenuti<br />
con metodiche non invasive<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Nazionale per la Sicurezza<br />
Occupazionale e Centro di Ricerca<br />
Tema della collaborazione: Misurazioni di prodotti di lipoperossidazione<br />
quali espressione di stress ossidativo<br />
nel condensato dell’aria espirata di pazienti<br />
affetti da scompenso cardiaco<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Cardiologia, Università<br />
di Ferrara<br />
Tema della collaborazione: Profili ormonali e infiammatori<br />
nel paziente con scompenso cardiaco e<br />
ischemia miocardica<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: Riabilitazione Respiratoria, Villa<br />
Pineta, Pavullo (MO)<br />
Tema della collaborazione: Protocolli in riabilitazione<br />
respiratoria<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Patologia, Università<br />
degli Studi di Brescia<br />
Tema della collaborazione: Valutazioni con microscopio<br />
a fluorescenza e amplificazione genica in<br />
Real Time PCR<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
Ente con cui si collabora: Clinica Veterinaria Cellatica,<br />
Brescia<br />
Tema della collaborazione: Valutazioni eco-cardiografiche<br />
su animali da esperimento<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 167<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Anatomia Patologica,<br />
Università degli Studi di Padova<br />
Tema della collaborazione: Valutazioni molecolariistochimiche<br />
cellule staminali ed infarto del miocardio<br />
Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI MONTESCANO<br />
Ente con cui si collabora: Centro Studi ANMCO<br />
Tema della collaborazione: A large scale clinical trial<br />
testing the effects of n-3 PUFA and Rosuvastatin<br />
on mortality/morbility of patients with symptomatic<br />
congestive heart failure (GISSI-HF)<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Ricerche Farmacologiche<br />
“Mario Negri”<br />
Tema della collaborazione: A large scale clinical trial<br />
testing the effects of n-3 PUFA and Rosuvastatin<br />
on mortality/morbility of patients with symptomatic<br />
congestive heart failure (GISSI-HF)<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Fisiologia Clinica,<br />
CNR di Pisa<br />
Tema della collaborazione: Analisi mediante tecniche<br />
lineari e nonlineari di segnali cardio-respiratori<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Cardiologia, Università<br />
di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Autonomic tone and reflexes<br />
in unexpected cardiac events (UNEX-<br />
PECTED)<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Department of Clinical Medicine,<br />
Prevention and Applied Biotechnologies, University<br />
of Milano-Bicocca<br />
Tema della collaborazione: Baroreflex sensitivity indices<br />
derived from spontaneous blood pressure<br />
and heart rate fluctuations. Physiological Background,<br />
Standards of Measurement, and Clinical<br />
Use - Recommendations from the European Society<br />
of Hypertension Working Group on Blood<br />
Pressure and Heart rate Variability of the (EURO-<br />
BAVAR)<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
168<br />
Ente con cui si collabora: INAIL - Sede centrale di Roma<br />
e locale di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione a livello clinico<br />
ed a livello scientifico relativamento allo<br />
studio delle metodiche di valutazione funzionale<br />
quantitativa delle capacità residue dei soggetti<br />
con disabilità ed all’identificazione ed attuazione<br />
clinica di protocolli riabilitativi inerenti il reinserimento<br />
lavorativo<br />
Servizio di Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia<br />
Ente con cui si collabora: Laboratorio di TBM, Dipartimento<br />
di Bioingegneria, Politecnico, Università di Milano<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione nella realizzazione<br />
di misure delle resistenze del sistema respiratorio<br />
con tecnica delle oscillazioni forzate e<br />
ad impulsi<br />
U.O. di Pneumologia Riabilitativa e Fisiopatologia Respiratoria<br />
Ente con cui si collabora: Fisiopatologia Respiratoria, ASO<br />
S. Croce e Carle, Cuneo<br />
Tema della collaborazione: Consulenza scientifica e collaborazione<br />
alla realizzazione di misure di meccanica<br />
delle vie aeree nella BPCO e nel paziente obeso<br />
U.O. di Pneumologia Riabilitativa e Fisiopatologia Respiratoria<br />
Ente con cui si collabora: Medicina Interna, Università di<br />
Genova<br />
Tema della collaborazione: Consulenza scientifica su<br />
Progetti di ricerca relativi a studi di fisiopatologia<br />
nella BPCO<br />
U.O. di Pneumologia Riabilitativa e Fisiopatologia Respiratoria<br />
Ente con cui si collabora: Associazione Italiana Pneumologi<br />
Ospedalieri (AIPO)<br />
Tema della collaborazione: Coordinamento del gruppo<br />
di studio: trapianto di polmone e problematiche<br />
chirurgiche<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Scuola di Specializzazione in<br />
Neurofisiologia Clinica, Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Corso di Elettromiografia e<br />
Tecniche Speciali e frequenza presso il Servizio di<br />
Neurofisiopatologia degli iscritti alla scuola<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Elettronica, Politecnico<br />
di Torino<br />
Tema della collaborazione: Elettrofisiologia e biochi-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
mica tissutale della fatica muscolare: dati normativi<br />
per applicazioni in riabilitazione<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Anestesia e Terapia del<br />
Dolore, Università di Padova<br />
Tema della collaborazione: Fisiopatologia e terapia del<br />
dolore in riabilitazione<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Università di Pavia, Diploma<br />
Universitario per Tecnici di Neurofisiopatologia<br />
Tema della collaborazione: Frequenza presso il Servizio<br />
di Neurofisiopatologia degli iscritti alla<br />
scuola<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Società Italiana di Medicina Fisica<br />
e Riabilitazione (SIMFER)<br />
Tema della collaborazione: Gestione ed aggiornamento<br />
del sito Internet della Società Scientifica<br />
Servizio di Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Medicina Interna,<br />
Università di Firenze<br />
Tema della collaborazione: La riabilitazione delle lesioni<br />
del sistema nervoso periferico: valutazione<br />
neurofisiologica del danno, del recupero e degli<br />
esiti. Sclerodermia<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Centro di Medicina del Sonno,<br />
Clinica Neurologica, Università di Parma<br />
Tema della collaborazione: La valutazione polisonnografica<br />
nei pazienti con OSAS<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa: Laboratorio di Polisonnografia<br />
Ente con cui si collabora: Centro Medicina del Sonno, Clinica<br />
Neurologica, Istituto C. Mondino<br />
Tema della collaborazione: La valutazione polisonnografica<br />
nelle malattie neuromuscolari<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa: Laboratorio di Polisonnografia<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Fisica di Bari,<br />
Centro di Eccellenza per Studi Interdisciplinari TIRES<br />
(Tecnologie Innovative per la Rivelazione e l’Elaborazione<br />
dei Segnali)<br />
Tema della collaborazione: Modellistica di serie temporali<br />
di origine fisiologica<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Clinico Humanitas, U.O.<br />
di Chirurgia Toracica<br />
Tema della collaborazione: Percorso pre e post intervento<br />
di chirurgia toracica per enfisema bolloso,<br />
mesotelioma pleurico, neoplasia polmonare<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Cardiochirurgia, Policlinico<br />
S. Matteo, Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Progetto relativo al trapianto<br />
polmonare e terapia chirurgica dell’embolia<br />
polmonare (tromboendoarteiectomia)<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Laboratorio di TBM, Dipartimento<br />
Bioingegneria, Policlinico Università di Milano<br />
Tema della collaborazione: Protocolli clinici ed attività<br />
scientifica inerenti a nuovi metodi di analisi delle<br />
resistenze delle vie aeree nella BPCO<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Servizio di Fisiopatologia Respiratoria,<br />
Aso S. Croce e Carle Cuneo<br />
Tema della collaborazione: Protocolli clinici ed attività<br />
scientifica inerenti a nuovi metodi di analisi delle<br />
resistenze delle vie aeree<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: ISPESL - Roma<br />
Tema della collaborazione: Protocolli clinici ed attività<br />
scientifica inerenti la medicina del lavoro e la medicina<br />
riabilitativa, in particolare sulla prevenzione<br />
delle patologie muscolo-scheletriche connesse<br />
con l’attività lavorativa<br />
Servizio di Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia<br />
Ente con cui si collabora: SIMFER (Società Italiana Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione)<br />
Tema della collaborazione: Stesura di linee guida nazionali<br />
per il trattamento riabilitativo dell’osteoporosi<br />
U.O. Riabilitazione Specialistica Neuromotoria<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento Scienze Precliniche<br />
L.I.T.A. Vialba, Università degli Studi di Milano<br />
Tema della collaborazione: Studio del controllo autonomico<br />
del sistema cardiovascolare<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria,<br />
Ospedale Sacco, Milano<br />
Tema della collaborazione: Studio delle apnee notturne<br />
in pazienti affetti da insufficienza respiratoria<br />
U.O. Pneumologia Riabilitativa: Laboratorio di Polisonnografia<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 169<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Fisiologia Clinica,<br />
CNR, Pisa<br />
Tema della collaborazione: Valutazione delle alterazioni<br />
del pattern respiratorio in soggetti con scompenso<br />
cardiaco cronico<br />
U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI MONTESCANO - PRESIDIO DI MEDE<br />
Ente con cui si collabora: Azienda Ospedaliera della Provincia<br />
di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Progetto ospedale senza<br />
dolore, Comitato Ospedale senza dolore e docenza<br />
ai corsi (anno 2006)<br />
U.O. Cure Palliative<br />
CENTRO DI RICERCHE AMBIENTALI<br />
DI PADOVA<br />
Ente con cui si collabora: Azienda Regionale per la Protezione<br />
dell’Ambiente della Valle d’Aosta, Saint-Christophe,<br />
Aosta<br />
Tema della collaborazione: Attività di studio e ricerca<br />
per il monitoraggio della concentrazione di acido<br />
fluoridrico aerodispersi/inquinanti aerodispersi<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Azienda ULSS n. 14 della Regione<br />
Veneto, Chioggia (VE)<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione finalizzata<br />
alla minimizzazione del rischio espositivo professionale<br />
a gas e vapori anestetici<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Azienda ULSS n. 3 della Regione<br />
Veneto, Bassano del Grappa (VI)<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione finalizzata<br />
alla minimizzazione del rischio espositivo professionale<br />
a gas e vapori anestetici e ad altri agenti<br />
chimici<br />
Ricerche Ambientali<br />
Ente con cui si collabora: Azienda Sanitaria Unica Regionale<br />
Marche - Zona Territoriale n. 1, Pesaro<br />
Tema della collaborazione: Formazione in igiene industriale<br />
e tossicologia rivolto ai tecnici della prevenzione<br />
della A.S.U.R. Marche<br />
Ricerche Ambientali<br />
170<br />
Ente con cui si collabora: Azienda ULSS n. 9 della Regione<br />
Veneto, Treviso<br />
Tema della collaborazione: Sicurezza e risanamento<br />
ambientale - assistenza e aggiornamento al personale<br />
dell’azienda ULSS in tema di igiene industriale<br />
e ambientale<br />
Ricerche Ambientali<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Ricerche Farmacologiche<br />
“Mario Negri”<br />
Tema della collaborazione: A large scale clinical trial<br />
testing the effect of n. 3 PUFA and rosuvastatin on<br />
mortality/morbidity of patients with symptomatic<br />
congestive heart failure (GISSI-HF)<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: <strong>Fondazione</strong> IRCCS Policlinico<br />
San Matteo, Pavia<br />
Tema della collaborazione: Affidabilità della misurazione<br />
del pH di soluzioni caustiche con differenti<br />
metodi utilizzati nei servizi d’urgenza del Sistema<br />
Sanitario Nazionale (SSN)<br />
Tossicologia<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Fisiologia Neuromotoria<br />
della <strong>Fondazione</strong> Santa Lucia (IRCCS), Roma<br />
Tema della collaborazione: Caratteristiche precliniche e<br />
modelli di trattamento non farmacologico dei disturbi<br />
cognitivi e motori della malattia di Parkinson<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Scienze Neurologiche<br />
(DINOG), Università di Genova<br />
Tema della collaborazione: Caratteristiche precliniche<br />
e modelli di trattamento non farmacologico dei disturbi<br />
cognitivi e motori della malattia di Parkinson<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento Tecnologia e Salute<br />
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)<br />
Tema della collaborazione: Caratteristiche precliniche<br />
e modelli di trattamento non farmacologico dei disturbi<br />
cognitivi e motori della malattia di Parkinson<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: INSERM U637, Physiopathologie<br />
Cardiovasculaire, Montpellier, Francia<br />
Tema della collaborazione: Characterization of abnormal<br />
intracellular Calcium handling and arrhythmogenesis<br />
Cardiologia Molecolare<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Milano,<br />
Fond Lu.V.i.<br />
Tema della collaborazione: Colaborazione per tirocinio<br />
pratico, medici ed infermieri, iscritti al Master<br />
Cure Palliative a fine vita<br />
Cure Palliative<br />
Ente con cui si collabora: <strong>Fondazione</strong> IRCCS Istituto Neurologico<br />
“Carlo Besta”<br />
Tema della collaborazione: Continuità assistenziale tra i<br />
due Enti - Iniziative di informazione e formazione reciproca<br />
nel campo della riabilitazione-neurologianeurochirurgia<br />
- Attività di ricerca e sviluppo di programmi<br />
di riabilitazione per i pazienti neurologici<br />
Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
Ente con cui si collabora: Università di Perugia, Dipartimento<br />
di Medicina Interna, Perugia<br />
Tema della collaborazione: Contributo della gravità, dei<br />
segnali visivi e propriocettivi nel controllo dell’equilibrio<br />
del cammino<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Università Tor Vergata, Roma<br />
Tema della collaborazione: Contributo della gravità, dei<br />
segnali visivi e propriocettivi nel controllo dell’equilibrio<br />
del cammino<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Superiore di Sanità,<br />
Roma<br />
Tema della collaborazione: Diagnosi e trattamento dell’intossicazione<br />
botulinica<br />
Tossicologia<br />
Ente con cui si collabora: U.O. di Riabilitazione e Terapia<br />
Fisica, Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV)<br />
Tema della collaborazione: Effetti antalgici della stimolazione<br />
transcutanea ad alta frequenza del nervo<br />
periferico<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Farma Resa, Takeda Italia Farmaceutici<br />
S.p.A.<br />
Tema della collaborazione: Effetto del candesartan cilexetil<br />
vs. terapia standard sui livelli sierici del<br />
peptide natriuretico cerebrale in pazienti con insufficienza<br />
cardiaca cronica con funzionalità sistolica<br />
ridotta o conservata<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Scienze Biomediche<br />
e Sperimentali, Università degli Studi di Padova<br />
Tema della collaborazione: Espressione e caratterizzazione<br />
funzionale delle mutazioni del gene CASQ2<br />
nei pazienti con aritmie ventricolari da sforzo<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: CBIM (Consorzio di Bioingegneria<br />
e Informatica Medica, Italia), Dr. Hein (Germania),<br />
UNIPI (Università di Pisa, Centro Piaggio, Italia),<br />
UNIPD (Università di Padova, Italia)<br />
Tema della collaborazione: Fighting cardiovascular diseases<br />
by preventive lifestyle and early diagnosis<br />
(MyHeart Project)<br />
Neuroriabilitazione<br />
Ente con cui si collabora: Unità Operativa di Chirurgia<br />
della Mano, Policlinico di Modena<br />
Tema della collaborazione: Fisiopatologia del dolore<br />
dell’arto superiore<br />
Servizio di Neurofisiopatologia<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento della Protezione<br />
Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma<br />
Tema della collaborazione: Gestione delle emergenze<br />
NBCR: aspetti tossicologici<br />
Tossicologia<br />
Ente con cui si collabora: SIT IRCCS Policlinico S. Matteo,<br />
Pavia<br />
Tema della collaborazione: Impiego del gel piastrinico<br />
nella guarigione pilotata delle piaghe da decubito<br />
in pazienti neurolesi<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
Ente con cui si collabora: FAB srl Abano Terme (PD)<br />
Tema della collaborazione: Impiego di sostituto dermico<br />
a base di acido jaluronico tridimensionale<br />
per la riparazione tissutale<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Istologia ed Embriologia,<br />
Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Ingegneria tissutale<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Superiore di Sanità,<br />
Roma<br />
Tema della collaborazione: Intossicazioni acute da pesticidi<br />
Tossicologia<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Medicina Sperimentale,<br />
Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: L’interazione sensori-mo-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 171<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
toria nel controllo della stazione eretta dopo locomozione<br />
umana<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Dottorato di Ricerca in Fisiologia<br />
e Neuroscienze, Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: L’interazione sensori-motoria<br />
nel controllo della stazione eretta dopo locomozione<br />
umana<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Universitario di Studi Superiori,<br />
Pavia<br />
Tema della collaborazione: Per l’utilizzo di strutture<br />
extra-universitarie a fini didattici integrativi da<br />
parte del Master post-universitario “Tecnologie<br />
nucleari e delle radiazioni ionizzanti”<br />
Fisica Sanitaria<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Milano<br />
Tema della collaborazione: Per l’utilizzo di strutture<br />
extra-universitarie a fini didattici integrativi da<br />
parte della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria<br />
Fisica Sanitaria<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Medicina Sperimentale,<br />
Università di Genova<br />
Tema della collaborazione: Post effetti sul controllo<br />
della stazione eretta di visione e vibrazione muscolare<br />
C.S.A.M.<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Nazionale Neurologico<br />
C. Besta, Milano<br />
Tema della collaborazione: Progetto ICF e coma: la<br />
persona in coma: disabilità con basso livello di<br />
funzionamento ed elevata necessità di facilitatori<br />
Neuroriabilitazione<br />
Ente con cui si collabora: Laboratorio di Informatica Medica<br />
I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, Pavia<br />
Tema della collaborazione: Registro Italiano della mielofibrosi<br />
con metaplasia mieloide<br />
Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica<br />
Ente con cui si collabora: Istituti Clinici di Perfezionamento<br />
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di<br />
Medicina del Lavoro<br />
Tema della collaborazione: Registro Mesoteliomi Lombardia<br />
Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica<br />
172<br />
Ente con cui si collabora: Università di Pavia, Facoltà di<br />
Lettere, Dipartimento di Psicologia<br />
Tema della collaborazione: Ricerche psicologiche sui<br />
Transessuali female vs male<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
Ente con cui si collabora: Laboratorio di Neurobiologia<br />
Molecolare, Dipartimento di Neuroscienze, Istituto di<br />
Ricerche Farmacologiche Mario Negri<br />
Tema della collaborazione: Studi di proteomica delle<br />
proteine nitrate in pazienti affetti da sclerosi laterale<br />
amiotrofica<br />
Neuroriabilitazione 2<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Ricerche Farmacologiche<br />
“Mario Negri”<br />
Tema della collaborazione: Studio clinico sull’associazione<br />
n. 3 PUFA e statina: effetti su infiammazione<br />
e quadro lipidico<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Cardiologia, Policlinico<br />
San Matteo, Pavia<br />
Tema della collaborazione: Studio delle alterazioni genetiche<br />
nelle patologie aritmogene ereditarie<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: Gruppo Italiano Studio Linfomi<br />
(GISL)-GISL Trial Office, Oncologia Medica Policlinico<br />
di Modena<br />
Tema della collaborazione: Studio istopatologico dei<br />
linfomi<br />
Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica<br />
Ente con cui si collabora: Centro Studi ANMCO<br />
Tema della collaborazione: Studio multicentrico, randomizzato,<br />
in doppio cieco, controllato con placebo,<br />
sull’uso del Valsartan, un antagonista dei recettori<br />
dell’angiotensina II; nella prevenzione delle<br />
recidive di fibrillazione atriale<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: PAREXEL International S.r.l.<br />
Tema della collaborazione: Studio multicentrico, randomizzato,<br />
in doppio cieco, controllato verso<br />
plecebo, per la valutazione dell’efficacia e della<br />
sicurezza a lungo termine nella somministrazione<br />
orale di Tolvaptan (OPC-41062) compresse<br />
nei soggetti ricoverati in ospedale con<br />
scompenso cardiaco congestizio in fase di peggioramento<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Neuroscienze,<br />
Università di Torino<br />
Tema della collaborazione: Studio pilota su sicurezza e<br />
tollerabilità di ripetute procedure di mobilizzazione<br />
di cellule di derivazione osteo-midollare in<br />
pazienti con sclerosi laterale amiotrofica<br />
Neuroriabilitazione 2<br />
Ente con cui si collabora: AMGEN S.p.A.<br />
Tema della collaborazione: Studio randomizzato, in<br />
doppio cieco, controllato verso placebo multicentrico<br />
per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia<br />
con darbepoetina alfa nel ridurre la mortalità<br />
e la morbilità dei pazienti affetti da insufficienza<br />
cardiaca con disfunzione sistolica sintomatica del<br />
ventricolo sinistro e anemia<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: CFCM - DIBIT Ospedale S. Raffaele,<br />
Milano<br />
Tema della collaborazione: Sviluppo di modelli trasngenici<br />
di suscettibilità alle aritmie ventricolare ed<br />
alla morte improvvisa<br />
Cardiologia Molecolare<br />
Ente con cui si collabora: Centro Antiveleni, Ospedali Riuniti<br />
di Bergamo<br />
Tema della collaborazione: Validazione di un protocollo<br />
per la gestione dei “body packers” e “body<br />
stuffers”<br />
Tossicologia<br />
Ente con cui si collabora: Servizio di Fisioterapia - IRCCS<br />
Policlinico S. Matteo, Pavia<br />
Tema della collaborazione: Valutazione mediante visita<br />
fisiatrica e impiego di pedana stabilometrica delle<br />
variazioni posturali pre e postoperatorie in donne<br />
portatrici di ipertrofia mammaria e sottoposte ad<br />
intervento di mastoplastica riduttiva<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TELESE-CAMPOLI<br />
Ente con cui si collabora: Università del Molise, Facoltà di<br />
Scienze del Benessere, Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />
Tema della collaborazione: Adiponectina, diabete e<br />
obesità: ruolo dell’attività fisica<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
Ente con cui si collabora: II Università degli Studi di Napoli,<br />
Scuola di Specializzazione in Geriatria<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
Cardiologia Riabilitativa - Riabilitazione Neuromotoria -<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Napoli<br />
“Federico II”, Scuola di Specializzazione in Geriatria<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica<br />
Cardiologia Riabilitativa - Riabilitazione Neuromotoria -<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Napoli<br />
Tema della collaborazione: Attività didattica nell’ambito<br />
della Scuola di Specializzazione in Geriatria<br />
Cardiologia Riabilitativa - Riabilitazione Neuromotoria -<br />
Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Seconda Università degli Studi<br />
di Napoli, Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Geriatrica<br />
Tema della collaborazione: Formazioni di Giovani Ricercatori<br />
ed Attività scientifica clinico-sperimentale<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Napoli “Federico II”<br />
Napoli, Cattedra di Geriatria<br />
Tema della collaborazione: Gestione del paziente anziano<br />
cardiopatico<br />
Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: U.O. di Chirurgia Plastica e<br />
Centro Grandi Ustioni, A.O. Cardarelli Napoli<br />
Tema della collaborazione: Protocolli riabilitativi degli<br />
esiti di cicatriziali da ustioni<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Malattie dell’Apparato<br />
Respiratorio della Seconda Università di Napoli<br />
Tema della collaborazione: Riabilitazione respiratoria<br />
Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: Clinica Neurologica, Università<br />
degli Studi di Bologna<br />
Tema della collaborazione: Studio del sistema nervoso<br />
autonomico cutaneo<br />
Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
Ente con cui si collabora: Clinica Neurologica, Università<br />
di Roma “La Sapienza”<br />
Tema della collaborazione: Studio dell’innervazione<br />
cutanea nel territorio trigeminale nella nevralgia<br />
del trigemino ed altre algie facciali<br />
Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 173<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: U.O. di Dermatologia, A.O.<br />
Rummo di Benevento<br />
Tema della collaborazione: Trattamenti chirurgici e riabilitativi<br />
delle ustioni sub-acute<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
Ente con cui si collabora: A.O. S. Eugenio, Centro Ustioni,<br />
Roma<br />
Tema della collaborazione: Trattamenti riabilitativi<br />
degli esiti cicatriziali da ustioni<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Chirurgia Plastica<br />
SUN, Napoli<br />
Tema della collaborazione: Trattamento chirurgico ricostruttivo<br />
delle ulcere cutanee: da decubito e<br />
post-traumatiche<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Chirurgia Bariatrica,<br />
Università La Sapienza, Roma<br />
Tema della collaborazione: Trattamento della obesità<br />
grave recidivante mediante bendaggio gastrico,<br />
interventi plastico ricostruttivi fisioterapia e trattamento<br />
dietetico<br />
U.O. di Chirurgia Plastica<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TRADATE<br />
Ente con cui si collabora: Stop TB Italia<br />
Tema della collaborazione: Attività nazionali ed internazionali<br />
di controllo della tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: Associazione Nazionale BPCO<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione scientifica<br />
relativa all’educazione del paziente con BPCO<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: FEDERASMA<br />
Tema della collaborazione: Consulenza scientifica relativa<br />
al paziente asmatico<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: SITAB Società Italiana Tabaccologia<br />
Tema della collaborazione: Impostare la ricerca sugli<br />
interventi di disassuefazione dal fumo nei pazienti<br />
con malattie respiratorie croniche<br />
Divisione di Pneumologia<br />
174<br />
Ente con cui si collabora: Università di Modena, Cattedra<br />
Malattie Apparato Respiratorio (Prof. Fabbri L.)<br />
Tema della collaborazione: Periodica revisione ed aggiornamento<br />
della versione italiana delle linee<br />
guida GOLD e GINA<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: Regione Calabria - Assessorato<br />
Sanità<br />
Tema della collaborazione: Preparazione Programma<br />
di Controllo della Tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: Ministero Affari Esteri<br />
Tema della collaborazione: Riconoscimento Centro di<br />
Eccellenza per attività di controllo della Tubercolosi<br />
(Mozambico)<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: Ist. Malattie Respiratorie, Università<br />
di Parma (Prof. Olivieri D.)<br />
Tema della collaborazione: Serie di progetti di ricerca<br />
sullo studio dell’infiammazione nell’asma e nella<br />
bronchite cronica<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Ente con cui si collabora: Ministero della Salute-CCM,<br />
Centro Controllo Malattie (Prof. Greco D.)<br />
Tema della collaborazione: Sottomissione nazionale<br />
tubercolosi<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
Ente con cui si collabora: Ministero della Salute - Direzione<br />
Generale della Prevenzione - Ufficio III, Commissione<br />
Nazionale Tubercolosi (Dr. Pompa M.G., D’Amato S.)<br />
Tema della collaborazione: Validazione risultati sorveglianza<br />
resistenze e risultati trattamento<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie Respiratorie<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI VERUNO<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi di Torino<br />
per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione<br />
Tema della collaborazione: 1. Fisiopatologia dello<br />
scompenso respiratorio acuto del paziente con<br />
BPCO - 2. Implementazione di tecniche di monito-<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
aggio respiratorio - 3. Training degli specializzandi<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Fisiologia Umana, Università<br />
di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Analisi della postura e del<br />
movimento - Stesura di protocolli di indagine clinica<br />
e di ricerca<br />
Divisione di Recupero e Rieducazione Funzionale<br />
Ente con cui si collabora: Sezione di Anatomia Umana -<br />
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli<br />
Studi di Palermo<br />
Tema della collaborazione: Analisi di Western Blotting<br />
di proteine provenienti da biopsie bronchiali<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Ospedale di Circolo, Varese<br />
Tema della collaborazione: Assessment of cardiac<br />
asynchrony by radionuclide phase analysis: Correlation<br />
with ventricular function in patients with<br />
narrow or prolonged QRS interval<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Centro di Ricerca su Asma e<br />
BPCO, Università di Ferrara<br />
Tema della collaborazione: Caratterizzazione della flogosi<br />
in soggetti con bronchite cronica ostruttiva e<br />
iperreattività bronchiale - Studio della flogosi<br />
bronchiale in soggetti con diverso grado di ostruzione<br />
cronica irreversibile delle vie aeree mediante<br />
lavaggio e biopsie della mucosa bronchiale<br />
- Studio della Flogosi in Lavaggio Bronchiale e<br />
Biopsie Bronchiali di soggetti con Asma Allergico<br />
e Asma Intrinseco, uno studio comparativo - Analisi<br />
dei Polimorfismi genetici di proteine infiammatorie<br />
nella Broncopneumopatia cronica ostruttiva<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Torino, Cattedra di<br />
Malattie dell’Apparato Respiratorio<br />
Tema della collaborazione: Caratterizzazione immunoistochimiche<br />
della flogosi bronchiale delle patologie<br />
ostruttive delle vie aeree<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Torino, Facoltà di<br />
Psicologia<br />
Tema della collaborazione: Collaborazione scientifico -<br />
didattica per l’Insegnamento di Neuropsicologia<br />
Clinica e lo studio di pazienti con deficit cognitivo<br />
da lesione cerebrale focale o degenerativa<br />
Divisione di Riabilitazione Neuromotoria - Lab. di Neuropsicologia<br />
- Casa di Cura Major<br />
Ente con cui si collabora: Istituto Auxologico Piancavallo<br />
Tema della collaborazione: Conditional cardiovascular<br />
response to growth hormone therapy in adult patients<br />
with Prader-Willi syndrome<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Associazione Nazionale ALFA1-AT<br />
Tema della collaborazione: Deficit dell’Alfa-1-antitripsina<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Cattedra di Malattie dell’Apparato<br />
Respiratorio, Università di Pavia<br />
Tema della collaborazione: Deficit dell’Alfa-1-antitripsina<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Anatomia Patologica,<br />
Università di Cagliari<br />
Tema della collaborazione: Deficit dell’Alfa-1-antitripsina<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Medicina Interna, Università<br />
di Brescia<br />
Tema della collaborazione: Deficit dell’Alfa-1-antitripsina<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Servizio di Pronto Soccorso -<br />
Area Critica, Presidio Sanitario Gradenigo, Torino<br />
Tema della collaborazione: Determinanti fisiopatologici<br />
del successo/insuccesso della ventilazione<br />
non invasiva nell’Insufficienza Respiratoria Acuta<br />
a causa di riacutizzazione di BPCO<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: IRCCS Santa Lucia, Roma<br />
Tema della collaborazione: Diagnosi precoce delle demenze<br />
Divisione di Neurologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Milano-Bicocca,<br />
Dipartimento di Psicologia<br />
Tema della collaborazione: Disturbi del linguaggio<br />
scritto<br />
Laboratorio per lo studio dei disturbi afasici<br />
Ente con cui si collabora: Centro Interdipartimentale<br />
Mente/Cervello, Università di Trento, Polo di Rovereto,<br />
Rovereto<br />
Tema della collaborazione: Disturbi semantico-lessicali<br />
in pazienti con lesioni cerebrovascolari nel<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 175<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
territorio di distribuzione dell’arteria cerebrale posteriore<br />
Laboratorio per lo studio dei disturbi afasici<br />
Ente con cui si collabora: Barilla S.p.a.<br />
Tema della collaborazione: Effetti metabolici e cardiovascolari<br />
di una dieta ricca di proteine vegetali,<br />
fibre e acidi grassi Omega-3<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Ospedali Riuniti di Bergamo<br />
Tema della collaborazione: Efficacia dell’assistenza<br />
ventilatoria non invasiva con Proportional Assist<br />
Ventilation (PAV) nell’insufficienza respiratoria da<br />
riacutizzazione di broncopneumopatia cronica<br />
ostruttiva (BPCO) con l’impiego del sistema PUL-<br />
MOLAB per la misura automatica dei parametri di<br />
meccanica respiratoria<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Chirurgia Maxillo-Facciale,<br />
Università del Piemonte Orientale, Novara<br />
Tema della collaborazione: Inquadramento clinico diagnostico<br />
ed approccio terapeutico del paziente<br />
con OSAS<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica,<br />
Università del Piemonte Orientale, Novara<br />
Tema della collaborazione: Inquadramento clinico diagnostico<br />
ed approccio terapeutico del paziente<br />
con OSAS<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Cardiologia Interventistica,<br />
Azienda Ospedaliera Busto Arsizio<br />
Tema della collaborazione: Intracoronary ST segment<br />
evolution during primary coronary stenting predicts<br />
infarct zone recovery<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Ospedali Riuniti Livorno<br />
Tema della collaborazione: Intracoronary ST segment<br />
evolution during primary coronary stenting predicts<br />
infarct zone recovery<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Presidio Sanitario Gradenigo,<br />
Torino<br />
Tema della collaborazione: L’identificazione dei pazienti<br />
affetti da insufficienza respiratoria acuta che<br />
richiedano la ventilazione non invasiva, con l’im-<br />
176<br />
piego del sistema PULMOLAB per la misura automatica<br />
dei parametri di meccanica respiratoria<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Medicina del Lavoro,<br />
Università di Parma<br />
Tema della collaborazione: Marcatori dell’ossidazione<br />
e dell’infiammazione in campioni biologici ottenuti<br />
con metodiche non invasive<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Riabilitazione per Disabili<br />
Psichici, Villa “S. Ambrogio”, Fatebenefratelli, Cernusco<br />
s/N, Milano<br />
Tema della collaborazione: Memoria semantica<br />
Laboratorio per lo studio dei disturbi afasici<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Psicologia Generale,<br />
Università di Padova<br />
Tema della collaborazione: Metodologia di riduzione<br />
del questionario di qualità di vita MRF-28 mediante<br />
l’impiego del modello di Rasch - Elaborazione di un<br />
questionario per pazienti italiani affetti da BPCO:<br />
criteri di scelta del numero ottimale di Items<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Assessorato alla Tutela della Salute<br />
e Sanità, Regione Piemonte<br />
Tema della collaborazione: Partecipazione al Gruppo<br />
Tecnico Area Psicologica per: - il supporto di competenza<br />
alla Direzione Programmazione Sanitaria<br />
nella programmazione di obiettivi di sistema a prevalente<br />
connotazione strategica; - per la formazione<br />
regionale degli psicologi; - per la formazione<br />
di formatori per la realizzazione degli ospedali<br />
senza dolore in attuazione della DRG 31/1142/2005<br />
Servizio di Psicologia<br />
Ente con cui si collabora: Reparto Epidemiologia delle<br />
Malattie Cardiovascolari, Istituto Superiore di Sanità<br />
Tema della collaborazione: Predittori di rischio cardiovascolare<br />
e di fragilità associata a malattie cardiocerebro-vascolari<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Assessorato alla Sanità Regione<br />
Piemonte<br />
Tema della collaborazione: Prevenzione delle recidive<br />
degli accidenti cardiovascolari<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Assessorato alla Sanità Regione<br />
Piemonte<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Tema della collaborazione: Progetto Salute Piemonte<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Milano, Clinica<br />
Neurologica<br />
Tema della collaborazione: Psicometria; Memoria semantica;<br />
Disturbi lessicali; Disturbi prassici; Trattamento<br />
logoterapico; Deficit cognitivi nei traumi<br />
cranici<br />
Laboratorio per lo studio dei disturbi afasici<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Informatica, Sistemistica<br />
e Telecomunicazioni (DIST) dell’Università di<br />
Genova<br />
Tema della collaborazione: Realizzazione di un dispositivo<br />
robotico che consente di eseguire esercizi in<br />
diversi piani dello spazio a tre dimensioni e in modalità<br />
di controllo di impedenza<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Università di Torino, Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia, Clinica Neurologica I<br />
Tema della collaborazione: Riabilitazione e valutazione<br />
cognitiva di pazienti con malattie neurodegenerative<br />
- Studio di parametri elettroneurografici in pazienti<br />
con malattie neurodegenerative<br />
Divisione di Riabilitazione Neuromotoria - Lab. di Neuropsicologia<br />
- Casa di Cura Major<br />
Ente con cui si collabora: Università di Torino, Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia, Clinica Ortopedica II<br />
Tema della collaborazione: Scuola di Specialità in Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione - Riabilitazione di patologie<br />
ortopediche post-chirurgiche<br />
Divisione di Riabilitazione Neuromotoria - Casa di Cura<br />
Major<br />
Ente con cui si collabora: Centro Studi ANMCO<br />
Tema della collaborazione: Strategie di prevenzione<br />
secondaria in ambito riabilitativo dopo infarto<br />
miocardico in Italia: GlObal Secondary Prevention<br />
strategiEs to Limit event recurrence after myocardial<br />
infarction. GOSPEL Study<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università degli Studi Piemonte<br />
Orientale, Ospedale Maggiore della Carità, SCDU Anestesia<br />
e Rianimazione, Novara<br />
Tema della collaborazione: Studio dei parametri di<br />
meccanica respiratoria nel paziente in fase acuta<br />
mediante sistema PULMOLAB<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
Ente con cui si collabora: Azienda Ospedaliera Spedali Civili<br />
Brescia<br />
Tema della collaborazione: Studio del profilo di rischio<br />
metabolico, trombotico, infettivo, infiammatorio e<br />
genetico nel paziente con cardiopatia ischemica<br />
giovanile<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università Cattolica di Campobasso<br />
Tema della collaborazione: Studio del profilo di rischio<br />
metabolico, trombotico, infettivo, infiammatorio e<br />
genetico nel paziente con cardiopatia ischemica<br />
giovanile<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Reparto di Alimentazione, Nutrizione<br />
e Salute - Dipartimento di Sanità Alimentare e<br />
Animale, Istituto Superiore di Sanità<br />
Tema della collaborazione: Studio del profilo nutrizionale<br />
dei pazienti fragili in riabilitazione cardiovascolare;<br />
alimentazione nella prevenzione delle<br />
malattie cardiovascolari; effetti metabolici e cardiovascolari<br />
di una dieta ricca di proteine vegetali,<br />
fibre e acidi grassi Omega-3<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Istituto di Istologia ed Embriologia,<br />
Università di Padova<br />
Tema della collaborazione: Studio della flogosi bronchiale<br />
in soggetti con diverso grado di ostruzione<br />
cronica irreversibile delle vie aeree mediante lavaggio<br />
e biopsie della mucosa bronchiale - Studio<br />
della Flogosi in Lavaggio Bronchiale e Biopsie<br />
Bronchiali di soggetti con Asma Allergico e Asma<br />
Intrinseco, uno studio comparativo<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Ospedale Maggiore di Novara,<br />
Divisione di Pneumologia<br />
Tema della collaborazione: Studio della Flogosi in Lavaggio<br />
Bronchiale e Biopsie Bronchiali di soggetti<br />
con Asma Allergico e Asma Intrinseco, uno studio<br />
comparativo<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: ARTS Lab, Scuola Superiore S.<br />
Anna (Pisa)<br />
Tema della collaborazione: Tecniche robotizzate per la<br />
valutazione ed il trattamento riabilitativo delle disabilità<br />
motorie dell’arto superiore<br />
Servizio di Bioingegneria<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 177<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
Ente con cui si collabora: Servizio di Anestesia e Riabilitazione,<br />
Ospedale Maria Vittoria, Torino<br />
Tema della collaborazione: Validazione sperimentale<br />
dell’individuazione “flow-based” dell’inizio degli<br />
sforzi inspiratori in pazienti BPCO in respiro spontaneo<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Dipartimento di Scienze Sanitarie<br />
Applicate e Psicocomportamentali, Sezione di<br />
Scienza dell’Alimentazione (responsabile Prof.ssa Roggi C.)<br />
Tema della collaborazione: Valutazione dello stato nutrizionale<br />
dei pazienti affetti da scompenso cardiaco<br />
di grado lieve-moderato<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
178<br />
Ente con cui si collabora: Istituto G. Gaslini IRCCS, Genova<br />
Tema della collaborazione: Valutazione ex vivo delle<br />
bradichinine bronchiali, colture cellulari e valutazioni<br />
delle cellule staminali polmonari<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
Ente con cui si collabora: Università di Modena e Reggio<br />
Emilia. Cattedra di malattie dell’Apparato Respiratorio,<br />
<strong>Fondazione</strong> Istituto Villa Pineta di Gaiato.<br />
Tema della collaborazione: Valutazione stato di salute<br />
e qualità della vita dei pazienti con insufficienza<br />
respiratoria cronica - Il questionario MRF-28<br />
come indicatore di risultato nella riabilitazione nei<br />
pazienti BPCO<br />
Divisione di Pneumologia Riabilitativa<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Convenzioni Operative con i Servizi Pubblici<br />
di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Nel Centro di Pavia è attivo il Servizio Multizonale<br />
di Unità Operativa Ospedaliera di Medicina<br />
del Lavoro (UOOML) per la ASL di Pavia<br />
ASL Lodi<br />
REGIONE VENETO<br />
ASL TREVISO<br />
ASL CHIOGGIA (VE)<br />
ASL BASSANO DEL GRAPPA (VI)<br />
REGIONE EMILIA ROMAGNA<br />
ASL PIACENZA<br />
Presidio Multizonale di Prevenzione, ASL, MODENA<br />
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
ASL UDINE<br />
REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE<br />
ASL TRENTO<br />
Provincia Autonoma di TRENTO<br />
REGIONE PUGLIA<br />
ASL BA/3 (Altamura, Gravina, Acquaviva,<br />
Cassano)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 179<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
EMERGENZE TRASPORTI SUL TERRITORIO<br />
NAZIONALE<br />
Servizio Emergenza Trasporti in caso di incidenti<br />
su strada e per ferrovia coinvolgenti prodotti<br />
chimici (come da protocollo di intesa fra Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento<br />
Protezione Civile, Ministero dell’Interno - Direzione<br />
Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi,<br />
e Federchimica) Milano<br />
REGIONE VALLE D’AOSTA<br />
Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto<br />
Soccorso e Unità Operativa Territoriale 118<br />
Azienda USL Valle d’Aosta - Aosta<br />
REGIONE PIEMONTE<br />
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, DEA,<br />
Anestesia e Rianimazione 118, Pediatria, Laboratorio,<br />
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio<br />
- C. Arrigo - Alessandria<br />
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 118,<br />
Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Azienda<br />
Ospedaliera - Asti<br />
Servizi di Emergenza ed Accettazione, 118,<br />
Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Azienda<br />
Ospedaliera A. Carle - Cuneo<br />
REGIONE VENETO<br />
Servizi di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza,<br />
Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Medicina<br />
Azienda ASL n. 18 - Rovigo<br />
Ospedale San Luca - Trecenta (RO)<br />
REGIONE LIGURIA<br />
Pronto Soccorso, Accettazione (DEA)<br />
Presidio Ospedaliero di Genova Ponente<br />
Ospedale S. Carlo di Voltri<br />
USL 3 “Genovese” - Genova Voltri<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
SSUEM 118<br />
Ospedale Civile S. Andrea<br />
Azienda USL n. 5 “Spezzino” - La Spezia<br />
180<br />
Convenzioni Operative con i<br />
Servizi Pubblici per l’Emergenza<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
Nucleo Operativo Medicina del Lavoro, Divisione<br />
di Dermatologia<br />
Ospedale S. Paolo<br />
USL n. 2 “Savonese” - Savona<br />
Pronto Soccorso, Medicina e Chirurgia d’Accettazione<br />
e d’Urgenza (DEA)<br />
E.O. Ospedali Galliera - Genova<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
Unità Operativa di Pediatria<br />
Ospedale V. Buzzi & Clinica Pediatrica De Marchi<br />
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento<br />
Milano<br />
Pronto Soccorso, Terapia Intensiva<br />
Casa di Cura Polispecialistica Clinica San Carlo<br />
Paderno Dugnano (MI)<br />
Pronto Soccorso, Terapia Intensiva<br />
Ospedale Clinicizzato “G. Morandi”<br />
San Donato Milanese (MI)<br />
Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, Anestesia<br />
e Rianimazione, SSUEM 118, Pediatria e<br />
Patologia Neonatale<br />
Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco<br />
Lecco (LC)<br />
Pronto Soccorso, Rianimazione, Laboratorio di<br />
Analisi<br />
Azienda Ospedaliera S. Anna - Como<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
SSUEM 118<br />
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia<br />
Servizio di Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
Pediatria, Azienda Ospedaliera “Mellino<br />
Mellini”<br />
Azienda USSL n. 14 - Chiari (BS)<br />
Dipartimento di Emergenza, Accettazione,<br />
Pronto Soccorso<br />
Ospedale di Desenzano - Azienda Ospedaliera<br />
di Desenzano - Desenzano del Garda (BS)<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
SSUEM 118, Pediatria<br />
Azienda Ospedaliera Ospedale “C. Poma”,<br />
Mantova<br />
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE<br />
Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto<br />
Soccorso<br />
Ospedale di Rovereto - Rovereto (TN)<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione,<br />
SSUEM 118, Pediatria<br />
Azienda ospedaliera Santa Chiara, Trento<br />
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza e altri<br />
Servizi ospedalieri<br />
Azienda Speciale USL Centro Sud, Bolzano<br />
REGIONE EMILIA ROMAGNA<br />
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza<br />
Ospedale Civile<br />
USL n. 2 - Piacenza<br />
Servizi Clinici del Presidio Ospedaliero Valditone<br />
Ospedali di Castel San Giovanni e Borgonovo<br />
Valtidone, Valtidone (PC)<br />
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Anestesia<br />
e Rianimazione<br />
Azienda Ospedaliera “Arcispedale S. Anna”<br />
Ferrara<br />
Presidio Ospedaliero di Forlì<br />
Azienda ASL di Forlì, Forlì (FC)<br />
REGIONE LAZIO<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione<br />
Ospedale Belcolle<br />
Viterbo<br />
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione<br />
Ospedali Riuniti Frascati - Marino<br />
ASL RM H - Frascati (RM)<br />
REGIONE PUGLIA<br />
Servizi di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza,<br />
Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Medicina<br />
Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”<br />
Acquaviva delle Fonti (BA)<br />
REGIONE SICILIANA<br />
Dipartimento di Emergenza<br />
Azienda Ospedaliera Ospedali Vittorio Emanuele,<br />
Ferrarotto, S. Bambino<br />
Catania<br />
Servizio di Anestesia e Rianimazione<br />
Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli<br />
Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero<br />
di San Giovanni di Dio<br />
Palermo<br />
CROCE ROSSA ITALIANA<br />
Comitato Provinciale di Benevento<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 181<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASSANO MURGE<br />
ASSERTIVITÀ ED OPERATORI SANITARI<br />
Laboratorio di Psicologia<br />
21-22/2/2007<br />
CONOSCERE E GESTIRE L’AFASIA<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
25-26/5/2007<br />
CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITÀ<br />
PROFESSIONALE: IL SISTEMA DI PROTEZIONE<br />
IPASVI, TUTELA LEGALE E ASSICURATIVA<br />
Direzione Scientifica<br />
29/6/2007<br />
CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE<br />
PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE<br />
U.O. di Cardiologia Riabilitativa<br />
18-19/5/2007<br />
DALLA FASE ACUTA ALLA VERTICALIZZA-<br />
ZIONE DEL PAZIENTE EMIPLEGICO SE-<br />
CONDO IL CONCETTO KABAT<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
Maggio-Giugno 2007<br />
DEGLUTIZIONE NORMALE E PATOLOGICA<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
7/6/2007<br />
IL CATETERISMO VESCICALE<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
15/1/2007<br />
LA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE CON<br />
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO<br />
U.O. di Cardiologia Riabilitativa<br />
24-26/5/2007<br />
LA NORMA UNI-EN ISO 9000: I PRINCIPI<br />
INFORMATORI DI UN SISTEMA DI GESTIONE<br />
DELLA QUALITÀ<br />
Ufficio Qualità<br />
8/3/2007; 12/4/2007<br />
182<br />
Congressi Organizzati nel 2007<br />
MODIFICAZIONE DELL’OUTCOME E RIEDU-<br />
CAZIONE DELLE TURBE COMPORTAMEN-<br />
TALI NEL PAZIENTE CON GCA<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
19-20/10/2007<br />
SINDROME OSTRUTTIVA POLMONARE: STATO<br />
DELL’ARTE<br />
U.O. di Pneumologia Riabilitativa<br />
5/11/2007<br />
UROSTAGE: CORSO TEORICO-PRATICO DI AP-<br />
PROFONDIMENTO IN URODINAMICA<br />
U.O. Neurologia, Neuroriabilitazione ed Unità Spinale<br />
13-14/07/2007; 21-22/9/2007; 16-17/11/2007<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI CASTEL GOFFREDO<br />
BASI FARMACOLOGICHE PER IL TRATTA-<br />
MENTO ANTIBIOTICO<br />
Campostini L., Laboratorio Analisi<br />
9 e 14/11/2007<br />
CORSO BOBATH BASE<br />
Grioni G., RRF<br />
12-13-14/10/2007; 23-24-25/11/2007;<br />
14-15-16/12/2007<br />
DIAGNOSI, CLINICA E TRATTAMENTO DEL<br />
PAZIENTE CON TRAUMA CRANIO-ENCEFA-<br />
LICO<br />
Avanzi S., RRF<br />
22 e 29/11/2007<br />
DIAGNOSI, CLINICA E TRATTAMENTO DEL<br />
PAZIENTE OSTEOPOROTICO<br />
Grioni G., RRF<br />
18 e 25/5/2007<br />
ESERCIZIO FISICO E ALIMENTAZIONE<br />
Selletti L., RRF<br />
12 e 26/10/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI E PROCE-<br />
DURA POST-ESPOSIZIONE<br />
Grioni G., RRF<br />
4 e 11/5/2007<br />
TRATTAMENTO RIABILITATIVO DEL PAZIENTE<br />
PROTESIZZATO D’ANCA<br />
Selletti L., RRF<br />
12 e 28/9/2007<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI GENOVA-NERVI<br />
ESECUTORE BLSD<br />
Divisione R.R.F.<br />
28/9/2007<br />
I DISTURBI RESPIRATORI DURANTE IL<br />
SONNO COME NUOVO MARKER DI GRAVITÀ<br />
DEI PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS CEREBRI O<br />
LESIONI MIDOLLARI. NUOVE PROSPETTIVE<br />
RIABILITATIVE<br />
Divisione R.R.F.<br />
27/10/2007<br />
IL RUOLO DELLE SCALE DI VALUTAZIONE IN<br />
MEDICINA RIABILITATIVA<br />
Divisione R.R.F.<br />
09-10/11/2007<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI MONTESCANO<br />
CARDIOLOGIE APERTE 2007<br />
Febo O., U.O. Cardiologia Riabilitativa<br />
23 e 30/9/2007<br />
PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE<br />
RESPIRATORIO CRONICO: IL LINK OSPE-<br />
DALE-TERRITORIO<br />
Fracchia C., U.O. Pneumologia; AIPO<br />
9/6/2007<br />
I DISTURBI PSICOLOGICI E COMPORTAMEN-<br />
TALI NELLE DEMENZE<br />
Servizio di Psicologia<br />
24/9/2007<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA<br />
ASPETTI MEDICO-LEGALI E DIRITTI DELLE<br />
PERSONE INVALIDI CIVILI<br />
Pistarini C.<br />
CORSO INTERATTIVO DI DIAGNOSI E TE-<br />
RAPIA DEL DOLORE<br />
Buonocore M., Bonezzi C.<br />
INTERNATIONAL FOCUS ON STROKE (MI-<br />
LANO)<br />
Pistarini C.<br />
LA BIOPSIA CUTANEA NEURODIAGNOSTICA<br />
Buonocore M.<br />
LA PET E LE SUE APPLICAZIONI CLINICHE<br />
Carena M.<br />
LE CELLULE STAMINALI: REALE PROSPOSTA<br />
TERAPEUTICA?<br />
Pistarini C.<br />
MASTER BIENNALE DI 2° LIVELLO IN MEDI-<br />
CINA ESTETICA - 2° ANNO<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
NEW TRENDS IN CHIRURGIA PLASTICA, RI-<br />
COSTRUTTIVA ED ESTETICA<br />
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva<br />
OTTO DOMANDE SUI TUMORI DEL COLON-<br />
RETTO, DELLA MAMMELLA E DELLA TIROIDE<br />
U.O. Chirurgia Mininvasiva; U.O. Chirurgia Senologica;<br />
U.O. Medicina Generale<br />
PRENDERSI CURA DI CHI CURA IL SOG-<br />
GETTO MIELOLESO IN AMBITO RIABILITATIVO<br />
Pistarini C., Giorgi I.<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TELESE TERME<br />
2° CONGRESSO SIRAS - SOCIETÀ ITALIANA<br />
DI RIABILITAZIONE DI ALTA SPECIALIZZA-<br />
ZIONE - LE SFIDE DELLA RIABILITAZIONE<br />
MULTISPECIALISTICA<br />
Bianchi L., Romano S., Verna S. (Segret. Org.)<br />
25-26/10/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 183<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI TRADATE<br />
PREPARAZIONE DI PUBBLICAZIONI SCIEN-<br />
TIFICHE<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con Università di<br />
Pavia<br />
19/2/2007; 23/2/2007<br />
WHO TRAINING COURSE FOR PPM CON-<br />
SULTANTS<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
3/4/2007; 18/4/2007<br />
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDI-<br />
CINA TROPICALE E SALUTE INTERNAZIO-<br />
NALE<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con Università di<br />
Brescia<br />
18/4/2007<br />
WHO GLOBAL TRAINING COURSE ON IM-<br />
PLEMENTING THE STOP TB STRATEGY<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
18/5/2007; 1/6/2007<br />
RISCHIO TUBERCOLOSI E PREVENZIONE<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con ASL Varese<br />
6/6/2007<br />
4 th UNION, EUROPE REGION CONGRESS<br />
AND STOP TB PARTNERSHIP E CORSO CON-<br />
SULENTI TB<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie<br />
25/6/2007; 30/6/2007<br />
WHO COURSE FOR EUROPEAN CONSUL-<br />
TANTS ON TB/HIV COLLABORATIVE ACTIVI-<br />
TIES<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
1/7/2007; 13/7/2007<br />
184<br />
WHO TRAINING COURSE FOR TB LABORA-<br />
TORY CONSULTANTS<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
4/8/2007; 13/8/2007<br />
WHO-GLRA TB/HIV COURSE FOR MANAGERS<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
e GLRA, Germania<br />
15/8/2007; 21/8/2007<br />
WHO NTP COURSE FOR MANAGERS<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
31/8/2007; 9/9/2007<br />
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA TU-<br />
BERCOLOSI<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con ASL, Varese<br />
24/9/2007<br />
WHO GLOBAL TRAINING COURSE ON IM-<br />
PLEMENTING THE STOP TB STRATEGY<br />
Servizio di Epidemiologia Clinica delle Malattie<br />
Respiratorie in collaborazione con WHO, Ginevra<br />
3/10/2007; 16/10/2007<br />
FACCIAMO IL PUNTO SULL’OSAS IN PRO-<br />
VINCIA DI VARESE<br />
Divisione di Pneumologia<br />
29/9/2007<br />
CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA BPCO<br />
PER I MMG<br />
Divisione di Pneumologia<br />
9/6/2007; 14/6/2007; 15/6/2007; 10/10/2007;<br />
24/10/2007<br />
CORSO SULLA DISASSUEFAZIONE DAL FUMO<br />
Divisione di Pneumologia<br />
8/11/2007<br />
INDICAZIONE E CORRETTA GESTIONE DELLA<br />
EMOTRASFUSIONE E DELLA SOMMINISTRA-<br />
ZIONE DI EMOCOMPONENTI - Dr. Ivo Beverina,<br />
Centro Trasfusionale Ospedale di Tradate<br />
Divisione di Cardiologia<br />
8/5/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
RECENTI ACQUISIZIONI SUL RUOLO PRO-<br />
GNOSTICO DEL TEST CARDIOPOLMONARE<br />
NELLA PRATICA CLINICA: OLTRE IL CON-<br />
SUMO DI O 2<br />
Divisione di Cardiologia<br />
10/4/2007<br />
LUCI E OMBRE NELL’UTILIZZO DEGLI STENT<br />
MEDICATI - Dr. Battistina Castiglioni, UO Cardiologia<br />
II Ospedale di Circolo, VA<br />
Divisione di Cardiologia<br />
28/5/2007<br />
ISTITUTO SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE<br />
DI VERUNO<br />
GLI ASPETTI NUTRIZIONALI DEL PAZIENTE<br />
CRITICO<br />
Divisione di Neurologia Riabilitativa<br />
12/12/2007<br />
LA GESTIONE DELLE COMORBIDITÀ IN CAR-<br />
DIOLOGIA IN COLLABORAZIONE CON<br />
ANMCO - VERUNO<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
12, 13/10/2007<br />
LA RIABILITAZIONE DI ALTA SPECIALIZZA-<br />
ZIONE: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE -<br />
TORINO<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
1/12/2007<br />
LE EPILESSIE SINTOMATICHE: DALLA DIA-<br />
GNOSI ALLA TERAPIA<br />
Divisione di Neurologia Riabilitativa<br />
7/11/2007<br />
METODICHE E PROTOCOLLI DI RIABILITA-<br />
ZIONE FISICA IN CARDIOLOGIA<br />
Divisione di Cardiologia Riabilitativa<br />
23/5/2007<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 185<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
ALIANI MARIA<br />
Otorinolaringoiatria; Corso di Laurea in Infermieristica<br />
- II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Malattie dell’Apparato Visivo; Corso di Laurea<br />
in Infermieristica - II Anno di Corso; Università<br />
degli Studi di Bari, Sede distaccata della <strong>Fondazione</strong><br />
S. <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge (Ba)<br />
APPENDINI LORENZO<br />
Rianimazione e Terapia Intensiva (IV anno); Facoltà<br />
di Medicina e Chirurgia; Scuola di Specializzazione<br />
in Anestesiologia e Rianimazione; Università<br />
di Torino<br />
Terapia Intensiva (II anno); Facoltà di Medicina<br />
e Chirurgia; Scuola di Specializzazione in Anestesia<br />
e Terapia Intensiva; Università di Torino<br />
BACHETTI TIZIANA<br />
Biologia Molecolare e Metabolismo Cardiaco;<br />
Medicina e Chirurgia; Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia; Università di Brescia<br />
BALACCO MARINA<br />
Tecniche Riabilitative 1 - MED/48 (modulo b);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
BALBI BRUNO<br />
Metodologia Clinica; Cattedra di malattie dell’apparato<br />
respiratorio; Scuola di Specializzazione<br />
in Malattie dell’Apparato Respiratorio; Università<br />
di Foggia<br />
BALZANO GIOVANNI<br />
Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria; Facoltà<br />
di Medicina e Chirurgia; Scuola di Specializzazione<br />
in Malattie dell’Apparato Respiratorio; Seconda<br />
Università di Napoli<br />
BAZZINI GIACOMO<br />
Ergonomia; Medicina Fisica e Riabilitazione;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e<br />
Riabilitazione; Università di Pavia<br />
Valutazioni funzionali in Terapia Occupazionale;<br />
Terapia Occupazionale; Corso di Laurea in<br />
Terapista Occupazionale; Università di Pavia<br />
Rischi da postura: prevenzione e valutazione;<br />
Prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro<br />
1; Scuola di Specializzazione in Medicina del<br />
Lavoro 1; Università di Pavia<br />
Fisiocinesiterapia; Medicina del Lavoro; Scuola<br />
di Specializzazione in Medicina del Lavoro 2; Università<br />
di Pavia<br />
Ausili per spostamenti e trasferimenti; Terapia<br />
Occupazionale; Scuola di Specializzazione in Terapista<br />
Occupazionale; Università di Pavia<br />
Ortopedia; Medicina del Lavoro; Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina del Lavoro 2; Università<br />
di Pavia<br />
Prevenzione delle patologie da movimentazione;<br />
Medicina del Lavoro; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro 2; Università di Pavia<br />
BERNARDO ANTONIO<br />
Prevenzione infortuni e malattie professionali;<br />
Attuali tematiche connesse con la prevenzione del<br />
cancro e oncogeni professionali; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro II; Università<br />
di Pavia<br />
186<br />
BRUSCHI CLAUDIO<br />
Tecniche fisiopatologiche scambi gassosi; Fisiopatologia<br />
Respiratoria; Scuola di Specializzazione<br />
in Malattie Apparato Respiratorio; Università<br />
di Pavia<br />
BUONOCORE MICHELANGELO<br />
Fisiopatologia del dolore in riabilitazione; Medicina<br />
Fisica e Riabilitazione; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione; Università<br />
di Pavia<br />
Neurofisiopatologia professionale; Neurologia<br />
4° anno; Scuola di Specializzazione in Medicina<br />
del Lavoro II; Università di Pavia<br />
Patologie neurologiche correlate all’attività lavorativa.<br />
Aspetti fisiopatologici; Medicina del Lavoro<br />
III; Scuola di Specializzazione in Medicina del<br />
Lavoro I; Università di Pavia<br />
Patologie neurologiche correlate all’attività lavorativa.<br />
Aspetti fisiopatologici; Medicina del Lavoro<br />
III; Scuola di Specializzazione in Medicina del<br />
Lavoro I; Università di Pavia<br />
BUTERA RAFFAELLA<br />
Risorse informatiche nei Centri Antiveleni; Medicina<br />
Interna - Area della clinica tossicologica;<br />
Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica;<br />
Università di Pavia<br />
Tossicologia di consultazione; Medicina Interna<br />
- Area della clinica tossicologica; Scuola di<br />
Specializzazione in Tossicologia Medica; Università<br />
di Pavia<br />
Tossicologia degli inquinanti; Master universitario<br />
di II livello “Valutazione e controllo del rischio<br />
tossicologico da inquinanti ambientali”; Università<br />
di Pavia<br />
CALABRESE SERGIO<br />
Fisiokinesiterapia I - MED/34; Corso di Laurea<br />
in Fisioterapia - I Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
Medicina Fisica e Riabilitativa I - MED/34;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
Medicina Fisica e Riabilitativa 2 - MED/34;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
Fisiokinesiterapia 2 - MED/34; Corso di Laurea<br />
in Fisioterapia - III Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
Cinema, Fotografia, Televisione - L-ART/06;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
CALIA PAOLA<br />
Tecniche riabilitative 3 - MED/48 (modulo b);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
CALSAMIGLIA GIUSEPPE<br />
Cardiologia Nucleare: Aspetti Clinici; Diagnostica<br />
per immagini e radioterapia; Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia; Università di Pavia<br />
CAMPOSTRINI LORELLA<br />
Biochimica; Corso integrato di Biochimica e<br />
Biochimica Clinica A3; Corso di Laurea in Fisioterapia;<br />
Università di Brescia<br />
Professori a Contratto<br />
CAPODAGLIO EDDA<br />
Ergonomia; Corso di Laurea in Scienze e Tecniche<br />
Psicologiche; Università di Pavia<br />
Ergonomia; Medicina del Lavoro II, Facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia; Corso di Laurea Tecnico<br />
della Prevenzione; Università di Pavia<br />
CASALE ROBERTO<br />
Tecniche EMG Speciali (Microneurografia);<br />
Elettromiografia e tecniche correlate I; Scuola di<br />
Specializzazione in Neurofisiologia Clinica; Università<br />
di Pavia<br />
Diagnostica Neurofisiologica in Medicina del<br />
Lavoro; Medicina del Lavoro III; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro; Università di<br />
Pavia<br />
Tecniche Speciali in Terapia Antalgica; Fisiopatologia<br />
del Dolore; Scuola di Specializzazione in<br />
Anestesia e Rianimazione; Università di Siena<br />
CASTOLDI ANNA FEDERICA<br />
Sostanze neurotossiche e danni neurologici<br />
nel corso dello sviluppo; Teratogenesi e tossicologia<br />
perinatale; Scuola di Specializzazione in Tossicologia<br />
Medica; Università di Pavia<br />
Tossicologia Generale; Master universitario di<br />
II livello “Valutazione e controllo del rischio tossicologico<br />
da inquinanti ambientali”; Università di<br />
Pavia<br />
Tutor del Corso di Neurobiologia; Istituto Universitario<br />
di Studi Superiori (IUSS) di Pavia<br />
CAUTERUCCIO SANTA<br />
Tecniche Riabilitative 2 - MED/48 (modulo b);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
CELLAMARE FARA<br />
Tecniche Riabilitative 1 - MED/48 (modulo a);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
CERIANA PIERO<br />
Trattamento d’urgenza delle manifestazioni<br />
tossiche in corso di anestesia; Facoltà di Medicina<br />
e Chirurgia; Scuola di Specializzazione in Farmacologia<br />
Clinica; Università di Pavia<br />
La terapia occupazionale in pneumologia riabilitativa;<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia; Corso di<br />
Laurea Triennale in Terapia Occupazionale; Università<br />
di Pavia<br />
COBELLI FRANCO<br />
L’emodinamica nelle prove da sforzo; Indagine<br />
diagnostiche invasive; Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia; Università di Pavia<br />
COCCINI TERESA<br />
Marcatori biochimici di tossicità; Farmacologia<br />
Generale; Scuola di Specializzazione in Tossicologia<br />
Medica; Università di Pavia<br />
Tossicologia inalatoria; Malattie dell’apparato<br />
respiratorio; Scuola di Specializzazione in Tossicologia<br />
Medica; Università di Pavia<br />
Tossicologia Generale; Master universitario di<br />
II livello “Valutazione e controllo del rischio tossicologico<br />
da inquinanti ambientali”; Università di<br />
Pavia<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
COLUCCI ANTONELLA<br />
Tecniche riabilitative 3 - MED/48 (modulo a);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
COTTICA DANILO<br />
Tecniche di prelievo ed analisi in gas massa<br />
per la determinazione di sostanze organiche aerodisperse;<br />
Patologia Clinica e monitoraggio biologico;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del<br />
Lavoro I; Università di Pavia<br />
Campionamento ed analisi di sostanze chimiche<br />
aerodisperse di interesse allergologico;<br />
Diagnostica Allergologica in vivo II; Scuola di Specializzazione<br />
in Allergologia; Università di Pavia<br />
Igiene Industriale; Corso Integrato di Medicina<br />
del Lavoro II anno; Scuola di Specializzazione in<br />
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei<br />
Luoghi di Lavoro; Università di Pavia<br />
Tecniche di bonifica; Corso Integrato di Medicina<br />
del Lavoro II; Scuola di Specializzazione in<br />
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei<br />
Luoghi di Lavoro; Università di Pavia<br />
Lineamenti di Igiene Industriale; Master “Valutazione<br />
e Controllo del Rischio Tossicologico da<br />
Inquinanti Ambientali”; Università di Pavia<br />
CRACA ANGELA<br />
Neuropsicologia Clinica - MED/26; Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
CUOMO VITADALBERTO<br />
Fisiologia I - BIO/09 (modulo b); Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Malattie App. Respiratorio e Riab. Respiratoria<br />
- MED/10; Corso di Laurea in Fisioterapia - II<br />
Anno di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
Bioetica - MED/02; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- III Anno di Corso; Università di Bari, Sede<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
DE CAMPI MAURIZIO<br />
Terapia Fisica - MED/34; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
DE SERIO SALVATORE<br />
Reumatologia - MED/16; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Fisioterapia - MED/34; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
DE TOMA LUIGI<br />
Cardioangiologia Medica e Riab. Cardiologica<br />
- MED/11; Corso di Laurea in Fisioterapia - III<br />
Anno di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
DEL PRETE MARINA<br />
Neurologia I - MED/26; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
DELL’ANNA MARIA ELISABETTA<br />
Neurologia Pediatrica; Medicina e Chirurgia;<br />
Scuola di Specializzazione in Neurologia; Università<br />
di Udine<br />
DI LEO LUCIA<br />
Tecniche Riabilitative 2 - MED/48 (modulo c);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
DURANTE STEFANO<br />
Igiene generale ed applicata - MED/42; Corso<br />
di Laurea in Infermieristica - II Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
Architettura degli interni ed allestimento -<br />
ICAR/16; Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno<br />
di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
Igiene generale ed applicata - MED/42; Corso<br />
di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
FERRIERO GIORGIO<br />
Scale di valutazione in terapia occupazionale;<br />
Corso di Laurea per Terapisti Occupazionali; Università<br />
di Pavia<br />
FOGLIO KATIA<br />
Corso di Malattia Apparato Respiratorio; Facoltà<br />
di Medicina Università di Brescia sede di<br />
Mantova; Corso di Laurea in educatori professionali;<br />
Università di Brescia<br />
FRACCHIA CLAUDIO<br />
Sindrome disventilatoria; Fisiopatologia Respiratoria;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica<br />
e Riabilitazione; Università di Pavia<br />
Fisiopatologia Respiratoria nella Riabilitazione<br />
toraco-polmonare; Terapia intensiva respiratoria e<br />
cardio-respiratoria; Scuola di Specializzazione in<br />
Malattie Apparato Respirtaorio; Università di Pavia<br />
FRANCHIGNONI FRANCO<br />
Cinesiologia e Cinesiterapia; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina Fisica e Riabilitazione; Università<br />
di Torino<br />
Metodologia generale della riabilitazione motoria<br />
e fisioterapia strumentale; Corso di Laurea<br />
per Fisioterapista; Università degli Studi del Piemonte<br />
Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara<br />
Tecniche di terapia occupazionale; Corso di<br />
Laurea per Terapisti Occupazionali; Università di<br />
Pavia<br />
FUMARULO GIUSEPPINA<br />
Tecniche Riabilitative 4 - MED/48 (modulo b);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
Tecniche Riabilitative IV; Master Universitario<br />
di I Livello in Terapia Riabilitativa nelle Malattie<br />
dell’Apparato Respiratorio - I Anno di Corso; Università<br />
Cattolica del Sacro Cuore di Roma<br />
FURGI GIUSEPPE<br />
Insegnamento Medicina Fisica e Riabilitazione;<br />
Scuola di Specializzazione in Geriatria; Università<br />
degli Studi di Napoli “Federico II”<br />
Riabilitazione Geriatrica; Scuola di Specializzazione<br />
in Geriatria; “Seconda Università” degli<br />
Studi di Napoli<br />
GALANTE MASSIMO<br />
Rieducazione Funzionale dell’Apparato Locomotore;<br />
Terapia Fisica e Riabilitazione, Università<br />
di Torino; Scuola di Specializzazione in Terapia Fisica<br />
e Riabilitazione; Università di Torino<br />
GALLI FRANCO<br />
Aspetti tecnici del trattamento emodialitico: la<br />
scelta dei biomateriali; Chirurgia d’urgenza;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro;<br />
Università di Pavia<br />
GIARDINI ANNA<br />
Valutazione psicodiagnostica e funzionale -<br />
Corso Progredito; Corso di Laurea in Scienze e<br />
Tecniche Psicologiche (Biennio Specialistico); Facoltà<br />
di Lettere e Filosofia; Università di Pavia<br />
GIORGI INES<br />
Teorie e tecniche dei test; Corso di Laurea in<br />
Scienze e Tecniche Psicologiche; Università di<br />
Pavia<br />
GRIGNANI ELENA<br />
Tecniche di valutazione dei rischi; Corso Integrato<br />
di Medicina del Lavoro II; Scuola di Specializzazione<br />
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente<br />
e nei Luoghi di Lavoro; Università di Pavia<br />
GRIONI GIUSEPPE<br />
Metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria;<br />
Riabilitazione Neuromotoria - Med/34; Corso<br />
di Laurea in Fisioterapia; Università di Brescia<br />
GUARNASCHELLI CATERINA<br />
Problematiche riabilitative nel grave cerebroleso;<br />
Terapia Occupazionale; Corso di Laurea in<br />
Terapia Occupazionale (Anno Accademico 2007-<br />
2008); Università di Pavia<br />
LA ROVERE MARIA TERESA<br />
Sistema nervoso autonomo e stratificazione<br />
prognostica del post-infarto; Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia; Università di Pavia<br />
Elettrocardiografia dinamica; Scuola di Specializzazione<br />
in Cardiologia; Università di Pavia<br />
LAERA ROSARIA<br />
Infermieristica ostetrico-ginecologica; Corso di<br />
Laurea in Infermieristica - II Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
LAGIOIA ROCCO<br />
Malattie Apparato Cardiovascolare - MED/11;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
LILLO MARIA<br />
Tecniche Riabilitative 2 - MED/48 (modulo a);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
LOCATELLI CARLO<br />
Tecniche di rianimazione negli avvelenamenti;<br />
Medicina interna - Area della clinica tossicologica;<br />
Scuola di Specializzazione in Tossicologia<br />
Medica; Università di Pavia<br />
Trattamento delle intossicazioni; Tossicologia<br />
clinica e terapia; Scuola di Specializzazione in Farmacologia;<br />
Università di Pavia<br />
Piani per le emergenze da grandi rischi; Medicina<br />
d’Urgenza; Scuola di Specializzazione in Medicina<br />
del Lavoro I; Università di Pavia<br />
Il pronto soccorso: rianimazione cardiorespiratoria;<br />
Medicina d’Urgenza; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro I; Università di Pavia<br />
Tossicologia con particolare riferimento alle intossicazioni<br />
acute per esposizione professionale;<br />
Tossicologia industriale e ambientale; Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina del Lavoro II; Università<br />
di Pavia<br />
Terapia intensiva nelle intossicazioni acute; Anestesiologia<br />
- Area dell’anestesia e della terapia intensiva<br />
nelle specialità; Scuola di Specializzazione in<br />
Anestesia e Rianimazione; Università di Pavia<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 187<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
ABC della rianimazione e misure di primo soccorso<br />
per le urgenze mediche in ambito professionale;<br />
Medicina d’Urgenza; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro II; Università di Pavia<br />
Tossicologia degli inquinanti; Master universitario<br />
di II livello “Valutazione e controllo del rischio<br />
tossicologico da inquinanti ambientali”; Università<br />
di Pavia<br />
LOIZZO CATERINA<br />
Tecniche Riabilitative 1 (modulo c) - MED/48;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
LOSAVIO ERNESTO<br />
Medicina Fisica e Riabilitativa 5 - MED/34<br />
(modulo b); Corso di Laurea in Fisioterapia - III<br />
Anno di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
LOVERRE ANNA<br />
Riabilitazione dell’età evolutiva - MED/34;<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
LULLO FRANCESCO<br />
Attività di Tirocinio Guidato del Corso Integratao<br />
di Tirocinio; Corso di Laurea per Tecnico di<br />
Neurofisiopatologia; Università di Napoli “Federico<br />
II”<br />
MAJANI GIUSEPPINA<br />
Psicologia della Salute; Corso di Laurea in<br />
Scienze e Tecniche Psicologiche; Facoltà di Lettere<br />
e Filosofia; Università di Pavia<br />
Psicologia Clinica; Scuola di Specializzazione<br />
in Psicologia del Ciclo di Vita; Università di Pavia<br />
MAJANI UGO<br />
Tecniche fisiopatologiche nella BPCO e bronchiectesie;<br />
Fisiochinesiterapia Respiratoria;<br />
Scuola di Specializzazione in Malattia Apparato<br />
Respiratorio; Università di Pavia<br />
MARSICO VITO<br />
Anatomia Umana I - BIO/16 (modulo b); Corso<br />
di Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
MERIGGI ANTONIO<br />
Diagnosi e terapia nella patologia da veleno di<br />
imenotteri; Diagnostica Allegologica III; Scuola di<br />
Specializzazione in Allergologia e Immunologia<br />
Clinica; Università di Pavia<br />
MIGLIORI GIOVANNI BATTISTA<br />
Come organizzare e scrivere un lavoro scientifico;<br />
Epidemiologia generale; Scuola di Specializzazione<br />
in Statistica Sanitaria; Università di Pavia<br />
MIOTTI DANILO<br />
Corso di Laurea specialistica in scienze infermieristiche<br />
ed ostetriche; Facoltà di Medicina e<br />
Chirurgia; Università di Pavia<br />
MONACO WALTER<br />
Tecniche Riabilitative 4 - MED/48 (modulo c);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
MONITILLO VINCENZO<br />
Neurofisiopatologia - MED/26; Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
188<br />
Fisiologia II - BIO/09 (modulo b); Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
MONTICONE MARCO<br />
Disabilità e Riabilitazione Psico-Motoria; Disabilità<br />
e Riabilitazione Psico-Motoria; Scuola di<br />
Specializzazione in Scienze e Tecniche Psicologiche<br />
di Riabilitazione, Facoltà di Lettere e Filosofia;<br />
Università di Pavia<br />
MONTRONE NICOLA<br />
Neurologia 2 - MED/26; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- III Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Neurotossicolgia professionale; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro; Università di<br />
Bari<br />
MOSCATO GIANNA<br />
Asma professionale allergico; Diagnostica allergologica<br />
in vivo I; Scuola di Specializzazione in<br />
Allergologia e Immunologia Clinica; Università di<br />
Pavia<br />
Asma professionale; Allergologia; Scuola di<br />
Specializzazione in Medicina del Lavoro I; Università<br />
di Pavia<br />
Patologia allergica professionale; Allergologia;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro<br />
II; Università di Pavia<br />
MULTARI VINCENZO<br />
Cinesiologia - MED/34; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- I Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
NARDONE ANTONIO<br />
Riabilitazione Neurologica I; Patologia Neurologica<br />
I; Corso di Laurea in Fisioterapia; Università<br />
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,<br />
Novara<br />
NARDULLI ROBERTO<br />
Medicina Fisica e Riabilitativa 5 - MED/34<br />
(modulo a); Corso di Laurea in Fisioterapia - III<br />
Anno di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
NAVA STEFANO<br />
Fisiologia dei muscoli respiratori; Corso di<br />
Laurea in Medicina; Scuola di Specializzazione in<br />
Malattie Apparato Respiratorio; Università di Pavia<br />
La ventilazione meccanica; Medicina e Chirurgia;<br />
Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato<br />
Respiratorio; Università di Catania<br />
Riabilitazione respiratoria; Diploma Universitario<br />
per Terapisti Occupazionali; Scuola di Specializzazione<br />
in Terapia Occupazionale; Università<br />
di Pavia<br />
NAVARRA ANTONELLA<br />
Tecniche microbiologiche; Microbiologia clinica;<br />
Scuola di Specializzazione in Microbiologia e<br />
Virologia; Università di Pavia<br />
Analisi e diagnostica microbiologica e virologica;<br />
Microbiologia clinica; Scuola di Specializzazione<br />
in Microbiologia e Virologia; Università di<br />
Pavia<br />
NERI MARGHERITA<br />
Autogestione e rieducazione respiratoria delle<br />
sindromi da ostruzione bronchiale; Fisiologia<br />
umana; Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato<br />
Respiratorio; Università di Pavia<br />
Intervento riabilitativo nella patologia professionale;<br />
Medicina del Lavoro III; Scuola di Specia-<br />
lizzazione in Medicina del Lavoro I; Università di<br />
Pavia<br />
NOLANO MARIA<br />
Corso Integrato di tecniche di esplorazione del<br />
sistema nervoso autonomico; Corso di Laurea per<br />
Tecnico di Neurofisiopatologia; Università di Napoli<br />
“Federico II”<br />
NUZZACO ALDA<br />
Medicina del Lavoro - MED/44; Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
Geriatria - MED/09; Corso di Laurea in Fisioterapia<br />
- III Anno di Corso; Università di Bari, Sede<br />
della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
PANIGAZZI MONICA<br />
Valutazioni funzionali in Terapia Occupazionale.;<br />
Terapia Occupazionale; Corso di Laurea in<br />
Terapista Occupazionale; Università di Pavia<br />
PAPPONE NICOLA<br />
Medicina Fisica e Riabilitazione; Scuola di<br />
Specializzazione in Reumatologia (III Anno); Università<br />
degli studi di Napoli “Federico II”; Università<br />
degli studi di Napoli “Seconda Università”;<br />
Scuola di Specializzazione in Reumatologia; Università<br />
degli Studi di Napoli “Federico II”; Università<br />
degli Studi di Napoli “Seconda Università”<br />
PARISI GIANPAOLO<br />
Diritto del Lavoro - IUS/07; Corso di Laurea in<br />
Fisioterapia - III Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Istituzioni di Diritto Pubblico - IUS/09; Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di<br />
Cassano Murge<br />
PASSANTINO ANDREA<br />
Fisiologia I - BIO/09 (modulo c); Corso di<br />
Laurea in Fisioterapia - I Anno di Corso; Università<br />
di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
Statistica; Corso di Laurea in Fisioterapia - I<br />
Anno di Corso; Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
PASSERINO COSTANTINO<br />
Organizzazione dei Servizi di Medicina e Igiene<br />
del Lavoro; Corso integrativo di Economia Aziendale<br />
ed Economia Sanitaria; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro II; Università di Pavia<br />
Organizzazione dei Servizi di Medicina e Igiene<br />
del Lavoro; Corso integrativo di Economia Sanitaria;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del<br />
Lavoro I; Università di Pavia<br />
PAVESI LORENZO<br />
Oncologia Medica; Medicina e Chirurgia;<br />
Scuola di Specializzazione in Oncologia; Università<br />
di Pavia<br />
Allergologia ed Immunologia; Medicina e Chirurgia;<br />
Scuola di Specializzazione in Allergologia<br />
ed Immunologia; Università di Pavia<br />
Diploma scienze sanitarie applicate; Medicina<br />
e Chirurgia; Università di Pavia<br />
PEDRETTI ROBERTO<br />
Come valutare un lavoro scientifico; Metodologia<br />
epidemiologica; Scuola di Specializzazione<br />
in Statistica Sanitaria; Università di Pavia<br />
Stratificazione del rischio; Diagnostica cardiologica<br />
non invasiva; Scuola di Specializzazione in<br />
Cardiologia; Università di Varese<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008
PEPE SILVANA<br />
Biologia Applicata - BIO/13; Corso di Laurea in<br />
Fisioterapia - I Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano<br />
Murge<br />
PERFETTI LUCA<br />
Ambienti indoor e allergeni; Diagnostica immunologica<br />
in vivo 2; Scuola di Specializzazione in<br />
Allergologia e Immunologia Clinica; Università di<br />
Pavia<br />
PICCININNO ANGELA<br />
Tecniche Riabilitative 5 - MED/48 (modulo a);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
PIGNATTI PATRIZIA<br />
Test diagnostici per la valutazione della immunità<br />
innata e specifica I; Diagnostica immunologica;<br />
Scuola di Specializzazione in Allergologia e<br />
Immunologia Clinica; Università di Pavia<br />
Test diagnostici per la valutazione della immunità<br />
innata e specifica II; Diagnostica immunologica;<br />
Scuola di Specializzazione in Allergologia e<br />
Immunologia Clinica; Università di Pavia<br />
Nuovi test diagnostici: dall’immunologia di<br />
base all’immunologia clinica; Diagnostica immunologica;<br />
Scuola di Specializzazione in Allergologia<br />
e Immunologia Clinica; Università di Pavia<br />
PISATI ALESSANDRO<br />
Malattie allergiche e loro principali fattori eziologici;<br />
Eziopatogenesi delle malattie allergiche ed<br />
immunologiche; Scuola di Specializzazione in Allergologia<br />
e Immunologia Clinica; Università di<br />
Pavia<br />
POGGI GUIDO<br />
Epatopatie professionali; Medicina del Lavoro;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro<br />
I; Università di Pavia<br />
RIPESI MARIA<br />
Tecniche Riabilitative 4 - MED/48 (modulo a);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
Tecniche riabilitative 3 - MED/48 (modulo c);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - II Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
Tecniche Riabilitative 5 - MED/48 (modulo c);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
SALERNO FRANCESCO GIUSEPPE<br />
Fisiologia dell’Apparato Respiratorio; Scuola di<br />
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio;<br />
Università degli Studi di Foggia<br />
SARTORIO FRANCESCO<br />
Metodologia e tecniche della riabilitazione<br />
motoria speciale; Corso di Laurea per Fisiotera-<br />
pista; Università degli Studi del Piemonte Orientale<br />
“Amedeo Avogadro”, Novara<br />
Tecniche di riabilitazione con la metodica isocinetica;<br />
Corso di Laurea per Fisioterapista; Università<br />
degli Studi del Piemonte Orientale<br />
“Amedeo Avogadro”, Novara<br />
SAVIOLA GIANANTONIO<br />
Terapia dell’artrosi; Terapia termale delle malattie<br />
reumatiche; MED/09 Medicina interna;<br />
Scuola di Specializzazione in Reumatologia; Università<br />
di Brescia<br />
SCAFA FABRIZIO<br />
La pratica della Medicina del Lavoro in azienda;<br />
Medicina del Lavoro III; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro; Università di Pavia<br />
SCAROLA ISABELLA<br />
Tecniche Riabilitative 5 - MED/48 (modulo b);<br />
Corso di Laurea in Fisioterapia - III Anno di Corso;<br />
Università di Bari, Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong><br />
di Cassano Murge<br />
SCELSI MARIO<br />
Quadri Istochimici particolari nella istopatologia<br />
delle immunopatie; Diagnostica cito-istopatologica<br />
immunologica; Scuola di Specializzazione<br />
in Allergologia ed Immunologia Clinica; Università<br />
di Pavia<br />
SCHMID MONICA<br />
Ipovisione nell’adulto: criteri di riabilitazione;<br />
Facoltà di Medicina e Chirurgia; Corso di Laurea<br />
Triennale per Ortottisti Assistenti in Oftalmologia;<br />
Università degli Studi di Pavia<br />
Terapia Occupazionale dell’Ipovisione; Facoltà<br />
di Medicina e Chirurgia; Corso di Laurea Triennale<br />
per Terapisti Occupazionali; Università degli Studi<br />
di Pavia<br />
SELLETTI LUISA<br />
Medicina generale e specialistica; Medicina<br />
dello sport Med/09; Corso di Laurea in Fisioterapia;<br />
Università di Brescia<br />
SESSAREGO PAOLO<br />
Chinesiterapia; Medicina fisica e riabilitazione;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e<br />
Riabilitazione; Università di Genova<br />
SPRINGHETTI ISABELLA<br />
Terapia Occupazionale II; Corso di Laurea<br />
Breve in Terapia Occupazionale; Università di<br />
Pavia<br />
TABARELLI DE FATIS PAOLA<br />
Informatica medica; Informatica; Scuola di Specializzazione<br />
in Radioterapia; Università di Pavia<br />
Controlli di qualità; Biofisica medica; Scuola di<br />
Specializzazione in Radiodiagnostica; Università di<br />
Pavia<br />
Controlli di qualità; Misure elettriche ed elettroniche;<br />
Corso di Laurea in Tecnico di Radiologia<br />
Medica, per Immagini e Radioterapia; Università<br />
di Pavia<br />
TEMPORELLI DANIELE<br />
Organizzazione e gestione delle risorse umane<br />
in medicina riabilitativa; Corso di Laurea in Fisioterapia;<br />
Università di Novara, Piemonte Orientale<br />
“A. Avogadro”<br />
Tecniche riabilitative cardiorespiratorie; Corso<br />
di Laurea in Fisioterapia; Università di Novara,<br />
Piemonte Orientale “A. Avogadro”<br />
TRAVERSI EGIDIO<br />
Cardiologia riabilitativa in terapia occupazionale;<br />
Laurea breve in terapia occupazionale; Università<br />
di Pavia<br />
VERCELLI STEFANO<br />
Metodologia della ricerca e consultazione<br />
banche dati; Corso di Laurea per Fisioterapista;<br />
Università degli Studi del Piemonte Orientale<br />
“Amedeo Avogadro”, Novara<br />
VILLA GIUSEPPE<br />
Problemi clinici e riabilitativi del paziente in<br />
trattamento emodialitico; Chirurgia d’urgenza;<br />
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro;<br />
Università di Pavia<br />
Tossici e impegno renale; Patologia clinica e<br />
monitoraggio biologico; Scuola di Specializzazione<br />
in Medicina del Lavoro II; Università di Pavia<br />
VILLANI LAURA<br />
Diagnostica cito e istopatologica dei tumori del<br />
grosso intestino; Area di laboratorio e diagnostica<br />
oncologica (Anatomia Patologica I); Scuola di<br />
Specializzazione in Oncologia; Università di Pavia<br />
VIOLANTE ELENA<br />
Patologia Generale - MED/04; Corso di Laurea<br />
in Fisioterapia - II Anno di Corso; Università di Bari,<br />
Sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Maugeri</strong> di Cassano Murge<br />
VITALE DINO FRANCO<br />
Medicina Fisica e Riabilitazione; Scuola di<br />
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia; Università<br />
degli Studi di Napoli “Federico II”<br />
Statistica Medica; Corso di Laurea in Scienze<br />
della Nutrizione Umana; Università degli Studi di<br />
Napoli “Federico II”<br />
VITTADINI GIOVANNI<br />
Tossicodipendenze in ambito lavorativo; Psicologia<br />
del lavoro; Scuola di Specializzazione in Medicina<br />
del Lavoro I; Università di Pavia<br />
ZANINI ANDREA<br />
Metodiche immunoistochimiche in patologia<br />
polmonare; Scuola di Specializzazione in Malattie<br />
dell’Apparato Respiratorio; Università degli Studi<br />
di Parma<br />
ZOTTI ANNA MARIA<br />
Intervento psicosociale; Scuola di Perfezionamento<br />
in Riabilitazione Cardiologica; Università<br />
Federico II, Napoli<br />
Valutazione psicodiagnostica; Corso di Perfezionamento<br />
in Psicogeriatria; Università degli<br />
Studi di Torino<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008 189<br />
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE<br />
190<br />
Totale<br />
pubblicazioni<br />
728<br />
FJLSKFJSL KDJF<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJF<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJFL<br />
FJLSKFJSL KDJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Pubblicazioni in Riviste<br />
non recensite<br />
38<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Consuntivo dell’Attività Scientifica 2007<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Comunicazioni Scientifiche pubblicate<br />
su riviste non recensite<br />
12<br />
Libri<br />
in italiano<br />
5<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Pubblicazioni in Riviste<br />
recensite su Science Citation<br />
Index/Index Medicus<br />
318 (I.F. 1332)<br />
Libri in lingua<br />
inglese<br />
3<br />
Comunicazioni Scientifiche pubblicate<br />
su atti congressuali<br />
178<br />
ABCDEF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
ABCDEF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Capitoli di libri<br />
in italiano<br />
13<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Comunicazioni scientifiche<br />
su riviste recensite Science<br />
Citation Index/Index Medicus<br />
107<br />
ABCDEF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Poster / Videotape<br />
19<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DKJF<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
ABCDEF<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLS FJLSKFJSL KDJFLSJFD<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJFD DK<br />
FJLSKFJSL KDJFLSJF<br />
Capitoli di libri in<br />
lingua inglese<br />
13<br />
<strong>Fondazione</strong> <strong>Salvatore</strong> <strong>Maugeri</strong> 2007-2008