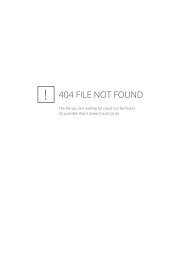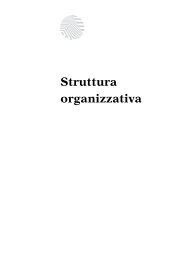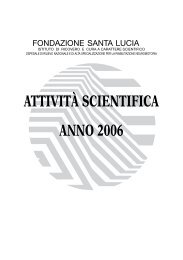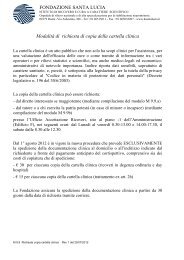23-Linea C-neuroscie.. - Fondazione Santa Lucia
23-Linea C-neuroscie.. - Fondazione Santa Lucia
23-Linea C-neuroscie.. - Fondazione Santa Lucia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C–NEUROSCIENZE SPERIMENTALI<br />
GIORGIO BERNARDI<br />
Università di Roma Tor Vergata – <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
C.1 –PLASTICITÀ DELLE CONNESSIONI NEURONALI IN RAPPORTO<br />
ALL’APPRENDIMENTO E ALLA MEMORIA IN CONDIZIONI FISIOPATOLOGICHE<br />
C.1.1 – Analisi comportamentale degli effetti di farmaci attivi sul sistema<br />
colinergico in presenza di danno colinergico del proencefalo basale<br />
(Laura Mandolesi)<br />
C.1.2 – Analisi stereo-morfologica di neuroni neocorticali in presenza<br />
di deplezione colinergica e trattamento con farmaci attivi sul sistema<br />
colinergico (Laura Petrosini)<br />
C.1.3 – Implicazione della trasmissione catecolaminergica mesolimbica<br />
e mesocorticale nei disturbi cognitivi di origine genetica ed ambientale<br />
(Stefano Puglisi-Allegra)<br />
C.2 –STUDIO MULTIDISCIPLINARE DEI MECCANISMI CELLULARI E MOLECOLARI<br />
ALLA BASE DI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE<br />
C.2.1 – Meccanismo di neurodegenerazione nell’atrofia muscolare spinale<br />
ed altre malattie (Tilmann Achsel)<br />
C.2.2 – Alterazioni della morfologia corticale e spinale e modificazioni<br />
delle funzioni cognitive e motorie nel topo G93A, un modello murino<br />
della sclerosi laterale amiotrofica (Martine Ammassari-Teule)<br />
C.2.3 – Basi molecolari e cellulari della sindrome dell’X fragile (Claudia Bagni)<br />
C.2.4 – Analisi del ruolo della chinasi mutata nell’Atassia Telangiectasia<br />
(ATM) nella morte cellulare programmata, nella neurodegenerazione<br />
e nel controllo della stabilità delle proteine (Daniela Barilà)<br />
C.2.5 – Alterazioni funzionali nella attività elettrica dei neuroni<br />
dopaminergici della sostanza nera pars compacta: ruolo delle<br />
afferenze sinaptiche estrinseche (Nicola Berretta)<br />
C.2.6 – Ruolo delle Scaffolding Proteins e del recettore NMDA<br />
nella plasticità sinaptica corticostriatale in modelli sperimentali<br />
di malattie neurodegenerative (Paolo Calabresi)<br />
C.2.7 – Studio delle alterazioni indotte dalle Cu,Zn superossido dismutasi<br />
mutanti associate alla sclerosi laterale amiotrofica di tipo familiare<br />
(Maria Teresa Carrì)<br />
C.2.8 – Analisi dello stress e della morte cellulare nella malattia di Alzheimer<br />
in modelli animali e cellulari di nuova concezione (Francesco Cecconi)<br />
C.2.9 – Strategie terapeutiche per la Corea di Huntington. Il ruolo<br />
di c-AMP-responsive element (CREB) (Francesca R. Fusco)<br />
C.2.10 – Recettori metabotropici e ionotropici del glutammato:<br />
risposte neuronali e canali transienti (TRP) (Ezia Guatteo)<br />
C.2.11 – Ruolo della tossicità da glutammato in un modello sperimentale<br />
di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) (Patrizia Longone)<br />
C.2.12 – Modulazione della trasmissione GABAergica mediata dalle amine<br />
in traccia in neuroni dopaminergici del mesencefalo ventrale<br />
(Nicola Biagio Mercuri)<br />
C.2.13 – Modulazione GABAergica e dopaminergica dell’eccitabilità<br />
dei neuroni dopaminergici in colture organotipiche di mesencefalo<br />
di topo (Nicola Biagio Mercuri)<br />
C.2.14 – Caratterizzazione di “ marcatori di danno ” in modelli sperimentali<br />
neurodegenerativi e di danno assonale (Marco Molinari)<br />
C.2.15 – Alterazioni patologiche della plasticità sinaptica nello striato<br />
come modello di patologie neurodegenerative (Antonio Pisani)<br />
402 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
C.2.16 – Alterazioni di Fosfodiesterasi specifiche nei neuroni striatali<br />
in un modello di parkinsonismo sperimentale nel ratto<br />
(Giuseppe Sancesario)<br />
C.2.17 – Analisi della regolazione post-trascrizionale della espressione genica<br />
nel differenziamento neuronale (Claudio Sette)<br />
C.2.18 – Attualità della trasmissione neurotensinergica nel modello<br />
di parkinsonismo da 6-OHDA: immunochimica ed elettrofisiologia<br />
in vivo tra animali denervati e denervati con discinesie<br />
(Alessandro Stefani)<br />
C.2.19 – Investigazioni di Proteomica e Metabonomica nelle sindromi<br />
neurodegenerative (Andrea Urbani)<br />
C.2.20 – Patologie neurodegenerative e recettori purinergici (Cinzia Volonté)<br />
C.3 –STUDIO MULTIDISCIPLINARE DELL’IMMUNOPATOGENESI<br />
DELLA SCLEROSI MULTIPLA<br />
C.3.1 – Studio delle caratteristiche fenotipiche e funzionali dei linfociti T<br />
regolatori nella Sclerosi Multipla (Luca Battistini)<br />
C.3.2 – Studio dell’attività neuronale e sinaptica in topi con encefalite allergica<br />
sperimentale, modello animale di Sclerosi Multipla (Diego Centonze)<br />
C.3.3 – Studi di epidemiologia molecolare, caratterizzazione genotipo-fenotipo<br />
ed identificazione di nuovi loci e geni malattia nelle malattie<br />
neurologiche (Antonio Orlacchio)<br />
2007 403
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
C.1 –PLASTICITÀ DELLE CONNESSIONI NEURONALI IN RAPPORTO<br />
ALL’APPRENDIMENTO E ALLA MEMORIA IN CONDIZIONI FISIOPATOLOGICHE<br />
C.1.1 – Analisi comportamentale degli effetti di farmaci attivi<br />
sul sistema colinergico in presenza di danno colinergico<br />
del proencefalo basale (Laura Mandolesi)<br />
Anno d’inizio: 2007<br />
Durata: 12 mesi<br />
Parole chiave: Sistema colinergico; Donepezil; Ratto.<br />
Altri Enti coinvolti: Università di Roma La Sapienza; Università di Napoli<br />
Parthenope.<br />
Descrizione<br />
La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un progressivo declino nelle<br />
funzioni cognitive, che include anche la perdita di memoria. Si pensa che<br />
l’ipofunzione colinergica sia una componente della malattia e molte evidenze<br />
cliniche e sperimentali supportano la nozione che una perdita della funzione<br />
colinergica contribuisca ai deficit cognitivi che caratterizzano tale malattia. Su<br />
questa base è stato proposto un iniziale approccio terapeutico che consiste nell’aumento<br />
farmacologico della funzione colinergica. La più efficace di tali strategie<br />
è l’aumento di ACh che si ottiene riducendone la degradazione da parte della<br />
acetilcolinesterasi. Tale azione può essere effettuata dal Donepezil, un antagonista<br />
della acetilcolinesterasi. Nonostante venga usato nel trattamento di pazienti<br />
con malattia di Alzheimer o con mild cognitive impairment, la valutazione degli<br />
effetti del trattamento cronico con Donepezil è quasi del tutto mancante nella<br />
letteratura sperimentale. Fra i vari tentativi di riprodurre la demenza tipo<br />
Alzheimer in modelli animali, uno dei più fruttuosi è quello in cui viene prodotta<br />
una ipofunzione colinergica attraverso la manipolazione sperimentale dei nuclei<br />
del proencefalo basale. In particolare, si può ottenere una selettiva lesione dei<br />
neuroni colinergici del proencefalo basale attraverso l’uso della immunotossina<br />
192-IgG saporina che blocca la sintesi proteica nei neuroni colinergici. Le iniezioni<br />
intraventricolari di tale tossina provocano lesioni del sistema proencefalico<br />
basale, rendendo il modello di deplezione colinergica particolarmente adatto per<br />
lo studio degli effetti dell’assenza della proiezione colinergica alla neocortex.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Il progetto di ricerca, concluso nel 2006, dal titolo “ Analisi delle strategie di<br />
foraging in presenza di lesione cerebellare ” ha evidenziato un’alterazione nelle<br />
abilità di esplorazione spaziale da parte degli animali con lesione cerebellare.<br />
Attività previste<br />
Nel presente progetto di ricerca ci si propone di analizzare gli effetti comportamentali<br />
del trattamento con Donepezil in presenza di deplezione coliner-<br />
404 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
gica del proencefalo basale. La batteria di test effettuati dopo il recupero postoperatorio<br />
permetterà di valutare diversi aspetti dei processi mnesici a breve e<br />
a lungo termine.<br />
Metodologia<br />
Saranno usati ratti Wistar che a 3 mesi di età riceveranno iniezioni intraventricolari<br />
bilaterali di tossina coniugata 192 IgG-saporina. Metà di tali animali<br />
riceveranno quotidianamente iniezioni i.p. di 0.5 mg/kg di Donepezil 1<br />
settimana prima e 2 settimane dopo la lesione colinergica. Un uguale numero<br />
di animali integri subirà o meno lo stesso trattamento farmacologico. In questo<br />
modo si otterranno quattro gruppi sperimentali, due trattati e due in condizioni<br />
standard, due con deplezione colinergica e due integri.<br />
Dopo 15 giorni di recupero post-operatorio, gli animali dei vari gruppi<br />
saranno sottoposti alla batteria di test comportamentali tesi ad evidenziare la<br />
comparsa di deficit mnesici spaziali precoci. Fra i test scelti, il labirinto radiale<br />
(con due protocolli sperimentali, di scelta libera e di scelta forzata, che permetteranno<br />
di distinguere le competenze procedurali dalle abilità di working<br />
memory spaziale), il labirinto ad acqua di Morris (che permetterà di studiare<br />
sia gli aspetti procedurali che quelli localizzatori della funzione spaziale, analizzandone<br />
le componenti a lungo termine), un labirinto sequenziale (che permetterà<br />
di analizzare l’apprendimento e la memorizzazione di sequenze spaziali,<br />
funzioni prevalentemente legate alle circuitazioni corticali pre-frontali,<br />
particolarmente influenzate dal danno al sistema colinergico proencefalico),<br />
ed infine l’open field (che permetterà di analizzare la costruzione della mappa<br />
spaziale). Alla fine della testatura comportamentale, gli animali saranno sacrificati.<br />
I cervelli saranno sottoposti ad analisi immuno- ed isto-chimiche del<br />
sistema colinergico, per verificare la presenza e la consistenza del danno colinergico<br />
proencefalico.<br />
C.1.2 – Analisi stereo-morfologica di neuroni neocorticali in presenza<br />
di deplezione colinergica e trattamento con farmaci attivi<br />
sul sistema colinergico (Laura Petrosini)<br />
Parole chiave: Sistema colinergico; Donepezil; Ratto.<br />
Altri Enti coinvolti: Università degli Studi di Roma La Sapienza.<br />
Descrizione<br />
La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un progressivo declino nelle funzioni<br />
cognitive, che include anche la perdita di memoria. Si pensa che<br />
l’ipofunzione colinergica sia una componente della malattia e molte evidenze<br />
cliniche e sperimentali supportano la nozione che una perdita della funzione colinergica<br />
contribuisca ai deficit cognitivi che caratterizzano tale malattia. Su<br />
questa base è stato proposto un iniziale approccio terapeutico che consiste nell’aumento<br />
farmacologico della funzione colinergica. La più efficace di tali strategie<br />
è l’aumento di ACh che si ottiene riducendone la degradazione da parte della<br />
2007 405
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
acetilcolinesterasi. Tale azione può essere effettuata dal Donepezil, un antagonista<br />
della acetilcolinesterasi. Nonostante venga usato nel trattamento di pazienti<br />
con malattia di Alzheimer o con mild cognitive impairment, la valutazione degli<br />
effetti del trattamento cronico con Donepezil è quasi del tutto mancante nella letteratura<br />
sperimentale. Fra i vari tentativi di riprodurre la demenza tipo Alzheimer<br />
in modelli animali, uno dei più fruttuosi è quello in cui viene prodotta una ipofunzione<br />
colinergica attraverso la manipolazione sperimentale dei nuclei del<br />
proencefalo basale. In particolare, si può ottenere una selettiva lesione dei neuroni<br />
colinergici del proencefalo basale attraverso l’uso della immunotossina 192-<br />
IgG saporina che blocca la sintesi proteica nei neuroni colinergici. Le iniezioni<br />
intraventricolari di tale tossina provocano lesioni del sistema proencefalico<br />
basale, rendendo il modello di deplezione colinergica particolarmente adatto per<br />
lo studio degli effetti dell’assenza della proiezione colinergica alla neocortex.<br />
Nel presente progetto di ricerca ci si propone di analizzare se il trattamento<br />
con Donepezil sia in grado di modificare la struttura dei neuroni piramidali<br />
della corteccia parietale in presenza di deplezione colinergica del<br />
proencefalo basale. In particolare, dato l’interessamento dei diversi strati corticali<br />
in circuiti diversi di afferenze ed efferenze con altre strutture corticali e<br />
sottocorticali, ci si propone di analizzare i neuroni piramidali del III e del V<br />
strato della corteccia parietale. Considerata inoltre la specificità della funzionalità<br />
recettiva dell’arborizzazione apicale e basale nei neuroni piramidali,<br />
l’analisi sarà tesa ad indagare le eventuali difformità fra i cambiamenti intervenuti<br />
nelle due porzioni della ramificazione dendritica.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nel presente progetto di ricerca ci si è proposti di analizzare come le condizioni<br />
di allevamento (standard o arricchito) siano in grado di modificare la<br />
struttura dei neuroni piramidali del III strato della corteccia parietale in presenza<br />
di deplezione colinergica del proencefalo basale. Si può ottenere una<br />
selettiva lesione dei neuroni colinergici del proencefalo basale attraverso iniezioni<br />
intraparenchimali della immunotossina 192-IgG saporina che è in grado<br />
di bloccare la sintesi proteica nei neuroni colinergici. A tal scopo sono stati<br />
analizzati parametri quali il numero e la densità delle spine dendritiche sull’arborizzazione<br />
dendritica, l’estensione complessiva dell’arborizzazione; il<br />
numero totale dei nodi dendritici.<br />
I risultati di tali analisi hanno evidenziato una chiara risposta neuronale<br />
alla deplezione colinergica del proencefalo basale. Il numero delle spine dendritiche<br />
era infatti significativamente aumentato in presenza di danno colinergico<br />
del proencefalo basale nei neuroni piramidali degli animali lesi allevati in<br />
condizioni standard ma anche degli animali lesi allevati in ambiente arricchito<br />
che peraltro partivano da valori significativamente più alti. Tale incremento sia<br />
del numero totale sia della densità delle spine si accompagnava ad una riduzione<br />
dell’albero dendritico. L’arborizzazione dei dendriti apicali e basali<br />
infatti si riduceva significativamente in presenza di lesione colinergica. Tali<br />
indicazioni dimostrano una differenziata reazione dell’encefalo in risposta al<br />
danno colinergico a carico delle diverse componenti neuronali.<br />
406 2007
Attività previste<br />
Neuroscienze sperimentali<br />
Saranno usati ratti Wistar che a 3 mesi di età riceveranno iniezioni intraventricolari<br />
bilaterali di 192 IgG saporina. Metà di tali animali riceveranno<br />
quotidianamente iniezioni i.p. di 0.5 mg/kg di Donepezil 1 settimana prima e<br />
2 settimane dopo la lesione colinergica. Un uguale numero di animali integri<br />
subirà o meno lo stesso trattamento farmacologico. In questo modo si otterranno<br />
quattro gruppi sperimentali, due trattati e due in condizioni standard,<br />
due con deplezione colinergica e due integri.<br />
Alla fine del periodo di testatura comportamentale, per ottenere una colorazione<br />
neuronale tipo Golgi, gli animali saranno anestetizzati e riceveranno<br />
iniezioni parietali di una soluzione di tracciante retrogrado BDA e di un agonista<br />
dei recettori glutammatergici NMDA. Dopo 96 ore, gli animali anestetizzati<br />
saranno sacrificati mediante perfusione transcardiaca di una soluzione di<br />
fissaggio. Una volta prelevati, i cervelli saranno conservati per 24 ore in sucrosio,<br />
e poi tagliati al microtomo congelatore in sezioni dello spessore di 50<br />
micron. I neuroni marcati con BDA saranno evidenziati usando il complesso<br />
avidina-biotina e analizzati alla Neurolucida. In particolare saranno analizzati<br />
i neuroni piramidali del terzo e del quinto strato in cui si prenderanno in considerazione<br />
cinque parametri: il numero delle spine dendritiche; la densità<br />
delle stesse sull’arborizzazione dendritica; l’estensione complessiva dell’arborizzazione;<br />
il numero totale delle ramificazioni, dato dalla somma dei nodi<br />
dendritici; il numero delle intersezioni dei dendriti con una serie di anelli concentrici,<br />
posti ad intervalli di 10 micron a partire dal centro del corpo cellulare.<br />
Tali parametri sono ritenuti indici di sinaptogenesi, fenomeno plastico di<br />
fondamentale importanza nel SNC.<br />
C.1.3 – Implicazione della trasmissione catecolaminergica mesolimbica<br />
e mesocorticale nei disturbi cognitivi di origine genetica<br />
ed ambientale (Stefano Puglisi-Allegra)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Corteccia prefrontale; Sistema mesolimbico; Dopamina;<br />
Noradrenalina; Neuroplasticità; Emozione; Motivazione; Attenzione; Stress;<br />
Genotipo.<br />
Altri Enti coinvolti: Dipartimento di Psicologia e Centro “ Daniel Bovet ”,<br />
Università di Roma La Sapienza.<br />
Descrizione<br />
Lo studio tratta del ruolo della trasmissione noradrenergica prefrontale e<br />
della regolazione su quella dopaminergica meso-accumbens nella ricomparsa<br />
della preferenza condizionata ad un ambiente precedentemente appaiato a<br />
sostanze d’abuso. A questo scopo sarà usato il test del “ reinstatement ” per<br />
verificare se la deafferentazione selettiva delle proiezioni noradrenergiche alla<br />
corteccia prefrontale mediale, effettuata dopo l’acquisizione di una preferenza<br />
2007 407
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
spaziale condizionata in topi del ceppo C57BL/6J e l’estinzione della stessa,<br />
impedisce il recupero, indotto da uno stressor (“ foot-shock ”) o dall’ampiamento<br />
di “ cues ” ambientali associati all’ambiente in cui viene somministrata<br />
la sostanza.<br />
Sarà inoltre studiato il ruolo della trasmissione catecolaminergica corticosottocorticale<br />
nell’acquisizione di una preferenza spaziale condizionata in<br />
presenza di sostanze naturali (ad es. cibo) o di sostanze note per la loro capacità<br />
di indurre delle reazioni avversive (ad es. ClLi, o stressor inevitabili) allo<br />
scopo di verificare se i circuiti fronto-cortico-limbici sono implicati in<br />
maniera simile nell’attribuzione di motivazione incentivante positiva o negativa.<br />
Un’attenzione specifica sarà rivolta allo studio degli effetti di uno stress<br />
inevitabile sulla risposta catecolaminergica nella corteccia prefrontale e della<br />
sua regolazione della risposta dopaminergica in aree mesolimbiche come il<br />
nucleus accumbens, un’area che ricopre un ruolo fondamentale nell’apprendimento<br />
e nell’attribuzione di motivazione incentivante.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Lo scorso anno abbiamo studiato il ruolo della trasmissione catecolaminergica<br />
cortico-sottocorticale nell’acquisizione di una preferenza spaziale condizionata<br />
in presenza di sostanze naturali (cibo) o di sostanze note per la loro<br />
capacità di indurre delle reazioni avversive (ad es. ClLi, o stressor inevitabili).<br />
I risultati hanno mostrato che il sistema costituito dalla noradrenalina in corteccia<br />
prefrontale mediale e dalla dopamina nel nucleus accumbens è implicato<br />
nell’attribuzione di salienza motivazionale collegata sia a stimoli positivi<br />
che negativi.<br />
Abbiamo, inoltre, dimostrato che la risposta bifasica ad uno stress inevitabile<br />
da parte del sistema mesolimbico dopaminergico (attivazione della<br />
liberazione di dopamina nel nucleo accumbens seguita da una inibizione) è<br />
regolata dall’azione complementare della liberazione di noradrenalina e di<br />
dopamina nella corteccia prefrontale mediale che determinano rispettivamente<br />
l’attivazione e l’inibizione della liberazione di dopamina nel nucleus<br />
accumbens.<br />
Attività previste<br />
Nel corso del 2007 sarà proseguito lo studio della trasmissione catecolaminergica<br />
cortico-sottocorticale nell’acquisizione di una preferenza spaziale<br />
condizionata in presenza di cibo di diversa appetibilità e di stimoli avversivi<br />
(stressor inevitabili) di diverse intensità allo scopo di verificare se i circuiti<br />
fronto-cortico-limbici sono implicati in maniera simile nell’attribuzione di<br />
motivazione incentivante positiva o negativa in rapporto alla salienza degli<br />
stimoli primari.<br />
Un’attenzione specifica sarà rivolta allo studio degli effetti di uno stress<br />
inevitabile sulla risposta catecolaminergica nella corteccia prefrontale e della<br />
sua regolazione della risposta dopaminergica in aree mesolimbiche come il<br />
nucleus accumbens, un’area che ricopre un ruolo fondamentale nell’apprendimento<br />
e nell’attribuzione di motivazione incentivante.<br />
408 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
Sarà valutato il ruolo delle catecolamine corticali nella valutazione dell’evento<br />
stressante e sulla motivazione diretta alla gestione dello stress, con<br />
particolare attenzione alla controllabilià ed alla prevedibilità dell’evento stressante<br />
(attraverso il metodo del c.d. “ yoked vs avoider ”). Questi studi sono<br />
rivolti alla comprensione del ruolo del sistema mesocorticolimbico catecolaminergico<br />
nella motivazione incentivante ed avversiva acquisita.<br />
2007 409
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
C.2 –STUDIO MULTIDISCIPLINARE DEI MECCANISMI CELLULARI<br />
E MOLECOLARI ALLA BASE DI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE<br />
C.2.1 – Meccanismo di neurodegenerazione nell’atrofia muscolare<br />
spinale ed altre malattie (Tilmann Achsel)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Atrofia spinale muscolare; Sclerosi laterale amiotrofica; Processamento<br />
dei RNA messaggeri; Splicing alternativo.<br />
Descrizione<br />
L’atrofia muscolare spinale (ASM) è una malattia che è causata da una<br />
diminuzione della proteina SMN, un fattore coinvolto nello splicing. Nonostante<br />
la sua presenza ubiquitaria, ci sono indicazioni che i neuroni siano più<br />
suscettibili alla mancanza di SMN a causa di un suo secondo ruolo. Noi guarderemo<br />
in particolare le proteine LSm1-7, che interagiscono con SMN in vitro.<br />
Queste proteine formano un complesso che ha un ruolo, in tutte le cellule<br />
somatiche, nella regolazione della traduzione. In precedenza, abbiamo osservato<br />
che la proteina LSm1 è molto presente nei prolungamenti di neuroni. Ci<br />
proponiamo adesso di approfondire quale sia il ruolo di LSm1 nella regolazione<br />
della traduzione neuronale, e quale sia l’influenza di una mancanza della<br />
proteina SMN su localizzazione e funzione delle proteine LSm.<br />
In un secondo programma di ricerca, abbiamo studiato alterazioni di<br />
splicing dei messaggeri in un modello cellulare della sclerosi laterale amiotrofica<br />
(SLA). Queste alterazioni toccano una gran parte delle mRNA, e possono<br />
così contribuire significativamente alla destabilizzazione dei neuroni (vedi<br />
sotto). Vogliamo adesso stabilire la causa di queste alterazioni dello splicing.<br />
In più, la degradazione dei motoneuroni progredisce in modo simile in SLA e<br />
ASM, e la proteina SMN, proteina causativa della ASM, ha un ruolo nello splicing.<br />
Perciò, vogliamo studiare se un difetto simile allo splicing si manifesta<br />
pure in cellule modello di ASM.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Abbiamo stabilito che il complesso delle proteine LSm1-LSm7, bersaglio<br />
della proteina SMN, che è colpita nella ASM, si associa con RNA messaggeri<br />
nei dendriti. La composizione proteica di questi complessi fornisce importanti<br />
informazioni sia su come gli RNA messaggeri vengano selezionati per il<br />
trasporto nei dendriti, sia su come siano attivati quando una stimulazione<br />
ripetitiva di una sinapsi richiede una sintesi proteica localizzata in tale<br />
regione. Questo è il primo complesso nei neuroni con una funzione specifica<br />
che può legare SMN; ora intendiamo quindi studiare il ruolo di SMN per<br />
l’assemblaggio e la funzione di questo complesso di RNA messaggero.<br />
Nel secondo programma di ricerca abbiamo dimostrato che un danno<br />
mitocondriale, precisamente l’abbassamento di ATP che risulta in seguito ad<br />
410 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
esso, provoca un cambiamento di splicing alternativo in linee cellulari di<br />
origine neuronale. L’effetto riguarda probabilmente tutti gli RNA messaggeri<br />
che subiscono splicing alternativo ed è perciò capace di cambiare molti<br />
equilibri fisiologici di isoforme – fino a 30% dei geni umani esprimono più<br />
di una isoforma. Visto che il danno mitocondriale è importante nella patogenesi<br />
di varie malattie neurodegenerative, fra le quali la SLA, e visto che<br />
tale cambiamento di splicing non è osservato in linee cellulari non-neuronali,<br />
è possibile che questo meccanismo dia un contributo importante per la<br />
patogenesi di tali malattie. Vogliamo adesso dimostrare se cambiamenti<br />
simili avvengano pure in modelli murini della SLA, e chiarire la cascata di<br />
trasduzione del messaggio dall’abbassamento di ATP fino al macchinario<br />
dello splicing.<br />
Attività previste<br />
• Analisi del complesso LSm1-mRNP in cellule primarie neuronali silenziate<br />
per SMN.<br />
• Analisi dello splicing alternativo in topi SOD G93A, modello murino<br />
della SLA, in vari tessuti del SNC ed in vari stadi della malattia, per vedere<br />
se il cambiamento è specifico per il tessuto colpito dalla malattia, cioè il<br />
midollo spinale, e se si osserva un cambiamento già in stadi pre-sintomatici,<br />
o solo come una conseguenza della degenerazione.<br />
• Analisi di varie cascate di chinasi per individuarne quella che trasmette<br />
il segnale del danno mitocondriale al macchinario dello splicing. Tale cascata<br />
di chinasi sarà un potenziale bersaglio per una strategia farmaceutica mirata<br />
a rallentare il progresso della malattia.<br />
C.2.2 –Alterazioni della morfologia corticale e spinale e modificazioni<br />
delle funzioni cognitive e motorie nel topo G93A, un modello<br />
murino della sclerosi laterale amiotrofica (Martine Teule-Ammassari)<br />
Anno d’inizio: 2005<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sclerosi Laterale Amiotrofica; Neurodegenerazione.<br />
Descrizione<br />
I sistemi di memoria, intesi come operazioni mnesiche specifiche a carico<br />
di circuiti anatomici circoscritti, sono stati a lungo considerati come delle<br />
unità funzionali indipendenti. Più recentemente, è stato osservato che i sistemi<br />
di memoria possono essere considerati come delle unità funzionali interattive<br />
poiché lesioni a carico di un sistema non solo lasciano inalterate operazioni<br />
dipendenti da un altro sistema ma possono anche incrementarle. Abbiamo<br />
quindi ipotizzato che l’analisi delle capacità di memoria e apprendimento<br />
residue o paradossalmente migliorate in pazienti o modelli animali di disfunzione<br />
cognitiva poteva fornire dei marcatori precoci della patologia. In quest’ambito<br />
abbiamo dimostrato che il topo Tg2576, considerato come un<br />
2007 411
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
modello animale della malattia di Alzheimer in quanto sovra-esprime la proteina<br />
mutata APP (swedish mutation), mostra alterazioni cognitive specificamente<br />
riconducibili ad una disfunzione ippocampica ma realizza, tuttavia,<br />
delle prestazioni superiori a quelle registrate negli animali wild-type in compiti<br />
striato-dipendenti. Intendiamo estendere l’analisi dell’interazione fra<br />
sistemi di memoria a patologie neurodegenerative quali la sclerosi laterale<br />
amiotrofica (utilizzando il topo G93A+/+) che sembra determinare un’alterazione<br />
delle funzioni esecutive legate alla corteccia frontale mentre operazioni<br />
ippocampo-dipendenti (memoria spaziale, condizionamento al contesto) sono<br />
paradossalmente migliorate.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Sebbene i deficit motori e la neurodegenerazione dei motoneuroni spinali<br />
del topo G93A, un modello murino della forma sclerosi laterale amiotrofica,<br />
siano stati ampiamente descritti, esistono poche evidenze relative al loro<br />
profilo cognitivo e alla neurodegenerazione dei motoneuroni corticali. Dati<br />
recenti della letteratura rivelano un interesse crescente per i fenomeni di<br />
neurodegenerazione in varie aree del sistema nervoso centrale e, in particolare,<br />
per le loro modalità di sviluppo dalla fase pre-sintomatica alla fase sintomatica.<br />
Questo interesse è largamente dovuto al fatto che i pazienti SLA<br />
mostrano disturbi cognitivi specifici a carico delle funzioni esecutive, funzioni<br />
mediate da aree corticali prefrontali (infra-limbica e pre-limbica:<br />
IL/PL) molto vicine all’area motoria (M1).<br />
Il nostro progetto è quello di effettuare uno studio longitudinale delle<br />
funzioni esecutive e della morfologia di neuroni cortico-frontali nel topo<br />
G93A e di condurre, in parallelo, un’analisi della morfologia dei neuroni spinali<br />
allo scopo di evidenziare il sito primario di neurodegenerazione. Per<br />
quanto riguarda le funzioni esecutive, ci siamo interessati ad un indice di<br />
flessibilità comportamentale quale la resistenza all’estinzione di un riflesso<br />
di paura (fear conditioning extinction). Per quanto riguarda la neuromorfologia,<br />
abbiamo analizzato la struttura fine dei neuroni piramidali nelle aree<br />
IL/PL e nella area M1 mediante impregnazione di Golgi. Questi studi sono<br />
stati effettuati nell’animale adulto pre-sintomatico (3 mesi).<br />
I nostri dati hanno evidenziato una perseverazione della risposta condizionata<br />
nei topi G93A insieme ad anomalie strutturali nelle aree della corteccia<br />
prefrontale esaminate. In particolare, abbiamo osservato che il topo<br />
G93A perseverava notevolmente nel manifestare una risposta di immobilità<br />
alla presenza di uno stimolo condizionato (nel nostro caso un suono neutro<br />
associato ad uno shock durante la fase di condizionamento) contrariamente<br />
al topo wild-type che estingueva rapidamente la risposta condizionata.<br />
Parallelamente, l’analisi morfologica ha rivelato l’esistenza di modificazioni<br />
strutturali precoci associate alla mutazione Cu/Zn SOD1. Queste modificazioni<br />
consistevano in una riduzione della ramificazione dei dendriti basali<br />
(branching) e nella presenza di un maggior numero di spine dendritiche<br />
immature. È interessante sottolineare che queste alterazioni sono apparse<br />
estremamente simili nelle aree IL/PL e M1 mentre non sono state riscon-<br />
412 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
trate nella corteccia visiva. Nel loro insieme i nostri dati sottolineano la presenza<br />
di alterazioni pre-sintomatiche a carico delle funzioni esecutive nei<br />
topi G93A, insieme alla presenza di anomalie strutturali in corteccia prefrontale<br />
a sostegno di una locale diminuzione di connettività nei circuiti<br />
cortico-frontali.<br />
Attività previste<br />
Stiamo attualmente lavorando al perfezionamento di tecniche di immunoistochimica<br />
per valutare lo stato di connettività e di maturazione di spine<br />
anche a livello del midollo spinale: nello specifico, l’uso di sonde molecolari<br />
come il DiA (4-Di-16-ASP (4-(4-(dihexadecylamino)styryl)-N-methylpyridinium<br />
iodide)) da applicare su campioni di tessuto trattati con anticorpi che<br />
marcano selettivamente i motoneuroni, per evidenziare e studiare facilmente<br />
le terminazioni sinaptiche e ramificazioni dendritiche neuronali sia a livello<br />
spinale che centrale. Tale metodo ci permetterà di approfondire la natura e la<br />
progressione del deficit cognitivo su più momenti temporali: svezzamento (3<br />
settimane), età adulta presintomatica (3 mesi), età adulta sintomatica (4-5<br />
mesi). Implementando gli studi comportamentali già sperimentati, intendiamo<br />
definire il “ time course ” della degenerazione, e il suo rapporto di progressione<br />
tra livello spinale e corticale.<br />
C.2.3 – Basi molecolari e cellulari della sindrome dell’X fragile<br />
(Claudia Bagni)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sindrome X Fragile; Gene FMR1; Ritardo mentale.<br />
Altri Enti coinvolti: Università Cattolica Sacro Cuore, Roma; Division<br />
of Neuroscience, University of Edinburgh, Edinburgh, UK; Wellcome Trust<br />
Sanger Institute, Hinxton, Cambridgeshire, UK.<br />
Descrizione<br />
La Sindrome dell’X Fragile è la forma più frequente di ritardo mentale<br />
ereditario legata al malfunzionamento del gene FMR1 situato sul cromosoma<br />
X. Il quadro clinico consiste in un ritardo mentale di grado variabile, da<br />
moderato a severo, e da una serie di caratteristiche fisiche quali dismorfie del<br />
volto, macro-orchidismo nei maschi e lassità dei legamenti.<br />
FMRP appartiene alla famiglia delle proteine che legano l’RNA ed è stata<br />
implicata nel controllo traduzionale alle sinapsi. Non è ancora chiaro come<br />
l’assenza di un regolatore tradizionale come FMRP possa portare ad un deficit<br />
nell’apprendimento e nella memorizzazione e quindi al ritardo mentale osservato<br />
nei pazienti affetti dalla sindrome.<br />
Poiché ad oggi sono stati isolati soltanto alcuni RNA messaggeri regolati da<br />
FMRP è di primaria importanza estendere questo studio al fine di caratterizzare<br />
il complesso ribonucleoproteico in cui FMRP esercita una azione regolativa.<br />
2007 413
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Tra gli RNA messaggeri in grado di interagire con la proteina FMRP<br />
abbiamo identificato l’mRNA codificante per la proteina PSD-95. In cellule neuronali<br />
ippocampali, in assenza di FMRP, l’mRNA per PSD-95 ha una vita media<br />
notevolmente ridotta. Questo potrebbe spiegare i fenomeni di non corretta plasticità<br />
sinaptica riscontrata nei pazienti e nel modello murino per la Sindrome.<br />
Abbiamo inoltre identificato la sequenza nucleotidica presente sul 3’UTR dell’mRNA<br />
per PSD-95 responsabile dell’interazione con FMRP e caratterizzato il<br />
dominio di FMRP responsabile di questa interazione. Infine, abbiamo dimostrato<br />
che la stabilità dell’mRNA di PSD-95 è regolato da attività sinaptica. Questi<br />
studi sono oggetto di un manoscritto spedito alla rivista Nature Neuroscience.<br />
Abbiamo inoltre caratterizzato la particella FMRP-mRNP durante lo sviluppo<br />
di cellule ippocampali e corticali e dimostrato che successivamente a<br />
stimolazione sinaptica la particella FMRP-mRNP si localizza nella regione<br />
postsinaptica per poi rilasciare, molto probabilmente, gli mRNA repressi traduzionalmente.<br />
Questi studi sono oggetto di una pubblicazione accettata su<br />
Molecular and Cellular Neuroscience.<br />
Attività previste<br />
• Caratterizzazione del complesso FMRP che regola la stabilità dell’mRNA<br />
di PSD-95.<br />
• Caratterizzazione del complesso FMRP che regola la traduzione degli<br />
mRNA alle sinapsi.<br />
C.2.4 – Analisi del ruolo della chinasi Mutata nell’Atassia Telangiectasia<br />
(ATM) nella morte cellulare programmata,<br />
nella neurodegenerazione e nel controllo<br />
della stabilità delle proteine (Daniela Barilà)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Atassia Telangiectasia, ATM; Apoptosi; p53; Recettore di<br />
morte Fas; Ubiquitinazione; Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).<br />
Descrizione<br />
L’obiettivo dei nostri studi è definire i meccanismi molecolari con cui la<br />
serina/treonina chinasi ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) la cui assenza di<br />
funzione è associata allo sviluppo di una patologia genetica rara, l’Atassia<br />
Telangiectasia (AT), contribuisce al controllo della morte cellulare programmata.<br />
I pazienti AT manifestano precocemente atassia cerebellare, telangiectasia<br />
e difetti a carico del sistema immunitario che comprendono immunodeficienza<br />
ed elevata predisposizione allo sviluppo di linfomi e leucemie. ATM<br />
ha un ruolo fondamentale nella risposta a stress che generano danno al DNA<br />
414 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
ed in particolare rotture a doppio filamento. Tali danni sono prodotti da<br />
radiazioni ionizzanti (IR), in seguito a forti stress ossidativi, da agenti radiomimetici<br />
tra cui molti chemioterapici, ma anche da eventi fisiologici come la<br />
ricombinazione VDJ delle immunoglobuline a carico delle cellule del sistema<br />
immunitario. In ogni caso, l’attivazione di ATM è necessaria per segnalare il<br />
danno ed attivare una risposta che prevede il blocco del ciclo cellulare e il<br />
riparo del DNA, oppure l’induzione della morte cellulare programmata.<br />
Entrambe le risposte sono controllate dall’attività chinasica di ATM che ha<br />
come substrati proteine importanti nel controllo del ciclo cellulare e dell’apoptosi.<br />
Da diversi anni il nostro laboratorio studia la risposta apoptotica indotta<br />
da attivazione del recettore di morte Fas, risposta che ha un ruolo importante<br />
nel sistema immunitario. Dal momento che il sistema immunitario è seriamente<br />
compromesso nei pazienti AT, il primo obiettivo che ci siamo posti è<br />
definire il possibile ruolo di ATM nell’apoptosi indotta da Fas.<br />
Inoltre, visto il coinvolgimento importante di ATM nel controllo della<br />
risposta apoptotica in risposta a stress e considerato che l’alterazione di questa<br />
risposta è spesso indicata come causa della degenerazione neuronale<br />
associata a diverse patologie neurodegenerative, ci proponiamo di indagare<br />
se ATM viene attivata e partecipa alla traduzione del segnale indotta in<br />
alcuni modelli sperimentali di tali patologie. In particolare in un modello<br />
murino di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è stato recentemente descritto<br />
un’aberrante fosforilazione ed accumulo di uno dei substrati fondamentali di<br />
ATM, p53, un’importante modulatore del ciclo cellulare e dell’apoptosi. Pertanto<br />
verificheremo se in tale sistema è presente un’attivazione aberrante di<br />
ATM e in caso positivo, ne definiremo il contributo nella degenerazione dei<br />
motoneuroni.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
L’obiettivo della nostra ricerca è definire il ruolo di ATM nella morte cellulare<br />
programmata indotta da Fas, un programma apoptotico fondamentale<br />
nel sistema immunitario, seriamente compromesso nell’AT. Utilizzando linee<br />
linfoblastoidi derivate da pazienti AT o da individui sani di controllo abbiamo<br />
dimostrato che cellule AT sono fortemente resistenti alla morte indotta da<br />
Fas. Partendo dalle cellule AT abbiamo generato tre importanti linee cellulari:<br />
1) ricostituite per l’espressione di ATM AT-ATM-wt; 2) ricostituite per<br />
l’espressione di una forma di ATM cataliticamente inattiva, AT-ATM-Kin-; 3)<br />
transfettate con un vettore vuoto di controllo, AT-pcDNA3. Utilizzando queste<br />
linee abbiamo quindi confermato che l’attività chinasica di ATM sensibilizza<br />
le cellule alla morte indotta da Fas.<br />
Analizzando il profilo di espressione dei componenti centrali della via di<br />
trasduzione del segnale a valle di Fas, abbiamo dimostrato che tutte le nostre<br />
linee cellulari esprimono livelli comparabili del recettore Fas e di Caspasi-8, la<br />
caspasi iniziatrice assolutamente necessaria per l’esecuzione di questa risposta<br />
apoptotica. Sorprendentemente e nonostante i livelli di Caspasi -8 siano<br />
del tutto indipendenti dalla presenza e dall’attività di ATM, la sua attivazione è<br />
2007 415
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
fortemente inibita nelle cellule AT o in quelle ricostituite con ATM cataliticamente<br />
inattivo, suggerendo quindi che l’attività di ATM sia in grado di modulare<br />
l’attivazione di Caspasi-8. Il principale inibitore dell’attivazione di<br />
Caspasi-8 è FLIP, che ne impedisce l’attivazione competendo per il reclutamento<br />
al recettore Fas. Abbiamo dimostrato che livelli proteici di FLIP sono<br />
significativamente più elevati in cellule AT, coerentemente con la loro resistenza<br />
all’apoptosi indotta da Fas e con la ridotta attivazione di Caspasi-8.<br />
Inoltre l’attivazione di ATM da IR o da radiomimetici induce l’abbassamento<br />
dei livelli di FLIP. Alcune evidenze sperimentali suggeriscono che ATM possa<br />
modulare l’ubiquitinazione e quindi la stabilità proteica di FLIP.<br />
Questo studio dimostra quindi un coinvolgimento diretto di ATM nella<br />
risposta apoptotica trasdotta dal recettore Fas e suggerisce quindi un nuovo<br />
meccanismo alla base dell’immunodeficienza e dell’alta incidenza di linfomi e<br />
leucemie caratteristici dell’AT.<br />
Attività previste<br />
• Analisi del ruolo del controllo ATM-dipendente dei livelli di FLIP nello<br />
sviluppo dei linfomi di Hodgkin.<br />
• Analisi del meccanismo che sottende alla regolazione dei livelli proteici<br />
di FLIP mediata da ATM.<br />
• Identificazione di altre proteine la cui ubiquitinazione e stabilità sono<br />
modulate da ATM.<br />
• Analisi dell’esistenza della modulazione ATM dipendente dei livelli di<br />
alcune proteine nel sistema nervoso.<br />
• Analisi dell’attività di ATM in un modello murino di SLA.<br />
C.2.5 –Alterazioni funzionali nella attività elettrica<br />
dei neuroni dopaminergici della sostanza nera pars compacta:<br />
ruolo delle afferenze sinaptiche estrinseche (Nicola Berretta)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Parkinson; Sostanza nera; Neurotrasmettitori.<br />
Descrizione<br />
I neuroni dopaminergici della Sostanza Nera pars compacta (SNc) svolgono<br />
un ruolo essenziale nel controllo motorio, tale per cui una loro<br />
degenerazione costituisce la causa principale dei disturbi motori associati a<br />
disfunzioni extrapiramidali come quelli tipici del Morbo di Parkinson. Le alterazioni<br />
funzionali dell’eccitabilità di questi neuroni si riflettono in modificazioni<br />
nell’entità e nella modalità di rilascio di dopamina (DA) nelle aree di<br />
proiezione, infatti è stato osservato che anche delle modificazioni nelle modalità<br />
di scarica dei neuroni dopaminergici possono influire sostanzialmente<br />
sulla quantità di DA rilasciata nel Nucleo Striato. Da ciò si evince quanto le<br />
416 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
afferenze sinaptiche a questi neuroni possano giocare un ruolo determinante<br />
nel modificare le loro proprietà di scarica e dunque la loro funzionalità nell’ambito<br />
di tutto il sistema dei gangli della base.<br />
Tra le afferenze estrinseche, le principali sono di natura inibitoria<br />
GABAergica, provenienti soprattutto dallo Striato e dal Pallido, tuttavia esiste<br />
anche una consistente afferenza di tipo eccitatorio glutammatergico, soprattutto<br />
dal Nucleo Subtalamico e dal Nucleo Peduncolopontino.<br />
Molti studi sono stati condotti sull’azione postsinaptica di queste afferenze,<br />
ma poco è noto sull’azione che il GABA ed il glutammato svolgono a<br />
livello presinaptico. D’altra parte è presumibile ipotizzare che queste afferenze<br />
possano essere sottoposte ad una fine modulazione nella loro efficacia, e che<br />
sia proprio attraverso spostamenti nel bilanciamento tra eccitazione ed inibizione<br />
che i neuroni dopaminergici modifichino la loro risposta funzionale<br />
nelle diverse condizioni fisiologiche e patologiche.<br />
I meccanismi sottostanti la modulazione presinaptica di rilascio di trasmettitore<br />
sono da lungo tempo oggetto di studio ed appare chiaro come questa<br />
possa esplicarsi sia attraverso meccanismi di modificazione nella permeabilità<br />
dei canali Ca 2+ voltaggio-dipendenti presenti sui terminali sinaptici, la<br />
cui apertura presiede al rilascio delle vescicole sinaptiche, sia attraverso meccanismi<br />
indipendenti dall’ingresso di calcio, per azione diretta sull’apparato<br />
che presiede alla fusione delle vescicole alla membrana presinaptica. D’altra<br />
parte, comprendere con maggiore precisione quali siano i meccanismi che<br />
presiedono tale modulazione può risultare particolarmente importante qualora<br />
si vogliano definire target specifici per interventi farmacologici, volti a<br />
ristabilire un corretto bilanciamento del rapporto eccitazione-inibizione degli<br />
input ai neuroni dopaminergici.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nel corso di questo anno abbiamo rivolto la nostra attenzione allo studio<br />
dei meccanismi di modulazione presinaptica del rilascio sinaptico di GABA su<br />
cellule dopaminergiche della sostanza nera pars compacta (SNc), in seguito a<br />
stimolazione di recettori GABA B<br />
e metabotropici glutammatergici (mGluRs),<br />
con tecniche elettrofisiologiche su preparati slice di mesencefalo ventrale. La<br />
stimolazione di ambedue i tipi recettoriali con baclofen e con AP4 determina<br />
una riduzione nella probabilità di rilascio sinaptico di GABA, misurato come<br />
riduzione nella frequenza delle correnti postsinaptiche inibitorie spontanee<br />
(sIPSCs). Abbiamo poi analizzato le correnti sinaptiche spontanee in miniatura<br />
(mIPSCs), perfondendo il preparato con TTX e cadmio e abbiamo potuto<br />
verificare una differenza nell’azione dei due agonisti recettoriali. Se infatti la<br />
perfusione con baclofen era ancora in grado di ridurre la frequenza dei<br />
mIPSCs, l’AP4 risultava invece inefficace.<br />
Questi risultati suggeriscono dunque che, mentre la stimolazione dei<br />
recettori mGluRs di tipo III riduce la probabilità di rilascio di GABA agendo<br />
sui canali voltaggio dipendenti, attivati durante l’insorgenza dei potenziali<br />
d’azione presinaptici, la stimolazione dei recettori GABA B<br />
raggiunge lo stesso<br />
obiettivo di inibizione presinaptica agendo sulle vie metaboliche successive<br />
2007 417
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
all’ingresso di calcio nel terminale presinaptico, presumibilmente sulla machinery<br />
coinvolta nel rilascio vescicolare.<br />
Attività previste<br />
Allo scopo di proseguire la nostra analisi dei meccanismi di inibizione<br />
presinaptica mediata dai recettori GABA B<br />
e mGluRs del gruppo III, verranno<br />
condotti studi volti a confermare la differente azione di questi tipi recettoriali,<br />
verificando in particolare l’ipotesi secondo cui i recettori GABA B<br />
agirebbero a<br />
livello dei meccanismi di rilascio vescicolare calcio-indipendente, mentre i<br />
recettori mGluRs-III su quello di tipo calcio-indipendente.<br />
A tal fine verificheremo la possibilità che l’agonista mGluRs AP4 (100 mM)<br />
sia in grado di deprimere il rilascio di GABA in presenza di TTX (1 mM), qualora<br />
sia presente nel mezzo di perfusione anche bario (1 mM). È infatti ipotizzabile<br />
che la depolarizzazione dei terminali associata alla presenza di questo<br />
catione permetta l’ingresso di calcio nel terminale, col risultato di ottenere un<br />
rilascio vescicolare dipendente dall’apertura di canali calcio voltaggio dipendenti<br />
(VDCCs), pur in presenza di TTX.<br />
In aggiunta, eseguiremo esperimenti in presenza di ionomicina (2 mM).<br />
Questa tossina promuove un rilascio vescicolare calcio-dipendente, pur senza<br />
attivare canali VDCCs. Verificheremo dunque l’azione dell’AP4 e dell’agonista<br />
dei GABA B<br />
baclofen (10 mM) sulle correnti sinaptiche GABAergiche evocate da<br />
questa tossina. Analogamente, ripeteremo gli stessi esperimenti in presenza di<br />
a-LTX (0.3 nM), peptide in grado di promuovere un rilascio vescicolare calcio-indipendente.<br />
Sulla base della nostra ipotesi è presumibile che l’AP4,<br />
agendo a livello dei canali VDCCs, sia inefficace in presenza di ionomicina e<br />
di a-LTX, mentre il baclofen, agendo a valle dell’ingresso di calcio, dovrebbe<br />
essere in grado di inibire il rilascio sinaptico di GABA in ambedue queste condizioni<br />
sperimentali.<br />
In aggiunta, verificheremo se questi due meccanismi di inibizione presinaptica<br />
si verifichino a livello degli stessi terminali GABAergici oppure esista<br />
una segregazione funzionale tra terminali sensibili all’AP4 ed al baclofen.<br />
Questo obiettivo potrà essere raggiunto mediante esperimenti di occlusione.<br />
C.2.6 –Ruolo delle Scaffolding Proteins e del recettore NMDA<br />
nella plasticità sinaptica corticostriatale in modelli sperimentali<br />
di malattie neurodegenerative (Paolo Calabresi)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Plasticità sinaptica striatale; Scaffolding proteins; Recettore<br />
NMDA.<br />
Descrizione<br />
Nelle sinapsi del sistema nervoso centrale i recettori NMDA sono raggruppati<br />
in una frazione subcellulare altamente organizzata, la Post Synaptic Density<br />
418 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
(PSD), dinamicamente regolata grazie all’aggregazione dei recettori ionotropici<br />
glutammatergici con le proteine di adesione e gli elementi di trasduzione del<br />
segnale. È noto che la funzionalità del recettore NMDA è modulata da processi<br />
di fosforilazione e che la fosforilazione di subunità specifiche del recettore<br />
risulta modificata in condizioni patologiche. Le proprietà fisiologiche dei recettori<br />
NMDA sono determinate non solo dalla composizione delle loro subunità e<br />
dalla loro localizzazione cellulare, ma anche dall’interazione proteica che<br />
governa la cascata di eventi innescata dall’attivazione recettoriale. Tra queste, la<br />
CaMKII è direttamente legata alla regione c-terminale delle subunità NR2A e 2B<br />
del complesso recettoriale NMDA competendo, a livello della subunità NR2A,<br />
con il legame con PSD-95. Il complesso proteico postsinaptico associato al recettore<br />
NMDA rappresenta un elemento chiave nella patogenesi delle modificazioni<br />
sinaptiche a lungo termine e delle anormalità motorie in modelli sperimentali di<br />
molte malattie neurodegenerative tra cui il Morbo di Parkinson (PD).<br />
Tra le “ scaffolding proteins ” i componenti della famiglia proteica delle<br />
MAGUK (membrane-associated guanylate kinase), come la SAP97 e la<br />
SAP102, sono stati coinvolti nei meccanismi molecolari che regolano il “ trafficking<br />
” e il “ clustering ” dei recettori ionotropici del glutammato (Glu) al<br />
compartimento postsinaptico.<br />
Sul terminale presinaptico la “ cytomatrix assembled at the active zone ”<br />
(CAZ) rappresenta il sito di rilascio del neurotrasmettitore ed è una zona altamente<br />
organizzata per il “ trafficking ” delle vescicole sinaptiche (SV). In questa<br />
zona “ Piccolo ” e “ Bassoon ” sono due proteine che svolgono un ruolo<br />
chiave nel trasporto delle SV nella zona attiva e nella loro fusione con la<br />
membrana sinaptica per il rilascio di glutammato dal terminale corticostriatale.<br />
Nessuno studio ha finora chiaramente dimostrato i meccanismi alla base<br />
dell’attività di questa e di altre SCAFFs nello striato, area di particolare interesse<br />
clinico in quanto sede dei più importanti fenomeni di plasticità sinaptica<br />
e costituita da popolazioni neuronali selettivamente vulnerabili alla neurodegenerazione.<br />
Uno studio più approfondito della trasmissione sinaptica<br />
striatale dal punto di vista elettrofisiologico sarebbe pertanto necessario per<br />
correlare i deficit cognitivi ad alterazioni neurofisiologiche ed investigare a<br />
fondo sui meccanismi alla base dei danni causati dai deficit trasmettitoriali<br />
dovuti alla mancata funzione delle SCAFFs.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Recentemente, abbiamo iniziato lo studio in vitro delle proteine MAGUK<br />
che permettendo il trafficking e la stabilizzazione in membrana delle subunità<br />
del recettore NMDA possono avere un ruolo nell’alterazione della plasticità<br />
sinaptica bidirezionale dei neuroni spinosi striatali nel corso dello sviluppo<br />
delle discinesie indotte da trattamento cronico con L-DOPA in ratti emiparkinsoniani.<br />
Utilizzando rispettivamente i peptidi sintetici TAT2B e TAT2A<br />
siamo in grado di impedire l’accesso e la stabilizzazione nel complesso NMDA<br />
delle due subunità NR2B e NR2A.<br />
Mentre il trattamento cronico con L-DOPA è in grado di ripristinare un<br />
normale LTP in tutti gli animali parkinsoniani trattati (dys e non dys), gli ani-<br />
2007 419
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
mali discinetici che mostrano questa iperattività motoria non sono in grado di<br />
depotenziare la sinapsi ai livelli di controllo in seguito al protocollo di stimolazione<br />
a bassa frequenza (LFS), segno di una correlazione importante tra<br />
l’iperattività motoria e l’iperattivazione sinaptica del recettore NMDA e di<br />
un LTP non depotenziabile. Quindi, negli animali trattati cronicamente con L-<br />
DOPA (dys e non dys) abbiamo applicato dopo l’induzione dell’LTP rispettivamente<br />
il peptide TAT2A e TAT2B prima del protocollo di depotenziamento per<br />
studiare se la manipolazione artificiale delle subunità del recettore NMDA<br />
può replicare le alterazioni molecolari e comportamentali analizzate nei precedenti<br />
lavori descritti.<br />
È di notevole interesse che, così come in vivo il TAT2B era in grado di<br />
indurre movimenti discinetici in animali che non ne avevano ancora mostrati<br />
e livelli di NR2B simili a quelli misurati nei ratti discinetici, la sua applicazione<br />
in vitro prima della LFS nei neuroni registrati da animali non dys è in<br />
grado di bloccare l’induzione del normale depotenziamento. Al contrario, il<br />
TAT2A è in grado di indurre un normale depotenziamento nei neuroni spinosi<br />
registrati dai ratti dys che normalmente non mostrano questo fenomeno fisiologico<br />
di “ resettaggio ” della sinapsi.<br />
In conclusione, risulta evidente il ruolo fondamentale delle MAGUK nel<br />
corretto assemblaggio del recettore NMDA e che l’insorgenza delle discinesie<br />
sia correlata ad una modificazione della localizzazione delle subunità nel<br />
complesso recettoriale nel compartimento postsinaptico.<br />
Attività previste<br />
• Analisi della plasticità sinaptica bidirezionale delle terminazioni corticostriatali<br />
dopo l’applicazione in vitro di specifici peptidi (TAT2A e 2B) ad<br />
azione disaccoppiante delle varie subunità del recettore NMDA. A tal fine,<br />
effettueremo registrazioni elettrofisiologiche intracellulari da fettine corticostriatali<br />
di ratti di controllo con TAT2A e TAT2B in grado di impedire alle<br />
“ scaffolding proteins ” di trasportare le diverse subunità del recettore NMDA<br />
al complesso recettoriale nella PSD.<br />
• Confronto tra l’effetto dei peptidi sintetici TAT sulla plasticità sinaptica<br />
dei neuroni spinosi striatali con l’azione di inibitori specifici delle subunità<br />
NR2A e 2B.<br />
• Sul terminale presinaptico la “ cytomatrix assembled at the active<br />
zone ” (CAZ) rappresenta il sito di rilascio del neurotrasmettitore ed è una<br />
zona altamente organizzata per il “ trafficking ” delle vescicole sinaptiche<br />
(SV). In questa zona “ Piccolo ” e “ Bassoon ” sono due proteine che svolgono<br />
un ruolo chiave nel trasporto delle SV nella zona attiva e nella loro fusione<br />
con la membrana sinaptica per il rilascio di glutammato dal terminale<br />
corticostriatale. Risultati preliminari ottenuti da test comportamentali ed elettrofisiologici<br />
indicano che la proteina Bassoon (BSN) ha ruoli differenti nella<br />
modulazione della plasticità sinaptica delle diverse popolazioni neuronali<br />
dello striato suggerendo una sua funzione regolatoria nell’organizzazione<br />
delle sinapsi glutammatergiche striatali.<br />
420 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
• Studio del ruolo delle alterazioni nel rilascio delle vescicole sinaptiche<br />
dal terminale corticostriatale presinaptico in topi KO per “ Bassoon ” sulle<br />
proprietà elettrofisiologiche nei vari sottotipi neuronali presenti nello striato<br />
(spiny neurons e fast-spiking). In questi animali KO studieremo, inoltre,<br />
l’eventuale alterazione della plasticità sinaptica corticostriatale e del suo depotenziamento<br />
nei due differenti tipi neuronali striatali.<br />
C.2.7 – Studio delle alterazioni indotte dalle Cu,Zn<br />
superossido dismutasi mutanti<br />
associate alla sclerosi laterale amiotrofica<br />
di tipo familiare (Maria Teresa Carrì)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sclerosi Laterale Amiotrofica; Superossido Dismutasi; Neurodegenerazione;<br />
Neuroinfiammazione.<br />
Altri Enti coinvolti: Università di Sassari.<br />
Descrizione<br />
Obiettivo del progetto è di indagare sulle modalità attraverso cui le mutazioni<br />
di superossido dismutasi (SOD1) tipiche di pazienti affetti da sclerosi laterale<br />
amiotrofica (SLA) causano la comparsa del fenotipo di danno motoneuronale<br />
nei pazienti. Recenti studi indicano che le SOD1 mutanti possono essere<br />
raggruppate almeno in due sottoclassi per quello che riguarda le loro proprietà<br />
chimico-fisiche [Valentine et al. (2005) Annu Rev Biochem 74: 563-593] e che i<br />
danni derivanti dall’aggregazione e/o dalla nuova funzione pro-ossidante di queste<br />
proteine siano mediati da un dialogo molecolare tra cellule neuronali e non<br />
neuronali. In particolare, la produzione di citochine neurotossiche da parte<br />
delle cellule microgliali ed astrocitarie sembra avere un forte ruolo patologico<br />
nella morte neuronale. Indicazioni in questo senso derivano dall’osservazione<br />
che l’attivazione di microglia e astrociti è una caratteristica di tutti i pazienti<br />
affetti da SLA. Inoltre, la produzione di TNF, IL-1, iNOS da parte delle cellule<br />
gliali aggrava l’effetto tossico dei mutanti della SOD1, in diversi modelli sperimentali<br />
di SLA. Questi fattori solubili fanno parte della risposta immunitaria<br />
innata e sono in gran parte sotto il controllo del fattore di trascrizione NF-kB.<br />
Con questo programma, ci proponiamo di studiare ulteriormente il dialogo<br />
molecolare tra cellule neuronali e non neuronali in un nuovo modello<br />
murino in cui la componente neuroinfiammatoria viene prevenuta mediante<br />
inibizione del fattore di trascrizione NF-kB mediante espressione della<br />
variante costitutiva dominante del suo inibitore IkBalfa.<br />
In particolare, in questi modelli si affronterà uno studio dell’induzione di<br />
fattori correlati con la morte cellulare per via mitocondrio-dipendente ed una<br />
dettagliata analisi dei segnali scambiati fra cellule neuronali e non neuronali.<br />
Lo studio sarà completato dall’esame delle proprietà biochimiche della<br />
frazione di proteina mutata localizzata all’interno del mitocondrio e dei meccanismi<br />
che ne inducono la compartimentalizzazione.<br />
2007 421
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Obiettivo di questa ricerca è di indagare sulle modalità attraverso cui le<br />
mutazioni di superossido dismutasi (SOD1) tipiche di pazienti affetti da sclerosi<br />
laterale amiotrofica (SLA) causano la comparsa del fenotipo di danno<br />
motoneuronale nei pazienti.<br />
In particolare, la nostra attenzione si è focalizzata sulla analisi dei segnali<br />
scambiati fra cellule neuronali e non neuronali nel dialogo molecolare che<br />
sottende la patogenesi della SLA.<br />
Utilizzando un modello cellulare costituito dalla linea motoneuronale<br />
murina NSC34 trasfettata per l’espressione inducibile di diverse FALS-SOD1<br />
mutanti, abbiamo dimostrato che un trattamento che mima la situazione di<br />
neuroinfiammazione presente nella SLA (trattamento con citochine quali<br />
interferon gamma e tumor necrosis factor alfa) è in grado di indurre un<br />
aumento di accumulo delle proteine mutanti nel compartimento mitocondriale.<br />
Questo accumulo si riflette in un accresciuto deficit energetico che<br />
innesca processi di morte neuronale.<br />
Parallelamente, abbiamo prodotto due nuove linee di topi transgenici nei<br />
quali l’attivazione del fattore di trascrizione NF-kB è impedita dalla espressione<br />
costitutiva del suo inibitore IkBalfa selettivamente negli astrociti o nella microglia.<br />
Queste linee murine, che non presentano un chiaro fenotipo tossico e sono<br />
attualmente in corso di caratterizzazione, saranno disponibili per l’incrocio con<br />
topi transgenici che esprimono la SOD1 mutante G93A, allo scopo di valutare la<br />
rilevanza del processo neuroinfiammatorio nella patogenesi della SLA.<br />
Attività previste<br />
• Analisi dei meccanismi che sottendono all’induzione di localizzazione<br />
mitocondriale delle SOD1 mutate in cellule neuronali trattate con citochine<br />
infiammatorie.<br />
• Caratterizzazione delle linee di topi transgenici in cui l’attivazione di<br />
NF-kB è inibita selettivamente negli astrociti o nella microglia mediante<br />
espressione costitutiva di IkBalfa.<br />
• Costruzione di due linee di topi doppio transgenici, che esprimono<br />
SOD1 mutata G93A ubiquitariamente e IkBalfa selettivamente negli astrociti<br />
o nella microglia.<br />
• Valutazione degli effetti della inibizione di processi infiammatori sulla<br />
sopravvivenza del modello murino di SLA.<br />
C.2.8 –Analisi dello stress e della morte cellulare nella malattia<br />
di Alzheimer in modelli animali e cellulari di nuova concezione<br />
(Francesco Cecconi)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Alzheimer; Apoptosi; Autofagia; Caspasi; Malattie Neurodegenerative;<br />
Transgenesi.<br />
422 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
Descrizione<br />
I meccanismi alla base delle neurodegenerazioni sono ancora in gran<br />
parte sconosciuti. La disfunzione di specifiche regioni del cervello è dovuta<br />
all’inabilità delle cellule che costituiscono tali regioni. È ora noto che il quadro<br />
patologico di numerose malattie neurodegenerative è causato da morte<br />
cellulare inappropriata. Per questo motivo, la comprensione e l’identificazione<br />
dei mediatori molecolari della morte cellulare programmata nonchè la verifica<br />
dei loro ruoli nella regolazione della morte rappresentano un passaggio<br />
essenziale verso la cura di queste malattie.<br />
Obiettivo del progetto è utilizzare modelli animali e cellulari nei quali<br />
l’apoptosi o altri meccanismi di morte o sopravvivenza cellulare siano stati<br />
manipolati geneticamente allo scopo di osservarne, previo incrocio o confronto<br />
con modelli di neurodegenerazione, la capacità compensativa.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
1. Il morbo di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa progressiva<br />
per la quale sono stati generati numerosi modelli sperimentali. Sia<br />
in pazienti che in modelli animali, è sempre più chiaro che la disfunzione<br />
neuronale ha luogo assai prima della deposizione delle placche amiloidi e<br />
della morte stessa dei neuroni. Il processo definito “ apoptosi ” è il percorso<br />
metabolico più studiato di morte cellulare. Molti dati confermano che le<br />
molecole dell’apoptosi sono associate al processamento del precursore amiloide<br />
APP ed alla morte ultima dei neuroni. Stiamo valutando la possibilità<br />
che un’attivazione precoce dell’apoptosi (alle sinapsi) possa indurre progressiva<br />
degenerazione sinaptica e progressiva perdita di connessione, una<br />
delle caratteristiche cliniche più significative della prima fase dell’AD,<br />
caratterizzata dall’assenza di demenza palese e denominata ‘leggero deficit<br />
cognitivo’.<br />
2. L’autofagia è un processo catabolico atto alla degradazione di proteine<br />
ed organelli in una grande varietà di organismi. Nei vertebrati, questo processo<br />
agisce come un meccanismo pro-morte in diverse condizioni fisiopatologiche,<br />
compresa la neurodegenerazione ed il cancro. Nonostante ciò, i ruoli<br />
dell’autofagia nella neurodegenerazione sono ancora oscuri. Abbiamo recentemente<br />
identificato Ambra-1 (molecola attivatrice dell’autofagia mediata da<br />
Beclin-1) come una nuova grande proteina che regola l’autofagia e gioca un<br />
ruolo cruciale nell’embriogenesi. Abbiamo infatti scoperto che Ambra-1 è un<br />
regolatore positivo del programma di autofagia dipendente da Beclin-1<br />
mediante esperimenti di interferenza dell’RNA e sovraespressione in vitro e,<br />
soprattutto, che l’inattivazione di Ambra-1 in embrioni di topo porta a difetti<br />
gravi della neurulazione, associati a disfunzione dell’autofagia, proliferazione<br />
sbilanciata, eccessiva morte cellulare ed accumulo di proteine ubiquitinate.<br />
Poiché quest’ultimo fenomeno è un segno distintivo dell’inattivazione condizionale<br />
dell’autofagia nel sistema nervoso adulto, che culmina in una grave<br />
forma di neurodegenerazione, ci proponiamo di studiare i ruoli svolti da<br />
Ambra-1 nel contesto dell’AD.<br />
2007 4<strong>23</strong>
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Attività previste<br />
• Analisi dei meccanismi che sottendono al trasporto, alla sintesi, all’attivazione<br />
ed alla funzione dell’apoptosoma alle sinapsi in condizioni fisiologiche<br />
e nell’AD.<br />
• Costruzione di una linea murina nella quale il locus Ambra-1 sia inattivato<br />
in modo selettivo solo nei tessuti nervosi adulti.<br />
• Analisi dell’autofagia alle terminazioni sinaptiche nell’AD.<br />
• Studio dei meccanismi molecolari dell’autofagia connessi al network<br />
molecolare di Ambra-1 in condizioni fisiologiche e patologiche.<br />
C.2.9 – Strategie terapeutiche per la Corea di Huntington.<br />
Il ruolo di c-AMP-responsive element (CREB)<br />
(Francesca Romana Fusco)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: HD; CREB; Therapy.<br />
Descrizione<br />
La comprensione dei meccanismi alla base della vulnerabilità o della<br />
resistenza dei neuroni striatali ai fenomeni neurodegenerativi della corea di<br />
Huntington (HD) è di importanza fondamentale per lo studio di strategie terapeutiche.<br />
Per tale motivo il nostro laboratorio si è in precedenza dedicato a studiare<br />
la presenza della proteina huntingtina nei principali sottotipi neuronali<br />
striatali del topo mutante R6/2, modello transgenico di HD. I nostri dati hanno<br />
confermato, anche nel topo mutante, una particolare ricchezza di huntingtina<br />
negli interneuroni colinergici, resistenti al danno eccitotossico. L’obiettivo successivo<br />
è stato quello di indagare la presenza di altre proteine che si sono dimostrate<br />
importanti nell’HD. La c- AMP-responsive-element (CREB) è una proteina<br />
regolatrice di varie funzioni cellulari, recentemente dimostrata essere<br />
coinvolta nei processi degenerativi dell’HD. Il nostro gruppo ha recentemente<br />
dimostrato una correlazione tra i livelli di CREB e le diverse sottopopolazioni<br />
neuronali striatali coinvolte nella degenerazione nell’HD (Giampà et al. 2006).<br />
Il progetto, che avrà durata triennale, sarà rivolto allo studio di strategie<br />
terapeutiche per l’HD che siano finalizzate all’aumento della CREB nei neuroni<br />
di proiezione che sono i primi a degenerare nella patologia. La prima parte del<br />
progetto mirerà allo studio dell’effetto di un inibitore della fosfodiesterasi 4, il<br />
Rolipram, sull’espressione a livello proteico della CREB nei neuroni di proiezione<br />
sia nel ratto normale che nel modello eccitotossico da lesione con acido<br />
quinolinico. Ratti wistar maschi verranno iniettati stereotassicamente con acido<br />
quinolinico 10mM in anestesia generale, dopo trattamento quotidiano con Rolipram<br />
a due differenti concentrazioni (0,15 mg/Kg; 1,15 mg/Kg) saranno perfusi<br />
a diversi time-points e fissati in paraformaldeide 4%. Verranno ottenute sezioni<br />
di encefalo dello spessore di 40 mm che saranno incubate con un cocktail di<br />
anticorpi primari diretti contro la CREB e contro la calbindina (CALB). Le<br />
424 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
sezioni verranno in seguito incubate con una miscela di appropriati anticorpi<br />
secondari fluorescenti, montati su vetrini gelatinati e quindi esaminate con un<br />
microscopio ad epi-illuminazione in fluorescenza e con un microscopio confocale.<br />
I dati ottenuti ci permetteranno di verificare una possibile strategia terapeutica<br />
per l’HD rivolta ad intervenire sui livelli di CREB intrastriatale.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Abbiamo dimostrato che l’inibitore della fosfodiesterasi-4 rolipram è in<br />
grado di ridurre l’area della lesione striatale eccitotossica e di aumentare<br />
l’attività della CREB nei neuroni superstiti. È quindi plausibile che l’effetto<br />
benefico del rolipram da noi dimostrato sia dovuto proprio ad un aumento<br />
dell’attività di CREB.<br />
Attività previste<br />
Nel 2007 verrà sviluppata una colonia di topi transgenici ceppo R6/2 il cui<br />
genotipo verrà caratterizzato mediante PCR. Quando la colonia sarà stabilizzata<br />
gli animali mutati di 4 settimane verranno trattati con rolipram 1,15 mg/kg o veicolo<br />
quotidianamente fino al raggiungimento di 12 settimane di età. Gli animali<br />
verranno sacrificati mediante perfusione transcardiaca ed i loro cervelli verranno<br />
trattati secondo il nostro protocollo di routine per l’istologia. Le sezioni ottenute<br />
verranno incubate con anticorpo anti calbindina per evidenziare i neuroni di<br />
proiezione striatali; inoltre, l’area della lesione verrà misurata sulle sezioni immunoistochimiche<br />
e su quelle istologiche colorate con Nissl tramite il software in<br />
dotazione del nostro microscopio confocale Zeiss CSLM510.<br />
C.2.10 – Recettori metabotropici e ionotropici del glutammato:<br />
risposte neuronali e canali transienti (TRP) (Ezia Guatteo)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Canali TRP; Cellule dopaminergiche; Cellule non dopaminergiche<br />
mesencefaliche; L-BMAA; Gangli della base; Neurodegenerazione.<br />
Descrizione<br />
Durante quest’anno concentreremo la nostra ricerca sul coinvolgimento<br />
dei recettori ionotropici glutammatergici nella degenerazione dei neuroni<br />
dopaminergici. A tale riguardo, sia fattori genetici che epigenetici sono ritenuti<br />
essere responsabili della neurodegenerazione che caratterizza i sintomi<br />
della malattia di Parkinson (PD). Sebbene la ricerca biomedica abbia cominciato<br />
a delineare le alterazioni geniche responsabili di alcune forme di PD<br />
[Polymeropulos et al. (1997) Science 276: 20045-2047], il ruolo dei fattori<br />
ambientali non è ancora pienamente conosciuto. A tale riguardo, lo scopo<br />
della presente ricerca è quello di definire i meccanismi fisiopatologici che<br />
caratterizzano i neuroni dopaminergici quando sono esposti a sostanze presenti<br />
nell’ambiente aventi potenziale attività neurotossica [Betarbet et al.<br />
(2000) Nat Neurosci 3: 1301-1306].<br />
2007 425
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Obiettivi<br />
Ci proponiamo di eseguire uno studio elettrofisiologico, microfluorometrico<br />
e morfologico allo scopo di definire le proprietà delle cellule dopaminergiche<br />
di roditore della sostanza nera parte compatta quando esposte a tossine<br />
in quantità note e per tempi definiti. La tossina oggetto dello studio sarà la<br />
L-BMAA (beta-N-methylamino-L-alanine). La L-BMAA, presente nei semi<br />
della Cycas circinalis, palma di cui si cibano le popolazioni delle isole del<br />
Pacifico occidentale, stimolerebbe i recettori glutammatergici non-NMDA<br />
[Durlach et al. (1997) Magnes Res 10(4): 339-353]. La sua specifica tossicità<br />
per le cellule dopaminergiche ci induce a comprendere i meccanismi neuropatologici<br />
che essa genera.<br />
Si cercherà di capire se la cascata di eventi negativi indotta dalla tossina<br />
nelle cellule dopaminergiche utilizzi meccanismi patologici comuni a quelli<br />
utilizzati dall’agonista dei recettori metabotropici già studiata in passato nel<br />
nostro laboratorio. Un probabile evento unificante responsabile, almeno nelle<br />
fasi iniziali, del danno cellulare indotto dalle sostanze potrebbe essere un<br />
eccessivo e prolungato aumento dei livelli di calcio citoplasmatico [Brownson<br />
et al. (2002) J Ethnopharmacol 82(2-3): 159-167], che potrebbe occorrere sia<br />
per apertura di canali specifici voltaggio- e recettore-dipendenti, che per liberazione<br />
da stores citoplasmatici e mitocondriali.<br />
Le informazioni derivanti dal presente studio ci permetteranno di comprendere<br />
perché i neuroni dopaminergici siano più vulnerabili di altre cellule<br />
ad alcuni tipi di tossine ambientali ed eventualmente ci permetterà di disegnare<br />
specifiche strategie preventive e riparative.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nel corso dell’anno 2006 abbiamo studiato l’attivazione del recettore<br />
metabotropo glutammatergico di gruppo I (mGluR I) nei neuroni dopaminergici<br />
della substantia nigra mediante stimolazione elettrica delle fibre afferenti<br />
glutammatergiche, anziché mediante applicazione esogena di agonisti selettivi.<br />
Da studi precedenti era emerso che la sua attivazione produce una corrente<br />
cationica depolarizzante e un aumento di calcio citoplasmatico. Tale<br />
corrente è mediata da canali TRP (transient receptor proteins), mentre<br />
l’aumento di calcio associato è mediato dai canali SOCs (store-operated channels).<br />
Le due risposte (corrente depolarizzante e aumento di calcio nel citoplasma)<br />
sono indipendenti, come dimostrato da esperimenti in cui abbiamo<br />
svuotato gli store intracellulari di calcio o abbiamo bloccato il rilascio<br />
mediante antagonisti dei recettori IP3 e ryanodina ma la corrente rimaneva in<br />
entrambi i casi invariata.<br />
Da esperimenti di RT-PCR su citoplasma di singoli neuroni registrati<br />
elettrofisiologicamente, è emerso che la maggior parte dei neuroni dopaminergici<br />
esprimono gli mRNA per i sottotipi TRPC1 e 5; i TRPC3 4 e 6 sono<br />
espressi solo da alcune sottopopolazioni. Da un punto di vista elettrofisiologico,<br />
abbiamo visto che, in presenza di antagonisti di recettori glutammatergici<br />
e gabaergici, attivati dalla stimolazione elettrica (NMDA, AMPA,<br />
GABA-A e GABA-B, glicina) si evoca una corrente post-sinaptica eccitatoria<br />
426 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
(EPSC) avente caratteristiche paragonabili a quelle della corrente attivata<br />
mediante applicazione esogena dell’agonista selettivo DHPG. In particolare,<br />
l’EPSC ha un potenziale di inversione intorno a –10 mV, è sensibile a bloccanti<br />
come SKF96365, acido flufenamico e rutenio rosso, tipici dei canali<br />
TRP. È inoltre bloccato dall’antagonista selettivo CPCCOEt, indicando che è<br />
mediato da mGluR I, analogamente alla corrente prodotta dall’agonista<br />
selettivo DHPG.<br />
Attività previste<br />
Valutazione del danno eccitossico mediato da L-BMAA (beta-N-methylamino-L-alanine).<br />
È un aminoacido contenuto nei semi di una palma (Cycas circinalis<br />
L) di cui si nutrono gli abitanti delle isole del West Pacific tra cui Guam, che<br />
presentano un elevato rischio per una patologia neurodegenerativa devastante,<br />
ALS-PDC. Si pensa che provochi un danno eccitotossico ai neuroni mediato da<br />
un aumento della concentrazione citoplasmatica di calcio [Brownson et al. (2002)<br />
J Ethnopharmacol 82(2-3): 159], mimando l’effetto di un agonista dei recettori<br />
glutammatergici non-NMDA [Durlach et al. (1997) Magn Res 10(4): 339].<br />
Noi andremo a misurare la concentrazione di calcio e le correnti di membrana<br />
nei neuroni dopaminergici durante trattamento acuto di fettine di<br />
mesencefalo con L-BMAA. Inoltre valuteremo il danno eccitotossico dopo<br />
trattamento prolungato (2, 4, 6 ore), e la funzionalità dei neuroni in risposta<br />
ai principali neurotrasmettitori.<br />
Tecniche utilizzate<br />
Elettrofisiologia – Utilizzeremo le procedure standard già descritte [Guatteo<br />
et al. (2000) J Neurosci 20(16): 6013; Guatteo et al. (2005) J Neurophysiol<br />
94(5): 3069-3080] per la preparazione delle fettine acute del mesencefalo di<br />
topo e ratto. Le registrazioni di patch-clamp sono effettuate su neuroni visualizzati<br />
mediante un sistema di contrasto differenziale interferenziale a infrarossi<br />
(IR-DIC), per mezzo di un obiettivo a immersione 40X e una telecamera<br />
(Hamamatsu, Japan).<br />
Microfluorimetria – Le misurazioni di [Na+] e [Ca2+] intracellulare verranno<br />
ottenute da neuroni caricati rispettivamente con SBFI o Fura-2 (0.25<br />
mM, Molecular Probes) aggiunti alla soluzione di riempimento dell’elettrodo<br />
di registrazione. La loro eccitazione si realizzerà attraverso luce UV emessa<br />
da un monocromatore (Till Photonics) a 340 e 380 nm. La luce emessa sarà<br />
monitorata con un filtro a 500 nm e captata da una camera CCD.<br />
C.2.11 – Ruolo della tossicità da glutammato in un modello sperimentale<br />
di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) (Patrizia Longone)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sclerosi Laterale Amiotrofica; Glutammato; Eccitotossicità.<br />
Altri Enti coinvolti: Consiglio Nazionale delle Ricerche.<br />
2007 427
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Descrizione<br />
Il topo transgenico che overesprime la SOD1 umana mutata nella posizione<br />
93 (G93A) e che, intorno al quarto mese di età, presenta degenerazione<br />
dei motoneuroni superiori ed inferiori, è considerato attualmente un buon<br />
modello per lo studio della Sclerosi Laterale Amiotrofica [Gurney et al. (1994)<br />
Science 17(264): 1772-1775].<br />
Sono sempre più numerose le descrizioni cliniche di pazienti SLA, che<br />
oltre alla principale degenerazione del sistema motorio, presentano anomalie<br />
nel sistema nervoso centrale accompagnate da vari disturbi cognitivi, e deficit<br />
fronto-temporale.<br />
Lo scopo del nostro progetto è di verificare se anomalie di tipo molecolare<br />
e/o cellulare dei neuroni della corteccia precedono o si sviluppano parallelamente<br />
alle anomalie dei neuroni spinali e al deficit motorio nel topo G93A.<br />
Nella patogenesi della SLA il sistema di neurotrasmissione di tipo glutammatergico,<br />
ricopre un ruolo centrale. In un precedente lavoro abbiamo osservato<br />
un incremento dell’mRNA e della proteina per la subunità GluR1 del recettore<br />
AMPA, nell’area ippocampale dei topi G93A [Spalloni et al. (2006) Exp Neurol<br />
197: 505-514]. Inoltre, in un modello in vitro di colture primarie nuronali,<br />
abbiamo osservato, in seguito a tossicità con il kainato, una maggiore vulnerabilità<br />
dei motoneuroni G93A rispetto ai controlli, ma non si è osservata<br />
invece alcuna differenza nelle cellule corticali G93A rispetto al controllo<br />
[Spalloni et al. (2004) Neurobiol Dis 15: 340-350; Neuroreport (2004) 15(16):<br />
2477-2480].<br />
Alla luce dei dati finora ottenuti, ci proponiamo di analizzare, in particolare<br />
nella corteccia motoria dei G93A, i livelli di espressione di proteine coinvolte<br />
nel pathway glutammatergico (ad es. le subunità dei recettori AMPA, dei<br />
recettori NMDA, la subunità mGluR5 dei recettori metabotropici) e di proteine<br />
implicate nel rilascio della vescicola sinaptica.<br />
Inoltre ci proponiamo di estendere gli studi di eccitotossicità, con<br />
l’utilizzo dell’agonista NMDA in colture di cellule corticali e di motoneuroni,<br />
di approfondire i possibili meccanismi molecolari della mortalità neuronale,<br />
ed infine il relativo ruolo svolto dalle cellule gliali.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Il nostro obiettivo è stato quello di studiare nel modello di topo transgenico<br />
G93A, in una fase precedente la comparsa del fenotipo SLA (circa 75<br />
giorni di età), i livelli di espressione di marker proteici, in corteccia motoria,<br />
un’area considerata la seconda più colpita dopo il midollo spinale nella SLA.<br />
In particolare abbiamo analizzato i livelli di espressione delle subunità dei<br />
recettori glutammatergici ionotropici (NMDA, ed AMPA) e della subunità<br />
mGluR5 dei recettori metabotropici, in preparazioni di sinaptosomi e nella<br />
post-synaptic density (PSD) di corteccia motoria da G93A e controlli.<br />
Dallo studio è risultata, in particolare nella PSD, una sostanziale diminuzione<br />
della subunità NR2A del recettore NMDA, subunità fondamentale nella<br />
normale maturazione delle spine dendritiche. Siamo allora andati a vedere se,<br />
a questo diverso stadio di maturazione della corteccia motoria dei G93A, cor-<br />
428 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
rispondessero anche differenti livelli di espressione di proteine fondamentali<br />
per il rilascio delle vescicole sinaptiche, quindi una anomalia nel release del<br />
glutammato. Tuttavia, proteine come SNAP-25, synaptophisin, synaptobrevinvamp<br />
non sembrano variare nei loro livelli di espressione.<br />
Parallelamente in esperimenti in vitro su colture di neuroni corticali,<br />
abbiamo testato la tossicità NMDA mediata, ed il ruolo dello zinco in questo<br />
pathway. È emerso un ruolo fondamentale dello zinco nella tossicità NMDA<br />
mediata, infatti i neuroni corticali G93A trattati con NMDA, dopo una preincubazione<br />
con zinco, sono drammaticamente più vulnerabili dei relativi controlli.<br />
Attività previste<br />
• Studio morfologico delle spine dendritiche in corteccia motoria e<br />
midollo spinale nel modello G93A, in diversi stadi di sviluppo.<br />
• Studio dei livelli di espressione di proteine fondamentali nella formazione<br />
del citoscheletro in corteccia motoria di G93A.<br />
• Analisi del ruolo che le cellule gliali (astrociti e microglia) hanno nella<br />
eccitotossicità NMDA-mediata in colture di neuroni corticali G93A.<br />
• Studio di meccanismi intracellulari e molecolari coinvolti nella aumentata<br />
mortalità dei neuroni corticali G93A in seguito ad esposizione con zinco<br />
ed NMDA.<br />
C.2.12 – Modulazione della trasmissione GABAergica mediata<br />
dalle amine in traccia in neuroni dopaminergici<br />
del mesencefalo ventrale (Nicola Biagio Mercuri)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Dopamina; Amine in traccia; Mesencefalo; Morbo di Parkinson;<br />
Elettrofisiologia; Meccanismi presinaptici; GABA.<br />
Descrizione<br />
Le amine in traccia (TA) sono amine endogene presenti in dosi minime<br />
nel cervello dei mammiferi. Tra esse abbiamo: la tiramina (TYR), la b-fenilalanina<br />
(b-PEA), la triptamina e l’ottopamina. Negli ultimi anni un’attenzione<br />
crescente è stata rivolta alle TA, soprattutto in seguito alla scoperta di una<br />
famiglia di recettori accoppiati a proteine G, tra cui il TA1 ed il TA2, attivati<br />
selettivamente da TYR e b-PEA. Varie evidenze suggeriscono un legame tra il<br />
sistema dopaminergico mesencefalico e le TA: esse infatti sono sintetizzate<br />
probabilmente dai neuroni dopaminergici della sostanza nera pars compacta<br />
(SNc), inoltre un’alta espressione di mRNA per il TA1 è stata rilevata sia nella<br />
SNc che nella reticolata (SNr) della sostanza nera. Sotto l’aspetto clinico, deficit<br />
nella regolazione dei livelli delle TA sono stati associati a malattie psichiatriche<br />
come la schizofrenia e la depressione, ed un ruolo potenziale di queste<br />
amine è stato suggerito per i disordini di iperattività da deficit di attenzione,<br />
emicrania, Morbo di Parkinson, tossicodipendenze e disordini alimentari.<br />
2007 429
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Il meccanismo d’azione delle TA per lungo tempo è stato considerato<br />
ristretto a quello di fattori anfetamino-simili, agenti dunque in grado di promuovere<br />
il rilascio di dopamina (DA), tuttavia sempre più sono le evidenze<br />
che suggeriscono un ruolo delle TA come neuromodulatori, che modificano<br />
l’attività di altri neurotrasmettitori. Nei neuroni dopaminergici della SNc, in<br />
particolare, il nostro laboratorio ha già in precedenza dimostrato che sia<br />
TYR che b-PEA sono in grado di ridurre l’inibizione mediata dalla stimolazione<br />
dei recettori GABAB, attraverso un meccanismo dipendente da proteine<br />
G.<br />
Dal momento che i recettori GABAB esercitano significative azioni anche<br />
a livello presinaptico, attraverso la nota inibizione del rilascio sia di GABA che<br />
di glutammato, risulta dunque interessante verificare se le TA siano in grado<br />
di modulare l’azione anche di questi recettori GABAB presinaptici. Questo<br />
permetterebbe di estendere la nostra comprensione del ruolo delle TA nel<br />
sistema nervoso centrale e di mettere in luce ulteriori target di azione dei loro<br />
recettori.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nel corso di questa prima fase del lavoro sperimentale è stato studiato il<br />
ruolo che le amine in traccia esercitano sui meccanismi inibitori GABA B<br />
dipendenti, in particolare su quelli che si esplicano a livello presinaptico.<br />
È stato prima di tutto necessario misurare il livello basale di tale effetto<br />
inibitorio, misurando le variazioni di frequenza delle correnti postsinaptiche<br />
inibitorie spontanee (sIPSCs). Il verificarsi di tali correnti è un effetto diretto,<br />
rilevato e misurato sul neurone postsinaptico, del rilascio di neurotrasmettitore<br />
da parte del terminale presinaptico; le eventuali variazioni dell’entità di<br />
tale rilascio inducono proporzionali e consensuali variazioni della frequenza e<br />
dell’ampiezza delle sIPSCs.<br />
Nei nostri esperimenti abbiamo osservato che l’applicazione di baclofen<br />
(1 mM) riduce significativamente la frequenza basale delle sIPSCs; tuttavia,<br />
se successivamente si aggiunge tiramina (100 mM), si osserva l’aumento<br />
della frequenza delle sIPSCs ad un valore prossimo a quello iniziale. Inoltre,<br />
alla sospensione della tiramina, la continuazione della perfusione con il solo<br />
baclofen riduce nuovamente la frequenza delle sIPSCs, in maniera statisticamente<br />
significativa. È interessante notare che l’applicazione della tiramina<br />
da sola non induce alcuna variazione della frequenza delle sIPSCs. Un<br />
effetto del tutto sovrapponibile si osserva per la b-fenilalanina (100 mM):<br />
anche questa riduce l’effetto inibitorio sulle sIPSCs indotto dal baclofen,<br />
senza tuttavia causare alcuna variazione quando applicata in assenza di<br />
baclofen.<br />
I risultati di questa fase del nostro studio estendono il ruolo delle amine<br />
in traccia, riconoscendole anche come modulatori delle variazioni, indotte da<br />
altre sostanze, del rilascio di neurotrasmettitore dal terminale presinaptico.<br />
Tale effetto è ascrivibile, come è stato dimostrato nel nostro laboratorio, ad un<br />
disaccoppiamento nella trasduzione del segnale tra recettore GABA B<br />
ed il suo<br />
effettore finale, il canale per il potassio accoppiato alle proteine G.<br />
430 2007
Attività previste<br />
Neuroscienze sperimentali<br />
Nelle prossime fasi del nostro lavoro verranno studiate le modalità di passaggio<br />
transmembrana delle amine in traccia, per poter meglio definire a<br />
quale livello effettivamente queste interagiscono nei processi di trasduzione<br />
del segnale; verranno inoltre indagate le eventuali variazioni dell’omeostasi<br />
ionica intracellulare indotta dalle tracce amine.<br />
C.2.13 – Modulazione GABAergica e dopaminergica dell’eccitabilità<br />
dei neuroni dopaminergici in colture organotipiche<br />
di mesencefalo di topo (Nicola Biagio Mercuri)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Dopamina; Trace-amine; GIRK; IPSP.<br />
Descrizione<br />
Abbiamo precedentemente descritto l’effetto pre-sinaptico e post-sinaptico<br />
delle amine in traccia (TA) sul rilascio di GABA sui neuroni dopaminergici<br />
della substantia nigra pars compacta (SNc), in fettine acute di mesencefalo<br />
ventrale. Nel nostro laboratorio abbiamo recentemente messo a punto le colture<br />
organotipiche di mesencefalo. Tale sistema è rappresentato da uno-pochi<br />
strati di neuroni e cellule gliali che mantengono le connessioni tra loro e possono<br />
essere mantenute in vitro per diverse settimane. Esso presenta il grosso<br />
vantaggio di poter essere trattato farmacologicamente per diversi giorni<br />
prima di effettuare lo studio elettrofisiologico e microfluorometrico. È possibile<br />
ad esempio studiare l’effetto di farmaci neuroprotettivi verso insulti<br />
ischemici/anossici, oppure quello di farmaci neurotossici. Infine è possibile<br />
studiare l’effetto di diverse condizioni di coltura (la presenza del tessuto target)<br />
sullo sviluppo neuronale.<br />
Andremo a valutare gli effetti delle TA in questo nuovo sistema, applicate<br />
acutamente e per alcune ore prima delle registrazioni elettrofisiologiche per<br />
valutare un potenziale effetto tossico.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Durante il 2006 la nostra Ricerca si è concentrata sullo studio degli effetti<br />
delle amine in traccia (TA) sul rilascio pre-sinaptico di GABA sui neuroni<br />
dopaminergici. Nonostante si tratti di amine endogene (la tiramina (TYR), la<br />
b-fenilalanina (b-PEA), la triptamina e l’ottopamina) presenti in dosi minime<br />
nel cervello dei mammiferi, negli ultimi anni le TA hanno riscosso un’attenzione<br />
crescente soprattutto in seguito alla scoperta di una famiglia di<br />
recettori accoppiati a proteine G, tra cui il TA1 ed il TA2, attivati selettivamente<br />
da TYR e b-PEA. Evidenze recenti hanno dimostrato un’alta espressione<br />
di mRNA per il TA1 sia nella sostanza nera compatta (SNc) che nella<br />
reticolata (SNr). In accordo con precedenti osservazioni, in quest’anno<br />
abbiamo trovato che l’agonista dei recettori GABA B<br />
baclofen (1 mM) riduce la<br />
2007 431
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
frequenza di correnti post-sinaptiche inibitorie spontanee (sIPSCs) da 16.5 ±<br />
1.1 a 12.4 ±0.6 Hz. Anche l’ampiezza degli sIPSCs è ridotta dal baclofen da<br />
29.1 ± 1.9 a 27.5 ± 1.7 pA, e ciò è probabilmente dovuto ad una riduzione del<br />
rilascio simultaneo di GABA da diverse aree. In presenza contemporanea di<br />
TYR (100 mM) e baclofen, la frequenza degli sIPSCs recupera parzialmente a<br />
14.5 ± 0.8 Hz indicando un effetto opposto della TYR sull’inibizione indotta<br />
da baclofen. In particolare, la TYR contrasta la riduzione della frequenza<br />
degli sIPSCs prodotta dal baclofen da 68.1 ± 2.8% a 85.4 ± 2.4% del controllo,<br />
in baclofen da solo e baclofen più TYR, rispettivamente. Analogamente, la b-<br />
PEA (100 mM), pur non modificando la frequenza basale degli sIPSCs, ha<br />
ridotto il grado di inibizione da parte del baclofen.<br />
In particolare la b-PEA contrasta la riduzione della frequenza degli<br />
sIPSCs operata dal baclofen da 65.7 ± 3.1% a 79.2 ± 1.9% del controllo, in<br />
baclofen da solo e baclofen più b-PEA, rispettivamente. Dato che nei neuroni<br />
dopaminergici le TA riducono le risposte post-sinaptiche indotte dai recettori<br />
GABA B<br />
interferendo con l’accoppiamento tra recettori GABA B<br />
e canali GIRK è<br />
anche possibile che esse riducano l’inibizione pre-sinaptica GABA B<br />
-mediata<br />
attraverso un meccanismo simile.<br />
Attività previste<br />
Preliminarmente, valuteremo le proprietà elettrofisiologiche intrinseche<br />
dei neuroni dopaminergici nelle colture organotipiche. In particolare, la presenza<br />
di firing spontaneo regolare, la risposta inibitoria all’applicazione di<br />
dopamina esogena e all’attivazione di recettori GABAB verranno valutate in<br />
colture iniziate a diverse età dell’animale (P2-P10). Infatti, l’espressione dei<br />
recettori D2 e GABAB, nonché di canali ionici come GIRK2, KATP, Ih nei neuroni<br />
dopaminergici in coltura, dipende dal grado di maturazione del tessuto<br />
di partenza. Per valutare se le condizioni di coltura possano influenzare<br />
l’espressione di tali proteine prepareremo co-colture, in cui cioè oltre che al<br />
mesencefalo ventrale verrà messo in coltura anche il tessuto target, rappresentato<br />
dallo striato dorsale.<br />
C.2.14 – Caratterizzazione di “ marcatori di danno ” in modelli<br />
sperimentali neurodegenerativi e di danno assonale<br />
(Marco Molinari)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Marcatori di danno; Stress ossidativo e nitrosativo; Danno<br />
assonale; Sistemi nitrergici e purinergici; Citocromo-c; Neurotossicità; Trimetil-stagno;<br />
Neurogenesi; Trasportatori del glutammato; Relina.<br />
Descrizione<br />
Obiettivo del progetto è lo studio di alcune molecole coinvolte nei meccanismi<br />
legati alla morte cellulare in modelli sperimentali di neurodegenera-<br />
432 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
zione. Tali molecole vengono definite genericamente “ marcatori di danno ”<br />
perché vengono indotte o si attivano dopo danno cellulare. Nel nostro laboratorio<br />
sono stati pianificati degli esperimenti che si propongono di andare a<br />
studiare alcune proteine coinvolte nello stress ossidativo e nitrosativo, nella<br />
risposta cellulare al danno, e nella disfunzione dei circuiti neurali. Questi<br />
esperimenti sono stati organizzati in quattro progetti principali con un grado<br />
di avanzamento differente a seconda dell’esperimento.<br />
Nel primo esperimento si valuterà l’induzione di marcatori di danno in<br />
un modello di danno assonale. Molte osservazioni sperimentali pongono lo<br />
stress ossidativo e nitrosativo come uno dei passaggi essenziali nei meccanismi<br />
legati alla morte cellulare in diversi tipi di insulti acuti come<br />
l’ischemia e il trauma, mentre esistono solo poche osservazioni riguardanti<br />
le patologie neurodegenerative. Il modello sperimentale da noi usato è<br />
quello del danno assonale, ottenuto attraverso una emicerebellectomia e<br />
che consente di seguire per tempi molto lunghi la progressione degli eventi<br />
degenerativi nelle stazioni precerebellari pontine ed olivari. I nostri obiettivi<br />
sono di andare a caratterizzare il fenotipo cellulare e la co-espressione,<br />
l’andamento temporale e la distribuzione anatomica del rilascio di citocromo-c,<br />
l’attivazione di caspasi, l’induzione dell’enzima NOS e dei recettori<br />
purinergici (sistemi nitrergici e purinergici). Nel secondo esperimento si<br />
valuterà l’espressione di marcatori di danno in un modello di neurotossicità<br />
basato sulla somministrazione di trimetil-stagno (TMT). La caratteristica<br />
peculiare di questo modello è la degenerazione selettiva delle cellule<br />
nell’ippocampo e di alcune aree limbiche corticali e subcorticali. I nostri<br />
obiettivi sono volti alla definizione della curva temporale di induzione di<br />
marcatori di danno ed alle possibili relazioni tra neurogenesi ed induzione<br />
dei sistemi nitrergici e purinergici. Nel terzo esperimento si valuterà<br />
l’espressione e la distribuzione in condizioni di base di marcatori fisiologici<br />
e di danno nel sistema orexinergico. Nel quarto esperimento si valuterà la<br />
connettività, la citoarchitettonica del cervelletto del topo Reeler attraverso<br />
l’utilizzo di marcatori anatomici e citologici. Il nostro obiettivo è di acquisire<br />
informazioni sui meccanismi istodismorfici prodotti dalla mutazione<br />
della proteina reelin.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Primo esperimento – Studio sull’induzione di marcatori di danno dopo<br />
assotomia. Sono stati prodotti una serie di dati nel nostro laboratorio che<br />
dimostrano come il sistema nitrergico e purinergico risultino attivati dopo<br />
lesione in neuroni e glia. In particolare, in un modello di assotomia del centrale<br />
sono state osservate attivazioni dell’enzima NOS e delle subunità P2X1 e<br />
P2X2 ristrette alle popolazioni neuronali i cui assoni erano stati danneggiati<br />
dalla lesione. Tali attivazioni coincidevano spazialmente e temporalmente<br />
suggerendo la presenza di un’interazione tra i due sistemi nella risposta neuronale<br />
al danno assonale. Il significato di questa interazione non è ancora<br />
stato chiarito, e sono stati suggeriti sia effetti neuroprotettivi che degenerativi<br />
[Florenzano et al., in preparation].<br />
2007 433
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Secondo esperimento – Studio sull’induzione di marcatori di danno in un<br />
modello di neurotossiticità. Abbiamo utilizzato un modello di lesione sperimentale<br />
neurotossica sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Anatomia<br />
della Università Cattolica. In questo modello viene ottenuta una lesione neurochimica<br />
selettiva in alcune aree attraverso la somministrazione di “ trimethyltin<br />
” (trimetil stagno) che induce citotossicità ed un conseguente stato<br />
epilettico. Abbiamo messo a punto la valutazione del danno citotossico attraverso<br />
l’analisi della morte neuronale nell’area ippocampale ed abbiamo incominciato<br />
ad analizzare l’espressione di alcuni marcatori di danno come<br />
l’enzima NOS ed i recettori purinergici nell’area di danno neuronale.<br />
Terzo esperimento – Studio sull’espressione e la distribuzione in condizioni<br />
di base di marcatori fisiologici e di danno nel sistema orexinergico. È stato<br />
svolto uno studio, con metodiche di immunoistochimica ed ibridizzazione in<br />
situ, nel quale abbiamo osservato la presenza della subunità P2X2, e solo<br />
quella, su tutti i neuroni orexinergici presenti nell’area dell’ipotalamo laterale.<br />
La presenza della subunità P2X2 presenta un particolare interesse, in quanto<br />
essa ha dimostrato di essere un fattore di attivazione della risposta cellulare in<br />
diversi paradigmi di lesione.<br />
Quarto esperimento – Studio sull’espressione dei trasportatori del glutammato<br />
nel cervelletto dei topi Reeler. Nel topo Reeler omozigote adulto abbiamo<br />
osservato modificazioni connettivali e citoarchitettoniche. Per la connettività<br />
abbiamo valutato i trasportatori del glutammato. L’immuoreattività per VGlut1<br />
si presentava conservata rispetto al topo wild type, mentre l’immuoreattività<br />
per VGlut2 si presentava profondamente alterata. La presenza di contatti glutammatergici<br />
VGluT2 positivi eterotopici e dismorfici indica una grave disorganizzazione<br />
della connettività cerebellare estrinseca. Per la citoarchitettonica<br />
abbiamo valutato sia gli elementi neuronali che gliali. Gli elementi gliali, gli<br />
astrociti, si presentavano con una distribuzione profondamente alterata con<br />
aree di astrocitosi diffusa ed aspecifica che suggeriva la presenza di uno stato<br />
infiammatorio cronico.<br />
– Amadio S, Tramini G, Martorana A, Viscomi MT, Sancesario G, Bernardi G,<br />
Volonté C (2006) Neuroscience 141(3): 1171-1180.<br />
– Florenzano F, Viscomi MT, Cavaliere F, Volonté C, Molinari M (2006) Advance Exp<br />
Med Biol 557: 77-100.<br />
– Florenzano F, Viscomi MT, Mercaldo V, Longone P, Bernardi G, Bagni C, Molinari<br />
M and Carrive P (2006) J Comp Neurol 498(1): 58-67.<br />
– Marinelli S, Di Marzo V, Florenzano F, Viscomi MT, Fezza F, van der Stelt M, Bernardi<br />
G, Molinari M, Maccarrone M and Mercuri NB (2007) Neuropsychopharmacol<br />
32: 298-308.<br />
– Martorana A, Giampà C, DeMarch Z, Viscomi MT, Patassini S, Sancesario G, Bernardi<br />
G, Fusco FR (2006) Europ J Neurosci 24(3): 732-738.<br />
Attività previste<br />
• Analisi dell’induzione dei marcatori di danno nella glia e relazioni tra<br />
attivazione gliale e danno neuronale. Modulazione dei marcatori di danno in<br />
434 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
seguito a trattamenti neuroprotettivi con glucocorticoide (metilprednisolone<br />
sodio succinato, solu-medrol) ed una tetraciclina (minociclina) dopo assotomia<br />
del centrale (emicerebellectomia).<br />
• Dopo lesione neurotossica indotta da somministrazione di trimetil stagno,<br />
andremo a verificare i rapporti spaziali e temporali nell’induzione dell’enzima<br />
NOS ed i recettori purinergici nell’ippocampo.<br />
• Sarà approfondita l’analisi degli aspetti dismorfici ed aberranti nella connettività<br />
e citoarchitettonica del topo Reeler omozigote adulto. Per acquisire<br />
una maggiore comprensione delle dismorfie osservate nel topo Reeler adulto, lo<br />
studio verrà effettuato anche nel periodo post-natale.<br />
C.2.15 – Alterazioni patologiche della plasticità sinaptica nello striato<br />
come modello di patologie neurodegenerative (Antonio Pisani)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Malattia di Parkinson; Striato; DJ-1; Pink1; Parkin; Plasticità<br />
sinaptica; Elettrofisiologia.<br />
Descrizione<br />
Lo striato è una struttura cerebrale coinvolta nell’apprendimento e nella<br />
memoria motoria. Alterazioni della funzionalità striatale sono alla base di<br />
patologie neurodegenerative come la malattia di Parkinson. La forma più diffusa<br />
della malattia di Parkinson è sporadica ed è caratterizzata dall’esordio in<br />
età avanzata. Sono però note anche rare forme genetiche a trasmissione autosomica<br />
recessiva, che sono caratterizzate da mutazioni nei geni DJ-1, Pink1,<br />
Parkin e si caratterizzano per l’esordio giovanile.<br />
Poiché si ritiene che i fenomeni di plasticità sinaptica a lungo termine a<br />
carico dei neuroni di proiezione dello striato (potenziamento e depressione)<br />
costituiscano il meccanismo cellulare sottostante l’apprendimento e la memoria<br />
motoria, abbiamo ipotizzato che alterazioni nell’espressione di plasticità<br />
striatale possano sottendere la sintomatologia della malattia di Parkinson,<br />
caratterizzata dall’insorgenza di disordini del movimento. A sostegno di questa<br />
ipotesi, in un modello animale ben caratterizzato della forma sporadica di<br />
malattia di Parkinson avevamo osservato che i neuroni striatali avevano perso<br />
la capacità di esprimere entrambe le forme di plasticità sinaptica. Durante il<br />
primo anno della ricerca, per verificare se alterazioni della plasticità sinaptica<br />
striatale costituiscano una caratteristica fisiopatologica comune anche alle<br />
forme genetiche di malattia di Parkinson, abbiamo esteso queste osservazioni<br />
ad un modello di topi con la delezione del gene Pink1.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nel primo anno di ricerca sono state analizzate le caratteristiche elettrofisiologiche<br />
intrinseche di neuroni striatali, in due modelli genetici di malattia<br />
di Parkinson, i topi knock-out per il gene Pink1 o Parkin. Sono state utilizzate<br />
2007 435
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
tecniche di registrazione intracellulare e di patch clamp. In particolare sono<br />
stati studiati neuroni principali spinosi, interneuroni colinergici (LA) e interneuroni<br />
Fast Spiking (FS). Le proprietà intrinseche di membrana di ogni tipo<br />
cellulare non sono risultate alterate rispetto ai topi wild-type di controllo. La<br />
caratterizzazione elettrofisiologica degli interneuroni Fast Spiking è stata integrata<br />
con uno studio morfologico di microscopia elettronica realizzato in collaborazione<br />
con il prof. Yoland Smith della Emory University Atlanta USA.<br />
Successivamente sono state studiate le risposte sinaptiche delle sopraddette<br />
classi neuronali striatali, di cui sono state valutate ampiezza, durata e caratteristiche<br />
farmacologiche. Benché le proprietà sinaptiche siano risultate paragonabili<br />
a quelle di controllo, i neuroni spinosi striatali dei topi Pink1-/-<br />
hanno mostrato alterazioni in entrambe le forme di plasticità, non essendo<br />
infatti in grado di esprimere né LTP né LTD.<br />
– Bonsi P, Sciamanna G, Mitrano DA, Cuomo D, Bernardi G, Platania P, Smith Y,<br />
Pisani A (in press) Functional and ultrastructural analysis of group I mGluR in<br />
striatal fast-spiking interneurons. Eur J Neurosci.<br />
Attività previste<br />
Durante il secondo anno di attività verrà approfondito lo studio farmacologico<br />
della plasticità sinaptica in neuroni spinosi striatali nel modello genetico<br />
dei topi knock-out per il gene Pink1. In particolare, verrà studiata, con<br />
tecniche intracellulari convenzionali, la capacità di molecole ad azione dopamino-agonista<br />
di tipo D1 e/o D2 di ripristinare una normale plasticità sinaptica<br />
nei topi Pink1-/-, la cui espressione, dai dati ottenuti durante il primo<br />
anno di ricerca, è risultata severamente compromessa. In un precedente studio<br />
condotto su di un differente modello genetico di Parkinson (DJ-1),<br />
abbiamo infatti osservato che il quinpirolo (agonista del recettore di tipo D2<br />
della dopamina) è in grado di ripristinare l’LTD, che in questi neuroni risultava<br />
essere assente [Goldberg, Pisani et al. (2005) Neuron 45: 489-496].<br />
In seguito, entrambi i fenomeni di plasticità sinaptica, LTP e LTD, verranno<br />
studiati anche nell’altro modello genetico di malattia di Parkinson, i<br />
topi knock-out per il gene Parkin. In particolare, verranno studiati neuroni<br />
principali spinosi dello striato per confrontare le osservazioni con i dati ottenuti<br />
dal modello dei topi Pink1-/- precedentemente analizzato. Il riscontro di<br />
eventuali alterazioni della plasticità sinaptica tra topi Parkin-/- e animali di<br />
controllo non portatori di mutazione costituirà la base per un successivo studio<br />
più prettamente farmacologico della plasticità sinaptica. Farmaci specifici,<br />
quali agonisti ed antagonisti dopaminergici e glutammatergici, verranno<br />
utilizzati per caratterizzare in dettaglio la natura delle alterazioni riscontrate<br />
al fine di tentare di ripristinare una normale funzionalità sinaptica.<br />
Infine, verranno valutate, utilizzando tecniche di patch-clamp, le correnti<br />
postsinaptiche spontanee, sia di tipo GABAergico inibitorio (IPSC), sia di tipo<br />
glutammatergico eccitatorio (EPSC). Il confronto di parametri quali ampiezza<br />
e frequenza degli eventi registrati dai topi transgenici o dai rispettivi controlli<br />
fornirà ulteriori indicazioni sulla natura delle eventuali alterazioni della<br />
trasmissione sinaptica.<br />
436 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
C.2.16 – Alterazioni di Fosfodiesterasi specifiche nei neuroni striatali<br />
in un modello di parkinsonismo sperimentale nel ratto<br />
(Giuseppe Sancesario)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Morbo di Parkinson; L-DOPA; Fosfodiesterasi.<br />
Altri Enti coinvolti: Università dell’Aquila.<br />
Descrizione<br />
La dopamina ricopre un ruolo importante nella modulazione della attività<br />
sinaptica nello striato: la sua azione sui recettori dopaminergici D1 e D2<br />
nei neuroni striatali determina rispettivamente l’attivazione o la inibizione<br />
della adenil ciclasi, regolando in modo opposto la sintesi del secondo messaggero<br />
AMP ciclico (cAMP). Un gran numero di processi biologici sono infatti<br />
regolati dai livelli intracellulari dei secondi messaggeri (cAMP) e GMP ciclico<br />
(cGMP), la cui azione è interrotta dall’intervento di fosfodiesterasi (PDE) specifiche.<br />
Pur non esistendo al momento alcuna documentazione sull’attività<br />
delle PDE nella malattia di Parkinson [Kakkar et al. (1999) Cell Mol Life Sci<br />
55: 1164–1186], numerosi indizi sperimentali suggeriscono che in tale patologia<br />
si verificano alterazioni della modulazione della sintesi nonché del catabolismo<br />
dei nucleotidi ciclici [Hossain and Weiner (1993) J Pharmacol Exp Ther<br />
267: 1105-1111; Kotter (1994) Prog Neurobiol 44:163-196; Sancesario et al.<br />
(2004) Eur J Neurosci 20: 989-1000]. In particolare, recentemente, è stato<br />
dimostrato, in un modello sperimentale di Parkinson nel ratto, che la lesione<br />
della via dopaminergica con 6-idrossidopamina (6-OHDA) determina nello<br />
striato profonde ed opposte modificazioni dei livelli di cAMP e cGMP come<br />
conseguenza di una ridotta espressione della nNOS [Sancesario et al. (2004)<br />
Eur J Neurosci 20: 989-1000].<br />
Dal momento che l’NO agisce da secondo messaggero nella trasmissione<br />
glutammatergica, è stato suggerito che la ridotta espressione striatale della<br />
nNOS e di conseguenza la ridotta sintesi di NO, dopo 6-OHDA, possa rappresentare<br />
un meccanismo compensatorio che va a controbilanciare una trasmissione<br />
glutammatergica corticostriatale drammaticamente aumentata dopo la<br />
lesione con 6-OHDA [Calabresi et al. (1993) Brain 116: 433-452]. Riveste particolare<br />
interesse l’osservazione che, nello striato deafferentato, non solo si<br />
determina un’alterazione della via dopamina-cAMP, paradossalmente in<br />
eccesso, ma anche un’alterazione in difetto della via ossido nitrico-cGMP<br />
[Sancesario et al. (2004) Eur J Neurosci 20: 989-1000].<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Noi abbiamo recentemente dimostrato in un modello murino di Parkinson<br />
sperimentale che la lesione della via dopaminergica determina nello<br />
striato e nel globo pallido profonde ed opposte modificazioni dei livelli di<br />
cAMP e cGMP, con un inaspettato aumento del primo ed una riduzione del<br />
2007 437
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
secondo; abbiamo inoltre chiarito che nello striato e nel globo pallido queste<br />
modificazioni sono dipendenti non solo dalla primaria compromissione della<br />
trasmissione dopaminergica, ma anche da un’alterata espressione ed attività<br />
di specifiche fosfodiesterasi (PDE), gli enzimi che, deciclizzando il cAMP ed il<br />
cGMP, ne regolano i livelli intracellulari. Abbiamo verificato come un inibitore<br />
selettivo (zaprinast) delle fosfodiesterasi PDE5 e PDE1B possa aggravare<br />
nel ratto con una lesione della sostanza nera la difficoltà ad apprendere una<br />
risposta differita ad uno stimolo condizionato.<br />
Abbiamo infine verificato come in questo modello l’uso cronico della terapia<br />
con L-DOPA possa modificare i livelli di cAMP e il cGMP e come i livelli di questi<br />
possano essere profondamente diversi negli animali che presentano discinesie da<br />
L-DOPA. Non è tuttavia al momento chiaro se gli alterati livelli dei secondi messaggeri<br />
negli animali che sviluppano discinesie da L-DOPA possano essere dipendenti<br />
da modificazioni del “ rate ” della sintesi o del loro catabolismo.<br />
Attività previste<br />
Scopo del nostro progetto è quello di chiarire i meccanismi della alterata<br />
regolazione di cAMP e cGMP nello striato dopo deafferentazione dopaminergica<br />
in condizioni basali, dopo trattamento con L-DOPA e dopo trattamento<br />
con inibitori selettivi delle fosfodiesterasi. A tal fine condurremo:<br />
• Studio immunocitochimico nel ratto e nell’uomo della localizzazione<br />
cellulare delle differenti isoforme di PDE specifiche dei gangli della base e<br />
delle relative variazioni dopo deafferen-tazione nigrostriatale.<br />
• Studio biochimico delle variazioni della attività, della espressione e<br />
degli mRNA delle differenti isoforme di PDE specifiche dei gangli della base<br />
dopo deafferentazione nigrostriatale nel ratto, nel cervello umano di controllo<br />
e nel paziente affetto da Morbo di Parkinson.<br />
C.2.17 – Analisi della regolazione post-trascrizionale della espressione<br />
genica nel differenziamento neuronale (Claudio Sette)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Metabolismo degli mRNA; Differenziamento; Sam68.<br />
Altri Enti coinvolti: Università di Roma Tor Vergata<br />
Descrizione<br />
La regolazione post-trascrizionale della espressione genica assume una<br />
rilevanza particolare in sistemi cellulari complessi quali i neuroni. Queste<br />
cellule presentano un pattern di splicing alternativo peculiare di geni<br />
espressi anche in altri tipi cellulari. Inoltre, la trascrizione e la traduzione di<br />
mRNA possono diventare spazialmente separate nei neuroni, e gli mRNA<br />
sono trasportati da proteine specifiche lungo i dendriti e gli assoni per<br />
essere tradotti in proteine nella periferia della cellula. L’importanza della<br />
regolazione post-trascrizionale della espressione genica nei neuroni è con-<br />
438 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
fermata dagli elevati livelli di espressione di proteine leganti gli mRNA nel<br />
cervello e dalle patologie indotte da mutazioni in alcuni dei geni codificanti<br />
per esse. Il nostro laboratorio si occupa della proteina di legame all’RNA<br />
chiamata Sam68. Essa è fortemente espressa nei neuroni ed è stato dimostrato<br />
che Sam68 viene indotta durante il differenziamento di cellule staminali<br />
neuronali in neuroni maturi. Recentemente è stato anche dimostrato<br />
che Sam68 è espressa nei neuroni ippocampali della corteccia e che la depolarizzazione<br />
di questi neuroni induce la sua traslocazione in granuli dendritici<br />
suggerendo un ruolo regolatorio di questa proteina nel metabolismo di<br />
specifici mRNA.<br />
Esperimenti condotti in altri sistemi cellulari hanno dimostrato che<br />
Sam68 partecipa a diversi aspetti del metabolismo cellulare degli mRNA,<br />
quali lo splicing, l’esporto ed il rilascio citoplasmatico di mRNA ed il controllo<br />
traduzionale. È stato proposto che Sam68 funzioni da sistema di ricezione dei<br />
segnali di trasduzione di stimoli esterni alla cellula e modulando l’utilizzo di<br />
RNA bersaglio. Infatti questa proteina è modificata post-traduzionalmente da<br />
eventi di fosforilazione, metilazione ed acetilazione che ne modulano la capacità<br />
di legame degli RNA.<br />
Il nostro laboratorio ha inoltre recentemente dimostrato che Sam68 associa<br />
con i polisomi ingaggiati nella traduzione in risposta a segnali di progressione<br />
del ciclo cellulare, suggerendo un ruolo di controllo traduzionale per<br />
questa proteina. Abbiamo anche identificato alcuni degli mRNA legati da<br />
Sam68 e tra questi abbiamo osservato alcuni per proteine fondamentali per lo<br />
sviluppo neuronale quali Bcl-x, Neogenina, Mash1 e Tipin (Timeless interacting<br />
protein).<br />
In questo progetto ci proponiamo di studiare la regolazione di questi<br />
mRNA da parte di Sam68 in neuroni normali o sottoposti a stress degenerativo.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Abbiamo caratterizzato la regolazione post-trascrizionale di uno dei bersagli<br />
di Sam68: Bcl-x. Esperimenti di silenziamento genico e di espressione<br />
transiente di forme di Sam68 mutate hanno dimostrato che questa proteina<br />
modula la scelta dei siti di splicing alternativo di Bcl-x. In particolare, un<br />
aumento di espressione di Sam68 induce l’espressione della forma Bcl-x(s), ad<br />
attività pro-apoptotica. L’azione di Sam68 su Bcl-x correla con la capacità<br />
della proteina di indurre apoptosi in cellule trasfettate in modo transiente.<br />
L’attività di Sam68 richiede la sua associazione con hnRNP A1 ed è contrastata<br />
dallo splicing factor ASF/SF2. Inoltre, abbiamo dimostrato che la tirosin<br />
chinasi Fyn reverte l’azione di Sam68, trasformandola da pro-apoptotica a<br />
anti-apoptotica. L’effetto di Fyn è mediato dalla fosforilazione di Sam68 su<br />
residui di tirosina localizzati all’estremità C-terminale della proteina. La fosforilazione<br />
influenza anche la localizzazione sub-nucleare di sam68 ed interferisce<br />
con la sua capacità di associare con hnRNP A1.<br />
Visto il coinvolgimento di Bcl-x nello sviluppo embrionale del sistema<br />
nervoso centrale, i nostri studi mettono in luce una possibile azione di Sam68<br />
sulla genesi delle isoforme necessarie alla sopravvivenza dei neuroni.<br />
2007 439
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Per verificare questa ipotesi, abbiamo messo appunto condizioni colturali<br />
per ottenere un efficiente differenziamento delle cellule staminali embrionali<br />
(ES) in neuroni. Al momento, stiamo effettuando esperimenti di silenziamento<br />
per RNA interference di Sam68 al fine di valutare il ruolo di questa<br />
proteina in tale differenziamento. In particolare, seguiremo l’espressione dei<br />
bersagli molecolari di sam68 descritti sopra. In questo anno abbiamo anche<br />
descritto il ruolo di Sam68 sulla sopravvivenza cellulare delle cellule LNCaP,<br />
un tumore di prostata di derivazione neuroendocrina.<br />
Attività previste<br />
• Lo studio del ruolo di Sam68 nel differenziamento neuronale delle cellule<br />
ES.<br />
• La caratterizzazione dei bersagli molecolari di sam68 coinvolti in questo<br />
processo.<br />
• L’approfondimento del meccanismo di azione di Sam68 sui bersagli<br />
molecolari identificati.<br />
C.2.18 – Attualità della trasmissione neurotensinergica nel modello<br />
di parkinsonismo da 6-OHDA: immunochimica<br />
ed elettrofisiologia in vivo tra animali denervati<br />
e denervati con discinesie (Alessandro Stefani)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Neuropeptidi; Elettrofisiologia; Immunochimica; Parkinson<br />
sperimentale; Globo pallido.<br />
Altri Enti coinvolti: Università di Roma Tor Vergata.<br />
Descrizione<br />
Non disponiamo di informazioni sufficienti sul ruolo endogeno dei neuropeptidi<br />
nei gangli della base di mammifero. Poco chiare sono le risultanze<br />
relative a neurotensina (NT) e Sostanza P (SP) benché le loro interazioni con<br />
le amine biogene siano state suggerite da tempo dalla farmacologia clinica.<br />
Il territorio oggetto di questa ricerca corrente attiene all’approfondimento<br />
degli effetti neurofisiologici di tali peptidi nel globo pallido (o pallido<br />
esterno) di ratto adulto. Esamineremo l’azione esercitata da NT e SP su correnti<br />
calciche ad alta soglia (in prevalenza da neuroni dissociati con metodo<br />
enzimatico). Una modulazione delle stesse dovrebbe apportare significative<br />
modifiche al pattern di scarica dei neuroni esaminati, con riflessi plausibili<br />
sulla cascata di fosforilazioni intracellulari e sull’attività di release a valle. La<br />
ricerca viene integrata con indagini immuno-istochimiche, tese a convalidare<br />
la presenza dei recettori specifici per NT (in particolare il sottotipo NTS1,<br />
sensibile a SR48692 e SR142948), e la loro distribuzione sia in termini di<br />
regionalizzazione (predominanza nei settori laterodorsali del GP) che di colocalizzazione<br />
(con parvalbumina e/o CHAT).<br />
440 2007
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Neuroscienze sperimentali<br />
Abbiamo approfondito l’azione del tricapeptide neurotensina (NT) nel<br />
globo pallido (GP) di ratto. NT, come è noto, viene considerata una sorta di<br />
“ neurolettico endogeno ” per l’interferenza con la trasmissione dopaminergica.<br />
La gran parte delle evidenze sin qui accumulate depone per una prevalente<br />
azione esplicata attraverso i neuroni principali dello striato (e non del<br />
GP). Peraltro, precedenti risultati del nostro gruppo [1] avevano suggerito che i<br />
recettori per NT di cosiddetto tipo 1 (NTS1, non sensibili all’antiistaminico<br />
levocabastina) sono distribuiti ed in misura abbondante su almeno 1/3 dei<br />
neuroni GP [1] . Alla radice del nostro studio, dunque, stavano diversi quesiti<br />
aperti:<br />
– Esiste una azione fisiologica di NT sulle conduttanze calciche del GP [2]<br />
e non solo nello striato?<br />
– È verosimile che NT eserciti effetti postsinaptici su neuroni acutamente<br />
dissociati ?<br />
Il progetto ha permesso di porre in evidenza i seguenti aspetti [3] :<br />
– NT inibisce le correnti calciche ad alta soglia.<br />
– L’azione è farmacologicamente specifica (significativamente più potente<br />
il frammento attivo, c.d. 8-13 e viene efficacemente antagonizzata da antagonisti<br />
NTS1 SR48692 e SR142948, a dosi 1-10 micromolare).<br />
– L’effetto è relativamente voltaggio-indipendente, rapidamente reversibile,<br />
senza desensitizzazione e richiede il coinvolgimento di G proteine (impedito<br />
dalla pre-incubazione con la NEM).<br />
– La conduttanza modulata da NT è conotossina GVIA sensibile, ergo<br />
una classica corrente di tipo N.<br />
Un capitolo a parte è quello relativo alla determinazione di quali neuroni<br />
del neuropilo GP siano sensibili a NT. L’inibizione del calcio voltaggiodipendente<br />
è rilevato in circa il 56% delle registrazioni, prevalendo su neuroni<br />
a fenotipo “ piccolo-medio ” (tipo I, 1). Sebbene non inequivocabilmente ascrivibili<br />
ai Parvalbumino-negativi, tali cellule sono prive di correnti calciche a<br />
bassa soglia e, condividono, con NT, la responsività al baclofen [3] .<br />
Il dato funzionale saliente dunque è quello di una sottopopolazione di cellule<br />
GP, abbondanti nella regione più limitrofa allo striato, peculiarmente sensibili<br />
alla trasmissione NT e GABA-B (benché non additive), entrambe assicurando<br />
un tono inibitorio endogeno al calcio postsinaptico. I riflessi di tali dati<br />
(in che misura modifichino l’eccitabilità cellulare ed il release di GABA e glutammato)<br />
vanno valutati in modelli a circuitistica conservata, come registrazioni<br />
elettrofisiologiche in vivo.<br />
1. Martorana A, Fusco FR, D’Angelo V, Sancesario G, Bernardi G (2003) Exp Neurol<br />
183(2): 311-319.<br />
2. Hainsworth AH, Randall AD, Stefani A (2006) Methods Mol Biol 312: 161-179.<br />
3. Martorana A, Martella G, D’Angelo V, Fusco FR, Spadoni F, Bernardi G, Stefani A<br />
(2006) Synapse 60(5): 371-383.<br />
2007 441
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Attività previste<br />
Gli sviluppi futuri della ricerca sono incentrati su diverse direttive:<br />
• In che misura la descritta modulazione si traduce in una tangibile<br />
modificazione del firing di GP registrato con tecniche elettrofisiologiche<br />
extracellulari in vivo. In altri termini, chiariremo se NT influenzi l’eccitabilità<br />
spontanea dei neuroni GP verrà indagato con applicazioni per via iontoforetica<br />
diretta (in GP) e mediata (in striato). L’aspetto più qualificante del progetto<br />
consta nel fatto che confronteremo tali effetti a registrazioni svolte in un<br />
modello sperimentale di parkinsonismo (lesione da 6-idrossidopamina).<br />
• Si aggiunga, a tale riguardo, che la verifica degli effetti NT-mediati sarà<br />
praticata non solo su naive vs. lesionati ma anche su lesionati vs. roditori che<br />
(a seguito di priming e trattamento con L-DOPA) abbiano manifestato (o<br />
meno) movimenti involontari. In sostanza otterremo una stima credibile di<br />
quanto NT influenzi il “ behavior ” fisiologico dopamino-dipendente nell’asse<br />
striato-pallidale (porzione della cosiddetta via indiretta del modello circuitistico<br />
dei gangli della base).<br />
• L’altra linea guida del progetto corrente attiene alla pathway endogena<br />
dell’ossido nitrico (NO) e all’ipotesi che gli effetti di NT interagiscono con la<br />
cascata NO-GC.<br />
C.2.19 – Investigazioni di Proteomica e Metabonomica nelle sindromi<br />
neurodegenerative (Andrea Urbani, Giorgio Federici)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Alzheimer; Sclerosi Multipla; Malattie Neurodegenerative;<br />
Proteomica; Metabonomica.<br />
Altri Enti coinvolti: Università di Roma Tor Vergata; Università di Chieti<br />
G. D’Annunzio.<br />
Descrizione<br />
La Proteomica è una disciplina che permette una analisi induttiva, olistica,<br />
dei polipeptidi presenti in un campione biologico. Questa unisce le separazioni<br />
di polipeptidi, analisi di spettrometria di massa ed inferenza dei dati ottenuti su<br />
banche dati genomiche e/o di proteine. L’analisi del profilo metabolico viene<br />
anch’essa svolta mediante una indagine aperta accoppiando sistemi liquido cromatografici<br />
accoppiati a spettrometri di massa operanti in alta risoluzione con<br />
analisi statistiche multivariate al fine di ricostruire gruppi (cluster) di metaboliti<br />
specifici di una determinata condizione.<br />
Il nostro scopo è quello della valutazione dei profili di espressione differenziale<br />
di proteine e metaboliti al fine di dissezionare il ruolo biochimico<br />
di un definito pattern molecolare nell’ambito di specifiche sindromi neurodegenerative.<br />
Queste indagini potranno portare alla identificazione di marcatori<br />
molecolari di diagnosi e/o prognosi oltre a poter fornire delle informazioni<br />
442 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
sull’identificazione di nuovi potenziali bersagli molecolari di trattamento.<br />
Le patologie del sistema nervoso centrale che verranno considerate all’interno<br />
di questo programma sono la Sclerosi multipla ed la demenza di Alzheimer in<br />
quanto rappresentative di due patologie neurodegenerative assolutamente<br />
non correlate tra loro. Per il programma sulla Sclerosi multipla verranno<br />
comparati campioni di CSF e plasma di pazienti affetti da SM con differenti<br />
gruppi clinici affetti da patologie autoimmuni periferiche (Guillain-Barré,<br />
Artrite reumatoide, etc.). Per il programma sul morbo di Alzheimer verranno<br />
realizzate delle indagini differenziali con altri gruppi clinici di demenze quali:<br />
demenze a corpi di Lewi, frontotemporale e vascolare. Una validazione funzionale<br />
dei meccanismi molecolari messi in luce mediante questa tecnologia<br />
verrà realizzata sia attraverso lo studio di modelli cellulari in vitro ed ex-vivo<br />
da modelli animali disponibili all’interno del CERC: modello di topo transgenico<br />
APPsw per il morbo di Alzheimer, modello di topo con encefalite allergica<br />
acuta per la sclerosi multipla.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Le tecnologie allo stato dell’arte di spettrometria di massa sono il nostro<br />
punto di forza nello sviluppare indagini multivariate di biochimica clinica sia<br />
nello studio del Proteoma che del profilo Metabolico. In particolare ci siamo<br />
concentrati nello studio di campioni clinici (plasma, CSF) di pazienti.<br />
L’investigazione del liquor cerebro spinale (CSF) e del plasma dei pazienti<br />
arruolati è stata inizialmente sviluppata mediante spettrometria di massa<br />
MALDI-TOF-MS lineare. Queste indagini danno la possibilità di sviluppare<br />
dei saggi veloci e riproducibili di “ protein profiling ”. Questa tecnica permette<br />
lo screening di polypeptidi di basso peso molecolare, 800-20000 Da, potendo<br />
facilmente campionare un alto numero di soggetti e di condizioni di arricchimento.<br />
Tali indagini sono in corso presso i nostri laboratori con risultati che<br />
mettono in luce una risoluzione di massa superiore a 1500 FWHM a 15000<br />
AMU ed una accuratezza di massa di +/- 1 AMU dopo calibrazione interna<br />
basata sulle catene dell’emoglobina.<br />
I segnali con una segregazione significativa (p
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
• Analisi mulivariata di “ protein profiling ” dei gruppi clinici. A questa<br />
seguirà una prima indagine di Metabonomica. Indagini di 2DE PAGE del<br />
repertorio proteico del CSF in gruppi clinici selezionati sulla base dei dati raccolti<br />
precedentemente.<br />
• Completamento dell’acquisizione della casistica necessaria al progetto<br />
sulle demenze ed analisi mutivariata di “ protein profiling ” di CSF e siero.<br />
• Sviluppo di un modello cellulare in vitro bassato su linee umane di neuroblastoma<br />
SH-5YSY per valutare l’effetto molecolare di farmaci in grado di<br />
alterare i meccanismi di degradazione proteica.<br />
– Angelucci A, Valentini A, Millimaggi D, Gravina GL, Miano R, Dolo V, Vicentini C,<br />
Bologna M, Federici G, Bernardini S (2006) Anticancer Drugs 17(10): 1141-1150.<br />
– Bernardini S, Nuccetelli M, Noguera NI, Bellincampi L, Lunghi P, Bonati A,<br />
Mann K, Miller WH Jr, Federici G, Lo Coco F (2006) Ann Hematol 85(10):<br />
681-687.<br />
– Biroccio A, Del Boccio P, Panella M, Bernardini S, Di Ilio C, Gambi D, Stanzione P,<br />
Sacchetta P, Bernardi G, Martorana A, Federici G, Stefani A, Urbani A (2006) Proteomics<br />
6(7): <strong>23</strong>05-<strong>23</strong>13.<br />
– Bonomini M, Pavone B, Sirolli V, Del Buono F, Di Cesare M, Del Boccio P, Amoroso<br />
L, Di Ilio C, Sacchetta P, Federici G, Urbani A (2006) J Proteom Res 5(10):<br />
2666-2674.<br />
– Del Boccio P, Pieragostino D, Lugaresi A, Di Ioia M, Pavone B, Travaglini D,<br />
D’Aguanno S, Bernardini S, Sacchetta P, Federici G, Di Ilio C, Gambi D, Urbani A<br />
(2006) Ann Neurol Sep 27 [Epub ahead of print].<br />
– Del Boccio P, Urbani A (2005) Annali ISS 41(4): 479-482. Review.<br />
– Candiano G, Musante L, Bruschi M, Petretto A, Santucci L, Del Boccio P, Pavone<br />
B, Perfumo F, Urbani A, Scolari F, Ghiggeri GM (2006) J Am Soc Nephrol<br />
17(11): 3139-3148.<br />
– Greco M, Chiriaco F, Del Boccio P, Tagliaferro L, Acierno R, Menegazzi P, Pinca E,<br />
Pignatelli F, Storelli C, Federici G, Urbani A, Maffia M (2006) Proteomics 6(19):<br />
5350-5361.<br />
– Musante L, Bruschi M, Candiano G, Petretto A, Dimasi N, Del Boccio P, Urbani A,<br />
Rialdi G, Ghiggeri GM (2006) Biochem Biophys Res Commun 349(2): 668-673.<br />
– Spalletta G, Bernardini S, Bellincampi L, Federici G, Trequattrini A, Caltagirone C<br />
(2006) Eur J Neurol 13(2): 176-182.<br />
– Valentini A, Pucci D, Crispini A, Federici G, Bernardini S (2006) Chem Biol Interact<br />
161(3): 241-250.<br />
C.2.20 – Patologie neurodegenerative e recettori purinergici<br />
(Cinzia Volonté)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Recettori P2 metabotropici; Interazioni recettoriali; Oligomerizzazione;<br />
Struttura quaternaria.<br />
Altri Enti coinvolti: Consiglio Nazionale delle Ricerche.<br />
444 2007
Descrizione<br />
Neuroscienze sperimentali<br />
I recettori purinergici P2 per i nucleotidi extracellulari sono ampiamente distribuiti<br />
nel sistema nervoso centrale e periferico. La famiglia dei recettori P2 si<br />
divide in due sottofamiglie: recettori ionotropici ad attivazione veloce, P2X, dei<br />
quali sono stati finora identificati sette diverse subunità (P2X 1-7<br />
), e recettori metabotropici<br />
accoppiati alle proteine G, P2Y, dei quali sono state clonate otto subunità<br />
fra loro differenti (P2Y 1-2,4,6,11-14<br />
). Pur essendo distinti in struttura primaria-terziaria,<br />
ulteriori eterogeneità fra tali recettori si manifestano anche a livello di<br />
struttura quaternaria. Mentre è stato ampiamente dimostrato che le subunità dei<br />
recettori P2X si associano tra loro per formare complessi omo- ed etero-oligomerici<br />
con struttura quaternaria di tipo trimerico, ben poco è ancora noto, invece,<br />
dell’architettura dei recettori metabotropici P2Y.<br />
Sebbene i modelli classici indichino che i recettori accoppiati a proteine G<br />
(GPCR) siano espressi solo come monomeri, studi recenti hanno invece dimostrato<br />
che anche i GPCR esistono sotto forma di complessi dimerici e multimerici<br />
di tipo omo- od etero-merico. In tal senso, è stato provato che il recettore P2Y 1<br />
forma dei dimeri con i recettori A1 ed A2A per l’adenosina, e che la regolazione di<br />
tali complessi sia sotto il controllo degli agonisti specifici di entrambe le famiglie<br />
di proteine. È stato inoltre dimostrato che la subunità P2Y 4<br />
si associa al recettore<br />
del glutammato NMDAR1 ed al recettore a bassa affinità per l’NGF, p75. Nel loro<br />
insieme, questi dati inducono quindi ad ipotizzare che i recettori P2Y posseggano<br />
delle sequenze specifiche che permetterebbero loro di associarsi a formare dei<br />
complessi oligomerici anche all’interno della stessa famiglia P2Y.<br />
Nel presente programma di ricerca si intende pertanto studiare la potenziale<br />
interazione delle diverse subunità della famiglia dei recettori P2Y a formare complessi<br />
recettoriali di ordine superiore.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Nell’ambito dell’attività di ricerca, abbiamo analizzato la distribuzione in<br />
particolare del recettore metabotropico P2Y12 nel sistema nervoso centrale<br />
di ratto, per mezzo di reazioni immunoenzimatiche, tecniche immunoistologiche<br />
e di western blotting, analisi al microscopio elettronico. Abbiamo localizzato<br />
il recettore P2Y12 esclusivamente negli oligodendrociti di corteccia<br />
cerebrale e nuclei subcorticali (striato e substantia nigra), non colocalizzando<br />
tale recettore con il generico marker neuronale NeuN ed NFL, con lo<br />
specifico marker neuronale calbindina per lo striato, tiroxina idrossilasi per<br />
la substantia nigra, con il marcatore microgliale IB4 e quello astrocitario<br />
GFAP. Abbiamo invece osservato colocalizzazione tra il recettore P2Y12 e<br />
l’MBP, che riconosce i corpi cellulari degli oligodendrociti e gli avvolgimenti<br />
mielinici, ed il RIP, che individua solo i corpi degli oligodendrociti ed i loro<br />
processi multipli che terminano in prossimità degli avvolgimenti mielinici,<br />
ma non la mielina stessa nella porzione distale degli assoni.<br />
Ad elevato ingrandimento, abbiamo notato fibre P2Y12-MBP positive<br />
contenenti strutture segmentali costituite da brevi tratti d’interruzione della<br />
mielina, che sono rispettivamente regioni internodali della fibra e nodi di<br />
Ranvier. Inoltre, abbiamo osservato piccole strutture P2Y12-MBP positive<br />
2007 445
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
con corti processi radiali, che assomigliano a corpi cellulari di oligodendrociti<br />
adiacenti a corpi neuronali. Inoltre, è stata confermata la presenza del<br />
recettore P2Y12 negli oligodendrociti, anche mediante microscopia elettronica<br />
e Western blotting. L’identificazione del recettore P2Y12 esclusivamente<br />
negli oligodendrociti farebbe quindi supporre ad un ruolo specifico di tale<br />
recettore nei meccanismi di comunicazione e contatto glia-neurone delle<br />
aree cerebrali descritte.<br />
Attività previste<br />
Poiché il recettore P2Y4 ed il recettore P2Y6 costituiscono l’unico sistema<br />
ad ora conosciuto di trasmissione esclusivamente pirimidinergica, essendo<br />
entrambe le subunità sia attivate dall’UTP e dall’UDP, sia coespresse negli<br />
stessi tipi cellulari dove mediano funzioni sovrapponibili pur differendo nelle<br />
cinetiche di attivazione, il principale obiettivo del presente programma di<br />
ricerca sarà quello di confrontare la struttura quaternaria del recettore P2Y4<br />
con quella del recettore P2Y6, per verificare se anche quest’ultimo sia in grado<br />
di formare omo-complessi. Inoltre, analizzeremo il ruolo funzionale delle<br />
diverse forme di aggregazione di ciascuna proteina, confrontando l’eventuale<br />
ridistribuzione della forma monomerica rispetto ai complessi oligomerici, sia<br />
in seguito ad attivazione del recettore da parte dell’agonista specifico UTP, sia<br />
in compartimenti di membrana specifici, quali le terminazioni sinaptiche del<br />
sistema nervoso centrale. Infine, poiché le interazioni tra GPCR possono<br />
essere di tipo omo-dimerico o etero-dimerico, a seconda che derivino da un<br />
unico tipo di recettore o da subunità diverse, valuteremo l’esistenza di complessi<br />
etero-oligomerici costituiti dalle subunità P2Y4 e P2Y6.<br />
In conclusione, il nostro studio ci permetterà di definire le differenze<br />
nella struttura quaternaria dei recettori pirimidinergici P2Y4 e P2Y6 e di individuare<br />
una possibile funzione delle diverse forme di aggregazione di ciascun<br />
recettore.<br />
446 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
C.3 –STUDIO MULTIDISCIPLINARE DELL’IMMUNOPATOGENESI<br />
DELLA SCLEROSI MULTIPLA<br />
C.3.1 –Studio delle caratteristiche fenotipiche e funzionali<br />
dei linfociti T regolatori nella Sclerosi Multipla<br />
(Luca Battistini)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sclerosi Multipla; Linfociti T regolatori; Autoimmunità; Terapia<br />
cellulare.<br />
Altri Enti coinvolti: Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine (MDC),<br />
Berlino<br />
Descrizione<br />
La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata<br />
da infiltrazione linfocitaria e infiammazione della sostanza bianca<br />
del sistema nervoso centrale. Numerose evidenze cliniche e sperimentali<br />
suggeriscono che linfociti T specifici per antigeni della mielina siano coinvolti<br />
nella patogenesi della malattia. Benché i linfociti T autoreattivi siano<br />
presenti anche nei soggetti sani, nei pazienti con malattie autoimmuni tali<br />
cellule si attivano con facilità maggiore rispetto alle cellule ottenute da soggetti<br />
sani. Tale alterata reattività potrebbe riflettere una ridotta funzionalità<br />
dei linfociti Treg. Nel prossimo futuro ci proponiamo di studiare le capacità<br />
di soppressione e di migrazione della sottopopolazione di cellule T regolatorie<br />
CD25 High isolate da individui sani e da pazienti affetti da Sclerosi<br />
Multipla. Verranno utilizzate sofisticate tecniche che permettono la misurazione<br />
della presenza, della distribuzione, e dell’attività immunologica delle<br />
T regolatorie in pazienti affetti da Sclerosi Multipla con la forma relapsingremitting.<br />
Verranno inoltre monitorati i markers sopramenzionati al fine di<br />
valutare la possibilità di associazione di un determinato fenotipo con l’attività<br />
di malattia.<br />
L’alterazione funzionale dei linfociti Treg nei pazienti con malattia<br />
autoimmune suggerisce immediatamente che la terapia con tali cellule<br />
potrebbe rappresentare un mezzo per ristabilire l’equilibrio immunologico<br />
dell’individuo, in cui le cellule autoreattive non sono più “ controllate ” dal<br />
sistema immunitario. Come premessa per le applicazioni in clinica, le cellule<br />
identificate nelle fasi precedenti del progetto verranno coltivate e iniettate nei<br />
topi in cui sia stata indotta l’encefalite. Gli effetti sui sintomi neurologici verranno<br />
valutati seguendo criteri convalidati. Nell’ultima fase di questo progetto<br />
ci proponiamo di disegnare un protocollo sperimentale per la terapia cellulare<br />
dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, mediante trattamento con cellule<br />
regolatorie autologhe purificate e attivate in vitro.<br />
2007 447
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
È stata definita la sottopopolazione di cellule T regolatorie più efficace<br />
nel sopprimere la risposta immunitaria. Tale sottopopolazione è caratterizzata<br />
da bassi livelli di espressione dell’integrina VLA-4, fondamentale per<br />
l’interazione con le cellule dell’endotelio vascolare durante la migrazione<br />
all’interno dei tessuti. Questo dato ha diverse implicazioni: da un lato contribuisce<br />
a spiegare l’efficacia del trattamento terapeutico con Tysabri, un<br />
anticorpo monoclonale diretto contro la VLA-4 che, somministrato ai<br />
pazienti con Sclerosi Multipla, ha dimostrato un’efficacia quasi doppia<br />
rispetto ai farmaci attualmente in uso; dall’altro ha evidenziato che le cellule<br />
T regolatorie sono gli unici linfociti T CD4+ ad utilizzare un distinto repertorio<br />
di molecole di adesione per la transmigrazione nei tessuti infiammati.<br />
Nell’ultimo periodo abbiamo ottenuto dati preliminari che dimostrano<br />
l’importanza dei recettori purinergici, dell’ATP e dei suoi metaboliti (quali<br />
l’adenosina) nel meccanismo di immunosoppressione mediato dalle cellule<br />
T regolatorie. Questi ultimi dati hanno aperto la strada a un nuovo emozionante<br />
panorama di ricerca.<br />
Il sistema nervoso ed il sistema immunitario costituiscono reti complesse<br />
di cellule in comunicazione tra loro. Il termine di sinapsi immunologica,<br />
preso a prestito dalle <strong>neuroscie</strong>nze, definisce la zona di interazione e di comunicazione<br />
tra due cellule del sistema immunitario. Come avviene nelle sinapsi<br />
nervose, anche nelle sinapsi immunologiche vengono rilasciati mediatori<br />
solubili, e tra questi (oltre alle citochine e chemochine) è possibile che<br />
abbiano un ruolo di primo piano l’ATP e i suoi metaboliti. I nostri primi dati<br />
mostrano che a livello dei linfociti sono presenti depositi di ATP, che possono<br />
venire rilasciati in seguito a stimolazione, ed è noto che tutti i linfociti<br />
esprimono recettori purinergici, che li rende quindi sensibili all’azione dei<br />
nucleotidi. La presenza poi di ectoenzimi che rapidamente metabolizzano i<br />
nucleotidi rilasciati nello spazio extracellulare conferisce un ulteriore livello<br />
di regolazione del signalling innescato da queste molecole.<br />
La nostra ipotesi è che la soppressione immunologica mediata dai linfociti<br />
T regolatori, le uniche cellule ad esprimere l’ectoenzima CD39 associato<br />
ad elevati depositi intracellulari di ATP, sia collegato al rilascio e alla regolazione<br />
della concentrazione extracellulare di nucleotidi. Lo studio di questi<br />
meccanismi, oltre ad aprire nuove frontiere di ricerca, è un passo fondamentale<br />
verso l’utilizzo delle cellule T regolatorie nella pratica clinica.<br />
Attività previste<br />
Le attività previste includono:<br />
• lo studio della risposta immunitaria nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla;<br />
• la caratterizzazione fenotipica e funzionale dei linfociti T autoreattivi<br />
isolati dal sangue periferico dei pazienti nelle varie fasi di malattia;<br />
• l’identificazione di markers immunologici di malattia mediante citofluorimetria.<br />
448 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
C.3.2 –Studio dell’attività neuronale e sinaptica in topi<br />
con encefalite allergica sperimentale, modello animale<br />
di sclerosi multipla (Diego Centonze)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Sclerosi Multipla; EAE; Plasticità Sinaptica; Elettrofisiologia.<br />
Altri Enti coinvolti: Ospedale San Raffaele, Milano; Università di Teramo.<br />
Descrizione<br />
In questa nuova fase della ricerca indagheremo le alterazioni del sistema<br />
endocannabinoide in corso di sclerosi multipla e sclerosi multipla sperimentale.<br />
Il sistema endocannabinoide potrebbe essere coinvolto tanto nel danno<br />
infiammatorio che in quello neurodegenerativo in corso di SM. Esistono<br />
infatti consistenti evidenze a supporto del ruolo benefico della stimolazione<br />
dei recettori per i cannabinoidi in tale condizione patologica. Non è stato tuttavia<br />
mai indagato se il sistema endogeno dei cannabinoidi (endocannabinoidi)<br />
si trova a essere alterato nei pazienti con SM e nei topi con SM sperimentale.<br />
Le alterazioni della trasmissione sinaptica da noi descritte nei topi<br />
con EAE potrebbero essere secondarie a un rimaneggiamento del sistema<br />
endocannabinoide cerebrale.<br />
Risultati e prodotti conseguiti<br />
Le nostre registrazioni hanno evidenziato un’abnorme sensibilità neuronale<br />
alla stimolazione dei recettori NMDA nei topi EAE, in cui la frequenza<br />
delle correnti spontanee glutammato-mediate e l’ampiezza dei potenziali postsinaptici<br />
eccitatori si sono rivelate essere significativamente ridotte in presenza<br />
di antagonisti dei recettori NMDA. Al contrario, nei topi di controllo la<br />
riduzione è stata minima e non statisticamente significativa. La stimolazione<br />
ad elevata frequenza delle terminazioni glutammatergiche corticostriatali ha<br />
determinato nello striato di topi di controllo una depressione a lungo termine<br />
(LTD) dell’efficacia sinaptica. Tale forma fisiologica di plasticità sinaptica era<br />
assente nei topi EAE, e poteva essere ripristinata unicamente in seguito al<br />
blocco farmacologico dei recettori NMDA.<br />
Lo studio della trasmissione sinaptica inibitoria ha rivelato una drammatica<br />
riduzione della frequenza media delle correnti spontanee post-sinaptiche<br />
GABA-mediate nei topi con EAE, modificazione che si manifesta molto precocemente<br />
e si mantiene almeno fino a 90 giorni dopo l’immunizzazione.<br />
Attività previste<br />
• Misurazione dei livelli di endocannabinoidi nel sangue periferico e nel<br />
liquor di pazienti con SM.<br />
• Misurazione dei livelli di endocannabinoidi nel cervello di topi con SM<br />
sperimentale.<br />
2007 449
Sezione III: Attività per linea di ricerca corrente C<br />
• Correlazione di tali livelli con la presenza del danno degenerativo e<br />
infiammatorio evidenziato alla RM dell’encefalo.<br />
• Misurazioni delle attività di sintesi, trasporto e degradazione dei principali<br />
endocannabinoidi nei linfociti di pazienti con SM e nel cervello dei topi<br />
con encefalomielite autoimmune sperimentale (EAE).<br />
• Misurazione degli effetti elettrofisiologici delle stimolazione dei recettori<br />
per gli endocannabinoidi nel cervello di topi con EAE.<br />
C.3.3 – Studi di epidemiologia molecolare, caratterizzazione<br />
genotipo-fenotipo ed identificazione di nuovi loci<br />
e geni malattia nelle malattie neurologiche (Antonio Orlacchio)<br />
Anno d’inizio: 2006<br />
Durata: 36 mesi<br />
Parole chiave: Neurogenetica; Malattie neurologiche; Analisi di linkage; Analisi<br />
mutazionale; Genotipo-Fenotipo; Epidemiologia molecolare.<br />
Descrizione<br />
L’attività di ricerca del Laboratorio di Neurogenetica, CERC-IRCCS<br />
S. <strong>Lucia</strong>, Roma verte su studi di genetica molecolare effettuati su malattie<br />
neurologiche. L’attività di ricerca è indirizzata a studi di “ linkage ” genetico,<br />
ad analisi “ mutazionali ” geniche, a studi di correlazione genotipo/fenotipo,<br />
a studi di genetica di popolazioni e a svariati altri studi di<br />
ricerca genetica di base ed applicata. Annualmente, vengono studiate un<br />
ampio numero di famiglie con ricorrenza di malattie neurogenetiche. La<br />
raccolta di queste famiglie, la definizione della regione critica tramite studi<br />
di linkage quando la localizzazione del gene sia nota, o in caso contrario, la<br />
mappatura su larga scala estesa a tutto il genoma ed infine l’identificazione<br />
del gene malattia tramite l’approccio posizionale del gene candidato o tramite<br />
analisi dei geni candidati rappresentano gli scopi principali della<br />
nostra ricerca.<br />
Risultati acquisiti<br />
Tra i risultati raggiunti ricordiamo:<br />
a) l’identificazione di un nuovo locus genetico per una variante di paraparesi<br />
spastica ereditaria a tramissione autosomica dominante, la Silver<br />
Syndrome;<br />
b) l’identificazione di un nuovo locus genetico per una nuova forma di<br />
paraparesi spastica ereditaria a tramissione autosomica dominante (SPG29);<br />
c) la riduzione della regione critica in cui si dovrebbe trovare il gene causativo<br />
della forma SPG12 di Paraparesi Spastica Ereditaria sul cromosoma<br />
19q. Le analisi hanno permesso di restringere moltissimo la zona in cui si<br />
dovrebbe trovare il gene, tra i punti D19S416 e D19S220, avvicinando così il<br />
momento della sua completa identificazione;<br />
450 2007
Neuroscienze sperimentali<br />
d) la scoperta, secondo uno studio dell’aplotipo, di una nuova mutazione<br />
fondatore del gene Spastina causativa di Paraparesi Spastica Ereditaria Autosomica<br />
Dominante nella popolazione Scozzese;<br />
e) la costituzione di una Banca di DNA e cellule la cui funzione è di raccogliere<br />
e conservare, a scopo di ricerca genetica, DNA e cellule prelevati da<br />
individui affetti o da portatori sani di malattie neurologiche e dai loro familiari.<br />
Dal 2000, data della sua istituzione, sono stati accumulati nella Banca<br />
più di 5000 campioni di DNA e sono state allestite approssimativamente 2500<br />
linee cellulari. Le procedure relative al funzionamento della Banca sono<br />
conformi ad un protocollo approvato dal Comitato di Bioetica della <strong>Fondazione</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> ed in linea con le norme etiche raccomandate dalla Federazione<br />
Mondiale di Neurologia;<br />
f) la possibilità di fornire diagnosi genetica per le seguenti patologie:<br />
Demenza di Alzheimer, Demenza Fronto-Temporale, Sclerosi Laterale Amiotrofica,<br />
Paraparesi Spastica Ereditaria, Morbo di Parkinson, Neuroacantocitosi,<br />
Roussy-Levy Syndrome, Atassia con aprassia oculomotoria 2 (AOA2).<br />
Attività previste<br />
• Ampliamento del database clinico istituito il primo anno con la caratterizzazione<br />
fenotipica dei casi familiari e sporadici; acquisizione di ulteriori<br />
campioni di DNA e linee cellulari da pazienti con malattie neurologiche a<br />
carattere ereditario.<br />
• Acquisizione di dati di epidemiologia molecolare aggiuntivi a quelli del<br />
primo anno per le malattie neurogenetiche più comuni mediante la messa a<br />
punto e l’integrazione di protocolli di screening mutazionale ad elevata efficienza<br />
e con potenzialità di automazione per i geni noti.<br />
• Determinazione della frequenza di mutazioni in geni di norma e non di<br />
norma associati con fenotipo Paraparesi Spastica Ereditaria, Demenza di<br />
Alzheimer, Demenza Fronto-Temporale, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Morbo<br />
di Parkinson, Neuroacantocitosi, Roussy-Levy Syndrome, Atassia con aprassia<br />
oculomotoria 2 (AOA2).<br />
• Identificazione di nuovi loci malattia: analisi di linkage in famiglie<br />
nucleari informative, selezione di pool di famiglie che condividono peculiarità<br />
fenotipiche.<br />
2007 451