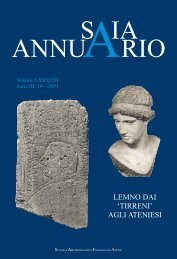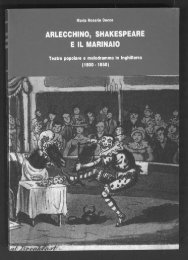Leonardo da Vinci. L'“angeLo incarnato” - OPAR L'Orientale Open ...
Leonardo da Vinci. L'“angeLo incarnato” - OPAR L'Orientale Open ...
Leonardo da Vinci. L'“angeLo incarnato” - OPAR L'Orientale Open ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Pianta d’Ellefante d’India”:<br />
L’“Angelo <strong>incarnato”</strong> come Shiva-Dioniso*<br />
Carlo Vecce<br />
<strong>Leonardo</strong> <strong>da</strong> <strong>Vinci</strong> è stato forse il solo di quegli artisti ad aver<br />
avuto uno sguardo veramente sovracristiano. Egli conosce<br />
bene l’Oriente, quello interno altrettanto bene di quello<br />
esterno. C’è in lui qualcosa di sovraeuropeo e di taciuto,<br />
qualcosa che è tipico di chiunque abbia contemplato una<br />
cerchia troppo vasta di cose buone e cattive.<br />
Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi (1884-1885)<br />
ALL’INTERNO della secon<strong>da</strong> copertina di cartone del<br />
Codice F, tra le varie scritture occasionali che di solito si<br />
stratificano su queste ‘soglie’ (d’entrata o di uscita) del labirinto<br />
testuale dei manoscritti di <strong>Leonardo</strong>, compare una nota enigmatica:<br />
“piata dellefante djndja chella antonello / mercaio ”.<br />
In trascrizione critica: “pianta d’Ellefante d’India che‧ll’ha<br />
Antonello merciaio”.<br />
A quando risale la nota? Sulla stessa facciata, dopo uno spazio<br />
bianco, si presenta un ricordo di prestito a Salaì: “A dì d’ottobre<br />
1508 ebbi scudi 30 / 13 ne prestai a Salai per compiere la dota alla<br />
sorel/la e 17 ne restò a me”, seguito <strong>da</strong> una curiosa filastrocca in<br />
latino sui prestiti incauti. E lo stesso codice reca sul f. 1 r la solenne<br />
<strong>da</strong>ta di ‘inizio’: “Cominciato a Milano addì 12 di settembre<br />
1508”. La nota sembrerebbe però di grafia leggermente diversa,<br />
e potrebbe essere stata apposta a distanza di tempo, come spesso<br />
avviene nei fogli vinciani.<br />
Per la sua interpretazione, tramontate le ipotesi antiche e fantasiose<br />
(la parte inferiore di una zampa d’elefante secondo Ravaisson-<br />
Mollien, uno strano vegetale proveniente <strong>da</strong>ll’India, o il monte<br />
dell’Elefante nel Siam) 1 , resta quella più probabile, e comune-<br />
* Riproduco qui, con opportuni aggiornamenti, il testo inedito della conferenza su <strong>Leonardo</strong><br />
<strong>da</strong> <strong>Vinci</strong> and India, tenuta all’Indira Gandhi National Center for Arts di Nuova Delhi<br />
il 12 ottobre 2004, e ripresa in forma seminariale alla Ja<strong>da</strong>vpur University di Kolkata il 16<br />
ottobre. Mi è grato ricor<strong>da</strong>re i nomi di Patrizia Raveggi e di Supriya e Sukanta Chauduri,<br />
prodighi allora di consigli e suggerimenti. E soprattutto quello di Carlo Pedretti, che mi ha<br />
generosamente messo a disposizione la sua biblioteca e il suo archivio di Los Angeles.<br />
1<br />
Les manuscrits de Léonard de <strong>Vinci</strong>, a c. di C. Ravaisson-Mollien, vol. IV, Paris, 1889, ad<br />
locum: “Elephanta <strong>da</strong>ns l’Inde anglaise (îlot du golfe de Bombay), ou: Plan (ou Plante) de<br />
l’éléphant de l’Inde”. Nella biblioteca Pedretti a Los Angeles si conserva una copia dell’edizione<br />
posseduta e postillata <strong>da</strong> Emil Möller, che annota in margine: “Caro Benedetto ...<br />
per <strong>da</strong>rti”, un evidente richiamo alla lettera a Benedetto Dei; più in basso, una postilla di<br />
Carlo Pedretti respinge l’ipotesi di accostamento: “impossibile, perché la lettera al Dei è del<br />
1490-5 ca.”. L’errore di trascrizione e traduzione nella prima edizione dell’antologia di Jean<br />
Paul Richter, The Literary Works of <strong>Leonardo</strong> <strong>da</strong> <strong>Vinci</strong>, London, 1883, §1471, risulta <strong>da</strong>ll’unione<br />
di alcuni testi sulle due facciate della copertina: “Piata d’Elefante d’India che à Antonello<br />
Merciaio 2 <strong>da</strong> maestro Maffeo; perchè 7 anni la ter 3 ra alza e 7 abbassa;––– 4 cerca di Vitruvio<br />
5<br />
fra cartollaj”; in traduzione: “Map of Elephanta in India which Antonello Merciaio has<br />
from maestro Maffeo;––––there for seven years the earth rises and for seven years it sinks;–<br />
––Enquire at the stationers about Vitruvius”. L’abbaglio venne corretto nelle edizioni successive<br />
(Oxford, 1939 e London, 1970).<br />
Pianta della baia di Bombay, oggi Mumbai, con l’isola di Elephanta evidenziata<br />
in giallo<br />
Map of the bay of Bombay, now Mumbai, with the Elephanta Island<br />
shown in yellow<br />
mente accettata <strong>da</strong>gli studiosi: la “pianta d’Ellefante” dovrebbe<br />
essere una planimetria (secondo un uso già attestato nel lessico<br />
artistico e architettonico dell’epoca), una mappa di un luogo in<br />
India chiamato ‘Elefante’ 2 . Tale luogo esiste realmente: l’isolotto<br />
di Garapur nella baia di Mumbai, ribattezzato <strong>da</strong>i Portoghesi<br />
Elephanta, a causa di una scultura colossale di un elefante, ora<br />
perduta. E qui, normalmente, si fermano tutti i commentatori.<br />
Solo il Solmi allega il brano suggestivo di un viaggiatore francese<br />
del XIX secolo 3 . E l’unico studioso che, a mia conoscenza,<br />
si sia interrogato su quel che <strong>Leonardo</strong> avrebbe potuto venire<br />
a conoscenza, tramite la ‘pianta’ o una relazione scritta, è stato<br />
Carlo Pedretti, che approfondisce la questione in una nota del<br />
Commentary al Richter 4 ; e soprattutto esamina le riproduzioni<br />
di sculture di Elephanta, come testimoniano alcuni suoi disegni<br />
che risalgono al 1959-1960.<br />
Come è noto, l’interesse per l’Oriente è vivissimo nei manoscritti<br />
di <strong>Leonardo</strong>, a partire <strong>da</strong>i suoi contatti a Milano con un grande<br />
2<br />
C. Vecce, <strong>Leonardo</strong>. Presentazione di Carlo Pedretti, Roma, 2006, p. 288.<br />
3<br />
E. Solmi, Le fonti dei manoscritti di <strong>Leonardo</strong>, Torino, 1908, pp. 240-242. Rara eccezione è<br />
il contributo di M. Baratta, Sopra le fonti cartografiche di <strong>Leonardo</strong> <strong>da</strong> <strong>Vinci</strong>, Vol. II degli “Atti<br />
dell’VIII Congresso Geografico Italiano”, 29 marzo-6 aprile 1921, Firenze, 1923, pp. 381-395,<br />
dove a pp. 288-289 l’appunto nel Codice F è considerato anche per il significato che la<br />
parola “pianta” poteva avere per <strong>Leonardo</strong> e per i suoi contemporanei.<br />
4<br />
The literary works of <strong>Leonardo</strong> <strong>da</strong> <strong>Vinci</strong>, ed. J.P. Richter. A Commentary by Carlo Pedretti,<br />
Oxford, 1977 (d’ora in poi Pedretti, Richter Commentary), ad locum.<br />
[355]