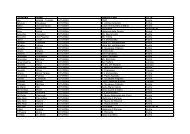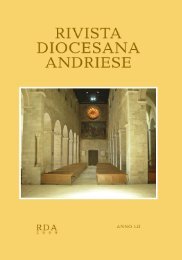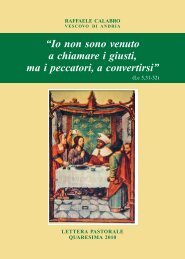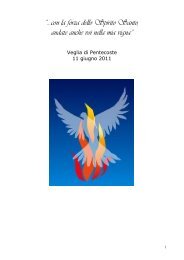RELAZIONE Don Matteo Crimella - Diocesi di Andria
RELAZIONE Don Matteo Crimella - Diocesi di Andria
RELAZIONE Don Matteo Crimella - Diocesi di Andria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Martedì 19 <strong>di</strong> febbraio 2013<br />
<strong>Andria</strong> – Parrocchia San Paolo<br />
Relazione alla Settimana biblica <strong>di</strong>ocesana<br />
0. Introduzione<br />
IL METODO EDUCATIVO DELLE PARABOLE<br />
don <strong>Matteo</strong> <strong>Crimella</strong><br />
Il tema che dobbiamo affrontare questa sera non è né semplice né imme<strong>di</strong>ato, in<br />
quanto non si limita a leggere ed interpretare le parabole, ma cerca <strong>di</strong> entrare<br />
nel metodo educativo parabolico.<br />
Avendo un tempo molto risicato vorrei procedere in questo modo.<br />
Prenderei le mosse, anzitutto, da un esempio concreto, la celebre parabola del<br />
buon Samaritano, mettendo in luce come i criteri ermeneutici che guidano la<br />
lettura non sono in<strong>di</strong>fferenti per la sua comprensione. In secondo luogo<br />
cercherò <strong>di</strong> offrire una definizione <strong>di</strong> parabola per mostrare che nel suo stesso<br />
meccanismo v’è un’istanza educativa. Infine terminerò con un altro esempio.<br />
1. La parabola del buon Samaritano (Lc 10,25-37)<br />
25 Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese:<br />
«Maestro, che cosa devo fare per ere<strong>di</strong>tare la vita eterna?». 26 Gesù gli <strong>di</strong>sse:<br />
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il<br />
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua<br />
forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28 Gli <strong>di</strong>sse:<br />
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 29 Ma quello, volendo giustificarsi, <strong>di</strong>sse<br />
a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30 Gesù riprese: «Un uomo scendeva da<br />
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via<br />
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per<br />
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide,<br />
passò oltre. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33 Invece<br />
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe<br />
compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi<br />
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura <strong>di</strong> lui. 35 Il<br />
giorno seguente, tirò fuori due denari e li <strong>di</strong>ede all’albergatore, <strong>di</strong>cendo: “Abbi<br />
cura <strong>di</strong> lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 36 Chi <strong>di</strong><br />
questi tre ti sembra sia stato prossimo <strong>di</strong> colui che è caduto nelle mani dei<br />
briganti?». 37 Quello rispose: «Chi ha avuto compassione <strong>di</strong> lui». Gesù gli <strong>di</strong>sse:<br />
«Va’ e anche tu fa’ così».<br />
Di questa parabola vorrei offrire tre letture: l’interpretazione allegorica tipica<br />
dell’epoca patristica, l’interpretazione storico-critica e l’interpretazione che<br />
procede dalla moderna narratologia.<br />
1
La prima lettura è quella allegorica tra<strong>di</strong>zionale: ad ogni elemento fittizio<br />
corrisponde un elemento reale. È la lettura dei padri della Chiesa, <strong>di</strong> Origene e,<br />
alla sua scuola, <strong>di</strong> Agostino. Scrive il vescovo <strong>di</strong> Ippona:<br />
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. È da intendervi Adamo e in lui tutta<br />
l’umanità. Gerusalemme è la città celeste della pace, dalla cui beatitu<strong>di</strong>ne egli<br />
decadde. Gerico, etimologicamente uguale a “luna”, rappresenta la nostra<br />
con<strong>di</strong>zione mortale in quanto la luna nasce, cresce, invecchia e tramonta.<br />
I briganti sono il <strong>di</strong>avolo e i suoi angeli, che spogliarono l’uomo della veste<br />
dell’immortalità e, infertegli delle ferite inducendolo a peccare, lo lasciarono mezzo<br />
morto. In effetti l’uomo è vivo per quella parte che gli è dato comprendere e<br />
conoscere Dio, mentre è morto per quella parte che si corrompe sotto il peso dei<br />
peccati. Per questo si <strong>di</strong>ce che fu lasciato mezzo morto. Quanto al sacerdote e al<br />
levita che, avendolo visto, passarono oltre dall’altra parte della strada<br />
rappresentano il sacerdozio e il ministero dell’Antico Testamento, incapaci <strong>di</strong><br />
giovare alla salvezza. Il samaritano, etimologicamente il “custode”, rappresenta<br />
in forza dello stesso nome il nostro Signore. La fasciatura delle ferite è il freno<br />
imposto ai peccati, l’olio è la consolazione derivante dalla buona speranza che<br />
viene dalla remissione della colpa e porta alla riconciliazione e alla pace; il vino<br />
è l’esortazione ad agire con spirito il più possibile fervente. Il suo giumento è la<br />
carne con cui si è degnato venire tra noi. Essere posti in sella al giumento è<br />
credere nell’incarnazione <strong>di</strong> Cristo. La locanda è la Chiesa, dove trovano ristoro<br />
i pellegrini che dal paese remoto tornano alla patria eterna. Il giorno successivo è<br />
il tempo dopo la resurrezione del Signore. I due denari sono i due precetti della<br />
carità che gli apostoli ricevettero in dono dallo Spirito Santo per cui si misero a<br />
pre<strong>di</strong>care il Vangelo ai presenti. Ovvero sono le promesse della vita presente e<br />
della futura, <strong>di</strong> cui fu detto: In questo tempo riceverà sette volte tanto e nell’altro<br />
mondo otterrà la vita eterna. L’albergatore è quin<strong>di</strong> l’Apostolo. Ciò che spende in<br />
più concerne il consiglio <strong>di</strong> cui Paolo <strong>di</strong>ce: Riguardo alle vergini non ho<br />
un’ingiunzione da parte del Signore, ma io stesso consiglio. Potrebbe però riguardare<br />
anche il fatto che egli lavorava manualmente per non gravare nessun fratello<br />
infermo nello spirito a causa della novità usata nell’annunziare il Vangelo,<br />
sebbene a lui fosse consentito ricavare il sostentamento dal Vangelo (Quæstiones<br />
Evangeliorum II, 19).<br />
Il metodo è chiaro: ogni elemento della parabola è figura <strong>di</strong> un momento della<br />
storia della salvezza così che alla fine il racconto parabolico è una semplice<br />
allegoresi dei momenti salienti della cronologia biblica: la creazione, il peccato<br />
dell’uomo, il dono della Legge, la profezia, l’incarnazione <strong>di</strong> Gesù, la Chiesa. È<br />
evidente che il racconto parabolico evapora per lasciar spazio alla<br />
riproposizione della vicenda del popolo d’Israele, <strong>di</strong> Gesù e della comunità<br />
cristiana. Una simile lettura è profondamente centrata sull’evento <strong>di</strong> Cristo ma<br />
porta con sé il pesante fardello dell’allegoresi che snatura la parabola.<br />
Alla fine del XIX secolo in ambiente esegetico tedesco v’è stato un vero e<br />
proprio rifiuto <strong>di</strong> una simile interpretazione. Si è fatta strada una nuova lettura<br />
2
delle parabole che, abbandonando l’allegoria, fosse in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il<br />
funzionamento del racconto fittizio.<br />
Al cuore dell’interpretazione <strong>di</strong> questa parabola v’è la figura del<br />
Samaritano. Protagonista infatti del racconto fittizio è un uomo, un uomo<br />
qualunque, senza nome né identità. Appena è assalito dai briganti è spogliato<br />
delle sue vesti. Il vestito in Oriente (ancora oggi) è un forte segno identitario,<br />
sicché spogliare una persona non è solo umiliarla in profon<strong>di</strong>tà, ma è privarla <strong>di</strong><br />
qualsiasi segno <strong>di</strong> riconoscimento. A quest’uomo spogliato è quasi sottratta<br />
l’identità. Qual è l’effetto sul lettore? A fronte della violenza dei briganti verso il<br />
viandante, scatta nel lettore un duplice sentimento: una chiara antipatia per i<br />
ban<strong>di</strong>ti e una profonda empatia nei confronti del ferito. Il narratore, cioè, ha<br />
fatto sorgere due effetti: da una parte una tensione narrativa nella forma<br />
dell’attesa per la sorte del ferito e dall’altra una forte empatia, cioè un<br />
meccanismo <strong>di</strong> identificazione col povero malcapitato. A partire da una serie <strong>di</strong><br />
valori antropologici fondamentali il narratore ha condotto il suo ascoltatore a<br />
stringere un’alleanza col ferito.<br />
Sulla strada che scende da Gerusalemme a Gerico camminano un<br />
sacerdote e un levita. Luca raddoppia i personaggi, dando vita a due tipi<br />
perfettamente identici. Fra il viandante e il sacerdote si instaura una sorta <strong>di</strong><br />
solidarietà legata alla con<strong>di</strong>visione puramente casuale <strong>di</strong> una stessa esperienza:<br />
ambedue sono in cammino e percorrono la medesima strada. Ma nel momento<br />
in cui dallo sfondo si passa al primo piano, cioè al rilievo del racconto, il verbo<br />
“vedere” permette <strong>di</strong> entrare nella percezione del sacerdote: il lettore apprende<br />
che questi viene a conoscere la situazione del ferito proprio come il narratore<br />
l’ha descritta. Il sacerdote si trova cioè <strong>di</strong> fronte ad un uomo spogliato, percosso<br />
e abbandonato mezzo morto lungo la strada: personaggio e lettore con<strong>di</strong>vidono<br />
così lo stesso grado <strong>di</strong> conoscenze. La tensione narrativa cresce e scatta l’attesa.<br />
Chi ha seguito la narrazione fino a questo punto, si aspetta involontariamente<br />
una peripezia dell’azione: ora, finalmente, avverrà, quanto deve avvenire! Ma<br />
così non è. Frustrando l’attesa del lettore il narratore trasforma la suspense in<br />
sorpresa: il sacerdote passa accanto al ferito e lo supera, senza prendersi cura <strong>di</strong><br />
lui. Il levita poi fa esattamente la stessa cosa, a spese del ferito, il quale vede<br />
sfumare per ben due volte la possibilità <strong>di</strong> un soccorso.<br />
A proposito dei motivi che hanno spinto sacerdote e levita a quella scelta<br />
si sono versati i classici fiumi d’inchiostro: il sangue li renderebbe impuri (essi<br />
però non stanno andando a Gerusalemme per il culto ma scendono verso<br />
Gerico); lo sconosciuto malcapitato non dovrebbe essere annoverato nella<br />
categoria del “prossimo” (secondo una stretta interpretazione <strong>di</strong> Lv 19,18); il<br />
pover’uomo era morto o stava per morire (i sacerdoti non possono toccare i<br />
3
morti secondo Lv 21,1-4). E tuttavia ogni ragione accampata non tiene <strong>di</strong> fronte<br />
all’urgenza della situazione.<br />
A questo punto v’è un’ulteriore sorpresa. I testi giudaici usano nominare<br />
tre categorie <strong>di</strong> persone: sacerdoti, leviti e Israeliti. L’u<strong>di</strong>tore attende che dopo il<br />
sacerdote e il levita giunga presso il ferito un Israelita; e invece si presenta un<br />
Samaritano. Che fra Giudei e Samaritani non corresse buon sangue è cosa nota<br />
(cfr. Gv 4,9). Considerando un poco il contesto lucano lo stupore aumenta ancor<br />
più: quando infatti Luca informa che Gesù «ha fatto duro il suo volto» (Lc 9,51)<br />
e si è <strong>di</strong>retto decisamente verso la città santa, la prima tappa del viaggio è stato<br />
un villaggio <strong>di</strong> Samaritani. Essi però non lo hanno ricevuto perché era in<br />
cammino verso Gerusalemme (cfr. Lc 9,52-53). Ebbene: nonostante sia stato<br />
rifiutato dai Samaritani Gesù sceglie come eroe della sua parabola proprio un<br />
Samaritano!<br />
Gesù caratterizza la reazione del Samaritano per mezzo <strong>di</strong> un verbo<br />
davvero singolare (v. 33): egli «è preso da compassione» (il verbo greco utilizza<br />
una ra<strong>di</strong>ce che richiama le interiora, cioè i sentimenti più profon<strong>di</strong>). In Luca il<br />
verbo caratterizza l’intensa emozione <strong>di</strong> Gesù <strong>di</strong> fronte alla donna vedova che<br />
ha perso il suo unico figlio (7,13); inoltre l’evangelista utilizza lo stesso verbo<br />
per esprimere lo slancio del padre allorché vede il figlio pro<strong>di</strong>go che si sta<br />
avvicinando a casa (15,20).<br />
L’olio e il vino versati sulle ferite del povero malcapitato sono i<br />
me<strong>di</strong>camenti dell’epoca. Scrive Ippocrate: «Dopo aver immerso le foglie <strong>di</strong> aro<br />
nel vino e nell’olio si applicano sulla ferita tenendole strette con una benda» (De<br />
ulceribus 22,3). I due denari che il Samaritano ha sborsato al locan<strong>di</strong>ere in favore<br />
del ferito incontrato per caso sulla sua strada erano sufficienti per alloggiare<br />
nell’albergo almeno due settimane.<br />
In conclusione: questa lettura mostra la <strong>di</strong>fferenza fra il Samaritano che si<br />
prende cura del malcapitato ferito e il sacerdote e il levita che invece passano<br />
oltre. Questa interpretazione non è scorretta: tutti gli elementi contestuali citati<br />
sono veri e concorrono ad un’interpretazione che pone in luce il funzionamento<br />
della parabola, senza cadere nella trappola dell’allegoria. Tuttavia rimane<br />
irrisolta una questione. Nel momento in cui si intende passare dal racconto<br />
fittizio alla vita cristiana, si vuole cioè istituire un ponte fra la parabola e<br />
l’esperienza credente, il rischio è quello del moralismo. Il Samaritano è<br />
l’esempio della carità e così debbono comportarsi i <strong>di</strong>scepoli del Signore! Ma, ci<br />
si chiede, come è possibile comportarsi allo stesso modo? In base a che cosa è<br />
possibile fare lo stesso? Ecco la lettura moralistica: si enuncia un valore e poi si<br />
<strong>di</strong>ce: “fa’ così”!<br />
4
V’è una terza lettura che si chiede: da quale punto <strong>di</strong> vista Gesù ha<br />
raccontato la parabola? Forse dal punto <strong>di</strong> vista del Samaritano? Certamente no:<br />
solo alla fine (vv. 36-37) v’è il passaggio. Il punto <strong>di</strong> vista dal quale Gesù ha<br />
raccontato la parabola è quello del ferito. In altre parole: tutto avviene secondo<br />
gli occhi del ferito. La parabola, cioè, non punta all’esemplarità del Samaritano<br />
ma cerca <strong>di</strong> fare entrare l’ascoltatore (e il lettore) nella pelle del ferito,<br />
nell’esperienza traumatica e splen<strong>di</strong>da <strong>di</strong> quest’uomo senza volto e senza nome.<br />
Alcune spie in<strong>di</strong>cano che la strategia è proprio questa. Prima spia:<br />
l’uomo aggre<strong>di</strong>to dai briganti non ha identità, è senza un nome e senza una<br />
qualifica, è cioè un membro dell’umanità; un’identità così aperta non può che<br />
facilitare l’identificazione con il lettore. Seconda spia: il sacerdote e il levita<br />
vedono il ferito e passano oltre senza fermarsi. Perché? Il narratore non <strong>di</strong>ce<br />
una sola ragione. Perché questo silenzio? Perché il punto <strong>di</strong> vista adottato dal<br />
narratore è quello del ferito e il racconto rivela solo ciò che questi può sapere. Il<br />
ferito constata solo che il sacerdote e il levita (riconoscibili dal loro abito) non si<br />
prendono cura <strong>di</strong> lui. Il ferito fa solo questa amara constatazione senza poterla<br />
spiegare, in quanto è una vittima! Terza spia: la parabola abbonda <strong>di</strong> particolari<br />
solo nel momento in cui il viandante ne può <strong>di</strong>sporre. E quell’uomo sa bene che<br />
cosa gli ha fatto il Samaritano; i dettagli sono precisi: olio e vino sulle ferite,<br />
giumento, locanda, denaro. In breve: il lettore vede con gli occhi del ferito.<br />
Quarta spia: la domanda finale posta da Gesù al dottore della Legge: «Chi <strong>di</strong><br />
questi tre ti sembra sia stato prossimo <strong>di</strong> colui che è caduto nelle mani dei<br />
briganti?» (v. 36), è la chiave per capire da che punto <strong>di</strong> vista la parabola è<br />
narrata. Essa infatti interroga sull’identità del prossimo non più a partire dal<br />
donatore (questa era la prospettiva del dottore della Legge - v. 29), ma a partire<br />
dal beneficiario. A partire dalla misera situazione <strong>di</strong> una vittima si decide lo<br />
statuto del prossimo, non da una definizione teorica. Per permettere al lettore <strong>di</strong><br />
capire il capovolgimento dell’interrogativo relativo al prossimo c’era bisogno <strong>di</strong><br />
un racconto che facesse entrare il lettore nella pelle <strong>di</strong> un essere umano in quella<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>sperata. È il punto <strong>di</strong> vista adottato dal parabolista che provoca<br />
nel lettore il capovolgimento <strong>di</strong> prospettiva; alla fine egli non può che<br />
rispondere, come il dottore della Legge, ciò che è evidente: quando sono posto<br />
in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza, qualunque sia la mia identità, aspetto che un<br />
altro si riconosca prossimo per me.<br />
2. Per una definizione della parabola<br />
L’esempio da cui siamo partiti è molto significativo perché ci offre non pochi<br />
spunti <strong>di</strong> riflessione a proposito del metodo educativo delle parabole <strong>di</strong> Gesù.<br />
5
Vorrei, in seconda battuta, concentrarmi su una riflessione più teorica a<br />
proposito delle parabole. Possiamo tentare una definizione della parabola? «La<br />
parabola è un racconto fittizio utilizzato in funzione <strong>di</strong> una strategia <strong>di</strong>alogicoargomentativa<br />
che opera in due momenti: dapprima sollecitando, in base alla<br />
logica interna del racconto, una certa valutazione e trasferendola poi, in forza <strong>di</strong><br />
un’analogia <strong>di</strong> struttura, alla realtà intesa dal parabolista» (V. Fusco).<br />
La parabola anzitutto è un racconto, cioè la descrizione <strong>di</strong> un<br />
avvenimento. C’è racconto quando v’è un nesso <strong>di</strong> causalità. C’è racconto<br />
quando noi rappresentiamo quello che avviene nel tempo per mezzo del tempo!<br />
Questo meccanismo vale sia per i racconti che mettono in scena qualcosa che è<br />
avvenuto un tempo (e allora sono al passato remoto), sia per i racconti che<br />
mettono in scena quello che avviene sempre (e allora sono al presente).<br />
Tale racconto è fittizio: esso è creato lì per lì, pur facendo riferimento ad<br />
un mondo preciso (il talento e il denaro sono monete del tempo <strong>di</strong> Gesù,<br />
l’ostilità fra giudei e samaritani è una realtà storica <strong>di</strong> allora, la tecnica <strong>di</strong><br />
coltivazione consistente nel seminare e poi nel rivoltare la terra era tipica <strong>di</strong><br />
quei luoghi). Le parabole poi usano immagini già presenti dell’Antico<br />
Testamento (come la vigna, o il pastore). Da qui la necessità <strong>di</strong> conoscere lo<br />
sfondo palestinese per comprendere usanze, abitu<strong>di</strong>ni, modalità espressive.<br />
Tuttavia la parabola ha un carattere fittizio che produce una particolare<br />
<strong>di</strong>namica interna che occorre rispettare.<br />
Il racconto fittizio è utilizzato in funzione <strong>di</strong> una strategia <strong>di</strong>alogicoargomentativa.<br />
La parabola funziona solo all’interno <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong>alogico,<br />
cioè nella relazione fra chi parla e chi ascolta. Detto in altro modo: la parabola<br />
intende produrre un effetto sull’ascoltatore, intende incidere sul suo punto <strong>di</strong><br />
vista, intende mutare la sua visione della realtà. Qui noi cogliamo un primo<br />
aspetto educativo della parabola: la parabola, nell’ingenuità <strong>di</strong> un racconto<br />
fittizio, in realtà <strong>di</strong>segna una visione del mondo, presenta un’interpretazione<br />
della realtà che è propria del parabolista (spesso <strong>di</strong>fferente dalla visione del<br />
mondo propria dell’ascoltatore o del lettore).<br />
La funzione <strong>di</strong>alogico-argomentativa è un proce<strong>di</strong>mento in due momenti<br />
che si saldano insieme l’un l’altro. In un primo momento all’interlocutore viene<br />
proposto un caso ipotetico sul quale è invitato a pronunziarsi (per es. Lc 7,41-42,<br />
la parabola dei due debitori cui è rimesso il debito); ottenuta la risposta<br />
desiderata inizia un secondo momento: la valutazione logica offerta<br />
dall’ascoltatore viene trasferita ad un’altra realtà finora non menzionata e alla<br />
quale mirava dall’inizio il parabolista. Solitamente questo avviene in un<br />
secondo momento perché gli interlocutori o non accettano il punto <strong>di</strong> vista del<br />
parabolista (e quin<strong>di</strong> lo respingerebbero se il <strong>di</strong>scorso fosse <strong>di</strong>retto) oppure<br />
6
hanno una visione del mondo che è ben <strong>di</strong>fferente e debbono essere condotti a<br />
poco a poco nella nuova logica del Regno <strong>di</strong> Dio. In altre parole: si cerca <strong>di</strong> far<br />
scaturire dagli interlocutori le valutazioni. Ecco un secondo aspetto che è<br />
letteralmente maieutico perché coinvolge l’interlocutore, lo obbliga a prendere<br />
posizione, ad esprimere un giu<strong>di</strong>zio.<br />
Due sono i requisiti <strong>di</strong> questo duplice proce<strong>di</strong>mento. Il primo: la vicenda<br />
fittizia deve essere coerente, animata da una ferrea logica interna così da<br />
portare alla valutazione voluta e non ad un’altra. Da qui la frequenza delle<br />
domande poste da Gesù: «Forse che? Non è possibile che?». Tornando alla<br />
parabola analizzata: <strong>di</strong> fronte alla domanda <strong>di</strong> Gesù la logica non permette <strong>di</strong><br />
dubitare; solo il samaritano è stato prossimo. In altre parole: a fronte del<br />
racconto la risposta alla domanda posta da Gesù può essere una e solo una. Il<br />
secondo requisito: la vicenda fittizia deve essere isomorfa, cioè strutturalmente<br />
abbastanza vicina alla vicenda reale. La parabola esige un trasferimento da una<br />
valutazione all’altra. Fra Davide e il ladro <strong>di</strong> bestiame (riferendoci alla celebre<br />
parabola <strong>di</strong> Natan in 2 Sam 12,1b-4) c’è un punto <strong>di</strong> contatto: un potente che fa<br />
violenza ad un debole. L’elemento comune è una vera e propria corrispondenza<br />
strutturale: A : B = A’ : B’. Non ha dunque senso attribuire un significato<br />
simbolico ad ogni singolo elemento del racconto fittizio. Anzi, il punto <strong>di</strong><br />
contatto dev’essere il più generale possibile, astratto e potenzialmente valido<br />
per ogni situazione simile (è condannabile il ricco che ruba ad un povero, avrà<br />
riconoscenza colui cui è condonato <strong>di</strong> più). In questo senso la parabola è<br />
insurrogabile: l’effetto che vuole ottenere non si può ottenere in altro modo.<br />
In questo senso la parabola è educativa: essa non è l’evangelo (non è il<br />
kérygma), non assorbe l’evangelo ma rinvia ad esso. Rinviando alla pre<strong>di</strong>cazione<br />
<strong>di</strong> Gesù e alla sua prassi, la parabola rinvia al mistero della persona <strong>di</strong> Gesù, in<br />
attesa <strong>di</strong> un <strong>di</strong>svelamento della sua identità e della sua autorità. Le parabole<br />
dunque non sono né un corpo estraneo né il centro del vangelo ma la frontiera<br />
del vangelo. Si tratta <strong>di</strong> un dono inau<strong>di</strong>to, <strong>di</strong> un messaggio <strong>di</strong> Dio per gli uomini.<br />
La parabola, per mezzo del suo appello alla razionalità, cerca <strong>di</strong> far accettare il<br />
messaggio <strong>di</strong> Gesù. L’effetto della parabola non è l’effetto della parola accolta<br />
nella fede: l’ascoltatore può comprendere ma può anche chiudersi. La parabola<br />
spiana la via al vangelo rimuovendo pregiu<strong>di</strong>zi, aprendo la strada verso la fede.<br />
3. La parabola del seminatore (Mc 4,3-8)<br />
Dopo questa riflessione teorica terminiamo con un altro esempio. Ascoltiamo la<br />
celebre parabola del seminatore nella versione <strong>di</strong> Marco.<br />
7
3 «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 Mentre seminava, una parte<br />
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5 Un’altra parte<br />
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò perché<br />
il terreno non era profondo, 6 ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non<br />
avendo ra<strong>di</strong>ci, seccò. 7 Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la<br />
soffocarono e non <strong>di</strong>ede frutto. 8 Altre parti caddero sul terreno buono e <strong>di</strong>edero<br />
frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». 9 E<br />
<strong>di</strong>ceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».<br />
Notiamo, anzitutto, un forte contrasto: in tre terreni il seme è perso (o a causa<br />
degli uccelli, o a causa dei sassi, o a causa delle spine) ma v’è pure la terra<br />
buona che dà frutto abbondante. Fra i quattro terreni l’antitesi è chiara: da una<br />
parte la sterilità dei primi tre, dall’altra la fecon<strong>di</strong>tà della terra buona. Il<br />
contrasto fra un terreno così fruttifero e gli altri tre terreni è molto forte e più<br />
ra<strong>di</strong>cale dell’opposizione fra i terreni. A questo proposito l’opposizione pare<br />
ricordare quella fra le piante nell’apologo <strong>di</strong> Iotam (cfr. Gdc 9,9-15), oppure la<br />
<strong>di</strong>fferenza fra i servitori nella parabola dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) o delle mine<br />
(cfr. Lc 19,12-27). Sembra cioè che la <strong>di</strong>stinzione dei terreni non abbia che uno<br />
scopo: porre in rilievo la magnifica raccolta della terra buona. In altre parole:<br />
tutte le per<strong>di</strong>te non impe<strong>di</strong>scono una buona raccolta.<br />
Ma v’è pure un’altra <strong>di</strong>namica. La parabola ha una progressione<br />
ascensionale. All’inizio il fallimento è totale: ogni seme è <strong>di</strong>vorato dagli uccelli.<br />
Invece sul suolo sassoso qualcosa spunta; fra le spine la pianta ad<strong>di</strong>rittura inizia<br />
a crescere; nella terra buona infine dà frutto ora il trenta, ora il sessanta, ora il<br />
cento. Dal nulla al cento la progressione è continua. Questo dato non<br />
contrad<strong>di</strong>ce il contrasto fra i terreni ma riba<strong>di</strong>sce che l’acme sta nello<br />
straor<strong>di</strong>nario raccolto finale. Si tratta cioè <strong>di</strong> mettere in relazione il fallimento<br />
iniziale e il successo finale. Proprio questa relazione deve essere sottolineata.<br />
Ma se la parabola prende luce da questo rapporto, che cosa intende esprimere?<br />
Raccogliendo le osservazioni svolte finora iniziamo a percepire meglio la<br />
strada da percorrere per l’interpretazione. La chiave <strong>di</strong> volta sta nelle battute<br />
finali, ovverosia nel rapporto fra i terreni sterili e il raccolto abbondante.<br />
Iniziamo dunque a considerare il pro<strong>di</strong>gioso raccolto. Ciò che stupisce è<br />
l’esagerazione delle proporzioni: trenta, sessanta, cento per uno. Gli stu<strong>di</strong>osi<br />
hanno rilevato che nel territorio della Palestina la proporzione è 1 a 2 oppure 1 a<br />
4; nella pianura della Shefela si arriva a 1 a 10 (ad<strong>di</strong>rittura a 13) e nella pianura<br />
<strong>di</strong> Esdrelon 1 a 20. Ma qui il minimo è 30. La parabola non parla dunque <strong>di</strong> una<br />
raccolta normale ma <strong>di</strong> una messe straor<strong>di</strong>naria. Una tale abbondanza ricorda<br />
testi dell’Antico Testamento dove il segno rappresenta una particolare<br />
bene<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>vina (cfr. Gen 26,12; Lv 26,5; Am 9,13; Sal 72,16). Queste<br />
immagini non sono un caso: Gesù sta annunziando il Regno <strong>di</strong> Dio e le sue<br />
8
parabole sono l’illustrazione <strong>di</strong> questo messaggio. Sicché la messe abbondante<br />
fa pensare alla situazione che creerà l’avvento del Regno <strong>di</strong> Dio.<br />
Il racconto accorda particolare attenzione anche ai fallimenti del seme: la<br />
strada, i sassi, le spine. Ogni volta c’è una descrizione dettagliata che fa crescere<br />
la tensione e prepara l’affermazione finale concernente il raccolto meraviglioso.<br />
Si tratta unicamente <strong>di</strong> un meccanismo retorico? Cre<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> no. Forse <strong>di</strong>etro<br />
c’è una comunità che fatica a vedere la potenza del Regno <strong>di</strong> Dio che si<br />
manifesta. Si inizia allora coi fallimenti, uno dopo l’altro ma con la certezza che<br />
il Regno <strong>di</strong> Dio si manifesterà in potenza: i primi insuccessi che seguono la<br />
seminagione lasciano spazio al successo finale della raccolta straor<strong>di</strong>naria.<br />
Anche il seminatore non è da sottovalutare. Il Regno <strong>di</strong> Dio non avviene<br />
per caso, in modo impersonale. Al contrario Dio interviene e stabilisce il suo<br />
Regno sulla terra proprio in Gesù. In lui l’intervento definitivo <strong>di</strong> Dio è<br />
cominciato, anzi è la svolta decisiva della storia della salvezza. Nel senso<br />
originale della parabola gli insuccessi del seme rappresentavano la situazione<br />
come appariva nel momento del ministero <strong>di</strong> Gesù; le delusioni che si<br />
provavano non dovevano far dubitare della splen<strong>di</strong>da raccolta che si stava<br />
compiendo per mezzo della venuta del Regno <strong>di</strong> Dio. Se questo era l’orizzonte<br />
della parabola Marco riconosce non pochi parallelismi con la situazione che ha<br />
sotto gli occhi. La pre<strong>di</strong>cazione del vangelo produce effetti molti vari,<br />
rappresentati dalla sorte del seme nei <strong>di</strong>fferenti terreni che lo accolgono.<br />
Preoccupato dai fallimenti Marco mette in guar<strong>di</strong>a i suoi lettori a proposito<br />
degli ostacoli che non permettono alla Parola <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong> portare frutto; ma il<br />
successo della terra buona mostra che il Regno <strong>di</strong> Dio è già presente nella vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana dei fedeli nei quali il messaggio evangelico mostra la sua fecon<strong>di</strong>tà.<br />
Chi ha orecchi cresce nella consapevolezza della potenza del Regno <strong>di</strong><br />
Dio, più grande <strong>di</strong> ogni fallimento. L’ascoltatore è educato ed è educato alla<br />
speranza.<br />
9