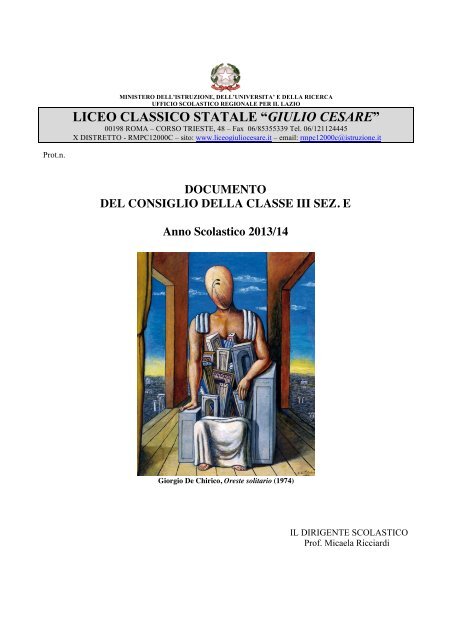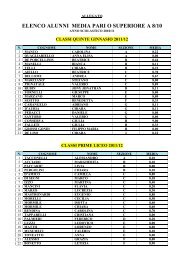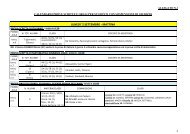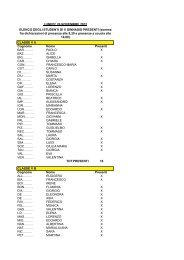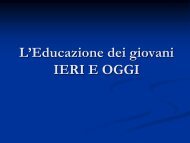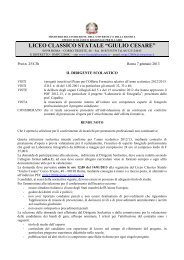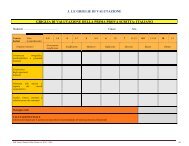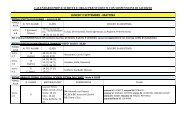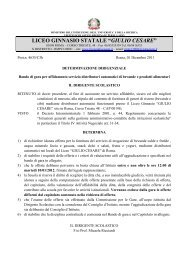Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />
X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />
Prot.n.<br />
DOCUMENTO<br />
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. E<br />
Anno Scolastico 2013/14<br />
Giorgio De Chirico, Oreste solitario (1974)<br />
IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
Prof. Micaela Ricciardi
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> E<br />
Anno scolastico 2013/14<br />
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />
disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />
Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione E ha definito contenuti, obiettivi, metodi e strumenti<br />
valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.<br />
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />
Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è sorto<br />
(1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />
Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran parte<br />
residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa collocazione<br />
urbana.<br />
L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />
diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità ) ed aule<br />
speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca, dotata di moderni<br />
sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi palestre e un campo di<br />
basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />
Dal POF dell’anno scolastico 2013/14 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />
ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />
ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />
per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />
particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione alla<br />
legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute.<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La <strong>classe</strong> <strong>III</strong> E è costituita da 17 studenti (10 alunne e 7 alunni), dei quali la componente maggioritaria è<br />
rappresentativa dell'originario nucleo ginnasiale, mentre 4 allievi, provenienti sia da altre classi della scuola<br />
(due elementi) sia da altri istituti scolastici (due elementi), vi si sono inseriti in itinere, dal secondo anno del<br />
ciclo ginnasiale fino al secondo anno del ciclo liceale.<br />
All'inizio del triennio la <strong>classe</strong> si componeva di 20 studenti, divenuti 22 nello stadio successivo grazie alle<br />
nuove immissioni. In quest'ultimo anno la struttura compositiva della <strong>classe</strong> ha fatto registrare una<br />
significativa riduzione numerica, determinata dalla non ammissione di due studenti e del trasferimento di altri<br />
tre.<br />
La continuità didattica è stata assicurata per la maggior parte delle materie, in ambito sia umanistico che<br />
scientifico. La Storia dell'Arte, dopo l'avvicendamento di due docenti al ginnasio, ha raggiunto uno stabile<br />
equilibrio in virtù della presenza continuativa, nei tre anni del liceo, di un'unica figura professionale; per la<br />
cattedra di Scienze va segnalato l'insediamento, nell'ultimo anno, di una nuova insegnante.<br />
Piuttosto eterogenea nelle sue connotazioni socio-culturali, la <strong>classe</strong> ha sviluppato dinamiche comunicativorelazionali<br />
strutturate in prospettiva pluralistica, facendo progressivamente affermare l'idea di una koiné<br />
scolastica fondata sul confronto, sulla condivisione, sulla partecipazione paritetica.<br />
Nel primo anno del percorso liceale, benché apparisse limitatamente organizzata sul piano del metodo di<br />
studio, la <strong>classe</strong> evidenziava, comunque, l'adeguato possesso di quelle qualità critico-cognitive e linguisticoespressive<br />
che sono requisiti imprescindibili per l'impostazione e lo sviluppo della formazione iniziale del<br />
triennio, e segnalava la presenza di alcuni studenti già particolarmente maturi, motivati, responsabili.
Nel secondo anno di liceo le indubbie capacità e l'impegno di molti studenti, se inizialmente si manifestavano<br />
nella forma di produzioni episodiche o estemporanee, in seguito sono stati canalizzati lungo le coordinate di<br />
una più attenta riflessione critica e di un approccio metodologico meglio disciplinato, con risultati convincenti<br />
anche nell'articolazione di percorsi consapevolmente elaborati.<br />
In quest'ultimo anno del triennio la <strong>classe</strong> ha fatto registrare il potenziamento delle capacità linguisticoespressive<br />
e critiche e il consolidamento degli strumenti di analisi e di sintesi; e ciò si è riscontrato in modo<br />
apprezzabile anche in quegli allievi che si mostravano, nei primi tempi, più defilati e perplessi rispetto al<br />
lavoro proposto. Seppure con una certa escursione nella qualità degli esiti, gli studenti mediamente hanno<br />
affinato e reso più rigorosa la metodologia operativa, acquisendo un più sicuro controllo critico dei contenuti e<br />
pervenendo a un uso più appropriato dei linguaggi specifici disciplinari. All'interno della <strong>classe</strong> si individuano<br />
tre livelli, delineati attraverso la seguente climax di valori:<br />
• Gli studenti del primo livello hanno manifestato notevole interesse per le discipline di studio,<br />
impegnandosi proficuamente nell'approfondimento dei contenuti e partecipando al dialogo didatticoeducativo<br />
con vivacità argomentativa. Hanno evidenziato ottime qualità intellettuali, approfondendo le<br />
varie problematiche con lucidità critica e proponendo rielaborazioni e collegamenti in contesti<br />
interdisciplinari, con approcci espositivi anche non canonici.<br />
• Gli studenti del secondo livello hanno partecipato alle attività didattiche con senso di responsabilità,<br />
acquisendo una preparazione adeguatamente articolata nei contenuti e assimilata con consapevolezza,<br />
anche se non sempre valorizzata da personali apporti critici.<br />
• Gli studenti del terzo livello, che costituiscono un gruppo decisamente minoritario, non sempre<br />
regolari e assidui nell'impegno, pur esprimendo provvisorietà di approccio metodologico, hanno,<br />
tuttavia, acquisito le conoscenze fondamentali, raggiungendo una preparazione di taglio descrittivonozionistico,<br />
ancora non organizzata criticamente.<br />
Il lavoro del Consiglio di Classe è stato orientato nella triplice direzione del recupero delle carenze, del<br />
potenziamento delle capacità linguistico-espressive, del consolidamento di un metodo di studio il più possibile<br />
autonomo ed efficace. Alla fine del percorso liceale gli allievi, il cui comportamento è stato disponibile e<br />
collaborativo nei confronti dei docenti, hanno globalmente raggiunto traguardi indicativi di una soddisfacente<br />
maturazione critica, correlata ad una preparazione omogenea nei contenuti, nelle competenze, nei possessi<br />
metodologici. Alcuni di loro, per rigore, spessore intellettuale e autonomia critica, possono aspirare ad una<br />
valutazione di eccellenza.<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2009/10 A.S. 2010/11<br />
MATERIE LETTERARIE,<br />
LATINO E GRECO<br />
Ferrante<br />
Ferrante<br />
MATEMATICA<br />
Alessandro<br />
Alessandro<br />
INGLESE D’Andrea D’Andrea<br />
STORIA DELL'ARTE Di Mambro Capalbo<br />
ED. FISICA Mitrano Mitrano<br />
IRC Jori Jori
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2011/12 A.S. 2012/13 A.S. 2013/14<br />
ITALIANO Zisa Zisa Zisa<br />
LATINO/GRECO Stilo Stilo Stilo<br />
STORIA E FILOSOFIA Cecchi Cecchi Cecchi<br />
MATEMATICA E FISICA Alessandro Alessandro Alessandro<br />
INGLESE D’Andrea D’Andrea D’Andrea<br />
SCIENZE Petricca Petricca Federico<br />
STORIA DELL'ARTE Bellisario Bellisario Bellisario<br />
ED. FISICA Mitrano Mitrano Mitrano<br />
IRC Jori Jori Jori<br />
!
OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate sono stati<br />
concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />
riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e<br />
culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti delle<br />
diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere nei<br />
seguenti punti :<br />
- acquisire i contenuti generali e specifici;<br />
- potenziare le abilità di analisi, di sintesi, argomentative e di rielaborazione personale delle<br />
conoscenze acquisite;<br />
- padroneggiare i linguaggi specifici attinenti alle diverse aree disciplinari;<br />
- possedere le competenze di sintesi ed astrazione, proprie dell’impostazione logico-scientifica;<br />
- arricchire ed approfondire i contenuti in senso pluridisciplinare;<br />
- sviluppare il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea;<br />
- saper riconoscere le forme e i contenuti propri del sapere antico e metterli a confronto con il<br />
moderno, anche in un’ottica interdisciplinare.<br />
A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina, che tutti gli<br />
alunni dimostrano di aver raggiunto, sia pure a livelli diversi, secondo la scala di valori precedentemente<br />
illustrata.<br />
MATERIA<br />
ITALIANO<br />
LATINO<br />
GRECO<br />
OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />
Conoscere i fenomeni letterari fondanti e le più rilevanti problematiche culturali<br />
relative all’Ottocento e al Novecento; consolidare le abilità di analisi e di<br />
sintesi; saper interpretare tipologie testuali di diverso ambito; saper esporre e<br />
argomentare con chiarezza, coerenza e competenza morfosintattica; saper<br />
padroneggiare i mezzi linguistici nella ricezione e produzione, orale e scritta, in<br />
situazioni comunicative diverse; saper contestualizzare e rielaborare<br />
criticamente gli elementi culturali acquisiti; saper riconoscere i rimandi<br />
intertestuali; saper stabilire opportuni collegamenti disciplinari e tra discipline<br />
diverse.<br />
Leggere, comprendere, tradurre, interpretare testi letterari, complessi nella<br />
trama concettuale, nell’articolazione sintattica, nella struttura lessicale;<br />
effettuare analisi testuali di opere antiche, classificandone i diversi livelli<br />
linguistici (morfologico-sintattico-lessicale-semantico-metrico-stilisticoretorico);<br />
effettuare analisi intertestuali, inserendo i testi in quadri sinottici e<br />
definendo il sistema di analogie e la fenomenologia di influenza; collocare gli<br />
autori e i prodotti letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale;<br />
riconoscere le relazioni di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel<br />
quale si contestualizza, tracciando le coordinate del genere di appartenenza;<br />
utilizzare la lingua dei testi antichi come veicolo ed espressione di categorie<br />
antropologiche e culturali.<br />
Leggere, comprendere, tradurre, interpretare testi letterari, complessi nella<br />
trama concettuale, nell’articolazione sintattica, nella struttura lessicale;<br />
effettuare analisi testuali di opere antiche, classificandone i diversi livelli<br />
linguistici (morfologico-sintattico-lessicale-semantico-metrico-stilisticoretorico);<br />
effettuare analisi intertestuali, inserendo i testi in quadri sinottici e<br />
definendo il sistema di analogie e la fenomenologia di influenza; collocare gli
STORIA<br />
FILOSOFIA<br />
INGLESE<br />
MATEMATICA<br />
FISICA<br />
SCIENZE<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
ED.FISICA<br />
IRC<br />
autori e i prodotti letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale;<br />
riconoscere le relazioni di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel<br />
quale si contestualizza, tracciando le coordinate del genere di appartenenza;<br />
utilizzare la lingua dei testi antichi come veicolo ed espressione di categorie<br />
antropologiche e culturali.<br />
Acquisire conoscenze nell’ambito dei contenuti e delle problematiche inerenti<br />
alla storia e alla filosofia del terzo anno; acquisire capacità atte a<br />
contestualizzare le conoscenze; acquisire capacità atte a stabilire collegamenti<br />
trasversali sia tra le due materie, ma anche, ove possibile, tra le varie<br />
discipline; acquisire un linguaggio specifico; acquisire capacità riflessive e<br />
critiche; acquisire autonomia e sistematicità nel metodo di studio.<br />
Acquisire conoscenze nell’ambito dei contenuti e delle problematiche inerenti<br />
alla storia e alla filosofia del terzo anno; acquisire capacità atte a<br />
contestualizzare le conoscenze; acquisire capacità atte a stabilire collegamenti<br />
trasversali sia tra le due materie, ma anche, ove possibile, tra le varie<br />
discipline; acquisire un linguaggio specifico; acquisire capacità riflessive e<br />
critiche; acquisire autonomia e sistematicità nel metodo di studio.<br />
Raggiungere il livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento, ovvero,<br />
essere in grado di utilizzare la lingua e di saper comprendere le idee-chiave di<br />
un testo letterario che tratti sia argomenti concreti che astratti; saper interagire<br />
con un buon grado di “fluency”, dimostrando conoscenza e padronanza critica<br />
dei contenuti storico-letterari previsti dal curricolo; comprendere le idee<br />
principali di un’ampia tipologia di testi, anche complessi, inserendoli nel loro<br />
contesto storico-sociale, individuandone gli elementi propri del periodo<br />
letterario e dell’autore; saper produrre un testo su vari argomenti, esprimendo<br />
con chiarezza il proprio punto di vista; essere in grado di sapersi orientare in<br />
una conversazione a carattere pluridisciplinare in lingua straniera.<br />
Conoscere i contenuti generali e specifici della matematica; comprendere il<br />
linguaggio formale specifico; saper utilizzare le procedure tipiche del<br />
linguaggio matematico.<br />
Conoscere i fenomeni naturali più significativi; utilizzare con padronanza il<br />
linguaggio matematico adeguato alle situazioni descritte, saper utilizzare e<br />
interpretare modelli e leggi fisiche in situazioni diverse.<br />
Conoscere i nodi fondanti della disciplina; saper argomentare e rielaborare i<br />
temi trattati in maniera personale e critica; saper utilizzare un linguaggio<br />
tecnico- scientifico rigoroso; saper collegare gli argomenti con le discipline<br />
scientifiche ed umanistiche integrandoli in una visione globale.<br />
Saper contestualizzare il prodotto artistico e gli artisti nel corretto momento<br />
storico; saper riconoscere stili e tecniche artistiche; saper leggere l’opera<br />
d’arte sia dal punto di vista iconografico che iconologico; saper confrontare,<br />
esprimere pareri critici e relazionarsi con le altre discipline; saper utilizzare<br />
correttamente il lessico specifico.<br />
Riconoscere e consolidare le proprie potenzialità in ambito sportivo sia sotto<br />
l’aspetto fisico che psichico; acquisire familiarità con l’attività motoria e<br />
assumere la pratica sportiva come abitudine di vita; acquisire una conoscenza<br />
critica dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società;<br />
consolidare il carattere; consolidare lo spirito di socializzazione e il rispetto<br />
delle regole; saper partecipare attivamente alle attività di gruppo.<br />
Contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della chiesa<br />
dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.<br />
Identificare i punti teologici fondamentali della dottrina sociale della chiesa<br />
(encicliche sociali) e del Concilio Vaticano.<br />
Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose.
I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di insegnamento/apprendimento sono stati:<br />
• lezione frontale<br />
• didattica interattiva<br />
• lavori di ricerca e approfondimento<br />
• peer education<br />
• coopertative learning<br />
• uso delle ITC<br />
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />
Rispetto agli obiettivi prefissati, il Consiglio di Classe ha ritenuto importante promuovere quelle<br />
attività curricolari ed extracurricolari alle quali gli studenti potessero interessarsi con risultati positivi,<br />
ai fini di un ulteriore ampliamento del loro orizzonte culturale e di un significativo arricchimento<br />
critico-intellettuale.<br />
La <strong>classe</strong>, pertanto, nella sua globalità o attraverso rappresentanze di studenti, nel corso del triennio<br />
ha partecipato ai seguenti progetti e iniziative culturali:<br />
Greco e Latino • Conferenza:”Il classicismo e le radici della cultura europea”, Università LUISS<br />
di Roma.( Borrello, Fea, Pennetta.), a.s.2012-2013<br />
• Convegno “!"#$% e Civitas Christiana” Università Salesiana di Roma,<br />
a.s.2012-2013. Otto allievi della <strong>classe</strong> (Imperatrice, Manes, Marianeschi,<br />
Mattii, Moriggi, Pisano, Tesolin, Toneatto) hanno partecipato al convegno,<br />
relazionando sul tema “La donna nella &"#$%”, e hanno ricevuto l’encomio del<br />
Preside di Facoltà. Il lavoro per la rigorosa e originale analisi della<br />
problematica proposta, è stato inserito nella pubblicazione degli Atti del<br />
Convegno.<br />
• Conferenza di Guido Paduano e Monica Centanni sul “Teatro di Sofocle, da<br />
Antigone ad Edipo Re”, a cura dell’INDA., a.s.2012-2013.<br />
• Convegno internazionale “Villa Adriana: memoria, storia, fortuna, futuro”<br />
presso il “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”, con Monica<br />
Centanni.(Borrello, Fea, Pennetta, Tesolin)., a.s.2012-2013.<br />
• “Theatron: teatro antico alla Sapienza”, a cura di Anna Maria Belardinelli,<br />
a.s. 2011-2012, a.s.2012-2013.<br />
• Progetto P.O.F. : “La drammaturgia classica” in collaborazione con l’Istituto<br />
Nazionale del Dramma Antico. Approccio drammaturgico ai testi teatrali<br />
classici, complementare alle metodologie filologiche. Conferenze tenute da<br />
docenti universitari presso i licei firmatari del protocollo di intesa con<br />
l’I.N.D.A: Mamiani, Visconti, <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>, Dante Alighieri, Convitto<br />
Nazionale. Corso monografico: ”Potere e politica: attualità della tragedia<br />
greca”, a.s.2013-2014.<br />
• Conferenze A.I.C.C. (Associazione Italiana Cultura Classica) su: Teocrito,<br />
Virgilio, Apuleio, a.s.2012-2013.<br />
• Convegno Internazionale di Studi sul Dramma Antico: “Agamennone, cento<br />
anni dopo”, a cura dell’INDA (Manes,Marianeschi, Mattii, Moriggi, Musumeci,<br />
Pennetta, Pisano, Toneatto), a.s.2013-2014.<br />
• Visita alla Biblioteca Angelica con accesso allo spazio manoscritti,a.s.2012-<br />
2013.<br />
• Nel corso del triennio gli alunni hanno seguito un percorso di approfondimento<br />
degli elementi fondanti della drammaturgia classica. A complemento e<br />
integrazione delle suddette attività gli studenti hanno fruito delle seguenti<br />
rappresentazioni teatrali e cinematografiche:”Antigone”, “Ippolito”, “Medea”,<br />
“Amore e Psiche”, “La Pace”, “Mostellaria”, “Il Mercante di Venezia”,<br />
“Satyricon “ di Federico Fellini, “Pompei” a cura del British Museum.
Inglese<br />
Italiano<br />
Storia e<br />
Filosofia<br />
• Progetto P.O.F. “Le Idi di…”(Giornale d’istituto) (Luzzi), a.s.2011-2012.<br />
• Progetto P.O.F.“Book Generator”. Presentazione del libro “Se ti abbraccio non<br />
aver paura” di Fulvio Ervas. (Pennetta, Toneatto),a.s.2011-2012.<br />
• Progetto P.O.F. “ Quotidiano in <strong>classe</strong>”, a.s.2013-2014.<br />
• Progetto P.O.F.”Letture filosofiche” sul tema “Le radici della filosofia<br />
politica”, a.s.2011-2012.<br />
• Progetto P.O.F. “Geografia delle memoria nel Lazio”.! Gli/le studenti/sse<br />
Imperatrice Maria, Manes Silvia, Musumeci Valeria, Tesolin Lorenzo, Toneatto<br />
Anna nell’a.s. 2012/13 hanno partecipato al progetto –Geografia della memoria<br />
nel Lazio – patrocinato dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Museo della<br />
Shoah di Roma, un lavoro di ricerca sulle leggi razziali italiane del 1938-43 e<br />
sui luoghi d’internamento situati nel territorio regionale.<br />
• Progetto P.O.F. “Olimpiadi della Filosofia” (Manes, Mattii, Tesolin), a.s.2012-<br />
2013.<br />
• Conferenza sul tema:“Settanta anni fa, quello che ci costituisce e è la<br />
resistenza”, <strong>Liceo</strong> Righi (Imperatrice, Sanzò, Scali, Toneatto),a.s.2013-2014.<br />
• Progetto P.O.F. sulle Ballate inglesi :“ Lyrical Ballads”, a.s. 2011-2012.<br />
Matematica e<br />
Fisica<br />
• Progetto P.O.F. “ Olimpiadi di Matematica”, a.s.2011-2012 (Imperatrice,<br />
Luzzi, Mattii, Sova); a.s.2012-2013(Imperatrice, Mattii, Sova) ; a.s.2013-2014<br />
(Imperatrice).<br />
• Progetto P.O.F. “ Laboratorio di Oscillazioni Meccaniche” (Luzzi,<br />
Mattii),a.s.2012-2013.<br />
• Progetto P.O.F. “N.E.R.D. –Non E’ Roba per Donne”<br />
(I seminario: ha partecipato tutta la <strong>classe</strong>; II seminario: Toneatto.), a.s.2013-<br />
2014.<br />
• Progetto P.O.F. “P.L.S” (Piano Lauree Scientifiche) presso l’Università<br />
Sapienza, Dipartimento di Matematica: Esercitazioni di ambito disciplinare.<br />
(Luzzi e Mattii),a.s.2013-2014<br />
Scienze • Progetto P.O.F. “Planetario a scuola”, a.s.2013-2014.!<br />
Storia dell’Arte • Progetto P.O.F. “Laboratorio di restauro” (Scali), a.s.2012-2013.!<br />
Attività<br />
Complementari<br />
• Viaggio di Istruzione a Parigi, a.s.2011-2012.<br />
• Viaggio di Istruzione a Berlino, a.s.2013-2014.<br />
• Mostra su Verdi con concerto e visita didattica all’Accademia dei Lincei.<br />
(Borrello, Fea, Luzzi, Marianeschi, Moriggi),a.s.2013-2014.<br />
• Concerto Auditorium Parco della Musica: “Musiche di Mozart”. (Manes,<br />
Musumeci, Toneatto), a.s.2013-2014.<br />
• Progetto P.O.F. Ciclo di conferenze sul tema : “Economia Politica”, a.s.2012-<br />
2013.<br />
!
VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />
In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia di indicatori<br />
che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />
La valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, avvenuta in itinere e alla fine dei due<br />
periodi (trimestre e pentamestre), è stata intesa come momento formativo, atto a cogliere i progressi compiuti<br />
dagli alunni rispetto ai loro livelli di partenza.<br />
La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione che si<br />
allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie sono state<br />
approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame, con una durata delle prove di<br />
3 ore per la Terza Prova e di 5 ore per la Prima Prova.<br />
Modalità e tipologie della simulazione della Terza Prova<br />
Per la <strong>classe</strong> <strong>III</strong> E sono state programmate due simulazioni della terza prova. La prima, somministrata, secondo<br />
la tipologia A, nel primo periodo dell’anno scolastico (trimestre), in data 20/11/2013, con la durata di 3 ore,<br />
verteva sulle seguenti materie: Latino, Storia, Inglese, Fisica, Storia dell’Arte.<br />
La seconda simulazione della Terza Prova, somministrata, secondo la tipologia B, nel secondo periodo<br />
dell’anno scolastico (pentamestre), in data 15/04/2014, con la durata di 3 ore, verteva sulle seguenti materie:<br />
Latino, Filosofia, Inglese, Matematica, Storia dell’Arte.<br />
Si allegano i testi delle prove (allegato n.5) e le relative griglie di valutazione.<br />
Dai riscontri in sede di valutazione collegiale, emerge che la tipologia B è più congeniale al conseguimento di<br />
risultati positivi.!Le materie in cui gli studenti hanno conseguito migliori esiti di profitto risultano essere Fisica<br />
e Storia (oltre a Latino, Inglese e Storia dell’Arte, materie presenti in entrambe le simulazioni).<br />
E’ stata programmata per il giorno 20/05/2014 la simulazione della Prima Prova, con la durata di 5 ore.<br />
Si allegano al presente documento:<br />
ALLEGATI<br />
Allegato n.1 -<br />
Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />
Allegati n.2 – 3 - 4 - Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza prova<br />
Allegati n. 5<br />
Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />
Allegati n.6 al 17 - Programmi disciplinari<br />
Roma 15 maggio 2014
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
ITALIANO prof. ZISA DANIELA (firma)……………………..<br />
LATINO prof. STILO DELIA (firma)……………………..<br />
GRECO prof. STILO DELIA (firma)……………………..<br />
INGLESE prof. D’ANDREA VALERIA (firma)……………………..<br />
STORIA E FILOSOFIA prof. CECCHI FABIO (firma)……………………..<br />
MATEMATICA E FISICA prof. ALESSANDRO ROSA M. (firma)……………………..<br />
SCIENZE prof. FEDERICO MARIA (firma)……………………..<br />
STORIA DELL’ARTE prof. BELLISARIO FABIO (firma)……………………..<br />
ED. FISICA prof. MITRANO ANTONIO (firma)……………………..<br />
IRC/MAT.ALT. prof. JORI ANTONELLA (firma)……………………..
! ALLEGATO N.1<br />
VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />
strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />
Abilità:<br />
implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />
pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />
culturale.<br />
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />
Voto<br />
Indicatori di<br />
conoscenze<br />
Indicatori di<br />
abilità<br />
Indicatori di<br />
competenze<br />
Livello di certificazione delle competenze di<br />
base<br />
(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />
1 – 3<br />
Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />
argomenti disciplinari e disarticolate<br />
nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />
Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />
assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />
argomentazione.<br />
Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />
non è in grado di applicare regole o elementari<br />
operazioni risolutive.<br />
4<br />
Conosce in modo vago e confuso gli<br />
argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />
difficoltà i nuclei essenziali e le<br />
interrelazioni.<br />
Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />
nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />
un linguaggio disordinato e scorretto.<br />
Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />
semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />
procedure di risoluzione.<br />
Non ha raggiunto il livello base delle<br />
competenze.<br />
5<br />
E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />
conoscenze, delle quali coglie<br />
parzialmente implicazioni e rimandi<br />
essenziali.<br />
Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />
incompleto, con non certa padronanza delle<br />
soluzioni espressive.<br />
Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />
limitato di contesti. Applica, non sempre<br />
adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 – 10<br />
Conosce gli ambiti delle diverse<br />
discipline e ne coglie in linea globale<br />
contenuti e sviluppi.<br />
Conosce gli argomenti e li colloca<br />
correttamente nei diversi ambiti<br />
disciplinari.<br />
Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />
grazie ad approfondimenti personali negli<br />
aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />
Mostra piena padronanza degli ambiti<br />
disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />
di informazioni.<br />
Comprende le consegne e risponde in modo<br />
semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />
linguaggi disciplinari.<br />
Comprende e contestualizza le consegne e le<br />
sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />
complessivamente coerenti.<br />
Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />
operando collegamenti con<br />
appropriata scelta di argomentazioni.<br />
E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />
dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />
efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />
collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />
Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />
scelta e nella applicazione delle strategie di<br />
risoluzione.<br />
Sa impostare problemi di media complessità e<br />
formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />
di risoluzione.<br />
E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />
di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />
operare scelte coerenti ed efficaci.<br />
Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />
ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />
anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />
Livello base: lo studente svolge compiti<br />
semplici in situazioni note, mostrando di<br />
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />
saper applicare regole e procedure<br />
fondamentali.<br />
Livello intermedio: lo studente svolge<br />
compiti e risolve problemi complessi in<br />
situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />
le abilità acquisite.<br />
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />
problemi complessi in situazioni anche non<br />
note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />
sostenere le proprie opinioni e assumere<br />
autonomamente decisioni consapevoli
ALLEGATO N.2<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
!<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Giudizio sintetico<br />
Correttezza ortografica,<br />
morfosintattica e proprietà<br />
lessicale<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
Conoscenza<br />
degli argomenti<br />
proposti<br />
Aderenza alla traccia e<br />
rispetto dei vincoli<br />
comunicativi<br />
Analisi, sintesi, coerenza e<br />
rielaborazione dei contenuti<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)
ALLEGATO N.3<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
!<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Giudizio sintetico<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
Comprensione del testo<br />
Conoscenza della morfosintassi<br />
Qualità linguistica della traduzione<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
I DOCENTI
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
ALLEGATO N.4<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />
STUDENTE: ……………………………………….<br />
CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
!<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />
STUDENTE: ………………………………………<br />
CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />
Voto in<br />
decimi<br />
Voto in<br />
quindicesimi<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Giudizio sintetico<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
Descrittori<br />
Quesiti<br />
1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare<br />
criticamente le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
!<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
ALLEGATO N.5<br />
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
TESTI DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 20/11/2013 (Tipologia A)<br />
Latino<br />
La protesta dell’intellettuale durante il Principato di Nerone, tra inquietudine esistenziale, riflessione<br />
morale e dissenso politico.<br />
Storia<br />
Spiega perché la penetrazione imperialista delle potenze europee nel continente asiatico fu più difficile di<br />
quella attuata in Africa ed illustra contestualmente la differenza tra i modelli di amministrazione delle<br />
colonie.<br />
Inglese<br />
Explain W. Blake’s poetry, by considering his social, artistic and historical background; his idea of<br />
imagination and the poet. You can make references to his poems.<br />
Fisica<br />
Descrivi le proprietà elettriche di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico.<br />
Storia dell’Arte<br />
Tramite l’analisi dell’ opera “Pubertà” (1895) delineate il nesso tra la poetica figurativa di E.Munch e la<br />
coeva produzione del drammaturgo H. Ibsen.
TESTI DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 15/04/2014 (Tipologia B)<br />
Latino<br />
1) Modernità di Quintiliano nell’impostazione delle problematiche educative.<br />
2) La posizione ideologico-culturale di Plinio il Giovane nei confronti dei Cristiani.<br />
Filosofia<br />
1) Analizza le tematiche generali dell’opera Al di là del bene e del male di Nietzsche.<br />
2) Libertà e aut-aut nella filosofia esistenziale di Kierkegaard.<br />
Inglese<br />
1) The Victorian novel is considered to be a mirror of life. Explain. You can make references to one or<br />
more than one authors.<br />
2) What are the main features and themes of the novel A Passage to India, by E. M. Forster<br />
Matematica<br />
1) Determinare i cateti di un triangolo rettangolo ABC, sapendo che la sua area è 36!3 e che uno degli<br />
angoli acuti è doppio dell’altro.<br />
2) Risolvi la seguente equazione 1- cos2x = senx . Al termine dimostra la formula di duplicazione del<br />
coseno.<br />
Storia dell’Arte<br />
1) Delineate, tramite opportuni esempi, le due fasi della pittura futurista.<br />
2) Il concetto di “stimmung” nietzschiano permea tutta la pittura metafisica di Giorgio De Chirico.<br />
Tramite un’opera delineatene il significato specifico.
ALLEGATI<br />
PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />
ALLEGATO N. 6.<br />
ALLEGATO N. 7.<br />
ALLEGATO N. 8.<br />
ALLEGATO N. 9.<br />
ALLEGATO N. 10.<br />
ALLEGATO N. 11.<br />
ALLEGATO N. 12.<br />
ALLEGATO N. 13.<br />
ALLEGATO N. 14.<br />
ALLEGATO N. 15.<br />
ALLEGATO N. 16.<br />
ALLEGATO N. 17.<br />
Italiano<br />
Latino<br />
Greco<br />
Inglese<br />
Storia<br />
Filosofia<br />
Matematica<br />
Fisica<br />
Scienze<br />
Storia dell’arte<br />
Educazione fisica<br />
Insegnamento Religione Cattolica
ALLEGATO N.6<br />
ITALIANO<br />
Programma svolto<br />
Manuale in adozione: Baldi – Giusso – Razetti - Zaccaria: “Testi e storia della Letteratura”, volumi D,E,F,<br />
Paravia.<br />
Preromanticismo: le premesse e gli aspetti fondamentali.<br />
Il Romanticismo: Origine del termine; le tematiche, l’intellettuale e le contraddizioni dell’età.<br />
Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti, la poetica dei romantici italiani, Madame de<br />
Stael, “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni; Pietro Giordani “Un italiano risponde al discorso della de<br />
Stael”; Giovanni Berchet, da “Lettera semiseria di Grisostomo”, “La poesia popolare”.<br />
Il romanzo storico: le caratteristiche del genere, il romanzo storico in Italia.<br />
Alessandro Manzoni: vita, formazione; prima delle conversione: le opere classisicistiche; dopo la<br />
conversione: la concezione della storia e della letteratura; dalla “Lettre a M. Chaveut”, “Storia e invenzione<br />
poetica”; lettera di Manzoni a <strong>Cesare</strong> d'Azeglio: dalla “Lettera sul Romanticismo”, “L'utile,il<br />
vero,l'interessante”.<br />
Da “Gli inni sacri”, “La Pentecoste” (contenuto informativo).<br />
La lirica patriottica e civile: “Marzo 1821” (contenuto informativo); “Cinque Maggio” (contenuto<br />
informativo).<br />
Le Tragedie: la novità della tragedia Manzoniana,; “Il conte di Carmagnola” (vicenda e temi),” L'Adelchi”<br />
(vicenda e temi); “la morte di Ermengarda” coro dell'atto IV.<br />
Il “Fermo e Lucia” e i “Promessi Sposi”: Manzoni e il problema del romanzo; i Promessi Sposi e il romanzo<br />
storico; il quadro polemico del Seicento; l'ideale manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo;<br />
l'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il rifiuto dell'idillio; la<br />
concezione manzoniana della Provvidenza; l'ironia verso la narrazione e i lettori; l'ironia verso i personaggi;<br />
il Fermo e Lucia: un altro romanzo; il problema della lingua.<br />
Testi: “Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico”, dal “Fermo e Lucia”, tomo II, capitolo VII,<br />
nel confronto con “L’Innominato: dalla storia al mito” da “I Promessi Sposi”, capitolo XIX.<br />
Giacomo Leopardi: la vita, la formazione. Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura<br />
malvagia, il pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito”: l'infinito nell'immaginazione, il bello<br />
poetico, antichi e moderni.<br />
Testi: dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”,<br />
“L’antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”, “Parole poetiche”, “Ricordanza<br />
e poesia”, “ Teoria del suono”, “Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La doppia visione”, “La<br />
rimembranza”.<br />
I Canti: le Canzoni, gli Idilli, il “Risorgimento” e i “Grandi idilli” del '28-'30; la distanza dai primi idilli; la<br />
Ginestra e l'idea Leopardiana del progresso.<br />
Testi: dai Canti: “L'infinito”; “Ultimo canto di Saffo”; “A Silvia” ; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno<br />
di un pastore errante dell'Asia”; “La ginestra o il fiore del deserto”.<br />
Le Operette morali e “l'arido vero”.<br />
Testi: dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico”.<br />
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il<br />
Romanticismo straniero; un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata;<br />
Testi: I.U. Tarchetti, “Fosca” (lettura integrale).<br />
Il Positivismo: contesto storico, socio-economico e culturale.<br />
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart;<br />
tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano; “Madame Bovary” (vicende e temi).<br />
I fratelli De Goncourt, da “Germinie Lacerteux” la Prefazione: “Un manifesto del Naturalismo”.<br />
Emile Zola: vita, opere;<br />
Testi: “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”, Prefazione de “Il romanzo sperimentale”;<br />
“L’Assommoir” (trama).<br />
Giovanni Verga: vita, formazione, opere.<br />
I romanzi preveristi.<br />
Testi: da Eva, Prefazione, “Arte, Banche e Imprese industriali”.<br />
La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità; la tecnica<br />
narrativa.<br />
Testi: “Sanità rusticana e malattia cittadina”; da “L’amante di Gramigna”, Prefazione, “Impersonalità e<br />
regressione”; “L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato”.<br />
L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del pessimismo.<br />
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative; le diverse ideologie.<br />
Vita dei campi.<br />
Testi: da “Vita dei campi”, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”.<br />
Il ciclo dei Vinti.<br />
Testi: da “I Malavoglia”, Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”.<br />
I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione<br />
romantica del monto rurale; la costruzione bipolare del romanzo.<br />
Testi: da “I Malavoglia”, capitolo I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; dalle “Novelle rusticane”,<br />
“La roba”, “Libertà”.<br />
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la<br />
critica alla “religione della roba”.<br />
Testi: da “Mastro-don Gesualdo”, I, capitolo IV, “La tensione faustiana del self-made man”.<br />
Il Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e<br />
miti della letteratura decadente.<br />
Testi: C. Baudelaire, da “Le fleur du mal”, “Correspondances”; “L’albatro”.<br />
La poesia simbolista: simbolo e allegoria; la lezione di Baudelaire.<br />
Testi: P. Verlaine, da “Un tempo e poco fa”, “Arte Poetica”; “Languore”; A. Rimbaud, dalle “Poesie”,<br />
“Vocali”; S. Mallarmè, da “Un colpo di dadi”, “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”.<br />
Il romanzo decadente in Europa, coordinate culturali (Wilde, J.K. Huysmans)<br />
Gabriele d'Annunzio: vita. L’estetismo e la sua crisi: i versi degli anni Ottanta e l'estetismo; “Il Piacere” e<br />
la crisi dell'estetismo.<br />
I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l'esteta; “Il Trionfo della morte” (temi e<br />
trama); “Le vergini delle rocce” (temi e trama); “Il fuoco”(temi e trama).<br />
Le Laudi: progetto e struttura.<br />
Testi: da “Alcyone”, “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”.<br />
Il periodo notturno.<br />
Giovanni Pascoli: vita, formazione, opere. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i<br />
simboli.<br />
La poetica: il fanciullino; la poesia “pura”.<br />
Testi: da “Il fanciullino”, “Una poetica decadente”.<br />
Ideologia politica: dal socialismo alla fede umanitaria, la mitizzazione del piccolo operaio rurale, il<br />
nazionalismo.<br />
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori, i miti.<br />
Le soluzioni formali; sintassi,lessico,aspetti fonici,metrica e figure retoriche.<br />
Myricae.<br />
Testi: da “Myricae”, “Arano”, “X Agosto”, “Temporale”; dai “Poemetti”, “Italy” (II,<strong>III</strong>,V,V<strong>III</strong>), dai “Canti<br />
di Castelvecchio”, “Il gelsomino notturno”.
Italo Svevo: vita, opere; la formazione culturale: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin; i<br />
rapporti con la psicoanalisi.<br />
I romanzi e le figure dell’ “inetto”: “Una vita”: inettitudine, malattia , “doppio”. “Antiromanzo di<br />
formazione”. “Senilità”: tematica, autoinganni. “La coscienza di Zeno”: tematica psicoanalitica;<br />
ambivalenza salute-malattia. Struttura narrativa e scardinamento dell’ordine cronologico.<br />
Testi: “La coscienza di Zeno”, lettura integrale consigliata.<br />
Luigi Pirandello: vita, formazione, opere. Ideologia e poetica: realtà e apparenza, la dissoluzione dell'io, la<br />
critica alle convenzioni sociali, la poetica dell'umorismo; i romanzi e le novelle: da “L'Esclusa” al “Il fu<br />
Mattia Pascal” e a “Uno, nessuno e centomila”; “Novelle per un anno”; il teatro pirandelliano. Il<br />
“metateatro”: “ Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico IV”.<br />
Testi: “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale consigliata.<br />
La nuova poesia “ermetica”<br />
Origine e significato del termine “ermetismo”, il contesto culturale, la poetica, i temi, gli aspetti formali.<br />
La poesia del Novecento (coordinate culturali): Crepuscolarismo, “Manifesto del Futurismo” di Marinetti.<br />
Umberto Saba: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />
Testi: dal “Canzoniere”, “Trieste”.<br />
Giuseppe Ungaretti: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />
Testi: da “L'Allegria”, “Soldati”; “Veglia”.<br />
Eugenio Montale: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />
Testi: da “Ossi di seppia”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.<br />
Dante, “DIVINA COMMEDIA”- PARADISO<br />
Testo in adozione: F. Greco, “Antologia dei canti dalla Commedia”, Zanichelli.<br />
Canto I: protasi e invocazione(vv1-36), ascesa al cielo (vv 37-81), dubbi di Dante risolti da Beatrice (vv 82-<br />
99), l'ordine dell'Universo(vv 100-142)<br />
Canto II: ammonimento ai lettori(vv1-18)<br />
Canto <strong>III</strong>: il cielo della Luna (vv 1-33), Piccarda Donati (vv 34-57), i gradi della beatitudine e l'inadempienza<br />
dei voti (vv 58-108), l'imperatrice Costanza (vv 109-130)<br />
Canto VI: Giustiniano (vv 1-33), storia e funzione dell'impero (vv34-111), Romeo di Villanova (vv 112-142)<br />
Canto V<strong>III</strong>: Cielo di Venere. Gli spiriti amanti (vv 1-30), Incontro con Carlo Martello (vv 31-48), Carlo<br />
Martello si presenta (vv 49-84), Spiegazione sulle diverse inclinazioni umane (vv 85-135), Gli uomini<br />
devono assecondare le inclinazioni (vv 136-148)<br />
Canto XI: le cure umane e le glorie celesti (vv 1-12), dubbi di Dante(vv 13-27), elogio di San Francesco( vv<br />
28-117), decadenza dell'ordine Domenicano( vv 118-139)<br />
Canto XII: riassunto.<br />
Canto XVII: perplessità di Dante (vv 1-30), risposta di Cacciaguida: profezia dell'esilio di Dante (vv 31-39),<br />
la missione del poeta (vv 100-142)<br />
Canto XXX<strong>III</strong>: preghiera di San Bernando alla Vergine (vv 1-45), visione di Dio e dell'unità dell'universo in<br />
Dio (vv 46-108), misteri della Trinità e dell'Incarnazione (vv 109-132), sforzo supremo della mente di Dante,<br />
sua folgorazione e appagamento (vv 133-145).<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. DANIELA ZISA
ALLEGATO N.7<br />
LATINO<br />
Programma svolto<br />
L’ETÀ DEL PRINCIPATO<br />
Il contesto storico-culturale<br />
Il sistema letterario<br />
Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale<br />
SENECA IL VECCHIO e Le Declamationes<br />
Le Recitationes<br />
La tradizione favolistica: FEDRO<br />
La poesia astronomica: GERMANICO E MANILIO<br />
La filosofia: SENECA<br />
L’epica: LUCANO<br />
PETRONIO e il Satyricon<br />
La satira :<br />
- PERSIO<br />
- GIOVENALE<br />
Il sapere enciclopedico: PLINIO IL VECCHIO<br />
L’epigramma: MARZIALE<br />
L’ oratoria: QUINTILIANO<br />
Le cause della decadenza dell’oratoria nel dibattito culturale dell’età imperiale:<br />
Velleio Patercolo, Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Anonimo Del Sublime.<br />
Tra oratoria ed epistolografia: PLINIO<br />
La storiografia: TACITO<br />
La biografia: SVETONIO<br />
APULEIO e Il romanzo<br />
TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA<br />
FEDRO, Fabulae, 1,15<br />
2,1<br />
5,1<br />
SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, 1<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 37<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 40<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 67
Epistulae morales ad Lucilium, 75<br />
De tranquillitate animi, 4, 6-8<br />
De brevitate vitae, 1,1;1,3<br />
LUCANO, Pharsalia, 1, 1-32<br />
1, 183-227<br />
2, 286-323<br />
10, 53-103<br />
PETRONIO, Satyricon, 1, 4<br />
31, 3-37,10<br />
110, 6-113, 2<br />
PERSIO, Saturae, 3<br />
GIOVENALE, Saturae, 3,41-48<br />
6<br />
PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, 29,17-27,<br />
MARZIALE, Epigrammata, 1,61<br />
12,73<br />
1,19<br />
1,30<br />
2,15<br />
1,84<br />
4,41<br />
8,79<br />
3,26<br />
5,34<br />
4,49<br />
10,96<br />
11,62<br />
10,4<br />
10,47<br />
12,94<br />
11,108<br />
QUINTILIANO, Institutio Oratoria, 1, 2, 18-28<br />
2, 2 ,4-13<br />
10, 1, 85-88<br />
10,1,93-96<br />
10, 1, 105-110<br />
10,1, 125-131<br />
8, 5, 2<br />
1,1, 20-29<br />
PLINIO IL GIOVANE, Epistulae, 3,16<br />
6,16<br />
8,8<br />
10, 96-97<br />
10,97(98)<br />
TACITO, Dialogus de oratoribus, 35<br />
36<br />
Germania, 8<br />
19<br />
Historiae, 1, 36
Annales, 13,16<br />
15, 62-63<br />
SVETONIO, De vita Caesarum,<br />
Divus Claudius, 41-42<br />
Domitianus, 16,17<br />
APULEIO, Metamorfosi, La favola di Amore e Psiche, 4,28-6,24<br />
1, 1-3<br />
3, 21-22<br />
LETTURE CRITICHE<br />
G.B. Conte, Seneca filosofo: linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione<br />
G.B. Conte, Sul “genere” della Pharsalia di Lucano<br />
G.B. Conte, Letteratura satirica: Persio e Giovenale<br />
A. Traina, Contemplazione della morte e contemplazione del cosmo nelle Consolationes di Seneca<br />
A. La Penna, Il realismo di Persio<br />
TESTI IN LATINO<br />
ORAZIO, poeta della saggezza e della misura<br />
Carmina, I,1<br />
I,5<br />
I,9<br />
I,11<br />
I,23<br />
I,37<br />
I,38<br />
<strong>III</strong>,13<br />
<strong>III</strong>,30<br />
IV,7<br />
Lettura metrica, traduzione, commento<br />
SENECA, dall’impegno civile alla terapia dell’anima<br />
De brevitate vitae, 2<br />
De providentia, 6<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 1<br />
37, 1-3<br />
47<br />
Traduzione e commento<br />
TACITO, tra storia e tragedia<br />
Agricola, 30<br />
Annales, XV, 57<br />
XVI, 18<br />
XVI, 19<br />
Historiae, 1, 10<br />
Traduzione e commento<br />
LIBRO DI TESTO<br />
CONTE PIANEZZOLA, Storia e testi della letteratura latina, Le Monnier<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. DELIA STILO
ALLEGATO N.8<br />
GRECO<br />
Programma svolto<br />
L’ETA’ ELLENISTICA<br />
La civiltà ellenistica<br />
- Storia del termine “Ellenismo”<br />
- Quadro storico-politico: i regni ellenistici<br />
- La civiltà del libro e i luoghi di produzione della cultura<br />
- Alessandria e le sue istituzioni culturali:<br />
Il Museo e la Biblioteca; studi filologici<br />
- Caratteri della civiltà ellenistica:<br />
Cosmopolitismo e Individualismo<br />
Filosofia, Scienza, Religione<br />
La Lingua; la nuova Letteratura<br />
MENANDRO e La commedia nuova<br />
CALLIMACO e La nuova poetica<br />
La poesia elegiaca:<br />
- Fileta<br />
- Ermesianatte<br />
- Fanocle<br />
-Alessandro Etolo<br />
APOLLONIO RODIO e La poesia epico-didascalica<br />
TEOCRITO e La poesia bucolico-mimetica<br />
La poesia bucolica dopo Teocrito:<br />
- Mosco<br />
- Bione<br />
La poesia mimetica dopo Teocrito:<br />
- Eroda<br />
- Il lamento dell’esclusa<br />
L’epigramma<br />
- L’epigramma dorico-peloponnesiaco<br />
- L’epigramma ionico-alessandrino<br />
- L’epigramma fenicio<br />
La storiografia ellenistica<br />
POLIBIO e La storiografia pragmatica<br />
- Storiografia mimetica. Gli Storici di Alessandro<br />
- Timeo e la storia d’Occidente<br />
- Ecateo e la storia utopistica
- Evemero,tra ricerca storica e utopia<br />
La filosofia dell’età ellenistica<br />
- Epicuro e l’Epicureismo<br />
- Lo Stoicismo<br />
L’ETA’ GRECO-ROMANA<br />
- Gli orientamenti della cultura<br />
La retorica e il trattato SUL SUBLIME<br />
- Asianesimo e Atticismo<br />
- Le polemiche retoriche:<br />
Apollodorei e Teodorei<br />
La Seconda Sofistica<br />
LUCIANO<br />
Tra biografia e riflessione morale<br />
PLUTARCO<br />
IL ROMANZO<br />
-Contenuti, strutture, tipologie narrative<br />
-Il problema delle origini<br />
TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA:<br />
MENANDRO, Il Misantropo<br />
L’arbitrato<br />
CALLIMACO, Aitia, Contro i Telchini,fr.1 Pfeiffer,1-38<br />
Acontio e Cidippe,fr.75 Pfeiffer,1-49<br />
Ecale, Fr.69 Hollis-Pfeiffer, 1-15<br />
Fr.74 Hollis-Pfeiffer, 44-69<br />
Giambi, La contesa fra l’alloro e l’ulivo,fr.194 Pfeiffer,G. IV,12-92<br />
Inni, Artemide bambina;Inno ad Artemide,1-86<br />
L’accecamento di Tiresia; Per i lavacri di Pallade,70-142<br />
Epigrammi<br />
Epigrammi erotici, XXV,XXXI,XL<strong>III</strong>,XXV<strong>III</strong><br />
Epigrammi funebri, II,X<strong>III</strong>,XIV,XVI,XXXIV<br />
Epigrammi encomiastici, LI<br />
FILETA, Orgoglio di poeta, fr.10 Powell<br />
FANOCLE, Morte di Orfeo, fr.1 Powell<br />
ALESSANDRO ETOLO, La triste sorte di Anteo, fr.3 Powell<br />
APOLLONIO RODIO, Argonautiche, Il proemio,I, 1-22,<br />
Libro <strong>III</strong><br />
TEOCRITO, Idilli, VII, Le Talisie<br />
II, L’incantatrice<br />
XV, Le Siracusane
MOSCO, Eros fuggitivo,7-11<br />
BIONE, Epitafio di Adone,15-61<br />
IL POETA DELL’ESCLUSA, Fragmentum Grenfellianum<br />
ANTOLOGIA PALATINA, Epigrammi erotici<br />
Epigrammi sepolcrali<br />
POLIBIO, Storie, Libro VI<br />
EPICURO, Lettera a Meneceo<br />
ANONIMO DEL SUBLIME, Il Sublime<br />
Le fonti,7-9,3<br />
Apologia dell’imperfezione sublime, 33;35, 2-5<br />
Le cause della corrotta eloquenza,44<br />
LUCIANO, Dialoghi dei morti, 3,157, Fugacità della bellezza umana<br />
Storia vera, 2,20, Omero e la questione omerica<br />
PLUTARCO, Vite Parallele, Alessandro, I, 1<br />
Cicerone, 47-49, 1-2<br />
Demostene-Cicerone (confronto), 50-54<br />
<strong>Cesare</strong>,63-66<br />
Moralia,16-17, La morte di Pan<br />
LETTURE CRITICHE<br />
Cantarella, L’ambiguo malanno<br />
M. Fusillo, L’Orestea secondo Pasolini, in “Quaderni di Dionisio”, INDA<br />
P.P. Pasolini, Lettera del traduttore, in Eschilo, Orestiade, traduz. di P.P. Pasolini<br />
B. Snell, Il giocoso in Callimaco, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo<br />
TESTI IN GRECO<br />
Giustizia e vendetta nel mito e nella storia.<br />
Coordinate antropologiche e culturali: dal "#$%& alla '()*&.<br />
ESCHILO, Agamennone,<br />
Prologo, 1-39<br />
Parodo, 40-82<br />
161-183<br />
218-257<br />
I Episodio, 320-344<br />
351-354<br />
I Stasimo, 438-487<br />
II Stasimo,681-716<br />
<strong>III</strong> Episodio, 810-828<br />
844-876<br />
<strong>III</strong> Stasimo, 975-1034<br />
Lettura metrica del trimetro giambico.
Traduzione e commento.<br />
Lettura integrale del testo in traduzione italiana.<br />
LISIA, Per Eufileto, 1-31<br />
Traduzione e commento<br />
LIBRO DI TESTO<br />
CASERTANO-NUZZO, Storia e Testi della letteratura greca, Palumbo<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. DELIA STILO
ALLEGATO N.9<br />
INGLESE<br />
Programma svolto<br />
Dal libro di testo Literary Hyperlinks. Ed Cideb Volumi A e B<br />
THE ROMANTIC AGE<br />
Linee essenziali del Romanticismo.<br />
The historical and social context.<br />
The beginning of an American identity<br />
The Industrial and the French revolution. Social implications of Industrialization.<br />
Emotion vs Reason. The Age of the Sublime.<br />
Mary Shelley: dal "Frankestein" lettura del brano: “What was I”<br />
Jane Austen: da “Sense and Sensibility”, lettura del brano “Are my ideas so scanty”<br />
The first and the second generation of Romantic Poets.<br />
William Blake: vita e opere. Lettura ed analisi delle poesie "Infant Joy" , da Songs of Innocence, “Infant<br />
Sorrow” e “London”, da Songs of Experience.<br />
William Wordsworth: vita e opere. Lettura ed analisi di "I Wandered Lonely as a Cloud, "A certain<br />
colouring of imagination"(Fotocopia), dalla Prefazione alle Lyrical Ballads, "Composed upon Westminster<br />
Bridge".<br />
John Keats: vita e opere. Lettura ed analisi di "Ode on a Grecian Urn" e de “La Belle Dame sans Merci”.<br />
Samuel Taylor Coleridge: vita e opere. Lettura ed analisi di “The Rime of the Ancient Mariner”.(Parte I e<br />
II).<br />
Percy Bysshe Shelley: vita e opere. Lettura ed analisi di “Ode to the West Wind”<br />
THE VICTORIAN AGE<br />
Queen Victoria accession to the throne. The later years. The Age of Empire.<br />
The Victorian Compromise. Faith and Progress. Education in Victorian England. The urban habitat. The<br />
Victorian literature. Women’s voices. The Victorian novel : a mirror of life. The late Victorian period. A<br />
time of new ideas. United States: birth of a nation. The Pre-Raphaellite Brotherhood. Aestheticism and<br />
Decadence.<br />
Charles Dickens: vita e opere. Da "Oliver Twist" lettura del brano "Jacob’s island”. Da “Hard Times”<br />
lettura del brano “A Man of realities”.<br />
Charlotte Bronte: vita e opera. Da “Jane Eyre” lettura dei brani “Thornfield Hall” e “The Madwoman in the<br />
attic”.<br />
Oscar Wilde: vita e opere. Da "The Picture of Dorian Gray" lettura dei brani "The Preface" (Fotocopia) e di<br />
"I would give my soul for that!".<br />
G. B. Shaw: vita e opere. Da “Pygmalion” lettura del brano “What’s to become of me”<br />
Walt Whitman: vita e opere. Lettura ed analisi di “Song of Myself”.<br />
THE MODERN AGE<br />
Modernism in Europe. Historical and social background. Modernism and the Novel. Stream of consciousness<br />
fiction. American fiction in the early 20 th century.<br />
Thomas Sterne Eliot: vita e opere. Da "The Waste Land" lettura della poesia "The Burial of the Dead".<br />
Riferimenti ad Ezra Pound.<br />
Edward Morgan Forster: vita e opere. Da “ A Passage to India” lettura dei brani “The city of<br />
Chandrapore” e “Echoing Walls”.<br />
James Joyce: vita e opere. Da "Dubliners" lettura del brano, tratto dal racconto "The Dead", "His<br />
riot of emotions”.<br />
Virginia Woolf: vita e opere. Da "Mrs. Dalloway" lettura dei brani “She would not say….” e “A very sad<br />
case”.<br />
George Orwell: vita e opere. Da “Nineteen-Eighty Four” lettura del brano “Big Brother is watching you”.
Francis Scott Fitzgerald: vita e opere. Da “The Great Gatzby” lettura del brano “Death of a dream”.<br />
Cenni sul teatro dell’assurdo.<br />
Dal libro di testo “Headway digital” upper-intermediate Oxford, nella prima parte dell’anno scolastico, sono<br />
state svolte lezioni su esercizi di reading, writing , speaking e listening. (Dalla unit 7 alla 12).<br />
Visione in lingua originale dei seguenti film: Frankestein, The Great Gatzby, Mrs. Dalloway , My Fair<br />
Lady, A Passage to India, The Importance of Being Earnest.<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. VALERIA D’ANDREA
ALLEGATO N.10<br />
STORIA<br />
Programma svolto<br />
Libro di testo: De Bernardi – Guarracino, I saperi della Storia, Bruno Mondadori Scuola, vol. 2 Tomo B e<br />
vol. 3 Tomo A e B<br />
IMPERI, MASSE, NAZIONI<br />
- L’età dell’imperialismo e la società di massa (cap. 18):!<br />
1. Una crisi economica generale;<br />
2. Colonialismo e imperialismo;<br />
3. 1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica;<br />
4. La società di massa;<br />
5. La crisi dello stato liberale.<br />
- Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo (cap. 19):<br />
1. Gli Stati Uniti e il panamericanismo;<br />
2. Il difficile equilibrio europeo.<br />
Brani analizzati: "Imperialismo economico e imperialismo sociale" da E. Hobsbawm L'età degli<br />
imperi 1875-1914;<br />
"Il delirio imperialistico" da W. Mommsen, L'età dell'imperialismo.<br />
- L’Italia dalla Destra alla Sinistra (cap. 20):<br />
1. La nuova <strong>classe</strong> dirigente;<br />
2. Una nuova Italia nel contesto internazionale.<br />
- L’Italia crispina e la svolta giolittiana (cap. 21):<br />
1. Il modello bismarckiano di Crispi;<br />
2. La crisi di fine secolo;<br />
3. Il programma liberal-democratico di Giolitti;<br />
4. Il grande balzo industriale;<br />
5. Dualismo economico e politica di potenza;<br />
6. La fine del compromesso giolittiano.<br />
Brani analizzati: "Il brigantaggio in Lucania" da Il brigantaggio meridionale a cura di A. De Jaco. Scheda:<br />
Le interpretazioni del risorgimento italiano: Volpe, Croce, Gramsci.<br />
LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA<br />
- La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale (cap. 1):<br />
1. Le ragioni dell’immane conflitto;<br />
2. Cultura e politica del nazionalismo;<br />
3. L’inizio delle operazioni militari;<br />
4. L’intervento italiano.<br />
- Dinamica ed esiti del conflitto (cap. 2):<br />
1. Lo stallo del 1915-16;<br />
2. Dalla guerra europea alla guerra mondiale;<br />
3. La fine della Grande Guerra.<br />
- La rivoluzione russa (cap. 3):<br />
1. L’impero zarista;<br />
2. La caduta degli zar<br />
3. La rivoluzione d’ottobre.<br />
Documenti analizzati: i Quattordici punti di W. Wilson<br />
Le tesi di aprile di Lenin<br />
LA LUNGA CRISI EUROPEA<br />
- Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale (cap. 4):<br />
1. La pacificazione impossibile;<br />
2. Crisi degli imperi coloniali e “risveglio dei popoli”: la lotta per l’indipendenza in<br />
India e la figura di Gandhi.
- Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso (cap. 5):<br />
1. La crisi europea: alla ricerca di nuovi assetti;<br />
2. La crisi negli stati democratici;<br />
3. La Germania di Weimar.<br />
- La costruzione dell’Unione Sovietica (cap. 6):<br />
1. Il periodo del “comunismo di guerra”;<br />
2. La nascita dell’URSS;<br />
3. Gli inizi dell’egemonia di Stalin.<br />
- Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo (cap. 7):<br />
1. Difficoltà economiche nel primo dopoguerra;<br />
2. Il biennio rosso in Italia;<br />
3. L’avvento del fascismo;<br />
4. La costruzione del regime.<br />
Brani analizzati: "La marcia su Roma" da P. Gorgolini, La rivoluzione fascista;<br />
<strong>Documento</strong>: B. Mussolini Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 3 gennaio 1925.<br />
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI<br />
- L’Italia fascista (cap. 9):<br />
1. I tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo;<br />
2. La fascistizzazione della società;<br />
3. Tra dirigismo e autarchia;<br />
4. L’imperialismo e la nuova politica estera.<br />
- Il nazismo e i regimi fascisti (cap. 10):<br />
1. La Germania nazista;<br />
2. L’affermazione dei fascismi in Europa;<br />
- L’Europa democratica (cap. 11):<br />
1. L’antifascismo.<br />
- L’internazionale comunista e lo stalinismo (cap. 12):<br />
1. Il mito dell’URSS e l’internazionale comunista;<br />
2. La società sovietica e la dittatura di Stalin.<br />
- La seconda guerra mondiale (cap. 13)<br />
1. Verso la seconda guerra mondiale<br />
2. Il dominio nazifascista sull’Europa<br />
3. La mondializzazione del conflitto<br />
4. La controffensiva degli alleati nel 1943<br />
5. La sconfitta della Germania e del Giappone<br />
Sono stati utilizzati nel corso dell’a.s. numerosi audiovisivi, per approfondire e completare l’analisi di tutte<br />
le problematiche storiche trattate. In particolare documentari che riguardavano:<br />
- l’Italia liberale (1861-1900)<br />
- le colonie italiane nel periodo giolittiano e nell’Italia fascista<br />
- la politica interna italiana nell’età giolittiana<br />
- la prima guerra mondiale sul fronte occidentale e l’economia di guerra<br />
- il nazismo e il fascismo italiano<br />
- la seconda guerra mondiale<br />
- Uno specialista (il processo ad Eichmann – La banalità del male )<br />
I programmi sono stati completati con la lettura integrale di un’opera, a scelta di ciascuna/o studentessa/e<br />
nell’elenco qui riportato:<br />
- S. Kierkegaard, Aut-aut, ed. Oscar Mondadori.<br />
- F. Nietzsche, La nascita della tragedia, ed. Adelphi.<br />
- H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, ed. Feltrinelli<br />
GLI STUDENTI<br />
IL DOCENTE<br />
Prof. FABIO CECCHI
ALLEGATO N.11<br />
FILOSOFIA<br />
Programma svolto<br />
Libro di testo: F. Occhipinti, Logos, Einaudi Scuola, vol. 3<br />
Romanticismo e idealismo: un confronto critico<br />
G. W. Hegel:<br />
1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />
2. le linee essenziali del sistema hegeliano;<br />
3. la Fenomenologia dello spirito;<br />
4. la dialettica;<br />
5. la filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto;<br />
6. la filosofia della storia;<br />
7. l’eredità di Hegel e la sinistra hegeliana.<br />
Brani analizzati: “Il rapporto servo-padrone” dalla Fenomenologia dello spirito<br />
"La razionalità del reale e il compito della filosofia" e “Lo Stato” da Lineamenti di filosofia<br />
del diritto<br />
A. Schopenhauer :<br />
1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />
2. il mondo come rappresentazione: tra il pensiero filosofico occidentale e l’antica sapienza<br />
orientale; spazio, tempo, causalità;<br />
3. il mondo come volontà: il filo del corpo, le caratteristiche della volontà, il dolore del<br />
mondo;<br />
4. le vie della liberazione: arte, morale, ascesi;<br />
5. Schopenhauer e Leopardi<br />
Brani analizzati: “ La vita umana fra il bisogno e la noia” da Aforismi sulla saggezza della vita e “La<br />
musica” da Il mondo come volontà e rappresentazione<br />
- S. Kierkegaard :<br />
1. vita e opere,<br />
2. contro Hegel, a partire dall’ironia;<br />
3. fra vita estetica e vita etica: l’aut-aut; la scelta religiosa;<br />
4. l’esistenza umana: l’essenza non contiene l’esistenza, l’angoscia e la malattia mortale, la<br />
fede e la filosofia<br />
5. Kierkegaard interprete di Mozart<br />
Brani analizzati: “La scelta etica” da Aut-aut<br />
“ L’angoscia” da Il concetto dell’angoscia<br />
- K. Marx:<br />
1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />
2. critica della filosofia hegeliana del diritto;<br />
3. il problema dell’uguaglianza, il lavoro alienato, il comunismo, la polemica contro la<br />
sinistra hegeliana<br />
4. il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, la rivoluzione comunista, la critica<br />
dell’economia politica<br />
5. l’analisi dell’economia capitalistica e il concetto di plusvalore, le contraddizioni<br />
dell’economia capitalistica<br />
Brani analizzati: “La concezione materialistica della storia” da L’ideologia tedesca<br />
- Filosofia e Scienza nell’età del Positivismo (caratteri generali). L’evoluzionismo di<br />
C. Darwin.<br />
- F. Nietzsche :<br />
1. Il contesto storico-culturale; vita e opere: periodizzazione e stile degli scritti;
2. la diagnosi della decadenza: il senso tragico della vita, Apollo e Dioniso, l’intuizione<br />
tragica del mondo e le “finzioni” del linguaggio;<br />
3. l’analisi genealogica e la definizione del nichilismo: la critica della morale e del<br />
cristianesimo, al di là del bene e del male, il nichilismo;<br />
4. le parole di Zarathustra: la volontà di potenza, la volontà di verità nella metafisica, la fine<br />
della verità e del soggetto, il superuomo, l’eterno ritorno dell’identico.<br />
Brani analizzati: “La fine di un lungo errore” da Crepuscolo degli idoli<br />
“ Il peso più grande” da Aurora<br />
“L’eterno ritorno dell’identico” da La gaia scienza e Così parlò Zarathustra<br />
Nel quadro della filosofia occidentale del Novecento sono state operate le seguenti scelte:<br />
- H. Bergson:<br />
1. vita e opere; spiritualismo e intuizionismo;<br />
2. il carattere qualitativo dei dati della coscienza, la coscienza e il tempo, il mondo delle<br />
immagini, le due memorie, intelligenza e intuizione, l’origine della materia,<br />
l’evoluzione creatrice, istinto e intelligenza;<br />
3. la società, la morale, la religione.<br />
Brano analizzato: “Il linguaggio” da L’evoluzione creatrice<br />
- H. Arendt :<br />
1. vita e scritti,<br />
2. origini e natura del totalitarismo,<br />
3. la politeia perduta e la condizione del cittadino nella società contemporanea.<br />
Brano analizzato: “La vita attiva”, da Vita activa. La condizione umana<br />
K. Popper<br />
1. vita e opere;<br />
2. società chiusa e società aperta: il contributo di Popper al pensiero politico del ‘900.<br />
Brano analizzato: “La democrazia” da La società aperta e i suoi nemici<br />
I programmi sono stati completati con la lettura integrale di un’opera, a scelta di ciascuna/o studentessa/e<br />
nell’elenco qui riportato:<br />
- S. Kierkegaard, Aut-aut, ed. Oscar Mondadori.<br />
- F. Nietzsche, La nascita della tragedia, ed. Adelphi.<br />
- H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, ed. Feltrinelli<br />
GLI STUDENTI<br />
IL DOCENTE<br />
Prof. FABIO CECCHI
ALLEGATO N.12<br />
MATEMATICA<br />
Programma svolto<br />
Testo in adozione: Bergamini Trifone – La trigonometria (Modulo O verde) – Zanichelli<br />
Goniometria e trigonometria<br />
Misurazione di angoli ed archi orientati: sistema sessagesimale, radiante. La circonferenza goniometrica.<br />
Funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante: definizione, variazione e<br />
grafici. Il coefficiente angolare di una retta. Relazioni fondamentali della gonometria e relative applicazioni.<br />
Funzioni goniometriche di archi particolari (30°,45°,60°). Relazioni tra le funzioni goniometriche di<br />
particolari coppie di archi. Archi associati. Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari.<br />
Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, parametriche, bi<strong>sez</strong>ione, prostaferesi, Werner<br />
e applicazioni. Metodi risolutivi di equazioni goniometriche di vario tipo: equazioni di secondo grado in una<br />
funzione goniometrica riducibili ad equazioni elementari mediante metodi algebrici; equazioni riconducibili<br />
ad equazioni elementari mediante formule goniometriche; equazioni lineari in seno e coseno; equazioni<br />
omogenee in seno e coseno di secondo grado. Teoremi sul triangolo rettangolo. Risoluzione dei triangoli<br />
rettangoli ed applicazioni. Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso. Area di un<br />
parallelogramma. Area di un quadrilatero. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema delle proiezioni.<br />
Teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli qualunque. Problemi di geometria piana risolvibili con la<br />
trigonometria.<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. ROSA MARIA ALESSANDRO
ALLEGATO N.13<br />
FISICA<br />
Programma svolto<br />
PROGRAMMA DI FISICA<br />
Testo in adozione: Ugo Amaldi – Elettromagnetismo con CD-ROM - Zanichelli<br />
Elettromagnetismo<br />
La carica elettrica e la legge di Coulomb<br />
Interazioni tra corpi elettrizzati. La carica elettrica. Isolanti e conduttori. Induzione elettrostatica.<br />
Conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb.<br />
Campo elettrico, il potenziale elettrico, fenomeni di elettrostatica<br />
Il campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. Le linee del<br />
campo elettrico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una<br />
distribuzione piana infinita di carica. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Le superfici<br />
equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. La<br />
distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un<br />
conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb. La capacità di un<br />
conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un<br />
condensatore.<br />
La corrente elettrica continua<br />
La corrente elettrica. L’intensità di corrente. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di<br />
Ohm. I resistori in serie e in parallelo. L’energia elettrica e l’effetto Joule. La potenza elettrica. La forza<br />
elettromotrice. La seconda legge di Ohm. Resistività. Superconduttività.<br />
Campo magnetico<br />
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti: legge di<br />
Ampere. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo<br />
magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. La forza<br />
magnetica sulle cariche in movimento. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. Il moto di una<br />
carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo<br />
magnetico: il teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali (cenni).<br />
L’induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche<br />
La corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni<br />
di Maxwell. La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche. Cenni sulle onde elettromagnetiche.<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. ROSA MARIA ALESSANDRO
ALLEGATO N.14<br />
SCIENZE<br />
Programma svolto<br />
Libro di Testo Lupia Palmieri Parotto - Il Globo terrestre e la sua evoluzione – Ed.<br />
Zanichelli<br />
Cap 1) L’ambiente celeste<br />
- la posizione delle stelle,<br />
- le caratteristiche delle stelle,<br />
- l’evoluzione dei corpi celesti,<br />
- le galassie e la struttura dell’Universo,<br />
- origine ed evoluzione dell’Universo: ipotesi a confronto<br />
Cap 2) Il Sistema Solare<br />
- i corpi del Sistema solare,<br />
- la stella Sole,<br />
- l’attività solare,<br />
- i pianeti del Sistema solare,<br />
- Mercurio,<br />
- Venere,<br />
- Terra,<br />
- Marte,<br />
- Giove,<br />
- Saturno,<br />
- Urano,<br />
- Nettuno,<br />
- I corpi minori,<br />
- Origine ed evoluzione del Sistema solare<br />
Cap 3) Il pianeta Terra<br />
- La forma della Terra,<br />
- Le dimensioni della Terra,<br />
- Le coordinate geografiche,<br />
- I movimenti della Terra,<br />
- Il moto di rotazione,<br />
- Il moto di rivoluzione terrestre,<br />
- I moti terrestri con periodi millenari (moto doppio conico – precessione degli equinozi –<br />
spostamento della linea degli apsidi ed altri moti millenari),<br />
Cap 4) La Luna e il sistema Terra-Luna<br />
- Forma e dimensioni della Luna,<br />
- Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera,<br />
- I movimenti della Luna e del sistema Terra-Luna ( moto di rotazione lunare- moto di rivoluzionemoto<br />
di traslazione),<br />
- Le fasi lunari e le eclissi,<br />
- Il paesaggio lunare (i mari lunari, terre alte ed altre forme del paesaggio lunare),<br />
- La composizione superficiale e l’interno della Luna,<br />
- L’origine e l’evoluzione della Luna<br />
Cap 6) La crosta terrestre: minerali e rocce<br />
- I costituenti della crosta terrestre,<br />
- La “chimica” della crosta terrestre,<br />
- I minerali (composizione chimica – struttura cristallina – proprietà fisiche e classificazione),
- Le rocce ( lo studio delle rocce e i processi litogenetici),<br />
- Rocce magmatiche o ignee (dal magma alle rocce magmatiche – classificazione delle rocce<br />
magmatiche),<br />
- L’origine dei magmi,<br />
- Rocce sedimentarie (dai sedimenti sciolti alle rocce compatte – le rocce clastiche o detritiche – le<br />
rocce organogene ),<br />
- Rocce metamorfiche (metamorfismo di contatto – metamorfismo regionale – le facies metamorfiche<br />
– classificazione delle rocce metamorfiche),<br />
- Il ciclo litogenetico,<br />
Cap 7) La giacitura e le deformazioni delle rocce<br />
- Elementi di Tettonica (quando le rocce si rompono: le faglie – quando le rocce si flettono: le pieghe<br />
– quando<br />
le rocce si accavallano: sovrascorrimenti e falde),<br />
Cap 8) I fenomeni vulcanici<br />
- Il vulcanismo ( l’attività vulcanica – i magmi),<br />
- Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica,<br />
- Vulcanismo effusivo ed esplosivo ( vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi)<br />
Cap 9) I fenomeni sismici<br />
- Lo studio dei terremoti,<br />
- Propagazione e registrazione delle onde sismiche,<br />
- La forza di un terremoto (magnitudo e l’intensità del sisma),<br />
- Gli effetti del terremoto<br />
Cap 10) La tettonica delle placche: un modello globale<br />
- L’espansione dei fondi oceanici (la deriva dei continenti – le dorsali oceaniche – le fosse abissali –<br />
espansione e subduzione),<br />
- La tettonica delle placche (le placche litosferiche – l’orogenesi),<br />
- Moti convettivi e punti caldi<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. MARIA FEDERICO
ALLEGATO N.15<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
Programma svolto<br />
L’Impressionismo:<br />
-C. Monet<br />
-E. Degas<br />
-P. Cezanne<br />
Il Postimpressionismo:<br />
-V. Van Gogh<br />
La Grennouillère<br />
La Cattedrale di Rouen<br />
Lo stagno delle ninfee<br />
L’assenzio<br />
La <strong>classe</strong> di danza del signor Pierrot<br />
Giocatori di carte<br />
La montagna Sainte Victoire<br />
Mangiatori di patate<br />
Autoritratto<br />
La camera da letto<br />
Notte stellata<br />
La cattedrale di Auvers<br />
Campo di grano con corvi<br />
Il Modernismo:<br />
-A. Gaudì<br />
Casa Milà – Casa Batllò – La Sacrada Familia<br />
La Secessione austriaca:<br />
- G. Klimt<br />
Il ballo dell’Opera<br />
Giuditta<br />
Pre-espressionismo ed Espressionismo:<br />
-E. Munch<br />
L’urlo<br />
Pubertà<br />
Passeggiata in Corso Karl Johans<br />
Madonna<br />
-E.L. Kirchner<br />
Marcella<br />
Nollendorfplatz<br />
Foresta in inverno<br />
Il Cubismo:<br />
-P. Picasso<br />
Il Futurismo:<br />
- U. Boccioni<br />
Poveri in riva al mare<br />
I giocolieri<br />
Les Demoiselles d’Avignon<br />
Ritratto di A. Vollard<br />
Guernica<br />
Autoritratto
Officine a Porta Romana<br />
La città che sale<br />
Stati d’animo:quelli che restano<br />
Stati d’animo:gli addii<br />
Ritratto del Maestro F. Busoni<br />
Forme uniche della continuità nello spazio<br />
La pittura metafisica:<br />
-G. De Chirico<br />
Il Dadaismo:<br />
-M. Duchamp<br />
-K.Schwitters<br />
Canto d’amore<br />
La piazza d’Italia<br />
Le Muse inquietanti<br />
Fontana<br />
La Gioconda<br />
Merzbau<br />
L’Astrattismo:<br />
-V.Kandinskij<br />
Il Cavaliere azzurro<br />
Composition<br />
Il Surrealismo:<br />
-R. Magritte<br />
Impero della luce<br />
Il doppio segreto<br />
Architettura del XX secolo:<br />
- Architettura Razionalista – Le Corbusier<br />
- Architettura Organica – F. L. Wright<br />
- Bauhaus<br />
GLI STUDENTI<br />
IL DOCENTE<br />
Prof. FABIO BELLISARIO
ALLEGATO N.16<br />
EDUCAZIONE FISICA<br />
Programma svolto<br />
Obiettivi<br />
1. Potenziamento<br />
fisiologico e<br />
attivazione<br />
funzioni muscolari<br />
2. Rielaborazione<br />
degli schemi<br />
motori<br />
3.Consolidamento<br />
del carattere,<br />
sviluppo della<br />
società e del senso<br />
civico<br />
4. Conoscenza e<br />
pratica delle<br />
attività sportive<br />
GLI STUDENTI<br />
Miglioramento delle funzioni:<br />
cardio-circolatorie<br />
respiratoria<br />
metabolica<br />
Potenziamento della forza muscolare<br />
Miglioramento della resistenza<br />
Miglioramento della velocità<br />
Miglioramento dell’elasticità muscolare<br />
Coordinazione<br />
Acquisizione dell’autonomia motoria<br />
Saper effettuare prove di destrezza<br />
Approfondimento della conoscenza del rapporto<br />
tra soma e spazio<br />
Rispetto di sé<br />
Rispetto degli altri<br />
Rispetto delle strutture ad uso comune<br />
Rispetto delle norme di comportamento<br />
Consapevolezza dei propri limiti e dei propri<br />
mezzi<br />
Conoscenza pratica dei più grandi sport di<br />
squadra<br />
Saper partecipare a gare<br />
Conoscenza e rispetto delle regole dell’attività<br />
sportiva in generale e degli sport di squadra in<br />
particolare<br />
Conoscenze delle nozioni essenziali<br />
sull’apparato locomotore, respiratorio e<br />
cardiovascolare<br />
Elementi di pronto soccorso<br />
Contenuti<br />
Andature varie<br />
Corse di resistenza<br />
Esercizi a carico naturale e non<br />
Esercizi di opposizione e resistenza<br />
Esercizi ai grandi attrezzi<br />
Esercizi differenziati<br />
Stretching<br />
Percorsi ginnici<br />
Esercizi ai grandi attrezzi Prove di<br />
destrezza ed abilità<br />
Prove di equilibrio del corpo in volo<br />
Affidamento a rotazione dei compiti<br />
di giuria e arbitraggio<br />
Assistenza ai compagni in difficoltà<br />
I grandi sport di squadra: calcio,<br />
calcetto, basket, pallavolo<br />
Sport individuali: l’atletica leggera<br />
(resistenza, velocità, salti)<br />
IL DOCENTE<br />
Prof. ANTONIO MITRANO
ALLEGATO N.17<br />
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA<br />
Programma svolto<br />
Dottrina sociale della Chiesa<br />
Sviluppo, concetti-chiave e documenti principali<br />
COMPENDIO della DOTTRINA SOCIALE della CHIESA<br />
www.vatican.va/.../rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc.<br />
http://it.cathopedia.org/wiki/Dottrina_sociale_della_Chiesa<br />
1. “La Croce e la svastica”: esoterismo pseudo-religioso nel regime nazista di Hitler e resistenza da<br />
parte di vescovi e teologi della Chiesa cattolica e delle comunità evangeliche:<br />
Cfr. “La Grande Storia: La Croce e la Svastica” – RaiTre a cura di Luigi Bizzarri<br />
http://www.youtube.com/watchv=Oi8Wi44lkN8&feature=share&list=PL6E057CB9CFC4875B<br />
2. Concilio Ecumenico Vaticano II<br />
Documenti completi: www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican.../index_it.htm<br />
Storia del Concilio Vaticano II: http://it.cathopedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II<br />
Cfr. “La Grande Storia: il Concilio Vaticano II” – RaiTre a cura di Luigi Bizzarri<br />
http://www.youtube.com/watchv=WdpRLaHvLmU&list=PL5iZcxmtspsLc3JlTHUd4-<br />
4UqCrlssEbZ&feature=share<br />
Cfr. “Concilio Vaticano II” – RaiUno a cura di Vania De Luca http://youtu.be/-KP3ZDt2Hr0<br />
Cfr. “La Grande Storia: il Papa buono” – RaiTre a cura di Luigi Bizzarri http://youtu.be/ZMOOyKrGzZM<br />
Cfr. Intervista al Card. Carlo Maria Martini: http://youtu.be/qgmOAixUTC8<br />
GLI STUDENTI<br />
LA DOCENTE<br />
Prof. ANTONELLA JORI