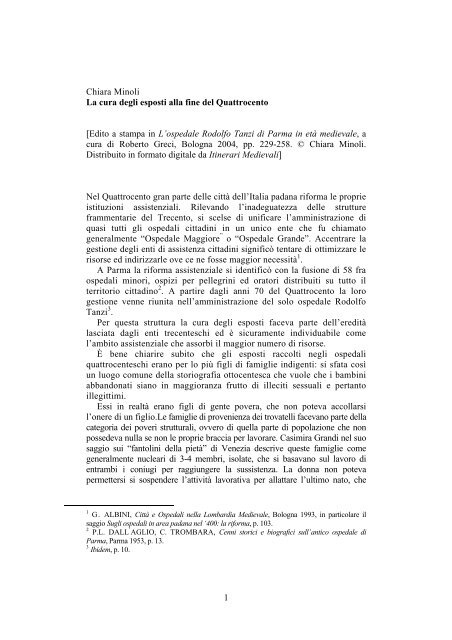La cura degli esposti alla fine del Quattrocento - Itinerari Medievali
La cura degli esposti alla fine del Quattrocento - Itinerari Medievali
La cura degli esposti alla fine del Quattrocento - Itinerari Medievali
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Chiara Minoli<br />
<strong>La</strong> <strong>cura</strong> <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> <strong>alla</strong> <strong>fine</strong> <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong><br />
[Edito a stampa in L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale, a<br />
<strong>cura</strong> di Roberto Greci, Bologna 2004, pp. 229-258. © Chiara Minoli.<br />
Distribuito in formato digitale da <strong>Itinerari</strong> <strong>Medievali</strong>]<br />
Nel <strong>Quattrocento</strong> gran parte <strong>del</strong>le città <strong>del</strong>l’Italia padana riforma le proprie<br />
istituzioni assistenziali. Rilevando l’inadeguatezza <strong>del</strong>le strutture<br />
frammentarie <strong>del</strong> Trecento, si scelse di unificare l’amministrazione di<br />
quasi tutti gli ospedali cittadini in un unico ente che fu chiamato<br />
generalmente “Ospedale Maggiore ” o “Ospedale Grande”. Accentrare la<br />
gestione <strong>degli</strong> enti di assistenza cittadini significò tentare di ottimizzare le<br />
risorse ed indirizzarle ove ce ne fosse maggior necessità 1 .<br />
A Parma la riforma assistenziale si identificò con la fusione di 58 fra<br />
ospedali minori, ospizi per pellegrini ed oratori distribuiti su tutto il<br />
territorio cittadino 2 . A partire dagli anni 70 <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong> la loro<br />
gestione venne riunita nell’amministrazione <strong>del</strong> solo ospedale Rodolfo<br />
Tanzi 3 .<br />
Per questa struttura la <strong>cura</strong> <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> faceva parte <strong>del</strong>l’eredità<br />
lasciata dagli enti trecenteschi ed è si<strong>cura</strong>mente individuabile come<br />
l’ambito assistenziale che assorbì il maggior numero di risorse.<br />
È bene chiarire subito che gli <strong>esposti</strong> raccolti negli ospedali<br />
quattrocenteschi erano per lo più figli di famiglie indigenti: si sfata così<br />
un luogo comune <strong>del</strong>la storiografia ottocentesca che vuole che i bambini<br />
abbandonati siano in maggioranza frutto di illeciti sessuali e pertanto<br />
illegittimi.<br />
Essi in realtà erano figli di gente povera, che non poteva accollarsi<br />
l’onere di un figlio.Le famiglie di provenienza dei trovatelli facevano parte <strong>del</strong>la<br />
categoria dei poveri strutturali, ovvero di quella parte di popolazione che non<br />
possedeva nulla se non le proprie braccia per lavorare. Casimira Grandi nel suo<br />
saggio sui “fantolini <strong>del</strong>la pietà” di Venezia descrive queste famiglie come<br />
generalmente nucleari di 3-4 membri, isolate, che si basavano sul lavoro di<br />
entrambi i coniugi per raggiungere la sussistenza. <strong>La</strong> donna non poteva<br />
permettersi si sospendere l’attività lavorativa per <strong>alla</strong>ttare l’ultimo nato, che<br />
1 G. ALBINI, Città e Ospedali nella Lombardia Medievale, Bologna 1993, in particolare il<br />
saggio Sugli ospedali in area padana nel ‘400: la riforma, p. 103.<br />
2 P.L. DALL ’ AGLIO, C. TROMBARA, Cenni storici e biografici sull’antico ospedale di<br />
Parma, Parma 1953, p. 13.<br />
3 Ibidem, p. 10.<br />
1
finiva per essere abbandonato 4 .<br />
Durante il XIV e XV secolo ai figli dei poveri strutturali si aggiunsero i figli<br />
dei poveri creati dalle numerose congiunture economiche negative. Famiglie<br />
che riuscivano a mantenersi sopra la soglia di povertà durante le annate buone,<br />
erano ridotte <strong>alla</strong> fame non appena si presentava una carestia, una guerra,<br />
un’epidemia. In molti casi esse affidarono i loro figli all’ospedale solo per il<br />
periodo <strong>del</strong>l’<strong>alla</strong>ttamento, troppo costoso ed oneroso per loro, nella speranza di<br />
riprenderli con sé <strong>alla</strong> <strong>fine</strong> <strong>del</strong>la crisi, se fossero sopravvissuti 5 .<br />
Purtroppo le “male annate” si susseguirono e a metà <strong>del</strong> XV il numero dei<br />
bambini <strong>esposti</strong> mise in seria difficoltà gli ospedali medievali. Molto spesso fu<br />
proprio l’impossibilità a dare assistenza ai trovatelli, aumentati a causa <strong>del</strong><br />
momento economico sfavorevole, e <strong>del</strong>la rinnovata crescita demografica, ad<br />
essere presa a causa <strong>del</strong>l’urgenza di provvedere all’unificazione <strong>degli</strong> ospedali 6 .<br />
Cosi, più per necessità pressanti che per scelta, quasi ovunque, l’ospedale<br />
“riformato” si occupò principalmente dei trovatelli, pur senza rinunciare<br />
all’assistenza ai malati.<br />
Il nuovo ospedale “grande”, creato per portare soccorso agli <strong>esposti</strong> finì per<br />
essere, nella mentalità <strong>del</strong>l’epoca, la soluzione migliore per i bambini<br />
indesiderati, perché esso cercava di garantire la loro sopravvivenza.<br />
Paradossalmente però bambini che non sarebbero mai dovuti essere<br />
abbandonati, seguirono questo destino poiché le loro madri, consapevoli <strong>del</strong><br />
valore economico <strong>del</strong> proprio latte, li esposero all’ospedale per prendere a<br />
balia un altro bimbo da privati o addirittura dal medesimo ente. Tutto ciò<br />
dietro pagamento di un salario tutt’altro che modesto 7 . All’inizio <strong>del</strong><br />
Cinquecento, grazie anche <strong>alla</strong> ripresa <strong>del</strong>la crescita demografica che si verifica<br />
d<strong>alla</strong> metà <strong>del</strong> XV secolo 8 , gli ospedali sono così affollati da costringere le<br />
autorità civili e religiose a prendere provvedimenti per arginare gli abbandoni,<br />
ormai, così numerosi da annullare l’effetto benefico <strong>del</strong>le nuove strutture 9 .<br />
Al momento <strong>del</strong>la loro apertura, però, essi significarono la differenza tra la<br />
vita e la morte per molti fanciulli, considerando che l’unica alternativa<br />
all’abbandono era l’infanticidio.<br />
4 C. GRANDI, L’assistenza all’infanzia abbandonata veneziana: i fantolini <strong>del</strong>la pietade (1346-<br />
1548); in A.J. GRIECO, L. SANDRI (a <strong>cura</strong> di), Ospedali e città. L’Italia <strong>del</strong> Centro-Nord, XIII-<br />
XVI secolo, Atti <strong>del</strong> Convegno Internazionale di Studio, Firenze 1997, p. 77.<br />
5 ALBINI, Città e ospedali cit., pp. 147-153; e L. SANDRI, Dinamiche politico-istituzionali e<br />
sorte <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong>, in C. GRANDI (a <strong>cura</strong> di), “ Benedetto che ti porta, maledetto chi ti manda”:<br />
Infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV e XIX), Treviso 1997, pp. 69-70.<br />
6 ALBINI, Città e Ospedali, cit., p. 148.<br />
7 L. SANDRI, Baliatico mercenario ed abbandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: un<br />
medesimo disagio sociale, in M.G. MUZZARELLI, P. GALETTI, B. ANDREOLLI (a <strong>cura</strong><br />
di), Donne e lavoro nell’Italia Medievale, Torino 1991, p. 97 e ss.<br />
8 G. PINTO, Il numero <strong>degli</strong> uomini, in S. COLLODO, G. PINTO (a <strong>cura</strong> di), <strong>La</strong> società<br />
medievale, Bologna 1999, p. 25.<br />
9 Esistono una serie di bolle papali nelle quali si alternano minacce di scomunica per chi<br />
abbandona i figli e promesse di indulgenza per chi accogliesse i trovatelli. Cfr. ALBINI, Città e<br />
ospedali cit., p. 169.<br />
2
<strong>La</strong> caratteristica comune <strong>del</strong>le strutture ospedaliere quattrocentesche,<br />
riscontrabile anche a Parma, si individua in una nuova attenzione al fenomeno<br />
<strong>del</strong>l’infanzia abbandonata, cha portò ad una rinnovata gestione <strong>del</strong>la questione<br />
<strong>degli</strong> abbandoni, molto diversa dall’assistenza disordinata e casuale fornita<br />
dalle antiche fondazioni medievali. <strong>La</strong> nuova sensibilità al problema dei<br />
trovatelli si concretizzò in un mo<strong>del</strong>lo assistenziale che mirava a seguire<br />
l’”esposto” dal suo ingresso nell’ospedale fino <strong>alla</strong> maggiore età 1010 . Lo stesso<br />
schema planimetrico-funzionale <strong>del</strong> nuovo ospedale rispecchiava la tendenza a<br />
distinguere le parti da destinare a funzioni differenti: due corsie, una per gli<br />
infermi, l’altra per gli <strong>esposti</strong> 11 .<br />
Nel 1482 l’ospedale si prendeva <strong>cura</strong> di circa 226 bambini, dei quali 146<br />
furono accolti nell’ospedale Rodolfo Tanzi nel solo ultimo anno da febbraio<br />
a dicembre. Nel 1483 il numero <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> di cui l’ospedale dovette<br />
occuparsi fu di 112; 50 nuovi affidi e 62 bambini <strong>del</strong> 1482. Nel 1484<br />
l’ospedale finanziò il baliatico di 85 infanti, di cui 44 entrati nello stesso<br />
anno. Nel 1485 i bambini a cui si doveva provvedere erano 84, di cui 37<br />
nuovi ingressi e 46 <strong>del</strong>l’anno precedente. Nel 1486, ai 50 <strong>esposti</strong> rimasti a<br />
carico <strong>del</strong>l’ospedale dall’anno precedente, se ne aggiunsero 64 per un totale<br />
di 117. Ed in<strong>fine</strong>, nel 1487 da gennaio a luglio, l’ospedale Rodolfo Tanzi<br />
pagò il baliatico a 100 bambini di cui 36 nuovi ingressi e 64 già ospiti 12 .<br />
Nonostante l’incompletezza dei dati sopra riportati, riferibile <strong>alla</strong><br />
lacunosità <strong>degli</strong> anni considerati, si distingue l’elevato numero <strong>degli</strong><br />
<strong>esposti</strong> assistiti nel 1482. Essi furono circa il doppio rispetto a ciò che<br />
sarà la media negli anni successivi. Ciò non è dovuto soltanto <strong>alla</strong><br />
maggior completezza <strong>del</strong>la fonte rispetto al 1482, ma si può tentare di<br />
spiegarlo tenendo presente la storia stessa di Parma.<br />
Nel 1460 gli abitanti <strong>del</strong>la città erano circa 19000 13 , ma si ridussero<br />
notevolmente negli anni successivi a causa di ripetute pestilenze: nel<br />
1468 erano soltanto 8000. Sotto il principato di Ludovico Maria Sforza,<br />
la popolazione tornò a crescere, ma molto lentamente a causa dei ritorni<br />
di pestilenza che occorsero nel 1477 e nel 1481, il che forse può<br />
spiegare un maggior numero d’orfani accolti nel 1482. Inoltre ho<br />
ragione di credere, avendo osservato il Manoscritto Parmense 1625, che<br />
riporta i crediti e i debiti <strong>del</strong>l’ospedale nei confronti dei suoi salariati<br />
(registrazioni complessive) negli anni 1478-1480 14 , che la registrazione<br />
10 L. SANDRI, <strong>La</strong> richiesta dei figli da adottare da parte <strong>del</strong>le famigli fiorentine tra XIV e XV<br />
secolo, in “Annali Aretini”, III (1995), p. 120.<br />
11 P. DALL ’ AGLIO, C. TROMBARA, Cenni biografici e storici sull’antico ospedale di Parma,<br />
Parma 1956, p. 13.<br />
12 C. MINOLI, `Debe esser morto’; balie e bambini <strong>del</strong>l’Ospedale Rodolfo Tanzi di Parma <strong>alla</strong><br />
<strong>fine</strong> <strong>del</strong> XV secolo, tesi di laurea, Università <strong>degli</strong> Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a.<br />
1999-2000, rel. G. Albini, p. 60.<br />
13 R. LASAGNI, Storia demografica <strong>del</strong>la città di Parma, Parma 1983, p. 190.<br />
14 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 61 e Biblioteca Palatina di Parma (d ’ ora in poi BP), Ms.<br />
Parmense (d ’ ora in poi Ms. Parm.) 1625 (aa. 1483-1490).<br />
3
puntuale <strong>degli</strong> affidi alle balie, dopo l’unificazione <strong>degli</strong> ospedali <strong>del</strong><br />
1471, fosse cominciata proprio negli anni 1481-82. Questo può aver<br />
portato i compilatori <strong>del</strong> libro mastro a riportare in quegli anni i conti<br />
che si riferivano a bambini giunti all’ospedale anche in anni precedenti<br />
ma che non erano stati registrati ac<strong>cura</strong>tamente; come <strong>del</strong> resto accade<br />
nel libro detto Morello, dove prima di iniziare ad annotare i conti<br />
riguardanti i bambini a balia nel 1492, è riportata la registrazione di<br />
alcuni baliatici dal 1488 15 .<br />
<strong>La</strong> registrazione indicava in primo luogo il nome <strong>del</strong>la balia e la sua<br />
provenienza, in seguito era riportato il nome <strong>del</strong> bambino e la data<br />
<strong>del</strong>l’affido <strong>alla</strong> nutrice. Solo sporadicamente, a questo punto <strong>del</strong>la<br />
registrazione venivano inserite altre notizie come la provenienza <strong>del</strong><br />
bambino, se portava segni di riconoscimento, la sua probabile età oppure se<br />
era stato precedentemente affidato ad una altra balia.<br />
Registrati i dati di riconoscimento, i rettori passavano ad annotare più<br />
o meno minuziosamente tutto ciò che le balie ricevevano come pagamento<br />
anticipato in natura o denaro e che doveva essere detratto dal saldo finale.<br />
Chiusi o sospesi i conti, il rettore annotava nell’ultima parte <strong>del</strong>la<br />
registrazione la sorte <strong>del</strong> fanciullo.<br />
Il formulario standard riportava: il nome <strong>del</strong>l’intestatario <strong>del</strong> conto<br />
«che sta in» nome <strong>del</strong> paese di provenienza, «si ha tolto uno puto/a<br />
nominato/a» nome <strong>del</strong> bambino «et fu adi» data <strong>del</strong>l’affido «debe<br />
dare...». A questo punto il conto veniva suddiviso in due colonne: sul<br />
lato sinistro <strong>del</strong>la pagina, venivano elencati tutti gli anticipi che la balia<br />
aveva ricevuto sul salario; mentre, sulla destra erano elencati i mesi e<br />
giorni <strong>del</strong>la durata <strong>del</strong> baliatico. In<strong>fine</strong>, veniva annotata, quando<br />
conosciuta, la sorte <strong>del</strong> bambino o altre informazioni utili 16 .<br />
<strong>La</strong> registrazione qui sopra descritta è solo un mo<strong>del</strong>lo: nella maggior<br />
parte dei casi le registrazioni mancano di uno o più elementi; ad esempio<br />
le molte carte che contengono la prosecuzione <strong>del</strong>le registrazione di conti<br />
aperti in anni precedenti citano solo il nome <strong>del</strong>la balia e solo in qualche<br />
caso anche la sorte <strong>del</strong> bambino.<br />
L’analisi puntuale d’ogni registrazione ha permesso di stabilire il<br />
sesso di 350 bambini; sui 408 annoverati nel registro, come si evidenzia<br />
d<strong>alla</strong> tabella 2, circa il 58% <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> era di sesso femminile.<br />
Parma, dunque non faceva eccezione <strong>alla</strong> media <strong>del</strong>le altre istituzioni<br />
ospedaliere <strong>del</strong> tardo medioevo in cui è una costante il fatto che le<br />
bambine abbandonate fossero più numerose dei bambini 17 . A Firenze,<br />
15 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 61 e BP, Ms. Parmense 1626 (aa. 1492-1493), c. 114 e<br />
ss.<br />
16 Ibidem, p. 62.<br />
17 L. SANDRI, Fuori e dentro l’ospedale. Bambine nel <strong>Quattrocento</strong>, in S. ULIVIERI (a <strong>cura</strong> di),<br />
Le bambine nella storia <strong>del</strong>l’educazione, Bologna-Bari 1999, p. 77.<br />
4
all’ospedale <strong>degli</strong> Innocenti negli anni tra il 1445 e il 1485 le bambine erano<br />
il 57% <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> 18 , a San Giminiano, nello stesso periodo, il 60% 19 . A<br />
Milano nel 1471 le bimbe rappresentavano il 70% dei bambini<br />
abbandonati 20 .<br />
<strong>La</strong> ragione di questa predominanza <strong>del</strong> sesso femminile negli ospedali<br />
per il ricovero <strong>del</strong>l’infanzia abbandonata è la stessa di tutti i tempi. Nelle ,<br />
società basate economicamente sull’agricoltura le figlie femmine sono<br />
considerate una bocca in più da sfamare e non ricchezza di braccia da la<br />
voro 21 ; se a questo si aggiunge l ’ onere di costituire una dote per ogni<br />
bambina <strong>del</strong>la famiglia, si capisce come mai si preferisse disfarsi <strong>del</strong>le<br />
femmine piuttosto che dei maschi. Lucia Sandri propone una lettura<br />
“contrario” <strong>del</strong> fenomeno: l’alto numero <strong>del</strong>le bambine negli ospedali potrebbe<br />
significare «un maggior valore dato in quest’epoca <strong>alla</strong> vita <strong>del</strong>le<br />
figlie rispetto ai secoli passati, quando più frequentemente è attestato l ’ in<br />
fanticidio perpetrato a loro danno» 22 . Qualunque sia l’interpretazione è<br />
innegabile che nel Medioevo si privilegiasse l’abbandono <strong>del</strong>le bambine.<br />
<strong>La</strong> nostra fonte non consente la rilevazione di dati inerenti alle<br />
condizioni, età o altro, dei bambini al momento <strong>del</strong> loro ingresso in<br />
ospedale In qualche conto, tuttavia, i rettori inserirono alcune<br />
annotazioni che possono aprire uno spiraglio di luce su alcuni di questi<br />
aspetti.<br />
In 11 conti <strong>del</strong> 1482 il rettore annotò dopo la data d’affido anche l’età,<br />
stimata, fino a quel momento. Ad esempio: di Francesca presa balia il 15<br />
aprile 1482 da Aliti moglie di Mate di Quintav<strong>alla</strong>, viene ri ferito che «po<br />
havere mexi VI» 23 ; di Catelina, affidata ad Antonia d Parti di Vigatto il 2<br />
febbraio 1482, si afferma che «po havere mex VII» 24 , la stessa stima vale<br />
per Maddalena data in affido a Tomaxo Cab gnola 25 il 21 febbraio <strong>del</strong>lo<br />
stesso anno e per Angelo Maria preso a bali da Catelina di Zanna 26 1’8<br />
aprile. Otto e nove mesi avevano rispettiva mente Vinturina, affidata a<br />
Jacopo Pezalo il 23 marzo 1482 27 e Zohanno, che Catelina Farchioni 28<br />
18 T. TAKAHASHI, I bambini e i genitori « espositori" <strong>del</strong>lo spedale di Santa Maria <strong>degli</strong><br />
Innocenti di Firenze nel XV secolo, in “Annuario <strong>del</strong>l’Istituto Giapponese di Cultura”, XXV<br />
(1992), p. 42.<br />
19 L. SANDRI, L’ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala di S. Giminiano nel <strong>Quattrocento</strong>.<br />
Contributo <strong>alla</strong> storia <strong>del</strong>l ’ infanzia abbandonata, Società Storica <strong>del</strong>la Val<strong>del</strong>sa, Firenze 1982,<br />
cit., p. 188.<br />
20 ALBINI, Città e ospedali, cit., p. 175 in nota.<br />
21 SANDRI, Fuori e dentro l’ospedale, cit., p. 78.<br />
22 Ibidem, p. 78.<br />
23 MINOLI, “Debe esser morto” cit. e BP, Ms. Parmense 1629 (Liber hospitalis Roda<br />
comunitatis Parme, fragmenta variorum annorum sec. XV), c. 36.<br />
24 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 32.<br />
25 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 33.<br />
26 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 35.<br />
27 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 34.<br />
28 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 32.<br />
5
prende con sé il 4 febbraio <strong>del</strong>lo stesso anno. Masina di Michele da Lorto il<br />
3 maggio 1482 portò con sé nel parrocchia di San Michele, Maria: una<br />
bimba di diciotto mesi 29 ; il giorno dopo Pellegrina Mazola prense a balia<br />
Rufino che aveva diciannove mesi 30 . Circa due anni, invece avevano<br />
Catelina, data a Maria Gasona il 10 febbraio 1482 31 e Octaviano, affidato<br />
ad Antonia de Cristofalo Biancho 32 .<br />
Purtroppo, non essendoci pervenuta nessuna registrazione riguardante<br />
l’età <strong>degli</strong> infanti al loro ingresso all’ospedale, non possiamo affermare<br />
con sicurezza che le stime sopra riportate si riferiscano ad essa. Tuttavia,<br />
non essendo indicata, per nessun bambino, una balia precedente (vedremo<br />
poi che in alcuni casi lo è) questi bambini probabilmente erano stati<br />
accolti dall’ospedale già grandicelli, cosa tutt’altro che rara anche nel resto<br />
<strong>degli</strong> ospedali <strong>del</strong>l’epoca 33 . Un’altra ipotesi è che i bambini fossero stati<br />
in precedenza affidati ad altra nutrice.<br />
Il caso d’Agnese, affidata il 20 febbraio 1482 a Francesca di <strong>La</strong>rio<br />
Bersello <strong>del</strong>la Parrocchia di S. Maria Maddalena si presta ad un’altra<br />
interpretazione. I rettori nello stimare la sua età azzardarono che «po<br />
habere anni VIII» 34 : dunque era già svezzata da lungo tempo, allora<br />
perché mandarla a balia L’ipotesi più probabile è che fosse malata: nel<br />
medioevo il latte materno era considerato un alimento speciale, che<br />
possedeva poteri taumaturgici 35 tanto che anche gli adulti vi facevano<br />
ricorso 36 . <strong>La</strong> bambina, però, non sembra che ne abbia tratto giovamento<br />
perché n’è riportata la morte il 14 agosto <strong>del</strong> 1482.<br />
I fanciulli raccolti all’ospedale Rodolfo Tanzi provenivano sia d<strong>alla</strong><br />
città che dal contado. L’unificazione <strong>del</strong>l’amministrazione <strong>degli</strong> ospedali,<br />
avventata nel 1471, portò a concentrare la raccolta e lo smistamento dei<br />
fanciulli, per l’invio a balia, nelle mani dei rettori <strong>del</strong>l’ospedale. <strong>La</strong> fonte,<br />
purtroppo, non rivela l’esatta provenienza dei bambini, se non in un caso:<br />
il compilatore <strong>del</strong> registro, nell’annotare l’affido a balia di Pellegrina a<br />
Pellegrina Mazola di Borgonovo, aggiunse che la bimba proveniva da<br />
Sissa 37 .<br />
Un altro caso singolo riguarda la conoscenza <strong>del</strong>la paternità <strong>del</strong>l ’ infante. Il<br />
24 settembre 1484 fu affidato a Jacoma di Sartori, abitante nella parrocchia di<br />
29 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 37.<br />
30 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 112.<br />
31 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 32.<br />
32 Ibidem, p. 65 e ss. e Ms. Parm. 1629, c. 39.<br />
33 Sull’accoglimento dei bambini già cresciuti cfr. SANDRI, Fuori e dentro l’ospedale cit., p.<br />
115 e EADEM, L ’ ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 54.<br />
34 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 66 e Ms. Parm. 1629, c. 36.<br />
35 SANDRI, Baliatico mercenario dei bambini cit.<br />
36 C.M. CIPOLLA, Storia economica <strong>del</strong>l’Europa pre-industriale, Bologna 1997, p. 17.<br />
37 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 66 e Ms. Parm. 1629, c. 112: «...la quale fu<br />
portata da Sissa...».<br />
6
San Pietro, un bambino chiamato Jacomo Maria; da quel che si ricava d<strong>alla</strong><br />
registrazione di questo conto, sembra che Jacoma abbia portato lei stessa il<br />
bimbo all’ospedale perché testimonia che il padre <strong>del</strong> bambino era tale<br />
Pasquino Pixono 38 .<br />
Interessanti sono i casi dei bambini che giungevano all ’ ospedale con una<br />
lettera sistemata tra le fasce o appesa al collo. Altavissa, affidata a Maria di<br />
Ripuano nel 1485, portava un breve al collo che recitava «fiola de uno bono<br />
citadino» 39 . Nel contratto d’affido a Domenegina Piaxentina, il 14 settembre<br />
1484, <strong>del</strong>la piccola Cassandra si legge che la bimba era stata portata all’ospedale<br />
con al collo un cordone verde, cui era appeso un breve 40 . Anche Zohanno,<br />
affidato a Jacomo da Pannocchia portava un breve al collo e si specifica che<br />
era vergato in «littera grossa» 41 .<br />
Inserito nel manoscritto, come foglio sciolto, vi è uno di questi brevi Esso<br />
non si riferisce a nessuno dei bimbi di cui ho trovato traccia nel registro,<br />
probabilmente il contratto che lo riguardava era contenuto in un <strong>del</strong>le carte che<br />
sono andate perdute.<br />
Il breve è datato 20 marzo 1485 e recita: «A vuoy massari <strong>del</strong> spedale<br />
voliate dare a bayla questa puta nominata Durateya, la quale è fiola de una<br />
persona da bene e al presente se ritrova fora de casa e se Dio lo manda a casa<br />
sano e salvo farà el donatione al spedale». Sotto, scritto dai rettori <strong>del</strong>lo<br />
ospedale, è stato aggiunto: «adi 30 de marzo la soprascritta fu data a bayila al<br />
Ponte dal’Enza» 42 . Il breve non riporta il nome dei genitori, ma la bimba era<br />
quasi si<strong>cura</strong>mente legittima. Durateya apparteneva <strong>alla</strong> categoria dei bambini<br />
abbandonati, non perché non desiderati, ma perché i loro genitori erano<br />
impossibilitati da cause di forza maggiore a tenerli con sé. Tutto il breve è<br />
imbevuto di speranza e affetto, la promessa <strong>del</strong>la donazione e l’invocazione a<br />
Dio lo testimoniano. Sembra quasi vedere il genitore affranto scrivere<br />
queste poche righe e nasconderle nelle fasce, raccogliere la bambina e<br />
portarla all’ospedale prima di partire per un viaggio dal quale non sa se<br />
tornerà.<br />
A differenza d’altre strutture ospedaliere, come ad esempio l’ospedale di<br />
Santa Maria <strong>del</strong>la Scala di San Giminiano 43 , i rettori <strong>del</strong>l ’ ospedale Rodolfo<br />
Tanzi non segnalavano se i bambini fossero già stati battezzati, tuttavia i Libri<br />
Battesimali di Parma riportano il battesimo d’alcuni trovatelli. Il Benassi ci<br />
38 Ibidem, p. 66 e Ms. Parm. 1629, c. 99. Il manoscritto riporta: «Jacoma di Sarto che sta in la<br />
vicinanza de Santo Pedro si ha tolto uno puto a bayila nominato Jacomo Ma ria che dita Jacoma<br />
testificha essere fiolo de Pasquino Pixono...».<br />
39 Ibidem, p. 66 e Ms. Parm. 1629, c. 105: «...fiola de uno bono citadino tomo di per uno<br />
breve che laveva al collo...».<br />
40 Ibidem, p. 67 e Ms. Parm. 1629, c. 98. Il Manoscritto riporta: «...et ha uno cord ne al collo<br />
verdo con uno breve e in lo breve ze signato uno contello...».<br />
41 Ibidem, p. 67 e Ms. Parm. 1629, c. 111 «...el quale haveva uno scripto al collo letera<br />
grossa...».<br />
42 Ibidem e foglio sciolto inserito nel Ms. Parm. 1629.<br />
43 SANDRI, L’ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 170 e ss.<br />
7
informa che le balie interne <strong>del</strong>l’ospedale erano solitamente le madrine <strong>degli</strong><br />
<strong>esposti</strong>: nella registrazione <strong>del</strong> battesimo di una bambina, avvenuto il 9 marzo<br />
1485, è nominata come madrina Antonia «que lactact infantes in dicto hospitali<br />
(Rodulfi)». <strong>La</strong> stessa balia è elencata nel Manoscritto Parmense 1629 come<br />
balia nell’ospedale 44 e ancora nello stesso libro battesimale come madrina nel<br />
1501 45 . Da padrini <strong>degli</strong> <strong>esposti</strong> facevano i salariati <strong>del</strong>l’ospedale: nel<br />
battesimo di un trovatello, <strong>del</strong> 23 febbraio 1487, è compare «Bernardus de<br />
Tafurelis de Bobio, nutricius in Hospitali» e in un altro, amministrato il 2<br />
giugno 1487, come padrino compare «Jo de Pontremulo, famulus in<br />
Hospitali» 46 .<br />
Le registrazioni <strong>degli</strong> affidi nel Manoscritto Parmense terminano il primo<br />
luglio 1487. A differenza di quanto sostenuto da Benassi e Maria Banzola 47 , il<br />
Manoscritto Parmense 1626, detto libro Morello, oltre alle registrazioni <strong>degli</strong><br />
affidi verificatesi durante il 1492, riporta, anche, gli affidi a decorrenza<br />
antecedente tale epoca, ma conclusisi nell’anno in corso: infatti, troviamo affidi<br />
risalenti al 1488 48 .<br />
Una volta entrati nell ’ ospedale, i bambini abbandonati erano dati a balia il<br />
più presto possibile, perché il latte di una donna era l ’ unico alimento ritenuto in<br />
grado di nutrire un bambino nei primi mesi di vita.<br />
I testi di puericultura medievale sconsigliavano l’utilizzo <strong>del</strong> latte<br />
animale per i neonati. Paolo da Certaldo nel suo Libro dei buoni costumi<br />
scrisse <strong>del</strong>le significative parole in proposito: «Anche, abbi molto guardia<br />
(...) di darlo a baglia ch’abbia abbondanza di latte, acciò che la detta<br />
baglia per necessità di latte non gli desse a bere latte di capra o di pecora<br />
o, d’asina o d’altra bestia; che il fanciullo o fanciulla che si nodrisce a<br />
latte di bestia non à sua ragione perfetta (...) anzi sempre pare ne la sua<br />
vista balordo e vano e non compiuta ragione» 49 .<br />
L ’ ospedale Rodolfo Tanzi aveva alle sue dipendenze sei balie interne,<br />
definite «bayila in ospitali» 50 o «bayila in casa» 51 , spesso mogli d’altri<br />
salariati <strong>del</strong>l’istituto. Queste nutrici erano coordinate da una «magistra<br />
priora», chiamata Maria 52 , e si presume che si prendessero <strong>cura</strong> <strong>degli</strong><br />
44 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 68 e Ms. Parm. 1629, c. 132: «Antonia bayila che<br />
stava in lo hospitale...».<br />
45 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 68 e U. BENASSI, Storia di Parma, Parma 1908,<br />
p. 37, che cita Libro battesimale, ad annum, p. 9.<br />
46 MINOLI, `Debe esser morto" cit., p. 68 e BENASSI, Storia di Parma cit., p. 37, che cita<br />
Libro battesimale, ad annum, p. 5 e p. 10.<br />
47 M. O. BANZOLA, L’ospedale vecchio di Parma, Parma 1980, p. 104 che riprende<br />
BENASSI, Storia di Parma cit., p. 39.<br />
48 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 71 e Ms. Parm. 1626, c. 114 e ss.<br />
49 PAOLO DA CERTALDO, Libro dei buoni costumi, documento di vita trecentesca, a <strong>cura</strong> di A.<br />
SCHIAFFINI, Firenze 1945, p. 234.<br />
50 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 72 e Ms. Parm. 1629, c. 132: «... bayila in Io hospitale...».<br />
51 Ibidem, p. 72 e Ms. Parm. 1629, c. 165: «Angela bayila in caxa...».<br />
52 Ibidem, p. 72 e Ms. Parm. 1629, c. 136: «Magistra Maria priora in lo hospitalle...».<br />
8
infanti nel momento <strong>del</strong> loro ingresso nell’ospedale il loro salario era di<br />
soli 10 soldi al mese 53 , ossia la metà <strong>del</strong> salario di una balia esterna. Si<br />
possono ipotizzare due spiegazioni circa il minor compenso, purtroppo<br />
non verificabili allo stato attuale <strong>del</strong>la ricerca. <strong>La</strong> prima è che a queste<br />
balie fosse fornito vitto e alloggio e quindi i 10 soldi rappresentino la<br />
parte <strong>del</strong> salario pattuita in denaro. <strong>La</strong> seconda ipotesi è che fossero in<br />
realtà balie “asciutte ” e non fornissero latte, ma si limitassero ad accudire<br />
i bimbi già svezzati e rientrati all’ospedale. <strong>La</strong> seconda teoria è<br />
supportata dal fatto che queste balie sono registrate per più anni di<br />
seguito, ed è poco probabile che continuassero a restare incinta; inoltre ad<br />
Antonia, balia all’ospedale, nel 1485 è specificatamente affidata una<br />
bambina chiamata Venturina ed è retribuita una lira al mese 54 , esattamente<br />
come le balie esterne che erano pagate per <strong>alla</strong>ttare al seno i bambini.<br />
I bambini <strong>del</strong>l’ospedale erano, inoltre, assistiti da un medico: il<br />
«Magistro Zohanne da Bologna, medigo, conduto per li rettori a madegare a<br />
le necessità <strong>del</strong> hospitale de Rodolfo» 55 , la cui presenza è attestata sin dal<br />
1484. D<strong>alla</strong> scarsa entità <strong>del</strong> suo salario, veniva pagato otto staia di grano<br />
l’anno (che corrispondevano a circa otto lire, quando la priora <strong>del</strong>l’ospedale<br />
ne riceveva 32), ho dedotto che non vi lavorasse stabilmente, ma visitasse<br />
l’ospedale di tanto in tanto. Considerata l ’ ambiguità <strong>del</strong>la figura <strong>del</strong>la balia<br />
interna, sembra che il passo immediatamente successivo all’ingresso <strong>del</strong><br />
bambino in ospedale fosse quello di cercare una balia esterna che<br />
provvedesse ad <strong>alla</strong>ttarlo, <strong>alla</strong> quale fornire anche un corredo fatto di<br />
«pezze, fascie e cupertore». Questo equipaggiamento costava 16 soldi e<br />
doveva essere reso nel momento <strong>del</strong> rientro <strong>del</strong> bambino all’ospedale: alle<br />
balie che non restituirono il corredo, il suo costo fu detratto dal salario 56 .<br />
Le balie esterne conteggiate nel manoscritto per il periodo che<br />
abbiamo preso in considerazione sono circa 370, per 227 di queste sono<br />
riuscita ad individuare la località di residenza. 33 balie risiedevano in 14<br />
diverse parrocchie entro le vecchie mura <strong>del</strong>la città di Parma, mentre<br />
altre 10 nelle vicinie attorno <strong>alla</strong> città. <strong>La</strong> zona da cui proviene il maggior<br />
numero di balie era quella <strong>del</strong>la parrocchia di Ognissanti insieme <strong>alla</strong><br />
adiacente parrocchia di San Basilide (soppressa nel 1810 e oggi facente<br />
parte <strong>del</strong>la vicinia di San Giuseppe) che complessivamente fornirono 9<br />
balie. Le restanti balie abitanti a Parma provenivano equamente dalle<br />
altre parrocchie 57 .<br />
53 Ibidem, p. 72 e Ms. Parm. 1629, c. 136: «De havere per il so salario conduca pro li<br />
domini Rectoriy a comenzando in calende de luyo 1485 in raxone de s. 10 el mexe...».<br />
54 Ibidem, p. 72 e Ms. Parm. 1629, c. 132.<br />
55 Ibidem, p. 74 e Ms. Parm. 1629, c. 104.<br />
56 Ibidem, p. 74 e Ms. Parm. 1629.<br />
57 In particolare nelle parrocchie di: S. Maria, 1; Santa Croce, 2; S. Bartolomeo, 2; S.<br />
Bernardo, 2; S. Giovanni Battista, 1; Duomo, 1; Ognissanti, 4; S. Anastasio (soppressa<br />
nel 1653, oggi fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Andrea); S. Giorgio 1 (soppressa 1 1510,<br />
oggi fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Pietro); S. Barnaba, 4 (soppressa nel 1810, oggi fa<br />
9
Altre 47 nutrici risiedevano nella zona che ora fa parte <strong>del</strong> comune di<br />
Parma, specialmente nella zona sud-est, ove ne risiedevano 27 58 .<br />
Nel contado risiedevano 147 balie. Le località più vicine a Parma<br />
fornivano più balie: più ci si allontanava d<strong>alla</strong> città, più le balie<br />
diminuivano. Il paese da cui provenivano più balie era Guardasone,<br />
addirittura 28.<br />
Vi sono, anche, nutrici che risiedevano assai lontano dall’ospedale,<br />
ad esempio ad Albazzano (oggi nel comune di Tizzano), a Berceto, e ve<br />
ne erano tre che provenivano da San Sisto, che ora si trova in provincia<br />
di Reggio Emilia. In quelli che oggi sono i comuni di Felino,<br />
Collecchio e Sala Baganza risiedevano 16 balie 59 . Nei comuni odierni di<br />
Fontanellato, Fontevivo, Medesano e Noceto abitavano 26 balie 60 . Nella<br />
zona di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile risiedevano 9 balie 61 . 28<br />
erano le nutrici provenienti dai comuni di Montechiarugolo e<br />
Taversetolo 62 . Dai paesi di Roccabianca, San Secondo, Sissa e Trecasali<br />
provenivano 22 balie 63 . Più ci si allontanava da Parma, meno erano le<br />
balie presenti nelle varie zone. Nei comuni di Solignano, e Varano de’<br />
Melegari abitavano 10 balie 64 . 8 balie risiedevano nei comuni di<br />
Calestano, Fornovo di Taro e Terenzo 65 e 4 nel comune di Soragna (2 a<br />
Soragna e 2 a Carzeto). Il comune di <strong>La</strong>nghirano forniva 5 balie 66 . 2<br />
nutrici provenivano dal comune di Tizzano, 1 da Canetolo, 2 da<br />
Provazzano e un’altra da Mozzano. A Pessola abitava un’altra balia e in<br />
parte <strong>del</strong>la parrocchia <strong>del</strong>la SS. Trinità); S. Basilide, 5 (soppressa nel 1810, oggi fa<br />
parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Giuseppe); S. Quintino, l; S. Giacomo, 4 (probabilmente<br />
San Marco); S. Jmerio, 4 (soppressa nel 1534, oggi fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S.<br />
Apollinare); S. M. Maddalena, 1; S. Michele, 2; S. Matteo, 9 (soppressa nel 1542, oggi<br />
fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Alessandro); S. Pietro, 1; S. Salvatore, 1 (soppressa<br />
1634, oggi fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Tommaso,); S. Silvestro, 1 (soppressa 1810,<br />
oggi fa parte <strong>del</strong>la parrocchia di S. Quintino); S. Maria in Borgo Taschieri, 2; S.<br />
Spirito, 1; Porta S. Francesco, 1; Borgo Torto, 1 (oggi Corso Corsi). Le informazioni<br />
sulla soppressione <strong>del</strong>le parrocchie sono state tratte da: LASAGNI, Storia demografica<br />
<strong>del</strong>la città di Parma cit., p. 173.<br />
58 In particolare: Viarolo, 2; Baganzola, 4; Paradigna, 1; Alberi, 1; Carigano, 4; Castelnovo,<br />
1; Malandriano, l; Marano, 1; Mariano, 1; Marore, 2; Marrorano, 6; Panocchia, 4; Ronco di<br />
Pascolo, 2; S. Prospero, 1; Valera, l; Viarolo, 2; Vicofertile, 4; Vigatto, 3.<br />
59 In particolare: Madregolo, 1; Collecchio, 6; S. Martino Sinzano, 2; Giarola, 1; Oppiano,<br />
2; Sala baganza, 1; S. Vitale, l; S. Ilario Baganza, 1; S. Michele Tiorre, 1.<br />
60 In particolare Fontanellato, 3; Albareto, 2; Bianconese, 4; Castelguelfo, 5;Toccaimatto, 1;<br />
Costamezzana, 5; Cella, 2; Medesano, 3; Maiano, 3; Felegara, 5; Varano Marchesi 2.<br />
61 In particolare: Torrile, 2; Colorno, 1; Gainago, 1; Sorbolo, 2; Bogolese, 2; S.Andrea, 2.<br />
62 In particolare: Maiano, 3; Basilicanova, 1; Montechirugolo, 25.<br />
63 In particolare: Fontanelle, 6; Torricella, 2; S. Nazzaro, 1; Trecasali, 2; S. Secondo, 8; S.<br />
Quirico, 1; Ronchetti, 1; Ronco di Campo Canneto, 1; Sissa, 5.<br />
64 In particolare: Montesalso, 3; Riviano, 1; Orlano, 6.<br />
65 In partcolare: Selva, 3; Fornovo, 2; Neviano de Rossi, 1; Vallerano, 1; Vigolone, 1.<br />
66 In particolare: Torchiara, 2; Arola, l; Riano, 1; Cozzano, 1.<br />
10
<strong>fine</strong> 2 balie provenivano da Tabiano.<br />
Il notevole numero di balie abitanti in Parma e dintorni sembrerebbe un<br />
tentativo <strong>del</strong>l’ospedale di attuare un sistema di controllo sulle balie stesse;<br />
la vicinanza <strong>alla</strong> struttura permetteva una sorveglianza più ac<strong>cura</strong>ta da<br />
parte dei responsabili <strong>del</strong>l’ospedale che non erano così costretti a percorrere<br />
lunghi tratti di strada per informarsi <strong>del</strong>la salute <strong>del</strong> trovatello. Inoltre, a<br />
differenza di quanto avveniva a Firenze, la scelta di balie residenti vicino<br />
all’ospedale costituiva un vantaggio economico, poiché tutte le balie<br />
esterne percepivano lo stesso salario. A Firenze, invece, gli ospedali<br />
cittadini preferivano le balie di campagna in quanto il loro compenso<br />
diminuiva con l’aumento <strong>del</strong>la loro distanza d<strong>alla</strong> città 67 .<br />
Le balie cittadine <strong>del</strong>l ’ ospedale Rodolfo Tanzi appartenevano al ceto<br />
dei piccoli commercianti e dei bottegai. Ad esempio Catelina, che prense<br />
con sé Zohanna nel 1487, era la moglie di Lionardo Fuxaro che aveva in<br />
affitto una bottega sotto l ’ ospedale 68 .<br />
Le balie <strong>del</strong> contado appartenevano al ceto dei contadini e dei<br />
mezzadri, non di rado erano le mogli <strong>degli</strong> affittuari <strong>del</strong>l’ospedale,<br />
preferite perché già legate all’istituto da altri vincoli. Ad esempio dal<br />
salario <strong>del</strong>la moglie di Andrea Moreto, che prese in affido il piccolo<br />
Mase nel 1482, sono scalate circa tre lire come anticipo sull’affitto di un<br />
mulino di proprietà <strong>del</strong>l’ospedale 69 .<br />
Un altro aspetto <strong>del</strong> baliatico all’ospedale Rodolfo Tanzi consiste nel<br />
fatto che spesso i contratti erano stipulati a nome <strong>degli</strong> uomini. Su 370<br />
contratti d’affido, a partire dal primo febbraio 1482, 45 erano intestati a<br />
uomini e due erano intestati ad entrambi i coniugi 70 .<br />
<strong>La</strong> figura <strong>del</strong> balio era una figura comune in tutti i contratti che<br />
riguardano l’affido a balia in molte città italiane. A Firenze, nel<br />
<strong>Quattrocento</strong>, quando un cittadino voleva mandare a balia il proprio<br />
figlio, il più <strong>del</strong>le volte contrattava direttamente con il balio 71 , quasi che<br />
l’<strong>alla</strong>ttamento fosse una faccenda da uomini.<br />
Una volta trovata la balia, che fosse di città o di campagna, per<br />
l’ospedale era auspicabile che questa tenesse il bambino il più a lungo<br />
possibile, ma non molti furono i casi di bimbi tenuti per più di un anno,<br />
infatti, in sei anni solo 28 affidi superarono questo lasso di tempo e<br />
generalmente si conclusero con un’adozione.<br />
Nel registro da me esaminato sono segnalati 9 conti in cui è chiaramente<br />
67 SANDRI, L’ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 147.<br />
68 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 79 e Ms. Parm. 1629, c. 179, «...pro la pixone de la<br />
botega posta sotto lo hospitale...».<br />
69 Ibidem, p. 79 e Ms. Parm. 1629, c. 36.<br />
70 Ibidem, p. 79 e Ms. Parm. 1629.<br />
71 CH. KLAPISCH-ZUBER, <strong>La</strong> famiglia e le donne nel Rinascimento, Roma-Bari 1995, p.<br />
226.<br />
11
iportato il passaggio da una balia ad un ’ altra. In tutti i casi il bambino era<br />
affidato <strong>alla</strong> nuova balia il giorno stesso o il successivo a quello in cui la<br />
prima balia l’aveva reso all ’ ospedale. In tre casi in cui il bambino cambiò<br />
balia nello stesso giorno si scopre, inoltre, che entrambe le balie<br />
abitavano nello stesso paese. A Carignano, il 10 settembre 1485, Isabetta<br />
passò dalle mani di Catelina moglie di Zohanne Antonio Payno a quelle di<br />
Margarita di Pellegrino di Jacopetto 72 . <strong>La</strong> bimba era stata con Catelina<br />
per un anno e mezzo e restò con Margarita per nove mesi, completando<br />
felicemente lo svezzamento; infatti, viene resa all’ospedale in salute il 13<br />
luglio 1487 73 .<br />
Non altrettanto fortunata fu Agnexa a Pontetaro che, dopo essere stata<br />
con Antonia di Pedronus Casso per due giorni, fu data a Catelina di<br />
Antonio di <strong>La</strong>nzi che la vide morire due mesi dopo 74 .<br />
In questi casi si può ipotizzare che le balie si fossero passate i bambini<br />
di propria iniziativa, informando l’ospedale in un secondo tempo. Mi<br />
pare poco probabile, infatti, che su circa 408 bambini solo 9 cambiassero<br />
balia. <strong>La</strong> tesi è supportata dal fatto che molti affidi si conclusero con la<br />
resa <strong>del</strong> bambino da parte <strong>del</strong>la balia dopo pochi giorni.<br />
Oltre ad essere presenti casi in cui i bambini cambiavano balia è<br />
presente anche il fenomeno contrario, ovvero, nei sette anni considerati,<br />
29 balie presero in affido più di un bambino. In 22 casi le balie presero in<br />
affido due <strong>esposti</strong>. Di queste, 15 ottennero in affido un secondo bambino,<br />
perché il precedente era morto, la sostituzione, infatti, avvenne nel giro<br />
di breve tempo, massimo un mese, onde evitare di perdere il latte. Lo<br />
stesso avvenne per 6 balie che presero in affido più di due trovatelli:<br />
<strong>La</strong>rio e Zohanna Bertonzino di Ronco di Pascolo, addirittura, ebbero in<br />
affido tre bambine nel giro di tre mesi. L’ultima mori il primo di<br />
dicembre 1486, ma i bali non si scoraggiarono e lo stesso giorno presero<br />
in affido Cristofalo, <strong>del</strong> quale possiamo ipotizzare una sorte migliore,<br />
dato che, quando il registro 1629 si interrompe, era ancora vivo 75 .<br />
Nei restanti sette casi tra un affido e l’altro passarono almeno sei mesi e i<br />
primi bambini affidati tornarono tutti vivi all’ospedale, si può ipotizzare che<br />
il secondo affido fosse giustificato da una nuova gravidanza <strong>del</strong>la balia<br />
oppure che il figlio <strong>del</strong>la balia fosse vivo e che lei lo <strong>alla</strong>ttasse insieme al<br />
piccolo esposto. <strong>La</strong> scarsa propensione sia dei privati, sia <strong>degli</strong> ospedali,<br />
pur ammettendo una certa elasticità nel caso di questi ultimi, ad assumere<br />
balie il cui bambino non fosse morto, fa pensare che l’ipotesi <strong>del</strong>la nuova<br />
gravidanza sia più credibile. In<strong>fine</strong> in due casi, le balie presero in affido il<br />
secondo bambino dopo aver adottato il primo, che ormai aveva si<strong>cura</strong>mente<br />
più di tre anni: in questo caso è evidente che era intervenuta una nuova<br />
72 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 80 e Ms. Parm. 1629.<br />
73 Ibidem, p. 80 Ms. Parm. 1629, c. 152.<br />
74 Ibidem, p. 80 Ms. Parm. 1629, c. 169.<br />
75 Ibidem, p. 81 e Ms. Parm. 1629, c. 150.<br />
12
gravidanza.<br />
Il rapporto tra l ’ ospedale e le balie non era sempre facile. Soprattutto<br />
nei primi due anni esaminati (1482-1483), per i rettori non era agevole<br />
controllare la salute dei bambini dati a balia. Quando all’ospedale non<br />
giungeva più notizia alcuna dei bambini, il conto restava in sospeso ed il<br />
pagamento bloccato. In questi casi il compilatore <strong>del</strong> registro si limitava<br />
a segnare un laconico «debe esser morto» in calce <strong>alla</strong> registrazione<br />
<strong>del</strong>l’affido. In un caso leggiamo addirittura un «debono esser morti tutti<br />
gran tempo fa» 76 . A partire dal 1484, la sorveglianza migliorò, poiché le<br />
segnalazioni di affidi ad esito ignoto diradarono grandemente ed in<br />
alcuni casi, l’ospedale obbligò la balia all ’ ottemperanza <strong>del</strong>le proprie<br />
direttive mediante la minaccia di non pagarle il salario. Nel 1485 a<br />
Domenegina Checa, di Soragna, è ordinato di rendere il piccolo<br />
Domenego, dopo due mesi d ’ affidamento, perché lo «governava male» 77<br />
e nel 1486 Agnexina di Aldino di Marore è avvertita che se non renderà<br />
Zohanno, che tiene con sé da tre anni e quattro mesi, non sarà pagata<br />
oltre 78 .<br />
L’ospedale nel 1487 non riuscì a farsi restituire un bambino; nel conto<br />
intestato a Domenego Biacho da San Sisto vi è un ’ annotazione che dice:<br />
«non debe esser pagato perché non ha mai voluto portare il puto che ha anni<br />
vij» 79 , la stessa che si ritrova nel conto <strong>del</strong>lo stesso Domenego un anno<br />
prima, cioè nel 1486, con la differenza che il bambino all’epoca aveva sei<br />
anni. In realtà si trattò di un caso particolare: in una <strong>del</strong>le carte andate perse<br />
riguardanti il 1482 (da calcoli fatti, posso azzardare che si trattasse <strong>del</strong>la<br />
carta 46), doveva esserci notizia <strong>del</strong>l’affido <strong>del</strong> piccolo Zohanne a<br />
Domenego Biacho, il quale lo rese poi il 18 novembre <strong>del</strong> 1483. Nel 1485 vi<br />
è un altro conto aperto a nome <strong>del</strong>lo stesso Domenego nel quale si dice:<br />
«Domenego Baicho da San Sisto si ha tolto uno puto a bayila da lo<br />
hospitale, nominato Zohanno e fu de queli de caxa. Il quale era amalato in<br />
caxa e dito Domenego lo aveva alevato et fu adì 26 de aprile» 80 . Siamo,<br />
come nel caso di Altavissa, davanti a un caso di amore: i bali si sono<br />
affezionati al bambino, l’hanno allevato e l’hanno <strong>cura</strong>to quando era<br />
malato, non era forse naturale che lo volessero tenere Dal canto suo<br />
l’ospedale non sembrò preoccuparsi troppo, l’unico provvedimento è la<br />
sospensione <strong>del</strong> salario.<br />
Altre balie non erano così amorevoli o attente ai bambini loro affidati.<br />
Caso singolare è quello di Catelina, affidata a Maxina de Polo <strong>del</strong> Lovo<br />
76 Ibidem, p. 83 e Ms. Parm. 1629, c. 126.<br />
77 Ibidem, p. 83 e Ms. Parm. 1629, c. 112: «Non gli dare niente che fu per male<br />
tegnire lo Auto...».<br />
78 Ibidem, p. 83 e Ms. Parm. 1629, cc. 66 e 113 «Nota chomo li fu dito adì 18 ro che<br />
la portasse le detta puta a la <strong>fine</strong> de febraro e non dee esser pagata per più».<br />
79 Ibidem, p. 84 e Ms. Parm. 1629, c. 163.<br />
80 Ibidem, p. 84 e Ms. Parm. 1629, c. 103.<br />
13
di Guardasone il 23 aprile 1485. <strong>La</strong> balia riportò la bambina all’ospedale<br />
il 3 giugno 1486, ma l’ospedale la costrinse a riprenderla perché la<br />
bambina aveva i pidocchi 81 .<br />
<strong>La</strong> scarsa attenzione <strong>alla</strong> <strong>cura</strong> e l’igiene dei bambini da parte di alcune<br />
nutrici, è testimoniata anche dal caso di Francesco, dato a balia ad<br />
Agnexa de <strong>La</strong>rio di Guardasone. Il bimbo fu reso all’ospedale dopo sei<br />
mesi di baliatico, vivo, ma il compilatore <strong>del</strong> registro si lamenta che era<br />
tristo e malato 82 .<br />
81 Ibidem, p. 84 e Ms. Parm. 1629, c. 152: «Nota che la rexe la puta adì 23 aprille et la<br />
tornò a torre adì 3 de zugno perché la puta hera venuta piochiosa».<br />
82 Ibidem, p. 84 e Ms. Parm. 1629, c. 129: «Rexe adì 22 de mayo 1486, tristo e amalato».<br />
14
Il grafico riportato nella pagina accanto raffigura, in percentuale, la<br />
casistica dei vari destini dei 408 <strong>esposti</strong> all’ospedale Rodolfo Tanzi negli<br />
anni dal 1482 al 1486 83 . Ad una prima lettura potrebbe sembrare che la<br />
percentuale di mortalità non fosse poi così elevata, ma se si considera che al<br />
26% <strong>del</strong>le morti accertate dall’ospedale deve essere aggiunta la percentuale<br />
dei bambini la cui sorte fu registrata con un laconico «debe esser morto» da<br />
parte dei rettori <strong>del</strong>l’ospedale, la percentuale di morti, certi e presunti, sale<br />
al 32%. Non solo, a questo tasso va si<strong>cura</strong>mente aggiunto qualche altro<br />
punto percentuale: sia perché parte dei bambini, di cui non è stato possibile<br />
determinare la sorte, si<strong>cura</strong>mente morirono, sia perché il registro manca<br />
di alcune carte. Inoltre bisogna considerare che sono stati conteggiati<br />
come “morti” solo i bambini che morirono durante l’affidamento a balia.<br />
Infatti, dei bambini rientrati all’ospedale dopo il baliatico non sappiamo<br />
quanti sopravvissero. Per poter fornire dei dati statisticamente significativi,<br />
ho rivolto la mia attenzione a 108 affidi effettuati nel 1482 ed ad 43 affidi<br />
<strong>del</strong> 1483, per i quali è stato possibile determinare, in maniera più precisa, sia<br />
la data di affido, sia il destino dei bambini.<br />
Il numero totale di <strong>esposti</strong> di sesso maschile presi a balia nel 1482 di<br />
cui sono riuscita reperire sia la date di affido, sia la sorte è di 42. Di<br />
questi ne morirono 13; 3 entro un mese dall’inizio <strong>del</strong> baliatico, 2 entro<br />
tre mesi, 6 entro sei mesi dall’affido e altri 2 dopo più di un anno. A<br />
questi vanno aggiunti altri sette conti chiusi dai compilatori <strong>del</strong> registro<br />
con «debe esser morto». Per lo stesso anno, il numero di trovatelle fu di<br />
63, <strong>del</strong>le quali ne morirono 17, soprattutto nel primo mese di baliatico (6)<br />
e altre 7 non superarono i primi sei mesi.<br />
Esaminando il 1483, sono riuscita ad individuare 45 contratti di<br />
baliatico indicanti sia l’affido che la sorte: 22 per le bambine e 23 per i<br />
bambini. Di questi morirono 7 bambine, la maggior parte <strong>del</strong>le quali<br />
non superò i primi sei mesi <strong>del</strong>l’affido e 7 maschietti, prevalentemente<br />
morti entro due mesi dall’uscita dall’ospedale.<br />
Di cosa morivano i piccoli <strong>esposti</strong><br />
Si<strong>cura</strong>mente molti di loro non sopravvivevano al trauma<br />
<strong>del</strong>l’abbandono. <strong>La</strong>sciati per strada, davanti ai portoni spesso non erano<br />
raccolti subito e subivano le intemperie e i rigori <strong>del</strong>la stagione. Altri<br />
giungevano all’ospedale già in condizioni precarie, sofferenti per un<br />
parto difficile o malnutriti. Inoltre, nei periodi di pestilenza gli <strong>esposti</strong><br />
risentivano in particolare modo <strong>del</strong>la scarsa igiene <strong>del</strong>la struttura<br />
ospedaliera 84 . Usciti dall’ospedale per andare a balia, i bambini non<br />
erano certo al riparo da malattie ed incidenti. Le malattie intestinali erano<br />
83 Si ricorda inoltre che, per i conti riguardanti il 1486 e 1487, a volte è stato impossibile<br />
determinare la sorte, poiché il baliatico si concluse dopo il 1487.<br />
84 G. PINTO, Personale, balie e salariati <strong>del</strong>l ’ ospedale di San Gallo, estratto da “ Ricerche<br />
storiche”, 2 (1974), ripubblicato con altri saggi di notevole interesse in G. PINTO (a <strong>cura</strong> di), <strong>La</strong><br />
società <strong>del</strong> bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, Firenze 1989, cit., p. 127.<br />
15
le più pericolose: caratterizzate da violente diarree e indicate col nome di<br />
«pondi», «bachi», «flussi», che colpivano i bambini, in particolare quelli<br />
molto piccoli, in maniera letale e erano si<strong>cura</strong>mente da attribuire alle<br />
scarse cure e <strong>alla</strong> mancanza d’igiene 85 .<br />
Dai “Libri <strong>del</strong>le ricordanze” fiorentini si ricavano i nomi di queste<br />
altre malattie: «mala di chanchero e bole nela bocha», «rosolie», «febre e<br />
lattime», «mal di tossa» 86 .<br />
A queste malattie si aggiungevano quelle epidemiche: la peste<br />
imperversò d<strong>alla</strong> metà <strong>del</strong> XIV secolo e per tutto il XV secolo. Verso la<br />
<strong>fine</strong> <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong> fece la sua comparsa il “mal francioso” o “mal di<br />
seme”, ovvero la sifilide che in questo periodo afflisse l ’ Europa intera 87 .<br />
Numerose altre morti erano provocate da incidenti. Il più comune era<br />
«1’affogamento» <strong>del</strong> bambino durante il sonno: i bambini erano messi a<br />
dormire nello stesso letto dei bali e sovente erano schiacciati o soffocati<br />
da loro durante la notte 88 . Alcuni ospedali cercarono di arginare il<br />
fenomeno, fornendo ai bali <strong>del</strong>le speciali cassette di legno, denominate<br />
«zana con guanciale» 89 , da usare come culla, che potevano essere portate<br />
a letto, ma servì a poco 90 . Un altro tipo di disgrazia che poteva accadere<br />
ai bambini abbandonati ere quello di «volar» fuori d<strong>alla</strong> culla, perché<br />
cullato troppo violentemente. Doveva essere un incidente molto comune<br />
poiché al beato Agostino Novello è attribuito il salvataggio di uno di questi<br />
sfortunati bambini 91 .<br />
Altri incidenti domestici si verificavano quando il bambino cresceva e<br />
toglieva la stretta fasciatura che lo aveva tenuto imprigionato nei primi<br />
mesi di vita: lasciati liberi di camminare per la casa e i suoi dintorni e<br />
poco o per nulla sorvegliato dai bali, impegnati nelle attività lavorative<br />
quotidiane, i bambini correvano gravi rischi e spesso non sopravvivevano<br />
85 SANDRI, L ’ ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 67. D. HERLIHY, CH. KLAPISCH-<br />
ZUBER, I Toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino <strong>del</strong> 1427, Bologna 1988, pp.<br />
464-467.<br />
86 KLAPISCH-ZUBER, <strong>La</strong> famiglia e le donne cit., 1995, p. 238, n. 69.<br />
87 SANDRI, L’ospedale di S. Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 169; per la storia <strong>del</strong>le malattie: A.<br />
PAZZINI, Scritti di storia <strong>del</strong>le malattie, Roma 1969; M.S. MAllI, Salute e società nel Medioevo,<br />
Firenze 1978.<br />
88 KLAPISCH-ZUBER, <strong>La</strong> famiglia e le donne cit., p. 233.<br />
89 SANDRI, L ’ ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 163.<br />
90 Ibidem, p. 162.<br />
91 Il miracolo è descritto da un quadro di Simone Martini, con la tecnica di rappresentare<br />
più scene consequenziali nello stesso quadro. Nella pala si vede la culla <strong>del</strong> bambino,<br />
appesa al soffitto con un sistema di corde sopra al letto dei genitori, che muovendo solo un<br />
braccio, potevano farla dondolare. <strong>La</strong> culla ha le corde spezzate, forse per un movimento<br />
troppo brusco ed il bambino è finito fuori d<strong>alla</strong> <strong>fine</strong>stra e giace morto sulla strada. A questo<br />
punto interviene il beato Agostino e lo resuscita. SIMONE MARTINI, Il beato Agostino<br />
Novello salva un bimbo caduto d<strong>alla</strong> culla, particolare <strong>del</strong>la Pala <strong>del</strong> Beato Agostino Novello,<br />
tempera su tavola, inizio <strong>del</strong> XIV secolo; Siena, Pinacoteca Nazionale. A. FRUGONI, C.<br />
FRUGONI, Storia di un giorno in una città medievale, Bari 1998, p. 124.<br />
16
al loro primo contatto con il mondo esterno 92 . Per i primi due anni di vita<br />
il bambino, infatti, era tenuto fasciato, le bende dovevano lasciare libere<br />
le braccia e essere sufficientemente larghe da permettete il flusso<br />
<strong>del</strong>l’urina, ma non di più. Si riteneva, infatti, che le fasce favorissero il<br />
corretto sviluppo <strong>del</strong>le membra <strong>del</strong> bambino 93 . <strong>La</strong> pratica di fasciare il<br />
bambino resistette fino al XVIII secolo ed era utilizzata da tutti i ceti.<br />
Nei primi quattro o cinque mesi di vita i neonati erano stretti da replicati<br />
giri di robusta fascia dai piedi fino al collo. Nei mesi successivi venivano<br />
liberate le braccia, continuando a tenere immobilizzate le gambe 94 .<br />
All’ospedale <strong>degli</strong> Innocenti, un balio riferì che il bambino di tre anni<br />
a lui affidato era caduto nel fuoco ed era morto carbonizzato; un’altra<br />
bimba morì annegata nel pozzo dove venivano lavati i panni 95 .<br />
Il “mal governo” <strong>del</strong>le balie non si limitava all’incuria: in qualche<br />
caso esse provocavano la morte <strong>del</strong> bambino mediante un precoce<br />
tentativo di svezzarli, dando loro alimenti che non erano in grado di<br />
digerire 96 .<br />
Come se non bastasse, Parma fu colpita da successive ondate di peste, a<br />
partire d<strong>alla</strong> metà <strong>del</strong> XIV secolo, <strong>del</strong>le quali una si verificò durante gli anni<br />
presi in considerazione. Tenendo conto <strong>del</strong>le limitazioni sopra riportate, la<br />
percentuale di decessi era compresa tra il 32 e il 50%. A parte i casi in cui i<br />
bambini furono addottati (5%), <strong>del</strong> restante 45% sappiamo solo che venne<br />
riportato all’ospedale. Il silenzio <strong>del</strong>la fonte viene interrotto solo dal già<br />
citato conto intestato a Domenego Biacho. In questo caso sappiamo che<br />
bimbo rientrò all’ospedale al termine <strong>del</strong> baliatico («...nominato Zohanne<br />
e fu de queli de caxa...»), nel 1483. Sucessivamente, caduto malato, fu<br />
ripreso (e mai più restituito) da Domenego nel 1485, quindi, durante i<br />
due anni intercorsi tra i due affidi il bambino era rimasto all’ospedale,<br />
probabilmente accudito dalle balie interne, certamente con altri bambini<br />
rientrati dal baliatico 97 . Considerando la breve durata di alcuni affidi e la<br />
scarsità dei casi in cui un bambino portava a termine l’intero baliatico<br />
presso una sola balia, si può supporre che una parte di essi morisse subito<br />
dopo il rientro in ospedale. Il manoscritto riporta un solo conto in cui è<br />
segnalato il motivo per il quale il bambino era riportato all ’ ospedale.<br />
Purtroppo il primo giugno 1487 Zohanne Antonio da Rezo riporta<br />
all’ospedale la piccola Maria Biancha, che sua moglie Catelina aveva preso<br />
a balia sette mesi prima, per ché Catelina era morta il giorno prima e<br />
92 HERLIHY, KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie cit., p. 230.<br />
93 Ibidem, p. 757.<br />
94 M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti <strong>del</strong>la famiglia in Italia dal XV al XX secolo,<br />
Bologna 2000, p. 337.<br />
95 PH. GAVITT, Charity and Children in Renaissance Florence. The Ospitali <strong>degli</strong> Innocenti, 1410-<br />
1536, Ann Arbour 1990, pp. 221-222.<br />
96 SANDRI, L’ospedale di Santa Maria <strong>del</strong>la Scala cit., p. 166.<br />
97 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 92 e Ms. Parm. 1629, c. 103.<br />
17
nessuno poteva più prendersi <strong>cura</strong> <strong>del</strong>la bambina: «Rexe la puta perché la<br />
dona sua morì» 98 .<br />
Altri furono, con molta probabilità, affidati ad altre balie sebbene non<br />
ne sia lasciata traccia. Ho provato a verificare questa ipotesi seguendo il<br />
destino di alcuni bambini a cui erano stati dati nomi poco comuni 99<br />
controllando se vi fosse una corrispondenza tra le date di restituzione da<br />
parte di una balia e la data di affido di un’altra che prese a balia un<br />
bambino che portava lo stesso nome. I casi descritti qui di seguito<br />
destano i maggiori sospetti.<br />
Il primo caso di corrispondenza <strong>del</strong>le date riguarda Madalena, che<br />
potrebbe aver cambiato tre balie. Il 21 febbraio 1482 un’esposta con<br />
questo nome fu affidata a Tomaxo Cagnola 100 , che la rese l’otto giugno<br />
<strong>del</strong>lo stesso anno; in questa stessa data Biatrixa Moranda 101 prese a balia<br />
una bambina chiamata Madalena, che riporterà il 21 luglio 1482, guarda<br />
caso, proprio il giorno in cui Cechino Canalo 102 portò a casa sua un’altra<br />
Madalena.<br />
Un altro caso riguarda Olivia, tolta dall’ospedale il quattro d’aprile <strong>del</strong><br />
1482 da Jacopo di Redolfi 103 e resa all’ospedale il 19 maggio 1482,<br />
identica data in cui a Catelina de Bernardi 104 fu affidata una bimba con lo<br />
stesso nome. Molti altri casi riportano qualche giorno di scarto tra la data<br />
di resa e quella di un nuovo affido per bambini che portano il medesimo<br />
nome, il che mi porta ad azzardare l’ipotesi che la registrazione <strong>del</strong><br />
passaggio di balia avvenisse solo nel caso in cui una nutrice cedesse il<br />
bambino ad un’altra il senza portarlo all’ospedale, e lo informassero in<br />
un secondo momento. Questo spiegherebbe il perché siano registrati cosi<br />
pochi passaggi di balia e perché ci siano così tanti affidi di breve durata,<br />
ma è soltanto un’ipotesi per la quale non ho trovato conferme. Pertanto<br />
nell’analisi dei dati ho considerato come passaggi di balia solo quelli<br />
segnalati chiaramente dal manoscritto.<br />
Un altro caso che lascia intravedere un passaggio di balia è quello di<br />
Cassandra, nome che compare solo due volte in tutto il registro, che<br />
utilizzerò per introdurre il discorso sullo svezzamento. <strong>La</strong> prima volta che<br />
una bimba chiamata Cassandra fu registrata era il 14 settembre 1484 e fu<br />
affidata a Domenegina Piaxentina 105 che la rese circa tre mesi più tardi, cioè<br />
il 1 gennaio 1485 106 . Il 2 gennaio <strong>del</strong>lo stesso anno una bambina con lo<br />
98 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, c. 153.<br />
99 I nomi più usati erano: per i bambini Zohanne o Zohanni, Filipo, Pedro; per 1e bambine<br />
Agnexa, Catelina, Ursolina.<br />
100 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 92 e Ms. Parm. 1629, cc. 33, 122, 158.<br />
101 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, c. 40.<br />
102 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, cc. 44, 158.<br />
103 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, cc. 34, 122, 158.<br />
104 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, c. 38.<br />
105 Ibidem, p. 93 e Ms. Parm. 1629, c. 98.<br />
106 Ibidem, p. 93 e Ms. Parm. 1629, c. 98.<br />
18
stesso nome fu affidata a Pelegrina de San Quilico di Mozzano 107 che la<br />
renderà all’ospedale il 1 agosto <strong>del</strong> 1486. Anche ammettendo che<br />
Cassandra fosse stata una neonata quando fu portata all’ospedale, avrebbe in<br />
ogni caso avuto circa due anni al termine <strong>del</strong>l’ultimo affido, quindi quasi<br />
si<strong>cura</strong>mente rientrò all’ospedale completamente svezzata ed in grado di<br />
mangiare normalmente. Lo svezzamento o “ispoppamento” era il processo<br />
mediante il quale le balie abituavano i bambini a mangiare le prime pappe e<br />
quindi passare, più o meno lentamente, da un’alimentazione di tipo liquido a<br />
base esclusiva di latte umano ad una di tipo misto, comprendente cibi solidi<br />
come pappe d’avena. Francesco da Barberino, vissuto all’inizio <strong>del</strong> XIV<br />
secolo, suggeriva <strong>alla</strong> nutrice che doveva svezzare un bambino, di<br />
cospargersi il seno con un liquido amaro, ma innocuo,<br />
contemporaneamente di cominciare a dare al bambino cibi molli o tritati,<br />
riservandosi di tornare al latte se il bimbo non riusciva a digerirli; come<br />
primo cibo solido, Barberino suggeriva un po ’ di pane misto a succo di<br />
mela o a latte, ad acqua, a qualche goccia di vino 108 .<br />
Paolo da Certalday nel 1370, dava queste direttive: «E no’ gli si vuole<br />
dare il primo anno altro che la poppa, e poi chomenciarli a dare cho’la<br />
poppa insieme de l’altre cose a mangiare a pocho a pocho» 109 . Nel suo<br />
studio sull’invio a balia dei figli dei fiorentini nel <strong>Quattrocento</strong>, la<br />
Klapisch-Zuber, indica come e media <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>lo svezzamento, per<br />
gli anni 1470-1530, diciotto mesi e mezzo per i maschi e sedici mesi e<br />
mezzo per le femmine 110 . Le bambine erano svezzate prima dei bambini,<br />
e come sempre subirono la scarsa attenzione che il secolo attribuiva loro:<br />
uno svezzamento anticipato poteva essere letale. Il sesso era si<strong>cura</strong>mente<br />
un fattore discriminante per il trattamento dei bambini, e in special modo<br />
alle bambine era attribuito un difetto dal punto di vista biologico e<br />
perfino da quello spirituale 111 . Ciò è testimoniato sin dal Trecento e ben<br />
si può darne un esempio attraverso le parole di Paolo da Certaldo: «Il<br />
fanciullo maschio pasci bene e vesti come puoi... <strong>La</strong> fanciulla femmina<br />
vesti bene, e come pasci non le cale, purché abbia sua vita, no la tenere<br />
troppo grassa» 112 . Lo svezzamento poteva durare uno o due mesi, ma<br />
poteva protrarsi anche fino a sei 113 . Gli statuti <strong>del</strong> comune di Pistoia <strong>del</strong><br />
1292, indicavano come durata ideale all’affido a balia tre anni, Paolo da<br />
II<br />
107 Ibidem, p. 92 e Ms. Parm. 1629, cc. 103, 132.<br />
108 FRANCESCO DA BARBERINO, Reggimento e costumi di donna, a <strong>cura</strong> di G. E.<br />
SANSONE, Torino 1957 (Collezione di “filologia Romanza”, 2). Cfr. HERLIHY,<br />
KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie cit., p. 758.<br />
109 PAOLO DE CERTALDO, Libro dei buoni costumi cit., p. 126. Cfr. HERLIHY,<br />
KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie cit., p. 758.<br />
110 KLAPISCH-ZUBER, <strong>La</strong> famiglia e le donne, cit., p. 241.<br />
111 HERLIHY, KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie cit., 761.<br />
112 PAOLO DE CERTALDO, Libro dei buoni costumi cit., p. 127. Cfr. HERLIHY,<br />
KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie cit., p. 761.<br />
113 Ibidem, p. 240.<br />
19
Certaldo due anni, ma comunque un periodo che comprendesse almeno<br />
un anno e qualche mese di <strong>alla</strong>ttamento e il periodo necessario allo<br />
svezzamento. Si può ipotizzare che, all’ospedale Rodolfo Tanzi di<br />
Parma, la durata <strong>del</strong> baliatico dei piccoli <strong>esposti</strong> fosse di tre anni: fino al<br />
compimento <strong>del</strong> terzo anno di età o comunque dopo tre anni<br />
dall’affidamento. <strong>La</strong> questione è dubbia, giacché il Benassi 114 interpretò<br />
la frase riportata in calce a una registrazione di un contratto di baliatico<br />
<strong>del</strong> 14... «Reddidit die ultimo Septembris, nam tempus annorum trium<br />
preterierat» 115 e la <strong>del</strong>iberazione fatta in data 18 ottobre 1493, in merito<br />
alle balie che avessero voluto tenere più a lungo i bambini che recita:<br />
«...si que ex baylis infantium spuriorum tenuerit et tenebit ipsos infantes<br />
ultra tempus trium annorum (de quo percipiunt singulo mense soldi<br />
viginti imperiales pro baliatura), quaod ultra dictorum trium annorum, si<br />
ipsis placebit tenere ipsos infantes, ut supra, habeant singulis tribus<br />
mensibus starium unum frumenti et non alium premium, nec pretium;<br />
...» 116 , come se i tre anni fossero riferiti all’età <strong>del</strong> bambino. A me sembra<br />
che i tre anni vadano, invece, interpretati come la durata massima per al<br />
quale la balia poteva essere pagata una lira al mese per l’affidamento,<br />
indipendentemente dall’età <strong>del</strong> bambino. Passati tre anni, il sussidio<br />
andava diminuito.<br />
A sostegno di questa ipotesi, il Manoscritto Parmense 1629 riporta il<br />
caso di Maria, una bimba per la quale nel contratto di affido si dice che<br />
«po habere mensi XVIII» e che fu affidata Masina <strong>del</strong> Polo nel 1482; la<br />
balia la terrà per due anni e tre mesi, quindi al momento <strong>del</strong>la resa Maria<br />
doveva avere quasi quattro anni, ma il salario <strong>del</strong>la balia resta di una lira<br />
al mese per tutto il baliatico 117 . In un altro caso, Pedra de Gambano da<br />
Felegara tenne una bimba per quattro anni prima di renderla all’ospedale<br />
e il suo salario restò di una lira per tutti i quattro anni 118 . Sembrano<br />
esserci dunque soluzioni diverse; più probabilmente l’ospedale<br />
considerava i casi singolarmente e decideva secondo le necessità e può<br />
essere che prima <strong>del</strong> 1493, anno <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera sopra riportata, non avesse<br />
una politica ben definita a riguardo.<br />
Esaminando i bambini che restarono affidati ad una sola balia per un<br />
periodo di tempo superiore ad un anno, mi sono accorta, che nella<br />
stragrande maggioranza dei casi questi affidi si conclusero con un’adozione<br />
vera e propria, definita d<strong>alla</strong> formula «10 tolse pro Piolo» o «fiola». Inoltre<br />
in un altro foglio <strong>del</strong> Manoscritto Parmense 1626 si trova un’altra<br />
<strong>del</strong>ibera 119 <strong>del</strong> 1492, in cui si auspicava l’adozione dei trovatelli da parte di<br />
114 BENASSI, Storia di Parma cit., p. 39.<br />
115 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 96 e Ms. Parm. 1626, c. 267.<br />
116 Ibidem, p. 96 e Ms. Parm. 1626, c. 263.<br />
117 Ibidem, p. 96 e Ms. Parm. 1629, cc. 37, 62, 89.<br />
118 Ibidem, p. 96 e Ms. Parm. 1629, c. 127.<br />
119 Ibidem, p. 97 e Ms. Parm. 1626, c. 293.<br />
20
«bone persone» e per favorirla l’ospedale forniva agli adottanti staia di<br />
frumento o altri doni. Si possono, dunque, ipotizzare due destini per i<br />
bambini che fossero sopravvissuti al baliatico, il primo era di restare<br />
nella fa, miglia <strong>del</strong>la balia che li aveva allevati, ma come “ospiti<br />
paganti”: l’ospedale forniva a queste balie «singulis tribus mensibus<br />
starium et non ali premium, nec pretium; adeo quod in capite unius anni<br />
habere possin staria quattruor frumenti et non ultra, ut supra, pro dicta<br />
tenuta et ultra dictos tres annos, ut supra», ed una volta raggiunta un’età<br />
idonea al lavoro, rientravano all’ospedale. <strong>La</strong> seconda possibilità era<br />
quella di esse adottati d<strong>alla</strong> balia o da qualcun altro, e in questo caso i<br />
genitori adottivi almeno nei casi che ho censito e che si riferiscono a<br />
prima <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 1492 che assegnava 3 o 4 stari di frumento,<br />
potevano scegliere il dono che fosse più consono alle loro esigenze. Gli<br />
affidi più lunghi, infatti si conclusero quasi tutti con l’adozione<br />
<strong>del</strong>l’esposto da parte <strong>del</strong>la farri glia dei bali e in questo caso sono<br />
applicate regole diverse, perché non si trattava di un semplice affido, ma<br />
di vere e proprie adozioni registrate innanzi ad un notaio.<br />
In tutto il Manoscritto 1629 ho trovato 22 annotazioni riguardanti le<br />
adozioni. Di queste, 11 si riferiscono a bambini dati in affido prima che il<br />
Manoscritto Parmense cominci le sue registrazioni, per questo<br />
possediamo solo il nome <strong>del</strong>le balie e la data di adozione e qualche<br />
sporadica annotazione. Ad esempio, sappiamo che Antonia da Cozzano<br />
adottò il 15 ottobre 1482 una bambina che aveva avuto a balia, ma che<br />
non smise la sua attività di nutrice; infatti, prende a balia altri due<br />
bimbi 120 . <strong>La</strong> medesima cosa accade a Zohanna di Marco Giarola, che<br />
dopo aver adottato un bimbo di cui non sappiamo niente prese a balia<br />
un altro bimbo e un’altra bimba 121 .<br />
Di un’altra bimba, di cui sappiamo solo la data di adozione, i rettori<br />
annotarono che fu adottata da Polo Carbognano, fratello <strong>del</strong> suo balio<br />
Vincenzo 122 . Anche un’altra bimba di cui è noto solo il nome, Lucia, non<br />
fu adottata dai suoi bali, ma da altra persona di cui conosciamo il nome<br />
Mato da Mobriano 123 . Invece, Zohannina di Gabriele Martino adottò una<br />
bimba, di cui era nutrice, il 1 gennaio 1483, e spiegò ai rettori che la teneva<br />
perché malata; forse la malattia <strong>del</strong>la bambina l’aveva intenerita a tal<br />
punto da suscitarne l’istinto materno 124 . <strong>La</strong> formula con cui i compilatori<br />
annotavano una adozione nel registro era: «lo tolse pro fiola o fiolo» e a<br />
volte era aggiunto «con consenso de li domini Rettori» 125 .<br />
120 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, cc. 21, 38, 43, 68.<br />
121 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, cc. 22, 60, 80, 82, 95, 98, 109, 129, 162.<br />
122 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, cc. 58, 88, 109.<br />
123 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, cc. 91.<br />
124 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, cc. 56, 58, 128, 162<br />
125 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, c. 130.<br />
21
Altre due adozioni sarebbero rimaste misconosciute, se non avessi<br />
trovato, tra gli atti <strong>del</strong> notaio Gasparo Dal Prato 126 , rogatore<br />
<strong>del</strong>l’ospedale durante tutto il periodo preso in considerazione, i<br />
rispettivi atti ufficiali di adozione, che mi hanno permesso di integrare<br />
le scarse informazioni <strong>del</strong> Manoscritto Parmense 1629. Il primo è il<br />
contratto di adozione stipulato il 13 dicembre 1483, da Vesconto dei<br />
Ghibellini, figlio di Battista Antonioli e abitante a Bogolese, che, <strong>alla</strong><br />
presenza dei massari <strong>del</strong>l’ospedale, si impegnò a prendere «pro sua<br />
filia» e a nutrire da quel momento in poi, la piccola Domenica che sua<br />
moglie aveva tenuto a balia dal 1482 127 . Il secondo contratto, che<br />
utilizza un formulario molto simile a quello citato in precedenza, ma<br />
più completo, riguarda l’adozione <strong>del</strong>la piccola <strong>La</strong>zarina. L’8 maggio<br />
1484 Maria, figlia <strong>del</strong> fu Johannino de Fachino, moglie di Jacopino dei<br />
Fiori, si impegnò <strong>alla</strong> presenza dei rettori <strong>del</strong>l’ospedale a trattare<br />
<strong>La</strong>zarina come se fosse sua figlia, ora e in futuro; inoltre si impegnò,<br />
quando sarebbe giunto il momento di maritarla, a dotarla (non è<br />
specificato l ’ ammontare <strong>del</strong>la dote). L ’ ospedale in cambio si impegnava<br />
a darle le quattro lire che ancora doveva ricevere, metà a Ferragosto e<br />
metà a Natale. Delle altre adozioni non ho trovato i contratti di affido,<br />
ma il manoscritto è abbastanza ricco di informazioni: in 7 contratti<br />
altrettanti <strong>esposti</strong> maschi furono adottati dalle rispettive balie, che<br />
provenivano tutte dal contado. In 3 di questi casi le balie adottarono i<br />
bambini dopo più di tre anni d<strong>alla</strong> data di affido, due dopo due anni,<br />
una dopo sei mesi e una dopo soli diciotto giorni (di una non<br />
conosciamo la data di affido, ma si può ipotizzare che l’avesse tenuto<br />
per almeno due anni). Gli altri 2 casi riguardano bambine, entrambe<br />
adottate dalle rispettive balie esterne, provenienti dal contado, dopo due<br />
anni d<strong>alla</strong> data di affido.<br />
Generalmente, a tutti coloro che prendevano in affido un ’ esposto,<br />
l’ospedale forniva un sussidio: frumento, soldi, perfino tre braccia di panno<br />
grigio. Ad esempio ecco cosa è stato dato a Isabetta de Pedrello al<br />
momento <strong>del</strong>l’adozione: «Nota como Pedrello suprascritta tolse la pota<br />
per fiola e fu adi 25 de marzo, como appare per instrumento rogato per Ser<br />
Gasparo dal Pra e li fu dato soldi quattro in dinari e braza tre in sussidio de<br />
panno bruno» 128 .<br />
Nel caso <strong>del</strong>le adozioni non possiamo fare a meno di notare che il ben<br />
documentato sfavore a cui andavano incontro le bambine al momento<br />
<strong>del</strong>la loro nascita non inficiava la loro possibilità di essere adottate. Su 22<br />
casi di adozione da me riscontrati nel Manoscritto Parmense 1629, ben<br />
126 Ibidem, p. 98 e Ms. Parm. 1629, c. 110: «Ser Gasparo dal Pra pro<strong>cura</strong>tore <strong>del</strong>o<br />
hospitale»; lo stipendio da pro<strong>cura</strong>tore era di L. 16 all ’ anno.<br />
127 Ibidem, p. 98 e Archivio di Stato di Parma, Notarile, E 225. Inoltre Ms Parm.<br />
1629, c. 130.<br />
128 Ibidem, p. 99 e Ms. Parm. 1629, c. 105.<br />
22
13 riguardavano bambine, mentre solo 7 sono quelle dei bambini. Come<br />
si vede, le adozioni riguardanti bambine erano circa il doppio rispetto a<br />
quelle dei maschi; il sesso, quindi, non era penalizzante al momento<br />
<strong>del</strong>l ’ adozione, nonostante l’onnipresenza <strong>del</strong>la richiesta di fornire una dote<br />
alle bambine, una volta raggiunta l’età <strong>del</strong> matrimonio. Anche all’ospedale<br />
<strong>degli</strong> Innocenti di Firenze le bambine non erano penalizzate dal loro sesso<br />
al momento <strong>del</strong>l’adozione. <strong>La</strong> preferenza ad abbandonare le bimbe è<br />
evidente anche agli Innocenti, inoltre il Gavitt fa notare che nei casi in<br />
cui i bimbi furono restituiti ai genitori naturali, essi erano<br />
prevalentemente maschi nella proporzione di 1 bambina ogni 3 maschi<br />
circa 129 . Evidentemente una bimba già cresciuta poteva in ogni caso essere<br />
molto utile, soprattutto per la <strong>cura</strong> <strong>del</strong>la casa. Inoltre bisogna considerare<br />
che essendo più alto il loro numero all’interno <strong>del</strong>la struttura ospedaliera,<br />
era probabile che le bambine che sopravvivessero agli anni<br />
<strong>del</strong>l’<strong>alla</strong>ttamento fossero in proporzione più numerose rispetto ai maschi<br />
e, proporzionalmente, più disponibili all’adozione, In ultimo, dato che la<br />
maggior parte dei genitori adottivi nominati dal libro dei conti<br />
<strong>del</strong>l’ospedale Tanzi si rivelano essere gli stessi bali che avevano avuto <strong>cura</strong><br />
dei bambini durante l’<strong>alla</strong>ttamento, si può supporre che si fosse instaurato<br />
un rapporto affettivo, che prescindeva dal sesso <strong>del</strong>l’esposto.<br />
Nulla o quasi sappiamo di come vivessero i bambini che, dopo aver<br />
concluso il loro soggiorno presso una balia, rimanevano all’ospedale. Le<br />
uniche informazioni ci vengono dal registro dei conti tenuto<br />
dall’ospedale nel 1550. Il manoscritto ci dice che, quando gli <strong>esposti</strong><br />
raggiungevano un ’ età sufficiente, erano mandati come famigli presso<br />
fattorie fuori città, oppure nella bottega <strong>degli</strong> artigiani parmensi. Nel<br />
1550 gli <strong>esposti</strong> mandati nelle fattorie <strong>del</strong> contado furono 31, mentre 21<br />
restarono in città. Di questi la maggior parte erano impiagati presso<br />
tessitori di lana (7) e presso calzolai (5) e i restanti trovatelli si dividevano<br />
tra ciabattini, tessitori di tela e sarti 130 .<br />
Lo stesso libro mastro 1632 ci informa che nel 1549, l’ospedale fornì<br />
la dote a tre fanciulle <strong>del</strong>l’ospedale (una di loro ricevette in dote 100 lire<br />
imperiali 131 ).<br />
Le informazioni sopra riportate si riferiscono a più di cinquanta anni<br />
dopo il manoscritto oggetto di studio, per cui non vanno ritenute valide<br />
anche per gli anni <strong>alla</strong> <strong>fine</strong> <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong>, facendo l’errore di<br />
attribuire ad un’epoca antecedente le usanze di una successiva.<br />
Tuttavia, se dall ’ ospedale di Parma ci spostiamo in altre città <strong>del</strong>l ’ Italia<br />
centro settentrionale, troviamo che le strutture qui preposte <strong>alla</strong> gestione<br />
<strong>del</strong>l’infanzia abbandonata nel <strong>Quattrocento</strong> risolsero il problema dei<br />
129 GAVITT, Charity and Children cit., p. 204 e ss.<br />
130 MINOLI, “Debe esser morto” cit., p. 101 e BP, Ms. Parmense 1631 (aa. 1548-1555),<br />
ripreso da BENASSI, Storia di Parma cit., p. 40.<br />
131 Ibidem, p. 40.<br />
23
ambini non adottati in maniera non dissimile da come farà l ’ ospedale<br />
Rodolfo Tanzi nel XVI secolo.<br />
Alla <strong>fine</strong> <strong>del</strong> XV secolo, l ’ ospedale <strong>degli</strong> Innocenti di Firenze<br />
mandava a lavorare fuori dall’ospedale sia i fanciulli che le fanciulle,<br />
quando questi avevano raggiunto i cinque o sei anni 132 . I maschi erano<br />
affidati ad artigiani, perché imparassero il mestiere e non solo, mentre i<br />
maestri artigiani Fiorentini si impegnavano a trattarli bene. Le bambine<br />
erano mandate a servizio in case di personaggi benestanti, o impiegate<br />
come operaie presso le manifatture <strong>del</strong>la seta, privilegiando i contratti di<br />
apprendistato che richiedevano la residenza dei fanciulli nelle case <strong>degli</strong><br />
artigiani. Patrizia Mainoni ci dà la definizione di questi contratti:<br />
«L ’ apprendistato costituisce uno dei tratti più caratteristici <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong><br />
mondo medievale: il garzone veniva collocato dal padre, d<strong>alla</strong> madre, o<br />
dal tutore presso un maestro artigiano per imparare il mestiere e<br />
conviveva con la famiglia <strong>del</strong> datore di lavoro per un periodo di più anni,<br />
concordato a seconda <strong>del</strong>le consuetudini...» 133<br />
Nei primi anni <strong>del</strong>la loro creazione e fino <strong>alla</strong> <strong>fine</strong> <strong>del</strong> XV secolo, a<br />
differenza di quello che succederà nei secoli futuri, l’ospedale si prendeva<br />
<strong>cura</strong> dei bambini abbandonati e cercava da subito di inserirli in un contesto<br />
familiare 134 . Quando l ’ ospedale descriveva se stesso e i suoi bambini come<br />
«tutta la famiglia», non faceva un mero esercizio di retorica: gli addetti agli<br />
<strong>esposti</strong> si comportavano come genitori, spingendo i bambini a<br />
partecipare sia <strong>alla</strong> vita interna <strong>del</strong>l’istituzione sia a quella civica.<br />
L ’ inserimento dei bambini nelle famiglie artigiane e contadine nella<br />
seconda metà <strong>del</strong> XV secolo era facilitato d<strong>alla</strong> diminuzione <strong>del</strong>la<br />
popolazione causata dalle ricorrenti pestilenze che, sin dal secolo<br />
precedente si erano abbattute sulla penisola e su tutta l’Europa: «Dopo<br />
tre secoli circa di crescita <strong>del</strong>la popolazione il XIV e il XV secolo si<br />
caratterizza da una forte crisi demografica. Tra l’inizio <strong>del</strong> Trecento e la<br />
metà <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong> l ’ Europa occidentale avrebbe perduto circa il<br />
30% dei suoi abitanti (da 70 a 50 milioni); in Italia il calo fu ancora più<br />
forte, nell’ordine <strong>del</strong> 40% (da 12,5 a 7,5 milioni circa)» 135 . <strong>La</strong> peste,<br />
arrivata a bordo di vascelli provenienti dall’oriente nei porti<br />
mediterranei, trovò la popolazione europea impreparata dal punto di<br />
vista immunologico: l’ultima epidemia di peste risaliva al VI secolo.<br />
Non solo, la forte pressione demografica <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong> XIV secolo<br />
inasprì gli effetti <strong>del</strong>le cicliche crisi di sussistenza che si verificarono<br />
132 L. SANDRI, Fanciulli e Fanciulle posti con altri all’ospedale <strong>degli</strong> innocenti di Firenze: note<br />
per una storia <strong>del</strong> lavoro minorile nella seconda metà <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong>, in G. DA MOLIN (a<br />
<strong>cura</strong> di), Senza famiglia: mo<strong>del</strong>li demografici e sociali <strong>del</strong>l’infanzia abbandonata e <strong>del</strong>l ’ assistenza in<br />
Italia, secc. XV-XX, Bari 1997, p. 237.<br />
133 P. MAINONI, <strong>La</strong> produzione urbana, in <strong>La</strong> società medievale cit., p. 364.<br />
134 GAVITT, Charity and Children cit., p. 243 e ss.<br />
135 PENTO, Il numero <strong>degli</strong> uomini cit., pp. 19-20.<br />
24
dall’ultimo quarto <strong>del</strong> Duecento. <strong>La</strong> sottoalimentazione rese la<br />
popolazione ancora più debole, soprattutto i vecchi e i bambini 136 .<br />
Questo fece in modo che, nel <strong>Quattrocento</strong>, i bambini abbandonati<br />
assumessero un valore non solo economico, ma anche emotivo. I<br />
contratti di adozione e/o di apprendistato concordano che i trovatelli<br />
debbano essere trattati come figli 137 .<br />
Intorno <strong>alla</strong> metà <strong>del</strong> XV secolo si avvertirono i primi segnali di<br />
ripresa <strong>del</strong>la crescita demografica, che proseguirà fino al XVII secolo. Alla<br />
metà <strong>del</strong> Cinquecento molte città italiane avevano quasi raggiunto i livelli di<br />
popolamento riscontrabili nella prima metà <strong>del</strong> XIV secolo 138 . A questo<br />
punto i trovatelli non erano più così richiesti e le loro possibilità di venire<br />
inseriti in una famiglia diminuirono. Questo portò gli ospedali ad una<br />
trasformazione: da sistemazione provvisoria, l’ospedale ormai assunse<br />
il carattere di residenza permanente. Sia i ragazzi, sia le ragazze, nella<br />
maggior parte, uscivano la mattina dall’ospedale e vi rientravano la<br />
sera; infatti, se <strong>alla</strong> metà <strong>del</strong> <strong>Quattrocento</strong>, si preferiva collocarli presso il<br />
maestro o la casa che dava loro un lavoro, quarant’anni dopo questa<br />
soluzione non era più attuabile: «I fiorentini non vogliono più, o<br />
desiderano molto meno, i loro trovatelli in casa, né intendono più<br />
salvaguardare l’onore <strong>del</strong>le fanciulle, <strong>del</strong> resto così poco sicuro, tra le<br />
mura domestiche, preferendo di gran lunga ora, la reclusione <strong>del</strong>le<br />
femmine e il lavoro pendolare dei maschi» 139 .<br />
Le adozioni diminuirono, e aumentarono i “figli <strong>del</strong>l’ospedale”,<br />
facilmente riconoscibili dal cognome che portavano: a Firenze ai bambini<br />
veniva imposto il cognome “Innocenti”. I bambini allevati presso<br />
l’ospedale Rodolfo Tanzi prendevano da lui il cognome, fino al 1812,<br />
quando, per evitare che i bambini soffrissero a causa di un cognome che il<br />
designava come “bastardi”, una disposizione ministeriale obbligò l’ospedale<br />
a non chiamare più Tanzi i piccoli orfanelli, ma di mettere loro un cognome<br />
a caso 140 .<br />
136 Ibidem, p. 20.<br />
137 GAVITT, Charity and Children cit., p. 239.<br />
138 PINTO, Il numero <strong>degli</strong> uomini cit., p. 25.<br />
139 GAVITT, Charity and Children cit., p. 240.<br />
140 T. TOMMASINI, Alcune parole sull’esposizione de’ bambini in Parma, Parma 1867, p<br />
21.<br />
25