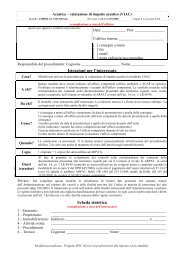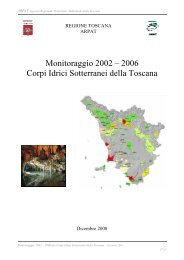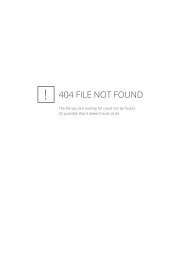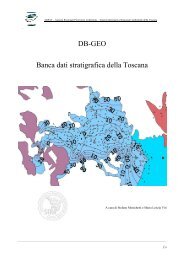005 - presentazione della tesi - Arpat
005 - presentazione della tesi - Arpat
005 - presentazione della tesi - Arpat
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA<br />
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI<br />
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA APPLICATA<br />
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON<br />
PERICOLOSI “LE MACCHIAIE” (Sinalunga, SI):<br />
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE<br />
EMISSIONI NELLE MATRICI ACQUA ED ARIA<br />
Relatore: Prof. Enrico GUASTALDI<br />
Correlatori: Dott. Geol. Alessandro BECATTI<br />
Prof. Leonardo DISPERATI<br />
Tesi di laurea di:<br />
Marilena TROTTA<br />
Anno Accademico 2007/2008
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 2
1. Obiettivi<br />
OBIETTIVI<br />
‣ Studio del quadro<br />
normativo<br />
‣ Rilevamento geologico di<br />
dettaglio<br />
‣ Campionamenti delle<br />
matrici acqua, biogas e<br />
percolato<br />
‣ Nuova base cartografica<br />
geologica<br />
STAGE<br />
‣ Analisi chimica di<br />
laboratorio<br />
‣ Controllo <strong>della</strong> qualità<br />
dell’aria<br />
‣ Analisi statistica univariata e<br />
multivariata<br />
‣ Analisi geostatistica<br />
‣ Campagna di misurazione<br />
delle emissioni fuggitive<br />
‣ Valutazione dei risultati<br />
‣ Considerazioni sul particolare<br />
chimismo delle acque<br />
22 luglio 2008 3
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 4
2. Inquadramento<br />
INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO<br />
1° Recettore Sensibile
2. Inquadramento<br />
INQUADRAMENTO GEOLOGICO<br />
‣ Zona a morfologia collinare<br />
‣ Margine Occidentale del Bacino <strong>della</strong><br />
Valdichiana<br />
Discarica<br />
‣ Pendici dei rilievi <strong>della</strong> Dorsale<br />
Rapolano-Trequanda-Monte Cetona<br />
Dorsale Rapolano – Trequanda – Monte Cetona. Modificata da:<br />
22 (Aquè luglio R; 2008 Brogi A, 2002)<br />
6
2. Inquadramento<br />
STRATIGRAFIA DELL’AREA<br />
‣ Depositi alluvionali (Quaternario)<br />
• Alluvioni attuali, recenti e colluvi: ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali<br />
attuali e delle aree di esondazione (b);<br />
‣ Depositi marini (Pliocene superiore - Pleistocene)<br />
• Sintema <strong>della</strong> Valdichiana:<br />
• sub-sintema di Bettolle<br />
• ciottolami e sabbie di Podere Mulinello (e1);<br />
• Sintema del Bacino di Siena:<br />
• sub-sintema di Poggigialli<br />
• sabbie di Podere Colombaiolo (f2), con livelli di ciottolami poligenici (f3) e argille<br />
scure con cristalli di gesso (f4);<br />
• sub-sintema di Guazzino<br />
• argille di fornace Monte Martino (g);<br />
‣ Falda Toscana, successione dei Monti del Chianti<br />
• Macigno (MAC);<br />
• Gruppo <strong>della</strong> Scaglia Toscana:<br />
• Argilliti e calcareniti di Dudda (STO3).<br />
22 luglio 2008 7
2. Inquadramento<br />
STRATIGRAFIA DELL’AREA<br />
‣ Depositi alluvionali (Quaternario)<br />
• Alluvioni attuali, recenti e colluvi: ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali<br />
attuali e delle aree di esondazione (b);<br />
‣ Depositi marini (Pliocene superiore - Pleistocene)<br />
• Sintema <strong>della</strong> Valdichiana:<br />
• sub-sintema di Bettolle<br />
• ciottolami e sabbie di Podere Mulinello (e1);<br />
• Sintema del Bacino di Siena:<br />
• sub-sintema di Poggigialli<br />
• sabbie di Podere Colombaiolo (f2), con livelli di ciottolami poligenici (f3) e argille<br />
scure con cristalli di gesso (f4);<br />
• sub-sintema di Guazzino<br />
• argille di fornace Monte Martino (g);<br />
‣ Falda Toscana, successione dei Monti del Chianti<br />
• Macigno (MAC);<br />
• Gruppo <strong>della</strong> Scaglia Toscana:<br />
• Argilliti e calcareniti di Dudda (STO3).<br />
MAC<br />
MAC<br />
22 luglio 2008 8
2. Inquadramento<br />
STRATIGRAFIA DELL’AREA<br />
‣ Depositi alluvionali (Quaternario)<br />
• Alluvioni attuali, recenti e colluvi: ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali<br />
attuali e delle aree di esondazione (b);<br />
‣ Depositi marini (Pliocene superiore - Pleistocene)<br />
• Sintema <strong>della</strong> Valdichiana:<br />
• sub-sintema di Bettolle<br />
• ciottolami e sabbie di Podere Mulinello (e1);<br />
• Sintema del Bacino di Siena:<br />
• sub-sintema di Poggigialli<br />
• sabbie di Podere Colombaiolo (f2), con livelli di ciottolami poligenici (f3) e argille<br />
scure con cristalli di gesso (f4);<br />
• sub-sintema di Guazzino<br />
• argille di fornace Monte Martino (g);<br />
‣ Falda Toscana, successione dei Monti del Chianti<br />
• Macigno (MAC);<br />
• Gruppo <strong>della</strong> Scaglia Toscana:<br />
• Argilliti e calcareniti di Dudda (STO3).<br />
f 2 f 2 f 2<br />
22 luglio 2008 9
2. Inquadramento<br />
STRATIGRAFIA DELL’AREA<br />
‣ Depositi alluvionali (Quaternario)<br />
• Alluvioni attuali, recenti e colluvi: ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali<br />
attuali e delle aree di esondazione (b);<br />
‣ Depositi marini (Pliocene superiore - Pleistocene)<br />
• Sintema <strong>della</strong> Valdichiana:<br />
• sub-sintema di Bettolle<br />
• ciottolami e sabbie di Podere Mulinello (e1);<br />
• Sintema del Bacino di Siena:<br />
• sub-sintema di Poggigialli<br />
• sabbie di Podere Colombaiolo (f2), con livelli di ciottolami poligenici (f3) e argille<br />
scure con cristalli di gesso (f4);<br />
• sub-sintema di Guazzino<br />
• argille di fornace Monte Martino (g);<br />
‣ Falda Toscana, successione dei Monti del Chianti<br />
• Macigno (MAC);<br />
• Gruppo <strong>della</strong> Scaglia Toscana:<br />
• Argilliti e calcareniti di Dudda (STO3).<br />
f 3 f 3<br />
22 luglio 2008 10
2. Inquadramento<br />
STRATIGRAFIA DELL’AREA<br />
‣ Depositi alluvionali (Quaternario)<br />
• Alluvioni attuali, recenti e colluvi: ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali<br />
attuali e delle aree di esondazione (b);<br />
‣ Depositi marini (Pliocene superiore - Pleistocene)<br />
• Sintema <strong>della</strong> Valdichiana:<br />
• sub-sintema di Bettolle<br />
• ciottolami e sabbie di Podere Mulinello (e1);<br />
• Sintema del Bacino di Siena:<br />
• sub-sintema di Poggigialli<br />
• sabbie di Podere Colombaiolo (f2), con livelli di ciottolami poligenici (f3) e argille<br />
scure con cristalli di gesso (f4);<br />
• sub-sintema di Guazzino<br />
• argille di fornace Monte Martino (g);<br />
‣ Falda Toscana, successione dei Monti del Chianti<br />
• Macigno (MAC);<br />
• Gruppo <strong>della</strong> Scaglia Toscana:<br />
• Argilliti e calcareniti di Dudda (STO3).<br />
f 4<br />
f 4 f 4<br />
22 luglio 2008 11
2. Inquadramento<br />
Sez. 298130<br />
Sez. 309010<br />
22 luglio 2008 12<br />
Carta geologica dell’area di studio (sistema di proiezione UTM WGS84 fuso 32N)
2. Inquadramento<br />
Sezioni geologiche relative ai sondaggi geognostici eseguiti tra Agosto 1991 e Febbraio 1992 per il progetto di risanamento ambientale e ampliamento <strong>della</strong> discarica
2. Inquadramento<br />
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO<br />
‣ Ubicazione <strong>della</strong> discarica all’interno di una piccola valle<br />
‣ Presenza di una falda idrica superficiale con direzione di flusso<br />
WSW-ENE<br />
‣ Aspetto quantitativo e qualitativo <strong>della</strong> falda<br />
‣ Non si rilevano sostanziali modifiche sugli equilibri idrogeologici<br />
Carta dell’andamento piezometrico ottenuta dalle misure piezometriche effettuate durante questo lavoro di <strong>tesi</strong> in data 13 febbraio 2008 nei pozzi e<br />
piezometri interni ed esterni all’impianto.<br />
22 luglio 2008 14
2. Inquadramento<br />
Fosso Barlato<br />
Fosso Maglione<br />
22 luglio 2008 15<br />
Carta geologica dell’area di studio (sistema di proiezione UTM WGS84 fuso 32N)
2. Inquadramento<br />
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO<br />
‣ Ubicazione <strong>della</strong> discarica all’interno di una piccola valle<br />
‣ Presenza di una falda idrica superficiale con direzione di flusso<br />
WSW-ENE<br />
‣ Aspetto quantitativo<br />
‣ Non si rilevano sostanziali modifiche sugli equilibri idrogeologici<br />
Carta dell’andamento piezometrico ottenuta dalle misure piezometriche effettuate durante questo lavoro di <strong>tesi</strong> in data 13 febbraio 2008 nei pozzi e<br />
piezometri interni ed esterni all’impianto.<br />
22 luglio 2008 16
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 17
3. Quadro normativo di riferimento<br />
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />
22 luglio 2008 18
3. Quadro normativo di riferimento<br />
Classificazione delle<br />
discariche secondo il<br />
D.P.R. 1982 (Rifiuti<br />
ammissibili allo<br />
smaltimento)<br />
22 luglio 2008 19
3. Quadro normativo di riferimento<br />
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />
22 luglio 2008 20
3. Quadro normativo di riferimento<br />
Classificazione delle<br />
discariche secondo il<br />
D.Lgs. 36/2003<br />
(Tipologia del rifiuto<br />
smaltito)<br />
22 luglio 2008 21
3. Quadro normativo di riferimento<br />
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />
22 luglio 2008 22
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 23
4. Scelte progettuali<br />
SCELTE PROGETTUALI<br />
Capienza: 240.000 m 3 Capienza: 399.000 m 3<br />
Pianta dell’attuale discarica controllata per rifiuti non pericolosi di “Le Macchiaie” Sinalunga (SI) (modificata da (Sienambiente,<br />
2<strong>005</strong>)).
4. Scelte progettuali<br />
SCELTE PROGETTUALI<br />
Primo stralcio con copertura definitiva e ripristino ambientale (foto del 9 Giugno<br />
2008, scattata verso sud est)<br />
Secondo stralcio in coltivazione (foto del 9 Giugno 2008, scattata verso sud)<br />
22 luglio 2008 25
4. Scelte progettuali<br />
SCELTE PROGETTUALI<br />
(40 cm)<br />
(40 cm)<br />
(1 m)<br />
Silos di stoccaggio del percolato<br />
Impermeabilizzazione di fondo con rivestimento composito doppio<br />
Vasca di stoccaggio del percolato<br />
Pozzetti per i campionamenti delle acque di drenaggio <strong>della</strong> falda<br />
22 luglio 2008 26
4. Scelte progettuali<br />
SCELTE PROGETTUALI<br />
Stazione di regolazione <strong>della</strong> depressione dei pozzi di captazione del biogas<br />
Torcia per la combustione<br />
del biogas<br />
Testa di pozzo<br />
22 luglio 2008 27
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 28
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO<br />
FINALITÀ PRIMARIE:<br />
‣ Raccolta dei dati ambientali richiesti dalla normativa IPPC<br />
‣ Valutazione di conformità delle emissioni rispetto ai limiti<br />
emissivi prescritti<br />
COSTITUITO DA DUE PARTI:<br />
‣ Controlli a carico del gestore<br />
‣ Ispezioni a carico dell’Autorità preposta al controllo<br />
Attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che deve essere la<br />
componente principale del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
ISPEZIONI A CARICO DELL’AUTORITÀ PREPOSTA AL CONTROLLO<br />
Periodo Attività Previsto da<br />
19/20 Luglio 2007<br />
07 Dicembre 2007<br />
13/14 Febbraio 2008<br />
29 Febbraio 2008<br />
07 Luglio 2008<br />
Campionamento:<br />
• acque di drenaggio<br />
• acque dei pozzi di monitoraggio <strong>della</strong> falda,<br />
• acque di drenaggio infratelo<br />
• percolato<br />
Monitoraggio:<br />
• qualità dell’aria<br />
Campionamento:<br />
• acque di drenaggio<br />
• acque dei pozzi di monitoraggio <strong>della</strong> falda,<br />
• acque di drenaggio infratelo<br />
• percolato<br />
Campionamento:<br />
• biogas in ingresso alla torcia<br />
Monitoraggio:<br />
• emissioni fuggitive di biogas dalla copertura <strong>della</strong> discarica<br />
Cronologia dell'attività sperimentale eseguita in discarica<br />
PMeC 2007<br />
PMeC 2007<br />
PMeC 2008<br />
PMeC 2008<br />
PMeC 2008<br />
22 luglio 2008 30
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Campionamento del percolato del 1° Stralcio direttamente alla tubazione di adduzione alla vasca di stoccaggio
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Linea di campionamento allestita<br />
Particolare <strong>della</strong> trappola per l’umidità<br />
Campionamento del percolato del biogas alla torcia
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Misura delle emissioni<br />
fuggitive con<br />
flussimetro con camera<br />
di accumulo<br />
Misura delle emissioni<br />
fuggitive con GA2000<br />
Interno <strong>della</strong> valigia contenente il misuratore<br />
di flussi<br />
Camera di accumulo<br />
Gas Analyser 2000
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Campionamenti di acqua di drenaggio e dei pozzi di monitoraggio <strong>della</strong> falda effettuati il 19/20-07-07 e il 13/14-02-08
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Mappa dei punti di campionamento rappresentati con un triangolo e la sigla<br />
corrispondente (sistema di proiezione UTM WGS84 fuso 32N)<br />
Campionamento delle acque di<br />
drenaggio <strong>della</strong> falda al pozzetto<br />
Sorgente Acquapassante<br />
(foto di febbraio 2008)<br />
Fosso Maglione (foto di febbraio 2008)
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
“SME” DELLA DISCARICA DI “LE MACCHIAIE”<br />
Rifiuti:<br />
‣ In ingresso<br />
‣ In uscita<br />
Misura del livello piezometrico tramite freatimetro<br />
Emissioni in<br />
aria:<br />
‣ Qualità dell’aria<br />
‣ Convogliate<br />
‣ Diffuse<br />
• Fuggitive<br />
Misurazione di pH, conducibilità, potenziale redox e<br />
temperatura<br />
Emissioni in<br />
acqua:<br />
‣ Acque superficiali<br />
‣ Acque sotterranee<br />
Suddivisione del campione in aliquote<br />
Condizionamento delle aliquote
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
ISPEZIONI A CARICO DELL’AUTORITÀ PREPOSTA AL<br />
CONTROLLO<br />
CONDIZIONAMENTI<br />
• Aliquota A - Tal quale in bottiglia in vetro da 1L<br />
• Aliquota B - Condizionata con 5mL/L di HNO 3<br />
in bottiglia in PE da 0.25 L<br />
• Aliquota C - Condizionata con H 2<br />
SO 4<br />
fino a pH 1-2, in bottiglia in vetro da<br />
0.25 L<br />
• Aliquota D - Condizionata con 1 mL/L di HCl, in bottiglia in vetro scuro da<br />
0,1 L<br />
• Aliquota E - Condizionata con CH 3<br />
COOZn + NaOH fino a pH 9, in bottiglia<br />
in PE da 0.25<br />
• Aliquota F - Condizionata con KMnO 4<br />
+ HNO 3<br />
in vetro scuro da 0.1 L<br />
22 luglio 2008 37
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI LABORATORIO<br />
Laboratorio accreditato SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori)<br />
Secondo le Normative europee UNI CEI EN ISO-IEC 17025, 2000<br />
• Organizzazione tecnica e gestionale riconosciuta in tutta Europa<br />
• Valori analitici validi in tutta la Comunità Europea<br />
22 luglio 2008 38
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
CAMPIONE ALIQUOTA PARAMETRO INVESTIGATO METODO UTILIZZATO<br />
Azoto ammoniacale<br />
Spettrofotometrico con reattivo di Nessler<br />
A (Tal quale)<br />
Nitriti<br />
Bicarbonato<br />
Anioni<br />
Cationi<br />
Spettrofotometrico con reattivo di Griess<br />
Titolazione<br />
Cromatografia liquida<br />
Cromatografia liquida<br />
Acqua<br />
B (Condizionata con HNO 3<br />
)<br />
C (Condizionata con H 2<br />
SO 4<br />
)<br />
Metalli<br />
Spettrometria ad assorbimento atomico in fiamma o in<br />
fornetto di grafite<br />
COD Kit <strong>della</strong> LANGE (range di misura: 0 – 150 mg/l di O 2 )<br />
Fosforo Kit <strong>della</strong> LANGE (range di misura: 1.5 – 15.0 mg/l di PO 4<br />
3-)<br />
D (Condizionata con HCl)<br />
E (Condizionata con CH 3<br />
COOZn +<br />
NaOH)<br />
Composti organici aromatici volatili e Solventi<br />
Clorurati/Alogenati cancerogeni e non cancerogeni<br />
Solfuri<br />
Gascromatografico con rilevatore gas-massa, previa<br />
estrazione con Purge and Trap<br />
Retrotitolazione<br />
F (Condizionata con KMnO 4<br />
+ HNO 3<br />
) Mercurio Spettrometria ad assorbimento atomico a vapori freddi<br />
A (Tal quale)<br />
Solidi in sospensione<br />
BOD5<br />
Ammoniaca<br />
Nitrati<br />
Cloruri<br />
Fluoruri<br />
Gravimetrico<br />
Sistema di misura manometrico completo di base agitante e<br />
incubatore<br />
Cromatografia liquida previa distillazione<br />
Cromatografia liquida<br />
Cromatografia liquida<br />
Metodo potenziometrico<br />
Percolato<br />
B (Condizionata con HNO3)<br />
C (Condizionata con H 2<br />
SO 4<br />
)<br />
Metalli<br />
Spettrometria ad assorbimento atomico in fiamma o in<br />
fornetto di grafite previo attacco acido<br />
COD Kit <strong>della</strong> LANGE (range di misura: 0 – 1000 mg/l di O 2 )<br />
Idrocarburi totali<br />
Estrazione con etere di petrolio<br />
Fosforo Kit <strong>della</strong> LANGE (range di misura: 1.5 – 15.0 mg/l di PO 4<br />
3-)<br />
D (Condizionata con HCl)<br />
E (Condizionata con CH 3<br />
COOZn +<br />
NaOH)<br />
Composti organici aromatici volatili e Solventi<br />
Clorurati/Alogenati cancerogeni e non cancerogeni<br />
Solfuri<br />
Gascromatografico con rilevatore gas-massa, previa<br />
estrazione con Purge and Trap<br />
Retrotitolazione<br />
F (Condizionata con KMnO 4<br />
+ HNO 3<br />
)<br />
22 luglio 2008 Sin<strong>tesi</strong> delle modalità di esecuzione delle analisi chimiche in laboratorio<br />
39<br />
Mercurio<br />
Spettrometria ad assorbimento atomico a vapori freddi previo<br />
attacco acido
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI LABORATORIO<br />
Attacco acido del campione di percolato<br />
STEP DURATA POTENZA TEMPERATURA<br />
1 2 min. 250 W 100°C<br />
2 1 min. 0 W 100°C<br />
3 5 min. 250 W 175°C<br />
4 5 min. 400 W 175°C<br />
5 5 min. 700 W 175°C<br />
6 8 min. 350 W 175°C<br />
RAFFREDDAMENTO<br />
Programma utilizzato dal digestore a microonde<br />
22 luglio 2008Campione al momento del prelievo Digestore a microonde con controllo <strong>della</strong> temperatura Filtrazione del campione dopo l’attacco acido<br />
40
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI LABORATORIO<br />
Determinazione delle concentrazioni dei metalli<br />
Spettrometro ad assorbimento atomico<br />
in fiamma<br />
Spettrometro ad assorbimento atomico in<br />
fornetto di grafite<br />
Determinazione delle concentrazioni dei Solfuri<br />
Preparazione dei campioni<br />
22 luglio 2008 41<br />
Aggiunta di iodio al campione Aggiunta di salda d’amido Retrotitolazione con tiosolfato di sodio
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI LABORATORIO<br />
Analisi sul biogas campionato alla torcia<br />
Sistema di introduzione del campione di gas anidro a volume<br />
variabile e controllo di pressione<br />
Gascromatografo con rivelatore a termoconduzione (TCD) e Gascromatografo con<br />
rivelatori a ionizzazione di fiamma (FID)<br />
22 luglio 2008 42
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 43
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI<br />
MATRICE<br />
EPOCA<br />
1<br />
DATA<br />
Acqua Percolato Biogas<br />
N° Punti di<br />
campionamento<br />
N° Punti di<br />
campionamento<br />
Ingresso alla Torcia Emissioni Fuggitive Qualità dell'aria<br />
15/01/2001-<br />
14/11/2001<br />
9 1 0 0 0<br />
2 19/11/2001 4 0 0 0 0<br />
3 11/07/2002 0 1 0 0 0<br />
4 05/05/2003 9 1 0 0 0<br />
5 17/07/2006 3 1 0 0 0<br />
6<br />
11/10/2006-<br />
17/10/2006<br />
6 2 0 0 0<br />
7 27/02/2007 0 0 1 6 7<br />
8 17/05/2007 0 0 0 0 7<br />
9<br />
19/07/2007-<br />
20/07/2007<br />
5 2 0 0 0<br />
10 07/12/2007 0 0 0 0 7<br />
11<br />
13/02/2008-<br />
14/02/2008<br />
8 2 0 0 0<br />
12 29/02/2008 0 0 1 0 0<br />
13 07/07/2008 0 0 0 48+35 0<br />
22 luglio 2008 Sin<strong>tesi</strong> delle epoche con indicazione del tipo e numero di campionamento effettuato<br />
44
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 45
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
Sin<strong>tesi</strong> dei superamenti, il numero indica quanti superamenti ci sono stati in relazione al totale dei<br />
22 luglio 2008 campioni analizzati nella determinata epoca<br />
46
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
EPOCA 1<br />
Al<br />
As<br />
Fe<br />
Mn<br />
Ni<br />
SO 4<br />
‣(15/Gen/2001-<br />
Rap<strong>presentazione</strong> (μg/L) (μg/L) grafica (μg/L) Box and (μg/L) whiskers (μg/L) plot<br />
14/Nov/2001)<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
Deviazione<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
Conteggio 9 9 9 9 9 9<br />
Statistica descrittiva dei parametri dell’epoca 1 che hanno evidenziato superamenti delle CSC<br />
22 luglio 2008 47<br />
(mg/L)<br />
CSC 200 10 200 50 20 250_mg/L<br />
Media 668.89 6.34 7484.18 4323.37 94.19 893.26<br />
Errore standard 270.64 1.35 3185.14 1950.32 82.27 224.07<br />
Mediana 300 6.3 2500 900 5.32 921.6<br />
Moda 2000 2.5 - - 1.5 -<br />
standard 811.93 4.06 9555.43 5850.96 246.81 672.20<br />
Varianza<br />
campionaria 659236.11 16.47<br />
91306189.7<br />
1 34233696.29 60915.91 451855.11<br />
Curtosi -0.35 -1.62 -0.37 3.71 8.93 -0.23<br />
Asimmetria 1.15 0.37 1.10 1.84 2.99 0.39<br />
Intervallo 1990 10.2 25492.6 17992.64 750 2053.49<br />
Minimo 10 2.5 7.4 7.36 1.5 35.71<br />
Massimo 2000 12.7 25500 18000 751.5 2089.2<br />
Somma 6020 57.1 67357.6 38910.36 847.72 8039.31
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 48
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 49
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
Matrice dei coefficienti di correlazione lineare EPOCA 1<br />
22 luglio 2008 50
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
Diagramma di PIPER con indicazioni sulle possibili facies<br />
geochimiche (Civita M, 2<strong>005</strong>)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
Diagramma di PIPER EPOCA 1<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 51
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
Qualità del dato analitico tramite il calcolo dello scarto<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
ANIONI (meq/L)<br />
SCARTO<br />
AMMISSIBILE<br />
< 3 0.2 (meq/L)<br />
3 > 10 2%<br />
Concentrazioni in mg/L degli ioni utilizzati per la costruzione dei diagrammi di PIPER<br />
10 > 800 + 5%<br />
Scarti ammissibili (fonte: Standard Methods, Civita M.,2<strong>005</strong>)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 52<br />
Tabella riassuntiva <strong>della</strong> stima delle concentrazioni di HCO 3 in meq/L ed in mg/L
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
Diagramma di PIPER con indicazioni sulle possibili<br />
facies geochimiche (Civita M, 2<strong>005</strong>)<br />
Diagramma riassuntivo di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 53
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
P4 %<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
A 100[(HCO 3<br />
-SO 4<br />
)/SUMAN] 89.16<br />
B 100[(SO 4<br />
/SUMAN)-(Na/SUMCAT)] -7.99<br />
C 100[(Na/SUMCAT)-(Cl/SUMAN)] 6.09<br />
D 100[(Na-Mg)/SUMCAT] -9.01<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
E 100[(Ca-Mg)/SUMCAT] 48.46<br />
F 100[(Ca-Na-K)/SUMCAT] 56.76<br />
Calcolo dei parametri utilizzati per la costruzione dei diagrammi<br />
rettangolari<br />
Diagrammi rettangolari standards (Barazzuoli P et al., 1987)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 54
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
P1<br />
‣ Analisi A B C statistica D E F descrittiva<br />
100<br />
50<br />
0<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
-50<br />
-100<br />
100<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
P5<br />
A B C D E F<br />
P3<br />
A B C D E F<br />
100<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
-100<br />
Diagrammi rettangolari standards (Barazzuoli P et al., 1987)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 55
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
P7<br />
A B C D E F<br />
‣ Analisi 100 statistica descrittiva<br />
50<br />
0<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> -50<br />
grafica Box and whiskers plot<br />
-100<br />
Sorgente Acquapassante<br />
A B C D E F<br />
100<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
-100<br />
Diagrammi rettangolari standards (Barazzuoli P et al., 1987)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 56
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE ACQUA<br />
100<br />
P4<br />
Acqua termale S'Giovanni<br />
‣ Analisi statistica descrittiva<br />
A B C D E F<br />
A B C D E F<br />
100<br />
50<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
0<br />
‣ Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
-50<br />
-100<br />
-100<br />
Acqua termale antica Querciolaia Sorgente 1<br />
A B C D E F<br />
100<br />
Pozzo Tisinille 1<br />
A B C D E F<br />
100<br />
‣ Analisi statistica multivariata<br />
50<br />
50<br />
0<br />
-50<br />
-100<br />
0<br />
-50<br />
‣ Costruzione dei diagrammi di Piper<br />
-100<br />
Diagrammi rettangolari standards (Barazzuoli P et al., 1987)<br />
‣ Costruzione dei diagrammi rettangolari<br />
22 luglio 2008 57
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
22 luglio 2008 58
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Statistica descrittiva delle concentrazioni di metano ed anidride carbonica misurati su entrambi gli stralci con il metodo <strong>della</strong> camera di accumulo<br />
22 luglio 2008 59
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
22 luglio 2008 Box plot delle misure di metano e anidride carbonica effettuate con flussimetro con camera di accumulo sul 1° e 2° stralcio<br />
60
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
Il ρ calcolato per i valori che superano i limiti di rivelabilità dello<br />
strumento:<br />
•Per il 1° stralcio = 0.30<br />
•Per il 2° stralcio = 0.95<br />
Discrepanza dovuta alla differenza nel numero di dati ritenuti validi a disposizione<br />
22 luglio 2008 61
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il GA2000<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Statistica descrittiva delle concentrazioni di metano ed anidride carbonica misurati sul secondo stralcio con il GA2000, alla profondità di 0.3m dal p.c.<br />
22 luglio 2008 62
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il GA2000<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Box plot delle misure di metano e anidride carbonica effettuate con il GA2000<br />
sul 1° e 2° stralcio a profondità di 0.3m dal p.c.<br />
Box plot delle misure di metano e anidride carbonica effettuate con il GA2000<br />
sul 1° e 2° stralcio a profondità di 0.5m dal p.c.<br />
22 luglio 2008 63
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il GA2000<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
Misure sulla copertura Provvisoria a profondità di 0.3m dal p.c. H 2<br />
S Conc. Media (ppm) CO (ppm) O 2<br />
(%)<br />
H 2<br />
S Conc. Media (ppm) 1<br />
CO (ppm) 0.71 1<br />
O 2<br />
(%) 0.99 0.79 1<br />
Matrice di correlazione delle concentrazioni di H2S, CO e O2 misurate alla profondità di 0.3m dal p.c.<br />
Misure sulla copertura Provvisoria a profondità di 0.5m dal p.c. H 2<br />
S Conc. Media (ppm) CO (ppm) O 2<br />
(%)<br />
H 2<br />
S Conc. Media (ppm) 1<br />
CO (ppm) 0.92 1<br />
O 2<br />
(%) -0.11 -0.22 1<br />
Matrice di correlazione delle concentrazioni di H2S, CO e O2 misurate alla profondità di 0.5m dal p.c.<br />
22 luglio 2008 64
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure rilevate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi statistica descrittiva<br />
‣Rap<strong>presentazione</strong> grafica Box and whiskers plot<br />
‣Analisi statistica multivariata<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Pianta <strong>della</strong> discarica (2<strong>005</strong>) con rap<strong>presentazione</strong> dei limiti di interpolazione e dei punti di misura<br />
delle emissioni fuggitive<br />
22 luglio 2008 65
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Analisi esplorativa delle misure di CH4 rilevate sul secondo stralcio: A) Istogramma di frequenza dei dati originali; B)<br />
Semivariogramma sperimentale omnidirezionale; C) Mappa dei dati; D) diagramma di confronto fra la distribuzione dei dati originali<br />
22 luglio 2008<br />
e la distribuzione gaussiana (Q-Q Plot)<br />
66
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Analisi esplorativa delle misure di CH4 rilevate sul secondo stralcio con il mascheramento dell’outlier: A) Istogramma di frequenza<br />
dei dati originali; B) Semivariogramma sperimentale omnidirezionale; C) Mappa dei dati; D) diagramma di confronto fra la<br />
22 luglio 2008<br />
distribuzione dei dati originali e la distribuzione gaussiana (Q-Q Plot)<br />
67
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Analisi esplorativa delle misure di CH4 rilevate sul secondo stralcio dopo la trasformazione nello spazio log-normale: A) Istogramma<br />
di frequenza dei dati originali; B) Semivariogramma sperimentale omnidirezionale; C) Mappa dei dati; D) diagramma di confronto fra<br />
22 luglio 2008<br />
la distribuzione dei dati originali e la distribuzione gaussiana (Q-Q Plot)<br />
68
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Analisi delle misure effettuate con il flussimetro portatile<br />
‣Analisi geostatistica<br />
Parametri di calcolo per le interpolazioni<br />
A B C<br />
22 luglio 2008 69<br />
Modelli dei variogrammi: A) CO 2<br />
primo stralcio; B) CO 2<br />
secondo stralcio; C) CH 4<br />
secondo stralcio
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Interpolazioni flusso CH 4<br />
22 luglio 2008 70<br />
Deviazioni standard delle stime del flusso CH 4
6. Analisi dati e risultati<br />
ANALISI DATI DELLA MATRICE BIOGAS<br />
Interpolazioni flusso CO 2<br />
22 luglio 2008 71<br />
Deviazioni standard delle stime del flusso CO 2
6. Analisi dati e risultati<br />
RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI<br />
BIOGAS<br />
Andamento temporale, nelle diverse fasi di degradazione dei rifiuti, <strong>della</strong> composizione del biogas<br />
in una discarica per RSU (Cossu R; de Fraja Frangipane E, 1995)<br />
• Aumento <strong>della</strong> percentuale di CH 4<br />
da una media di 14.2 ad una media di 17.13 %<br />
v/v gas secco<br />
• Diminuzione <strong>della</strong> percentuale di N 2<br />
da una media di 62.15 ad una media di<br />
56.09 % v/v gas secco<br />
• Diminuzione <strong>della</strong> percentuale di CO 2<br />
da una media di 15.6 a una media pari a<br />
13.23 % v/v gas secco<br />
• Presenza di O 2<br />
che da una media di 9.21 è passato ad una media di 12.58 % v/v<br />
gas secco<br />
22 luglio 2008 72
6. Analisi dati e risultati<br />
RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI<br />
PERCOLATO<br />
• pH in media pari a 7.8 per il primo stralcio ed a 7.9 per il secondo<br />
• Rapporto BOD5/COD pari a 0.1 mg/L nel primo stralcio e 0.55 mg/Lnel secondo<br />
• Concentrazioni medie di metalli tendenti ad un generale abbassamento e in<br />
particolare risultano più basse nel primo stralcio e più alte nel secondo<br />
• Conducibilità alte per entrambi i percolati, pari di media a 18968 μS/cm per il<br />
primo stralcio e a 17460 μS/cm per il secondo stralcio<br />
22 luglio 2008 73
SCHEMA DEL LAVORO<br />
1. Obiettivi<br />
2. Inquadramento<br />
3. Quadro normativo di riferimento<br />
4. Scelte progettuali<br />
5. Piano di monitoraggio e controllo<br />
6. Analisi dati e risultati<br />
7. Conclusioni<br />
22 luglio 2008 74
7. Conclusioni<br />
MATRICE ACQUA<br />
In tutte le epoche ed in tutti i punti:<br />
‣ Alta conducibilità (in media pari a 4000 μS/cm) ed elevata durezza<br />
(in media pari a 200 GradiF)<br />
‣ Superamenti delle CSC nelle concentrazioni di Fe, Mn, Ni e SO 4<br />
• proprietà geologiche, idrogeologiche e geochimiche dell’area<br />
oggetto di studio;<br />
• presenza di CO 2<br />
22 luglio 2008 75
7. Conclusioni<br />
PERCOLATO<br />
Per entrambi i percolati:<br />
‣ Basicità delle soluzioni<br />
‣ Il basso contenuto di sostanza organica biodegradabile<br />
Discarica in età avanzata e tipo di rifiuto conferito<br />
‣ Concentrazioni di:<br />
• Fe 1° Stralcio: 3515 μg/L , 2° Stralcio: 532 μg/L<br />
• Mn 1° Stralcio: 1480 μg/L , 2° Stralcio: 237 μg/L<br />
Molto al di sotto delle concentrazioni riscontrate nelle acque pari a 23470 μg/L<br />
per il Fe e a 5120 μg/L per il Mn<br />
• Naturale presenza di tali metalli nelle acque<br />
• Esclusione di una contaminazione dovuta all’impianto di smaltimento<br />
22 luglio 2008 76
7. Conclusioni<br />
MATRICE ARIA<br />
Biogas campionato alla torcia:<br />
‣ Gli anni di gestione operativa <strong>della</strong> discarica indicherebbero una<br />
fase metanigena stabile<br />
‣ Discordanze dalla curva teorica di degradazione dei rifiuti:<br />
• diversa natura dei rifiuti conferiti nei due stralci<br />
• possibile intercettazione di aria ambiente da parte delle trincee<br />
drenanti perimetrali<br />
‣Aumento <strong>della</strong> concentrazione di CH 4<br />
• Materia organica inevitabilmente presente nel totale <strong>della</strong> massa<br />
rifiuti<br />
Sviluppo di una fase metanigena meno evidente<br />
22 luglio 2008 77
7. Conclusioni<br />
MATRICE ARIA<br />
Misure delle emissioni fuggitive:<br />
‣ Misure di concentrazione e di flusso più basse sul 1° Stralcio<br />
rispetto a quelle del 2° Stralcio<br />
Diversa copertura<br />
‣ Inaspettati flussi sia di CH 4 che di CO 2 nella zona di<br />
conferimento delle scorie del termoutilizzatore<br />
Si sottolinea quanto sia importante ed utile un efficiente Piano di<br />
Monitoraggio e Controllo al fine di evitare o, qualora non sia<br />
possibile, di ridurre le emissioni nelle varie matrici aumentando<br />
le prestazioni dell’impianto, in modo da garantire un elevato<br />
livello di protezione dell’ambiente<br />
22 luglio 2008 78
Grazie per l’attenzione …<br />
22 luglio 2008 79