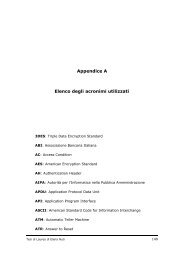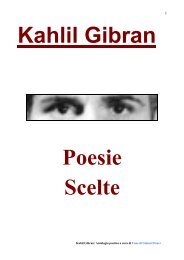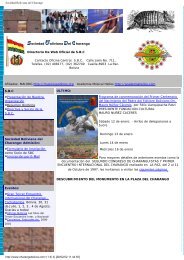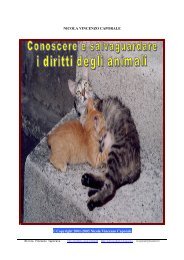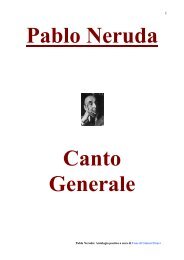Amor Mundi e Amor dei riflessioni e spunti a partire da una ... - Virgilio
Amor Mundi e Amor dei riflessioni e spunti a partire da una ... - Virgilio
Amor Mundi e Amor dei riflessioni e spunti a partire da una ... - Virgilio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Amor</strong> <strong>Mundi</strong> e <strong>Amor</strong> <strong>dei</strong><br />
<strong>riflessioni</strong> e <strong>spunti</strong> a <strong>partire</strong> <strong>da</strong> <strong>una</strong> poesia di Petrarca<br />
di Federica Zichella, classe 3D, 1999<br />
“Solo et pensoso i più deserti campi<br />
vo mesurando a passi tardi et lenti,<br />
et gli occhi porto per fuggire intenti<br />
ove vestiio human la arena stampi...”<br />
Il concetto fon<strong>da</strong>mentale di questo sonetto è la sofferenza. Il poeta passeggia<br />
a piccoli e lenti passi fino ad un luogo ove non c’è nessuno perchè non vuole<br />
esternare la sua angoscia agli altri; afferma inoltre che è abituato ad isolarsi<br />
a tal punto che la natura lo conosce.<br />
Ciò è curioso perchè Petrarca si distacca <strong>da</strong>lla natura, invece un po’ di secoli<br />
più tardi, Gabriele D’Annunzio nella poesia “Meriggio” s’impersonifica in essa<br />
sentendosi addirittura un Superuomo...<br />
Petrarca nel Canzoniere ci porge il primo esempio di un’analisi psicologica<br />
intensa, ancora prima di Freud, a scavare dentro di se; a confessare ogni<br />
“movimento” della propria anima tormentata, troppo attaccata ai beni<br />
terreni per elevarsi a Dio, troppo debole per vincere la passione per Laura,<br />
troppo amante della gloria per rinunciare alla dignità e trovare pace nella<br />
solitudine. Per tutta la sua vita il poeta è succube dell’isolamento perchè<br />
preso <strong>da</strong> questa contraddizione tra amor mundi/amor <strong>dei</strong> preferisce<br />
rimanere <strong>da</strong> solo e pensare alla stra<strong>da</strong> giusta <strong>da</strong> percorrere solo che questo<br />
dubbio lo “perseguita” fino alla morte.<br />
Un’altra lirica che rispecchia questo contrasto è “Pace non trovo, et non ò <strong>da</strong><br />
far guerra”.<br />
“Pace non trovo, et non ò <strong>da</strong> far guerra;<br />
e temo, etspero; et ardo, et sono un ghiaccio;<br />
et volo sopra il cielo, et ghiaccio in terra<br />
et nulla strngo, et tutto ‘l mondo abbraccio”.<br />
Il poeta non può contentarsi dell’amore, ma non può neppure opporvisi (...far<br />
guerra),vista l’indifferenza di Laura, teme di non essere amato ma spera il<br />
contrario. Arde <strong>da</strong>l sentimento ma “é di ghiaccio” perché non é corrisposto.<br />
Egli preso <strong>da</strong>lla felicità sembra che voi ma subito cade perchè ingannato.<br />
Ama a tal punto che si sente onnipotente (et tutto ‘l mondo abbraccio) ma<br />
poi si rende conto che é soltanto un’illusione.<br />
Sono convinta che questa contraddizione sia comunque causata <strong>da</strong>lla<br />
situazione, <strong>da</strong>l sobbuglio, presente in Italia in quell’epoca.<br />
Infatti, alla fine del 1200 le due grandi istituzioni medioevali, Chiesa e<br />
Impero, che <strong>da</strong>l tempo di Carlo Magno avevano dominato la storia europea,
sono in piena decadenza. In Francia, Spagna, Inghilterra sono sorti Stati<br />
Nazionali; l’Italia e la Germania sono divise in un’infinità di staterelli, ai quali<br />
inutilmente l’imperatore si sforza di imporre la propria autorità.<br />
Per l’Italia questo é il periodo della trasformazione <strong>dei</strong> Comumi in Signorie:<br />
un periodo politicamente molto confuso, caratterizzato <strong>da</strong> lotte continue tra<br />
<strong>una</strong> città e l’altra e fra partiti della stessa per la conquista del potere. Fra i<br />
Comuni dell’ Italia centrale, il più potente è Firenze, con a capo i Medici, che<br />
ha esteso il suo dominio su gran parte della Toscana, in altre c’erano i<br />
Gonzala a Mantova, i Visconti e gli Sforza a Milano e i Savoia in Piemonte.<br />
Il potere è in mano alla borghesia, cioè ai ricchi mercanti e industriali, che<br />
sono riusciti a espellere <strong>da</strong>l governo i nobili. La città è però divisa in due<br />
gruppi: Bianchi e Neri. Dopo circa un decennio di predominio <strong>dei</strong> Bianchi, nel<br />
1301 i Neri, con l’aiuto del pontefice Bonifacio VIII, riescono ad avere il<br />
sopravvento e cacciarono in esilio i capi di parte bianca...<br />
Questo é in prevalenza il dubbio che porta Petrarca alla disperazione, lui é un<br />
diacono e si trova a “parteggiare” alcuni ideali dell’imperatore. Petrarca<br />
come Montale in “Forse un mattino an<strong>da</strong>ndo” nota che non vi è<br />
comunicazione tra la società e l’individuo anche perché quest’ultimo é<br />
vissuto in un periodo di dittatura per cui spesso accadeva che esprimendo le<br />
proprie opinioni pubblicamente se avesse il timore di essere ucciso <strong>da</strong><br />
qualcun’altro di ideologie opposte anche se Petrarca preferiva isolarsi...<br />
Infatti questa crisi politica è la metafora dell’amore che il poeta prova per<br />
Laura nel Secretum in cui vi è un ipotetico dialogo tra Petrarca e S.Agostino,<br />
un pontefice che dichiarò (molto tempo prima) la netta separazione tra amor<br />
mundi e amor <strong>dei</strong> ma la sottomissione della ragione alla fede, con un altro<br />
personaggio, la Verità.<br />
Inizialmente quest’opera affronta il problema della volontà umana,<br />
insufficiente a resistere alle seduzioni terrene. A Petrarca, Agostino<br />
rimprovera la debolezza della volontà. I due personaggi rappresentano i<br />
termini opposti e sempre in conflitto tra loro, della personalità del poeta:<br />
Agostino è la fermezza della ragione, che indica la via della fede e del<br />
dominio di sè, mentre Francesco é la turbolenza delle passioni e del<br />
sentimento.<br />
(...)<br />
Nel canto V dell’inferno, Dante incontra Paolo e Francesca; due cognati<br />
innamorati, (protagonisti di un’ipotetica storia d’amore che circolava nel<br />
‘300); spinti all’inferno a causa di questo sentimento adultero. Egli sotolinea<br />
questo affetto, rappresentandoli uniti(che insieme vanno) anche dopo la<br />
morte.<br />
Essi si lasciano trasportare <strong>da</strong>l vento (all vento esser leggeri) senza opporre<br />
resistenza come non si opposero alla passione nel corso della loro esistenza.<br />
La bufera presente sembra contenersi contro queste due anime. La leggen<strong>da</strong><br />
dice che la ragazza fu ingannata e credette di essere maritata con il fratello<br />
di Giacotto, Paolo, di cui era già innamorata prima del matrimonio.
Quando il marito scoprì tutto ciò, li uccise entrambi, infatti si dice che nel<br />
castello (il luogo del delitto) esista l’impronta della mano insanguinata di<br />
Francesca.<br />
Il poeta a questo punto sembra parteggiare per questa coppia perchè sono<br />
pur sempre <strong>dei</strong> cuor gentili e forse non dovrebbero an<strong>da</strong>re all’inferno...<br />
Dopo un colloquio, che vede impegnati Francesca e Dante, si avverte la<br />
felicità di questo amore che unisce questi individui anche soppressi <strong>da</strong>lla<br />
sofferenza;ambedue con<strong>da</strong>nnano Giangiotto, che li ha uccisi sperando che<br />
quest’ultimo li raggiungi al più presto a far parte di questa situazione.<br />
Il poeta nel sentire le parole patite di Francesca prova molta pietà e dolore<br />
nei loro confronti a tal punto che sviene. Questa azione manifesta il palese<br />
appoggio all’amor mundi perchè se fosse stato d’accordo con la chiesa non<br />
avrebbe perso i sensi ma avrebbe con<strong>da</strong>nnato gli amanti.<br />
(...)