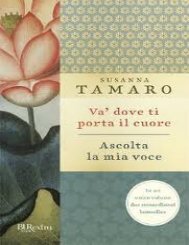Ogni angelo è tremendo - Su ali d'aquila
Ogni angelo è tremendo - Su ali d'aquila
Ogni angelo è tremendo - Su ali d'aquila
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Su</strong>sanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957 e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematograa, diplomandosi in regia. Perdieci anni ha lavorato per la televisione, re<strong>ali</strong>zzando documentari scientici. I suoi libri, che hanno venduto milioni di copie inIt<strong>ali</strong>a e sono stati tradotti in tutto il mondo, sono in corso di pubblicazione, in una nuova edizione, presso Bompiani.Ricordiamo in particolare: Per voce sola, Va’ dove ti porta il cuore, Rispondimi, Fuori, Ascolta la mia voce, Luisito, Per sempre(Giunti, 2011).Nel 2000 ha istituito la Fondazione Tamaro, ente che si <strong>ali</strong>menta esclusivamente con i diritti dei suoi libri e con eventu<strong>ali</strong>donazioni, contribuendo allo sviluppo di progetti a favore dei più deboli.
NARRATORI ITALIANI
SUSANNA TAMAROOGNI ANGELO È TREMENDOBOMPIANI
I passi dalle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke citati nel testo (1 e 2) sono tratti dalla traduzione di Enrico e Igea De Portu,Torino, Einaudi, 1978.Il passo 1 è tratto da Srečko Kosovel, Ostri Ritmi Aspri Ritmi, Trieste, ztt-est, Editoriale Stampa Triestina, 2011.© 2013 <strong>Su</strong>sanna TamaroTutti i diritti riservatiwww.susannatamaro.it© 2013 Bompiani / RCS Libri S.p.A.Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 MilanoISBN 978-88-58-75806-9Prima edizione digitale 2013 da edizione Bompiani gennaio 2013Copertina: progetto grafico Polystudio.Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
Lodate il Signore dalla terra,mostri marini e voi tutti, abissiSalmo 148Ein jeder Engel ist schrecklichR.M. Rilke
1.Sono nata in uno dei giorni con meno luce dell’anno, nel cuore più profondo della notte.Soffiava una bora fortissima.Bora scura, con neve e con ghiaccio. Soava ancora quando uscii dal sanatorio. La ripidas<strong>ali</strong>ta che ci avrebbe condotto a casa era assolutamente impraticabile, così arrivai adestinazione affidata al precario equilibrio dei miei genitori.Il vento li aggrediva alle spalle, sospingendoli in avanti con quelle rache improvvise eferoci che solo la bora sa dare mentre il ghiaccio rendeva ogni loro passo un miracolo diabilità.I miei tre chili e un po’ di essere umano, avvolti come un cannolo da una coperta bianca,rosa e azzurra fatta da mia madre, alla fine furono messi in salvo.Ci sono poche cose che mi aascinano come i neonati. <strong>Ogni</strong> volta che ne vedo uno, nonposso fare a meno di guardarlo con attenzione e chiedergli: chi sei? da dove vieni? chemistero si cela in quei tuoi occhi che ancora non vedono?No, forse sarebbe meglio dire che vedono altro.Nove mesi nella pancia della mamma, ma, prima di quella pancia c’è la storia dei suoigenitori, dei suoi nonni e dei trisavoli. E la storia dei suoi genitori e progenitori è la storiadelle loro scelte, delle loro conquiste e dei loro errori, delle meschinità e delle grandezze.<strong>Su</strong>lle loro piccole vicende si inserisce la Storia più grande, quella in cui, anche se non sivuole, si nisce per venire coinvolti e spesso anche stritolati. E Storia, molto spesso, vuoldire guerra, e dunque odio, violenza, morte – dolori che si tramandano, in modo sottile, digenerazione in generazione.<strong>Ogni</strong> bambino che nasce viene al mondo con le spalle ricurve come quelle di Atlante.Soltanto che, invece del mondo, regge pagine e pagine di storie – di storie e di Storia – esono proprio quelle pagine a far apparire i suoi occhi così stanchi, così lontani nei primigiorni.Solo alcuni genitori particolarmente ingenui e ottimisti possono credere che un neonatosia una tabula rasa, un blocco di argilla che riusciranno a trasformare, con il loro amore ela loro buona volontà, nell’essere dei loro sogni. Bisognerebbe essere un po’ meno duciosiper rendersi conto che quelle manine, in realtà, stringono una lunga pergamena arrotolatae che, se il padre e la madre avessero il coraggio di aprirla, vedrebbero che là dentro è giàtracciato, a grandi linee, il destino dell’essere che hanno appena messo al mondo.Dove si nasce?Da chi si nasce?Quando si nasce?
Non è racchiuso in queste tre domande uno dei grandi misteri che avvolge la nostra vita?Si può venire al mondo, infatti, in una villa sull’Aventino o in una baracca di Nairobi. Sipuò nascere da genitori amorevoli o alcolizzati, o semplicemente distratti o devoti amantidella crudeltà. Si può venire abbandonati in un cassonetto e morire così, in mezzo alleplastiche sporche e alla spazzatura putrescente, oppure essere già eredi, n dalla nascita, diun impero economico. Si può avere un padre e una madre, o soltanto una madre, magariuna persona ferita, debole di mente o, semplicemente, incapace di amare. Si può nascere daun grande amore o da un coito maldestro, nel bagno di una discoteca, come si può venire almondo da uno stupro.E quando si nasce?Se si ha la sventura di farlo nel bel mezzo di una guerra, paura sarà il nostro respiro nelmondo. Se invece si viene al mondo di notte, su un barcone di immigrati, il rischio è quellodi morire subito, gettati ai pesci. Si può nascere in una meravigliosa mattina di maggio,quando le rose sono tutte in ore e il profumo dell’aria è un unico inno alla vita, o invece sipuò venire al mondo in una notte di tempesta, con il vento che schianta e divelle ogni cosa,come una mano gelata priva di pudore.Non è una ninna nanna, ma un ululato quello che ti accoglie, e quell’ululato è nuovo eantichissimo. Ti ricorda la storia dei primordi, l’ancestrale che comunque è dentro di te. Saiche sei un niente disperso in un’immensità e questa immensità è cieca, prepotente, pronta adivorarti e a dimenticarsi di te subito dopo averti divorato.Condi allora nei tuoi genitori, nella copertina che ti avvolge, nei passi che, per alcuniistanti, ti sembrano saldi.Questa fiducia è la tua unica àncora.Ci crederai anche dopo anni, anche quando la realtà ti avrà mostrato l’esatto contrario.Devi crederci, non puoi fare altro, perché la radice del tuo senso aonda nel terreno deituoi genitori. Comunque vada, sono loro la ragione del tuo esserci.Per quale motivo non dovrebbero proteggerti?La prima casa della mia vita si trovava in una palazzina di cemento armato squadrata epriva di qualsiasi frivolezza. Era stata tirata su in fretta, nell’immediato dopoguerra, sullemacerie di un altro edicio distrutto dalle bombe – dunque sopra una voragine didisperazione e morte – e si era subito popolata di giovani coppie di sposi. Intorno a essa,c’erano palazzi molto più vecchi, giardini che digradavano e, dal balcone della cucina, sipoteva vedere il mare.I miei genitori erano giovani, come lo erano molti padri e madri nel dopoguerra.Ricostruire case e mettere al mondo figli era l’imperativo quasi biologico di quegli anni.Con l’ultimo bombardamento, mia madre aveva perso la villa dove era nata e, con lavilla, il suo adorato cagnolino. Mio padre, invece, era stato preso ancora adolescente daitedeschi e portato in un campo di lavoro.Tutto questo, però, era alle spalle, e doveva restare alle spalle. Davanti a loro si aprivanoi giorni splendenti del boom economico. Stava per arrivare la televisione, alcuni viciniavevano già la lavatrice. Una voce allegra dalla radio cantava Una casetta in Canadà e il
carbone per la stufa arrivava su un carro tirato da un cavallo.L’occupazione americana, nita da appena tre anni, aveva lasciato in città una passionesfrenata per la musica jazz.L’appartamento in cui abitavamo era battuto costantemente dal sole e d’estate, quando lacucina e le camere diventavano dei forni, mia madre drappeggiava il balcone con dellepesanti tende verdi. La casa sembrava così uttuare nella luminosità di un acquario e noi, lìin mezzo, nuotavamo come pesci stupefatti.Luce!Forse è stata proprio questa la ragione che ha spinto i miei genitori a sceglierequell’appartamento così poco affascinante.Luce e vita andavano di pari passo. La luce rendeva chiara ogni cosa, i gli erano unarpione lanciato nel futuro.Luce, perché alle spalle c’era solo buio.Scrivo “buio” ma mi rendo subito conto che la parola è inesatta. Nel buio si può accendereuna lampada, nel buio possono, improvvise e benevole, comparire le stelle.Non era buio, ma tenebre ciò che si erano lasciati alle spalle. Guerra, eccidi, morti,stermini. Tutto questo era compreso nello spazio/tempo racchiuso intorno ai loro giorni.A un chilometro dalla nostra casa sorgevano i muri ancora tiepidi della Risiera di SanSabba, unico campo di sterminio nazista in It<strong>ali</strong>a, mentre sulle alture intorno alla cittàvenivano ancora calati uomini per recuperare i corpi rimasti nelle foibe dopo l’occupazionejugoslava. La scritta US – uscita di sicurezza – era ancora visibile su molti edici a indicarela direzione da imboccare per mettersi in salvo durante i bombardamenti.L’uscita di sicurezza era, allora, una vita “americana” che sembrava aprirsi davanti aloro, una vita fatta tutta di P – progresso, pace, prosperità. Uscita di sicurezza dalle loropaure, dalle loro fragilità, da tutto ciò che avevano vissuto e non avrebbero voluto vivere.Fino ad allora, la Storia con la S maiuscola si era imposta su di loro. Da quel momento inpoi, ne erano certi, sarebbe stata la loro piccola storia a vincere sulla Grande Storia.La storia della norm<strong>ali</strong>tà, della vita che va avanti e che, con la sua quieta ban<strong>ali</strong>tà,sospinge le tenebre in un angolo, rendendole inoffensive.Erano giovani, i miei genitori, e fervidamente ingenui. Non erano mai stati colti dalsospetto che un glio, anziché essere un arpione lanciato verso il futuro, potesse diventareun’àncora che, una volta issata a bordo, trascina con sé strascichi del fondale del passato.Non avevano mai avuto davvero il tempo di osservare gli occhi di un neonato.Non avevano visto i miei – grandi, sgranati, interroganti.Non avevano fatto caso alle mie orecchie a vela, sempre tese, sempre in ascolto.Orecchie/antenne, orecchie/radar, capaci di percepire anche il più sottile scricchiolìo delmondo.
2.Da un po’ di tempo a questa parte, quando sento parlare di letteratura provo uno stranodisagio.Negli ultimi venti anni, nel mondo editoriale, sono avvenuti straordinari cambiamenti. Lescuole di scrittura creativa – nate all’inizio del Novecento negli Stati Uniti come corsiall’interno di un percorso universitario – si sono ormai diuse a macchia d’olio anche inIt<strong>ali</strong>a. Molte sono le persone che le hanno frequentate in questi ultimi anni, traendonespesso un notevole benecio, così come un notevole benecio l’hanno avuto anche glieditori i qu<strong>ali</strong>, anziché venir invasi da sgrammaticati deliri solipsistici, si sono trovati tra lemani dei plot interessanti, carichi di suspence e di colpi di scena, capaci di renderecommerciale il libro.L’unica volta che sono stata invitata a tenere una lezione in una di queste scuole, hodeclinato con gentilezza l’invito. Nessuno mi ha insegnato a scrivere e, dunque, non sareistata in grado di intrattenere gli allievi nel modo in cui probabilmente si aspettavano.Malgrado abbia pubblicato venti libri, la scrittura resta per me un evento assolutamentemisterioso.Nei primi anni della mia vita editoriale, mi trovavo spesso a dire nelle interviste chequello che avevo appena pubblicato sarebbe stato il mio ultimo libro. Non era una boutade,ma una certezza di quel momento. Per la stessa ragione, non ho mai accettato nessuncontratto per un libro a venire, nessuna clausola, nessuna opzione.Per me davvero ogni libro era l’ultimo.Era l’ultimo perché, scrutando l’orizzonte, non intravedevo nulla, forse per la stanchezzae la prostrazione in cui mi aveva lasciato la sua stesura, o forse perché – nel suo apparire enel suo svolgersi – ogni libro aveva intorno a sé l’aura del miracolo. E il miracolo, si sa, nonpuò compiersi a comando.Adesso non lo dico più, sono stata smentita troppe volte. Continuo soltanto a covarlodentro di me, come un presagio. Un presagio, ma anche un imperativo etico. Nel momentoin cui mi accorgessi che scrivere è diventata una routine, un mestiere tra gli altri, illuminatounicamente dalla tecnica e dal buon senso, smetterei di farlo. Per la stessa ragione, hoaccettato un’unica volta di scrivere un racconto su commissione, per poi pentirmene subitodopo. Non so scrivere a comando, non mi diverte, non mi eccita, non mi dà soddisfazione.Ho mille cose da fare più interessanti che scrivere dei temi su argomenti scelti da altri.Non ho mai considerato la scrittura uno svago, una professione, qualcosa che si potessefare come tante altre cose, come non ho mai pensato che lo scrivere bene, lo scrivereforbito, appropriato, siano preludi della vera scrittura.La vera scrittura sta altrove, giù in profondità, nel nucleo di fuoco della terra, nel cuoredi tenebra dell’uomo. Procede e si mantiene in bilico tra questi due estremi.
Per questo affatica, logora, fa male alla salute.Per questo non insegno, non consiglio.Anzi, appena posso, sconsiglio.Nella casa in cui mi sono trovata a vivere, c’era già un bambino di tre anni più grande dime – mio fratello. Per placare la sua furibonda gelosia, gli avevo regalato un bel furgoncinorosso. “Guarda cosa ti ha portato la tua sorellina!” In realtà era stato un inaspettato guizzopsicologico dei miei genitori. Ma quel furgoncino era servito a ben poco.La prima foto che ci ritrae insieme – io, sul letto, con la coperta rosa, bianca e azzurra, luiaccanto a me con un’espressione perplessa e le mani protese verso il mio collo – ha davveropoco di rassicurante.Il suo regno di primogenito maschio – primo anche di tutti i nipoti – ormai era statoinfranto. Oltre a tutto, non potevamo essere più diversi. Sembravamo adottati in dueorfanotro di dierenti paesi. Lui era un perfetto bambino turco, mentre io ero una tipicaglia dei Balcani. Ancora adesso, quando andiamo in giro insieme, è dicile immaginareuna così stretta consanguineità.Oltre il camioncino, il mio arrivo non gli ha portato nient’altro di buono. Di lì a poco,infatti, i nostri genitori hanno iniziato a capire di non essere fatti l’uno per l’altro e lacasetta in Canadà, con vasche pesciolini e tanti fiori di lillà, si è rapidamente dissolta.Al suo posto, è disceso il gelo.Un gelo tagliente, acuto, che rendeva impossibile anche respirare.Il primo ricordo che ho è quello di mio fratello che, grazie a un potente schiao, vola giùdalla sedia. Ero sul seggiolone e l’ho visto sparire. Rammento ancora il senso di stupore epoi, fulminea, l’incertezza. In quel momento credo di aver capito che ogni passo potevaessere falso, ogni respiro sbagliato.Sopravvivere sarebbe stato un compito, una necessità.Il secondo ricordo riguarda i primi passi. Li ho sperimentati sul balcone della cucina, unterrazzino lungo e stretto protetto non da un’inferriata, ma da un muro di cemento. Non sipoteva vedere niente, ma si sentivano le sirene. Il braccio di mare su cui si aacciava lacasa era quello del porto industriale, da lì le navi da carico arrivavano e partivano e, ognivolta, suonavano la sirena. Anche i cantieri nav<strong>ali</strong> suonavano una sirena per segnalare iturni di lavoro.Quel verso – UUUUUUU – ripetuto così spesso mi metteva addosso un’inquietantetristezza.Qualcuno soriva, di certo, ma chi? Chi poteva essere così grande da urlare in quelmodo?Se il mondo di casa era piuttosto minaccioso, quello fuori non sembrava certo migliore.Dormivo nella stessa camera di mio fratello e dunque, non appena ho imparato a parlare,è stato lui il primo testimone della mia follia. Era il mio idolo, il mio mito e, dato che igenitori avevano avuto una certa caduta di interesse nei nostri riguardi, era anche l’unicapersona più grande a cui potevo rivolgermi.
Il tormento cominciava appena si spegnevano le luci nella stanza. A quel punto, dal miolettino, si levava la mia piccola voce che lo chiamava e, non appena lui rispondeva “eh?”,partiva senza pietà la mia carica di domande.Iniziavo alle nove e andavo avanti – o meglio, sarei andata avanti – no a notte fonda,se uno dei due genitori non fosse entrato di colpo gridando con voce terribile: “Silenzio!Basta!”“Cosa ti chiedevo?” ho domandato tempo fa a mio fratello.“Cose impossibili,” mi ha risposto.“Tipo?”“Tipo, chi ha fatto le stelle? Da dove viene la luce? Chi ha fatto il sole? E quandoscompare, dove va? Tornerà sempre, tutte le mattine?”“E tu cosa rispondevi?”“Per un po’ inventavo, poi, quando ero stanco ti dicevo: ‘Non lo so! Dormi!’”Non lo so, dormi!Ecco la frase di tutte le mie notti.Solo che lui dormiva, mentre io no.
3.L’insonnia è stata la compagna fedele di gran parte della mia vita. Forse per questo, hopiù ricordi notturni che diurni della mia prima infanzia.Potrei ancora descrivere tutti gli istanti delle mie notti come una radiocronaca di unapartita di calcio. L’andata a letto, dopo Carosello; il bacio della buonanotte – quel bacio cheavrebbe dovuto essere uno scudo, una pozione magica contro il terrore che, da lì a poco,avrei dovuto arontare – e la solita domanda retorica che facevo a mia madre: “Dormirò,vero?” e la sua altrettanto retorica rassicurazione: “Certo che dormirai!” La luce che sispegneva e poi, ancora per qualche ora, i rassicuranti rumori della casa – la radio prima, latelevisione poi. Inne quelle voci cominciavano ad aevolirsi e iniziava la sequenza deirumori igienici – rubinetti, sciacquoni e l’ultima pipì dell’inquilino di sopra, che chiudeva ledanze.Soltanto allora si apriva l’orrore della notte. Il rombo delle auto sempre meno frequente,il atone della lovia che apriva le porte con uno sbuo sotto la mia nestra per poiallontanarsi verso il capolinea.Poi anche l’autobus niva le sue corse e si apriva il tempo sospeso, il tempo vuoto. Iltempo del terrore e della claustrofobia, il tempo degli scricchiolii e dei sussurri, delle voci edei mostri, delle loro risate sadiche che echeggiavano nella stanza.Finché ancora dormivo con mio fratello, di tanto in tanto tentavo un “Dormi?” ma il suosilenzio era la più eloquente delle risposte.Un pomeriggio riuscii persino a escogitare un antidoto, disegnando a matita sulla pareteaccanto al mio letto un mostro che più mostruoso non poteva essere. E quel mostro, vistoche l’avevo creato io, aveva una preziosa caratteristica – era un mio amico, un Golem almio devoto servizio. Quando però lo mostrai a mio fratello, la risposta fu degna della suaconcretezza:“Dov’è? Cos’è? Vedo soltanto uno scarabocchio.”La tragedia della stanza vuota arrivò a cinque anni, quando cambiammo casa. Non piùdomande, non più il suo rassicurante respiro da bambino con le adenoidi. Sola! Sola con ilsilenzio. Sola con i mostri. Sola con un’alba che non arrivava mai.Che sollievo quando il chiarore iniziava a ltrare sotto la nestra! E, con il chiarore, gliuccelli cominciavano a cantare sugli alberi intorno – i merli per primi, poi gli uccelli piùpiccoli. Quando le tortore partivano con i loro tristissimi versi, il mio corpo nalmente sirilassava. Ecco, finalmente era giunto il momento di dormire.Ma dopo un’ora già si presentava l’incubo di andare a scuola. In aula ciondolavo con latesta, capivo ancor meno di quello che sarei stata in grado di capire. Quando mia madreandava ai colloqui, la maestra la rimproverava: “La bambina non deve stare alzata no a
tardi a vedere la televisione!”Ero una bambina depressa?Sicuramente. Appena avevo un momento libero, mi sdraiavo sul pavimento della stanza einiziavo a piangere. Piangevo per ore, senza limiti, no allo snimento. Ero unamaratoneta del singhiozzo. I miei pianti non avevano nessuna ragione apparente e questoirritava molto mia madre. “Perché piangi?” mi gridava e io, senza interrompere la miaattività, rispondevo: “Non lo so!”In realtà lo sapevo benissimo. Piangevo perché le cose nivano, perché, dietro la luce,c’era sempre in agguato il buio. Piangevo perché la copertina mi aveva illusosull’accoglienza e sull’amore, ed era brutto svegliarsi dalle illusioni. Piangevo perché la miatesta esplodeva di domande e non c’era nessuna persona a cui potevo rivolgermi. Piangevoper il pozzo di solitudine dolorosa in cui ero sprofondata. Piangevo perché tutti siaspettavano che io fossi una brava bambina normale e io non ero capace di esserlo.Fossi stata una bambina oggi, probabilmente mi avrebbero portata da uno psicologo chemi avrebbe parlato per ore con voce calma. Avrei interagito con dei bambolotti e,dall’osservazione delle mie azioni, sarebbe sicuramente venuta fuori la causa di tantodisagio. Avrei fatto centinaia di sedute terapeutiche, forse mi avrebbero dato anche un po’di pilloline, così, tanto per aggiustare il tiro e, alla ne, sarei diventata quello che tutti siaspettavano che diventassi – una bambina che dorme quando deve dormire e che parlaquando deve parlare, soci<strong>ali</strong>zzata al punto giusto, obbediente al punto giusto.Una bambina comprensibile, insomma.Ma, a quel tempo, non si usava dare tanta importanza ai piccoli; se c’erano dei problemi,si sarebbero risolti con il tempo. L’unica cosa importante era essere obbedienti. E se non liavesse risolti il tempo, i problemi, ci avrebbe comunque pensato la selezione naturale. Ilpedagogo a cui si ispirava mio padre, infatti, era Darwin: per lui solo i forti e gli adattierano degni di sopravvivere. I vasi di coccio tra i vasi di ferro non gli interessavano, sisarebbero eliminati da soli. La visione di mia madre, invece, era più vicina a quella di undomatore di bestie feroci o di capricciosissime scimmie. Prima di ogni altra cosa, i bambiniandavano appunto domati e, per farlo, erano v<strong>ali</strong>di tutti i sistemi, tranne quello delbocconcino premio. Il bocconcino premio, infatti, poteva venire scambiato, come qualsiasialtra forma di gratificazione, per debolezza e scatenare così inappropriate resistenze.Con questo sistema, sia io che mio fratello siamo diventati in breve tempo degli abililettori del pensiero. Sempre sull’attenti, sempre pronti a ubbidire, ancor prima che l’ordinesi manifestasse in parole.Naturalmente, in questa visione formativa non rientrava la possibilità di malesseri omalattie. Qualsiasi dolore, qualsiasi lamento veniva catalogato nella serie “inopportunerichieste di attenzione” e, in quanto tale, ignorato.Forse proprio per questo, intorno ai tre anni ho sorato la peritonite. Per fortuna, in quelperiodo, il più assiduo corteggiatore di mia madre era un pediatra ed è stato lui ad
accorgersi che quel continuo pianto non era una furbesca strategia per ottenere una carezzao un bacio, ma qualcosa di davvero serio che stava accadendo nella mia pancia. Ricordoancora perfettamente l’espressione improvvisamente impaurita e preoccupata di miamadre. A un tratto c’era, era lì e, soprattutto, mi vedeva.Rammento poi la corsa in macchina, gli alberi capovolti dietro al nestrino, poi l’ingressonella sala operatoria e una maschera nera di gomma come una proboscide che mi venivamessa sul volto, una puzza tremenda e poi più niente.Silenzio, buio, finalmente sonno!Ed è stato sempre grazie a quel pediatra che, una certa sera, sul mio comodino sonocomparse delle pillole di colore arancione e delle polveri eervescenti bianche. Le pozionimagiche che aspettavo da tempo! Bastava ingerirle per sprofondare in pochi minuti tra lebraccia di Morfeo. La mia mano, sul bicchiere d’acqua, tremava come quella dei naufraghiquando aerrano la prima noce di cocco. Giù, presto, le pillole; giù, presto, la polvere.Gratitudine per le palpebre improvvisamente pesanti, per gli sciacquoni sempre più lontani,per l’autobus che sarebbe arrivato e non mi avrebbe trovato ad attenderlo perché,finalmente, come tutti gli altri, sarei stata nel mondo dei sogni.Grazie chimica! Quando nessuno si prendeva cura di me, tu l’hai fatto! Grazie bromuro,dolce compagno delle mie notti e dei miei giorni.Perché non dormivo?Non dormivo perché pensavo alla morte. Non avevo perso ancora nemmeno uno dei mieinonni, eppure non pensavo ad altro. Pensavo alla morte dei miei genitori, alla mia, aquella degli anim<strong>ali</strong> e delle piante. Pensavo che anche il sole, un giorno, sarebbe potutomorire.Durante la notte, la bora cominciava a far tremare la tenda della camera – un grandefantasma bianco che danzava soltanto per me. Ma non era una danza benevola perché, alsuo interno, si nascondevano degli scheletri. Anche loro ballavano, scatenati, allegri. Potevosentire il rumore ritmico delle loro mandibole, lo stridìo delle rotule e delle clavicole. “Sarainostra, sarai nostra!” cantavano, dimenando le anche e le braccia.Soltanto nella seconda parte della notte, quando la bora iniziava a incalzare con il suoululato, comparivano i lupi. Se ne stavano lì, fermi, in agguato, con le fauci spalancate, identi scintillanti come diamanti e la grande lingua rossa a penzoloni. Aspettavano eansimavano. Sarebbe bastato un attimo di distrazione per averli addosso.Con il tempo, avevo imparato a mettere in atto dei deboli antidoti per tenerli lontani.Contavo quante calze c’erano in un cassetto. Dato che non ero mai certa di ricordarne ilcolore, il numero e la disposizione, mi alzavo in continuazione per controllarli. Altre voltedicevo delle parole all’inverso, toccavo o non toccavo certi oggetti; camminavo o no in certiluoghi, con la speranza che quei ritu<strong>ali</strong> potessero tenere lontano da me quegli occhisinistramente scintillanti.Potevo tenere fermi gli scheletri, i lupi, ma non avevo alcun potere nei riguardi del vento.“Da dove viene?” chiesi un giorno a mio fratello.
“Dalla steppa,” mi rispose.“Nessuno lo può fermare?”“Nessuno.”Da poco mi avevano raccontato la storia dei Tre Porcellini e quel “soerò, soerò no adistruggere la vostra casa” mi era purtroppo divenuto familiare, perché era chiaro che labora non voleva fare altro.Voleva sradicare, divellere, distruggere.Anche se all’inizio si presentava come un vento leggero che sollevava appena le tende erinfrescava le caviglie, in breve, però, mostrava il suo vero volto, facendo vibrare lanestra e il letto. Vibravano anche le fondamenta. Sentivo chiaramente ondeggiare la casa,come una barca in balìa delle onde, un po’ a destra, un po’ a sinistra. Ondeggiava eoscillava, oscillava e ondeggiava. Per questo mi aggrappavo al letto come fosse unascialuppa. Se la casa avesse ceduto, la coperta e il materasso sarebbero stati la miasalvezza. Avrei potuto volare lontano verso altri mondi, come se avessi avuto un tappetomagico.La bora mi faceva paura perché aveva tante voci, e nessuna di queste era buona. Mifaceva paura perché, in quei giorni, l’elettricità già elevata della mia testa diventavaelevatissima. Se avessi dovuto darmi il nome da sola, mi sarei chiamata Elettra.
4.Nascere a Capri o nascere a Trieste non è la stessa cosa.A Capri, avrei trovato prima o poi qualche zia aettuosa in grado di prendersi cura di noinipoti, un simpatico cugino che ci avrebbe portati a fare delle gite in barca, una nonnacapace di scacciare la nostra tristezza con dei calzoni ripieni appena tolti dal forno.A Capri, avrei potuto contemplare la dolcezza del mare, farmi stordire dalla oritura deilimoni e da quella dei gelsomini, accompagnare mia madre al mercato e rendermi conto chela vita era un’avventura piena di colori e rumori, un’avventura allegra, lieve, che valeva lapena di essere vissuta.A Trieste no.Trieste, in quegli anni, era una città cupa, sinistra, piena di fumo.Il fumo dei treni che attraversavano lenti le Rive diretti verso Campo Marzio.Il fumo della Ferriera che tutt’ora incombe come un fungo nucleare su una parte dellacittà.I fumi dei riscaldamenti, <strong>ali</strong>mentati per lo più a carbone.E i fumi della Storia.Il fumo dell’odio razziale, dell’odio etnico.Il fumo delle navi di profughi che arrivavano dall’Istria e dalla Dalmazia.Il fumo dei milioni di vite sacricate per riportare la nostra città all’It<strong>ali</strong>a durante laprima guerra mondiale. Trento e Trieste. Quante volte mi sono sentita a chiedere, “Sonovicine, vero?”Il fumo del comunismo che, da lì a Vladivostok, stava appollaiato alle nostre spalle.Il fumo della delusione, perché già cominciava ad apparire chiaro che il ritorno allaMadre Patria in fondo era stata una gran fregatura.E tutti questi fumi non esplodevano in manifestazioni esterne, come magari sarebbesuccesso a Capri, ma piuttosto implodevano, si trasformavano in un veleno freddo. E quelveleno, assieme al sangue, cominciava a scorrere nelle vene.Anch’io respiravo quei fumi silenziosi.Attraverso i pori, quelle sostanze tossiche entravano dentro di me. Assorbivo arsenico,cianuro, radon, amianto. Fin dai primi anni, senza che me ne rendessi conto, si eranodepositate nella linfa, precipitate nel sangue e, dal sangue, correndo si erano diffuse in ognidove. Il veleno era la mia camera di combustione.Di giorno, naturalmente, vivevo tutte le norm<strong>ali</strong> passioni infantili. Scendevo con miofratello a giocare in cortile con gli altri bambini del palazzo, sempre come mascotte o come
palo. Ero comunque grata di essere ammessa nel mondo dei grandi.Il loro gioco preferito era quello degli indiani e dei cow-boy, e il mio ruolo, neanche dirlo,era quello di fare il morto. “Adesso tu muori” mi dicevano e io, docile, mi sdraiavo perterra. Oppure mi sparavano con la mano tesa a pistola e allora dovevo stramazzare al suolodi colpo. La seconda variante era quella di venire legata a un palo e venir tratta dallefrecce degli indiani al grido di: “Muori, cane!”Alle prime morti, quando non ero ancora una professionista, chiedevo timidamente a mestessa: “Ma poi rinasco?” Temevo infatti che la nzione potesse sorare la verità. Chi maipoteva dire se facessi davvero nta, se non venissi scambiata per una morta vera? Magariera possibile passare da uno stato all’altro, per sbaglio, senza accorgersene. Così morivosempre con un occhio semiaperto, per essere pronta, nel caso, a gridare: “Non dormo, nonsono morta, sono sveglia. Sto solo giocando!”E poi, durante quelle prolungate morti apparenti, mi chiedevo: “Ma quante volte si puòmorire nella vita? Una sola, oppure tante?” E questa domanda era legata a quella piùcruciale. Dov’ero prima di essere in questo mondo? Dove, o chi, o quando?Pur sapendo di essere nata in quella notte di tempesta, non potevo non sentire qualcosadi diverso che vibrava dietro quell’evento. Era un po’ come se osservassi il passato con uncaleidoscopio; dietro a un piano, ce n’era un altro, con colori smaglianti. Bastava scuotere iltubo perché quel piano crollasse e ne comparisse uno diverso, di incomparabile bellezza.Ruotandolo poi, il paesaggio luminoso cambiava ancora, con prospettive che prima eradifficile intuire.Quante vite, mi chiedevo allora, ci sono dietro una vita?Quelli erano davvero i miei genitori o solamente i guranti di una nuovarappresentazione?E se di rappresentazione si trattava, quale mai sarebbe stato il mio ruolo su questopalcoscenico?E dopo di queste ce ne sarebbero state altre?Un giorno sarei morta, mi avrebbero fatto il funerale e, mentre tutti – pochi –piangevano, io mi sarei svegliata da un’altra parte, in un’altra culla. Magari una culla digiunco sotto le palme di un’isola tropicale, con due genitori con gli occhi a mandorla che miavrebbero sempre sorriso. E anch’io avrei sorriso loro, avrei risposto al mio nuovoimpronunciabile nome e avrei imparato a zampettare sulla spiaggia e a raccogliereconchiglie.<strong>Ogni</strong> tanto, di notte, mi sarei svegliata di soprassalto perché qualcosa di orrendo sarebbeentrato nel mio cuore, nella mia mente. Avrei risentito un sibilo, anzi un ululato. L’ululatodi un vento feroce. Un vento con neve, con ghiaccio, con volti di lupi, di streghe, di adultiche non sorridono e non prendono in braccio. Mi sarei svegliata urlando, sudata, e i mieigenitori di turno sarebbero subito accorsi e mi avrebbero consolato. “È tutto passato,” miavrebbero detto baciandomi con labbra fresche la fronte.L’idea che quello fosse soltanto uno dei tanti passaggi, in qualche modo mi rasserenava.Se la vita non era molto diversa da una lotteria, bisognava solo avere un po’ di pazienza e
attendere la nuova estrazione. Ero convinta che questa verità fosse chiara a tutti.“Ma tu, dove vivevi prima?” chiesi infatti una volta a una mia compagna di primaelementare. “Ho sempre vissuto a Trieste.” “Ma no, prima,” insistetti scioccamente.“Nell’altra casa, con gli altri genitori!” Invece di rispondermi, riprese caparbiamente acancellare il suo foglio.Cancellare!Ecco, era proprio quello che avrei dovuto fare anch’io, con tutta l’enorme quantità di coseche avevo in mente.Stavo cominciando a comprendere che c’era un mondo nella mia testa e un altroall’esterno e che questi due mondi avevano raramente la felice idea di coincidere.Con l’ingresso nella vita pubblica – asilo e poi scuola – fu subito chiaro a tutti che l’esseresocievole non rientrava nei programmi della mia vita. Vivevo immersa nei miei pensieri emi riuscivano incomprensibili le leggi non scritte della soci<strong>ali</strong>tà. Quelle delle bambine poimi sembravano particolarmente irritanti. Il mondo a cui facevano riferimento era quellodelle fate e dei principi, dei frizzi e dei lazzi, delle piccole cattiverie vicendevolmentesussurrate alle spalle. Tutte realtà che non mi riguardavano in alcun modo, intuivo in essesempre qualcosa di superuo, di superciale, di falso. Tanto ero felice di fare la squaw neigiochi del cortile e preparare papponi di fango nel tepee per i capi indiani, altrettanto erodisperata quando, all’asilo, mi veniva affidata la parte della damina.Amavo i giochi dei maschi perché in quei giochi era sempre presente la morte. E la morte,già allora, mi pareva l’unica garanzia di verità.Oltre che per la morte, in quel periodo avevo una vera passione per le gurine delformaggino Mio. Si trattava di minuscole immagini tridimension<strong>ali</strong>, bastava muoverle unpo’ per vedere comparire, dietro la prima gura, una seconda. Ne avevo un paio e leconservavo come un tesoro.Dunque era vero, dietro una realtà se ne nascondeva sempre un’altra e questo mi dava uncerto conforto.Risale a quell’epoca anche il sogno di imparare a volare. Avendo una natura ossessiva, miesercitavo ogni giorno. Correvo in cortile no a farmi scoppiare il cuore e, quando lavelocità era abbastanza alta, cominciavo a frustare l’aria con le braccia. Poi, al momentogiusto, come fossero i carrelli di un aereo, tentavo di sollevare i piedi.Mio fratello era spesso testimone dei miei tentativi.“Ho volato?” domandavo speranzosa, alla fine.“Sì. Un po’ mi sembra, sì,” rispondeva generosamente lui.
5.Volare sì.Volare via, lontano, le ossa improvvisamente cave, il sacco aereo al posto dei bronchi.Una mattina mi sarei sporta dal balcone di cemento e da lì, nella meraviglia generale – maguarda, chi l’avrebbe detto, ha imparato a volare! – mi sarei lanciata compiendo dei grandigiri di prova sopra il cortile. Poi sarei s<strong>ali</strong>ta in alto, ancora più su, no a vedere le casedella città piccole e regolari come i cubi di legno con cui ero solita giocare.Da lassù avrei poi deciso dove andare. A est, verso le alture da cui scendeva la bora,l’avevo già escluso per motivi di sicurezza. Il mare sembrava invece un’alternativaattraente. Più vai a sud e più è caldo, mi aveva detto mio fratello, e poi laggiù c’èIstanbul…Istanbul! Già solo il nome mi faceva sognare.Purtroppo, nonostante il mio impegno, i progressi nello spiccare il volo erano modesti,così decisi di spostare la data dei mio exploit al Duemila.“Credi che voleremo nel Duemila?” chiedevo a mio fratello.“Certo che voleremo,” rispondeva, “voleremo con il pensiero. Ci siederemo nel nostrocanotto e lui, con noi sopra, volerà.”“Senza volante? Senza niente?”“Senza volante, senza niente. Pensiero e basta.”Piccola pausa di riflessione, poi io chiedevo.“Ma nel Duemila sarò ancora viva?”“Per forza, avrai quarantatré anni.”Già, ma intanto come sopravvivere fino al Duemila?Dalla constatazione che non erano fatti l’uno per l’altra, i miei genitori avevano nelfrattempo fatto progressi.La presenza di mio padre si era fatta saltuaria, un po’ c’era e un po’ no, su quel un po’ nonon c’era alcuna spiegazione. Non che cambiasse molto perché, anche quando era presente,non parlava. Se ne stava sempre seduto in poltrona con gli occhi<strong>ali</strong> da sole a guardare ilvuoto. Anche mia madre guardava il vuoto dietro a occhi<strong>ali</strong> scuri, su un’altra poltrona. Ungiorno, però, i suoi occhi si sono ammalati, così al posto degli occhi<strong>ali</strong> portava una bendascura come quella dei pirati.Noi cercavamo di essere la non esistenza.Non fare rumore, non parlare, non disturbare, non avere sciocche esigenze.Credo che mio padre avesse una ripulsa quasi sica nei confronti dei bambini, esseri
deboli, insignicanti, soprattutto irritanti. Quando si ricordava di averne generati due, erapreda di improvvisi scoppi d’ira. Camminavamo così in punta dei piedi, trattenendo il ato.Per fortuna mio fratello era bravissimo a guidare il tappeto dell’ingresso. Lui si sedevadavanti, io dietro e, su quel tappeto, andavamo lontanissimi. Tappeto nave, tappeto treno,tappeto volante, capace di portarci a Istanbul in un istante.Cancellata l’idea di essere una famiglia, i miei genitori stavano cercando di immaginarenuove strade verso cui dirigere le loro vite. Era come se la nostra casa fosse diventata unastazione di autocorriere. S<strong>ali</strong>vano su un mezzo, scendevano da un altro; alcune volte soli,altre in compagnia, spinti dalla loro ansia di esplorazione. <strong>Ogni</strong> tanto si incontravanonell’atrio per cambiare bagagli. Le loro espressioni erano sempre tristi, tese. In tutto questoandirivieni di arrivi e partenze, si erano dimenticati dei due pacchi che sarebbero stati diloro competenza.I pacchi eravamo noi.Stavamo lì sul marciapiede ad aspettare un segno, un cenno, un schio, qualcuno che cirivolgesse la parola, che ci mettesse un cartello al collo con sopra scritta la destinazione.Proprio mentre stavamo lì in attesa di qualcuno che ci indicasse la strada, nella nostravita comparve Gianna.Gianna veniva il pomeriggio, dalle tre e mezza alle sette, e si prendeva cura di noi. Ora sichiamerebbe baby-sitter ma quella volta, a Trieste, si chiamava “signorina”, per direttatraduzione dal tedesco Fräulein. Rimase con noi dai miei tre anni ai sette e, più che unasignorina, per noi fu una zattera. Dal tappeto volante dell’ingresso saltammo direttamentesu di lei e, su di lei, restammo abbarbicati sfoderando tenaci unghione da bradipi.Gianna era giovane, gentile, affettuosa.Invece di trattarci come delle scimmie astutamente ribelli, ci trattava come dei bambini acui voler bene. Spesso, nell’età adulta, mi sono ritrovata a pensare che forse, proprio graziealla sua presenza mio fratello e io non siamo morti in giovane età in qualche gabinetto diperiferia con un ago conficcato nelle vene.Lei era il Virgilio con cui abbiamo cominciato ad attraversare in lungo e in largo la città.Uscivamo con qualsiasi tempo. Il bambino darwiniano infatti doveva essere assolutamenteindierente alle variazioni meteorologiche. Lasciavamo la palazzina di cemento – in pienaestate, in sand<strong>ali</strong> e maglietta; in inverno, con la bora che soava oltre i cento chilometriall’ora, nei nostri logori loden che svolazzavano come bandiere intorno al corpo – eandavamo a esplorare il mondo.Ricordo lunghe marce attraverso le Rive, con le locomotive che transitavano fumose elente, nascondendo in gran parte il mare; le soste in piazza Unità, dove c’era una vecchiettache vendeva cartocci di granturco per i colombi; i pomeriggi passati sul molo con le gambea penzoloni, una togna in mano e la curiosità di sapere cosa mai sarebbe venuto su da quello trasparente che spariva nell’oscurità cupa dell’acqua del porto. E poi, appena il lo sitendeva, il terrore, perché “non uccidere” è stato n dall’inizio per me un imperativocategorico.
Gianna ci aveva poi fatto scoprire l’Acquario, accanto al molo, luogo di elezione dellamia infanzia. Un lato dell’enorme edicio di mattoni rossi lo conoscevo già perché era laPescheria centrale e vi ero andata spesso con mia madre a fare la spesa.All’interno, le voci rimbombavano in maniera straordinaria, c’era un odore fortissimo dipesce e il mio sentimento era sempre contrastante. Una parte di me, infatti, – quella cheavrei conosciuto più tardi – era eccitata dall’idea di vedere tante forme di vita così diverse;l’altra, invece – quella che conoscevo già, l’insonne e devota alla morte – non riusciva asopportare la vista delle branchie che si dilatavano spasmodicamente, di quei guizzi, queisalti, quei colpi di coda sempre più deboli, quegli occhi che via via si facevano più opachi.Fu proprio in Pescheria che feci uno dei primi e più metasici pianti della mia vita,davanti una cassetta di canocchie – vive!!! veniva scritto sulla lavagna nera con tre puntiesclamativi. Com’era possibile sopportare la visione di tutto quel dolore, di quelle creatureche si contorcevano disperatamente, che agitavano le innite zampette, che dilatavano lebranchie come bocche, emettendo un invisibile urlo?Come si poteva osservare tutto quel tormento e restare indifferenti?E per quale ragione bisognava infliggere quel dolore?I miei bronchi vibravano con le loro branchie, le loro zampette erano spine pronte atrafiggere il mio cuore.Mi guardavo intorno per vedere se qualcun altro fosse preda dello stesso sgomento, mavedevo solo persone che parlavano, ridevano, facevano scivolare le povere bestie incartocci di carta giallastra che, ancora tutti vibranti, venivano posati sulla bilancia.Nel frastuono rimbombante dell’enorme Pescheria, io e il dolore del mondo eravamo unodi fronte all’altro, senza difese, soli.Da quel momento, nelle notti insonni, ai lupi e agli scheletri si erano così aggiunte anchele canocchie. Mentre gli scheletri ballavano, loro si arrampicavano su per le tende. Le tendenon erano di stoa ma di carta paglia, così le loro zampe facevano un fruscio sottile. Piùche un fruscio, era uno stridio acuto, acutissimo. Per non sentirlo e per evitare che mifacesse esplodere il cuore, ero costretta a tapparmi le orecchie con le dita.L’Acquario, in questo senso, era un conforto. Gli stessi pesci che agonizzavano inPescheria, là dentro vivevano nutriti e protetti, lontani dai pericoli e, per di più, con il loronome scritto su una targhetta.All’Acquario, allora, non c’erano gli esemplari multicolori che i bambini del mondoglob<strong>ali</strong>zzato sono abituati a vedere oggi, ma i pesci grigiastri e ordinari che vivevano nelleacque antistanti al porto. Guati e spari, sardine, menole, moli, cef<strong>ali</strong> e branzini nuotavanodi fronte a noi in mezzo a qualche alga di posidonia. Il motivo di eccitazione non stavanella loro visione – anche se era bello saperli in salvo – ma in quella della grande vasca conle mante e gli squ<strong>ali</strong>. E soprattutto nella coppia di pinguini che vivevano in una casettacome quella dei cani da giardino, con davanti una piccola vasca da bagno.Della pinguina non ricordo il nome, forse perché è morta giovane, ma il nome di lui,Marco, lo ricordano tutti i triestini della mia età perché era una specie di eroe cittadino.Viveva lì da tantissimi anni e, nelle giornate di bel tempo, veniva portato a passeggio lungo
il molo antistante all’Acquario, come fosse un barboncino.La vasca delle mante era quadrata e foderata di piastrelle – una via di mezzo tra un bidete una micropiscina – fornita di sgabelli di legno, per permettere ai bambini di guardaredentro. Gli squ<strong>ali</strong> credo fossero appena dei gattucci e le mante appena delle arzille, maallora non lo sapevo, mi parevano soltanto dei mostri spaventosi.Che gli squ<strong>ali</strong> potessero divorarti, lo sapevo già. Fu invece mio fratello a spiegarmi cheanche le mante, con la loro coda puntuta, erano in grado di darti una scossa mortale. Miofratello, infatti, non era mai in imbarazzo a manifestare un velato sadismo che si rivelòessere, da subito, un lato evidente del suo carattere. “Metti la mano nell’acqua,” mi dicevasuadente, “vediamo se succede qualcosa.” Ma io tenevo le mani rigorosamente serrate nelletasche del cappotto. Troppe volte mi ero data dei suoi inviti che non avevano tardato atrasformarsi in trappole.Durante quelle visite, provavo un po’ di pena per il pinguino. Mi sembrava che vivere suighiacci dovesse essere più bello che passare la vita tra una vasca da bagno e una cuccia dacani. La prigionia dei pesci, invece, non mi faceva impressione perché cattività, per loro,voleva dire salvezza. Neppure a me, in fondo, sarebbe dispiaciuto vivere in un piccolospazio confortevole, nutrita regolarmente, protetta dagli imprevisti e immersa in unacostante penombra piena di blu-blu.Con Gianna raggiungevamo le diverse piste da pattinaggio della città. Nei pomeriggiinvern<strong>ali</strong>, quando la luce terminava presto, ci portava a quella più vicina a casa, inpiazzale Rosmini. Nelle giornate più lunghe, invece, andavamo a quella straordinariamenteeccitante del giardino di San Michele – una pista fatta a otto, con s<strong>ali</strong>te e discese che,all’epoca, mi sembravano foriere di straordinarie prodezze – oppure alla pista lontanissimadi Villa Revoltella.Compito principale di mio fratello, in quei frangenti, era quello di farmi cadere nelpeggiore dei modi il maggior numero di volte, e compito mio era quello di stare in piedi ecercare di salvare la pelle.I ruoli rimanevano immutati quando, nelle giornate estive, andavamo al bagno Ausonia.Lì, invece di spingermi o strattonarmi, aveva l’abitudine di tenermi la testa a lungosott’acqua. Quanto tempo poteva resistere un essere umano senza respirare? si chiedeva,curioso. Erano i tempi di Enzo Maiorca e, quando nessuno lo vedeva, credo cercasse ditrasformarmi in una sua diretta emula. Per questo, anche a casa, mi faceva ripetere gliesperimenti nella vasca da bagno, nel lavandino e anche nella tazza del gabinetto.Avevo il terrore di quegli esperimenti. Tra me e i pesci della Pescheria non c’era nessunadierenza. Entrambi, a parti invertite, lottavamo per sopravvivere – con branchie dilatate epolmoni compressi ci dimenavamo alla disperata ricerca di ossigeno.Al bagno Ausonia risale anche uno dei pochi ricordi legati alla gura di mio padre.Dovevo essere molto piccola e l’acqua intorno era davvero cupa, striata dalle scie oleosedegli scarichi del vicino porto. Mi avevano messo sulla sua schiena, le braccia allacciateintorno al suo collo. Lui lasciò la scaletta di ferro e cominciò a nuotare verso quello che a
me sembrava mare aperto.Stavo aggrappata sul suo dorso come fosse un delno. Avevo paura del buio intorno, ma,al tempo stesso, percepivo la sicurezza nei suoi movimenti e questo mi tranquillizzava. Losentivo incredibilmente forte, potente e, per alcuni brevissimi istanti – mai più ripetuti – hoavuto l’impressione che mio padre fosse qualcuno di cui in fondo avrei potuto fidarmi.Gianna ci portava anche avanti e indietro dalla casa dei nonni.Con Gianna andavamo a prendere una pallina di gelato. Più spesso, quando le nanzenon erano all’altezza, prendevamo solo il cono e il gusto lo aggiungevamo con la fantasia.Nei pomeriggi di pioggia, con Gianna, guardavamo le avventure di Rintintin. “Yuuuu,Rinty!” era il nostro grido preferito.Con Gianna, leggevamo i fumetti, costruivamo le casette con il Lego.Gianna ci faceva fare la merenda sul tavolo della cucina. Pane e marmellata o pane burroe zucchero che scricchiolava meravigliosamente sotto i denti.Sempre con Gianna guardavamo arrivare dal balcone i rimorchiatori che trascinavano lenavi. Venivano da Istanbul, da <strong>Su</strong>ez, dalla Polinesia, da tutti i luoghi che la fantasiageografica di mio fratello riusciva a suggerire.Con Gianna eravamo felici.Anche se c’era la bora che faceva tremare i vetri, quando c’era Gianna non eravamo aTrieste, ma a Capri.Gianna ci faceva sentire amati.Il trillo, puntu<strong>ali</strong>ssimo, del suo campanello era il trillo pavloviano delle ore di felicità.Occhi lucidi, s<strong>ali</strong>vazione abbondante, incipiente senso di benessere.Poi, un giorno, nell’autunno della mia terza elementare, il campanello rimase muto.Tre e trentacinque, tre e quaranta, tre e quarantacinque. Fissavo l’orologio della cucinacon ansia crescente, tre e cinquanta, tre e cinquantacinque. Alle quattro andai da miamadre in salotto, immersa, come al solito, nella contemplazione solitaria del vuoto.“Gianna non arriva,” dissi timidamente.E lei, senza interrompere la sua attività, rispose:“Gianna non verrà mai più.”
6.Risale a quell’epoca l’aacciarsi, nei miei pensieri, di una nuova categoria mentale,quella del vuoto. Prima una cosa c’era, poi non c’era più.Non era ben chiaro per quale ragione ciò avvenisse, ma era altrettanto chiaro che eraun’insidia di cui bisognava assolutamente tenere conto. Il pavimento su cui camminavamoera apparentemente solido. In realtà, sotto i nostri piedi, in alcuni punti c’erano dei mattonie in altri solamente della paglia, ma non erano distinguibili a vista, bisognava metterci ilpiede sopra per saggiare la reale consistenza.La vita, dunque, non era poi molto diversa da un percorso in un campo minato.Nell’atrio della scuola – che oramai avevo iniziato a frequentare – c’era un grandecartellone. Mostrava, sotto forma di fumetto, le avventure di un gruppo di bambini comenoi che andava in giro a giocare per le strade. Nel secondo riquadro, uno di loro trovava inun campo un oggetto dalla forma bizzarra e tutti insieme, per gioco, cominciavano apercuoterlo. Nell’immagine dopo c’era una specie di un fuoco d’articio, con amme elampi luminosi che andavano in tutte le direzioni. E in quella dopo ancora, ricomparivanogli stessi bambini, un po’ diversi da prima. A uno mancava una mano, a un altro tutt’e duele braccia, un terzo aveva la benda sugli occhi perché era diventato cieco e un altro ancorasi trascinava penosamente su una stampella di legno.Attenzione! Pericolo! Non toccare! Non giocare! c’era scritto in calce a caratteri cubit<strong>ali</strong> epoi, ancora più sotto, erano raffigurati diversi oggetti bizzarri – granate, mine, bombe aeree– le fonti di tutte le disgrazie.Esistevano dunque le voragini della paglia e, oltre alle voragini, i fuochi d’articio ingrado di strapparti le gambe. Potevi precipitare o diventare per sempre cieco.Non occorreva molta fantasia per capire che muoversi era comunque pericoloso.Meglio stare fermi, quindi, meglio trattenere il fiato.Mettendo un piede su una mina, saltavi in aria, disintegrato in mille pezzi come gattoSilvestro – con l’unica dierenza che la scena dopo lui si ricomponeva, mentre tu sarestirimasto a brandelli – ma mettendo il piede sul pavimento, dove mai saresti nito? Cosasarebbe successo di te? Sotto la paglia, cosa c’era? Il vuoto.Ma cos’era il vuoto?Mio padre era scomparso, il simpatico pediatra che per diversi anni era stato accanto amia madre – l’uomo dalla pelle scura e dalle orecchie pelose come un orso, che ci curava, ciportava a fare le scampagnate e ci regalava pistole da cow-boy e archi da indiani – erascomparso. Gianna era scomparsa.
Queste sparizioni non erano precedute da alcun segno premonitore, da alcun campanellod’allarme. Semplicemente, da un giorno all’altro, non esistevano più. Non avevano unnumero di telefono, un indirizzo, un luogo dove mandare una cartolina. Non accadevaneppure di incontrarle per strada, purtroppo. Persone a cui ero geneticamente legata, comenostro padre, o soltanto aettivamente, come Gianna, delle qu<strong>ali</strong> mi ero data,permettendo loro di contrastare la notte sempre in agguato dentro di me, erano svanite nelnulla.A quel tempo, mio fratello e io facevamo una raccolta di gurine. Si chiamava Genti ePaesi e quell’album – gono e crocchiante per la colla fatta con la farina – era la passione ditutti i nostri pomeriggi.In quell’album, oltre all’aurora boreale, avevo imparato a conoscere il fantastico mondodelle calotte polari. <strong>Su</strong> quei ghiacci perenni non cresceva proprio nulla, né un filo d’erba, néun muschio, né un albero, né un ore, niente. Anche gli anim<strong>ali</strong> che da noi erano marroni ofulvi, come le volpi, al Polo Nord erano bianchi. Bianchi come gli orsi che zampettavano sulpack, famosi per essere le creature più feroci del mondo animale, così come ferocissimeerano le loro compagne acquatiche, le orche assassine.Stare nel bianco e nel freddo faceva dunque diventare cattivissimi. Intorno alle calottenavigavano gli iceberg, che altro non erano che alte montagne di ghiaccio. Le didasc<strong>ali</strong>enon dicevano se, al loro interno, queste montagne fossero piene o vuote, come le uova diPasqua. Dato che anche il Carso, che sembrava apparentemente così solido, in realtà eradisseminato, sotto la sua supercie, di grotte, spazi cavi e foibe, mi ero convinta che anchegli iceberg contenessero al loro interno delle cavità vuote.Ma chi abitava in quelle bolle di ghiaccio? Le gurine non dicevano nulla in merito,dunque non erano state ancora colonizzate.In un pomeriggio in cui la bora faceva vibrare la casa, decisi che sarei diventata io laprima abitante dell’iceberg. Altri avrebbero avuto freddo, io invece mi sarei trovatabenissimo, ne ero sicura. La luce vi sarebbe arrivata ltrata, e così pure i rumori. Di tutto ilfrastuono del mondo non sarebbe arrivato che una debole eco e le persone non sarebberostate altro che delle sagome astratte. Non avrei avuto intorno a me che una montagna dighiaccio. Ghiaccio sugli occhi, ghiaccio sul cuore, ghiaccio sui miei pensieri. Ghiaccio sullemani e sui piedi.Era bellissimo essere finalmente un bambino di ghiaccio.Agli inesperti, il ghiaccio poteva sembrare come un fragile cristallo. Bastava percuoterlocon forza per accorgersi che invece era più duro dell’acciaio.Ghiaccio, vento siderale.Secondo una leggenda, la bora nasce in una misteriosa grotta in qualche luogo lontano elà dentro si arrotola, si srotola e si arrotola ancora, ruggendo con una furia semprecrescente per poi imboccare impetuosa la via d’uscita e iniziare la sua folle corsa verso lacittà. <strong>Ogni</strong> cosa viene travolta dalla sua invisibile e spaventosa forza, fa volare vasi e tetti,spezza rami, divelle alberi, sposta automobili e guidatori, poi si abbatte su Trieste e, dal
comignolo, entra nella casa dei miei nonni. Da lì scende, percorre le scale urlando ed escedal portone, lasciando, a memoria del suo passaggio, stalattiti di ghiaccio.Sì, quel portone – che varcavamo devotamente una volta alla settimana per andare atrovare i nonni – era simile a una grotta, arcuato, scuro, capace di aggredirti con un soogelato anche quando l’aria era ferma e la bora dormiva placida nelle sue lande desolate.Venivamo ass<strong>ali</strong>ti dall’odore acre di pipì di gatto appena entravamo nell’androne buio,passando davanti alla minuscola bottega di un ciabattino, calligher in triestino. Lovedevamo sempre in grembiule, chino su una scarpa alla oca luce di una lampadinaappesa a un lunghissimo lo, circondato da un gran disordine di chiodi, martelli, tomaie eda un forte odore di colla.In quel palazzo vivevano i genitori di mio padre e in qualche modo godevano della stessacaratteristica del figlio.C’erano, ma era come se non ci fossero.Del nonno – morto quando avevo solo tre anni – ricordo soltanto la rigidità del corpo, lanuca tesa, i baetti corti, tipici di chi cova dentro di sé una rabbia malamente repressa.Della nonna rammento invece quasi soltanto la sua cucina. Era di origine ungherese e illivello di colesterolo spaventosamente alto con cui combatto da anni credo sia un’eredità diquei suoi primi deliziosi pranzi. Palacinche fritte, ripiene di carne, annegate nella pannaacida, goulasch con patate che navigavano nella cipolla e nello strutto, cavolori ricopertida tonnellate di pangrattato fritto nel burro, radicchi conditi con strisce di lardo croccante.Per quanto mi sforzi, però, non riesco a ricordare che vagamente il suo volto. Mi avevanodetto che era malata di cuore, per questo stava spesso a letto come la nonna di CappuccettoRosso. Vedo ancora la federa, la trapunta su cui posava le mani, ma né il viso, né la bocca,né lo sguardo riemergono dal passato. Eppure andavamo lì tutte le settimane. Eppure, ognianno, per i nostri compleanni, ci regalava una moneta da cinquecento lire, con sopra le trecaravelle, intimandoci, con voce tremolante, di non spenderla. Ma – a parte la voce, che mipareva molto simile a quella del lupo dopo che ha mangiato la nonna – di lei non ricordoaltro.La casa era buia e priva di riscaldamento. C’era un’unica stufa a cherosene che attiravatutta la mia attenzione. Passavo infatti gran parte della mia visita in ginocchio lì davanti aosservare le amme che danzavano, oscillando a destra e a sinistra, e cambiavano colore:rosse, gialle, arancio, arancio, gialle, rosse.Da quando ero venuta a conoscenza dell’esistenza dell’inferno, le ssavo con ancormaggior interesse. La stufa aveva un tubo marrone che spariva nel sotto, dunque misembrava abbastanza logico che, all’interno, ce ne fosse un altro che andava invece verso ilbasso. E quel tubo altro non era che il comodo ascensore per andare giù, sotto la crostadella terra, a trovare i satanassi. Non provavo alcun timore nei confronti dei diavoli.Rispetto agli scheletri, ai lupi e alle canocchie, mi sembravano soltanto dei pallidi figuranti.I pranzi domenic<strong>ali</strong> si svolgevano in un silenzio quasi assoluto. All’inizio mia madre –nuora devota, nonostante la scomparsa del marito – aggiornava la nonna sui fatti dellasettimana. Terminato però in breve il notiziario, sul tavolo scendeva una cappa di silenzio.
Si sentiva solo il tintinnio delle posate, il ruminare delle mandibole, il gorgogliare delletrachee attraverso cui passava l’acqua.Tra tutti i commens<strong>ali</strong>, però, la zia Marisa era la più silenziosa.Il suo posto era sempre apparecchiato, il suo bicchiere sempre pieno, eppure lei nonbeveva, non usava le posate, non srotolava e arrotolava il tovagliolo, non vi lasciava sopramacchie di rossetto o di sugo come facevamo noi.Non potevo dire se la zia Marisa mi era simpatica o antipatica. La sua presenzaintroduceva una nuova categoria nell’universo mentale del mio iceberg. La zia, infatti, eratrasparente. Non si vedeva, ma c’era. A dierenza di Gianna o del pediatra, che prima diessere inghiottiti dal vuoto erano esistiti, avevano avuto una voce, un volto, un modo diparlare, lei no. Lei era invisibile. O, perlomeno, io non riuscivo a vederla. Altrievidentemente sì, dato che si sedeva a tavola ogni giorno e aveva anche una stanza nellaquale noi avevamo il divieto assoluto di entrare e di curiosare.Ci passavamo davanti quando andavamo a lavarci le mani e, ogni volta, avevo unapaura tremenda. Da un momento all’altro, infatti, con un gelido colpo di vento, quellaporta poteva spalancarsi e risucchiarmi al suo interno no a farmi scomparire nel nulla,fino ad arrivare nell’antro della bora o nel gorgo nero da cui si generavano gli scheletri.Solo molti anni dopo, appresi che la zia non era un fantasma, ma la sorella di mio padremorta a vent’anni. Mia madre lottò come una belva perché io non portassi il suo nome. “Ilnome di una morta? Mai!” fu il suo grido di battaglia.Un giorno poi mio padre, in una delle sue fugaci comparsate, mi consegnò – come fossela cosa più preziosa del mondo – un frustino da cavallo. “Era della zia Marisa, ottimaamazzone,” mi disse. E di conseguenza, ottima amazzone avrei dovuto diventare anch’io.Già, perché per la famiglia di mio padre, nome o non nome, io comunque ero, anzi,dovevo essere lei. Dovevo avere i capelli lunghissimi e raccolti in una meravigliosa treccia;dovevo andare a cavallo dalla mattina alla sera, con piglio severo; dovevo sedurre tutti gliuomini al mio passaggio, con un semplice sguardo. Insomma, avrei dovuto in tutto e pertutto, con la mia modesta gura, riempire il vuoto spaventoso che la zia Marisa avevalasciato nelle loro vite.Per qualche mese venni dunque portata in un maneggio. Non avevo più di sette anni. Icavalli erano spaventosamente grandi, terribilmente alti, smisuratamente larghi eincontrollabili. La bambina dell’iceberg ne aveva un sacrosanto terrore.Per fortuna, dopo poche lezioni, il cavallo che mi avevano assegnato si imbizzarrì e miscaraventò oltre il suo collo, passandomi sopra. Mia madre decise nalmente che quellasarebbe stata l’ultima rappresentazione del lm La zia Marisa ritorna. Quell’orrendostrumento, il frustino, girò ancora un po’ per i miei cassetti e, alla ne, con mio grandesollievo, si ruppe.Il secondo atto di ribellione, lo compii io più tardi, al tempo delle medie. Uscii infatti dasola, un pomeriggio, con i miei risparmi in tasca e andai dal parrucchiere. “Cosa facciamo?”mi chiese il titolare, già con le forbici in mano.
“Tagliare tutto,” risposi decisa, “tagliare corto.”Pur dovendo essere il suo aspirante clone, nessuno mi aveva detto come era morta la ziaMarisa. Fumi, mezze parole, gelidi sorrisi. Fat<strong>ali</strong>tà. Un morbo misterioso. Un errore delmedico. “Era debole?” chiedevo allora. “Era malata? Aveva la tubercolosi?”“Ma no,” mi rispondevano, “era sana, sportiva, andava sempre in montagna con il suocane lupo. Stava a letto, sembrava dormisse, e invece era morta.”Di colpo, quando ero in quinta, non andammo più a pranzo dalla nonna. La sua casa, lesue palacinche, le sue cinquecento lire smisero di esistere. Il pavimento aveva ceduto eanche lei era scomparsa.Per nove mesi nessuno mi disse niente.In giugno comparve mio padre e così io, raccogliendo tutto il mio coraggio, diedi atoalla domanda che da mesi avevo dentro.“Ma la nonna è morta?”“Morta o viva, che importanza ha?” Poi, con fare aettuosamente condenziale,aggiunse: “Vedi, in realtà, siamo tutti già morti, siamo soltanto polvere che si trasforma. Ilvuoto ci genera e al vuoto – vuoti – torniamo. Per questo, avere sentimenti è una cosainutile, tutto sommato.”Da lì a pochi giorni la scuola sarebbe nita, l’aria tiepida di giugno portava l’odoresalmastro del mare. Eravamo fermi davanti al cartellone di latta di un bar che mostrava igelati della mia marca preferita, quella con i due orsetti. C’erano ghiaccioli multicolori,ricoperti, coppette, meravigliosi coni.Ricordo di averlo ssato intensamente e di avere poi abbassato lo sguardo sui mieisand<strong>ali</strong>, quelli sì sporchi di polvere. Poi dalla profondità del mio iceberg salì un pensieroche era come un grido. Io non sono il vuoto! Io voglio vivere! Voglio tuarmi, nuotare!Voglio mangiare tutti, ma proprio tutti, questi gelati!
7.Che cosa sappiamo davvero di ciò che si trasmette, attraverso i geni, da una generazioneall’altra? Apparentemente molto, sempre di più, ma in realtà ancora quasi niente.Quando penso alla mia linea di discendenza paterna, al gelo che usciva da quel portone ea quello anaettivo che usciva da tutte le gure a me note, non posso pensare ad altro chea qualche micron di filamento trasmesso devotamente di generazione in generazione.Il gelo dei Carpazi, il gelo degli Ur<strong>ali</strong>, il gelo dei Kurgan, popoli scesi dalle steppeassieme al vento a colonizzare le miti sponde dell’Adriatico, il gelo della Transilvania, deivampiri addormentati nelle segrete dei castelli, dei morti viventi che, di paese in paese,attraversavano i Balcani bevendo slivovitz e raccontando storie.La verità sulla morte della sorella di mio padre la conobbi soltanto intorno ai trent’anni,in modo piuttosto casuale.Ero a Roma, durante una cena a casa di amici, e la mia vicina di tavolo, una signora diuna certa età – allora non ero ancora una persona nota – vedendomi prendere il tovagliolo,esclamò:“Le mani di Marisa!”“Probabilmente sì,” le risposi, “dato che sono sua nipote.”Allora la signora mi raccontò la storia che, da più di vent’anni, aspettavo di conoscere.Marisa era infatti la sua migliore amica, avevano fatto il liceo insieme, e con lei avevatrascorso gli ultimi giorni della sua vita. Mia zia allora viveva a Firenze, dove studiavaScienze natur<strong>ali</strong>. La mia vicina di tavola invece si era trasferita a Venezia da Trieste.Tornando a casa per le vacanze di Natale, Marisa si era fermata un paio di giorni atrovare la sua vecchia amica. Lì, vuoi per il freddo, vuoi per la stanchezza del viaggio, leera esplosa una brutta inuenza, così aveva chiamato il padre chiedendogli di poterrimanere a Venezia no a quando non si fosse sentita meglio. Ma il padre, uomo inessibile– nuca rigida e baetti stretti –, non ne aveva voluto sapere. “Il Natale si deve passare infamiglia! A questa regola non esistono eccezioni!”Così, seppure molto malata, Marisa dovette mettersi in viaggio da Venezia a Trieste conla bora, con il ghiaccio, con i treni del 1936. Arrivata a casa, prese parte al pranzo nat<strong>ali</strong>zio– che cosa festeggiassero non mi è chiaro, visto che erano tutti dei feroci anticleric<strong>ali</strong> – e simise a letto. Qualche giorno dopo, in quello stesso letto, passò dal sonno alla morte.Era sola a casa, il padre era uscito per andare al caè e la madre a incontrare delleamiche. Rientrati all’ora di pranzo, trovarono il suo corpo ormai freddo. Il morbomisterioso, il fato m<strong>ali</strong>gno, alla fine, non fu probabilmente altro che una polmonite.Dall’amica, poi, avevo saputo che Marisa era una persona libera, indipendente, ribelle e
dotata di un grande fascino, oltre che di una grande passione per i cani. Amava moltoanche la musica e, nché era vissuta, aveva tenuto una corrispondenza con Bruno Walter, ildirettore d’orchestra.Così, quella sera, dallo stampo il cui vuoto io avrei dovuto colmare, la zia Marisa sitrasformò nalmente in un essere reale, una persona con lati del carattere che avrei potutosentire molto ani. Per qualche ragione misteriosa, quel frammento di DNA – il frammentodel gelo, della linfa che si trasforma in ghiaccio e da lì irradia una Siberia interiore – in leinon si era replicato, ma era stata proprio questa diversità ad averla resa fragile, anche se inmodo diverso da me. Il gelo l’aveva colpita con la perentorietà degli ordini, con l’arroganzadell’autorità, con l’impazzare del credo darwinista.Soltanto qualche anno fa sono andata a cercare la sua tomba. In una grigia giornata dinevischio, ho dovuto girare in lungo e in largo prima di trovarla. Dato che noi Tamaroeravamo solo vuoto generato dal vuoto, non ero mai stata messa al corrente dell’esistenzadi un qualche tipo di umana sepoltura. Per quello che ne sapevo, i miei antenati paternipotevano anche essere impegnati a girare il mondo come zombi.Ma alla fine l’ho trovata.Dei semplici nomi incisi su una lastra di pietra circondata da una pesante catena. Nessunore, nessun ornamento – erbacce e rovi, come fosse il sepolcro di un romanzo gotico. Nellostriminzito vasetto preposto agli omaggi, c’erano soltanto sassi. L’acqua caduta con lapioggia si era ghiacciata imprigionandovi delle pietre. Impossibile inlarvi la rosa che leavevo portato. Così l’ho deposta sul suo nome, su quelle date di una troppo breve vita. Poisono scesa giù di corsa, senza più voltarmi.Marisa, dolce vittima della durezza e della follia.Per due anni ho frequentato l’asilo, del quale conservo pochi ricordi tristi e confusi legatiper lo più al mio malessere nei riguardi della soci<strong>ali</strong>tà.L’estate antecedente all’ingresso alla prima elementare, invece, era stata un periodo digrande eccitazione. Presto avrei avuto una cartella e dei quaderni, un astuccio con dellematite colorate e nalmente avrei varcato anch’io l’austero portone in cui già da diversianni entrava mio fratello.L’edicio, a dire il vero, non era particolarmente entusiasmante. Adesso gli spazi dedicatiai bambini sono pieni di luce, colorati, con meravigliose vetrofanie alle nestre. Ai tempidella mia infanzia, invece, erano cupi, austeri, niente nel loro aspetto faceva pensare a unluogo di gioia o di svago.La mia scuola era una costruzione di mattoni rossi, un lungo rettangolo con dueminacciosi torrioni ornati da due leoni alle estremità – l’entrata dei maschi e l’entrata dellefemmine – circondato da una acuminata recinzione. Un portone di legno pesantissimofungeva da fauce oscura. I bambini vi sparivano inghiottiti come fosse la bocca di unmostro. Non sembrava particolarmente invitante. Più che un luogo di istruzione, aveva laparvenza di un carcere, ma questo suo aspetto non smorzava aatto il mio desiderio divarcare quella soglia.Ricordo il primo giorno, la grande folla assembrata nella palestra, le maestre che, con
una lista in mano e voce squillante, chiamavano gli scolari a loro assegnati, il gruppo chevia via si assottigliava con le classi formate che uscivano dalla sala.Il mio nome non usciva mai, mai!Pensavo già che si fossero dimenticati di me o non mi volessero, quand’ecco: “Tamaro<strong>Su</strong>sanna!” I passi che feci per raggiungere i miei compagni furono quasi di danza, le gambetremavano per la paura, ma dentro di me c’era una forza più grande.Sapevo che, varcata quella porta, niente più sarebbe stato come prima. Avrei imparato aleggere, a scrivere, avrei trovato nalmente qualcuno che avrebbe risposto a tutte ledomande che avevo in testa e alle qu<strong>ali</strong> mio fratello non aveva saputo rispondere.Le domande!L’incubo, l’ossessione della mia vita, il lo rosso che univa i miei giorni alle mie notti,quel lo che molto spesso si trasformava in rete, in groviglio. Là dentro sì, avrei trovato ilbandolo, qualcuno me lo avrebbe messo in mano e allora i miei pensieri si sarebberodipanati ariosi, sarebbero stati pensieri-aquilone. Io avrei tenuto in mano un’estremità dello e loro, sospinti da una brezza leggera, sarebbero s<strong>ali</strong>ti in alto, sempre più in alto concode colorate, lunghe, fruscianti. Sarebbe bastato alzare il naso per riuscire ad ammirarli.I primi due anni sono stati meravigliosi. La mia maestra, la maestra Soldati – per unavolta il nome non corrispondeva alla realtà –, era una persona allegra e serena, che amavamolto il suo lavoro. Abbecedario, stanghette, lineette, curve, tabellina dell’uno, del due,castagne nel riccio, il grappolo con gli acini e i vasi pieni di fagioli posati nell’ovatta vicinoalla finestra.Gli unici anni di scuola in cui davvero ho imparato qualcosa sono stati quelli, piccolosprazzo di Capri incastonato in una cupa caserma inglese. In sottofondo quasi si sentivaFuniculì funiculà. Mi ero persino dimenticata di essere una persona drammaticamentetimida, una bambina che aveva enormi difficoltà a parlare.Mio fratello e io andavamo e tornavamo a scuola a piedi, con qualsiasi tempo, inqualunque stagione.Lungo la strada ogni tanto compariva un signore che ci invitava ad andare a vedere il suoacquario. A me sembrava una proposta piuttosto interessante, ma mio fratello neanche glirispondeva e tirava dritto.Allora non si sapeva neppure cosa fosse un pedolo ma i bambini erano perfettamenteaddestrati a non parlare con gli sconosciuti, a non accettare caramelle e proposte di alcuntipo.Poco prima della scuola, ci fermavamo alla panetteria a comprare la merenda.Ovviamente i soldi li gestiva mio fratello e così, n da subito, ha cominciato aimbrogliarmi. “Sei malata,” mi ripeteva, “malata di fegato, per questo devi mangiare ilpane senza niente dentro.” Così nell’intervallo, addentavo sempre un panino tagliato in duee vuoto. E lui si mangiava doppia razione di cioccolata.Quegli anni – i miei sei, sette – sono stati anni di relativo respiro. C’era Gianna e la
promessa luminosa del sapere, con l’aettuosa presenza materna dell’adorata maestra.Ancora non ero scesa nel mio iceberg, ancora potevo illudermi di essere una bambina cometutte le altre. Avevo persino stretto amicizia con una compagna di classe che abitava nelpalazzo accanto al mio. Lei, Daniela, era quello che io non ero: sicamente robusta,estroversa, intraprendente e, come se non bastasse, padrona anche di un cane dalmata,Lady, cosa che nell’epoca della Carica dei 101 non era davvero poco.Aveva una madre con lunghi occhi verdi che faceva la madre, aspettava il ritorno dascuola dei gli e preparava patate fritte e cotolette croccanti. Con Daniela condividevol’assoluta insoerenza per i giochi delle altre bambine e una certa inclinazione perl’avventura, che in me era per lo più teorica, ma che lei era abilissima a trasformare inpratica.Ricordo ancora con vero terrore la volta in cui abbiamo deciso di andare in canotto aVenezia. Avevamo fantasticato per giorni su questo. Volevamo arrivare a piazza San Marco,scendere dal mio minuscolo canotto – quello che doveva volare –, parcheggiarlo, dare damangiare ai piccioni e tornare indietro.Sembrava un’impresa davvero meravigliosa. Peccato che una volta arrivate al largoavessimo scoperto l’esistenza delle correnti. Remavamo, remavamo e il canotto andavadalla parte opposta! L’immagine dei piccioni di piazza San Marco si trasformò allora inquella di Robinson Crusoe, di cui da poco avevo visto le avventure in televisione. Restosempre stupita di quanti pochi bambini muoiano ogni giorno per le conseguenze dei lorogiochi.Primo ottobre della terza.Rientro in classe, dopo le vacanze, con passo leggero ed esco, cinque ore dopo, con ilcuore racchiuso in un morso d’acciaio. Il pavimento aveva ceduto e la maestra non c’erapiù, era stata inghiottita da quel gorgo oscuro, come un maelström che in perpetuomovimento roteava intorno a me.Scomparsa la maestra Soldati, sparita la classe, smembrata e diluita nelle aule intorno.Credo di aver pianto per un mese intero.Mi svegliavo e piangevo, mangiavo e piangevo. Andavo a scuola e piangevo. Facevo icompiti e piangevo. Dormivo poco e, al risveglio, il cuscino era sempre bagnato. Persinomia madre, mossa a pietà, mi aveva bisbigliato: “Non è morta, è solo andata in pensione.”In quel mese di ottobre, una parte di me – la parte che aveva sperato, che si era illusa –era completamente morta. Sapevo che, da quel giorno in poi, avrei dovuto conviverci. Perun po’, forse, sarei riuscita a tenerla nascosta, ma poi il suo forte odore di decomposizioneavrebbe finito per svelare anche agli altri la mia reale situazione.La nuova maestra aveva una dicile situazione familiare e dunque il suo comportamentoera molto diverso da quello che conoscevo. Urlava, si spazientiva per poco. Sotto le sue urlami trasformavo in un paguro bernardo. Entravo nella conchiglia e chiudevo le paratiestagne.Non sentire, non sapere, non vedere.
<strong>Ogni</strong> tanto percepivo una sorta di eco lontana – spiegazioni, grida, risate dell’intervallo,tutte cose che non mi riguardavano più.Durante l’ora di ginnastica, marciavamo al ritmo di un tamburello. Avanti e indietro,indietro, avanti, anco dest, anco sinist, paaasso, dietrofront. Io battevo sempre il passofuori tempo, mi giravo sempre dalla parte sbagliata. Sopra sotto, destra, sinistra, niente miera chiaro dello spazio intorno. Spazio di rischio, spazio di minaccia.La creatività letteraria latitava notevolmente. Nei pensierini liberi scrivevo “Oggi c’è ilsole”, se quel giorno c’era il sole; se invece c’era la pioggia “Piove e fa freddo”. La liberaespressione – quella che al giorno d’oggi va tanto di moda – mi metteva in una condizionedi assoluto terrore.I numeri invece mi davano conforto. Erano lì e lì stavano dalla notte dei tempi. Le dita diuna mano erano cinque e questo era v<strong>ali</strong>do in tutto il mondo. Se le mani erano due,diventavano dieci, e anche questo era universalmente riconosciuto.La stessa cosa valeva per i solidi. Una palla era una palla, un dado un dado; solo unpazzo avrebbe potuto negare una realtà così evidente.Riettendo nel silenzio della mia conchiglia, ero giunta alla conclusione che ogni oggettoesistente dovesse avere il valore anche di un numero e che dunque, sommandoli tuttiinsieme, avrei potuto arrivare a quello che da sempre cercavo – il numero dei numeri, ilnumero che conteneva tutto ed era in grado di generare tutto.Così, con l’umiltà di chi sa di avere davanti a sé un lungo lavoro, mi ero messa a contare.Era quella, infatti, l’unica strada che conoscevo per giungere alla meta. Contavo in tutti imomenti liberi del giorno. La sera, su un foglietto, scrivevo la cifra raggiunta e la mattinadopo ripartivo da lì. Contavo quando mio padre c’era e quando non c’era; contavo quandomia madre guardava il vuoto con la benda sugli occhi e quando se la toglieva per cucinare;contavo quando mi schiantavo brutalmente sul cemento della pista da pattinaggio; contavosulle soglie della notte; contavo per la strada, sull’autobus, sotto il tavolo della stanza deinonni.Contavo e quei numeri erano il lo d’oro dei miei giorni, che si dipanava di stanza instanza, di curva in curva, come nel labirinto di Minosse. Seguivo quel lo e i miei giorniavevano un senso, una direzione, sapevo da che parte andare e perché ci stavo andando,nessuno ancora mai mi aveva dato delle risposte così esaurienti. Ho contato con devozione,con pazienza, con segreta felicità. Ho contato nché una mattina, al risveglio, unadomanda terribile è sorta nella mia mente. Come avrei potuto riconoscere il numero cosìgrande da contenere e generare tutti gli altri numeri? Sarebbe successo come nei ipper deibar, quando d’improvviso si illumina tutto?Oppure…?
8.Dio fece il mondo in sette giorni e alla ne di quel lavoro immane, con la fronte ancoragocciolante e le mani impolverate, raccolse in un sacco tutto ciò che gli era avanzato –tonnellate e tonnellate di sassi acuminati – e lo adò a uno dei suoi angeli preferitidicendo: “Va’ e buttalo al di là dell’universo!”L’<strong>angelo</strong> ubbidì e, caricato di quel peso per lui leggero, si mise in volo per raggiungere iconfini delle terre note. Come tutti gli angeli, era molto sereno e volava fischiettando, senzadarsi pena di quello che succedeva intorno. Non ricordava che uno di loro – il più bello, ilpiù amato – aveva tradito il patto con il Creatore; così non si rese conto che proprio lui,Lucifero, lo seguiva in silenzio, pronto a fargli uno scherzetto. Proprio mentre sorvolava illuogo dove ora sorge Trieste, il diavolo gli si avvicinò, tagliò di netto il sacco con uncoltello, facendo precipitare al suolo con un grande boato tutti gli scarti dell’universo etrasformando così il ridente luogo sottostante in un’arida e tagliente pietraia.<strong>Su</strong> quella pietraia qualcuno ebbe poi la pessima idea di fondare una città e qualcun altro,cioè io, l’altrettanto pessima idea di nascervi.Sassi aguzzi, sassi taglienti.Sassi impalpabili, come polvere, capaci di entrarti dentro.Sassi negli occhi, sassi nel cuore.Sassi come spugne, in grado di assorbire liquidi e umori.Sassi come piovre, pronti ad aerrarti con i loro lunghi tentacoli e ad attirarti nei loroanfratti oscuri.Come dubitare di questa leggenda che ci veniva raccontata a scuola? Come sfuggireall’idea che un destino malvagio si era accanito su quelle terre? Nell’ora di canto, con igrembiuli inamidati, i occhi e le treccine legate da coccinelle di plastica, intonavamo contrasporto Il testamento del capitano.E il capitan della compagniae l’è ferito e sta per morire manda a dire ai suoi alpiniperché lo vengano a ritrovar […]“Cosa comanda sior capitano?che noi adesso semo arriva’”“E io comando che il mio corpoin cinque pezzi sia taglia’”“Il primo pezzo alla mia patria
che si ricordi del suo alpin,secondo pezzo al battaglionche si ricordi del suo capitan,il terzo pezzo alla mia mammache si ricordi del suo figliolIl quarto pezzo alla mia bellache si ricordi del suo primo amorl’ultimo pezzo alle montagneche lo fioriscano di rose e fior.”Le nostre voci argentine vibravano nell’aula, elencando i pezzi in cui sarebbe statotagliato il capitano. Con la stessa passione cantavamo Il Piave mormorava e altre canzonidella prima guerra. Quando intonavamo Tapum, tapum, tapum le nostre code, le nostretrecce, i nostri fiocchi tremavano all’unisono.Siamo cresciuti nel culto della prima guerra mondiale. La seconda, conclusa da neanchevent’anni, non veniva mai nominata. A ricordare la sua esistenza erano sucienti imanifesti sulle mine appesi nell’atrio della scuola, insieme alle rovine, ai dolori e agli odiseppelliti all’interno di ogni famiglia. La terra che li ricopriva era leggera, sabbia appena eniente più. Sotto quei granuli di silicio era possibile intravedere ancora le braci,baluginavano apparentemente innocue nella cenere, in realtà sarebbe bastato un sooleggero per farle divampare nuovamente.La seconda guerra mondiale era il grande fantasma silenzioso che ci seguiva passo passo.La prima, invece, era il nostro habitat siologico. Oltre che a cantare le sue canzoni e aconsiderare i suoi eroi più famosi come divi del cinema, venivamo anche portate in gitapremio nei luoghi dove si era svolta.A sette anni, visita a Redipuglia. Una sc<strong>ali</strong>nata enorme e bianca, circondata da cipressi.Ci arrampichiamo su per i gradini.“Sapete cosa c’è qua sotto, bambine?”“No, signora maestra.”“Ci sono le ossa dei morti. E sapete quanti sono? Più di centomila!”“E perché non stanno a casa loro?” chiede una vocetta.“Perché la maggior parte di loro non ha una casa a cui tornare. Ci sono state tante madrie tante mogli che non hanno potuto piangere i loro cari.”“E perché?”“Perché erano ridotti in pezzi troppo piccoli, era dicile trovare un nome per ognuno diloro.”“E allora adesso possono venire qui?”“Certo. È una bella cosa, no?”S<strong>ali</strong>vo e sentivo le ossa scricchiolare sotto i piedi; mettevo un piede dopo l’altro titubante,pronta a scorgere in quel marmo bianco la prima crepa dalla quale sarebbero potute uscire
delle tibie, un teschio, una mandibola, qualche clavicola.Chi aveva portato tutte quelle ossa lassù? E come avevano fatto a distribuirle?L’immagine che avevo davanti agli occhi era quella di una partita di shanghai, il giococinese con i bastoncini. Si apre la mano e i bastoncini cadono ovunque in modo disordinato.Doveva essere successa la stessa cosa con le ossa.Centomila morti signicava un numero strepitosamente più grande di ossa. Un giorno,intorno a quelle ossa, c’era stata della carne, le tibie si chiamavano gambe, l’omero e l’ulnabraccia, il teschio era stato una testa e quella testa avrà avuto di sicuro dei pensieri.Quando arrivai in cima, pensai che il capitano della canzone, alla ne, aveva fatto benea farsi tagliare a pezzi. Fosse rimasto lì, la sua mamma e la sua danzata probabilmentenon sarebbero riuscite a trovarlo e avrebbero pianto sulle ossa di un altro.Mi era dicile, però, immaginare come fosse potuta avvenire la divisione delle parti.Avevano forse una sega i suoi alpini? Oppure si erano messi a tirare da una parte edall’altra, come fanno i cani quando si contendono un boccone?E chi aveva deciso quale pezzo mandare?E come l’avevano mandato, per posta?Forse no, la posta, mi dicevo, è un’invenzione troppo moderna. Allora si andava a piedi oa cavallo e dunque i soldati dovevano essere partiti ognuno al galoppo con un pezzo delcapitano nello zaino.Sebbene stessi camminando sopra le ossa di tutti quei poveri morti, continuavo aimmaginare quel tempo come un’epoca lontanissima. In realtà, dalla ne della Grandeguerra non erano ancora trascorsi cinquant’anni.Alla gita a Redipuglia, seguì quella a Oslavia.Lì, sulla cima di una collina vicino a Gorizia, c’era una grande costruzione di pietra aforma di cilindro. Entrando in quell’enorme spazio chiaro non si vedevano altro cheminuscoli cassetti che arrivavano sino al sotto, simili a quelli della dispensa dove mianonna teneva lo zucchero e la farina.A me sembrò un posto magnifico in cui avrebbero potuto nidificare i colombi.“Sapete cos’è questo luogo, bambine?”“È l’ossario, signora maestra!”“E in questi cassettini…?”Ormai edotte, rispondemmo in coro: “Ci sono ossa, signora maestra.”Poi tutte fuori, sedute sui muretti di pietra, con il pranzo al sacco – mangiavamo insilenzio o parlando piano perché quello era un luogo sacro alla patria – e di nuovo sulpullman, con il caldo, il panino che stentava a scendere e un groppo in gola che volevas<strong>ali</strong>re. Nausea, capogiro, malessere, senso di profondo disagio.Come la maggior parte dei nonni della mia generazione, anche il padre di mia madreaveva fatto la prima guerra mondiale. Era l’unico vero “it<strong>ali</strong>ano” della famiglia. Nato in
una famiglia poverissima piena di fratelli e sorelle sulle montagne dell’It<strong>ali</strong>a centrale, si eratrovato molto presto ad arontare la dicile scelta di come riuscire a sopravvivere.Essendo un ragazzo sveglio, il parroco perorò la sua entrata in convento o in seminario, mail nonno era una persona di appetiti estremamente terrestri, così declinò l’invito. A quindicianni viveva già a Ventotene e lavorava come secondino nel locale carcere. Riuscì apreparare da solo la maturità classica, che gli permise di sostenere poi gli esami diammissione all’Accademia militare di Modena, strada che, a quell’epoca, era l’unica,assieme a quella ecclesiastica, che permetteva a un ragazzo senza mezzi di ottenere unriscatto sociale. Arrivato diciannovesimo su quattrocento aspiranti, si trasferì a Modena e,quattro anni dopo, uscì dall’Accademia come giovane uciale. Sfortuna massima! Che annoera? Il 1914.Neppure un anno dopo era già in prima linea sul fronte. La sua guerra si svolse tra laValsugana, l’altopiano di Asiago e il Carso isontino. Venne ferito diverse volte, ma, graziealla sua forte tempra, riuscì sempre a sopravvivere.Anche il nonno ci portava a fare delle gite la domenica nei luoghi in cui si era bruciato lagiovinezza, ma erano di sapore molto diverso di quelle che facevamo con la scuola. Non ciparlava di ossa o di eroi dalle mirabolanti azioni, ma piuttosto dei sentimenti dolorosi edello strazio di un giovane uciale, costretto a mandare a morte certa i suoi soldati perobbedire agli ordini dei suoi superiori. L’esaltazione di un Enrico Toti, di un Cesare Battistio di uno Scipio Slataper era assolutamente sconosciuta alla truppa dei coscritti chedesideravano soltanto di riportare a casa la pelle.Nel piccolo paese in cui ora vivo c’è una stele che ricorda i molti morti della prima guerrasimile a quelle che esistono in ogni paese, città o borgo – dalla Sicilia al Piemonte – che hovisitato nelle mie peregrinazioni. Seicentocinquantamila morti, seicentocinquantamilaesseri umani che desideravano soltanto vivere.Il nonno fu anche tra gli uci<strong>ali</strong> che parteciparono all’azione di Cardano. In Valsugana,il battaglione avversario era costituito in gran parte da cechi. E i cechi, come una parte deitriestini, erano irredentisti, desideravano cioè sganciarsi dalla tutela dell’Impero asburgico.Così, con quella che ora si chiamerebbe un’operazione di intelligence, gli uci<strong>ali</strong> cechi siaccordarono con quelli it<strong>ali</strong>ani in modo da farli giungere vittoriosi a Trento, senza sparareneanche un colpo. Come sarebbe stato possibile? Nella notte prestabilita, avrebberoaddormentato le loro truppe con un pesante sonnifero, in modo da permettere agli it<strong>ali</strong>anidi marciare senza trovare ostacoli e conquistare così, trionfanti e indenni, la città di Trento.Una volta presi gli accordi e stabilito il piano, il cuoco sciolse nel rancio una droga dacavalli che fece cadere l’intero battaglione ceco in un sonno profondo, mentre gli uci<strong>ali</strong>it<strong>ali</strong>ani, con i nervi a fior di pelle, aspettavano nel buio l’ordine di avanzare.Aspettarono un’ora, aspettarono l’altra e non successe niente. Arrivò l’alba ed eranoancora lì, nella trincea, con i fucili in mano. La truppa ceca si svegliò – ahh!, che belladormita – e trovò Trento ancora lì, inespugnata roccaforte austriaca.Cos’era successo?Il comando it<strong>ali</strong>ano aveva passato la notte a litigare. Nessuno degli alti uci<strong>ali</strong> volevaentrare in città per secondo. Odi person<strong>ali</strong>, riv<strong>ali</strong>tà, invidie, ripicche, piccinerie, perverse
iflessioni di opportunità politiche dilaniarono così la loro notte. Alla fine non se ne fece piùniente. Avanti con le armi, avanti con gli eroi, avanti con i cassettini e le gradinate dariempire di ossa!Quando raccontava quest’episodio, mio nonno era ancora pieno di dolore e di rabbia.Non aveva nessuna stima per i suoi superiori che considerava, militarmente, degli inetti e,umanamente, dei crimin<strong>ali</strong>. Ricordò che, una volta, il cappellano del battaglione austriacovenne a parlamentare nelle loro trincee. “Per piacere,” lo implorò con le lacrime agli occhi,“non fatevi ammazzare così! Noi siamo cristiani, non ce la facciamo a uccidere altri esseriumani in questo modo! Praticamente vi buttate contro le nostre mitragliatrici!” Mio nonnopianse con lui. Ordini superiori. Ordini a cui non si poteva trasgredire perché, al momentodell’attacco, un plotone di carabinieri si sistemava alle spalle della truppa. Chi, al grido di“Savoia!”, non usciva a farsi crivellare dagli austriaci, veniva freddato da un loro colponella schiena. Carne da macello, tordi e quaglie da abbattere al momento del passo.Mio nonno si salvò perché, essendo uciale, fu il primo a balzare fuori dalla trincea, conla pistola in mano, gridando “Savoia!” Questione di secondi, di riessi che si attivano omeno. Le stesse pallottole che attraversarono le sue gambe colpirono alla testa e al petto isuoi soldati. Tutti morti.Queste nostre gite mi provocavano un turbamento diverso da quello delle visitescolastiche. Vedevo due lati della stessa storia, due modi dierenti di raccontarla. Il primo tispingeva a guardare le cose dall’esterno, a sentirti orgoglioso, a pronunciare parole alte,come eroismo, sacricio – la via della retorica. Il secondo ti costringeva ad alzare il velo delsipario, a guardare dietro e in fondo alle cose, a provare sentimenti nella cui complessitàera difficile riuscire a districarsi – la via della realtà.
9.Naturalmente, l’<strong>angelo</strong>, al posto di pietre, avrebbe potuto portare altri scarti, quelli deiori ad esempio. Centinaia e migliaia di semi e di bulbi inutilizzati, che, al taglio del sacco,sarebbero precipitati a terra, trasformando l’intera regione in un preludio di paradisoterrestre. Aprendo gli occhi in quel giardino fatato e camminando su tappeti di crochi ebucaneve, il mio carattere avrebbe forse preso una fisionomia diversa. O, perlomeno, la miavisione del mondo. Invece di essere inseguita da scheletri, sarei stata avvolta da corolle diori, al posto di tremare per il rumore delle mandibole, sarei stata stordita dal fragranteprofumo dei pet<strong>ali</strong>.In quegli anni, alle domande con cui perseguitavo mio fratello tutte le notti, se ne eranoaggiunte delle altre, scaturite dall’osservazione della realtà circostante. Il primo barlumeche ci fosse un mondo ancora più complesso e misterioso da arontare di quello che, no adallora, avevo conosciuto – la notte, il giorno, le stelle, il sole, i lupi e gli scheletri – si accesenella mia mente proprio durante una passeggiata domenicale con mio nonno.Il nonno, oltre a essere l’unico “it<strong>ali</strong>ano”, era anche l’unico sportivo della famiglia.Amava molto camminare e così, nei giorni di festa, andavamo a passeggiare con lui alparco di Miramare. L’attrattiva per noi bambini – non particolarmente entusiasti dellabotanica – era costituita dal fatto che laggiù c’era un piccolo lago con dei cigni e delleanatre. Portavamo spesso da casa un sacchetto di pane vecchio perché la parte piùappassionante della camminata consisteva proprio nel nutrire gli anim<strong>ali</strong>.Quel particolare giorno è stato immortalato da una foto in cui indosso una giacca dimaglia con dei bottoni dorati. Fu il giorno in cui mi feci la prima grande domanda nondirettamente legata alla concretezza del mondo naturale o ai fantasmi che tormentavano lamie notti. Sporgendo generosamente dalla balaustra il mio minuscolo braccio, infatti, avevooerto il cibo a quelle splendide creature e loro, invece di aerrarlo con la squisita graziache mi sarei aspettata, mi si avventarono contro con furia e ferocia, beccandomi le mani.Una specie di folgore attraversò il mio cuore, in quel momento. Se io do loro del cibo,dunque faccio una cosa gentile, perché loro reagiscono facendomi del male? Il lampoilluminò una zona oscura di cui, no ad allora, non avevo avuto coscienza. C’era unamancanza di conseguenza logica nelle azioni, e a questa mancanza non sapevo dare unnome. Mi sembrava naturale che, a un gesto gentile, si rispondesse in modo altrettantogarbato, che ci fosse cioè armonia tra queste due relazioni, ma così evidentemente non era.Da quel giorno, in me, nacque un nuovo paese. Un paese pieno di nebbie, di ombre, dicose poco chiare. C’erano le domande sulla realtà – il cielo, le stelle, la notte, il numero piùgrande – e, accanto a queste, esisteva un nuovo spazio dove sorgevano domande chesconfinavano in un altro tipo di realtà, di cui non avevo sospettato l’esistenza.A che cosa si doveva attribuire il comportamento dei cigni?
Se io ero buona con loro, per quale ragione loro non lo erano con me?Oltre agli scheletri e ai lupi, c’era dunque, nel mondo, un elemento ancora piùinquietante. Questo elemento non aveva un volto, un nome. Forse proprio per questo, con iltempo, ha cominciato a farmi più paura dei miei nemici abitu<strong>ali</strong>. In fondo, con il tempo,avevo imparato a gestire la danza macabra che popolava le mie notti. Potevo prendere lepillole, le polveri, potevo ripetere delle frasi o dei gesti magici e, con quelli, tenerla a bada.Ma il comportamento dei cigni?E quello degli esseri umani che si comportavano come cigni?Per quale ragione, nel mondo che mi circondava, esisteva questo motivo di non armonia?All’epoca, già non mi aspettavo più che mio fratello potesse rispondere come un oracoloalle mie domande, così quella zona di nebbia, inizialmente piccola, ha iniziato a roteare suse stessa come una trottola. Dalla mente è andata al cuore, dal cuore ai polmoni e da lì si ètrasformata in ragnatela. Il ragno era il padrone, con le sue zampe lunghe camminavaavanti indietro lungo le vene inoculando la sua pozione tossica dove più gli piaceva.Perché piangi?Perché ti butti per terra?Perché ti manca il fiato?Perché, perché, perché?Perché vivo con un nemico dentro, con la nebbia, con la notte, con lo smarrimento.Perché vedo il dolore e non posso farci niente. Perché vedo l’incompiutezza, il vuoto, ilfallimento e non ne capisco il senso. Perché sono sola, nessuno mi ascolta, nessuno miprende per mano. Perché da qualche parte in me intuisco un’armonia e una luce immense e,da questa luce e da questa armonia, mi sto allontanando come una nave che prende illargo; ciò che all’inizio era il senso di ogni respiro, con il tempo diventa il lampeggiare diun faro lontano. Piango perché ho paura del vuoto del buio e della solitudine che miattendono.A quell’età, non conoscevo i veri nomi dei sentimenti. Soltanto crescendo ho compreso chequello stato di profonda soerenza altro non era che compassione. Compassione era ciò cheavevo provato quando, dall’alto del seggiolone, avevo visto mio fratello volare giù dallasedia con uno schiao; era compassione quella che sentivo davanti ai miei genitori seduti inpoltrona a ssare il vuoto; compassione era quello che provavo per la strada, quandovedevo una persona anziana, o malata. Compassione per la loro solitudine. Compassioneper i pesci che uscivano dall’acqua con la bocca perforata dall’amo, compassione per igattini abbandonati, per i cavalli macilenti, per gli uccelli che il pediatra, la domenica,estraeva dal suo carniere dopo la caccia. Le loro piume erano morbidissime, le testecadevano avanti e indietro come pupazzi. Invano cercavo delicatamente di riaprire loro gliocchi con le dita. <strong>Su</strong>lle mie minuscole spalle di bambina si posava il dolore del mondo. Tuttociò che era ferito, mi feriva. Per questo piangevo, per questo mi buttavo per terra. Perquesto, appena potevo, sbattevo la testa contro il muro.
Invece di piangere, mio fratello giocava alla guerra.Bombardava, mitragliava, sparava. Sapeva fare perfettamente con la bocca il verso diogni arma, di ogni mezzo di guerra. Più cose esplodevano, più morti c’erano, piùraggiungeva uno stato di illuminata felicità.Durante l’estate, all’aperto, faceva deagrare anche delle piccole micce; ricordo ancora lospaventoso rumore di quelle esplosioni. A volte, si procurava della benzina o dell’alcol e liversava con gioia sulle lunghe le di formiche in giardino, no ad arrivare al formicaio.Metteva qualche petardo in un formicaio, tanto per gradire, e poi, incurante delle mielacrime e delle mie suppliche, dava fuoco al tutto, assistendo con gioia alla morte di tuttequelle creature innocenti.Quando poi riuscii ad avere nalmente un pesce rosso – il primo animale domestico dellamia vita – non c’era giorno che non minacciasse di versare nella sua vaschetta dellavarechina e non mi descrivesse il modo lento e atroce in cui sarebbe morto. “Lo troveraibianco, tutto bianco e gono,” ripeteva, saltellandomi intorno. Il non amore in cui stavamocrescendo creava in lui reazioni di sopravvivenza siologicamente opposte alle mie. Puressendo il mio riferimento aettivo, come potevo chiedergli consulenza, conforto? Comepotevo dirgli che per me anche la morte di una farfalla era motivo di grande dolore?
10.Vengo da una famiglia di grandi anticleric<strong>ali</strong>.Il mio trisavolo è andato addirittura in prigione per aver detto “sciocco” a un parroco.<strong>Su</strong>o glio, il mio bisnonno paterno, operaio ai cantieri nav<strong>ali</strong>, soci<strong>ali</strong>sta e libero pensatore,aveva convissuto senza mai sposarsi con la donna amata – un’operaia del pasticio – eaveva messo al mondo quattro gli senza mai fargli mettere piede in chiesa. Convivere, allane dell’Ottocento, era un atto di vera rottura, non battezzare i gli era quasi impossibile.Infatti, a un certo punto, fu costretto a farlo, probabilmente per poterli mandare a scuola, eallora decise di fare le cose alla grande. Scelse il giorno giusto – martedì grasso – e, oltre aiquattro gli, anche lui e la moglie si accostarono al fonte battesimale. Lo fecero entrandogià in maschera nella chiesa di Sant’Antonio, con i coriandoli in testa e, appena terminato ilrito, sparirono di nuovo in mezzo alla folla festante.La mia famiglia materna, pur non raggiungendo queste vette, viveva comunque unacondizione di totale indierenza nei riguardi della fede, considerata, nei migliori dei casi,una graziosa perdita di tempo. La scoperta che esistesse qualcosa che rispondeva al nome direligione, la feci andando a scuola. Negli anni sessanta, infatti, prima dell’inizio dellelezioni, i bambini avevano l’obbligo di dire una preghiera in piedi davanti al banco, con lemani giunte. In diverse occasioni dell’anno, c’era pure la messa obbligatoria. Di tutto quelloche accadeva in quel posto non capivo assolutamente nulla. Vedevo un signore vestito inmodo strano che ci dava la schiena, parlava una lingua incomprensibile ed era contornatoda una nube di fumo che faceva lacrimare gli occhi. Il fatto però che ci fosse tanta genteche, in devoto silenzio, guardava da quella parte mi faceva sospettare che forse, anche se ionon ero in grado di capire, lì dentro accadeva qualcosa di davvero importante.Le immagini del sussidiario cominciarono ben presto a confermare questa mia intuizione.Ce n’era una, in particolare, che mi colpì n dall’inizio. Un grande triangolo che irradiavaluce sul mondo sottostante. Quel triangolo si chiamava Dio.Non ricordo a che punto fossi della mia conta – tremilacinquecentododici odiecimilaventiquattro – ma ricordo di aver pensato di essere sulla buona strada, perché inumeri e i triangoli, in fondo, appartengono alla stessa categoria.E se Dio, come diceva il libro, aveva fatto l’universo, era evidente che aveva inventatoanche i numeri. Tutti i numeri, dal primo all’ultimo, erano quindi usciti dalla sua testa e,dunque, continuare a contare sarebbe stato un po’ come seguire i sassolini lasciati nel boscoda Pollicino. Prima o poi mi avrebbero portata alla meta.Oltre al triangolo, c’era un’altra immagine che mi sembrava piuttosto promettente, ed eraquella di un bambino aancato da due gure svolazzanti, una di colore rosso e l’altrabianca, che gli sussurravano qualcosa nelle orecchie Quella rossa rappresentava undiavoletto, la bianca un <strong>angelo</strong> e in mezzo, il bambino sembrava smarrito, come volesse
vivevo letteralmente appesa alle sue labbra ma, ben presto, la gioiosa attesa dellarivelazione si trasformò in una nuova forma di tormento.I bambini postconciliari colorano grandi album, cantano motivetti festosi e dormonotorpidi sonni, convinti che Gesù sia un amico che risolverà tutti i loro problemi, che faràfesta al loro arrivo, anche se poi, nella loro vita adulta, si trasformeranno nelle più grandicarogne del mondo. Comportarsi bene, comportarsi male – non c’è una grande dierenza,perché, alla fine, un gran colpo di spugna livellerà democraticamente tutte le nostre azioni.I bambini preconciliari, invece, stavano rigidamente seduti sui banchi, non avevano ildiritto di parola, imparavano a memoria parecchie cose invece di fare girotondi, e venivanoloro raccontate delle storie per niente rassicuranti.In quell’antro odoroso di mua e di pipì di gatto, ho imparato che i fratelli, per essere piùsimpatici a Dio, potevano uccidersi tra di loro e che, tra le attività predilette del Signore,c’era la richiesta ai padri di ammazzare i loro figli.Perché lo faceva?Per vedere fino a che punto erano disposti a ubbidire.Certo, poi, all’ultimo momento, lo fermava, chiedendogli di uccidere al suo posto unpovero capro impigliato tra i rovi, come a dire, si è trattato soltanto di una prova dicoraggio.Anche i Piedi Neri e gli Apache facevano cose del genere, ma erano uomini. Che bisognoaveva Dio di imporre una prova così terribile? Perché voleva sapere la verità sul cuore diAbramo e sulla sua fedeltà? Se era davvero così, se doveva ricorrere a quegli atrocischerzetti, crollava miseramente un altro teorema, quello della sua onnipotenza eonniscienza.E, in ogni caso, il povero capretto moriva ugualmente sgozzato.Che Dio era un Dio indierente al dolore degli anim<strong>ali</strong>? Un Dio che imponeva una provatanto crudele a una povera creatura che, per la sua stessa natura, era già innocente?Don Volpe diceva che dovevamo rivolgerci con ducia al Padre nostro che è nei Cieli. Macome si poteva provare questo sentimento davanti a un Padre che imponeva a un altropadre di ammazzare il proprio glio prediletto? Solo un’entità mostruosa, la stessa cherendeva i cigni feroci, poteva comandare una cosa del genere!Abramo ubbidì nonostante amasse alla follia suo figlio Isacco.E se avesse suggerito la stessa cosa a un genitore che non amava il proprio glio? Ilpadre in questione avrebbe obbedito con zelo e, anche se al momento fatidico, fosseapparso il capro d’ordinanza, lui avrebbe fatto nta di non vederlo e, con mano abile,sarebbe sceso sulla giugulare del glio zac! per poi dire contrito: “Oh, troppo tardi! Midispiace, non l’avevo visto.”I sentimenti vaghi e spesso minacciosi di nostro padre mi facevano immaginare situazionipotenzialmente inquietanti. Se la mattina, mentre si faceva la barba, Dio gli fosse apparso egli avesse detto: “Prendi i tuoi gli e port<strong>ali</strong> al Molo Audace, metti loro una pietra al collo egett<strong>ali</strong> in mare?” Non c’erano capri in riva al mare, il massimo in cui si poteva sperare era
un gabbiano…Insomma, più che un’entità saggiamente amorosa, quel triangolo con l’occhio in mezzo misembrava un mostro assetato di sangue dal quale era meglio fuggire a mille miglia.Terminata la parte biblica, entrò in scena Gesù. Camminava avanti e indietro per laPalestina assieme a un gruppo di suoi amici. Istintivamente ispirava una maggior ducia.Fiducia che però si incrinava ogniqualvolta don Volpe ripeteva che era il glio del Padre. Secosì era, pensavo rannicchiata nel mio banco, chissà qu<strong>ali</strong> mattane sta organizzando dietroquella sua aria serafica.A dierenza del Gesù attuale, il Gesù preconciliare aveva come principale interlocutore ildiavolo. Era una specie di sda continua, da cui Gesù usciva sempre vincitore. A volteSatana si presentava direttamente con la sua faccia, mentre altre preferiva nascondersidentro persone norm<strong>ali</strong> che, all’improvviso, si sentivano male. Ma Gesù lo stanava sempree, con poche parole, riusciva regolarmente a rimandarlo dove era venuto, cioè all’inferno.L’inferno era un luogo in cui divampavano le amme e il cui ingresso era rigorosamentevietato ai pompieri. Quel fuoco ardeva da sempre e sarebbe durato per sempre, perché ilsuo compito era quello di ospitare per l’eternità le persone che tanto buone poi non eranostate.E qui ci si ricollegava all’immagine del sussidiario: il diavoletto e l’<strong>angelo</strong> che sicontendevano l’attenzione del povero bambino. Se non si voleva nire là dentro, bisognavadunque vivere con un orecchio tappato, ascoltare l’<strong>angelo</strong> e basta, perché soltanto lui cidava consigli giusti, impedendoci di diventare ospiti di quel luogo arroventato. Il diavolo cisuggeriva soltanto peccati e i peccati, alla ne, non erano molto diversi dai punti delleraccolte premio. Più ne avevi, più rapidamente andavi all’inferno. L’<strong>angelo</strong>, invece, tisuggeriva come non farli.Forse, in virtù delle già tante gure spaventose di cui si nutriva la mia fantasia, non sonomai riuscita ad accogliere lo spavento del diavolo e dell’inferno nel mio mondo interiore.Non c’erano neanche posti in piedi là dentro, così sono rimasti fuori.Provavo invece una gran simpatia per l’<strong>angelo</strong>, soprattutto da quando avevo saputo cheognuno di noi ne aveva uno tutto per sé – il proprio <strong>angelo</strong> custode. Dato che la vita, no aquel momento, mi era parsa una realtà ricca di spiacevoli e rischiosi imprevisti, non eramale avere un amico invisibile e potentissimo. Tornando a casa dalle lezioni, loimmaginavo camminarmi accanto, luminoso e più alto di me, con enormi <strong>ali</strong> piumate emorbide, perpetuamente sorridente. Quando dovevo attraversare la strada, chiudevo gliocchi e dicevo tra me: “Pensaci tu!” Era un modo piuttosto empirico per accertarmi dellasua esistenza. Come saranno rimasti male gli automobilisti nel vedere quel raggio di luceche li fermava!Oltre che per l’<strong>angelo</strong>, provavo una certa simpatia per la mamma di Gesù. In fondo algiardinetto, in una grotta, c’era una sua statua con il manto azzurro e le braccia spalancate,pronte ad accoglierti. Sorrideva sempre con un’espressione dolce. Con lei potevo fare quelloche con la mia non osavo mai – guardarla dritta negli occhi senza provare terrore. Sì, quellagura era per me un’oasi di pace. Se mi avessero chiesto un parere in merito, avreisuggerito di far prendere rapidamente a Lei il posto del Signore che istigava a tagliare le
gole.Comunque, anche al livello del triangolo, le cose si erano parecchio complicate.Finalmente avevo saputo perché Dio non poteva essere un quadrato o un rombo. Nonpoteva perché, anche se sembrava uno, in realtà erano tre.Tre!!! Tre!!!Era stato come ricevere un colpo di gong in testa.Tre, continuavo a ripetermi, tre.Come è possibile comandare in tre?Le navi che vedevo entrare in porto accompagnate dai rimorchiatori avevano un solocapitano che le guidava. Un comandante sulla nave e un altro su ogni rimorchiatore.L’autobus che passava sotto le mie nestre aveva sempre un unico autista, la stessa cosasuccedeva anche per i treni e gli aerei.Cosa sarebbe successo se tre persone si fossero contese la guida di quei mezzi?Probabilmente avrebbero cominciato ad andare a zig zag, un po’ di qua e un po’ di là,secondo l’umore di chi era alla guida. Nessun capolinea, nessuna stazione, nessun portosarebbe stato più raggiunto.Ma ecco, forse eravamo arrivati al nocciolo della questione.Il mondo andava così male proprio perché i tre non si mettevano d’accordo!Comunque, se avessi potuto scegliere tra i tre, avrei scelto decisamente lo Spirito Santoperché, nel terzetto, la colomba, essendo un animale e dunque innocente, era quella che miispirava maggiore simpatia.Avevo ottenuto risposte in quei mesi?No, piuttosto una folla di personaggi ed eventi si era insinuata nella mia immaginazione,ampliando e complicando il numero delle domande. La questione dei cigni, invece dirisolversi, si era notevolmente ingarbugliata. Dio era buono, ripeteva don Volpe, ma, se erabuono, perché permetteva ai cigni di comportarsi in quel modo? E poi, da che punto di vistasi poteva considerare buono uno che istiga a fatti di sangue? Se era perfetto, onnisciente eonnipotente perché non aveva creato il mondo con questi attributi? Forse perché si sarebbeannoiato. Un mondo perfetto non avrebbe oerto nessuno spettacolo, nessunintrattenimento, un po’ come un pomeriggio di pioggia senza La tivù dei ragazzi.E per quale altra ragione aveva fatto il mondo, se non per svagarsi un po’? L’eternitàpiena soltanto di se stesso alla ne doveva essere noiosissima, così aveva inventato iltempo. Chissà come si divertiva a vedere la nostra agitazione, la nostra confusione, avedere i punti che accumulavamo caparbiamente nelle nostre tessere per farci nire da unaparte o dall’altra. Giù con lo scivolo, all’inferno! <strong>Su</strong> con l’ascensore, in paradiso!All’avvicinarsi della prima confessione, venni presa da un’ansia crescente. Tutti i possibilipeccati mi sembravano realtà molto lontane dalla mia vita. Non perché mi ritenessi santa –anzi quelle gure così arrendevoli e perfette mi inquietavano non poco – ma perché non miinteressavano. Invidiavo mio fratello, che ammazzava con il fuoco migliaia di formiche
innocenti. Almeno lui avrebbe potuto inginocchiarsi sereno e dire: “Ho formicato, padre.”Ma io?Mi arrampicavo sugli specchi per trovare un peccato. Certo, avrei potuto unirmi a miofratello nello sterminio ma poi, anche se il sacerdote mi avesse assolto, tutte quelle formichearse vive sarebbero rimaste sulla mia coscienza.E che cos’era più importante? Rispettare la vita o avere qualcosa da dire dietro quellatenda?Man mano che si avvicinava il mio turno, sentivo il terrore prendermi lo stomaco, nonper il peccato o per il diavolo, ma per l’impasse in cui si trovava la mia fantasia. Alla ne,quando si aprì la grata davanti a me, dissi tutto di un ato: “Ho rubato la marmellata!” Ilsacerdote mi diede una penitenza e io, con le guance incandescenti e un tentativo di ariacompunta, mi diressi verso i banchi. Appena inginocchiata, mi resi conto di essermi giàdimenticata quello che avrei dovuto fare come penitenza e un secondo dopo, grandiosa emagnifica, mi apparve la verità.Ce l’avevo fatta, avevo peccato!Avevo mentito.Già, perché non avevo mai rubato la marmellata, anzi, a dire il vero, la marmellata nonmi piaceva per niente. Sì, la bugia era proprio un peccato con la P maiuscola. Entusiastadella scoperta, tornai al confessionale, spostai la tenda trionfante, dicendo: “Padre,finalmente ho peccato davvero! Ho detto una bugia, non ho mai rubato la marmellata!”Con il passare dei mesi – quando le giornate cominciarono ad allungarsi, quando la boratornò nella sua tana, il giardinetto si ornò di modesti orellini e l’aria si caricò dei tenuiprofumi di aprile – mi accorsi che dentro di me l’oscurità non era più la stessa dell’autunno.Non si era dissolta, ma aveva cambiato nome e aveva un volto. A un tratto, la paurairragionevole e folle si era trasformata in timore. In punta dei piedi, sbagliando spessostrada, incespicando, stordita dalla confusa arditezza dei miei pensieri, ero comunquegiunta alle soglie di un territorio misterioso.Il territorio del sacro.E lì mi ero fermata, trattenendo il ato. Il giorno della comunione, davanti all’idea didover indossare l’abito bianco ebbi un moto di ribellione. Che bisogno c’era di travestirsi?Gesù mi doveva amare così com’ero, in sand<strong>ali</strong> e maglietta a righe.Poi, inginocchiata alla balaustra assieme a tutti gli altri, quando il sacerdote disse “AgnusDei, qui tollis peccata mundi”, un potente singhiozzo squarciò il mio minuscolo petto.L’Agnello era accanto a me, tenero, inerte.L’Agnello era accanto a me, con me.L’Agnello viveva in me, silenzioso, mite, generoso nel porgere le sue spalle a sostegno deldolore del mondo.
11.Intanto i miei genitori continuavano il loro viaggio alla ricerca di nuove mete esistenzi<strong>ali</strong>.S<strong>ali</strong>vano e scendevano da autobus sempre diversi, la casa era diventata la loro sala d’attesa;vi arrivavano impolverati, stanchi, silenziosi, tesi; bastava un rumore anche minimo perfarli esplodere in risse, brevi e ferocissime; tutto ciò che stavano scoprendo non dava loroappagamento o, forse, fuori da lì erano più felici. Era il ritorno nell’appartamento/salad’attesa a renderli così inquieti.Noi, comunque, sapevamo che erano fragili, inammabili, instabili, per questocamminavamo in punta dei piedi, stavamo sempre all’erta, pronti a percepire anche il piùpiccolo cambiamento di direzione del vento.Mio padre se n’era andato senza veramente andarsene. <strong>Ogni</strong> tanto tornava e recitava laparte del padre e del marito degli anni cinquanta. Usciva tutte le mattine in completogrigio, cravatta e borsa da lavoro in mano per andare a lavorare. Ho qualche vago ricordodel fatto che mi accompagnasse all’asilo. Era laureato in legge e dunque avrebbe dovuto – opotuto – fare l’avvocato, ma lavorare non era esattamente la sua vocazione. La riteneva inqualche modo un’attività infamante.A dire il vero, era un’idea condivisa da un po’ tutta la sua famiglia. <strong>Su</strong>o zio, dopo una vitatrascorsa alle spalle degli altri, a quarant’anni era stato costretto a trovare un lavoro.Umiliazione per lui intollerabile, alla quale ovviò il primo giorno di ucio estraendo unapistola dalla borsa di cuoio e sparandosi un colpo in testa.Dopo qualche anno di praticantato, mio padre si mise in aari con un lestofantepseudoarmatore e insieme a lui escogitò alcune operazioni trualdine di sicuro e facileguadagno. Peccato, però, che non fosse aatto furbo, né avesse quell’abilità levantina dellato materno della mia famiglia. Tra il Gatto, la Volpe e Pinocchio, lui sarebbe statosicuramente Pinocchio. Seppellì gli zecchini dove gli aveva suggerito il socio e rimase inattesa che crescesse l’albero di monete d’oro, per poter passare il resto dei suoi giorni nelPaese dei balocchi. Ma, al posto dell’albero, crebbero soltanto i guai.Un giorno si trasferì a Milano. Che lavoro facesse, però, restò un mistero. Ricordo il miosmarrimento davanti al primo terribile tema: Il lavoro del mio papà. Quel pomeriggio,raggiunsi mia madre in cucina con il quaderno in mano e chiesi: “Il papà, che lavoro fa?”Lei guardò a lungo nel vuoto e poi, con un sospiro, mormorò: “Il procuratore.” Non avevola minima idea cosa volesse dire “fare il procuratore”, così, per rendere le cose più semplici,scrissi che faceva il dattilografo, perché aveva delle grandi mani con unghie curate.Se un procuratore è stato mai mio padre, è stato un procuratore di guai. Da Milano,tornava a Trieste a bordo di una smagliante spider blu Pininfarina, che gli fece guadagnareparecchi punti agli occhi di mio fratello. Mia madre, invece, si inferociva. La considerava –come era in realtà – un manifesto di vita. Un padre di famiglia non guida una spider, a
meno che non sia così ricco da possedere anche una berlina o una giardinetta con cuiscorrazzare moglie e gli. Altrimenti, con i suoi unici due posti, quella spider aveva unsignificato inequivocabile – era uno strumento da seduttori.“I tuoi gli non hanno il cappotto,” gridava, “e tu hai la spider. Ci hanno pignorato lacasa per i tuoi debiti e a te non te ne importa nulla. Vai in giro felice, strombazzando con letue amiche.”E, in eetti, a lui non importava proprio nulla, non riteneva sua competenza prendersicura dei gli. Faceva spallucce e sorrideva: “Non sono aari miei, arrangiatevi!” Equell’“arrangiatevi” voleva dire una sola cosa: “Che ci pensi tuo padre a voi!”E, in eetti, fu mio nonno a pagare i suoi debiti e a mantenerci no a che mia madre noniniziò a lavorare.Molte volte mi sono soermata a osservare la foto del matrimonio dei miei genitori.All’uscita della chiesa, il volto di mia madre è raggiante di felicità, non altrettanto possodire di quello di mio padre – occhi fuggenti, inquietanti, occhi che non promettono niente dibuono.<strong>Ogni</strong> volta che la guardo, mi fa male al cuore. Accecata dall’amore e dalla giovane età,mia madre non si era accorta di chi aveva davvero accanto. Se avesse sposato un uomo chele avesse voluto bene, un uomo anche solo un po’ meno disgraziato di mio padre,probabilmente, sarebbe stata la splendida e appassionata madre che aveva sempredesiderato essere. Fin da ragazza, infatti, aveva considerato la maternità la cosa più di belladel mondo. Quando le cose intorno a lei – intorno a noi – cominciarono a sbriciolarsi cometenera roccia di tufo, cercò per un po’ di puntellare, di resistere, di proteggere i suoi glidallo sfacelo.Fingeva la norm<strong>ali</strong>tà, mentiva per nascondere le trame precocemente logore del lororapporto. Con l’aiuto della vicina di casa, la mattina spostava dalla porta d’ingresso ilcorpo esanime di mio padre, per permetterci di andare a scuola senza scavalcarlo.Esanime per il troppo alcool.Per qualche anno ce la fece, tappando i buchi di qua e di là. Correndo però da una parteall’altra, non si accorse che anche dentro di lei qualcosa aveva iniziato a franare. Eraconvinta di essere fatta di una solida roccia di calcare ma, con il tempo, il calcare sitrasformò in friabilissimo gesso e cominciò a sfaldarsi.Lo sfaldamento portò con sé nuovi assetti. Al posto di una parete solida, comparve unagrotta e, da quella grotta – da quella porta aperta sull’oscurità – uscì una persona di cui,no ad allora, nessuno di noi aveva sospettato l’esistenza. Un vento gelido accompagnò ilsuo apparire sulla scena e quel vento – lo stesso che sentivamo uscire dalle cavità carsiche –la seguiva ovunque andasse. Sembrava provenire da un abisso. Metallo fuori, vuoto dentro.Incrociare i suoi occhi metteva paura. Se poi era lei a guardarti, ti sentivi morire. Il suosguardo, come quello di certe divinità mitologiche, era capace di ridurti in polvere solosfiorandoti.C’era freddezza là dentro, odio, desiderio di distruggere.Non eravamo più gli amati bambini, ma i gli di nostro padre, portatori di una tara
genetica. Eravamo la prova vivente del fallimento, la zavorra che si trascinava dalla suavita precedente.Dov’era nita la signora che per noi aveva sferruzzato quelle magniche copertineazzurre, rosa e bianche? Dov’era nita quella giovane donna che, nelle foto, ci stringeva alseno con sguardo dolce, come fossimo la cosa più preziosa del mondo?Non lo sapevamo.Se l’avessimo saputo, avremmo fatto qualsiasi cosa perché tornasse. Avremmo arontatodraghi, mostri, sacrici, magie, imprese eroiche. Intanto, non ci rimaneva che vivere conuna creatura bicefala. Da una parte, quella che per lo più si manifestava in pubblico, c’erala madre meravigliosa, quella che tutti avrebbero desiderato avere, dall’altra, quandorimanevamo soli, ritornava a essere l’essere mitologico con lo sguardo assassino.Le due signore non si conoscevano, non si frequentavano, non avevano mai presoneppure un caè insieme. Tra loro c’era un muro altissimo, insonorizzato, coperto di coccidi vetro e di lo spinato. Purtroppo avevano la stessa faccia, gli stessi vestiti e abitavanonello stesso appartamento.Per questo noi vivevamo come camminando su una tela di ragno. L’incertezzaaccompagnava ogni nostro passo, bastava un’imprevista vibrazione del lo perché ilpadrone di casa – il ragno –, fulmineo e silenzioso, ci piombasse addosso con il suo veleno.Come la maggior parte degli scrittori degni di questo nome, a questo punto, dovreiraccontare della mia precoce passione per i libri. C’era una grande biblioteca di famiglia eio, ancora incerta sulle gambe, già accarezzavo il dorso dei libri pregustando il futuropiacere che da loro avrei tratto… A cinque anni leggevo già perfettamente, a otto mi sonosprofondata nella lettura di Guerra e pace, a dieci anni già stupivo tutti con la perfezionedei racconti che uscivano dalla mia penna… Sarebbe stato bello avere una vita cosìmeravigliosamente agiografica. Invece, dei libri non mi importava più o meno nulla.La mia grande passione erano i giorn<strong>ali</strong>ni. Topolino in testa a tutti, ma poi ancheTiramolla, Il Monello, Capitan Miki e qualsiasi altra forma di narrazione il cui testo fossecontenuto in una nuvoletta. Attendevamo come manna dal cielo l’arrivo in casa di uno diquei volumetti colorati che poi logoravamo a furia di continuare a rileggerli. Gran parte delnostro immaginario viveva diviso tra Paperopoli e Topolinia e, probabilmente, ci sentivamopiù vicini a Pippo e a Paperino che alla maggior parte dei nostri familiari.Ancora adesso, quando parlo con mio fratello, ci capita di usare le espressionionomatopeiche dei fumetti. Bang, gulp, sigh! Ognuno è figlio del suo tempo.Avevamo comunque una discreta biblioteca per ragazzi perché a quei tempi – in un’epocadi basso o inesistente consumismo – ai compleanni si ricevevano principalmente libri. Sitrattava per lo più di classici o di riduzioni di classici. I libri, rispetto ai fumetti, avevano uninnegabile vantaggio – seppur più faticosi, duravano più a lungo. Così, nei tempi in cui ilperpetuo intrattenimento esterno dei bambini era ancora di là da venire, la lettura era unv<strong>ali</strong>do antidoto alla noia delle interminabili domeniche di pioggia.Il mio interesse era calamitato dai libri che avevano degli anim<strong>ali</strong> come protagonisti: Il
libro della giungla, Zanna bianca, Il richiamo della foresta. E poi, Lampo, il cane viaggiatore, lastoria del cane del capostazione di Piombino che aveva l’abitudine di viaggiare in treno perl’Europa, tornando ogni volta, infallibilmente, a casa.Leggevo, senza mai comunque percepire in alcun modo la sensazione che tra me e leparole ci fosse un legame speciale. Se avessi dovuto stilare una classica delle mie attivitàpreferite, la lettura di libri sarebbe stata piuttosto in basso. Avrei potuto benissimo farne ameno, senza provare una qualche forma di soerenza. La realtà – e la sopravvivenza a essa– assorbivano tutte le mie forze. Non avevo molte energie per entrare in altri mondi. In piùero – e tutt’ora sono – una persona molto sica. Andare in bicicletta o esplorare il mondocon il canotto, quelle sì che erano cose davvero per me irrinunciabili.Nell’età adulta, ho sviluppato una certa invidia per i piccoli musicisti, i giovanimatematici, i pittori in erba – per tutti quei talenti insomma che, grazie a una tecnica o aun sapere già scritto, si manifestano da subito per diventare poi universalmentericonosciuti. È più facile per loro sopravvivere al peso devastante del talento, anzi, a volte,può divenire motivo di grandi soddisfazioni. La stessa cosa vale per i precoci maghi dellapenna, capaci di commuovere le maestre con la bellezza delle loro composizioni. Vinconoconcorsi di poesie a tredici anni e a venti già dirigono una rivista, a trenta sono osannatiautori o critici, capaci, con le loro opinioni, di fare il bello e il cattivo tempo nel mondodelle lettere.Ma il bambino che ha in sé un’altra profondità di parola, come può sopravvivere al suotalento?Può avere la fortuna di incontrare una maestra sensibile, capace di accoglierlo, o unamadre che gli vuole bene comunque, anche se piange per ore senza nessuna ragioneapparente.Ma può anche non avere queste fortune.E allora?Allora non c’è consolazione, non c’è conforto. <strong>Ogni</strong> giorno ti alzi e sai di essere diverso datutti gli altri. Senti costantemente in te il richiamo dell’abisso e questo richiamo – il timore,il panico di questo richiamo – non puoi condividerlo con nessuna delle persone che ti stannoaccanto. A nessuno puoi dire: aiutami un po’ a portare questo peso. Nessuno mai ti farà icomplimenti per il tuo essere diverso, perché l’abisso non ti porta a essere brillante.La brillantezza amata e riconosciuta dal mondo è lontana da te mille miglia. Staraisempre zitto o, se aprirai bocca, sarà per dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato.Immerso costantemente in un pensiero parallelo, non ti accorgerai di quello che il mondoesterno desidera da te. Diventerai così ogni giorno più goo, più incapace, più terrorizzato,lucidamente certo che l’ambiente intorno ti consideri un idiota. Vedi la nudità scabra delreale e presto capisci che questa visione non è gradita a nessuno. Per trasposizione,neppure tu diventi gradito. Allora ti arrotoli, ti accartocci tenti di scomparire.“Già appena nata piangevi in modo diverso da tutti gli altri bambini,” mi ripeteva miamadre, per rassicurarmi.Capisco benissimo quei bambini che, di punto in bianco, saltano giù dal balcone.Personalmente, vivevo facendo quotidiane prove di asssia. Sdraiata sotto il letto,
trattenevo il ato ogni giorno di più. Ero convinta che, un giorno o l’altro, ce l’avrei fatta asconggere quella forza che comunque mi costringeva a tornare in supercie e a spalancarela bocca.
12.Mia nonna materna era una persona di intelligenza straordinaria. All’acutezza dellamente, univa quella meravigliosa dote che è l’ironia priva di sarcasmo. Donna inquieta,estremamente in avanti sui tempi, ripeteva spesso di aver sposato il nonno per immettereuna miglioria nella genetica della nostra famiglia. Aveva molti corteggiatori, raccontava,ma le loro mani molli e le loro vocette tremule non promettevano niente di buono.“Quando a un ballo incontrai vostro nonno, capii all’improvviso cos’era davvero unuomo.”A quei tempi, per una glia dell’alta borghesia mitteleuropea, voler sposare un uomo chearrivava dalle montagne dell’It<strong>ali</strong>a centrale, era più o meno come sposare oggi unimmigrato clandestino del Kurdistan. Dato che era ancora minorenne, per opporsi a questapassione, la famiglia la spedì dallo zio Ettore che lavorava in un loro stabilimento a Londra.Speravano che il tempo e la distanza le facessero dimenticare quel poco appetibile partito.Ma così non fu e, appena raggiunta la maggiore età, mia nonna tornò a Trieste e convolò anozze con il bel tenente dalle origini oscure. In quella battuta gioiosamente ironica, credo cifosse un fondo non indifferente di verità.<strong>Su</strong>lle pareti della mia casa di Trieste è appesa un’unica foto di famiglia, in bianco e nero.Risale al 1930 o al 1931 e rappresenta la mia trisavola, Olga Moravia, seduta in veranda,contornata da tutti i suoi nipoti. Tiene in braccio le ultime nate, mia madre e sua cuginaDora. Se ne sta lì appesa al muro, non per aetto o per nostalgia, ma semplicemente comemonito.La maggior parte, infatti, di quei bambini e di quelle bambine che sorridono nei lorovestiti alla marinaretta è stata falciata da un destino di distruzione. Droghe, suicidi, alcol,guerre, persecuzioni, disturbi ment<strong>ali</strong> li hanno spazzati via uno dopo l’altro prima deltempo.Il sangue del nonno, un sangue abituato alla sopravvivenza primordiale, era ben diversoda quello dei marinaretti cresciuti sotto l’occhio vigile delle nannies. C’era energia, forza,salute, oltre alla volontà caparbia di andare sempre e comunque avanti, sopravvivendo atutte le dicoltà. Era forse proprio quella forza che, nei tentativi di asssia, mi costringevacomunque ad aprire la bocca. Ed è proprio quella forza che, nei tanti momenti oscuri dellavita, mi ha permesso sempre e comunque di andare avanti, di immaginare un futuro in cuile cose sarebbero state diverse.Tra i racconti delle infanzie dei miei nonni – lei che andava a scuola con un calessetrainato da pony bardati con ciu, provando un’enorme vergogna nell’attraversare iquartieri operai intorno alla fabbrica, e mio nonno che scalava tutti i p<strong>ali</strong> della cuccagnadelle valli intorno nella speranza di arraare qualche la di salsicce – c’era un abissospazio-temporale per me difficile da colmare.
Da bambini, la domenica andavamo a pranzo da loro, insieme ai nostri cugini. Adierenza dei nonni paterni, ricordo benissimo la casa, insieme al senso di benessere che miprendeva ogni volta che varcavo quella porta. Si mangiavano grandi piatti di spaghetti –pietanza etnica introdotta dal nonno – e c’erano degli spazi dedicati esclusivamente a noi:un cassetto con matite colorate e fogli di carta, un libro illustrato e tre dischi che, con ilpermesso del nonno, potevamo ascoltare all’innito, mettendoli sul giradischi custodito inun grande mobile di legno.Uno dei dischi faceva rivivere la storia di Bambi, il secondo quella delle Tigri diMompracem e il terzo conteneva le terricanti canzoncine di un classico tedesco,Strwwpeter, da noi tradotto in Pierino Porcospino.Anche il libro corrispondente stava purtroppo in quel cassetto e le sue illustrazioni apenna sono ancora tutte ferocemente depositate nella mia memoria. Si trattava di unvolumetto dagli intenti pedagogici che, con i suoi agghiaccianti esempi, mirava atrasformare i bambini, da piccoli selvaggi indisponenti, in fanciulli virtuosi. Le diversestorielle avevano tutte un nale edicante. Dietro a un bambino che si succhiava estatico ilpollice spuntava un sarto che con una lunga forbice glielo tagliava di netto, lasciando ilpoveretto con la mano monca a ssare a terra il dito in questione in una pozza di sangue. Aquesta vicenda, che dava i brividi persino a mio fratello, seguiva la storia della dolceLisetta. Anche Lisetta era un po’ birichina. Lei, invece di succhiarsi il dito, giocava con iammiferi, nonostante i suoi genitori glielo avessero proibito. Immagine numero uno:Lisetta che gioca con gli zolfanelli, lo sguardo inebriato e felice; immagine numero due: isuoi vestiti che prendono fuoco; immagine numero tre: due gattini che piangono caldelacrime davanti a un mucchietto di cenere con due scarpette rosse, tutto ciò che rimanedella povera Lisetta. E che dire di Gasparino che non vuole mangiare la minestra? Capriccioggi, capricci domani e, alla ne, del orido bambino non resta che un cumulo di terra conuna croce e una bella zuppiera fumante sopra.Della vicenda del bambino Filippo ricordo ancora la canzoncina, che cantavo sempreinsieme a mio fratello. Dondola, dondola Filippo dondola. Dondola, dondola, poi non c’èpiù! Filippo, infatti, aveva l’abitudine di dondolarsi con la sedia, durante i pasti, facendoorecchie da mercante davanti ai ripetuti rimproveri dei suoi genitori. Così alla ne succedel’inevitabile. La tavola si ribaltava con tutto ciò che c’era sopra e lo travolgeva,uccidendolo.Ancora adesso, quando penso alla copertina di quel libro – un lurido bambino puzzolentee spettinato con le unghie delle mani così lunghe da toccare quasi i piedi – non posso nonprovare un senso di profondo turbamento. Spietatezza, crudeltà, sadismo – spinto no allamorte – era il destino dei bambini che uscivano appena un po’ dalle righe.A parte questo volume – che costituiva l’unico punto oscuro in quelle giornate – a casa deinonni era permesso anche prendere delle coperte e degli stracci e con quelli costruire dellecasette tra le sedie dove passare il pomeriggio. Il nonno aveva una visione benevoladell’infanzia, non era né darwiniano né domatore. Pur essendo severo nei nostri confronti,aveva sempre un atteggiamento positivo. La vita – credo pensasse – riservava giàabbastanza dicoltà, non occorreva inventarsene di nuove per amareggiare i bambini. La
nonna amava cucinare dolci e spesso, il pomeriggio, faceva le palacinche per noi nipoti.Per tutta la mia infanzia, però, non ho avuto un rapporto particolare con lei. È stataproprio la nonna a confessarmi, quando ero già adulta, che era impossibile relazionarsi conme. “Avevo paura solo a guardarti,” mi ha detto una volta. “Eri completamente muta,immobile, con lo sguardo assorto in un mondo irraggiungibile.”Lo sguardo, già, dove si posava?Dove non avrebbe dovuto posarsi.Il pianto che accompagnò la cerimonia della prima comunione fu uno dei miei ultimigrandi pianti. Ancora non lo sapevo ma, da lì a poco, tutte le lacrime che con tantaabbondanza versavo nelle situazioni più imprevedibili sarebbero scomparse, trasformandola loro essenza acquatica in quella più solida del ghiaccio. Il mio iceberg mi aspettavadocile, come lo stampo di un uovo di Pasqua. Bastava andarci dentro e chiudere la porta.Tutti i pianti non fatti si addensarono intorno alla mia persona, creando una corazzainespugnabile. Quello spessore trasparente e glaciale mi permise di andare avanti. Nessunsentimento mi toccava più. Ero, volevo essere, soltanto un automa che ubbidiva agli ordini.Persino i lupi e le streghe, scocciati da tanta indifferenza, cominciarono a defilarsi.L’atarassia è stato il modus vivendi – o meglio supravivendi – della mia seconda infanzia.Non legarsi a nulla, non provare nulla. Ci sono persone che si sottopongono ad anni diprivazioni, a esercizi estenuanti, a maratone di meditazione, per cercare di raggiungerequesto stato, al quale io arrivai per vie assolutamente natur<strong>ali</strong>.A otto, nove anni, tra me e il piccolo Buddha non c’era nessuna dierenza. Non avevodesideri, non avevo attaccamenti. Sentire qualcosa, legarsi, voleva dire soltanto provareuna serie infinita di sofferenze.A tutti orivo un sorriso enigmatico, una docilità assoluta, uno sguardo apparentementefermo. <strong>Ogni</strong> tanto, per non creare troppo sgomento intorno, ngevo di interessarmi allecose che normalmente attraggono i bambini. Me ne stavo seduta sulla cima di unamontagna mentre la vita avveniva laggiù, nelle valli. Di tutto il suo frastuono, ai cambi divento, mi giungeva appena un’eco – il muggito di una mucca che si è persa, la bruscafrenata di un’auto.I lupi, le streghe e gli scheletri vennero sostituiti, nella mia mente, dalla Fossa delleMarianne, l’abisso oceanico profondo undicimila metri situato in prossimità delle Filippine.Anche quella scoperta, come quella dell’iceberg, la feci grazie alla raccolta di gurine Gentie Paesi. Un gorgo enorme che, come un terricante imbuto, sprofondava vorticando verso leprofondità più oscure della terra.Il rumore di quel gorgo cominciò presto a popolare i miei giorni e le mie notti. Vuoom,vuuomm, vuuom. Anche se era lontanissimo dal mare Adriatico, sapevo che tra me e lui c’erauna profonda relazione stabilita dal destino.Da pochi anni, un essere umano era riuscito a calarsi là dentro e a raggiungerne il fondo.Non era andato con la maschera e le pinne, ma con una batisfera, una specie disommergibile tondo. Quella batisfera si chiamava Trieste e non certo per una casu<strong>ali</strong>tà
sentimentale, ma perché era stata costruita ai cantieri nav<strong>ali</strong> San Marco, cioè a pochecentinaia di metri da dove sono nata e cresciuta. Mentre muovevo i primi passi e ascoltavo,senza sapere cosa fosse, la lugubre sirena dei cantieri, là sotto, bang bang, stavano giàmartellando lo scafo che avrebbe compiuto l’impresa.Al tempo del mio ingresso all’asilo, 1960, la batisfera, con due persone a bordo – unuciale e un oceanografo, Jacques Piccard –, lentamente si calò negli abissi. Perraggiungere il fondo impiegò diverse ore e a undicimila metri si fermò per una ventina diminuti. Andarono laggiù da soli, o almeno così credettero, perché in realtà assieme a loroc’ero anch’io. Solo che loro ris<strong>ali</strong>rono quello stesso giorno, mentre io continuai a vivere làsotto per un bel po’ di tempo.Il gorgo, l’abisso, il nulla.Un buco di undicimila metri, largo duemilacinquecento chilometri, tremila metri piùdell’Everest. Ma mentre l’Everest aveva il conforto della solidità della roccia e, comunque, siergeva verso l’alto, verso la luce e gli spazi aperti del cielo, la fossa precipitava nell’oscuritàe il movimento che compiva vorticando era centripeto, capace dunque di risucchiare eingoiare senza pietà tutto quello si presentasse nelle sue vicinanze.Undicimila metri.Per quanti metri, scendendo, ci sarebbe stata la luce?Già al bagno Ausonia, guardando sotto dove l’acqua era alta provavo un assolutosgomento. A Grado si vedeva comunque il chiarore della sabbia, il tappeto di alghe che simuoveva lentamente, ma lì no, c’era solo il blu nero che poteva nascondere qualsiasi cosa.Gli squ<strong>ali</strong> potevano tranquillamente prendere il posto dei lupi, le mante, con le loro scosse,alla ne erano peggio delle streghe. Ma a mille, duemila, cinquemila metri, neppure loroerano in grado di arrivare. La pressione della colonna d’acqua li avrebbe rapidamentetrasformati in frittelle.L’abisso, invece di essere vuoto, era abitato da mostri.Non c’era luce laggiù, ma quelle spaventose creature erano uorescenti, per questo noiriuscivamo a vederli. Vedere cosa? Principalmente, enormi le di denti acuminati, qualchecoda, mandibole di dimensioni straordinarie, pinne, zanne, lance, dardi velenosi,l’improvviso gonfiore di uno stomaco.Nella Fossa delle Marianne, l’esistenza esibiva la sua più profonda e nuda verità. Vivere èdivorarsi a vicenda. Divorare e venir divorati. L’abisso, con la sua oscurità in perpetuomovimento, non consentiva la menzogna.C’era la Fossa delle Marianne, nell’oceano Pacico, e c’erano altre fosse delle Mariannesparse nella falsa quiete dei giorni. Anche se tutti facevano nta di niente, era chiaro chestavamo sempre sospesi su un baratro. Bastava un nonnulla, una distrazione minima permettere il piede in fallo e sprofondare tra quei sinistri bagliori, tra le lance, le zanne, laferocia dei dardi.Un giorno, prima dalla lezione di nuoto, feci un capriccio colossale. Sapevo di averequalche speranza di spuntarla dato che era toccato alla nonna di portarmi in piscina. Miaggrappai alla portiera della Seicento con la bora che mi sbatacchiava di qua e di là, ma
non importava. Mollata alla ne la presa, mi buttai per terra. Per fortuna la nonna nonaveva la verve del domatore e l’idea di trascinarmi a peso morto per il braccio no aglispogliatoi non le venne neppure in mente, così, mentre ancora mi dimenavo sull’asfalto,disse: “Va bene, allora per oggi, niente piscina.”Prima di mettere in moto l’auto, però, guardandomi sso, mi chiese: “Cosa succede? Chec’è che non va?”Con lo sguardo vuoto della bambina-iceberg, osservai il cruscotto. “Niente,” dissi. “Non loso, niente,” ripetei ancora tremante.In realtà, sapevo benissimo perché. La piscina aveva un enorme tappo sul fondo e queltappo, da un momento all’altro, avrebbe potuto saltare. Il risucchio allora sarebbe statopotente e rapidissimo. Nonostante le tavolette galleggianti, in pochi secondi saremmo statitutti inghiottiti dall’abisso. Non era un capriccio dunque, ma il tentativo di sottrarsi a uninfausto destino.Solo molti anni dopo, nell’età adulta, ho letto la dichiarazione resa da Jacques Piccard alritorno in supercie. “Pensavo di trovare laggiù l’oscurità totale, invece, a un certo punto,con mia grande sorpresa, il fondo apparve luminoso e chiaro.”
13.Ho sempre sofferto di chinetosi.Durante le nostre gite sul Carso, il nonno, dal posto di guida, mi inondava di consigli.“Stai dritta, guarda davanti, apri il nestrino…” Malgrado ciò, la nausea e il capogiros<strong>ali</strong>vano in maniera irrefrenabile e, alla prima curva un po’ più aspra, succedeval’inevitabile.Lo stesso tipo di nausea mi ass<strong>ali</strong>va quando accompagnavo mia madre nelle sueperegrinazioni artistiche. Oltre a quello di fare la madre, infatti, l’altro sogno che coltivavan da ragazza era quello di poter frequentare l’Accademia di Belle arti a Venezia. Il padreperò, uomo all’antica, non glielo concesse e così decise di convolare a nozze con il giovaneuomo di cui era profondamente innamorata.Nel momento in cui la struttura cominciò a franare e la casa divenne l’atrio di unastazione, decise di s<strong>ali</strong>re sull’autobus che l’avrebbe nalmente portata nel Paese dell’Arte. Ilfratello del famoso pediatra era uno scultore e, grazie a lui, cominciò a frequentare ungruppo di pittori della sua generazione. Usciva spesso con loro. In fondo era una ragazzagiovane, molto carina e piena di vita. Era normale che, per scrollarsi di dosso i calcinaccidel proprio matrimonio, andasse in giro a divertirsi.Ricordo una sera in cui ci portò con sé a una festa. Per motivi credo principalmentemeteorologici – non deve essere simpatico stare al trentesimo piano con la bora che soa a150 km orari – a Trieste esistono pochi edici alti e uno di quelli sorgeva sulle Rive e venivachiamato appunto Grattacielo.La festa si svolgeva lassù. C’era moltissima gente, ragazze in minigonna e pettinatura acarciofo, giovanotti con i jeans rivoltati in fondo, un giradischi che suonava all’impazzatamusica jazz, tantissimo fumo, un numero spropositato di bottiglie, risate, rumore dibicchieri. Venimmo parcheggiati su un divanetto dell’ingresso e lì rimanemmo nché ilsonno non ci colse.Il parcheggio sui divanetti, sulle poltrone, sulle varie sedie fu un po’ la costante di queinostri anni trascorsi nel mondo dell’arte.Nel frattempo, mia madre era diventata amica di Umbro Apollonio, l’allora direttoredella Biennale, e così il Lido di Venezia, durante l’estate, divenne la nostra seconda casa.Ricordo la noia di pranzi interminabili, cene innite, attese senza ne, discorsiincomprensibili che dovevamo subire senza protestare.A volte la glia di Apollonio, Gabriella, ci portava ai giardinetti, ma queste visitecostituivano un sollievo di breve durata. Oltre ai pranzi e alle cene, c’erano purtroppoanche le mostre. La Biennale in primis. E andare a visitare una mostra voleva dire stare perore immobili, rannicchiati su una sedia, con pance e gambe che ti passavano costantementedavanti. Di tanto in tanto qualche faccia sconosciuta si chinava su di te, chiedendo: “Farai
l’artista come la tua mamma, da grande?” Dato che ero la bambina-iceberg, la bambinagorgo,il “no” che usciva dalla mia bocca era piuttosto ebile, ma quello che risuonavadentro era potente come un ruggito. NOOO! Non avrei fatto mai l’artista, per nessuna ragioneal mondo. Per quale motivo avrei dovuto annoiarmi in quel modo?E poi, sebbene fossero tutti pittori, dai loro pennelli e dalle loro tele, con mia grandemeraviglia, non usciva mai nulla che riuscissi a riconoscere: un albero, una casetta, unvolto, niente. Soltanto cubi, cerchi, righe, rombi, triangoli, preferibilmente di colore biancoe nero, o di metallo luccicante, lamierette rotanti, sospese nell’aria con invisibili li dinylon.Erano i primi anni sessanta e impazzava l’Optical Art, con il suo astrattismo geometrico.La posta in gioco non era più il cuore, ma la retina; l’anima bella era diventata ormaioggetto di studio della psicologia sperimentale. Tale, infatti, era l’assunto del suo fondatoreVictor Vasarely a cui tutti si erano adeguati inventando forme geometriche sempre nuove,sempre più astruse ai miei occhi, sempre più foriere di spaventose ondate di malessere. Piùche di psicologia sperimentale, quei quadri mi sembravano tentativi di gastroenterologia.Fa vomitare? Non fa vomitare? Probabilmente era su questo valore che venivano giudicatele opere.Ricordo ancora in una mostra di mia madre un enorme cubo arancione costellato daisoliti geroglici geometrici. Ma l’esterno ancora non era niente. Appena si aveva lasventura di posare l’occhio su una sorta di cannocchiale conccato su uno dei lati, il cubocominciava a oscillare, cosicché l’optical racchiuso nella scatola diventava un opticalall’ennesima potenza, in grado di scatenare non la nausea delle miti curve del Carso, maquella violenta del passo dello Stelvio.Almeno i nostri amati fumetti riuscivano a vendicarci. A Topolinia e Paperopolisuccedeva spesso infatti che Paperina, Minnie e Clarabella andassero in estasi davanti adegli incomprensibili sgorbi, nelle mostre di arte moderna, ma per fortuna Pippo oPaperino, con i loro maldestri commenti, esprimevano la verità su quegli astrusi ghirigori.Un paio di anni fa, mio fratello – che ha condiviso con me tutto il training optical – inricordo di quei giorni nauseabondi mi portò dalla Finlandia una maglietta con su scritto:“Ce l’ho fatta a scappare dal museo di arte moderna!”Proprio quello che noi, in quei giorni, avremmo voluto fare. Fuggire a mille migliadall’attuale e dal fattuale, dalla fattu<strong>ali</strong>tà in atto e dall’attu<strong>ali</strong>tà in fatto. Fuggire dal mondodella noia pomposa, condita da parole altisonanti. Fuggire per passare i pomeriggi sdraiatisul pavimento a disegnare battaglie, bombardamenti, esplosioni, fortini di nordisti, attacchidi indiani, casette con camini e alberi, cieli con le stelle – tutto il mondo che, ai nostri occhidi bambini, aveva ancora un senso.Nel suo cammino di intellettu<strong>ali</strong>zzazione artistica, mia madre non tralasciava nulla.Doveva recuperare il tempo fatuamente perso inseguendo il sogno di diventare una perfettamadre di famiglia. Così una sera si sdraiò sul divano con un libro in mano e, su quel divano,con lo stesso libro, rimase sdraiata per anni.
Il tempo della lettura era sacro.Vietato fare rumore, vietato avere qualche necessità o dare vita alle solite scaramucce disopravvivenza a cui mi sottoponeva mio fratello. Scivolavamo per la casa, silenziosi, inpantofole, e per parlare tra di noi abbassavamo la voce come si fa ai funer<strong>ali</strong>.Bisbigli, sussurri, sospiri.Sdraiati sul pavimento, la guardavamo da sotto in su. <strong>Su</strong>lla copertina bianca del libro,c’era la foto di un signore con i baffi e sopra un nome: Marcel Proust.Con il tempo, il signor Proust, con i suoi ba e il suo sorriso indisponente, divenne ilnostro nemico giurato, l’argomento dei nostri conciliaboli segreti. Tutto il tempo cheavrebbe potuto passare con noi, lo dedicava a lui e non ne capivamo la ragione.Cosa ci poteva essere scritto in quelle pagine di così interessante? Erano pagine optical?Pagine ipnotizzanti?Dopo qualche mese, approttammo di una sua giornata di particolare buon umore perchiederle: “Ma quando finisce questo libro?”“È già finito,” ci rispose, “questo è un altro.”La guardammo stupefatti. Il signor Proust era sempre là, sulla copertina bianca, e ancheil titolo era lo stesso, però nostra madre diceva che era un altro.Ci stava forse prendendo in giro?All’altro, comunque, ne seguì un altro, e poi ancora un altro. Con il tempo, fummo presida una sorta di cupa rassegnazione. Era inutile competere con quel tipo coi ba per averepiù attenzione, perché era evidente che il signor Proust – Marcel, Marcello, già il nome cisembrava odioso – aveva carte da giocare molto migliori di noi.Da grande, ho interrogato mia madre sul suo rapporto con la Recherche. “L’ho letta perintero una volta,” mi rispose “e, appena l’ho nita, l’ho ricominciata da capo, per gustarein profondità ogni sua frase.” Ecco svelato il tempo infinito della nostra Recherche!A quel tempo risale anche il nostro primo incontro con un artista. A dire il vero, di artistialla Biennale ne avevamo già incontrati tanti – tra loro ricordo bene Miela Reina e GetulioAlviani –, ma erano persone dell’età più o meno di mia madre, che mangiavano e bevevanoinsieme a noi, dunque non mi era chiara aatto la dierenza tra un artista e un guidatoredi autobus.Insomma, fare l’artista mi sembrava un mestiere come un altro ed era chiaro che, tral’artista e il guidatore d’autobus, avrei sicuramente scelto il secondo.Ma un giorno accadde qualcosa di speciale. Mia madre ci convocò in cucina e ci disse:“Questa sera verrà a cena un grande artista.”“Grande quanto?” chiese allora mio fratello, come sempre interessato alla sicità dellaquestione.“Grandissimo. Un grandissimo poeta.”A questo annuncio, seguì il decalogo della domatrice, con tutto ciò che non avremmodovuto fare in quell’occasione. Oltre al respirare, ben poco ci venne concesso. Trascorsi il
esto della giornata assorta nelle mie abitu<strong>ali</strong> elucubrazioni. Se era grandissimo, dovevacerto essere molto più alto di mio padre, che comunque era già alto. Ce l’avrebbe fatta apassare per la porta o avrebbe dovuto chinarsi, come se stesse entrando in una spelonca dinanetti? E le sedie, il tavolo? Sarebbero stati sucientemente adeguati? O ci saremmotrovati nella stessa situazione di Riccioli d’Oro quando fa ingresso nella casa dei tre orsi?Forse, nel pomeriggio, mi dicevo, qualcuno avrebbe portato una seggiola gigante…E poi, che cosa voleva dire un poeta?L’unico rapporto che avevo avuto con la poesia era un bel cinque preso in secondaelementare. Era ottobre e dovevamo imparare a memoria un componimento celebrativosull’impresa di Cristoforo Colombo, dal titolo Le tre caravelle. Interrogata dalla maestra, mialzai in piedi, facendo scena muta. Invece delle caravelle, mi venivano in mente soltanto lecaramelle e, intorno a esse, il vuoto più assoluto.Nel pomeriggio, chiesi a mio fratello: “Non è che ci interrogherà su qualcosa?” “No, noncredo,” mi rispose, ma non sembrava molto convinto.Finalmente arrivò l’ora di cena. Il campanello suonò, la porta si aprì e comparve unuomo piccolo, un po’ curvo, con i capelli bianchi e due occhi azzurri dardeggianti in unvolto devastato dalle rughe. Mia madre prese il suo cappotto, muovendosi concircospezione, come fosse un oggetto di estrema fragilità.A noi, ovviamente, non fu concesso di mangiare con loro, ma il poeta, già seduto atavola, ci convocò al suo anco. A me chiese della carta e io subito corsi a prenderel’agenda vicina al telefono. Gliela porsi e lui estrasse dal taschino una grossa stilogracanera dalla quale tolse il tappo, e iniziò a scrivere…Straordinaria magia, tutte le parole erano colorate di verde.Svelato il mistero!Le poesie sono parole verdi!Il giorno dopo, a scuola, ebbi nalmente qualcosa di interessante da raccontare. Nonvedevo l’ora di rivelare ciò che avevo scoperto la sera precedente, così alzai la mano e dissi:“Signora maestra, ho conosciuto un grande poeta!”“Ah sì? E come si chiama?”“Ungaretti. Giuseppe Ungaretti!”La maestra scosse il capo, desolata.“Perché sei così bugiarda?”
14.Con il progredire nell’osservazione del reale, verso gli otto anni avvenne in me unimportante cambiamento. Le esperienze fatte no ad allora mi avevano fatto capire che lavita era caos, arbitrio. Non c’era un senso, un lo rosso, capace di legare insieme i giorni. Ilmondo dell’arte non oriva alcun appiglio. Quello degli aetti non era molto diverso dauna gigantesca palude stigia che inghiottiva una dopo l’altra le persone, facendole sparireper sempre.Per quanto riguardava l’Abitante dei Cieli, anche lì, non c’era molto da darsi. Oltre agliordini folli che usava dare a noi uomini – e che non avevo aatto dimenticato –,camminando avanti e indietro per la città ero venuta a conoscenza di un altro problema chemi tormentava non poco.Per raggiungere la casa dei nonni, infatti, passavamo davanti a un’enorme chiesasormontata da meravigliose cupole azzurre. Un <strong>angelo</strong> composto di tante tessere d’oro, conuna spada in una mano e una bilancia nell’altra, troneggiava sulla facciata.Era la chiesa serbo-ortodossa, mi venne detto.Dalle finestre dei nonni, scorgevo altre cupole azzurre, un po’ meno bombate.Erano quella della sinagoga.Nel rientrare a casa, poi, passavamo davanti a un altro edicio bianco – questa volta condue campanili ai lati – dal quale, un giorno, durante le vacanze di Natale, vidi uscire unala di persone che seguivano un crocisso. Il piccolo corteo raggiunse il Molo Audace equello che sembrava essere il sacerdote, come in preda a improvvisa follia, scagliò ilcrocisso in acqua. <strong>Su</strong>bito, dei giovanotti si spogliarono, tuandosi nelle gelide emaleodoranti acque per recuperarlo.Mi dissero che quello era un rito della chiesa greco-ortodossa.Allora, improvvisamente, mi fu chiaro il problema da risolvere.Dio è uno solo o ne esistevano tanti?E se erano tanti, come facevano a dividersi le cose in cielo? C’erano forse dei reticolatilassù, dei posti di conne, come quelli sul Carso, in cui bisognava esibire i documenti? Nellamia famiglia, convivevano tre diverse religioni: l’ebraica, la cattolica e l’ortodossa. Sarebbestato possibile stare tutti insieme nell’Aldilà? Oppure ci saremmo salutati fugacemente dalontano, approfittando di un buco nel muro o nella rete?E comunque, tornava ad aacciarsi la stessa domanda che mi ero fatta riguardo allaTrinità. Se sono tanti, chi comanda? Fanno a turno, oppure ognuno comanda un settoresoltanto? Mi sembrava anche logico che comandassero all’interno del recinto dei lorodevoti. A ognuno le sue regole e le sue infrazioni.Ma la natura, allora, chi la comandava?
Il sole sorgeva ogni giorno e ogni sera tramontava, per riapparire dall’altra parte delmondo. Le stagioni si susseguivano con precisione e le piante e gli anim<strong>ali</strong> si adeguavano aquesti mutamenti con assoluta naturalezza.Chi dirigeva tutta questa straordinaria complessità?Per quanto mi interrogassi, sulla reale consistenza e onnipotenza di Dio, non riuscivo atrovare nessuna risposta.Così, dopo aver tenuto per tutti quegli anni i miei pensieri costantemente rivolti versol’alto, all’improvviso, cambiai direzione, puntando il mio sguardo verso il basso. Visto che dilassù non si capiva granché, potevo almeno cercare di comprendere quello che succedevaquaggiù. Non tra gli uomini naturalmente – terreno minato, dal quale mi ero ritirata datempo – ma tra le cose re<strong>ali</strong>.I sassi, i semi, i fiori.Già da quando avevo memoria di me, ero aascinata dalle erbacce che spuntavanodall’asfalto – dalla parietaria, con cui Gianna ci componeva medaglie e collane, aitarassachi che comparivano all’improvviso in quel grigiore come piccoli splendidi soli. Ilmarciapiede era durissimo, a dierenza degli steli, eppure quelle fragili erbe verdi etenerissime erano capaci di vincere la loro battaglia, facendosi varco verso la luce. Dunquelaggiù c’era qualcosa di veramente interessante da indagare. L’apparenza poteva esserevinta da qualcos’altro di cui ancora non conoscevo il nome.Il nome!Ecco la grande domanda sospesa su quei giorni. D’un tratto mi resi conto che c’eranotante cose di cui non conoscevo il nome. “Guarda, degli uccellini!” mi dicevano, ma diuccellini ce ne erano tanti, alcuni marroni, altri grigi, altri ancora prevalentemente gialli,tutti drammaticamente diversi gli uni dagli altri. La stessa cosa accadeva con le erbacce,ognuna differente dall’altra, eppure tutte ban<strong>ali</strong>zzate da un’unica denominazione.Pensai allora che tutto ciò che cadeva sotto il mio sguardo dovesse avere la dignità delnome.<strong>Su</strong>l nome, a dire il vero, mi ero già parecchio interrogata quando, a sette anni, avevoiniziato a studiare il tedesco. Andavo a lezione da una vecchia amica di mia nonna, in unacasa enorme, spettrale e scricchiolante. Lì, nella penombra, abbarbicata sul bordo di unaustero tavolo, passavo un’ora con la severissima signora china su un libro che dovevaessere stato edito subito dopo la prima guerra.A quei tempi non c’erano metodi didatticamente avanzati, si imparava a memoria, ebasta. Der Ball, der Hund, die Kuh, die Mutter, der Bruder, die Kinder. Tornata a casa, queinomi continuavano a vorticarmi in testa.Oltre al tedesco, le mie orecchie conoscevano anche il francese perché la mia bisnonna,che era nata a Marsiglia, usava intercalarlo all’it<strong>ali</strong>ano, soprattutto quando non volevafarsi capire da noi bambini o dalla domestica. Anche mia madre e mia nonna avevanol’abitudine di usare quell’idioma per escluderci dalle conversazioni.Così un giorno sono tornata a casa, mi sono sdraiata sotto il tavolo e ho cominciato a
pensare: che cos’è questa cosa sopra di me?Un tavolo, der Tisch o la table?È il nome che fa la cosa o la cosa che fa il nome?È il legno che fa il tavolo, sono le quattro gambe e il ripiano o è il nome?E se pronuncio lo stesso nome in un’altra lingua, con un altro suono, la sua naturacambia o resta immutata?E se una cosa non ha un nome?Alla ne, chi decide i nomi delle cose? Quelli dei bambini lo decidono i genitori, ma tuttociò che esiste e non ha genitori?Il nome come interrogazione era già stato in cima ai miei pensieri, ma adesso ero entratain una fase nuova. Una fase di esplorazione conoscitiva perché, a quel punto, volevoconoscere il nome di tutte le cose. Se la mancanza di senso attanagliava il mondo, c’era unasola via per andare avanti, senza affondare nei miasmi della palude stigia.La via dell’ordine.Nominare le cose avrebbe voluto dire attribuire loro un destino e dunque, in qualchemodo, puntellare il caos intorno.In quel momento nacque la mia passione – che tuttora perdura immutata – per le scienzenatur<strong>ali</strong>. Il mio rivolgere lo sguardo verso il basso, per prima cosa, mi fece scoprire i sassi.Erano loro a costituire la supercie esterna della palla di fuoco che ardeva sotto di noi, loroche ci permettevano di camminare senza bruciarci le piante dei piedi.Nelle passeggiate domenic<strong>ali</strong>, però, mi imbattevo soltanto nella caparbia opacità delcalcare carsico o nei ciottoli consunti dalle onde disseminati nelle risicate spiaggette delgolfo, misti a frammenti di terracotta e vetro. Soltanto quando scoprii a una eraun’enciclopedia di scienze natur<strong>ali</strong> per ragazzi – che mi fu miracolosamente comprata – siaprì davanti a me il mondo meraviglioso dei cristalli. Sotto il monotono grigiore che eroabituata a conoscere, si nascondevano dunque dei gioielli di un’insospettabile bellezza.Ma ciò che l’occhio vedeva non era che una parte della bellezza, quella estetica. Labellezza più segreta era costituita dalle leggi geometriche che permettevano a quellestrutture di esistere. Il sistema isometrico, l’ortorombico, l’esagonale, il triclino, il monoclinocostituivano la splendida essenzi<strong>ali</strong>tà di quella materia. E quel privilegio – svelava il libro –non era riservato solo alle meraviglie della natura, che avremmo potuto anche ammirare inun museo o nelle vetrine di un gioielliere, ma era condiviso con una buona parte dellarealtà che ci circondava. La tazza in cui bevevo il latte, lo zucchero con cui lo mescolavofacevano tutti parte del sistema cristallino – disposizioni regolari di atomi tenute insieme daforze elettriche.Dietro l’apparenza del caos, dunque, le cose erano regolate dalle ferree leggi della sica edella chimica. E quelle leggi, pur invisibili, erano per me straordinariamente rassicuranti, inquanto erano segno di regolarità e di perfezione e, da quella regolarità e quella perfezione,venivano fuori una bellezza e un’armonia che nessuna Optical Art sarebbe stata mai ingrado di esprimere.
15.In fondo a ogni vita scorre una segreta saggezza che permette di far arrivare le cosegiuste al momento giusto. Nella concretezza dei giorni che passano, è dicile accorgersi diquesta legge così discreta ma quando, arrivati a una certa età, ci si volge indietro e sicontempla lo svolgersi degli eventi, è più facile vedere quel lo misterioso che, apparendo escomparendo con regolarità, ha legato tra loro i nostri giorni.Per me l’irrompere delle scienze natur<strong>ali</strong> è stato un’ancora di salvezza lanciata appenaprima del naufragio. Il mondo di incontrollata follia in cui ero cresciuta, a un tratto hainiziato a manifestare un ordine. E quell’ordine voleva dire stabilità, quiete, metodicoprocedere in una strada già tracciata da altri.Ho cominciato con l’impossessarmi dei nomi. E avere i nomi, in qualche modo, volevadire essere padroni della realtà. Padroni, non vittime. Il mio interesse ha poi iniziato aespandersi con larghi cerchi concentrici dai miner<strong>ali</strong> ad altri settori delle scienze.L’ornitologia, prima di tutto, poi gli insetti, gli alberi, i ori, i micro-mammiferi e imammiferi che non erano micro. Avevo sempre tra le mani l’enciclopedia, che continuavo aleggere senza stancarmi, da Abete a Zucca. Ancora adesso mi capita di svegliarmi lamattina pronunciando Oritteropo o Berillo – frammenti di quel sapere che ancora naviganonella profondità della mia mente.Tra compleanni e San Nicolò, all’enciclopedia si aggiunsero, nel tempo, altri libri, primifra tutti i due giganteschi volumi del Brehm. Questo nome – Alfred Brehm – oggi sconosciutoai più, allora era una vera celebrità tra gli appassionati di scienze natur<strong>ali</strong>. Quei due volumisono stati per me come un magico tappeto volante. Li aprivo, mi sdraiavo sopra e, con loro,volavo verso mondi meravigliosi. Al Brehm seguì Jules Renard, a Renard il Fabre, con le suestorie di scarabei stercorari. Avrei dato qualsiasi cosa per vederne uno in azione. Solo daadulta ho avuto questa fortuna, attraversando un brullo pascolo dell’Appenino.Durante l’estate, sulla spiaggia di Grado, cominciai a raccogliere conchiglie. Non nivomai di stupirmi della straordinaria arditezza delle loro forme. Come nei miner<strong>ali</strong>, sica echimica si univano per creare qualcosa di inimmaginabile e anche di magico, perché, anchea casa in pieno inverno, appoggiando l’orecchio sui murici si poteva sentire il rumore delmare. A dierenza dei miner<strong>ali</strong>, però, là dentro c’era la vita. La conchiglia, infatti, ospitavaun essere vivente che con le sue secrezioni era in grado di costruire quei capolavoriarchitettonici.Quale scheda di computer si può paragonare a un piccolo gasteropode che plasma volutee archi degni di una cattedrale barocca! L’unico mio rammarico era di essere nata a Triestee non in qualche atollo dell’oceano Indiano, o nel bel mezzo della foresta amazzonica.Andavo spesso in piazza Hortis a vistare lo straordinario Museo di scienze natur<strong>ali</strong>. Là
dentro, tra le altre cose, c’era – dico c’era perché il museo è stato ormai trasferito esmantellato dalla cecità dei politici loc<strong>ali</strong> – una grande collezione di conchiglie e io passavoore a guardarle una a una, stupendomi del fatto che tutto ciò che giungeva dai mari lontanipossedeva una complessità e una bellezza decisamente superiori a quello che proveniva dalmare locale.La stessa cosa poteva dirsi per le farfalle. Il massimo a cui si poteva aspirare, dalle nostreparti, era quello di vedere una vanessa, un pod<strong>ali</strong>rio, una saturnia del pero, mentre inAmazzonia svolazzavano delle specie di lenzuola iridescenti: enormi farfalle dai colorisplendidi, con lunghe code come aquiloni.Quando venni poi a conoscenza della grande avventura di Darwin, mi fu chiaro cheanch’io, un giorno, avrei fatto come lui: sarei s<strong>ali</strong>ta su un brigantino e avrei lasciato ilgrigiore dell’Europa alla volta del paradiso dei Tropici.Per anni ho desiderato un cane di razza beagle solamente perché quello era il nome dellanave che aveva portato in giro per il mondo il fortunato esploratore.Non ero neppure sorata dal sospetto che i tre alberi non solcavano più i mari e che illoro posto era stato preso dagli aerei e dagli elicotteri. Con quelli ormai gli esploratori dellaseconda metà del Novecento raggiungevano le loro mete.Il mio mondo natur<strong>ali</strong>stico era – ed è tuttora – quello dell’Ottocento, un mondo digentiluomini colti e curiosi, che viaggiavano, raccoglievano e indagavano per il puro einfantilissimo piacere di farlo.Che cos’è, infatti, la storia naturale se non l’ovvia prosecuzione della curiosità infantileper tutto ciò che ci sta intorno?Quella del natur<strong>ali</strong>sta è la condizione più spontanea dell’uomo perché, n dagli alboridella nostra specie, abbiamo dovuto imparare a conoscere tutto ciò che ci circondava perriuscire a sopravvivere. Se mangio un’erba, vivo, se mangio quell’altra, mi viene il mal dipancia e muoio. Anche per catturare un animale, prima di ogni altra cosa, devo sapere dovevive e come vive.Ma oltre a ciò – superata cioè la fase primitiva della sopravvivenza – questo tipo diosservazione permette di giungere a un’altra condizione, quella dello stupore.All’improvviso qualcosa mi sorprende, ed è questa sorpresa a compensare qualsiasi sforzo.Trovo qualcosa che non pensavo di trovare. Oppure ciò che vedo è così inaspettatamentebello da farmi trattenere il ato. Non me l’aspettavo! Non credevo di trovarlo qui! Nonimmaginavo fosse così bello!Le scienze natur<strong>ali</strong> richiedono l’abbandono alla meraviglia.Ancora adesso, riuscire a vedere dal vero degli anim<strong>ali</strong> o delle piante conosciutiunicamente sui libri è per me fonte di emozione straordinaria. Sono andata in Madagascarsoltanto per toccare i lemuri. Purtroppo non ho visto l’aye aye. Ho quasi pianto alleGalápagos, vedendo i famosi fringuelli svolazzarmi intorno. La stessa sensazione ho provatoin Africa, davanti ai piccoli elefanti dalla testa pelosa che si abbeveravano con le madri inuna pozza d’acqua.Non amo particolarmente viaggiare, ma per riuscire a vedere un animale sono disposta a
sobbarcarmi migliaia di chilometri. Tra i miei desiderata dei prossimi anni, c’è quello diandare ad ammirare le balene e gli orsi bianchi. Anche i koala stanno in cima ai mieipensieri. Vorrei capire che densità ha il loro naso. E poi, naturalmente, mi piacerebbetrovarmi faccia a faccia con l’ornitorinco, compendio di meraviglia naturale, ma temo chel’Austr<strong>ali</strong>a sia davvero troppo lontana per le mie scarse attitudini aeree.Per anni ho tenuto dei taccuini, annotando e disegnando tutto ciò che di naturale colpivala mia immaginazione. Non vedo l’ora che la mia vita sia più tranquilla per continuare afarlo.Nei lunghi anni trascorsi a Roma, in un palazzo di pietra stretto fra altri palazzi di pietra,ho esercitato la mia attività, osservando i pesciolini d’argento – quei minuscoli insetti chevivono tra i libri – e gli oniscidi, che correvano timidi a nascondersi tra le fessure deisanitari, appena accendevo la luce del bagno. Lasciavo la casa sempre un po’ sporca perpermettere a qualche minuscola forma di vita di manifestarsi. La domenica, mi aacciavoall’unica finestra della stanza e guardavo sotto, per ore, affascinata dall’intensa soci<strong>ali</strong>tà deiratti, mentre, di notte, tendevo le orecchie per percepire gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli,ricordando le geni<strong>ali</strong> ricerche dell’abate Spallanzani.Dagli otto, nove anni in poi, il piacere per la conoscenza e l’osservazione della natura èstato il chiodo sso dei miei giorni. Chi viene in visita a casa mia, spesso resta stupito daquanti pochi segni del mondo letterario ci siano in giro. Niente pompose librerie, oggetti didesign, trofei e targhe, simboli di intelligenza e padronanza intellettuale. Piuttosto, sparseun po’ ovunque, spuntano raccolte di piume, di nidi, casette per far riprodurre le coccinellee le farfalle, piccoli terrari che ospitano i bruchi, vasche dove far vivere i tritoni,micropozze nelle qu<strong>ali</strong> osservare i collemboli acquatici e le incantevoli diatomee. Il tuttocondito da un disordine creativo fatto di temperini, lenti, binocoli, forbici da giardino, pelidi gatto, di cane, fango e grandi opilionidi sospesi serenamente in tutti gli angoli della casa.Quando viaggio per lavoro, mi trovo spesso nell’incresciosa situazione di fronteggiare deigentili antrioni che, pensando di farmi cosa grata, organizzano per me delle visite aimusei, magari di arte moderna. Chissà, forse perché si ritiene che un artista debba per forzaessere interessato ad altre forme d’arte!Declino sempre l’invito con la scusa di un mal di testa o di una grande stanchezza.Appena sola, però, sgattaiolo fuori dall’hotel alla ricerca di un acquario, un museo discienze, uno zoo, qualcosa che mi dia le stesse emozioni che, magari ad altri, dà la visionedell’Optical Art.Una volta un giorn<strong>ali</strong>sta, alla ne del nostro colloquio, mi disse: “In fondo, il titolo dellasua autobiografia potrebbe essere: La ragazza che non voleva scrivere.” “In fondo, sì,” risposi.Per una grande parte degli anni della mia formazione, non sono stata neppurelontanamente sorata dall’idea che lo scrivere, la scrittura o una qualsiasi forma d’artefossero in qualche modo legati alla mia persona. La mia febbre era altrove, eranell’imparare il nome di ogni forma vivente. La mia febbre stava nello scoprire la relazioneche lega i nomi tra di loro. Per me era – ed è – suciente scoprire, durante unapasseggiata, una pianta, un ore o un insetto di cui non conosco il nome per cadere in uno
stato di grande irrequietezza. Irrequietezza che termina soltanto nel momento in cui riesco ascoprirlo.Anche adesso, mentre scrivo – è mezzogiorno – un gufo reale sta ripetendo il suo versopoco lontano dal mio studio e questo mi distrae dalla scrittura. Perché mai canta amezzogiorno? mi chiedo. E non so rispondermi. Ma, prima o poi, dovrò riuscire a trovareuna risposta.Capire la ragione di ogni cosa e saper scoprire la relazione di tutto ciò che si vede – sonoqueste le princip<strong>ali</strong> attitudini dell’appassionato natur<strong>ali</strong>sta.E se fossero anche quelle dello scrittore?Se, prima di tutte le teorie, le strutture, le tecniche ci fosse proprio questo, l’infantiledesiderio di decifrare il mondo intorno? La materia vivente mi racconta la sua storia e, daquesta storia, io so far derivare tutte le altre storie.Capire l’origine, il senso, comprendere la direzione.Non saperla n dall’inizio, ma trovarla per la strada piano piano grazie a una traccia, ungraffio, una piuma.Scoprirla lentamente, carta dopo carta, come nel gioco del solitario.La passione per le scienze natur<strong>ali</strong> è la radice profonda della mia scrittura. Dietro ognimia frase, c’è la lentezza e la quiete dell’entomologo.Io osservo e interrogo, interrogo e osservo.Mi interrogo e interrogo la realtà che mi vive intorno.Non sto in piedi sul piedistallo del mor<strong>ali</strong>smo, né indosso le lenti deformanti delsentiment<strong>ali</strong>smo.An<strong>ali</strong>zzo, annoto e, alla ne, ricerco il senso. I voli pindarici non sono il mio forte. Ilterritorio in cui mi muovo è quello della devozione alla realtà.Entrare nella meraviglia dell’universo mi sottrasse all’incomprensibilità del mondo degliuomini che mi circondava.Più l’esistenza quotidiana si faceva disarmonica, più io mi buttavo tra le braccia dellamineralogia, della malacologia, dell’entomologia. E più le loro braccia mi accoglievano, piùmi rendevo conto che dovevo invertire l’ordine delle domande.Non più: Chi comanda il mondo? ma piuttosto: Da dove vengono la sica, la chimica, lamatematica? Da dove scaturiscono le leggi che permettono alle cose di esistere nella loroconcreta stabilità? Stavano lì da qualche parte sospese nell’oscurità delle tenebre, in attesache qualcuno si decidesse a usarle, o erano nate per caso?La mia personale esperienza di persona alquanto disordinata mi suggeriva però il fattoche dalla casu<strong>ali</strong>tà difficilmente poteva sorgere l’ordine.E allora?Dal caso, potevano nascere forme perfette come la struttura elicoidale di una conchiglia?E quella struttura così sorprendente, non conteneva forse in sé anche un altro principio,quello della bellezza?
E la bellezza, cos’altro era, se non il soprassalto dello stupore? A un tratto, c’è qualcosache non mi aspetto e questo qualcosa colpisce direttamente il mio cuore.Ancora non lo sapevo, ma n dal principio sono stata un’anima assetata di bellezza. Enon sapevo neanche che la bellezza porta con sé, come discreta ancella, la sete di verità.
16.Qualche tempo fa, durante un mio soggiorno a Trieste, sono andata alla ricerca dellachiesa armena. Lì infatti, prima di venir confusamente istruita sulle dottrine teologiche –prima degli otto anni dunque – accompagnavo a volte mia nonna Elsa alla messa delladomenica. Ricordavo che, per raggiungerla, si percorreva una strada in discesa in fondoalla quale si vedeva, in lontananza, il mare, e che, accanto alla chiesa, sorgeva un ediciodi grandi dimensioni, il palazzo degli armeni, appunto. Per arrivarci, si passava davanti auna villa circondata da un giardino ombroso che mia nonna mi disse essere la casa diSlataper.Così, in una giornata di forte bora, girando per quelle vie silenziose, alla ne mi ritrovaidavanti alla prima chiesa della mia infanzia. Era molto più piccola di come la ricordavo ein uno stato di avanzato degrado. Il cancelletto che immetteva nel piccolo giardinoprospiciente era chiuso, le aiuole, ormai incolte e coperte di erbacce, accoglievano ogni tipodi riuto che la bora riusciva a trasportare – sacchetti di plastica, lattine, confezioni vuotedi panettoni. Per cercare protezione dalla violenza delle rache, due o tre gatti spelacchiatie rognosi dormivano rasente ai muri.Anche la canonica sembrava abbandonata da tempo e il cartello che indicava la comunitàcattolica di lingua tedesca pareva non aver più alcun riferimento con la realtà. L’unica cosache collegava l’immagine di cinquant’anni fa a ciò che mi stava davanti era il forte odore dipipì di gatto.L’odore!Non so se sia per la mia innata attitudine a indagare o per il dono ricevuto di un grandenaso, ma da sempre gli odori hanno avuto un ruolo cardine nella mia memoria. In untempo diviso equamente tra le puzze re<strong>ali</strong> – l’inquinamento – e quelle sintetiche –, ideodoranti creati per nascondere gli afrori natur<strong>ali</strong> – è sempre più dicile immaginare ilruolo guida che ha l’olfatto.Eppure è così.Grazie alla magnetite depositata nel loro becco, gli uccelli migratori percorrono migliaiadi chilometri orientandosi con il sole e le stelle, ma quando giungono in prossimità delladestinazione che volevano raggiungere, a guidarli nel riconoscimento non è lo sguardo,bensì l’olfatto. Per il lungo tempo dell’inverno, infatti, la loro memoria ha conservato glieuvi che li hanno accolti quando, rompendo il guscio dell’uovo, sono venuti al mondo.Grazie a quei precisi odori sono in grado di raggiungere la stessa stalla, lo stesso parco, lostesso albero in cui sono nati.Così, come le rondini ritornano sempre nel posto in cui sono venute al mondo, altrettantoio tornai in quel luogo – la chiesa armena, appunto, dove, in quegli anni lontani, si
adunava la comunità cattolica di lingua tedesca – come al luogo in cui, per la prima volta,ebbi la percezione che, nella realtà di tutti i giorni, si nascondesse qualcosa di diverso.Odore di pipì di gatto, di muffa, di umidità.Odore di inverno, di freddo, di assenza di riscaldamento. Intorno a me, tante persone chenon conoscevo. Mia nonna portava sempre con sé un album da colorare o un giorn<strong>ali</strong>no dasfogliare, ritenendo tedioso per una bambina assistere a un rito di cui non capiva nulla.Mi sedevo così sull’inginocchiatoio e, in silenzio, senza disturbare nessuno, passavo il miotempo. Le storie di Tiramolla mi attiravano sempre più di quello che succedeva intornoall’altare.Malgrado ciò, c’era sempre un momento in cui interrompevo la lettura. Era quando,all’improvviso, intorno a me scendeva un silenzio pressoché assoluto. Niente più colpi ditosse, né scricchiolii del legno. <strong>Ogni</strong> cosa si fermava. E, in quel silenzio carico d’attesa, a untratto, trillava tre volte un campanello argentino.Tling tling tling!Tling tling tling!Tling tling tling!Quel suono – la manifestazione dell’epiclesi – rimane presente nella mia memoria come ilgong delle illuminazioni buddiste.Tling! La scorza della realtà è dura e opaca.Tling! Ma questa è solo apparenza.Tling! In realtà c’è un mistero nascosto là dentro!Come molte glie di Gerusalemme trasmigrate poi tra le braccia del cristianesimo, mianonna frequentò le elementari presso le suore di Notre-Dame de Sion. Poi a dieci anni, peril periodo della prima guerra, si trasferì con la famiglia a Firenze e lì, in una bella villavicino ai Boboli, venne iscritta a una scuola inglese privata tenuta da due signorine che –come diceva mia nonna – “dovevano essere molto amiche, perché le trovavo sempreabbracciate sul divano del salotto”.Ritornata a Trieste, fu una delle prime ragazze a iscriversi al liceo classico e a concluderloa pieni voti. Ma l’onta di Notre-Dame de Sion rimase profondamente impressa nel suocuore. L’episodio delle pecorelle che cadono del burrone per i peccati, che ho raccontato inVa’ dove ti porta il cuore, appartiene alla sua educazione. Spirito libero e indipendente, malsopportava il clima di mor<strong>ali</strong>smo fanatico e punitivo che imperava in quelle aule.Proprio qualche giorno fa, una mia anziana cugina, Nadia Blitznako – una delle dueuniche sopravvissute della foto dei nipoti con Olga Moravia –, mi raccontava di essersisalvata in quella stessa scuola perché, in quanto ortodossa, era dispensata dalle lezioni direligione cattolica. Così, per farle passare il tempo, una giovane suora la portava in cimaalla torretta e da lassù, con dolcezza, le parlava dell’orizzonte del cielo e di quello del cuore.“Ringrazio sempre il cielo di quell’incontro,” mi ha confessato una volta, prima dichiudere la telefonata, “perché altrimenti, se avessi assistito a quelle lezioni, sareisicuramente diventata atea!”
Non so cosa fosse diventata mia nonna ma, di sicuro, non aveva nessuna aezione per gliinsegnamenti della religione. E non l’aveva principalmente per un fatto: perché là dentro,prima di ogni altra cosa, aveva visto trionfare l’ipocrisia. E l’ipocrisia è il più grande velenoche si possa buttare in faccia a chi è alla ricerca della verità.Nata da una madre giovanissima e da una famiglia che, nel corso di una solagenerazione, aveva sperimentato un salto sociale di dimensioni impressionanti – da poveridroghieri di Marsiglia a ricchi industri<strong>ali</strong> a capo di un impero diuso in tutto il mondo –,mia nonna aveva caricato su di sé tutte le fragilità e le incertezze di una simile situazione.Quando penso a sua madre, la mia bisnonna, che aveva soltanto diciassette anni di più disua figlia, e a lei, vedo lucidamente la frattura che divide l’Ottocento dal Novecento.Nella vita della bisnonna Dora, ogni cosa era – e doveva essere – al suo posto. La vedoancora entrare nelle stanze con la sua gura corta e massiccia, il suo bel viso sefardita, igrandi occhi scuri e tondi, con la voce forte e impostata di una persona che, per tutta lavita, si era dedicata al canto. Abitava nello stesso palazzo di sua glia, al piano superiore, ela sua casa con i pavimenti di linoleum tirati a lucido e un souso odore di buona cucina, dicera, naft<strong>ali</strong>na e mentine mi incuteva un certo timore.La grande attrattiva di quell’appartamento era per me il pianoforte. Appena la bisnonnaandava in un’altra stanza, sollevavo lentamente il coperchio, slavo il lungo panno verde ecominciavo a suonare. Non suonavo una musica prestabilita, ma soltanto quella che avevonella testa: sui tasti alti, ricercavo il rumore argentino della pioggia, su quelli bassi, ilpoderoso risucchio della Fossa delle Marianne e, nel mezzo, la follia dodecafonica dei mieipensieri quotidiani. Quando la nonna Dora sentiva le note di quell’improvvisato concerto,piombava come un’aquila nella piccola stanza, mi faceva scendere dallo sgabello girevole,risistemava il panno verde sui tasti, abbassava il coperchio e chiudeva a chiave l’oggetto deimiei desideri.Quanto avrei desiderato suonare il pianoforte!E quanto benecio probabilmente avrebbe avuto la mia mente da uno studiocontinuativo, capace di trasformare il caos in bellezza, quanta serenità mi sarebbe giuntadal comprendere e dominare l’armonia! Invece l’unico spartito che ero in grado di seguireera quello dell’assoluta dissonanza.La musica aveva sempre fatto parte del patrimonio culturale della mia famiglia. Labisnonna Dora cantava, il bisnonno Bepi, oltre a suonare il violoncello da solo o inquartetto con i suoi fratelli, era direttore della Società dei Concerti, per cui i grandi musicistidell’epoca passavano tutti per casa loro. Il fratello della bisnonna, Bruno, ebbe per unperiodo una brillante carriera di concertista, mentre lo zio Ettore, caparbiamente, siintestardì per anni nello studio della ciaccona con il suo violino. Anche mia nonna Elsastudiò pianoforte, ma, come ripeteva, grazie al fatto di aver sciacquato i panni in Arno, loebbe presto in uggia e così la catena dei musicisti si interruppe.In realtà credo che, più che la sua uggia, la distruzione del patrimonio musicale dipesedalla bomba che, il 20 febbraio del ’45, rase al suolo la villa in cui tutti, no ad allora,erano vissuti. Bruciò il pianoforte a coda; bruciarono gli spartiti; un bel falò avvolse violeviolini e violoncelli; vennero ridotti in cenere tutti i libri, i quadri e gli arredi, tutto ciò che,
per due generazioni, aveva costituito la realtà delle persone che avevano vissuto in quellavilla bianca.L’unica cosa che sopravvisse a quella tremenda esplosione, a quelle amme fu unaconfezione di uova che, da crude, divennero perfettamente sode.La bomba distrusse la memoria materiale della famiglia e, oltre a quella, la complessitàdei rapporti umani creatisi in quell’ottantina di anni di forzata convivenza.La fabbrica e la villa rimasero come misteriose entità uttuanti nei racconti della miainfanzia. Una sorta di Eldorado che aveva accolto tutti nell’abbondanza e nella felicità,prima che un destino m<strong>ali</strong>gno lo distruggesse, costringendo i suoi abitanti a vivere nelleristrettezze umilianti di appartamenti sparsi in giro per la città.Per tutta la vita mia madre ha vissuto nel nostalgico ricordo della sua infanzia passataalla villa. Al contrario, mia nonna reputava quella bomba un dono del cielo, perché l<strong>ali</strong>berò per sempre dal giogo di dover convivere forzatamente con la sua vasta e variegatafamiglia. Considerava, infatti, il vivere insieme ai propri parenti una tentazionedemoniaca, alla quale bisognava opporsi con tutte le proprie forze.<strong>Su</strong>a madre, invece, la nonna Dora, anche se ormai stava al quarto piano di un caseggiatoanonimo, continuava la sua vita come se niente fosse. Sicura di sé e dei valori del suomondo, a tavola, suonava imperiosamente il campanello per chiamare la cameriera, comese intorno alla modesta stanza da pranzo ci fosse ancora una moltitudine di stanze, comese, fuori, l’attendessero i giardinieri e, nelle stalle, ci fossero ancora le carrozze con i cavallilustri, il cocchiere con la frusta in mano, sempre pronto a scorrazzarla in giro per la città.Se neppure le bombe poterono scuotere la nonna Dora dalle sue certezze, altrettantoquell’esplosione riuscì a placare l’inquietudine che, fin dall’infanzia, attanagliava sua figlia.Per la nonna Dora, i privilegi della ricchezza erano qualcosa di dovuto e di indubitabile,mentre per Elsa erano fardelli di cui bisognava cercare di sbarazzarsi il prima possibile. Ilmatrimonio con mio nonno costituì un clamoroso atto di ribellione nei confronti di unarealtà che percepiva come profondamente inquinata dall’ipocrisia e dalla superfici<strong>ali</strong>tà.Le nozze, comunque, non attutirono aatto la sua inquietudine, si ritrovò soltantoprigioniera in un altro tipo di gabbia. Nonostante gli anatemi della sua famiglia sulla vitagrama che avrebbe avuto sposando quell’uomo venuto dal nulla, fu proprio grazie all’abilitànegli aari di suo marito – l’albero della cuccagna in cima ai suoi pensieri – che ebbeun’esistenza borghese e confortevole, anche se nei riguardi di quelle convenzioni provavaun senso di asssia. Asssia che manifestava esasperando i suoi lati peggiori: egoismo,prepotenza, vanità. Sentiva il vuoto intorno a sé, sotto di sé, ma a quel vuoto non sapevadare un nome. Per non ascoltare il silenzio assordante che usciva da quella stanza, riempivala sua giornata di costanti e inutili rumori.Poi, verso i cinquant’anni, nella sua testa e nel suo cuore, all’improvviso si spalancò unaporta. Per fortuna le suore di Sion erano ormai lontane. I ricatti, le ottusità, le meschinitàpiù bigotte del cristianesimo si erano attenuate nella sua memoria.Rincontrò un’amica d’infanzia che era sopravvissuta ad Auschwitz. Si frequentarono,passarono molti pomeriggi insieme. “All’inizio,” mi raccontava la nonna, “andavo da lei perfarle compagnia. Dopo quello che aveva passato, pensavo avesse bisogno di essere
distratta. Solo con il tempo, mi sono accorta che non era lei ad avere bisogno di me, ma iodi lei. Solo con il tempo ho capito che lei era pura luce e che la sua luce, così diversa daquelle che avevo conosciuto no a quel giorno, cominciava a toccare anche me. Lucedell’amore che tutto ha visto. Luce dell’amore che tutto comprende.”L’inquietudine, così, arrivò al capolinea e mostrò il suo vero volto. La sete di verità.
17.La vita come possesso.La vita come cammino.Sono queste le due condizioni tra le qu<strong>ali</strong>, alla ne, ci troviamo a scegliere. Individuareun luogo, raggiungerlo e lì rimanere fermi, oppure andare avanti, sentire che nessun postoè veramente giusto; trovare un vestito della taglia giusta e tenerselo stretto. Con il tempo,però, cresciamo e il vestito rimane sempre lo stesso, si adatta alle mutate condizioni delnostro corpo; così, lentamente e inesorabilmente, si trasforma in corazza.La corazza protegge, rassicura, sostiene un corpo che, via via, si fa più debole. Chebisogno c’è della spina dorsale, se c’è già il suo acciaio a tenerci dritti? L’interno, allora,diventa molle come quello di un gasteropode. Noi non ce ne accorgiamo, anche agli occhidegli altri siamo persone assolutamente norm<strong>ali</strong>. In realtà, il nostro interno si disfalentamente, collassa, e allora i nostri sentimenti, i nostri valori, i nostri pensieri diventanoquelli della corazza.Rigidi, limitati, stretti.Alla fine l’esoscheletro ha vinto sull’endoscheletro.Se uno schiaccia un coleottero, sente il crash della corazza chitinosa ma, dopo il crash, sulpavimento resta poco più di una poltiglia acquosa. Ben diversa è la consistenza di chi èdotato di vertebre.Tutte le fedi – con la sola gravissima eccezione del cattolicesimo che relega il corpo, nelmigliore dei casi, a livello di inutile zavorra – parlano dell’importanza della spina dorsale.La spina dorsale è ciò che ci fa stare dritti, ciò che ci fa s<strong>ali</strong>re come gli alberi, verso l’alto.Lungo la colonna vertebrale sono situati i chakra e, dall’armonia del loro funzionamento,dipende molto la salute del corpo. Se, nella sua crescita, tende a inclinarsi da un lato odall’altro, si dice che ha un vizio, un “vizio di postura”. E un vizio cos’altro è, se nonl’allontanarsi dalla retta via?Tempo fa, un ortopedico mi raccontava di avere in cura bambini di nove, dieci anni.Stando sempre sdraiati sul divano a guardare la televisione, accartocciati sul computer o suun videogioco, non hanno più modo di sviluppare il loro apparato scheletrico. Invece dicrescere sul piano verticale, si espandono su quello orizzontale. E questo è un segno dimutazione antropologica piuttosto inquietante. Con le parole, possiamo fare discorsimeravigliosi, ma se quelle parole non hanno fondamento nel corpo – nel qui e ora che ci faesistere – si può mascherare facilmente la falsità di quello che diciamo.La vita come stabilità delle cose, come stabilità della colonna.Ma paradossalmente, per raggiungere la stabilità, bisogna portare all’estremol’instabilità. L’uomo re<strong>ali</strong>zza se stesso alla massima potenza soltanto quando accetta lalegge profonda del cambiamento. Quanta tristezza, quanta cecità nelle persone che si
trincerano dietro alle loro solide opinioni, che m<strong>ali</strong>nconia in chi aerma ero: “Io sonofatto così e non posso farci niente!”Anche quando non lo sapeva, mia nonna era una nemica della corazza. La indossavacerto, perché non conosceva altre condizioni, ma, n da subito, ne percepì l’errore dimisura. Troppo stretta, troppo corta, troppo crudele nel limitare ogni movimento.In questo senso, ma solo in questo, Va’ dove ti porta il cuore è la sua storia, perché è lastoria di ogni persona che, invece di stare ferma, decide di andare avanti, di modicarsi, dicercare quel lo rosso che unisce la ban<strong>ali</strong>tà dei giorni e, improvvisamente, ore loro unsenso.Va’ dove ti porta il cuore è la storia della ricerca del proprio sé più profondo. Il grandeabbassamento culturale degli ultimi anni – unito alla carica di giorn<strong>ali</strong>sti che hanno invasoil campo con le loro storie vere in forma di romanzo – ha stravolto il ruolo della letteratura,facendo credere a molti che un libro altro non sia che una trascrizione di un fatto realmenteavvenuto.Quante risate abbiamo fatto con mia madre!Capitava spesso infatti, nelle situazioni più impreviste, quando lei svelava di essere miamadre – non portavamo lo stesso cognome –, che qualcuno esclamasse: “Ma come? Non èmorta?” E lei naturalmente faceva scongiuri di ogni tipo. Mia madre, infatti, era glia dimio nonno e non il frutto di un adulterio, mentre io non sono stata aatto allevata da mianonna. Quando già vivevo a Roma, passavamo le vacanze estive insieme e non perché eramia nonna, ma perché eravamo anime affini e stare vicine ci rendeva felici.Uno dei nostri argomenti preferiti erano i corteggiatori, che lei aveva avuto inabbondanza e che anch’io, all’epoca, avevo in abbondanza. Vicino al telefono le lasciavodei bigliettini-guida. “Se telefona A. chiamami. Se invece telefona B., fallo aspettare e digliche forse torno stasera. Se poi telefona C. digli che sono partita per un mese.”Si divertiva molto.<strong>Ogni</strong> tanto, con aria gioiosamente infantile, diceva: “Non è imbarazzante che parliamosoltanto di spasimanti?”“E di cosa dovresti parlare?”“In fondo sono tua nonna… Potrei dire qualcosa di barboso e di saggio, no?”Per fortuna, nonna Elsa era già morta quando è uscito Va’ dove ti porta il cuore, così nonha potuto leggere la gran quantità di castronerie scritte sul libro da parte di chi si eraaccontentato di sfogliarlo inforcando le spesse lenti del pregiudizio.La protagonista, infatti, è una donna lucida e crudele, una persona capace di dire,riguardo alla glia morta precocemente, che “non era per niente intelligente”. Una donnache ha mentito a tutti e che, con la menzogna, ha costruito la catastrofe della sua vita.Confondere l’an<strong>ali</strong>si del sentimento profondo con il sentiment<strong>ali</strong>smo è un altro grandesegno di ignoranza umana e culturale.Tra le poche cose lasciatemi in eredità da lei, comunque, c’è una piccola stampa che stavasopra il suo letto e che ora è sul mio. Rappresenta uno scheletro appoggiato con un gomito
su un sarcofago come fosse sdraiato su un divano. Sotto, in greco, c’è scritto: “Conosci testesso.” Bisogna essere spietatamente crudeli per obbedire a questo imperativo.Fino oltre ai cinquant’anni, mia nonna procedette sulla strada dell’inquietudine edell’irrequietezza, progredendo più per riuti che per aperture. L’incontro con l’amicasopravvissuta ad Auschwitz impose una brusca sterzata a questo suo cammino.All’improvviso, si trovò davanti a nuove domande, davanti a una sete di conoscenza in uncampo che, fino ad allora, le era stato totalmente estraneo.Proprio a quel periodo – le cose accadono sempre quando il tempo è maturo – risalel’incontro con padre Dietrich, il sacerdote che guidava la comunità cattolica tedesca e checelebrava la messa nella chiesa armena. In lui trovò una guida anticonvenzionale,coraggiosa, capace di infrangere ogni suo dubbio, ogni suo tentennamento. Immersa nelleScritture, scoprì improvvisamente una nuova linfa per la sua anima ormai appassita. Ladonna viziata e infelice stava trasformandosi in una persona che camminava verso laleggerezza e la gioia.Ricordo anch’io il viso di padre Dietrich, un volto dagli zigomi scolpiti, da tedesco delNord. A lui, alla sua memoria, ho dedicato il personaggio di padre Thomas. <strong>Su</strong>l prato sia ilprato, sotto l’albero sia l’albero, con gli uomini sia tra gli uomini.Purtroppo, fu stroncato da un tumore ancora in giovane età, lasciando così mia nonnaorfana delle sue frequentazioni domenic<strong>ali</strong>.Ma intanto, in quella chiesa, aveva conosciuto Maria.Maria era l’esatto opposto di mia nonna. Maestra elementare – nella mia stessa scuola tral’altro – aveva cominciato a lavorare a vent’anni, percorrendo in bicicletta tutte le zone piùdesolate del Carso e dell’Isontino. A dierenza della nonna, non aveva mai avuto uncorteggiatore o, se l’aveva avuto, l’aveva scartato in quanto non di suo gusto, ed era statasempre una donna indipendente. Non erano molte, allora, le donne che si mantenevano conil proprio lavoro e credo che mia nonna un po’ la invidiasse per questo. Alta, magra,camminatrice, appassionata di botanica, parlava perfettamente il tedesco ed era unagrande conoscitrice della letteratura di quella lingua. Di spirito protestante, conosceva benele Scritture. Viveva al pianterreno di una villetta nello stesso quartiere dove sono nata.Alla morte di mio nonno, diventò la grande compagna di mia nonna. Stavano insieme eparlavano no allo snimento di letteratura, di teologia, di qualsiasi cosa venisse loro inmente.La sete di conoscenza e di verità di Maria coincideva perfettamente con quella di Elsa.Era la prima volta nella sua vita che trovava una persona con la quale confrontarsi a unlivello alto.“Solo dei corteggiatori non posso parlare con lei,” si lamentava ironicamente con me.“Pazienza,” le rispondevo. “Puoi sempre farlo con me.”Insieme leggevano, insieme studiavano, insieme viaggiavano. Insieme, con allegria, conpassione, con curiosità, si sono avviate verso quell’età che, di solito, viene considerata la più
triste. Da giovane Maria aveva avuto la tubercolosi ed era rimasta di salute cagionevole.“Povera Maria, è così delicata,” ripeteva sempre mia nonna, che non aveva mai avutonulla, neppure un’unghia incarnita. Malgrado ciò, se ne andò vent’anni prima della suaamica, dopo aver arontato l’atroce oscurità dell’Alzheimer. Così ho ereditato l’amicizia diMaria nella mia vita.Maria, la mia prima grande lettrice, la mia prima grande incoraggiatrice! Quandopassavo per Trieste, andavo regolarmente a prendere un tè da lei. Parlando dei giornitrascorsi con mia nonna, spesso si commuoveva.Che gretta ottusità pensare che i legami dettati dal sangue siano i più importanti! Cheprigione mediocre ritenere il sesso ciò che lega davvero le persone!È nell’amicizia che l’essere umano conosce la forma più imprevedibilmente alta dirapporto.Nel cuore di mia nonna, il posto di padre Dietrich non venne poi più preso da nessunaltro. Fece alcuni deboli tentativi di trovare dei sostituti, ma, come le incontentabiliprincipesse delle abe, li scartò uno dopo l’altro. Troppo poco uomini, troppo mor<strong>ali</strong>sti,superfici<strong>ali</strong>, melliflui. Tutti troppo interessati a una sola cosa. Ricevere dei soldi.
18.“Milioni! Ti rendi conto?” raccontava mia madre. “Si chiamava Milioni! E come altro sipoteva chiamare, se non così?”Milioni, infatti, era il cognome del sacerdote patrocinatore alla causa di annullamento delloro matrimonio presso la Sacra Rota. E diversi milioni di lire – la legge sul divorzio ancoranon esisteva – furono sicuramente quelli che mio nonno dovette versare per permettere allasua amata figlia di tornare nubile.Già, perché intanto le cose erano andate avanti. Mio padre si era trasferitodenitivamente a Roma, dove viveva in improbabili seminterrati popolati di brandinepieghevoli e di minuscoli fornelli da campeggio per scaldarsi il cibo. Non aveva un lavoro,se non si considera lavoro il fatto di essere un bell’uomo e vivere nel turbine della dolce vitache, in quegli anni, impazzava nella capitale.Bello come un attore americano, misterioso e sfuggente come si conviene a ogni veroseduttore, mio padre penso abbia vissuto molti anni alle spalle dei suoi amici e delle donnea cui aveva infranto il cuore.Quando mi trasferii anch’io a vivere a Roma, mi capitò più volte di incontrare dellesignore che, a sentire il mio cognome, esclamavano sognanti: “Tamaro! Conoscevo un uomocon quel nome…” e alle qu<strong>ali</strong>, immancabilmente, rispondevo: “Temo che sia mio padre.” Misquadravano allora, stupefatte: “Davvero? Gianni non mi ha mai detto di avere dei figli.”Aveva una natura estremamente frugale, natura che io ho ereditato. Sosteneva che, peresseri liberi, bisognava sottrarsi alla terribile schiavitù del desiderio. Era capace di viverecon la stessa indierenza alle soglie della povertà o nel lusso estremo. La spider bluPinifarina era stata cambiata con una 850, sempre spider e, schiacciato dentro quellascatoletta – era un uomo imponente –, andava in giro per la capitale a fare danni.La prima volta che andai a trovarlo a Roma con mia madre, avevo otto anni e l’unicacosa che mi interessava davvero era poter visitare lo zoo. Tornai poi un paio di altre volte,ormai adolescente, insieme a mio fratello. L’unico motivo di felicità di quelle nostre visiteera costituito dal fatto che ci portava alle bancarelle a comprare i vestiti americani che aTrieste era impossibile trovare. Jeans, maglioni blu che venivano da Livorno, e persino unagiacca da marinaio con i bottoni d’oro che per mesi ho tolto soltanto al momento di andarea dormire. Quella giacca, infatti, mi sembrava il preludio della mia futura vita dinavigatrice a bordo dei brigantini.<strong>Ogni</strong> tanto, sempre più raramente, veniva a trovarci a Trieste. A ogni visita sembrava diritorno da qualche loc<strong>ali</strong>tà balneare. Arrivava con i jeans sfrangiati, le infradito ai piedi ocon dei sand<strong>ali</strong> che si era fatto fare su misura sulla costiera amaltana. Veniva daMarrakech, ci diceva, o da Capri o da Taormina. Di carnagione molto scura – negli ultimi
anni aveva assunto un’inquietante somiglianza con Saddam Hussein – sembrava appenauscito dal mare. Si scuoteva di dosso la sabbia e il sale e, per due o tre giorni, faceva la suacomparsata da padre, intervallando nei nostri confronti momenti di rabbia violenta – rivoltisoprattutto a mio fratello – a confortanti momenti di meditazione losoca sul vuotoassoluto delle nostre vite.Nei lunghi periodi trascorsi sulle varie spiagge alla moda o in altri luoghi di sublime ozio,si era infatti avvicinato al pensiero indiano, diventando un devoto lettore di Krishnamurti.<strong>Su</strong>l suo volto aleggiava quasi sempre una sorta di mezzo sorriso, mentre i suoi occhi non tiguardavano mai davvero. Anzi, non ti vedevano proprio, perennemente immersi com’eranonella lontana visione delle pendici dell’Himalaya.Le continue rimostranze per i soldi non lo toccavano minimamente, come non sembravariguardarlo neppure il fatto che, dato che lui non ci dava una lira, anche lei non spendevauna lira per noi. Fu allora che incominciammo a intuire che avevamo due madri: la signoraA e la signora B. E ognuna sembrava ignorare la presenza dell’altra.Per tutta la nostra infanzia, abbiamo mangiato pochissimo. E anche da adulti, quandonostra madre ci invitava a pranzo, ci premuravamo di prendere qualcosa prima, persopravvivere ai cinquanta grammi di pasta che ci sarebbero stati oerti. I nostri vestitierano sempre consunti, riciclati.<strong>Su</strong>l nostro benessere, insomma, si combatteva l’aspra e testarda battaglia dei loroprincipi. “Per te non spenderò neanche cento lire!” è stato il refrain che ha accompagnato ilcorso di tutta la nostra vita in famiglia.Proprio per questo, fu una vera sorpresa quando un giorno – ero in quarta elementare –tornammo da scuola e trovammo i nostri due genitori, benevoli e sorridenti, ad aspettarcidavanti a una tavola imbandita.“Bambini, vi dobbiamo parlare,” esordì mia madre e a quelle parole iniziarono atremarmi le gambe, perché il “vi dobbiamo parlare” era di solito l’anticamera di qualcosa diterricante. Però, quel giorno, sembravano stranamente tranquilli. A mio padre mancavasoltanto la fiammella sulla testa delle divinità induiste. Attendemmo quindi il seguito con unbarlume di fiducia.“Dobbiamo darvi una bella notizia.” Piccolo sospiro di felicità interiore. “Avrete unfratellino.”Gong!Barcollando, mio fratello e io raggiungemmo il bagno per lavarci le mani in silenzio,continuando a guardarci perplessi. Tornati a tavola, non riuscii a trattenermi dall’aprire labocca e chiesi:“Perché?”Quella domanda rimase per un po’ uttuante sopra la tavola imbandita, poi mia madrefece un respiro profondo, ci guardò con lo sguardo dolce della signora A e disse:“Quando due persone si amano, nascono i bambini.”Gong! Gong! Gong!
Ecco l’irruzione del koan nella mia vita! Tra il battito di una mano sola equell’aermazione, che dierenza c’era? Entrambi, per ottenere una risposta, richiedevanouna brusca uscita dalle rassicuranti leggi della consequenzi<strong>ali</strong>tà.Quando due persone si amano, nascono i bambini.Il bambino stava arrivando.Ma le persone che si amavano, dov’erano?Pur con questo koan che rimbombava dentro – a cui ho dedicato delle pagine nel racconto“Un’infanzia”, in Per voce sola – mio fratello e io fummo tutto sommato contenti di questanovità. Facevamo aprire la bocca a nostra madre e, da lì, gridavamo dei messaggi pernostro fratello. Preparavamo la culla, i completini, il bugigattolo vicino alla cucina chesarebbe diventato la sua stanza.La signora A sembrava aver conquistato più spazi, mandando la B momentaneamente incantina. Credo proprio che mia madre provasse una vera e propria gioia sica nel suoessere in stato interessante. A un certo punto contrasse la rosolia e ricordo la suainquietudine mentre stava a letto. Temeva di perdere il glio o che potesse nascere conqualche grave handicap, così mio fratello e io cercavamo di distrarla. Se ci fosse stata datala possibilità, se i nostri genitori ci avessero visti, se ci avessero lasciati avvicinare,saremmo stati di sicuro dei figli devoti, affettuosi e dolci.<strong>Su</strong> quella gravidanza mia madre ripose grandi speranze di rinnovamento, mi confessò piùtardi. La parte di sé più positiva, quella della ragazza che sognava di re<strong>ali</strong>zzarsi nellamaternità, si illuse che quel glio giunto in extremis avrebbe toccato il cuore di suo maritoriportandolo al posto dal quale, meno di dieci anni prima, era fuggito.Invece, qualche giorno dopo l’annuncio, mio padre ripartì, rapidamente riassorbito daigorghi indolenti della dolce vita romana.L’8 settembre di quell’anno – era il 1966 – nacque così il mio secondo fratello. Il primo eio eravamo a Opicina, nella casa che i miei nonni materni avevano comprato da pochi annie dove avevamo trascorso l’estate. Il travaglio durò appena una ventina di minuti, dalletredici alle tredici e venti, permettendo a mia madre di tornare a piedi nella sua stanza,come se fosse andata a fare una passeggiata per sgranchirsi le gambe.Per festeggiare il suo arrivo, noi due fratelli maggiori facemmo una corsa in bicicletta emio padre, come il genio della lampada di Aladino, si rimateri<strong>ali</strong>zzò. Asciutto, abbronzato,elegante nei suoi completi comprati a Porta Portese, si chinò estatico sulla culla, osservandol’ultimo prodotto della sua inesausta virilità, e, dopo aver emesso un profondo sospiro,sentenziò: “<strong>Ogni</strong> figlio è una benedizione del cielo!”Proprio in quel tempo, infatti, il suo mondo losoco si era aperto a nuovi orizzonti:dalle pendici dell’Himalaya il suo sguardo si era spinto più in là, raggiungendo le valli e levette del Tibet. Si era iscritto all’Istituto per l’Estremo Oriente e, oltre a studiare la linguacinese, aveva iniziato a immergersi nella complessità del pensiero taoista. Il concetto diCielo gli piaceva molto. Il Cielo, che contiene in sé i mille so ancestr<strong>ali</strong>, è nostro padre.Bisogna abbandonarsi al non agire per permettere a lui di agire, elargendo saggezza. Che
isogno c’era, dunque, di un padre terrestre, dato che ce n’era uno celeste? Il padrebiologico poteva fare soltanto una cosa: arrendersi al non agire, per permettere al padregrande, il Cielo, di portare al termine le sue azioni senza alcuna interferenza umana.La foto del battesimo di mio fratello Lorenzo – celebrato da padre Dietrich – è l’unicaimmagine che possiedo di me con entrambi i miei genitori, e mi ritrae seduta con il neonatoin braccio su una grande poltrona di nta pelle marrone, fasciata in un vestito marrone –l’unico vestito elegante della mia infanzia, fatto sicuramente con uno scampolo e da meferocemente odiato – e vegliata aettuosamente da mia madre e mio padre, in piedi allemie spalle, accanto a mio fratello Stefano appollaiato su un bracciolo, in giacchetta ecravatta, con un’aria ancora più scocciata di quella che aveva alla mia nascita.Dopo il battesimo, mio padre re<strong>ali</strong>zzò in pieno il Wu wei, smateri<strong>ali</strong>zzandosi quasi subito.Fu allora che anche la pazienza di mio nonno – che si chiamava Giovanni Battista e alquale le fumoserie orientaleggianti non erano particolarmente gradite – si esaurì. Eranoormai più di dieci anni che, con i risparmi di una vita di lavoro, tamponava i danni e lestupidaggini compiute da suo genero, mantenendo glia e nipoti, diventatiimprovvisamente tre.Era arrivata l’ora di cambiare musica e l’unico modo di farlo, a quei tempi, era quello dipreparare l’ennesima v<strong>ali</strong>gia di soldi e chiamare monsignor Milioni.
19.Ormai ero in quinta elementare. L’arrivo del fratellino portò una ventata di aria frescanella nostra vita. Era un bambino buono e sorridente e io amavo prendermi cura di lui,mentre mio fratello Stefano era felice di poter rinnovare la sua creatività con l’invenzionedi nuovi esperimenti di sopravvivenza. Il suo preferito era quello di mollare la carrozzinaall’inizio di un marciapiede in discesa. Voleva capire, infatti, quanto fosse importante ilfattore di accelerazione nella dinamica dei corpi in movimento. Una volta lasciata, correvain basso per accoglierla prima che deragliasse o si sfracellasse.Mia madre intanto aveva capito che i mille so del Wu wei erano assolutamenteinaerrabili e dunque fece l’unica cosa che poteva fare: si rimboccò le maniche e cercò unlavoro. Aveva una mente molto creativa e in tutti quegli anni trascorsi tra la pittura el’Optical Art aveva acquisito anche una certa abilità nel campo del disegno.Così il suo primo lavoro fu proprio quello di grafica.Ricordo l’anno della quinta come un anno d’inaspettata leggerezza: il neonato cherallegrava la casa, mia madre che nalmente lavorava e l’idea che in fondo l’età adulta –l’età della liberazione – non fosse poi tanto lontana. La scuola elementare era stata infattiper me un pesante giogo che aveva costretto il mio sguardo perennemente verso il basso.Avendo lo stesso spirito del buon soldato Švejk, avrei sempre voluto comportarmi neimigliori dei modi: essere eciente, diligente, capace di conquistare l’ammirazione e ilplauso di chi mi stava sopra, ma poi le cose andavano sempre in senso contrario. Quando lamaestra faceva una domanda, il più delle volte conoscevo la risposta, avrei potuto alzare lamano, saltellando dall’impazienza sulla sedia, e dire: “Lo so, lo so, signora maestra!” Inveceripetevo la risposta dentro di me, scartandola per la sua semplicità.Sarebbe bello che la risposta fosse questa, mi dicevo, ma è evidente che non è così; è solol’apparenza della risposta, un tranello appositamente teso per trarci in inganno, o forse ilpunto di partenza per andare alla ricerca della vera risposta.Così mentre le compagne rispondevano con voce argentina, io vagavo per i meandridella mia mente, alla ricerca di altre possibili risposte innescate da quella domanda.Nel racconto “Un’infanzia” in Per voce sola, il protagonista deve risolvere un problema diaritmetica riguardante la capienza di una vasca da bagno; invece di scoprire, attraversocalcoli ben deniti, il numero di litri necessari per riempirla, il narratore si perde nelle sueelucubrazioni, immaginando che il sotto della stanza da bagno crolli e che l’inquilino delpiano di sopra precipiti nella vasca, facendola improvvisamente traboccare e rendendoobsoleta la soluzione del problema. E così, oltre ad aver espresso in maniera intuitiva ilprincipio di Archimede, il giovane protagonista ha anche aggiunto un ulteriore quesito darisolvere: come rimuovere il corpo inerte del morto.
Con una testa così, ogni giorno di scuola era un Everest da scalare, un deserto delKalahari da attraversare, sfuggendo a feroci formiche rosse. Le rare volte in cui osavolanciarmi, mi accadeva come ai paracadutisti a cui, in volo, non si apre il paracadute.Ricordo che, una volta, avevo da giorni una parola in mente di cui non conoscevo ilsignicato, così quando la maestra ha chiesto: “Avete qualche domanda?” ho alzato subito ilbraccio, scattando in piedi accanto al banco e, scandendo bene le parole, ho detto: “Signoramaestra, che cosa vuol dire castrare?”Per questo la ne delle elementari – con l’abbandono di quel cupo edicio di mattonirossi nel cui atrio erano esposti tutti i tipi di bomba e di mina su cui avremmo potuto saltarein aria – mi sembrava la liberazione da un carcere che, per troppo tempo, mi aveva tenutaprigioniera.La scuola media non era molto distante e aveva un nome che mi faceva sognare: CampiElisi. Completamente all’oscuro di cosa fossero i campi elisi, ero convinta che avesserosbagliato la trascrizione e che si trattasse in realtà di campi di ord<strong>ali</strong>si. Amavo e amomoltissimo i ord<strong>ali</strong>si e così l’idea di frequentare un tale istituto mi dava un sensod’insperata leggerezza.L’edicio che ospitava la nuova scuola, anch’esso di mattoni rossi, era stato costruitodurante il protettorato degli americani e, con le sue nestre incorniciate di bianco, il suotetto con le tegole, i suoi alberi e i suoi cortili interni, sembrava uscito direttamente daquell’oasi di felicità che ritenevo essere gli Stati Uniti d’America.Nella scuola dei campi di ord<strong>ali</strong>si, gli insegnanti non avrebbero potuto essere altro cheeternamente sorridenti e quella loro felicità, pensavo, si sarebbe senza dubbio riversata sunoi alunni. Per raggiungerla, avrei dovuto fare lo stesso percorso della vecchia scuola,imboccando però, pochi metri prima, una strada in discesa che, in lontananza, lasciavaintravedere il mare e le gru dei cantieri. Dopo un paio di curve e l’attraversamento di unazona sterrata e incolta – ora occupata da palazzi – avrei raggiunto l’oasi della mia felicità.A sancire questo cambiamento, ci sarebbe stato anche l’abbandono della fedele cartella afavore della cinghia per i libri, segno evidente di una nuova leggerezza che mi avrebbetraghettato verso l’età adulta.Da mesi insomma, quelle due curve in discesa stavano lì sospese nella mia mente. Erotroppo piccola per sapere che immaginare di fare una cosa non è sempre preludio perriuscire poi a farla per davvero.Ancora non sapevo che, sui nostri desideri e sui nostri sogni, veglia costantemente ildestino, che le sue curve non sono le nostre, e che, tra una svolta e l’altra, il nostro bene èprobabilmente l’ultimo dei suoi pensieri. Fino a quel giorno, infatti, ero stata convinta cheesistesse una certa ritmica consequenzi<strong>ali</strong>tà nello scorrere dell’esistenza – i giorni di scuola equelli di festa, i sabati dalla nonna paterna, le domeniche dagli altri nonni, il Natale e laPasqua, con tutta la famiglia riunita dai bisnonni, i pomeriggi d’inverno a pattinare e quellid’estate al bagno Ausonia o a Grignano, a Sistiana, se non addirittura a Grado, raggiuntomagari con la vecchia motonave Ambria Bella, sembravano costituire un’ossatura stabiledella ritmicità del tempo, capace di contenere e smorzare tutte le follie, le incapacità, le
confusioni dei miei genitori.Ancora non sapevo che, mentre contemplavo beata la pace dei campi elisi contornati daord<strong>ali</strong>si, sentendo già nelle orecchie il fruscio delle vele del brigantino che mi avrebbeportata in Madagascar a studiare gli aye aye e i camaleonti, il destino, come in unautoscontro, aveva bruscamente girato il volante.Tutto cominciò con delle cenette.Cenette a cui io e mio fratello ovviamente non eravamo invitati. Noi mangiavamo prima,già in pigiama e, subito dopo Carosello, andavamo a letto. Solo allora arrivava questapersona, un collega conosciuto sul lavoro, e cenava in cucina con mia madre. Aveva unavoce molto forte, sgradevole, che non esiterei a descrivere come un timbro da osteria.Ricordo la luce accesa no a tardi e quel rumore, inusuale per una casa abitata da trebambini, invadere con violenza le nostre stanze. Al risveglio, poi, il nostro appartamentonon era più lo stesso ma sembrava più l’angolo di angiporto sopravvissuto a una notta dibagordi. Bottiglie e bicchieri sparsi dappertutto, la cucina avvolta da una nebbia puzzolentedi fumo freddo che, dai posaceneri pieni di cicche, si diondeva in tutta la casa.Preparandomi per andare a scuola, non riuscivo a trattenere dei conati di nausea.Una cenetta. Due cenette. Dieci, venti cenette. Più le cenette si moltiplicavano, piùsentivo montare l’inquietudine. E l’inquietudine, per me, era sempre foriera di quesiti. Nonerano domande immediate, spontanee, quelle che avrebbe fatto un bambino normale in unasituazione normale; temevo, infatti, più di ogni altra cosa di dover arontare lo sguardogelido e carico di odio della signora B.Tuttavia non riuscivo a tacere, così l’elaborazione delle mie domande subiva un percorsonon molto diverso dalle acque carsiche: s’inabissavano in forre, scorrevano rumoreggiandosottoterra, si precipitavano a cascata verso un livello ancora più basso e laggiù sidisperdevano in rigagnoli no quasi a estinguersi per poi, senza alcun preavviso, eromperedi colpo in superficie in un modo incontrollato.Così una sera, mentre ero già in pigiama e la signora B stava preparando l’ennesimacenetta, entrai in cucina e dissi: “Spero almeno che il signor X, prima di andarsene, ti paghiil conto.”Era una frase che avevo ponderato con estrema attenzione in ogni sua parte, dato che lamancanza di soldi era da sempre il refrain della nostra vita e noi gli eravamo la causa diquell’irragionevole salasso. Vedendo che mia madre, ogni sera, preparava dei manicaretti –fatto del tutto inusuale, visto che mangiavamo sempre purè di patate con dentro una fettadi prosciutto sminuzzato o una minestra di piselli secchi – e che la nostra casa era semprepiù simile a una bettola, mi era sembrato giusto trarre le logiche conseguenze.Se mia madre aveva intrapreso una nuova attività di ristoratrice era giusto che si facessepagare, altrimenti a che pro tutto quel lavoro, quel rumore, quella puzza di fumo cheavvelenava l’aria?Non avevo neppure nito di dire “conto” che già mi ero accorta del tragicissimo errore.Tutto il lungo percorso di puricazione e decantazione delle acque non era servito a nulla.Come scintille nella sterpaglia assetata d’agosto, le mie parole fecero divampare ciò che più
di ogni altra cosa temevo: lo sguardo inceneritore. La signora B coltivava dei sentimenti perniente benevoli nei nostri confronti e non aveva alcun pudore, quando eravamo soli, nelmanifestarli. In quegli occhi c’era ghiaccio e c’era fuoco e quel ghiaccio e quel fuoco sifondevano insieme in una forza nuova, capace di distruggere qualsiasi cosa.Avevo la bocca ancora a forma di “o” quando la sua mano aerrò il mio braccio comefosse l’artiglio di un’aquila, le unghie conccate quasi nell’osso e, scuotendomi con forza,gridò: “Non ti permetterò mai di interferire con la mia vita! MAI! MAAIII!” e, con uno spintoneviolento, mi buttò fuori dalla cucina.Quel “Mai!” era fatto di sassi acuminati, di acciaio, di cocci di vetro, di rotoli di lospinato. Quel “Mai!” era un ostacolo, un’arma, un cavallo di Frisia, messo per sempre adifesa della sua vita.Intanto monsignor Milioni era sceso in uno dei migliori alberghi della città escartabellava documenti, scriveva appunti, convocava testimoni, concedendosi, a spese dimio nonno, gustose cene di pesce nei vari ristoranti del centro.
20.Con il tempo, ormai adulta, ho capito che mia madre aveva subito due grandi traumi eche proprio intorno a quei due traumi si era inanellata tutta la sua vita.Ci sono tanti modi per reagire a un’esperienza forte: ci si può ribellare o si può sfuggirle,cancellandola, come si può anche, magari col tempo, tornare a elaborarla, sperando chequesto lavoro di an<strong>ali</strong>si ci conduca, un giorno più o meno lontano, a metabolizzarel’accaduto no a riuscire a stemperare quel sordo dolore che ha oppresso i nostri giorni;possiamo arontare le negatività che ci accadono, interrogandole, cercando di capire ladomanda che ci pongono, oppure possiamo vivere nell’ombra di quei ricordi, come archi ditrionfo sospesi sopra di noi, facendogli girare intorno tutta la nostra esistenza.I due archi di trionfo che accompagnarono la vita di mia madre furono il crollo sotto lebombe della villa che l’aveva vista nascere e crescere e la ne, altrettanto brutale, del suomatrimonio. Per tutta la durata della sua esistenza, mia madre continuò infatti a inseguireil sogno di tornare, un giorno, ad abitare in una villa e di avere un matrimonio felice.La villa riuscì a ottenerla, arrivando persino a montare, davanti l’esiguo giardinetto, ilcancello di villa Veneziani, l’unica parte sopravvissuta alle fiamme e al calore delle bombe.Di matrimoni ne ha celebrati tre e, se avesse vissuto un po’ più a lungo, di sicuro neavrebbe contratto un quarto. Ma ho il fondato sospetto che la felicità non abbia maidavvero abitato quelle stanze.Così, mentre monsignor Milioni passeggiava pensieroso sulle Rive e le cenettecontinuavano a impazzare a casa nostra, superai l’esame di quinta elementare e, con unasensazione di leggerezza per me insolita, mi apprestai ad arontare l’estate che miseparava dai Campi Elisi.D’abitudine, le nostri estati si dividevano tra un breve soggiorno ai primi di luglio in unapensioncina di Grado, i giochi in cortile con gli altri bambini a Trieste e il mese di agostopassato a Opicina dai nonni, assieme ai miei amati cugini.Quel mese era per noi un mese di gloria, primo perché eravamo in cinque e potevamostare all’aperto dalla mattina alla sera, poi perché lì dai nonni, come ricorda spesso miofratello ancora oggi, finalmente si mangiava.Ma quell’estate, l’estate del ’67, improvvisamente la routine venne stravolta. Alla nedella scuola, venni mandata insieme ad Anna, la signorina che intanto era stata assunta peroccuparsi di mio fratello Lorenzo, da una sua vecchia zia in un’isola dell’attuale Croazia.Lì per la prima – e ultima – volta, raccolsi sugli scogli una stella marina: era rossa e con ipiedi tubolari; tutte quelle che avevo visto no ad allora, nei fondi sabbiosi di Grado, eranopiatte e biancastre, così davanti a quell’inaspettato splendore non resistetti. Volevo portarlaa Trieste e farla vedere a mio fratello, dunque appena tornata dalla spiaggia presi un
catino, lo riempii d’acqua sciogliendovi dentro un pugno di sale da cucina e, condelicatezza, vi immersi quel magnifico animale.Quale delusione e che dolore, la mattina dopo, nel vederlo galleggiare, ormai biancastroe inerme, in mezzo alla bacinella! L’acqua intanto era diventata rossa e quel colore permolti giorni, per molti mesi, pesò sul mio cuore come la firma di un assassinio.<strong>Ogni</strong> mattina, andavamo al mare, un mare di roccia, freddo, bello, circondato da unbosco di pini dal quale proveniva lo spaventoso e continuo frinire delle cicale. Nelpomeriggio riposavamo nella penombra della casa, con gli scuri accostati.A volte Anna mi accompagnava fino al porto a prendere un gelato. Sladoled. Era quella laparola magica per farlo esistere. Come mi piaceva quel termine! Era innitamente più belloe pregnante del nostro stupido “gelato”. Slad, slad: non era forse quello il rumore che facevala lingua, nel leccarlo?Non furono per me giorni infelici, quelli in Croazia, piuttosto sospesi. L’ordine deglieventi che, no ad allora, avevo conosciuto e che mi aveva permesso di sopravvivere,aveva subito una brusca deviazione; intuivo che mi stavo aacciando su qualcos’altro ma, aparte la sensazione di leggero squilibrio, come camminassi in punta dei piedi, non ero ingrado di vedere niente.Soltanto al mio ritorno a Trieste, quella situazione di incertezza si tramutò in ansiaprofonda. Sostituito il costume da bagno con una giacca a vento, dopo qualche giorno eronuovamente con la v<strong>ali</strong>gia in mano.Destinazione: un Kinderheim in Austria.Viaggio interminabile sui sedili posteriori della 850, con mia madre e l’avventore dellecenette; nausea per le curve, nausea per il caldo, nausea per l’abbandono che sentivoimminente.Il Kinderheim consisteva in una specie di fattoria in montagna, già piena di altri bambini.Per mia fortuna, c’era qualcuno che già conoscevo e con cui avrei diviso la stanza: la gliadella migliore amica di mia madre. Aveva un anno più di me ed era già in balìa di interessisentiment<strong>ali</strong>, a me ancora del tutto estranei. Mentre lei passava il suo tempo a leggereLiala, io lo trascorrevo a piangere.La direttrice, oltre a indossare prevalentemente maglie sintetiche, era anche poco amicadell’acqua, così l’unico istante in cui riuscivo a trattenere le lacrime era quando la vedevoavvicinarsi per un abbraccio consolatorio.Non legavo con nessuno, come non provavo alcun entusiasmo nel parlare in tedesco.L’unico sollievo fu quello di imparare, con l’aiuto di un bambino, a catturare i porcospini.Ne avevo preso uno e lo avevo portato nella nostra camera. Lo nutrivamo con gli avanzi dicibo della tavola: frittate, mele, ciotoline di latte. Essendo un animale notturno, camminavatutta la notte per la stanza mentre di giorno dormiva in una scatola di cartone.Era l’unica cosa che emanava calore intorno a me. Avrei voluto abbracciarlo, mapurtroppo aveva le spine! Così, quando me lo concedeva, gli grattavo l’unica partemorbida, la pancia.
Il tempo libero lo trascorrevo nella sala comune, costruendo castelli di carte e scrivendolettere a mia madre. Le ho ritrovate tutte in un cassetto, legate con un occhetto, dopo lasua morte. Le righe vergate dalla mia mano infantile esprimevano una sempre maggioredisperazione. Dopo le prime missive interlocutorie, infatti – Come stai, cosa fai, cosa fannoi miei fratelli? – si aacciavano le prime crepe: So che non mi hai chiamato né scrittonora, soltanto perché vuoi che la mia gioia sia più grande, quando questo avverrà. Seguitipoi da piccoli tentativi di corruzione: Oggi ho comprato un bellissimo regalo per te, non tidico che cos’è perché voglio farti una sorpresa, così come me la vuoi fare tu, aspettando dichiamarmi, ma se mi chiami, qualcosina posso dirti… È bello che tu faccia nta di essertidimenticata di me… Ho raccolto dei orellini per te, ma ho paura che appassiscano primache tu possa vederli… Scrivevo e le mie lacrime cadevano abbondanti sul foglio, sbiadendoin più punti l’inchiostro.Lassù, infatti, tra quelle montagne piovose, con quella puzza di cipolla e di sudore, inquella solitudine consolata solo dagli aculei del porcospino, era successo qualcosa diincredibile: l’iceberg aveva cominciato a sciogliersi. Non era stato però l’abbraccio del sole <strong>ali</strong>quefarlo, ma un incendio divampato al mio interno. Un incendio senza amme, freddo,spietato come un’implosione atomica. Più che liberazione, in quelle lacrime c’era il progettodi una nuova e più invincibile prigione. Oltre a sciogliersi, il ghiaccio aveva un altro difetto,lasciava passare la luce. E la luce era vita, speranza, illusione testarda che, in qualchepunto, in qualche momento, potesse ancora penetrare una qualche forma di calore.Un giorno, per fortuna, arrivò una cartolina della signorina Anna: dietro alla fotograadi un cucciolo di cocker e di un gattino, c’era scritta qualche parola aettuosa. Quellacartolina fu la zattera che mi permise di arrivare viva alla ne del soggiorno. Dormivo conlei sotto il cuscino, non me ne separavo mai, neppure di giorno.Al momento di partire la bambina-iceberg era scomparsa e il suo posto era stato preso,temporaneamente, dalla bambina-scendiletto. Stavo lì immobile, sottile, discreta, nonrespiravo quasi – una sorta di sogliola sdraiata sul pavimento, in attesa soltanto di esserecalpestata.Tornai a Trieste, ma non a casa mia, bensì in quella dei nonni.“La nostra casa non c’è più,” disse mia madre. “Fra dieci giorni andiamo a vivere inun’altra città e questo – il frequentatore di bettole – è il nuovo compagno della mia vita.”Monsignor Milioni, intanto, aveva nito il suo lavoro. “Un uomo intelligente, arguto,”ricordava sempre mia madre, rievocando i loro incontri, “un uomo con cui era piacevolechiacchierare.” Interrogati i protagonisti e i testimoni, valutate le risposte, consultatipoderosi tomi e incassata la v<strong>ali</strong>getta con il milione – come il signor Bonaventura di cui,probabilmente era parente – aveva alla ne dichiarato nullo il matrimonio dei mieigenitori.A settembre ci trasferimmo così in una nuova città.Appena entrai nella nuova casa in atto – una villa! – estremamente lugubre, sentiiun’ondata di gelo s<strong>ali</strong>rmi lungo la spina dorsale. Avendo ereditato da mia madre la capacità
di guardare avanti, cercai comunque di vedere il lato positivo della nuova situazione. Primadi tutto, dato che nella nuova casa c’era un giardino, mi fu concesso nalmente di prendereun cane al canile e, in secondo luogo, mia madre si era innamorata, c’era il fratello piccoloe agli occhi di tutti i vicini avremmo potuto sembrare una famiglia felice.Una famiglia!Quanto è radicato nei bambini il desiderio di questa realtà. Anch’io avrei potuto ngereche quel signore fosse mio padre, anch’io avrei potuto aspirare a una quieta norm<strong>ali</strong>tà. Ilsignore, infatti, era diventato improvvisamente gentile con me, molto gentile, e io mi erofatta ingannare da quella gentilezza, come gli uccelli si fanno fuorviare dallo zimbello.Avevo dieci anni e una voragine affettiva da colmare, che cos’altro avrei potuto fare?Così per qualche mese, in quella nuova situazione, fui davvero felice. C’era un’unicaombra, un pensiero fisso che mi tormentava come un tafano.Dov’era finito mio padre?E se un giorno fosse tornato e avesse scoperto che il suo posto era stato preso da un altro?E anche se non si fosse arrabbiato, dove avrebbe dormito? In giardino, nella sua spider?O dove?All’epoca non c’era ancora sentore di famiglie allargate, dunque non riuscivo aimmaginare qu<strong>ali</strong> orizzonti si aprissero davanti a noi. Così quella domanda inopportunacominciò il suo lungo e avventuroso viaggio carsico. S<strong>ali</strong>va, scendeva, si inabissava, s<strong>ali</strong>vanuovamente; sembrava scomparsa, ma tornava con nuovo vigore; la ricacciavo indietro ericompariva da un’altra parte.Un pomeriggio, alla ne mi decisi: era giunto il momento! Avevo accompagnato miamadre a fare una commissione e, sulla via del ritorno, raccolsi tutto il mio coraggio. <strong>Ogni</strong>dieci passi, mi dicevo: adesso, adesso! ma la voce non mi usciva. Soltanto quando vidi lacasa in lontananza, feci un grande respiro da bambina-scendiletto e dissi:“Mi chiedevo una cosa…”“Che cosa?”“Mi domandavo se, tra tutte le cose moderne che hanno inventato, tipo i razzi, hannoinventato anche un… un… un letto a tre piazze.”Mia madre si bloccò in mezzo alla strada, guardandomi esterrefatta.“Ma cosa dici?” mi chiese, gelida.Con le ultime forze terminai il mio pensiero. “Ecco, insomma… mi chiedevo… quandoarriverà il papà… dove andrà a dormire?”“Il papà non verrà mai più,” rispose concisa, riprendendo a camminare.“Perché?”“Perché l’ha deciso la Sacra Rota,” mi rispose la sua schiena.“Cosa ha deciso?”“Che non è mai esistito.”Fine della trasmissione.
Nei giorni seguenti, riuscii a raccogliere altri frammenti da mio fratello. La Sacra Rotaviveva a Roma, nei palazzi che c’erano in piazza San Pietro e, tra i suoi poteri, avevaproprio quello di spezzare per sempre i rapporti tra le persone.Per mesi la Sacra Rota popolò i miei momenti di dormiveglia; vedevo le porte bronzee diSan Pietro aprirsi di colpo e apparire all’improvviso quel mostro roteante; era una sorta dipneumatico di dimensioni spaventose, al posto dei solchi del battistrada, aveva dellelamette da barba e, dall’inserto del perno, uscivano grandi sbu di incenso. Non per nienteera sacra.Dopo un attimo d’indecisione, quella gigantesca ruota dentata si lanciava giù dallegradinate della basilica pronta a investire tutte le persone che sostavano nella piazza; pertentare di salvarsi dalle sue lame c’era allora un fuggi fuggi generale; tra grida didisperazione, tutti cercavano riparo dietro a una colonna o a una fontana; il destino, percoloro che non ci riuscivano, era inesorabile: venivano schiacciati e tagliati a pezzi dallelame, i padri venivano separati dai gli, le mogli dai mariti, probabilmente, tra le vittime,c’erano anche dei nonni o dei cugini, travolti dalla furia di quella belva sanguinaria.Evidentemente mio padre, quel giorno, doveva avere avuto la stupida idea di andare apasseggiare in piazza San Pietro…Dopo la morte reale di mio padre, quando ero ormai adulta, volli risolvere il mistero dellaSacra Rota. Com’era possibile, infatti, mi domandavo, annullare un matrimonio dal qualeerano nati ben tre figli?Andai così a trovare quello che sapevo essere uno dei testimoni della causa diannullamento. Era uno degli amici d’infanzia di mio padre e dunque lo conosceva moltobene.“Prima di andare da monsignor Milioni,” mi disse, “mi ero preparato a dire ciò chepensavo che volesse sentire da me, che peraltro era la verità. Gli avrei detto che era uomoinadabile da tutti i punti di vista, dedito al bere, estremamente promiscuo, insomma unvero disgraziato, ma, appena aprii bocca, monsignor Milioni mi fece cenno di tacere. ‘Nonvoglio sapere niente. Mi dica una sola cosa sola: è massone?’”“‘Sì, lo è,’ risposi.”La Sacra Rota emise così il suo verdetto.
21.Quei primi mesi nella nuova città, con la mia nuova famiglia e l’ingresso nella scuolamedia, rimangono nella mia memoria come un fascio di luce in mezzo alla foresta. Misentivo felice, di una felicità mai provata prima, tutto quello che avevo desiderato nei diecianni precedenti si era re<strong>ali</strong>zzato.Avevo un padre, un giardino, un cane, una madre felice, innamorata del compagno;persino a scuola, nonostante non fossero i Campi Elisi, avevo trovato un’insegnante dilettere di cui non avevo timore e che, quando parlava, diceva cose che mi facevanoriflettere.Forse per la mia situazione familiare irregolare – quella volta queste cose contavano – eronita nell’ultima sezione della scuola, la H o giù di lì. Nella mia classe, tutta femminile,c’erano diverse ripetenti, glie di giostrai e altre bambine provenienti dal <strong>Su</strong>d. Mi sentivomolto a mio agio, riuscivo persino a brillare. Avevo una compagna di banco discreta esilenziosa che, in quegli anni, divenne la mia migliore amica.Conservo una polaroid in bianco e nero di quegli anni, penso scattata proprio da lei, chemi ritrae seduta sul letto, abbracciata al mio adorato cane Red, un botolo dal pelo fulvo conil corpo di un setter e le gambe di un bassotto.In quella foto si capisce che sono felice.In un’altra polaroid, è la mia amica Marina a essere seduta sullo stesso letto, dunque èevidente che, in assenza della modernità dell’autoscatto, ci eravamo immortalate a vicendaper ricordare quel pomeriggio.In questi ultimi anni, nel sentire comune, si è consolidata l’idea che la famiglia non siapoi così importante, per i bambini. Padri, madri, compagni, compagne, fratellastri,sorellastre, nonni e nonnastri possono fare da sfondo allegro e innocuo alla loro crescita. Inrealtà penso che questa sia una grande menzogna avvallata per tacitare le coscienze.È vero che i bambini si adattano a tutto e che trovano modo di sopravvivere in qualsiasisituazione ma, in fondo al proprio animo, desiderano una sola cosa: avere una mamma e unpapà, preferibilmente che si vogliano bene; e, preferibilmente, anche dei fratelli. La vitadesidera la vita e, per mantenere il suo passo nel cammino dell’essere umano, almeno comel’abbiamo conosciuto fino a ora, desidera riconoscersi nel fluire regolare delle generazioni.Così, in quei mesi di tregua insperata, la bambina-scendiletto cominciò a prendere corpo;respirava, si muoveva, rideva persino; la sera, quando si addormentava abbracciata alcuscino, sognava nalmente il futuro. Un futuro senza abissi e senza scheletri, senzaprigioni della lingua e della mente, senza solitudini e terrori.Mia madre e il suo nuovo compagno, entrambi graci, avevano aperto un’attività
indipendente e il lavoro sembrava assorbire tutte le loro energie, tornavano quindi spessola sera tardi, allora io lasciavo sul loro letto dei orellini o dei bigliettini con sopradisegnato un cuore. Vi voglio bene! Vi voglio bene!Ero felice, felice davvero.Spesso la domenica, come tutte le vere famiglie, andavamo a fare delle scampagnate conla 850 rossa e così il giorno dopo, a scuola, potevo nalmente scrivere: “Ieri ho fatto unabella gita con i miei genitori…” Quando mia madre spingeva il passeggino per le strade conil suo compagno la gente li guardava ammirata. Che bella coppia, dicevano, e che bel gliohanno! Il piccolo venne da subito considerato come il frutto del loro amore e anch’io cercaidi adattarmi. C’era il problema del cognome, certo, ma ero sicura che avrebbero trovatouna soluzione anche per quello. Dato che mio padre non era mai esistito, non sarebbe statopoi così difficile sfilarsi di dosso un giorno il suo cognome, così come ci si sfila un vestito.Questa improvvisa ventata di ottimismo mi portò persino ad abbandonare l’idea delbrigantino che mi avrebbe condotto in Madagascar. Tornata padrona cosciente delladimensione emotiva della mia vita, riaccolsi la compassione come sentimento dominante.Non più le scienze natur<strong>ali</strong>, ma la medicina sarebbe stata il nuovo orizzonte della mia vita.Guarire e alleviare il dolore: non mi sembrava potesse esserci un lavoro migliore di quello.Volevo diventare pediatra, sposarmi e avere un’innità di bambini. Sognavo una casaluminosa piena di voci allegre. Da quel momento in poi la luce e l’amore avrebbero guidatola mia vita, ne ero certa.Ho un amico entomologo che spesso si trova a fare perizie per chi compra una casa incampagna. Il venditore può magnicarne le doti nché vuole, ma è nelle travi che sinascondono le insidie più pericolose. Per questo c’è bisogno di un esperto. I tarli sonoanim<strong>ali</strong> misteriosi, sostiene il mio amico. Lavorano in solitudine, al buio, per anni; nel buiosi accoppiano, nel buio si riproducono; tu entri in una casa, ti guardi intorno e ogni cosasembra perfetta, poi, un semplice colpo di vento fa sbattere con violenza una porta e,intorno a te, all’improvviso non rimane che un cumulo di macerie e segatura. I tarlilavorano con meticolosa pazienza, dove c’è materia fanno il vuoto; per salvarsi si può fareuna cosa sola: accorgersi in tempo della loro presenza.Me ne ero accorta? Non me ne ero accorta?E mia madre, se ne era accorta e aveva fatto finta di niente?Forse era andata avanti lo stesso, perché era proprio quello ad attirarla?Quanta verità c’è nei detti popolari! È la prima impressione quella che conta, e la miaimpressione, la prima volta che lo vidi, fu estremamente negativa, ma poi volli credere allafavola; mia madre ci credeva e noi, naturalmente adati, l’abbiamo seguita. Era così bellaquell’illusione, così riposante; le tenebre si erano nalmente dissolte e, scomparendo,sembravano aver trascinato con sé anche la signora B.A un certo punto però, nel silenzio della casa, grazie alle mie grandi orecchie, iniziai asentire un rumore leggero e continuo: tk, tk tk. Che animale è? mi chiesi. È il tarlo? O èl’orologio della morte?
Alcuni segn<strong>ali</strong>, a dire il vero, nei primi mesi c’erano stati, ma li avevo lasciati insottofondo, come quando regalò la onda a mio fratello, istigandolo a rompere vetri equalsiasi cosa gli venisse a tiro, o la piccola c<strong>ali</strong>bro 22, che gli mise in mano con lo stessone. Non eri un uomo se non sapevi usarle, non eri un uomo se non eri in grado didistruggere.Mio fratello non aveva certo bisogno di essere stimolato in quel senso, ma pensavofossero cose da uomini, cose che non mi riguardavano: scricchiolii, un po’ di segatura checadeva da una trave, inezie.Ricordo, poi, altro episodio, di ritorno da una gita in montagna: la strada correva aanco di uno spaventoso burrone, lui era già abbastanza alticcio, ma percepiva la miapaura; si fermò in un bar e tracannò una grappa dopo l’altra, nonostante io lo supplicassidi non farlo. Poi si rimise alla guida, totalmente alterato, spingendo al massimosull’acceleratore, sbandando, tagliando dritto le curve e scansando all’ultimo secondo lemacchine che ci venivano incontro. Arrivammo miracolosamente vivi a casa ma, per giorni,restai preda di un sottile terrore. Ci misi un po’, quella volta, a risintonizzarmi sullalunghezza d’onda della fiaba.Il grande freno alla sua follia credo sia stata la presenza di mio nonno, che, seppureanziano, continuava a esprimere una certa autorevolezza; una domenica al mese venivano inonni a pranzo da Trieste e questo, in qualche modo, serviva da controllo. Poi, purtroppo,improvvisamente, mio nonno morì e, con la sua morte, tutto deagrò. La aba svaporò inun istante, il sipario si levò e si scoprì l’orrore. L’uomo di cui sognavo di prendere ilcognome era in realtà un sadico perverso paranoide. Vedeva nemici ovunque, odiava ilmondo intero e, nel mondo, le persone a lui più vicine, cioè noi.Mio fratello maggiore e io, infatti, avevamo una grande incancellabile colpa – eravamogli di nostro padre, l’uomo delle infradito e dei bermuda con le frange che passava il suotempo a rosolarsi sulle spiagge del Marocco. Eravamo figli di un pervertito, di un pederasta,di un bastardo, come amava ripeterci.I timbri di monsignor Milioni per lui non avevano alcun valore, nessun annullamentopoteva cancellare la realtà: nostro padre viveva, nei nostri volti, nelle nostre parole, neinostri respiri. E nei nostri volti, nei nostri gesti, nei nostri respiri andava scontto ognigiorno.Davanti a questi scoppi d’ira violenta, mia madre rimaneva impassibile e assente, non cidifendeva, non diceva niente.In quei giorni scoprii che la signora A e la signora B non esistevano più; una nuovapersona era entrata nella nostra vita: la signora C. La signora C ci osservava con la stessacompassata attenzione con cui un entomologo osserva i suoi insetti annaspare nellaprovetta di vetro. Insetti, o forse relitti lasciati sulla spiaggia dall’ultima mareggiata. Ciaveva dovuto trascinare con sé dalla sua vita precedente, ma era chiaro che avrebbepreferito non farlo.La signora C, ho imparato poi in quegli anni, conteneva dentro di sé anche la signora D,la signora E e molte altre. Non eravamo gli di una donna, ma di una bambola russa; ne
aprivi una e dentro ce n’era sempre un’altra, uguale alla prima. La B, la C, la D e la Eprobabilmente avevano assassinato la mite e innocente A, che ora se ne stava in paradiso asferruzzare copertine.Quest’impassibilità non era rivolta soltanto a noi ma anche ai suoi stessi genitori. Neigiorni che precedevano la visita dei nonni, a casa si scatenava un sabba di urla, di calci, diporte sbattute, di oggetti scagliati, il tutto accompagnato da epiteti osceni, tra i qu<strong>ali</strong> unpaio mi lasciavano particolarmente perplessa:“Non voglio la saponetta in casa!” gridava come un ossesso. “Non voglio il paralume atavola!”Ci ho messo un po’ a capire che relazione avessero quei due innocenti oggetti con mianonna. “Saponetta” e “paralume” non mi sembravano, infatti, degli insulti particolarmentecruenti, no a che non re<strong>ali</strong>zzai che, essendo lui un feroce antisemita, odiava il sangueebraico che scorreva nelle vene materne della mia famiglia e “saponetta” e “paralume”erano gli oggetti in cui si rammaricava non fosse stata trasformata mia nonna e in cui,probabilmente, sperava ci saremmo un giorno trasformati anche noi.Vedere che mia madre non reagiva agli insulti rivolti alla sua stessa madre mi lasciavaattonita. Se fossi stata al suo posto, gli avrei gridato: “Non ti permetto di parlare a questomodo!” e poi l’avrei buttato a calci fuori dalla porta.Invece lei continuava a sorridere silenziosa, annuendo vagamente.Avevo undici anni, allora, e la manu<strong>ali</strong>stica psichiatrica era piuttosto lontana dai mieiorizzonti; non sapevo quindi che i sadici violenti e paranoici possiedono un’abilità moltosimile a quella dei ragni: una volta individuata la preda, lentamente e senza farsi scorgere,cominciano a secernere il loro lo di seta; le loro armi segrete sono la gentilezza e ladedizione, così, in breve, la persona prescelta si rende conto di non poter più vivere senzaquelle aettuose attenzioni; nel frattempo il lo gira e si avvolge e la preda, ormaiprigioniera, si dibatte inutilmente: in natura non esiste infatti materiale più elastico eresistente di quello delle ragnatele.Dalle cenette in poi, tutto era stato concepito unicamente per re<strong>ali</strong>zzare questo diabolicopiano, del quale il cambiamento di città costituì la mossa conclusiva.Scacco matto.Finalmente avvolta nella tela, separata dai parenti, allontanata dagli amici, da tutto ciòche aveva conosciuto e che, in qualche modo, avrebbe potuto costituire una via di salvezza,il ragno poté quindi iniziare, senza fretta, la seconda parte del suo lavoro: divorare constudiata lentezza la sua preda.Un giorno, mentre eravamo sole, chiesi a mia madre: “Perché questo signore ci tratta cosìmale?”“Perché è un genio,” mi rispose, “e per noi è un grande onore vivergli accanto.”Sentendo quel termine mi venne in mente Mozart, l’unico genio conosciuto dalla miacultura infantile. Così, con il pragmatismo che mi contraddistingue, le chiesi:“<strong>Su</strong>ona forse qualche strumento?”
“No,” mi rispose. “Ma se volesse, potrebbe suonarli tutti.”Allora capii che eravamo perduti.
22.La casa in cui vivevamo suscitava l’ammirazione di molte persone; costruita da unafamiglia facoltosa negli anni sessanta, rispettava tutti i canoni dell’architetturad’avanguardia di allora, vale a dire un gelido assemblaggio di vetro, muratura, angoli acutie linee squadrate. Per me non era altro che un’enorme scatola di cemento in cui eraimpossibile trovare un luogo dove sentirmi rilassata, raccolta e provare l’umanissima emolto animale sensazione di essere nella mia tana.Era una villa immaginata per ricevere molti ospiti, aveva dunque un grande salone epersino un guardaroba e un bagno in marmo rosso, destinati agli eventu<strong>ali</strong> frequentatoridei ricevimenti e delle cene. Cene che, ovviamente, non si tennero mai, perché a nessunestraneo venne mai concesso il diritto di entrare nella nostra vita quotidiana.La maggior parte del tempo lo passavo in giardino, con Red. Non era un grande spazioma aveva dei luoghi sucientemente ombrosi per potermi nascondere dal mondo. Tanto miè sempre stato dicile parlare con gli esseri umani, altrettanto, come se possedessi unnaturale anello di re Salomone, mi è stato facile comunicare con gli anim<strong>ali</strong>.Fino ad allora, avevo posseduto soltanto dei pesci rossi e alcuni criceti: unici anim<strong>ali</strong>concessi a un bambino di città. A dire il vero, per un breve periodo a Trieste avevamo avutoanche un gatto, Shapur, amatissimo da me e mio fratello, ma mio padre, che aveva un odioassoluto per gli anim<strong>ali</strong> – i qu<strong>ali</strong>, come i bambini piccoli, appartenevano a quell’ordine dicose ingestibili delle qu<strong>ali</strong> bisognava prendersi cura e che, alla ne, si rivelavano soltantouna perdita di tempo –, quando se lo trovò tra i piedi, in uno dei suoi ritorni trimestr<strong>ali</strong>,tuonò: “O me o il gatto!” E così l’adorato Shapur venne portato dal veterinario e, con unapunturina, fu spedito a fare le fusa nelle verdi praterie di Manitù.Ci fu, in realtà, anche un cane che attraversò fugacemente la nostra vita cittadina: unafemmina di maremmano; quando arrivò a casa nostra – omaggio di un ammiratore di miamadre – Manon aveva appena quaranta giorni. Ricordo ancora il balzo di felicità che ebbeil mio cuore non appena la vidi: una palla di pelliccia bianca con la pancia vibrante. Miofratello e io eravamo pazzi di lei, come lei era pazza di noi. Peccato che, oltre a noibambini, non amasse nessun altro e che questo, una volta diventata adulta, si fossetrasformata in un serio problema di gestione. Così anche Manon, un bel giorno, scomparvedal nostro orizzonte.Oltre al cane Red, in quel periodo possedevo anche una piccola voliera che ospitava deicanarini, dei passeracei e una cocorita che avevo addomesticato. Ho letto da qualche parteche Mike Tyson è stato un appassionato allevatore di volatili; pare, infatti, che la cura deipennuti sia un grande antidoto per chi si sente abitato da un’incontrollabile violenza.Possiedo tutt’ora una grande voliera e quando mi prendo cura dei miei amici canori vivomomenti di vero relax.
Ripensando a quegli anni, vedo con chiarezza il grande mutamento che avvenne dentrodi me – a un tratto, la mia innocenza si sbriciolò. Ci fu una nota più alta delle altre e quellanota la mandò in mille pezzi, come il vetro. Non avevo più l’iceberg a proteggermi. Nonavevo corazze, né scudi. Non ero neanche più la bambina-scendiletto. La mia natura era –ed è tuttora – quella di un’anima candida, lontana dalle m<strong>ali</strong>zie quotidiane del mondo. Nonsapevo immaginare cattiverie, meno che meno mi veniva in mente di farle. Fino ad allora,era stata la compassione il sentimento trainante delle mie giornate. Per compassionepiangevo, per compassione mi interrogavo senza pace sulla genesi e sulle ragioni delmondo.Non ignoravo l’esistenza della Fossa delle Marianne, il gorgo nero che rumoreggiacostantemente nei giorni ma, no a quel momento, l’avevo soltanto contemplato da sopra,affacciandomi appena sulla sua superfice.In quei giorni, in quei mesi, in quegli anni, come i canarini che assorbono il grisù nelleminiere e poi muoiono, il mio corpo aveva iniziato ad assorbire la terribile energia delmale.Un male feroce, lucido, potentissimo.Tutto ormai era nudo davanti al mio sguardo, la mia persona e la purissima gelida forzadi distruzione stavano uno di fronte all’altro, immersi nella contemplazione.Ero sola, com’ero stata sola molti anni prima, in un campo di grano, durante una partitadi nascondino. Me ne stavo acquattata tra le spighe, quando, a un tratto, ai miei piedi vidiun serpente nero acciambellato su se stesso. Invece di fuggire o urlare, rimasi immobile assarlo. Anche lui mi ssò. Restammo a lungo fermi, lo sguardo di uno calamitato in quellodell’altra. Il gioco intanto era nito, sentivo le voci dei miei amici chiamarmi, sempre piùallarmate. Il sole aveva iniziato a tramontare e con la sua luce tingeva di arancione lepannocchie intorno a me. Solo allora il serpente si srotolò e pigramente, con il suo corposinuoso, scomparve in mezzo ai lari del campo. Solo allora uscii anch’io andando incontroai bambini che mi cercavano sentendomi lontana da loro, stordita.La nostra, però, fu una lotta impari. Io avevo undici, dodici anni ed ero sola, nessunopoteva aiutarmi. Mio fratello maggiore, ormai approdato alle scuole superiori, si eradileguato, non lo vedevo quasi più. Eravamo negli anni caldi del 1968 e dintorni, el’opzione di dividere il suo tempo tra le danzate e le barricate era certo migliore di quellarestare a casa a farsi insultare e prendere a calci.Mi prendevo cura di mio fratello minore il quale, per tutto il tempo che non serviva allarappresentazione della famiglia felice, viveva abbandonato in una stanza, davanti a untelevisore sempre acceso, con il naso sporco, sempre pronto a scodinzolare e a sorridere achiunque gli regalasse un po’ di attenzione.Un giorno d’inverno si ammalò e, nell’incuria, la malattia progredì: lo salvarono inextremis da una polmonite devastante. Rimase in ospedale per più di un mese; piangeva,non voleva farsi fare le iniezioni, aveva paura delle suore. Quando tornò a casa, ero sicurache anche lui si fosse ormai trasformato in un bambino-scendiletto.
Nel frattempo, io cercavo di sopravvivere come potevo. Trascorrevo molto tempo fuoricasa; non essendo ancora interessata agli spasimanti ed essendo, cronologicamente ementalmente, lontana dalle barricate, passavo i pomeriggi camminando con il cane oandando in bicicletta verso le periferie più sperdute; attraversavo campi brulli e sterrati,seguivo per chilometri le traversine della ferrovia. Appena potevo, andavo a dormire daqualche compagna di scuola. A nessuno interessava dove fossi o cosa facessi. Ho passato lafanciullezza e l’adolescenza in uno stato di totale abbandono.Per un po’ mi aggrappai allo sport, muovermi mi ha sempre reso felice; facevo atleticaleggera e andavo quasi tutti i giorni al campo di tartan rosso a correre, a saltare, a lanciareil giavellotto, insomma a sopravvivere. Dato che mi allenavo sempre con delle scarpe ditela blu, per un mio compleanno chiesi delle scarpe da atletica un po’ più robuste. Le scarpearrivarono, ma di quattro numeri più grandi. Non ebbi il coraggio di dirlo, non avrei retto,infatti, alla loro solita reazione: “Non ti va mai bene niente!” Le riempii allora di ovatta epartecipai alle gare ciabattando come Pippo. Quando nalmente vinsi una medaglia d’oro etornai a casa trionfante, l’unica reazione di mia madre fu: “Figuriamoci se l’hai vinta.”Per riuscire a stare in piedi, lottavo contro tutti e tutto, ma era una lotta sempre piùimpari, sempre più votata alla scontta. Giorno dopo giorno, parti di me si sgretolavanocome resti archeologici sotto la sferza delle intemperie, sentivo il loro tonfo, vedevo icalcinacci accumularsi sotto i miei piedi e non riuscivo a fare niente per fermarequell’inesorabile distruzione.Intanto la scuola andava di male in peggio, trascorrevo ore e ore sui libri ma non capivonulla. Passata ormai alle superiori, mi ero imbattuta in professori inessibili, ottusamentepersecutori, incapaci di immaginare anche solo per un istante che quella mia lentezza fossequalcosa di diverso da una mancanza di intelligenza.Nessuno seppe aprire un varco, nessuno mi tese una mano, nessuno si sognò mai diorirmi anche una sola vaga ragione di speranza. Così, in breve, anch’io mi convinsi dellascarsità della mia intelligenza e il mio futuro iniziò a restringersi vertiginosamente: nientemedicina, niente università, niente di niente.Per darmi delle mete, pensai che avrei potuto diventare una maestra di asilo o lavorarecome giardiniere; a mio fratello i professori avevano consigliato di fare il commesso, ma ionon mi sentivo portata per il contatto con il pubblico.Giorno dopo giorno, percepivo la follia s<strong>ali</strong>re dentro di me mentre sentivo calare semprepiù le forze in grado di contrastarla.Poi, a un tratto, con vaga regolarità, mio padre riprese a comparire. Dormiva in albergoe, prima di ripartire, ci portava fuori a pranzo. Dal Tibet, il suo sguardo si era spostato, nelfrattempo, sulle steppe dell’Asia centrale: Gengis Khan e il suo regno foc<strong>ali</strong>zzavano ormaitutta la sua attenzione e, dal primo al dessert, ci intratteneva unicamente sulla vita e leattività dei mongoli. <strong>Ogni</strong> tanto pronunciava delle parole in cinese, tracciando con la manodegli ideogrammi nell’aria.Mio fratello ne approttava per mangiare a quattro palmenti, mentre io speravo che,almeno per un istante, mio padre si accorgesse del mio sguardo.
Più che al mio sguardo, era interessato al mio corpo.Un giorno, vedendomi indossare dei pantaloni corti, mormorò commosso: “Con quellegambe, farai impazzire tutti gli uomini…” Non ero molto edotta sugli argomenti che unpadre avrebbe dovuto arontare con la propria glia, ma quell’osservazione, che nelle sueintenzioni doveva essere un gioioso complimento, mi ferì profondamente.Comunque era sempre mio padre e così, un giorno, esasperata dall’infelicità, decisi diprendere carta e penna e scrivergli. In quella lunga lettera, gli raccontai, senza entrare neidettagli, che stavo molto male in quella casa e che desideravo trasferirmi a Roma da lui.Milioni o non Milioni, in fondo era mio padre, no? E poi, non era stato proprio lui, unavolta in cui non avevo alcuna voglia di vederlo, a mormorarmi nell’orecchio, con la suavoce da gattone seduttore: “Perché non vuoi venire via con me, pulcino? Siamo fatti l’unoper l’altra, noi due…”In gran segreto compilai la lettera e, sempre in segreto, uscii a imbucarla. Quale sorpresae che terrore quando, il giorno dopo, al ritorno da scuola, trovai mia madre ad attendermi,con la lettera aperta in mano.“L’ha trovata una mia amica,” disse, “e ha pensato bene di portarmela. Comunque, senon sei felice in questa casa, potevi dirmelo in faccia, invece di tramare alle mie spalle. Perquello che riguarda tuo padre, posso toglierti subito l’illusione, se vuoi, puoi anchetelefonargli e chiederglielo, ma la sua risposta sarà comunque ‘no’. A lui, di voi non importanulla.”Fine della trasmissione.Fine della via di fuga.Fine della speranza.Un giorno, quando ero già adulta, mio padre mi confessò di aver sempre saputo che lapersona che aveva preso il suo posto nella nostra vita era gravemente squilibrata, dato chesi conoscevano n dalle elementari. Quando apprese che era diventato il nuovo compagnodi mia madre, le scrisse subito una lettera suggerendole di lasciarlo, dicendole che era unuomo violento, crudele, pazzo. Ma lei era già avvolta nella tela e gli rispose secca: “Ma cosadici? E l’uomo più meraviglioso del mondo.”“E noi?” chiesi allora a mio padre. “Non avevi pensato a noi?”“Voi?” mi rispose, senza un’ombra di imbarazzo, “voi dovevate imparare a sopravvivere.”Avevo dimenticato il darwinista.La stessa domanda, sempre da adulta, la rivolsi a mia nonna.“Perché non hai fatto niente?” le domandai.“Sembravano così felici,” mi rispose. “E poi non volevo fare la parte della suoceraintrigante.”Soltanto la zia Letizia, la mia madrina di battesimo, intuì qualcosa. “In quella felicità c’èqualcosa che non va,” disse.
23.La zia Letizia non viveva molto distante dalla casa in cui sono nata, tuttavia non micapitava mai di incontrarla per la strada o in un caè, come succedeva con le altre personedella famiglia. Quando andavamo a farle visita, ci riceveva sempre in salotto o, se lastagione lo permetteva, in giardino. Aveva un piccolo cane di nome Bambi, un pinscher, chele viveva praticamente in braccio.Il suo appartamento si aacciava su un giardino molto ombroso, forse per questo laricordo sempre immersa in una penombra rischiarata soltanto dai suoi occhi che brillavanoluminosi come stelle.Tre gli aveva avuto la zia Letizia, e li perse tutti e tre durante la guerra. Il primoscomparve in Russia, il secondo andò a cercarlo e non tornò più indietro e il terzo morì, unodegli ultimi giorni di guerra, colpito da una granata nel pieno centro della città.Appena mettevo piede nella sua casa, provavo uno strano senso di turbamento. Alloranon sapevo bene cosa fosse successo, mi avevano detto soltanto che i suoi gli eranoscomparsi in un paese lontano e che lei continuava a cercarli. Riceveva spesso lettere osegnalazioni, e quelle lettere e segnalazioni riaprivano sempre in lei qualche forma dilarvata speranza.Mia nonna mi raccontava anche di un gran numero di sciacalli, persone che, dietropagamento, promettevano informazioni che, immancabilmente, si rivelavano poi false.Comunque era chiaro che quella non era una casa adatta ai bambini. Dappertutto libri,quadri, tappeti, argenteria, divani di velluto, un grande pianoforte a coda: là dentro, nonavremmo certo potuto giocare a rincorrerci, come facevamo dai nonni. Per tutta la duratadella visita me ne stavo seduta sul bordo della poltrona, immobile e composta, ascoltandoquello che dicevano i grandi: discorsi di cui non capivo più o meno niente. Parlavano per lopiù di aari di famiglia o di vicende che riguardavano il padre della zia Letizia, lo zioEttore.Lo zio Ettore divideva un po’ il destino della zia Marisa.Pur non essendoci di persona, era sempre presente.A dierenza della zia, però, c’era un suo bel ritratto appeso nel salotto: un signorepiuttosto corpulento, con dei baffetti, privo di cattiveria nello sguardo.La zia Letizia aveva una voce fonda e meravigliosa, quando diceva “papà” la vibrazionesonora invadeva tutta la stanza. Ai miei occhi di bambina, appariva bella come una deadella mitologia: di carnagione scura, aveva denti regolari e bianchissimi, occhi brillanti eluminosi – come se vi avessero cosparso dentro dei frammenti di pietre preziose, diamanti,smeraldi, topazi – e i lobi delle orecchie allungati dalla consuetudine di indossare pesantiorecchini.Sebbene fosse la mia madrina di battesimo – e dunque mi avesse tenuto in braccio mentre
fuori infuriava la tempesta, promettendo al Cielo di accompagnare il mio cammino verso laLuce –, non ebbi con lei alcun tipo di condenza nell’infanzia. Non avrei mai potuto dirle,ad esempio, come facevo invece con la nonna, che avevo fame e volevo fare merenda,oppure che avevo mal di pancia. Quando la cameriera portava i bicchieri con le bibitedicevo “grazie” e bevevo in silenzio.<strong>Ogni</strong> volta che si prospettava una visita da lei, mi si formava un nodo allo stomaco; nodoche si dissolveva appena la porta si chiudeva alle nostre spalle e tornavamo a essereimmersi nella banale rumorosità dei giorni.La zia era sempre molto gentile con me, ma quella gentilezza non mitigava in alcunmodo la strana ansia che provavo ogni volta che entravo nel suo appartamento. La densitàdell’aria là dentro era diversa e la zia sembrava possedere tutta l’austera autorevolezza diuna sacerdotessa. Più che una casa, era un tempio: quale rito vi si celebrasse, però, non miera chiaro. Ancora non sapevo che l’Angelo, come la notte dell’esodo, era già passato e cheaveva tracciato il segno con il sangue dell’agnello sulla mia fronte, invece che sulla porta.
24.Nello sviluppo di una persona, il sadismo e il non amore possono creare delle profondedestrutturazioni alle qu<strong>ali</strong> è difficile porre rimedio.È un po’ come quando, nel corso di un esperimento, un oggetto viene sottoposto a unapotente forza d’urto: dove e in che modo si deformerà? si creeranno delle fessure, dellefratture? oppure esploderà? Nessuno lo può dire. Non si può mai prevedere, infatti, in chepunto e quando cederà la struttura. Oltre alla certezza del cedimento, non c’è altro.Naturalmente, all’inizio non te ne accorgi, sei sicuro di mantenerti saldo sulle tue gambe,non ti rendi conto di esserti trasformato in un camaleonte: la tua pelle sta prendendo ognisfumatura dell’ambiente che ti circonda; dalla pelle, il mutamento lentamente vieneassorbito e scivola al tuo interno, trasformandolo; cammini apparentemente tranquillo enon sai ancora che i tuoi occhi non sono già più i tuoi occhi, il tuo cuore non è più il tuocuore.L’odio scava cavità enormi dentro le persone. Come il bacillo di Koch, giorno dopogiorno, divora i tuoi polmoni; tu pensi di essere una persona e invece sei una cavità carsica;la temperatura è sempre bassa, per questo senti il bisogno di scaldarti.Com’è possibile, però, accendere il fuoco nelle viscere della terra? Mancando le presed’aria, in breve l’ossigeno viene a mancare; al posto delle amme, il fuoco produce fumo; ilfumo esala ossido di carbonio e tu, invece di scaldarti, rapidamente muori.Che errore pensare all’odio come qualcosa che infiamma!È l’amore che arde, l’odio può soltanto raggelare.La distruzione che inneschi nella tua vita è soltanto un tentativo di scaldarti.A casa la situazione diventava di mese in mese più dicile. Tornavo a casa da scuola e,appena ci sedevamo a tavola per mangiare, l’esordio era: “Tua glia ha cercato diammazzarmi.”La signora D, F, G, invece di rispondere “non dire cretinate” o di chiamare l’ambulanzadel soccorso psichiatrico, annuiva gravemente. A sentire le sue varie versioni, io ero capacedi attentare alla sua vita in molti modi, ma i preferiti erano quelli più indi, degni deibanchetti dei Borgia: veleni versati nell’acqua, schegge di vetro o invisibili chiodi mescolatiabilmente nelle vivande. L’unica arma che avevo era ripetere ogni volta: “Non è vero!” mala mia era la voce del bambino che grida: “Il re è nudo.”La favola si era trasformata in un lm dell’orrore, in un Grand Guignol, purappartenendo sempre al mondo del fantastico, perché non aveva alcun rapporto con laconcretezza del reale. La verità dei fatti era assolutamente inessenziale; nella realtà alteratadalla pazzia, la medaglia aveva solo due facce: la favola della felicità, da recitare a
enecio del mondo esterno, e il lm dell’orrore, che cambiava ogni giorno eppure erasempre monotonamente uguale e che si svolgeva tra le pareti di casa.Quando, in un palazzo, viene compiuto un omicidio, le risposte che i vicini danno aigiorn<strong>ali</strong>sti denotano spesso sempre di assoluto stupore: “Una bravissima persona,tranquillo, educato, mai un problema.”L’assassino.Vivevo perennemente immersa in un labirinto di specchi deformanti. All’inizio avevo unamemoria ancora chiara della mia immagine, ma con il tempo iniziai a smarrire ognicertezza di me stessa.Charles Darwin racconta di aver perduto completamente la sua fede in un Dio buonoosservando le abitudini di certi icneumonidi. Non si dava pace, infatti, che potesseroesistere delle creature tanto crudeli, capaci di par<strong>ali</strong>zzare la loro preda – solitamente unbruco succulento – traggendola con il loro aculeo per mantenerla in vita. Questiparticolari insetti, infatti, hanno bisogno di cibo fresco per le loro larve che, di lì a poco,depositeranno proprio sulla preda viva, della quale esse si ciberanno, giorno dopo giorno.L’impossibilità di stabilire un rapporto con il reale, mi aveva trasformata lentamente inquel bruco. Ero par<strong>ali</strong>zzata dal dardo velenoso, non riuscivo a muovermi, a chiedere aiuto.Del resto, che aiuto avrei potuto chiedere? Agli occhi degli estranei, la recita procedevasenza alcuna crepa.Lentamente, la certezza di che cosa fosse vero e che cosa no cominciò a confondersi anchenei miei pensieri. Chi ero, che cosa stava accadendo intorno a me? Non sapevo piùrispondermi.Mio padre, nel frattempo, era scomparso; non si faceva vivo da più di un anno; anche seavessi voluto, non avrei saputo dove cercarlo, come trovarlo. Mio fratello maggiore erauscito un giorno di casa dicendo “ciao” e, invece di andare a scuola o a trovare qualchedanzata, aveva raggiunto la Danimarca in motorino e lì si era fermato a lavorare pressoun gelataio.Uno dei lati positivi di mia madre era la totale assenza di ansia. Quella sera, nonvedendolo tornare a casa, non si preoccupò aatto. No news, good news era il motto che lepermise di veleggiare serena attraverso la tempestosità dei giorni.Un giorno, tornando da scuola, non trovai Red ad aspettarmi come al solito. Entrai incucina e vidi la sua brandina chiusa e piegata in un angolo, il suo collare rosso con lamedaglietta appeso alla manopola del termosifone. Mia madre stava cucinando, vedevo lesue spalle.“Dove il cane?” chiesi.Continuò a tagliuzzare, stava preparando un soffritto, credo.“L’abbiamo dovuto uccidere,” rispose senza voltarsi, “era malato.”Naturalmente il cane non era aatto malato, semplicemente era diventato una presenzasgradita. Il mio povero, innocente, sgraziato Red, l’unico puntello aettivo rimasto nella
mia vita – sparito anche lui.Nelle sere d’estate, le falene sbattono le <strong>ali</strong> confusamente attorno alle lampade: creatureforgiate per la notte, davanti a una luce imprevista e violenta smarriscono completamentela direzione del volo.A un tratto, di colpo, anch’io persi l’orientamento.Cominciai allora a vivere nelle sale d’attesa degli psichiatri.Mia madre raccontava che, n dalla nascita, piangevo in modo diverso dagli altribambini, che già all’asilo la maestra l’aveva messa in guardia su una possibile malattiamentale che covava sotto quelle innocue treccine. Alla ne, anche lei aveva dovutoarrendersi a quell’evidenza, ce l’aveva messa tutta per salvarmi, ma non ce l’aveva fatta.Del resto in famiglia c’erano già stati dei casi di persone non proprio norm<strong>ali</strong>.Quando un dottore, alla ne del suo accorato racconto, le ingiunse di presentarsi con ilmarito, la seduta seguente, mia madre si alzò di scatto, dicendo: “È lei la pazza, non noi!” euscì sbattendo la porta indignata.Non rimise più piede in quello studio.Fu in seguito a questo episodio che venne deciso il mio allontanamento da casa.Cominciai così un lungo peregrinare tra collegi, case famiglia, stanze in atto; provavodolore, certo, desolazione, ma anche un certo sollievo. Finalmente dormivo tranquilla,mangiavo in pace, comodità alle qu<strong>ali</strong> da troppo tempo non ero più abituata.Un giorno, lo psichiatra mi diede un passaggio in macchina e, prima di scendere, – nonmi ricordo se in risposta a una mia domanda o meno – mi disse: “Tua madre è una personagravemente malata.”Gong! Gong! Gong!A quella frase mi aggrappai come a una scialuppa di salvataggio. Dunque, tutto quelloche avevo intuito era vero. La A, la B, la C, la D esistevano! Allora non avevo alcuna colpa,non c’era nessuna pazzia in me, si trattava piuttosto di qualcosa di sottile, di oscuro, dimetafisico che, fin dalla nascita, aveva avvolto e condizionato la mia vita.La ne di questo tormentato periodo della mia vita lo voglio concludere con il brindisiche era solito risuonare in quella casa, durante i vari compleanni e in altre occasioni lietedella vita.Cin cin, cin cin, prosit!C<strong>ali</strong>ci in alto e tutti insieme, in coro: “Che la tua morte sia più atroce della mia!”Scuola di empietà.
25.Ho impiegato gran parte della mia vita per liberarmi del veleno che mi era statoinoculato. Ancora adesso, di tanto in tanto, sogno l’icneumonide che mi par<strong>ali</strong>zza con il suodardo.Il veleno, però, omeopaticamente mi è servito anche da antidoto: nella mia vita, infatti,non ho mai accettato, né permesso che durassero, rapporti in cui intravedevo la cifra dellamanipolazione e della falsità. Questo, di certo, non mi ha reso le cose più facili perchémanipolazione e falsità sono alla base, in forma più o meno vistosa, della maggior parte deirapporti umani, almeno di quelli che non si svolgono nella luce della consapevolezza.Il lungo training ascetico della mia infanzia e della mia giovinezza mi ha permesso didiventare una persona completamente libera dalle pastoie del sentiment<strong>ali</strong>smo, unapersona assetata di verità, incapace di accontentarsi delle piccole graticazioni dell’ego,così care a chi non è in grado di affrontare l’apparente desolazione della nudità.Non attaccarsi a nulla.Non desiderare nulla.Non attendersi nulla.Sapere di essere nulla.Quanti libri di ascetica bisogna leggere, quanti ritiri estremi, quanti gong suonati dalproprio maestro bisogna affrontare, nella speranza di giungere a questa consapevolezza!A me invece è bastato venire al mondo e respirare.Al raggiungimento della maggiore età, in me c’era il vuoto assoluto, la perfetta distanzada qualsiasi tipo di aspirazione banalmente umana. Dall’iceberg allo scendiletto, dalloscendiletto al tuo nella Fossa delle Marianne: avevo percorso con diligenza tutta la stradaper raggiungere l’entomologica freddezza dello sguardo.Uno dopo l’altro, erano stati distrutti i miei rapporti aettivi, neppure il cane erasopravvissuto a questa salutare pulizia. Per molte volte, avendo una natura molto calda,avevo cercato di far ripartire il motorino d’avviamento ma, a un certo punto, logorato daifallimenti, anche lui si era inceppato.Le strade della mistica impongono sempre il raggiungimento del deserto come passaggioobbligato, ed è giusto perché solo con il vuoto intorno, abbandonate tutte le illusioni, si puòintravedere il sentiero capace di portarci in una dimensione diversa. Nella confusione, nelladistrazione, è impossibile compiere questo passo. Anche i campi, secondo le antichetradizioni, dopo il raccolto venivano incendiati per permettere alla terra di accogliere lanuova vita dei semi.Il deserto, però, è uno stato intermedio e non possiede, tra le sue doti, quella della
neutr<strong>ali</strong>tà. Il deserto è il luogo in cui appaiono i miraggi, in cui si scatenano i pensieri, incui si manifestano i demoni.I demoni a me più fedeli sono quelli della violenza e della paura; vanno sempre in coppiae si generano costantemente l’un dall’altro, paura e reazione di difesa, desiderio disopraffare, di ferire, di distruggere, di calpestare.Persino adesso, in certi momenti di particolare silenzio, sento i passi dell’assassinorisuonare sotto la volta dei miei giorni. L’illusione di Rousseau – cioè dell’uomo che nascenaturalmente buono – la lascio agli spiriti ingenui, a tutti coloro che non sono stati maicostretti a guardare in faccia la vera natura dell’essere umano. Il male ha natura volatile,leggera, inodore e invisibile, penetra ovunque senza alcuno sforzo, invade le persone, senzache se ne accorgano. Da questa assenza di contemplazione interiore nasce il ricorso al caproespiatorio. Il male non è in me, ma nell’altro, per questa ragione va perseguitato eannientato.Non è questa forse la genesi di tutte le forme di umana distruzione? Basterebbe, invece,volgere onestamente lo sguardo dentro di noi per accorgerci dell’inutilità di trascinare ilcapro nel deserto, per buttarlo ritualmente giù dalla rupe.Eppure il demone è assolutamente necessario. Senza la sua presenza si rimane nel limbostucchevole dei buoni sentimenti, mantelli rosati deposti sulla belva che ci ruggisce dentro.Come dimostra magistralmente il simbolo taoista dello yin e dello yang, il nero non puòesistere senza il bianco, così come il bianco senza il nero. Si generano infatti a vicenda, inun moto continuo, e ognuno, per esistere, ha bisogno dentro di sé del principio dell’altro.S<strong>ali</strong>re in alto senza essere scesi in basso è sconsigliabile perché non c’è vero radicamentoin una tale crescita. Altrettanto sconsigliabile è inoltrarsi nel campo dello scrivere se, nellezone d’ombra dei propri giorni, non risuonano i passi dell’assassino.In quegli anni di sbandamento e di assenza di domicilio, ripresi a frequentare mia nonna.O meglio, fu lei, compresa nalmente la situazione, a venirmi incontro, cercando distabilire un rapporto. Di relazioni aettive, però, ormai non volevo più sentir parlare,dunque dovette impegnarsi a fondo per riuscire ad aprire una breccia nel muro inv<strong>ali</strong>cabileche mi circondava.Veniva a trovarmi con la sua Renault bianca nei vari luoghi dove vivevo oppure ero io araggiungerla, d’estate, nella sua casa sull’altipiano. Eravamo due caratteri forti che siscontravano ferocemente; la realtà che lei voleva orirmi, io sapevo solo riutarla. Il miosistema nervoso era ormai siologicamente distrutto, camminavo come su un lo sospeso,non potevo rischiare di mettere nuovamente in gioco il mio precario equilibrio.Eppure piano piano, giorno dopo giorno, con l’abilità di un cesellatore, riuscì a creareuno spiraglio per giungere al mio cuore.Spesso mi sono chiesta come sia stato possibile per lei compiere questo miracolo, pensoche nessun altro ci sarebbe riuscito. Non credo che il sangue e la parentela l’abbianoinuenzata, così come lo spirito di maternità – vale a dire il sapersi prendere naturalmentecura dell’altro – che non le era mai veramente appartenuto. Mi confessò, infatti, di aver
messo al mondo i suoi figli soltanto per consuetudine e non per una sua vera aspirazione.Penso che quello che, alla ne, che ci ha unite, sia stata la comune esigenza diraggiungere la verità nei rapporti. Tutta la vita aveva soerto a causa della superci<strong>ali</strong>tàdelle relazioni che, in quanto prima glia, poi moglie e madre borghese, era stata costrettaa intrattenere. Vedeva il velo, la scorza opaca che impedisce di giungere al nucleoincandescente delle persone, e tuttavia non sapeva come toglierlo. Ma l’esigenza di quelnucleo era, in lei, un’arsura costante che non riuscì a estinguere, no all’incontro con la suaamica sopravvissuta ad Auschwitz.Aborriva come me il mor<strong>ali</strong>smo e, come me, detestava l’obbligo di volersi bene per puraconvenzione. Non era la parentela a rendere necessario un rapporto, ma qualcosa di piùprofondo. Camminare verso la verità, nella verità. E camminare in quella direzione volevadire una sola cosa: cancellare, giorno dopo giorno, la menzogna, la noia perpetua efalsicante dell’ovvietà delle parole già dette, dei pensieri già pensati. Voleva dire anchenon avere alcun timore di entrare in una dimensione più profonda, quella dell’amore cheniente pretende, niente separa, cieco davanti ogni forma di giudizio.Alla nostra mente così piccola, così sempre desiderosa di distinguo, di separazioni, dicassetti ordinati in cui mettere le cose, di recinti in cui richiudere le persone, questo tipo diamore fa una paura tremenda perché, in qualche modo, si trasforma in una kenosis, in unvuoto.Ma, a dierenza del nulla a cui, n dalla più tenera età, ero stata ammaestrata da miopadre – un nulla deserto, brullo, sterile, in cui l’unica forma di movimento era quello diqualche rotolo di spine o di qualche barattolo trascinato dal vento – il nulla propostomi damia nonna, l’annullamento che veniva da Auschwitz e che, attraverso il suo corpo e le sueparole, era giunto no a me, conteneva in sé il principio perpetuamente rigenerante dellaredenzione.A questo principio ho dedicato le ultime righe di Va’ dove ti porta il cuore. “Stai ferma insilenzio e ascolta il tuo cuore…”Se io non avessi incontrato mia nonna, se lei non si fosse messa umilmente di traverso sulmio cammino, non mi sarei salvata. Forse neppure lei si sarebbe salvata, giungendo cioèalla pienezza dei suoi giorni, se non avesse incontrato la sua amica sopravvissuta alnazismo, come, di sicuro, anche quell’amica doveva essersi imbattuta, sulla sua strada, inqualcuno capace di comunicarle una diversa dimensione dell’esistere.Nel mondo delle monadi nessuno si salva.È la misteriosa e gratuita dinamica dell’incontro a permetterci di andare avanti.
26.Nel corso di quegli eventi così catastroci, mai, neppure per un istante, venni sorata dalsospetto che l’arte, in qualche modo, poteva riguardarmi.Il fallimento negli studi, il non riuscire a comprendere le cose più ovvie, mi aveva messodavanti al muro della mia non intelligenza. Oltre a nire i miei giorni allo Steinhof, ilmanicomio di Vienna – a Trieste era già arrivato Basaglia –, che cos’altro avrei potuto farenella vita?Intanto, però, ero arrivata alla maggior età e mi si imponeva una qualche decisione. Unlavoro che avrei fatto volentieri sarebbe stato quello della guardia forestale: miimmaginavo in giro tutto il giorno per i boschi, a piedi o a cavallo, felicemente lontana dalconsorzio degli umani. Ma, all’epoca, quell’impiego era purtroppo precluso alle donne.Anche la via del mare mi attirava parecchio. Gli sca e le onde erano nel DNA della miafamiglia, ma neppure lì c’erano possibilità per una ragazza.Quando ero all’ultimo anno di scuola – alla ne me la cavai frequentando faticosamentele magistr<strong>ali</strong> – un amico che conoscevo n dai tempi del ginnasio mi introdusse nel mondodella poesia russa. Leggendo quei versi, qualche remota corda del mio patrimonio geneticoslavo iniziò a vibrare.Cominciai così a immaginare di studiare il russo, tanto per orire un orizzonte credibileagli altri. In un futuro, pensavo, avrei potuto tradurre, anche quella, in fondo, eraun’attività che si poteva svolgere in solitudine. Ma non ero per nulla convinta. Innanzitutto,si sarebbe trattato di studiare, e io non mi consideravo assolutamente all’altezza di farlo; epoi, ammesso che ci fossi riuscita, avrei dovuto passare il resto dei miei giorni seduta a unascrivania con un vocabolario accanto.Non potevo immaginare niente di più deleterio per la mia salute! Per tutta la vita sonostata preda di una straordinaria irrequietezza sica, la mia testa in perpetua ebollizione miha sempre impedito di considerare l’immobilità dell’intellettuale un fattore positivo.Muovermi negli spazi aperti ha sempre dato ossigeno e stabilità ai miei pensieri.Trovare un lavoro normale era fuori discussione. Ero, infatti, abbastanza lucida ormai sulmio stato di disadattamento; sapevo che, ad esempio, se avessi dovuto servire delle torte,per due o tre giorni sarebbe andato tutto bene, ma al quarto o al quinto avrei rovesciato infaccia il piatto al primo cliente un po’ villano.Fino ad allora, avevo avuto soltanto delle esperienze come baby-sitter; non mi eradispiaciuto perché almeno con i bambini non era necessario alzare troppe difese, ma nonmi sembrava un lavoro che potesse diventare denitivo. Avrei potuto fare il concorso permaestra, ma anche lì si sarebbe riproposto lo stesso discorso delle torte e poi, comunque,non c’era nessun concorso all’orizzonte.
“Che fare?” come diceva il titolo di un libro molto in voga in quegli anni.Già perché, nel frattempo, erano arrivati i mitici anni settanta e, tra tutte le prospettivepossibili, per i ragazzi della mia generazione c’era anche quella della rivoluzione. Ilterrorismo infatti, con tutta la sua cupa scia di inquietudine e di morte, aveva invaso glispazi fin lì apparentemente sereni della società it<strong>ali</strong>ana.Oltre al terrorismo, anche un potente desiderio di innovazione era giunto come unaventata a sconvolgere ogni tipo di rapporto. Se avevi un ragazzo ed eri innamorata di lui,dovevi immediatamente demolire tutto ciò che di ovvio e banale c’era nella vostrarelazione. Anzi, ti sentivi persino costretta a vergognarti del desiderio di esclusività chenutrivi nei suoi confronti. Il tempo meschino della proprietà privata era nito, niente erapiù per sempre; la gelosia era bandita perché non doveva più esistere il possessoindividuale dei corpi, che tanta infelicità aveva portato agli esseri umani nel corso dellastoria.Eravamo tutti di tutti, tutti per tutti, finalmente liberi.Davanti a noi si stava spalancando il magnico mondo da Paese dei Balocchi che, per piùdi quarant’anni, aveva illuso il ricco Occidente. All’incertezza delle mie scelte private sisommava così l’incertezza di un periodo storico particolarmente confuso.Nel corso di quei mesi, fui preda del demone dell’accidia. Ovunque fossi, qualsiasi cosafacessi, avrei voluto essere da un’altra parte, fare un’altra cosa.Poi, un giorno, accadde il miracolo.Alla televisione trasmettevano un lm di un regista molto amato da mia nonna. Alle ottoe mezzo se ne stava già seduta in poltrona davanti al gigantesco apparecchio in bianco enero in attesa, mentre io, come sempre, andavo avanti e indietro per la casa – l’unico modoche conoscevo per dissipare l’energia che mi percorreva.Dopo un po’, però, mi sedetti anch’io. La scena che vidi mostrava un ragazzo inun’enorme buca che cercava di fondere una campana. La sua fatica era spaventosa enessuno intorno sembrava credere nel suo successo. Alla ne la fusione riuscì e soltantoallora lui si buttò per terra e scoppiò in singhiozzi, ripetendo: “Non l’avevo mai fattoprima… È la prima volta… Non l’avevo mai fatto!”Quando il film finì, rimasi a lungo seduta in poltrona a contemplare lo schermo.La mattina dopo, quando mi alzai, dissi a mia nonna: “Adesso lo so! So cosa voglio fare!”“Che cosa?”“Voglio raccontare storie!”Il film era Andrej Rublëv di Andrej Tarkovskij.Qualche mese prima, c’era stato il terremoto del Friuli: la terra dove vivevo fu scossa daun minuto intero di violenza e, in quel lunghissimo minuto, tutto il mondo della miafanciullezza e della mia adolescenza venne distrutto. Già da un anno, la mia famiglia eratornata a vivere a Trieste ma io ero rimasta nella città dove avevamo vissuto insieme, datoche le nostre vite erano ormai disgiunte.
Il 6 maggio era una giornata straordinariamente calda, il termometro toccava i 30 °C enel pomeriggio ero stata colpita da uno sbocco di epistassi.Condividevo l’ultimo piano di una casa fatiscente con altre studentesse e avevo da pocoun nuovo cane, Bella, preso al canile; c’era anche un gatto ed entrambi, da ore, erano predadi una strana agitazione.A un tratto mi accorsi che ogni cosa aveva cominciato a tremare. Dapprima pensai aBella, forse si stava semplicemente grattando – il pavimento di legno era, infatti, piuttostotraballante – ma quando la individuai nella stanza, vidi che mi ssava con gli occhi dilatati,immobile.Un istante dopo si scatenò il finimondo.Finché non si è vissuta una catastrofe, non si capisce subito che la si sta vivendo, non c’èriessione in quegli istanti, ma soltanto istinto e l’istinto mi diceva che l’unica cosa da fareera fuggire. Così feci l’unica cosa che, in una casa così vecchia, non avrei mai dovuto fare:imboccai le scale. Dopo alcuni gradini vidi che Bella non mi seguiva, par<strong>ali</strong>zzata dal terrore;allora tornai indietro, l’aerrai per il collare e, con lei in braccio, corsi verso uno spazioaperto.Non potevo permettermi di perdere un altro cane!Incrociai diverse persone smarrite e anziane in camicia da notte, nei pianerottolisottostanti, ma al grido di: “Sono giovane! Devo vivere!” le scansai, una dopo l’altra.L’istinto di sopravvivenza non è un damerino che chiede scusa o permesso. A diciotto anni ildesiderio di vivere è naturalmente superiore che a ottanta.Una volta in strada, mi trovai in mezzo a una folla sbandata, tutti correvano di qua e dilà, senza sapere cosa fare. Le strade erano piombate nella totale oscurità, si correva suicalcinacci.Per mettermi in salvo, pensai, devo raggiungere una grande piazza, un luogo dove ipalazzi non possono franare. Mi venne incontro lungo la strada il ragazzo di cui allora eroinnamorata e insieme a lui mi diressi verso la casa di una comune amica che stava inperiferia, sul limitare dei campi. Non c’erano radio né televisioni a poterci dare notizie,sentivo dire dalla gente intorno a me che c’era stato un terremoto nel Nord della Germania.Sdraiata sulla terra, accanto a quello che, in tempi meno confusi, avrei chiamato “il miodanzato”, vidi davanti ai miei occhi l’immagine di un’Europa rasa al suolo, le volte dellecattedr<strong>ali</strong> crollate e i lupi che vi scorrazzavano dentro.Se noi eravamo ridotti così, infatti, in che condizioni poteva essere il resto del mondocivilizzato?Quella notte non chiudemmo occhio. Le scosse continuavano a susseguirsi. Era incredibilesentire, sotto il nostro corpo, il movimento della terra. Gli alberi si ettevano e sipiegavano con gran rumore di fronde, sembrava volessero inchinarsi, anche se non spiravanessun <strong>ali</strong>to di vento.Poi, nel buio profondo della notte, successe qualcosa di incredibile: da un gelso pocodistante iniziarono a propagarsi delle cascate di note, gorgheggi, trilli. Era la prima voltache sentivo cantare un usignolo: su quel paesaggio di desolazione e morte, orivasfrontatamente la regale bellezza del suo canto.
Qualche ora dopo, nel cielo cominciarono a comparire gli elicotteri e a risuonare le sirenedelle ambulanze nelle strade.Dunque, l’Europa esisteva ancora!Ci separammo la mattina dopo. Con il cane come unico bagaglio, in pantaloni corti emaglietta, raggiunsi la stazione e saltai sul primo treno per Trieste. Ciò che rimaneva degliultimi anni della mia vita erano soltanto macerie. Macerie metaforiche e macerie re<strong>ali</strong>.Non ho alcun dubbio che, se fossi rimasta lì, avrei avuto soltanto due strade da percorreredavanti a me: la via della droga e quella dell’alcol – le realtà surrogate più facilmenteraggiungibili da chi vive devastato dal vuoto. Quella catastrofe mi costrinse bruscamente acambiare direzione.Nei mesi seguenti, sorii di un’insonnia pressoché assoluta, disturbo post-traumatico dastress. Maria, l’amica del cuore di mia nonna, conosceva un medico agopuntore moltoanziano che aveva vissuto a lungo in Cina. Un pomeriggio sì e uno no, con la Renaultbianca, raggiungevamo le alture di Muggia dove lui abitava. Mi riceveva in un salotto conuna doppia nestra sul golfo e lì mi inlava gli aghi, davanti a una grande testa di Buddhain pietra.Per tutto il tempo della seduta rimanevamo in silenzio, il Buddha, lui e io, a contemplareil mare.
27.Tornare a Trieste, in qualche modo, aveva voluto dire tornare alle mie radici. Mi eramancato molto il soo del vento, come anche l’assenza del Carso aveva lasciato un vuotoche non era stato sostituito da nulla.In quelle asperità, nel biancore aguzzo del calcare mi riconoscevo molto di più che nelledolci colline moreniche che contornano la pianura friulana. C’erano voragini nel Carso,cose nascoste, fatica, stentatezza; tutto lì cresceva “nonostante”. Nonostante il vento,nonostante lo strato minimo di terra, nonostante l’assenza di acqua.La vita sul Carso era una vita “contro”. Non crescono grandi alberi lassù, ma soloboscaglia dalle radici uncinate. Una vita che, per esistere, è costretta ad aermare la suacaparbietà.Come potevo non identificarmi con quella condizione?Oltre a questo, il Carso a quei tempi era anche una terra divisa. Il conne con quella cheuna volta si chiamava Jugoslavia passava a pochi chilometri da dove vivevo ed era unconne ben diverso da quello che, ad esempio, separava l’It<strong>ali</strong>a dalla Francia. Lì nival’Occidente e cominciava l’Oriente, dove per Occidente si intendeva tutto il mondo libero eOriente stava a indicare tutti quei paesi la cui la libertà era stata sottratta dai regimicomunisti.All’epoca – il trattato di Osimo non era ancora stato rmato – l’altopiano si divideva inzona A e zona B e noi abitanti eravamo forniti di un lasciapassare, la propusnica, che cipermetteva di muoverci avanti e indietro, senza attraversare i v<strong>ali</strong>chi di conne maggiori.Da bambini, andavamo spesso a fare la spesa con la nonna nella zona B, dove tutto era piùconveniente, ma anche più povero e più grigio.Se sono riuscita a non farmi stordire dalle sirene dell’ideologia, che tanti pensieri hannosottratto ai miei coetanei, penso abbia contribuito anche questo precoce e disincantatorapporto con i paesi in cui il comunismo non era un sogno, ma un’opprimente realtà. Tutti ipicnic e le passeggiate della nostra infanzia sono stati segnati dal timore delle esercitazioni,dei mitra e dei fucili che potevamo trovarci spianati addosso appena facevamo un passofalso, dalle grandi pietre che sapevamo benissimo non essere pietre, ma camuamenti chenascondevano cannoni, dai cani che abbaiavano in continuazione e non appartenevano aigitanti, bensì alle continue ronde che di giorno e di notte andavano alla ricerca di eventu<strong>ali</strong>sconnatori. Sconnatori casu<strong>ali</strong> come noi, da picnic, oppure sconnatori lucidi edeterminati. Persone in fuga da quel mondo che, in Occidente, molti ci incitavano asognare.Oltre al fenomeno potentemente ansiogeno di quel conne persecutorio, qua e là, sparseper l’altopiano, c’erano anche delle voragini il cui ingresso era sigillato da una lastra di
pietra con una croce sopra. Ce n’era una, in particolare, attorno alla quale andavamospesso a raccogliere i ciclamini che, in quel punto, crescevano più grandi e più profumatiche altrove.“Che cosa c’è qua dentro?” chiesi un giorno a mia nonna, seduta sul fresco di quel marmo,dondolando le gambe, con il mazzolino di fiori in mano.“Morti,” mi rispose. “Qua sotto ci sono molti morti.”La solita, monotona risposta. Quella volta, mia nonna non si diuse in spiegazioni suglieventi della seconda guerra mondiale, ma fu invece mio fratello a farmi da maestro,appassionato divoratore qual era della rivista Storia illustrata.Mi raccontò che li legavano a due, i prigionieri, per risparmiare le pallottole, poi peròsparavano a uno solo, così l’altro veniva trascinato giù e moriva comunque, magari dopogiorni di agonia, schiacciato da altri corpi.Oltre a quel dettaglio, di cui la mia sensibilità esasperata non aveva certo bisogno, miofratello provvide anche a farmi conoscere sui misteri del nazismo. I bunker di Berlino eranouna delle sue ossessioni. “Non c’è alcuna prova,” ripeteva per rassicurarmi, “che Hitlerdavvero sia morto lì; non è stato trovato il corpo, né il cranio, niente.” In realtà, lui avevasoltanto fatto nta di avvelenarsi con il cianuro, sosteneva. Da tempo, a sentire miofratello, il dittatore nazista, essendo un uomo previdente, aveva fatto scavare dei cunicolisotto l’oceano Atlantico e, attraverso quelli, con i suoi di, aveva raggiunto il <strong>Su</strong>damerica.Lì viveva indisturbato sulle Ande e presto, percorrendo le gallerie all’incontrario con unnuovo esercito e risalendo dalle fogne, sarebbe tornato a riconquistare l’Europa.Immaginavo allora i suoi fedeli non molto diversi da ratti giganti, vedevo i loro nasi neri esensibilissimi uscire vibrando dalla tazza del cesso: snu snu snu, ucci ucci, sento odor diebreucci.Come non pensare alla zia Letizia e al suo racconto sulla seconda guerra mondiale? Ungiorno, alla casa nelle campagne venete in cui si era nascosta con la sua famiglia, bussòimperiosamente un drappello di tedeschi. Attimi di panico. Che fare? Alla ne lei, con il suoincedere da regina, andò ad aprire la porta; la zia e i soldati si squadrarono a lungo, avicenda. “Desiderate?” “Haben sie salami?” Invisibile ed enorme respiro di sollievo:“Salami? Aber natürlich!”Credo che quel drappello si sia allontanato da casa avvolto in le di salsicce come unalbero della cuccagna. Troppo aamati, troppo stanchi per accorgersi del voltosquisitamente mediorientale della persona che glieli stava arrotolando intorno al collo.Ricordo ancora la risata sonora della zia Letizia quando mi raccontava questa storia.“Salami? Ma certo! Anche prosciutti, salsicce, cotechini, sanguinacci…”Ma non sarebbe stato possibile ingannare i ratti! Per anni, il loro uto era statoaddestrato soltanto a riconoscere anche la minima molecola in circolazione di quel popoloinfame. Meglio allora chiudere ogni sera la tavoletta del gabinetto, meglio serrarla – comela faceva la protagonista di Per voce sola – anche di giorno, magari con un peso sopra.Passeggiando sul Carso, in quei mesi, mi tornarono in mente tutti i pensieri, tutte leangosce che la Storia aveva depositato sulla mia anima nel corso dell’infanzia; angoscia per
la ne perennemente in agguato nei giorni; angoscia per l’ingovernabilità degliaccadimenti; angoscia per il fatto di appartenere al genere umano – tra tutte le specie dicreature, la più assetata di sangue.Se fossi cresciuta tra le dolci colline delle Marche, nell’Agro Pontino o a Capri, il miosentire della vita sarebbe stato completamente diverso. Invece ero lì, sospesa tra queglistentati arbusti e quelle pietre assetate di sacrici umani. Camminavo per ore tra laboscaglia e i prati giallastri, tra le crepitanti macchie di pino nero e i balzi di roccia biancache precipitavano verso il mare. Uscivo la mattina e tornavo la sera, non c’era anfratto,non c’era dolina o castelliere che mi fosse sconosciuto. Non mi era chiaro se qualcosainseguivo o da qualcosa stavo sfuggendo. Intanto continuavo ad andare avanti,improvvisamente commossa per l’inaspettato apparire di un ore. Una genziana, unapulsatilla – la memoria della presenza del bello.Nei giorni di vento, poi, raggiungevo un certo v<strong>ali</strong>co attraverso il quale la bora siincanalava con particolare forza. Lì in piedi aspettavo le rache e, al loro arrivo, aprivo lebraccia, abbandonandomi a peso morto al loro abbraccio. Avrei dovuto cadere, invece,finché il vento era con me, rimanevo sospesa nell’aria.Il vento che sibila, che ulula, altera in profondità l’equilibrio del tuo corpo senza chiedereil permesso. Quello della postura non è che il più evidente. Ti pieghi, barcolli, cerchidisperatamente di aggrapparti a qualcosa. In questo smarrimento delle vertic<strong>ali</strong>tà sinascondono altri sconvolgimenti. La linfa, il sangue, la sostanza in cui è avvolta la scatolacranica iniziano a scorrere in modo intermittente, i pensieri si confondono, strappati dicolpo dalla loro consequenzi<strong>ali</strong>tà e i sentimenti, sotto quell’invisibile sferza, all’improvvisosi alterano, impennandosi come cavalli imbizzarriti.Per la medicina cinese, l’elemento “vento” è uno dei più destabilizzanti perché grazie a luii pori si aprono e i so perversi penetrano all’interno. La medicina occidentale non deveessere arrivata a conclusioni molto diverse dato che, in molti paesi, un delitto compiuto inun giorno di forte vento viene giudicato con più indulgenza.La casa dei miei nonni materni si trovava proprio di fronte al tribunale: un enorme eopprimente edicio costruito negli anni del fascismo. Ricordo che, nelle notti di forte bora,si raccoglieva una piccola folla davanti al suo portone. Arrivavano alla spicciolata e lìrimanevano gran parte della notte, inveendo con i pugni alzati contro la facciata di quelcupo palazzo e io mi addormentavo cullata da quell’incomprensibile cantilena alternata allapotenza delle rache. Una delle statue poste a ornamento della facciata teneva in manouna bilancia ed era contro quella che le persone raccolte là sotto protestavano. Esistedavvero la giustizia, nel mondo degli uomini? Basta avere una conoscenza anche minimadella vita, per potersi darsi una risposta. Quella bilancia è un’ipocrita nzione. La giustiziaterrena riguarda infatti molto limitatamente gli esseri umani: palazzi, carte, avvocati egiudici non sono altro che una modesta messinscena per rendere meno evidente quellaverità. Era questo che offendeva e feriva le persone là sotto.Il vento dunque scoperchia le pentole, mette a nudo ciò che è pura convenzione,scombina i pensieri dal loro percorso obbligato, facendo intravedere nuove direzioni versocui muoversi.
Anni fa conobbi uno studioso che stava tentando di an<strong>ali</strong>zzare in che modo l’eettodestabilizzante del vento avesse potuto inuire sulla prosa di James Joyce. Percomprendere l’inusso del vento sulla sintassi basterebbe ascoltare i triestini: parlano tuttiin modo velocissimo, come se nelle profondità del loro respiro fosse racchiusa una raca dibora.Il vento, insomma, porta con sé ogni tipo di instabilità ed è proprio questa instabilità chepermette di affacciarsi su altri mondi.Avevo già cominciato a scoprire la poesia durante l’adolescenza, grazie all’amicizia conLuisa. Non era stata la frequenza della scuola ad averci avvicinate – lei, infatti, frequentavail liceo classico – ma quella forma sottile di insoddisfazione che ci rende facilmente emisteriosamente diversi dagli altri: ci si annusa, ci si intuisce simili e quella similitudine, aun tratto, unisce più di qualsiasi rapporto di sangue. Alla ne, in fondo, una delle ragionipiù evidenti di diversità tra gli esseri umani è proprio questa: la capacità di inquietarsi perl’invisibile o il non vederlo aatto. Tra le due condizioni, ovviamente è preferibile laseconda, perché è evidente che il mondo è retto e dominato da chi possiede questa felicececità. Tuttavia, senza la prima, la vita di tutti noi sarebbe straordinariamente più povera.Le sde dell’arte e della scienza nascono proprio da questa inquietudine. Gli inquieti silegano tra loro senza bisogno di molte parole.Luisa e io eravamo innamorate della poesia.Leggevamo soprattutto i poeti francesi perché a scuola studiavamo entrambe quell<strong>ali</strong>ngua e, con l’enfasi esagerata dell’adolescenza, passavamo ore a discutere sul signicatodei loro versi. Villon, Baudelaire e Rimbaud erano i nostri preferiti perché riconoscevamo inloro un estremismo che combaciava perfettamente con il nostro di allora. Sognavamo ditrasferirci a Parigi, da grandi, la capitale francese era la nostra città mito, come lo è, per iragazzi di adesso, Londra, probabilmente grazie a Harry Potter. Lì avremmo vissuto nelturbine della bohème: grandi amori, alcol, di tanto in tanto un po’ di oppio e una vitasempre e comunque fuori dall’ovvietà del quotidiano.Che grandi giornate abbiamo passato assieme! Per noi tutto era troppo piccolo, troppomeschino. Luisa viveva in un piccolo e grazioso paese in collina, in una casa dalla posizioneinfelice, accanto a un cavalcavia. Andavo spesso a trovarla e lì fantasticavamo per ore sullavita meravigliosa che avrebbe sfavillato davanti a noi nel momento in cui fossimo riuscite asfuggire da quell’opprimente grigiore.In qualche modo, Luisa ha tenuto fede a questo impegno perché poi si è sposata con unvero poeta e hanno vissuto felici insieme fino a che la morte – di lui – non li ha separati.Leggevamo poesie, è vero, ma non mi pare proprio di ricordare che le scrivessimo. Queiversi mi entusiasmavano per il loro vigore, per la carica eversiva che traspariva delle loroparole, ma l’eco interiore, a dire il vero, fu piuttosto scarsa. Con la poesia russa andò un po’meglio, anche se la vera apertura della mente e del cuore per me avvenne con la poesiatedesca.Con Rilke, soprattutto. Camminando sul Carso, un giorno arrivai alle bianche falesie diDuino e aprii a caso le Elegie duinesi. Quando lessi:
Ma chi ci ha rigirati cosìChe qual sia quel che facciamoÈ sempre come fossimo nell’atto di partire? ComeColui che sull’ultimo colle che gli prospetta per unaVolta ancoraTutta la sua valle, si ferma – indugia –,così viviamo per dir sempre addio.all’improvviso, visceralmente e in forma larvale, capii che, da qualche parte, tra me e leparole era stato scritto un destino.
28.L’estate del 1976 stava volgendo al termine e mio padre fece una delle poche cose utilidella sua vita, oltre a quella di mettermi al mondo. Si informò se, a Roma, ci fosse unascuola per diventare registi.La scuola c’era e, per chi la frequentava, era previsto anche il benecio di una borsa distudio. L’unico problema consisteva nel concorso che bisognava fare e, naturalmente,vincere, per potervi accedere. Ora, io sapevo di voler raccontare storie, ma non ero unapersona particolarmente devota al cinema. Quando ero a Trieste, accompagnavo spessomia nonna e la sua amica Maria alla Cappella Underground, una sala che proiettavaprevalentemente film d’essai, e questo era tutto.Oltre a ciò, data la bassa stima che avevo delle mie doti intellettu<strong>ali</strong>, l’idea di doversostenere un esame mi metteva in uno stato di panico assoluto.Ma, a volte, il destino ci sferra degli invisibili calci negli stinchi per farci andare avanti;la prima selezione, infatti, avveniva tramite una prova scritta da inviare per posta: in talmodo il trauma e l’onta erano limitati. Così presi carta e penna e scrissi una paginetta sulleragioni che mi spingevano a voler entrare in quella scuola. Compito fatto e pensieroarchiviato.Che sconvolgimento quando, in settembre, mi arrivò la convocazione per l’orale! Mirivolsi allora a uno dei responsabili della Cappella Underground e passai un pomeriggiocon lui, cercando di apprendere il massimo delle nozioni possibili riguardo al mondo delcinema.Il giorno dell’esame, arrivai puntu<strong>ali</strong>ssima, alle nove, davanti alla sede del Centrosperimentale di cinematograa di Roma, ma quando incontrai gli altri aspiranti mi resisubito conto di essere un vaso di coccio tra i vasi di ferro. Erano tutti parecchio più grandidi me, avevano quasi tutti già una laurea, molti avevano già tentato di entrare negli anniprecedenti e soprattutto, diversamente da me, erano tutti degli accaniti cinefili.Nell’attesa, qualcuno paternamente mi fece pat pat sulla spalla, dicendomi: “Coraggio, seigiovane, avrai ancora molte occasioni per riprovarci.”Appena si spalancarono davanti a me le porte della stanza in cui era riunita lacommissione – ricordo un tavolo lunghissimo, pieno di persone – feci l’unica cosa possibile:dichiarai subito, ad alta voce, di essere totalmente ignorante in materia. Del resto, fecinotare, che senso aveva frequentare una scuola, se si sapeva già tutto di quello che siavrebbe dovuto apprendere?Io volevo solo imparare a raccontare storie.Ricordo ancora i sorrisi della commissione. Dopo la processione di dotti che si erasusseguita no a quel momento, la mia ingenuità doveva essere stata accolta come un
aggio di sole. Ero, infatti, la più giovane in assoluto di tutto il concorso: giovane suidocumenti, ma ancora più giovane alla vista.Sentendo la mia dichiarazione, un signore dai capelli pepe e sale – seppi dopo che eraMiklós Jancsó – prese un grande libro con delle strane foto in bianco e nero e me lo aprìdavanti, dicendo: “Inventa una storia!” Di foto ne scorremmo parecchie e di storie neinventai altrettante. Alla fine venni congedata senza altri commenti.Tornata a Trieste, considerai chiusa per sempre la parentesi romana, mi sdraiai suldivano, accanto a mia nonna, che teneva sempre a portata di mano una scatola di lokum, eripresi a leggere romanzi. Mia nonna, infatti, oltre a quei dolci turchi di cui eraparticolarmente golosa, divorava un libro dopo l’altro e, in quei mesi di attesa e di inerzia,la sua passione contagiò anche me.Ma un giorno arrivò il postino e mi consegnò un telegramma e quel telegramma fu, perme, come una fucilata.Avevo vinto il concorso!C’erano venti posti per mille concorrenti e uno di quelli era mio; entro un paio disettimane avrei dovuto trasferirmi a Roma. Panico. Rifiuto totale. Giravo per casa gridando:“Non me ne importa niente del cinema, non andrò mai in quella città spaventosa!”A quel punto della mia vita, infatti, l’idea di passare l’inverno sdraiata su un divano, aleggere, mi sembrava la migliore delle opzioni; sotto il mio peso, lentamente i cusciniavrebbero iniziato a cedere, le molle a deformarsi in modo stabile e piano piano queldivano, che ancora possiedo, avrebbe accolto nella sua materia il peso della mia, così comela cenere accolse e pietrificò i corpi dell’infelice popolazione di Pompei.Libro dopo libro, anch’io, un giorno, avrei potuto appoggiarmi su un gomito e dire“Conosci te stesso”, perché cominciava a essermi chiaro che la via dei libri mi avrebbecondotto in quella direzione.Proprio in quei giorni ero presa dalla lettura di Oblomov e mi stavo convincendo che ilsuo modo di affrontare la vita fosse in assoluto il migliore.Per l’occasione, la nonna mi comprò un maglione nuovo, una camicia e dei pantaloni, limise, assieme ad altri, in una v<strong>ali</strong>gia di mio nonno – quelle grandi v<strong>ali</strong>gie rigide di cuoionaturale che ancora si vedono nei lm d’epoca – comprò il biglietto, preparò due panini emi caricò sul treno per Roma.Fino a che il mare non scomparve dai miei occhi, restai in piedi, immobile davanti alnestrino, come Ruben in La testa tra le nuvole. L’azzurro del mio maglione si confondevacon il colore di quell’immensa superficie illuminata dal sole.Quando passammo davanti al castello di Duino, una tta mi trasse il cuore. Proprio orache stavo cominciando a intuire qualcosa, proprio ora che, in quel luogo, una radice si stavaformando dentro di me, ero costretta a partire di nuovo verso un mondo sconosciuto epotenzialmente ostile.Roma era la Roma degli anni settanta, la dolce vita era svaporata e il suo posto era stato
preso dalle manifestazioni, dagli scontri, dalle spettr<strong>ali</strong> sirene che attraversavano la città digiorno e di notte.Ad attendermi nella metropoli tentacolare c’era mio padre.Seppure con sei anni di ritardo, avevo nalmente re<strong>ali</strong>zzato il mio sogno di andare avivere con lui.Anche nella sua vita, intanto, erano avvenuti dei cambiamenti. Era stato in Cina, conl’idea di potersi trasferire lì ma, quando aveva scoperto che, per poter avere dei rapporticon il gentil sesso, avrebbe dovuto prendere l’aereo e andare i ne settimana a Hong Kong,era tornato in It<strong>ali</strong>a, abbandonando anche lo studio del cinese. Aveva ormai 46 anni e lasua situazione si faceva ogni anno più precaria, così, un suo caro amico lo aiutò a trovareun posto come correttore di bozze. Dovette dunque arrendersi, a quel punto della sua vita,all’orrendo giogo del lavoro quotidiano.Il mio arrivo repentino e imprevisto – ebbe infatti un preavviso di soli dieci giorni –dovette essere per lui un fulmine a ciel sereno.Rispetto a sei anni prima però, c’era un vantaggio: ormai ero grande e non ci sarebbestato bisogno di occuparsi di me. Anzi, in fondo al suo cuore – e probabilmente neanchetanto in fondo – sperava che sarei stata io a occuparmi di lui. Nel suo scarno universoaettivo, il vuoto lasciato dalla sorella Marisa era sempre presente. Lui sperava che, comeBiancaneve, mi sarei messa a spazzare cantando, immersa in un mare di bolle e che avreipreparato manicaretti il cui profumo si sarebbe propagato no all’ingresso del palazzo, ioinvece speravo di trovare finalmente un padre.Ci deludemmo a vicenda.La sua casa, tanto per cambiare, era di nuovo in un seminterrato destinato a un unicoabitante e quindi piuttosto angusta; consisteva di una stanza da letto, un bagno, unaminuscola cucina e una specie di salottino; tutto era incredibilmente ordinato eincredibilmente sporco. La mia tendenza era opposta, preferivo vivere nel disordine ma inambienti puliti e già questo dunque ci situava in mondi incompatibili. Comprò per me unabrandina pieghevole e la sistemò nel salottino.Il suo sogno di avere una glia abile in cucina e desiderosa di viziarlo svanì nel corso delprimo mese; dopo anni di vita randagia, l’unica cosa che sapevo fare con un certo talentoera quella di aprire scatolette. Così continuò a essere un accanito frequentatore dirosticcerie, con l’unica dierenza che non mangiava più supplì e polpette da solo, ma consua figlia accanto.Ci vedevamo poco.Io uscivo all’alba per raggiungere Cinecittà e tornavo per la cena, lui a quell’ora era allavoro, almeno così mi diceva, e rientrava molto tardi. Dato che ormai soriva di insonnia,veniva nel salottino, accendeva la sua minuscola televisione e, fumando ininterrottamente,guardava film tutta la notte seduto ai piedi della mia brandina.Qualche volta, la domenica, andavamo insieme al ristorante, magari in un altroquartiere, al Flaminio, al Portuense, per simulare una gita fuori porta. Prima di quellenostre uscite, trovava sempre qualcosa da ridire sul mio abbigliamento. Secondo lui, infatti,
oltre che Biancaneve, avrei dovuto essere anche un’antesignana di Jessica Rabbit: calze arete, tacchi a spillo stratosferici, scollatura vertiginosa e passo felpato da pantera.Per sua sfortuna, io invece ho sempre preferito vestirmi come un atleta della nazionalececoslovacca in trasferta e non di rado capitava che il cameriere, facendo avvampare dirabbia mio padre, chiedesse: “Il giovanotto, cosa prende?”Avevo già allora il 42 di piede e quando andavo nei negozi e chiedevo delle scarpe,ricevevo sempre due tipi di risposta: “È per un regalo?” o “La signorina è tedesca?” Come senon bastasse, ho sempre avuto mani enormi e braccia lunghissime, spalle molto larghe, suoidoni genetici, oltre alla totale assenza di una qualsiasi traccia di vitino di vespa.Né lo spirito né il corpo di Jessica Rabbit mi sono mai appartenuti, ho sempre predilettouna femminilità nascosta, piuttosto che esibita. La penuria di spasimanti, per la gioia di mianonna, non è mai stato un problema, ho avuto piuttosto, no a un certo punto della miavita, il problema contrario.“Magari un altro paio di scarpe, eh…?” diceva mio padre, guardandomi i piedi,perplesso, e io, come tutta risposta, scrollavo le spalle, indifferente.Tanto, però, lui aveva le idee chiare su come io dovessi vestirmi e comportarmi,altrettanto io avevo poche idee e confuse su come dovesse essere un padre; e non ebbineppure modo di chiarirle perché, nonostante il passare degli anni, lui continuò a essereprigioniero del suo solipsismo. Non mi chiedeva niente, non mi vedeva, non mi parlava dicose che potessero in qualche modo riguardarmi. Se, durante quei pranzi, invece di suafiglia, avesse avuto davanti un cartello con due occhi dipinti, sarebbe stata la stessa identicacosa.Nei momenti vuoti, magari mentre tagliava l’abbacchio, cercavo di insinuarmi nei suoiripetitivi monologhi, parlandogli della scuola, dei miei compagni, dei miei sogni; appenachiudevo bocca, però, lui riprendeva implacabile il suo disco nel punto dove l’avevainterrotto. Come un giradischi rotto, amava far ripartire i suoi 33 giri – come li chiamavamoio e mio fratello – sugli stessi argomenti. Quello che era ancora in auge, allora, era il longplaying che raccontava delle scorrazzate di Tamerlano e Gengis Khan tra la Cina e le steppedell’Asia centrale. Un altro disco che rimetteva in continuazione riguardava il mondo degliideogrammi cinesi, a suo avviso capaci di interpretare la realtà in modo molto più profondodelle nostre 21 lettere. Seguiva poi quello sulla politica it<strong>ali</strong>ana, il cui refrain più ripetutoera: “Una banda di pagliacci.” C’erano poi alcuni 45 giri, tra i qu<strong>ali</strong> spiccava quello cheriguardava il problema delle tigri in India e dell’orso marsicano in Abruzzo. Com’erapossibile infatti, ripeteva, che nessuno avesse il coraggio di dire che bisognava prendere inmano il fucile e sterminarli, invece di spendere soldi per proteggerli?Con il tempo ho capito che ogni conversazione con lui non era molto diversa dalcamminare su un terreno minato: per non scatenare uno dei suoi ossessivi ritornelli,bisognava stare attenti a dove si mettevano i piedi. Prima di aprire bocca, quindi, dovevoimmaginare tutti i possibili collegamenti, logici e illogici, che quella mia frase avrebbepotuto mettere in moto nella sua mente e agire di conseguenza. Se intuivo che una miaparola era in grado di scatenare il disco, cambiavo bruscamente direzione.
Ero troppo giovane, troppo inesperta – troppo desiderosa di avere almeno uno straccio dipadre – per rendermi conto che lui era completamente alcolizzato e che, come tutte lepersone prigioniere di una dipendenza, era assolutamente incapace di accorgersi di chi glistava accanto. I gli hanno un bisogno assoluto di ammirare i genitori, di esserneorgogliosi; sono disposti ad aggrapparsi a qualsiasi cosa pur di immaginare in loro qualcosadi degno e di grande e, quando questo non avviene, un’ombra di umiliazione e di degrado sistende sulla loro vita, come ho scritto in una delle pagine che amo di più in Ascolta la miavoce.Non ricordo quanto sia durata questa nostra convivenza; so solo che, a un certo punto,trovai un’altra sistemazione – una stanza in atto in un fatiscente appartamento abitatoda studenti fuori sede e mi trasferii lì con le mie poche cose.Gli studi al Centro sperimentale erano purtroppo confusi e inquinati da un livelloasssiante di ideologia. Nella realtà, il corso di regia non esisteva più perché il regista eraconsiderato ormai come il frutto malato di una società borghese e individu<strong>ali</strong>sta. Con miagrande sorpresa, scoprii che la scuola che stavo frequentando avrebbe rilasciato, alla nedei tre anni, il più democratico e proletario titolo di “Addetto alle comunicazioniaudiovisive”. Se l’avessi saputo prima, avrei frequentato direttamente la Scuola RadioElettra!Così, una volta conseguito il diploma, ho preferito non ritirare il modulo cartaceo;sarebbe stato ridicolo appendere in casa un titolo del genere quando non ero in grado dimettere neppure uno spinotto a un videoregistratore. Non esistevano più, in quegli anni, icorsi individu<strong>ali</strong> – di montaggio, fotograa, scenograa, recitazione –, perché in un mondodavvero democratico tutti dovevano sapere fare tutto e nessuno doveva primeggiare suglialtri.Naturalmente, le storie che avrei voluto raccontare non interessavano a nessuno. Gliargomenti più in voga erano: le condizioni dei metalmeccanici, il movimento di lottademocratica delle prostitute e le dittature del <strong>Su</strong>damerica. Perciò, non essendo ferrata innessuno di questi temi, al momento di scegliere il saggio di esame al secondo anno, mi uniia un gruppo di studenti, per lo più stranieri, che stava mettendo in piedi un laboratorio dicinema di animazione.La mente del gruppo era un ragazzo, o meglio un giovane uomo, dato che aveva superatoi trent’anni, che veniva dall’Argentina. In breve diventammo molto amici. Aveva unacompagna it<strong>ali</strong>ana e scriveva poesie, io andavo spesso a casa loro e lì stavo no a tardi adascoltare i suoi versi. Enrique – che poi è tornato in Argentina e non è diventato regista mascrittore – è stato la mia porta sul grande e meraviglioso universo della letteratura latinoamericana.Le quattro ore che, ogni giorno, passavo sui mezzi, per raggiungere e tornare daCinecittà, le dedicavo tutte alla lettura dei romanzi. Seduta o in piedi, aggrappata aimprobabili appigli, sbattuta avanti e indietro dalle improvvise frenate, schiacciata tracorpulente massaie e le mani morte degli impotenti, continuavo imperterrita a vivere, senzamai distrarmi, le avventure dei miei eroi.Nei ne settimana, con Enrique e altri squattrinati compagni fuori sede, battevamo in
modo instancabile tutti i cineclub della capitale. Per il cinema di qu<strong>ali</strong>tà, quelli furono annidavvero straordinari: Wim Wenders, Fassbinder, Tarkovskij, Truaut; ogni serata era unsusseguirsi di emozioni, di intuizioni, di nuove aperture ment<strong>ali</strong>. Tutta quella ricchezza cimetteva in uno stato di felice eccitazione, facendoci dimenticare per alcune ore il clima diterrore in cui era sprofondato il paese.Il giorno in cui morì Giorgiana Masi, a Ponte Garibaldi, ero vicinissima al luogo deldelitto; non stavo manifestando, ma semplicemente tornando da una visita medica. Ricordole cariche, i lacrimogeni, gli spari, la fuga in un bar un attimo prima che le saracineschevenissero abbassate.Venni a sapere del rapimento di Aldo Moro appena arrivai al Centro sperimentale. Lelezioni erano state annullate e io mi sedetti sui gradini d’ingresso con la testa tra le mani.Ero convinta che, da lì in poche ore, ci sarebbe stato un colpo di stato e tutti noi avremmodovuto fuggire, mettendoci in salvo da qualche parte.Mi rammaricai di essere uscita di casa con gli zoccoli, non lo facevo mai; anche il giornodel terremoto avevo delle infradito ai piedi. Così, su quei gradini, pensai che il titolo delfilm della mia vita potesse essere Una fuga in ciabatte.Nel frattempo, avevo cambiato diverse volte sistemazione, intervallandole conmomentanee soste nel seminterrato. Il periodo più lungo lo trascorsi in una specie dicomune pazzoide. Vivevamo aastellati gli uni sugli altri, in una promiscuità poeticamenterivoluzionaria, sotto i tetti spioventi di una casa del centro storico. La sotta era priva diabitabilità e, quando pioveva forte, dovevamo correre con le bacinelle dappertutto,mettendo delle plastiche sul letto, sopra le coperte; l’acqua faceva plic plic, rimbalzandosulla superficie liscia, proprio mentre tentavi di addormentarti.Avevamo un unico minuscolo gabinetto vicino le scale e un’altrettanto minuscola cucina.Tra il fornello e il lavello, era incastrata una vasca da bagno, di quelle sedute, che pensoesistano ormai soltanto nei negozi di antiquariato. Uno di noi cucinava, mentre l’altrofaceva il bagno senza alcun problema di pudore.Ero nalmente riuscita a portare a Roma la mia adorata cagnolina Bella, che si trovò acondividere la casa con un altro cane, una sorta di spinoncino nero con il quale, perfortuna, andò subito d’accordo. Penso che, oggi, ci avrebbero deniti dei punkabestia, ma aquei tempi eravamo soltanto degli eccentrici abitatori del nostro tempo.In quella casa, sdraiata sotto il telo di plastica, lessi per la prima volta Delitto e castigo.Terminata la lettura, venni colta da una febbre altissima, priva di qualsiasi sintomo. L’unicamalattia di cui soffrivo erano le parole che avevo appena letto.Il più vecchio tra noi aveva già quarant’anni e a me sembrava più vecchio diMatusalemme. Era stato un militante di Potere operaio, coinvolto credo anche in qualcheazione piuttosto grave, ma proveniva da una famiglia di antica nobiltà. Ricordo ancora ilsuo imbarazzo quando un giorno, per la strada, una signora anziana e di umile aspetto loabbracciò con devozione chiamandolo “marchese”. Malgrado la sua militanza, era un uomoranato e decadente. Amava molto l’opera e aveva insegnato al suo cane a cantare
seguendo le arie della Callas. Buon conoscitore della letteratura, aveva fatto del verso diBaudelaire, il faut être toujours ivre, il motto della sua vita. Era capace di bersi il dopobarbaappena sveglio, come fosse caè. La sua compagna era un’attrice, mentre io dividevo il miosottotetto con Maria, un’aspirante ballerina di Gallarate.Il motto del padrone di casa divenne anche quello di tutti noi.Eravamo sempre e completamente alterati da qualcosa. Per questo il giorno delrapimento Moro arrivai a Cinecittà con gli zoccoli.Il ricordo di quegli anni è di una grande – ma non triste – confusione. Vivevamo inun’assoluta e allegra anarchia, totalmente priva di qualsiasi rapporto con la realtà.Recitavamo poesie, inventavamo recite, ci travestivamo, giravamo la notte con i nostri caniper le strade vuote, intonando pezzi di opera.Quando ripenso a quegli anni di confusa alterazione, li vedo come la prima, e unica,vacanza da me stessa che mi sono concessa nella vita. Con un colpo di spugna, avevocancellato il mio doloroso passato; sul futuro non mi facevo più domande. Roma, con la suamollezza tentacolare, con l’infamia della sua bellezza trasandata, con il suo vivi e lasciavivere, era l’antidoto alla forsennata durezza della mia infanzia. Le viti, le gabbie, lecorazze si stavano allentando. Non sapevo perché, non sapevo neppure dare un giudizio sulquel mutamento. Avevo semplicemente smesso di interrogarmi. Vivevo e basta, e questo erasufficiente per riprendere il fiato.Se Kafka si fosse trasferito a Napoli per qualche anno, probabilmente avrebbe vissuto piùa lungo e più felicemente.In tempi di glob<strong>ali</strong>zzazione, sembra ridicolo pensare all’inusso dei luoghi sulle persone,sugli artisti e sulla loro opera, eppure è così: ciò che sta fuori determina in modo nonindifferente ciò che sta dentro.Comunque, un giorno, in quel bailamme comparve una persona che sapevo essere unnoto esoterista. Veniva spesso a pranzo da noi perché gestiva una libreria speci<strong>ali</strong>zzatapoco distante. Amava molto parlare di alchimia e di kabbalà e le sue conversazioni miintrodussero nei misteri di Praga.Un pomeriggio di relativa quiete mi chiamò al suo anco – parlava sempre sottovoce – emi chiese la mia data di nascita. Il giorno dopo ricomparve:“Ti devo parlare…”Vagamente inquieta, gli andai vicino e mi sedetti al suo anco. Mostrandomi il disegnodel mio quadro astrale, chiese: “Ti dice qualcosa?”Scossi la testa, non mi diceva nulla.Continuò a parlare per un po’, usando termini tecnici per me astrusi – fuoco, terra, acqua,cuspidi, case, medio cielo, opposizioni, triangolazioni – poi, a un certo punto, sorò con ildito una parte del disegno e osservò:“Vedi, è proprio qui che accade…”“Accade che cosa?” domandai perplessa.
“Tra i 35 e i 40 anni la tua vita verrà investita da un brusco e potente cambiamento.”“Morirò…?”“No, diventerai un’artista famosa.”Quella previsione mi mise in uno stato di grande agitazione. Frequentavo, è vero, lascuola per addetti alle comunicazioni audiovisive, ma quella via non mi sembrava in alcunmodo collegata a una dimensione molto più alta quale consideravo quella dell’arte. Nellamia mente ancora ingenua, l’artista per eccellenza era rimasto il musicista, così la primacosa che dissi, con tono desolato, fu: “Ma se non so suonare neppure uno strumento!” e poi,pensando alla mia compagna di camera, aggiunsi: “E non so neanche ballare…”Il mio interlocutore rimase immobile come una sfinge.“Dimmi almeno qualcos’altro,” lo incalzai, scioccata da quel vaticinio, “dammi un segno,una direzione in cui poter andare…”La sfinge socchiuse gli occhi; intravedevo le pupille baluginare come spilli.“Non posso,” mi rispose. “Il cammino è il tuo. Quando sarà giunto il momento giusto,capirai.”
29.Ormai il dardo era lanciato e il veleno era entrato nella mia carne. Le stelle dicevano che,davanti a me, c’era un grande destino. Io non capivo niente di stelle e la bassissima stimache avevo di me stessa, a parte le disgrazie, non mi aveva fatto immaginare niente digrande. Tuttavia quelle scarne parole mi avevano messo in uno stato di grandeinquietudine.L’idea che mi avesse preso in giro non mi sorò neppure per un istante, non era unburlone e poi, perché mai avrebbe dovuto farlo? Poteva piuttosto aver preso un granchio.Sì, forse si trattava di un granchio; per questo, con le sue minuscole chele, quell’ideacontinuò a tormentarmi per giorni, per mesi.Non siamo più abituati a provare stupore davanti alla metamorfosi di una farfalla.Accecati dalla straordinarietà dell’elettronica, questo incredibile mutamento ci sembraormai solo il povero bagaglio di una vecchia maestra a corto di argomenti. Dal bruco nascela farfalla e la farfalla è innitamente più bella del bruco. Peccato non fermarsi a rietteresul tempo innito e sulla complessità che questo cambiamento comporta in ogni sua fase:materia che si forma, si disfa, si trasforma; parti si liquefanno e altre si solidicano. Ciò cheesce, alla ne, non sembra molto diverso dal risultato di un gioco di prestigio: il fazzoletto èentrato nel cilindro del mago e ne è uscito un coniglietto. Voilà!Ripercorrendo in queste pagine tutte le strade che mi hanno portata a scoprire lascrittura, mi rendo conto che il processo non è stato poi molto diverso da quello cheaccompagna le trasformazioni dei lepidotteri: ricambio di pelli, costruzione di serici bozzoli,visceri che si liquefanno nella penombra della cris<strong>ali</strong>de e nuove parti che iniziano aformarsi, antenne che spuntano, enormi <strong>ali</strong> raccolte e bagnate, ancora incapaci di aprirsi espiccare il volo.Senza essermene resa conto, nel corso della mia complicatissima vita avevo attraversatotutte queste fasi. In modo imprevisto, la profezia astrologica aveva squarciato la cris<strong>ali</strong>de e,con la cris<strong>ali</strong>de, il velo che fino ad allora era stato davanti ai miei occhi.Il corpo era formato, ma le <strong>ali</strong> erano ancora appesantite dall’umidità del bozzolo.Prigioniera di quella momentanea immobilità, avevo dalla mia parte il potere delleantenne.Erano loro il grande dono della mia vita; erano loro a permettermi di vedere ciò che nonsi vedeva, di sentire ciò che era impossibile percepire.Brusca ne della vacanza, rientro tra i ranghi della soerenza. A un tratto sapevo chedovevo mettermi alla ricerca, non sapevo di cosa e non sapevo dove. Sapevo soltanto chedovevo muovermi.
Il furore divenne all’improvviso il motore dei miei giorni. Ovunque fossi, qualsiasi cosafacessi, mi sentivo fuori posto. C’era un altrove da qualche parte e quell’altrove, ero certa,sarebbe stata la mia terra, ma non intravedevo alcuna indicazione, alcun segno sulladirezione verso cui muovermi.Ero come una volpe dalla coda infuocata, correvo veloce per liberarmi dall’incendio; mirotolavo nella sabbia, mi tuavo nei umi, ma l’incendio continuava a inseguirmi. Il suobagliore mi teneva sveglia anche di notte. Non c’era più sonno per me, non c’era più riposo.Le mie notti tornarono a essere quelle degli scheletri, dei fantasmi, delle canocchie.Nel buio dei miei vent’anni, però, non erano più loro a comparire – in fondo sarebberostati dei vecchi e cari amici – ma l’immagine molto più sobria e spaventosa del nulla che, inquieto silenzio, divorava le esistenze. Sentivo il suo vortice opaco nascosto in ogni istante,vedevo la vita intorno come una commedia recitata piuttosto male; alla ne nessunoavrebbe applaudito e dunque non si capiva la ragione di tanto movimento.La morte era la maestra di ogni istante e questa per noi uomini, pensavo – e pensotutt’ora – è l’unica certezza.Eppure…Eppure cominciavo a rendermi conto che la realtà, a un tratto, era capace di sollevare ilvelo – una mimosa, con la sua luce solare, può esplodere davanti a un muro di periferia –mostrando ai nostri occhi increduli un altro livello. Quello della sorpresa, del ato cherimane sospeso.Sì, c’è dell’altro, tra le sue pieghe la quotidianità nasconde tesori; l’artista è il minatore, ècolui che li cerca. È lui che deve calarsi nelle profondità della terra; lui che deve perdersi trai cunicoli, annaspare, disperarsi e poi prorompere nell’Ah! della scoperta. È sempre lui,l’artista, che deve ris<strong>ali</strong>re con la gemma in mano, orendo la visione del suo splendore acoloro che sono rimasti in superficie.Accompagnata dal mio fuoco, quell’estate tornai sul Carso e, a una sagra, incontraiMarko. Aveva un anno meno di me e studiava regia cinematograca alla scuola diZagabria. Stesso mondo, stesse passioni, stesso furore.Ci siamo riconosciuti in un istante e diventati compagni inseparabili di percorso. Moltedelle cose che racconto in Anima Mundi sono ispirate alla nostra amicizia. Trascorrevamoore al bar, a osservare i camion di bestiame che, con il loro carico dolente, si avviavano almacello. Restavamo lì a inalare i gas tossici di quella lunga sequela di Tir provenientidall’Est Europa che, ogni giorno, attraversava l’arteria principale del paese. Frequentavamotutte le osmizze. Tutte le alture del Carso, l’Orsario, il San Leonardo, erano nostre.Con le braci dentro, camminavamo senza sosta, il mistero dell’arte era il centro di tutti inostri discorsi. Varcavamo il conne per andare in pellegrinaggio alla casa di Kosovel; inquella casa modesta, in cui era ancora presente l’ombra della morte, recitavamo la nostrapoesia preferita:Io sono l’arco spezzatodi un cerchio.
Sono la figura infrantadi una statua.È l’opinione taciutadi qualcuno.Io sono la forzache l’asprezza ha schiantato.C’era una grande frattura, infatti, in noi e tutto quel nostro movimento non era altro cheun tentativo di ricomporla.Eravamo cacciatori di epifanie.Noi sapevamo che il velo poteva sollevarsi, noi volevamo che si sollevasse, nelle nostrelunghe notti insonni attendevamo che cadesse.Ma se i morti infinitamente dovessero mai destareun simbolo in noi,vedi che forse indicherebbero i penduli amentidei noccioli spogli, oppurela pioggia che cade su terra scura a primavera.E noi che pensiamo la felicitàCome un’ascesa, ne avremmo l’emozioneQuasi sconcertanteDi quando cosa ch’è felice, cade.Dalle torrette di conne alle scogliere di Duino, era quello il nostro mondo. Il furoredisperato di Roma, lassù si trasformava in qualcos’altro. Inseguiti dal vento, lanciati controil vento, abbandonati al vento. Vento, nostra cura, nostra placenta, nostro nutrimento,nostra visione. Vento, debolezza perversa del nostro sistema nervoso.Dalle grotte degli Ur<strong>ali</strong>, la bora portava giù per noi, nascoste tra i suoi refoli, delleparole; le buttava su un tavolo alla rinfusa come bigiotteria di poco conto. Ce n’erano init<strong>ali</strong>ano e in sloveno, un po’ per me e un po’ per lui. Ci mettevamo a rovistare lì in mezzo,quei frammenti erano pezzi smarriti di un puzzle, muovevamo le mani con tenacia, conansia. Sapevamo che lì era nascosta la parola capace di essere, a un tempo, apertura efondamento, solida chiave di volta.Anche Marko è diventato uno scrittore. Quando ci vediamo al caè, è come se non fossepassato neppure un giorno dai tempi della nostra giovinezza. Parliamo di poesia e di arte,come fossero cose vere e non progetti di marketing.Pur avendo un carattere allegro e ottimista, amante dei piaceri della vita, non possonegare che la cifra principale dei miei giorni sia stata la soerenza. Soerenza umana,prima di tutto, poi creativa.Che invidia provo per quelle persone che ti dicono: “Vorrei scrivere un romanzo” e poi,
davanti a una tazza di caffè, ti spiattellano tutta la trama!Io ho sempre vissuto nella totale incertezza della mia creatività. Il fatto di aver pubblicatoventi libri non cambia di un millimetro questa mia condizione che è fatta di incertezza,inquietudine, perplessità costante sulla giusta strada da prendere.Prima di scrivere e di capire che la direzione della profezia astrale era proprio questa,passai un periodo di dolore assoluto. Sentivo un’energia spaventosa che si stavaaccumulando alle mie spalle, ma non sapevo darle un nome, un volto. Nella solitudine dellanotte, spesso tornava il timore che non di arte si trattasse, ma di pazzia. Scricchiolii, sibili,piccoli assestamenti: segn<strong>ali</strong> che la diga, sotto la pressione dell’invaso, stava cominciando acedere.Alla fine, una mattina di maggio, mentre attraversavo a piedi ponte Sisto, la diga cedette.È dicile spiegare cosa successe. Posso dire solo questo – a un tratto le parole cominciaronoa fluire nella mia testa.Corsi in una tabaccheria a largo dei Baullari, comprai un quadernetto con la copertinaarancione e una penna biro, poi, seduta su un gradino poco distante, cominciai a scrivere.Una delle mie prime frasi fu: “Sono un’antenna con i fili scoperti.”Sono passati trent’anni, e non ho più smesso.
30.Da trent’anni tengo un diario, perché il diario è il preludio, la miniera, lo scavonecessario per affrontare qualsiasi altra forma di scrittura.Non so dire quanto tempo sia passato tra quel momento su Ponte Sisto e la stesura delprimo romanzo. Ricordo, nel frattempo, di avere scritto delle poesie ma, già scrivendole, mirendevo conto che si trattava soltanto di una stazione di passaggio. La mia destinazione eraun’altra.So però che era ancora di maggio e avevo 23 anni.Avevo trascorso una settimana a Vienna con il mio innamorato di allora e l’ultima seraeravamo andati a vedere Il auto magico. Mentre la Regina della Notte cantava, qualcosaavvenne nella mia testa. La mattina seguente, dopo averlo accompagnato all’aeroporto –veniva da un paese dell’Estremo Oriente – mi trovai sola e senza nessuna voglia di tornarea casa.Vidi allora degli autobus in movimento, davanti a me e, tra tutti, uno che aveva perdestinazione Illmitz. Quel nome mi piacque – Illmitz, limite – e vi s<strong>ali</strong>i sopra.Il paese, circondato da bassi laghi paludosi, si trovava ai margini della pianuraungherese, sui tetti nidicavano le cicogne. Mi sistemai in una pensione, aprii il quadernoche avevo con me e cominciai a scrivere. Scrissi ininterrottamente per venti giorni e,quando arrivai all’ultima pagina, capii di avere in mano un romanzo.Tornata a Trieste, lo comunicai a mia nonna: “Ho scritto un romanzo,” dissi, con il tonocon cui avrei potuto dire: “Ho combinato un pasticcio.”Avevo fatto il possibile per resistere, cercando di distrarre in tutti i modi la miaattenzione da quel progetto ma, alla ne, quella forza straordinaria era riuscita a vincereogni mia resistenza.La nonna lo lesse. “Sarò forse parziale, ma a me sembra bellissimo,” commentò. Toccòpoi alla sua amica Maria, che glielo restituì dicendo: “Meraviglioso!”A quel punto, in quell’aettuoso triumvirato aettivo senile che seguiva i miei passi,giunse il momento di passarlo alla zia Letizia.La zia Letizia!Non era forse a causa sua che, in quegli anni, avevo scalciato tenacemente contro ildemone che bussava alla mia porta? Provavo imbarazzo alla stessa idea di scrivere, avevola sensazione di saltare su un cavallo già domato da altri ngendo che fosse selvaggio.Anche il padre della zia Letizia, infatti, aveva scritto dei libri nel tempo libero dal lavoro.Nessun editore però li aveva ritenuti degni di pubblicazione e così alla ne si era dovutoarrendere e li aveva stampati a sue spese. Per non confondere i due piani della sua vita,
scelse uno pseudonimo.Italo Svevo anziché Ettore Schmitz.Per questo mi vergognavo a scrivere, mi sembrava ridicolo, se non impossibile, che nellastessa famiglia convivessero due scrittori. Inoltre, in un paese malato di familismo, mipareva anche una cosa di pessimo gusto, come a voler saltare sul carro di chi ha già vinto,farsi illuminare da riflettori già accesi per altri.Comunque, anche la zia Letizia lesse il libro e me lo restituì dicendo: “Hai proprio un beltalento!”Lo feci poi leggere, a Roma, alla mia amica Irene, fedelissima e instancabileaccompagnatrice di quegli anni di tormento. Posso dire che, grazie alla sua aettuosa eaettiva presenza, sono riuscita a compiere il grande salto: senza qualcuno, infatti, che titenga saldamente per mano come un bambino, è impossibile camminare a lungo sull’orlodel baratro. Anche a lei piacque molto.Mia nonna mi disse allora che, se davvero ero una scrittrice, dovevo frequentare altriscrittori e così mi portò dall’unico scrittore che conosceva. Giorgio Voghera.Voghera trascorreva la maggior parte delle mattine al Caè San Marco contornato daun’allegra compagnia. Tra i fedelissimi, la cugina Alma Morpurgo e Piero Kern. Il caè eramolto diverso da quello attuale, risorto dopo il restauro; ogni cosa era polverosa, cadente,con vassoietti di inox in mano e le camicie ornate di aloni di sudore, i cameriericiabattavano avanti e indietro per il locale.Gli avventori avevano il posto sso e quello di Voghera era nell’angolo in fondo a destra,una postazione ormai scomparsa. Si mormorava che proprio Giorgio Voghera fosse l’autored i Il segreto, un volume uscito da Einaudi negli anni sessanta rmato da un fantomatico“Anonimo Triestino”. Lui negava strenuamente, sostenendo che fosse in realtà un’opera delpadre matematico che aveva sbirciato tra i suoi diari di ragazzo. Comunque, chiunque fossel’autore, io avevo letto il libro e lo avevo amato moltissimo; non potevo non riconoscermiin quel bambino perennemente esitante, sempre assorto nei suoi pensieri.E poi, con Voghera, condividevo la passione per le scienze natur<strong>ali</strong>. Negli anni trascorsiin kibbutz, aveva studiato a lungo il comportamento delle galline e discutevamo a lungo diquello. L’etologia degli anim<strong>ali</strong> e quella degli uomini erano spesso al centro della nostraconversazione. Non eravamo mai soli ma sempre contornati da un cerchio di persone chemutava nel corso della mattina. C’era così il momento in cui si risolvevano insieme il rebuso la sciarada che Il Piccolo proponeva quel giorno e quello in cui si commentavano inecrologi, la frazione sospesa del witz o la discussione sull’ultimo libro di Singer e sullateoria di Konrad Lorenz riguardo ai cani. Spesso la cugina Alma declamava i suoi ultimiversi e lo squilibrato di turno si aacciava nel consesso, ponendo domande a cui eraimpossibile rispondere. Voghera, con la sua barba sempre mal rasata e le sue magliettecosparse di macchie, ascoltava tutti tentennando lievemente il capo e dava a tutti unarisposta come fosse un oracolo.Io ero l’unica persona giovane della compagnia ma non provavo alcun disagio perché, nda bambina, la mia felicità era stata vivere accanto alle persone anziane.
Quell’angolo del Caè San Marco era l’ultimo lembo di una cultura europea che si stavaormai spegnendo. Non c’erano i computer nelle case e, nelle vite, ancora era contemplatala presenza dell’ombra. Il mondo della volgarità, del consumo, del ne che giustica imezzi, del protagonismo narcisista sparso ovunque, delle luci sempre accese e mai in gradodi illuminare per davvero, della manipolazione planetaria delle menti, dell’informazionetrasformata in sapere, era di là da venire. Soltanto mia nonna, a un certo punto, avevacominciato a dire: “Sai, sono felice di morire perché il mondo che vedo avanzare non mipiace per niente.”Quando lei si ammalò, non andai più la mattina al Caè San Marco, perché nei mieibrevi soggiorni a Trieste, tutte le mie energie venivano assorbite dalla cura della nonna. Miè dispiaciuto molto perché Giorgio Voghera, con i suoi libri e con la sua persona, è stato unodei compagni importanti della mia avventura.Anche lui aveva letto il mio libro e lo aveva molto amato. Di sua iniziativa, l’avevaspedito all’Adelphi perché era stato amico di Bobi Bazlen e lo era ancora di Luciano Foa.Fu proprio Foa in persona, a ricevermi, a Milano. “Il libro è interessante,” mi disse,gentile, “ma noi, purtroppo pubblichiamo solo autori morti.”Non riuscii a salutare Voghera, prima della sua morte, ma penso che, se da qualche parteè, in qualche altro caè, in un’altra dimensione, con la sua testa eternamente tentennante,sta dicendo ai suoi compagni: “Ghe vavevo dito che la putela la iera piena di talento…”Anche la zia Letizia, nel frattempo, si era data da fare e aveva inviato il libro con unalettera di accompagnamento a tutti gli editori di sua conoscenza. “Mi pare che mia nipoteabbia un certo talento per la scrittura,” aveva scritto. Ma tutti le risposero picche,scambiando quelle righe per il frutto di un compassionevole cedimento senile. Anch’io, comesuo padre, secondo loro, avrei dovuto pagare per pubblicare i miei libri.Internet non era ancora realtà, così come i contatti on line, le agenzie letterarie, sorte unpo’ ovunque come funghi negli anni ottanta e novanta, e tutto il glamour che oggi contornail mondo delle lettere. Cercare un editore voleva semplicemente dire andare all’uciopostale, spedire i pacchi e tornare, dopo qualche mese, a ritirarli.L’impiegata dell’ucio sotto casa, una signora giovialmente formosa, dopo qualche annosi era appassionata alle mie sorti. “Novità?” mi chiedeva con aetto materno non appenacomparivo allo sportello. Scuotevo sempre il capo. “No, nessuna.” <strong>Su</strong>l suo viso scendevaallora un afflitto sconforto.Chissà se ha potuto rendersi conto che la mittente di quei pacchi che, per otto anni, sonopassati tra le sue mani alla fine è diventata un’autrice letta da milioni di persone.Lo zio Ettore e io condividiamo lo stesso segno zodiacale – il Sagittario; il medesimoambito famigliare – l’ottusissima e geniale famiglia Veneziani; la città in cui siamo cresciuti– Trieste; i caparbi riuti degli editori; l’aetto di due persone – la zia Letizia e la nonnaElsa, che oltre a essere cresciuta nella stessa villa aveva condiviso per qualche tempo il suoesilio londinese; il fatto di essere dei corpi totalmente estranei alla cultura it<strong>ali</strong>ana; latomba di famiglia e il patrimonio genetico di due antenati – Abramo Moravia e Sara Levi.
La sua opera e la mia si sorano in diversi punti. Il cane Argo del suo racconto è lo stessocane Argo di Va’ dove ti porta il cuore, così come Augusta, la più giovane di casa Malfentidella Coscienza di Zeno, è ispirata alla madre della protagonista di Va’ dove ti porta il cuore.Anche nel rapporto verso la psican<strong>ali</strong>si, il nostro modo di arontarla si intreccia e sisviluppa in modo conseguente. Un giorno, quando sono a tavola, alla madre dellaprotagonista di Va’ dove ti porta il cuore spiegano che se qualcuno sogna degli spaghetti vuoldire che ha paura della morte perché gli spaghetti rappresentano i vermi che, dopo lamorte, divoreranno il suo corpo. Allora lei, continuando a mangiare, obietta serenamente:“E se sogno i maccheroni?”Ecco, questo era il rapporto che si intratteneva nella mia famiglia con la psican<strong>ali</strong>si,considerata più che altro un gioco bizzarro, una fonte innta di witz e di boutade, unmeraviglioso intrattenimento letterario ma mai, per nessuna ragione, una pratica v<strong>ali</strong>da.“Non è bene per un uomo,” ripeteva spesso lo zio, “mostrare come è fatto dentro.”Bruno, il fratello della mia bisnonna Dora, era stato a lungo in cura da Freud. Essendoomosessuale, la voce che a Vienna ci fosse un medico in grado di guarire quella che alloraveniva considerata una malattia era giunta no a Trieste e così lui aveva deciso di partireper la città austriaca.“Io ho aderito volentieri alla tua prima cura con il dottor Freud,” gli scrive il padreGioacchino, “pareva giovasse e non fu così, perché ne intraprendesti un’altra con un altrodottore, Groddeck, e poi un’altra con l’attuale, con che risultato? A che ti giovano codestecure nelle qu<strong>ali</strong> non si vede chiaro e di nessun vantaggioso risultato? Durano tanto a lungoe senza vederne nemmeno prossima la ne! Essa ti ha costato un capitale e se prosegui cosìte ne costerà un altro…”Era questo l’ambito in cui nacque il rapporto di Svevo, e di conseguenza anche il mio, neiconfronti dell’ingombrante presenza della psican<strong>ali</strong>si nel Novecento. “Se proprio neabbiamo bisogno,” disse un giorno James Joyce allo zio Ettore, “teniamoci la confessione.”La mia famiglia materna si trovò ad attraversare come una meteora l’epoca compresa trala metà dell’Ottocento e quella del Novecento e la loro apparizione sulla scena avvenne nelcuore della cultura di quel mondo variegato, complesso e profondo che era l’imperoaustroungarico.Grazie a una fortunata formula segreta scoperta da un trisavolo, verniciarono gli scadelle navi in tutto il mondo e, con la bulimia dei nouveaux riches, si abbeverarono a pienemani dell’arte e del pensiero del loro tempo. Musicisti, loso, scrittori e poeti sialternarono per anni sui divanetti di villa Veneziani. Adesso, vengono pubblicati libri, sitengono seminari su queste persone ma, allora, erano soltanto amici e conoscenti chevenivano a prendere il tè.Tra tutte le navi verniciate dalla mia famiglia, ci fu anche il Titanic e la mia bisnonnavenne così invitata con il marito al viaggio inaugurale, ma quando scoprì di essere incinta esoffrendo di relative nausee, rinunciò a partire.Forse per questo, grazie allo scampato pericolo dei miei avi, venni al mondo con dellegrandi orecchie aperte, pronte a captare i primi segni del naufragio.
31.La velocità di cambiamento della società si è riessa, inevitabilmente, anche nel mondoletterario e fare lo scrittore è diventato un mestiere come un altro; un mestiere in cuifurbizia, abilità e capacità di orirsi ai media spesso suppliscono la presenza di un verotalento.Premesso che, quando me ne sto in vacanza sulla spiaggia, sono profondamente grataall’autore di un libro avvincente e ben congegnato, e che quindi sono priva di qualsiasimor<strong>ali</strong>smo o intellettu<strong>ali</strong>smo del tipo “un libro è bello e di valore se ha pochi lettori” –bugia stratosferica perché tutti i grandi classici sono best seller e long seller –, non possonon domandarmi se un romanzo sia davvero solo questo. Una forma di purointrattenimento.Ricordo, qualche anno fa, il mio assoluto stupore davanti alle aermazioni di un altodirigente di una grande casa editrice, il quale, rispondendo ad alcune mie semplicidomande, esclamò: “Dimmi quanto vuoi. Ti pago la cifra che vuoi, ma sappi che per me, tuo un altro siete la stessa cosa. Ne trovo mille come te.”Io, che in un editore ho sempre cercato il rapporto umano e professionale e mai l’assegno,sono rimasta senza parole. Non mi ero mai accorta che ci fosse un legame così stretto tra ilmio lavoro e l’attività più antica del mondo. Quanto vuoi? Ti compro, ti vendo. E se nonvendi, mi sbarazzo di te, troverò presto un’altra, un altro in grado di sostituirti. Bastafermare la macchina e abbassare il finestrino.Appena esplode un best seller, si scatena la caccia al possibile emulo. Ricordo, dopo Va’dove ti porta il cuore, la continua uscita di libri che avevano la parola “cuore” nel titolo emagari anche delle nonne come protagoniste. E anche dopo Il cacciatore di aquiloni,splendido libro, la rincorsa infruttuosa di vari lanciatori di trottole, inseguitori di farfalle edi struggenti avventure incentrate su sventurati ragazzini mediorient<strong>ali</strong>.Naturalmente, nessuna di queste emulazioni ha mai raggiunto davvero il cuore e la mentedei lettori perché, quando questo avviene, è quasi sempre il frutto di un’alchimia misteriosae non dell’astuzia di un plot sorprendente o di un buon progetto di marketing.Certo il marketing può molto, come può molto la manipolazione selettiva dei programmitelevisivi ma, alla fine, si tratta nella maggior parte dei casi di fuochi fatui.In fondo le case editrici non dimostrano di avere un gran rispetto dei lettori se liconsiderano qualcosa di non molto diverso da una massa indistinta, facile da manipolare.Che i libri non siano altro che scarpe la cui buona qu<strong>ali</strong>tà può essere replicata, usando glistessi macchinari, per un tempo se non innito, almeno molto lungo, è l’idea ssapurtroppo di molti dirigenti dell’editoria. Un libro, invece, un bel libro, è qualcosa di moltopiù complesso, delicato e dicile da gestire. Non si fa a comando, come non lo si può
imporre a comando.Penso che molti, nell’ambiente, mi considerino una fallita perché, dopo i milioni di copiedi Va’ dove ti porta il cuore, non ho mai replicato un simile successo. Considererei fallimentoesattamente il contrario. Certo, avrei potuto fare non uno, ma dieci seguiti, scadendosempre in qu<strong>ali</strong>tà e in intensità, vendendo una scarpa dopo l’altra e, nite le scarpe, avreipotuto mettere sul mercato anche solo le scatole con il mio nome sopra. Ma non ho maipensato, neppure per un istante, che il ne ultimo della letteratura sia quello di far soldi.Ho sempre avuto un grande rispetto per l’intelligenza e la sensibilità dei miei lettori. Nonpolli da spennare, ma persone con le qu<strong>ali</strong> fare un tratto di viaggio insieme. Come hosempre avuto timore e tremore nei riguardi della mia vocazione, che non avrei mai potutotradire in nessun modo.Che cosa vuol dire scrivere, dunque?Pensando al talento come a un dono, non posso non immaginare la genetica come unadelle vie attraverso cui questo dono si può diondere. Abramo Moravia, l’antenato cheunisce lo zio Ettore a me, non era un intellettuale bensì un macellaio addetto alla shechitah,la macellazione rituale della comunità ebraica. Impugnando coltelli senza tacca, recideva dinetto con un unico abilissimo gesto l’esofago, la trachea e la giugulare dell’animale che, intal modo, perdeva subito conoscenza. Il compito seguente era quello di privarlo del sanguee di far assorbire dalla terra quello caduto, disperdendo nell’acqua quello rimasto nel corpo.La lama perfetta, la mano sicura, l’essere continuamente immerso nell’alternarsi dellavita e della morte – con un sentimento sospeso a metà tra il distacco e la compassione,unita alla certezza di compiere un atto che trascende nella sua potenza la nostracomprensione e il timore che ne consegue – sono caratteristiche che la macellazione e lascrittura condividono. Bisogna conoscere perfettamente l’anatomia e avere pietà, ma ènecessario anche fare in modo che questa pietà non faccia tremare la mano, rendendo iltaglio un inutile strazio.Scrivere è uno squartamento.Squartamento della propria vita, che a ogni istante soggiace a quella tirannia, e dellarealtà che compare sotto i nostri occhi. Ma, a differenza dallo squartamento nichilista, è unosquartamento che acquista un senso a ogni istante. Squarcio per far luce, non per averconferma delle tenebre.Lo zio Ettore ebbe la fortuna di morire prima che si compissero i grandi orrori nelNovecento. Nella sua vita di borghese apparentemente pacato, aveva percepito con luciditàgli scricchiolii di quel mondo no ad allora così solido. Io, che sono nata poco dopo l’orrore,ho saputo da subito che quegli scricchiolii si erano già trasformati in schianti.Scrivere vuol dire andare a fondo alle cose, con lucidità, crudeltà, senza farsi abbagliareda niente. Recidere con il coltello ogni ombra di grasso, ripulendo i tendini dai muscoli. Nonci deve essere nessun innamoramento per le “belle parole”, nessun ascolto per le sirene delnarcisismo che tentano di condurci altrove.Tutti i libri che ho scritto sono un viaggio profondo nel cuore dell’uomo – il continente
più complesso, ignoto e affascinate che ci è dato di esplorare.Tutti i miei libri attraversano l’oscurità, non per il compiacimento di farlo, ma perscoprire il punto in cui, a un tratto, il buio misteriosamente si può trasformare in luce.Tutti i miei libri perlustrano i territori dell’inquietudine e dello smarrimento perché, solonel momento in cui si sa di non avere una strada, si comincia davvero a cercarne una.Soltanto nel momento in cui si accetta l’inquietudine come dato fondante, si entra davveronell’umanità.Viviamo in tempi di semplicazione massicante, di conseguenza l’inquietudine è il piùreietto dei sentimenti. Puoi essere infelice, certo, anzi, lo devi essere, perché tutti gli oggettiche ti suggeriscono di comprare non sono altro che succedanei della felicità, mal’inquietudine non ti è concessa perché è uno stato che produce domande e le domanderichiedono risposte e, per avere risposte, bisogna mettersi in viaggio come Abramo e, allane del viaggio, magari puoi scoprire che non sono le cose a darti pace, ma la profonditàdei sentimenti che sgorgano dal tuo cuore.Ecco, credo che i libri esistano proprio per farci compagnia in questo viaggio, per darciconforto nell’asperità del percorso. Esistono e rimangono con noi perché l’uomo, prima diogni altra cosa, è memoria e la sua vita è la vita delle generazioni che lo hanno preceduto.Se non fossi convinta di questo, non sarei stata neppure un pomeriggio seduta alla miascrivania, se non credessi questo mai avrei sottoposto i miei giorni a questa severa tirannia.Già, perché, oltre che squartamento, la scrittura è anche perdita della salute estraordinario sacricio. So di essere fuori tempo massimo, praticamente un dinosauro,perché questi pensieri e questi discorsi sono già stati travolti dalla velocità iper-epidermicadi questi tempi. Ciononostante, continuo a resistere in questo pensiero caparbio. L’uomo habisogno della bellezza.Senza questa apertura, ciò che si spalanca davanti a noi è solo il mondo dell’homo hominislupus, delle barbarie. E la parola – la parola fondata, la parola fondante – è una delle formein cui si manifesta la bellezza, il legame inquietamente profondo che lega l’essere umanoalla sua fragilità.Così, mi torna in mente un sogno che ho fatto qualche anno fa. Mi trovo in una città tuttadi mattoni rossi che so essere Ferrara. È notte, il tempo antico, non ci sono macchine, fafreddo e cade una neve tta. A un tratto scorgo una porticina da cui escono luce e tepore,decido di entrare e comincio a scendere delle scale; sono strette, tortuose, faccio parecchierampe prima di giungere in una stanza piena di gente. È un forno, per questo è aperto dinotte e, per questo, dalla porta uscivano luce e calore. Ci sono molte persone con deigrembiuli bianchi indaarate intorno ai fuochi; nessuno sembra accorgersi di me nché unuomo all’improvviso mi raggiunge, mi mette in mano un vassoio di biscotti appena sfornatie mi dice: “Port<strong>ali</strong> in supercie!” I biscotti hanno una forma strana. Osservandoli meglio,mi accorgo che sono aleph, beit, ghimel – le prime lettere dell’alfabeto ebraico. Obbedisco e,appena fuori, sotto la neve, accade una cosa incredibile. I biscotti si trasformano in tanteminuscole fiammelle.
La speranza allora è questa, che in noi torni la nostalgia per parole capaci di ardere.
32.Molte delle persone di cui ho parlato in questo libro non sono più su questa terra.Il primo ad andarsene è stato mio padre. Con il tempo la sua vita era diventata semprepiù solitaria e bizzarra. Non avendo aderito al suo credo darwinista, mi sono occupata di luino all’ultimo nei pochi spazi che lui lasciava aperti. Finché ho vissuto a Roma, cenavamoinsieme con una certa regolarità, quando poi mi trasferii in campagna era lui ogni tanto avenirmi a trovare.Negli ultimi anni lavorava a Pomezia, che raggiungeva ogni mattina a bordo di unamacchina di terza mano, non più una spider. Quando, a sessantacinque anni, andò inpensione, venne da me per festeggiare. Gli regalai una pipa, per l’occasione, e ne fu felicecome un bambino; continuava a girarla tra le mani, ripetendo: “Non ho mai ricevuto unregalo in vita mia.”“Avrò un mucchio di vantaggi, adesso,” ripeteva. “Lo sconto al cinema, quello sui treni…la tessera ridotta per gli autobus.” Vedeva il periodo che gli si stava aprendo davanti comeun’età dell’oro.Tornato a Roma, si procurò la tessera dell’Atac Intera rete e cominciò a girare con gliautobus, dalla mattina alla sera. <strong>Ogni</strong> tanto mi chiamava: “È proprio un lusso, sai, venirscarrozzati tutto il giorno da un autista.” Spesso i miei amici da Roma si facevano vivi altelefono, dicendomi, di volta in volta: “Ho visto tua padre sulla Tiburtina… al Portuense…sulla Nomentana… a Prati… a piazza dei Cinquecento.” “Cosa faceva?” chiedevo allora.“Niente,” mi rispondevano, “camminava…”, “guardava fuori dal nestrino…”, “stavaseduto su una panchina”.A volte spariva totalmente dal radar, come le navi nel triangolo delle Bermuda. Staccavail telefono e, non avendo il cellulare, era impossibile da raggiungere.“Morirò a settant’anni, come mio padre,” ripeteva spesso, “ma può darsi anche che miuccida prima.”È stato lui a ispirarmi il solitario declino del professor Ancona, in Ascolta la mia voce.Non aveva mantenuto rapporti con gli amici di un tempo e penso che avesse archiviatoanche l’argomento “donne”. Stava sempre nei suoi pensieri, sempre più dicili da scrutare;non dimostrava aatto la sua età, sembrava più un bambino; si meravigliava, sorrideva perpiccole cose, come se vedesse per la prima volta ciò che lo circondava.Non credo abbia mai letto nessuno dei miei libri ma, quando ho avuto successo, eracontento di portare il mio stesso cognome. Più che il successo in sé, credo lo commuovesse ilfatto che, grazie ai miei diritti d’autore, in qualche modo fossi stata fedele al suo credo, cheera quello di fuggire, nché possibile, il posto di lavoro. “Non farti incastrare da nessuno,non farti inquadrare,” mi ripeteva sempre, “sono tutti mezze calzette.” Si riferiva aigiorn<strong>ali</strong>sti che, grazie al suo posto di correttore di bozze in un noto settimanale, conosceva
molto bene. Essendo un uomo colto, con interessi soprattutto in campo storico, inorridivaper gli innumerevoli errori di grammatica che gli toccava correggere.Quando nalmente, nel ’98, lo invitai a inaugurare la mia prima vera casa, in campagna,non si stancò di camminare avanti e indietro, ripetendo estasiato: “Ma qui è tuttostraordinariamente grande!” L’appartamento in cui visse gli ultimi anni era di appenaquindici metri quadrati, forse per questo i centossessanta della mia gli sembrarono unareggia. Dato che era stato sfrattato dal suo monolocale, avevo comprato per lui unappartamento accanto al mio, a Roma, ma non fece in tempo ad abitarlo.L’ultima volta, infatti, che i suoi passi risuonarono sul cotto del mio pavimento dicampagna fu nel ferragosto di quello stesso anno; aveva da poco compiuto i settant’anni eavevamo passato quella giornata insieme a mio fratello maggiore e alle sue figlie.Mentre lo accompagnavo alla macchina, improvvisamente si girò verso di me e mi disse:“Ti devo parlare presto, è una cosa importante.”Quella richiesta mi stupì, in quarant’anni anni non si era mai rivolto a me in quel modo.Di lì a qualche giorno sarei partita per una vacanza in montagna, così gli promisi chel’avrei chiamato al mio ritorno.Molte volte, negli ultimi anni, avevo immaginato la sua morte; ero quasi certa cheavrebbero trovato il suo corpo inerte in un deposito degli autobus, a ne corsa, oppureaosciato da giorni su una panchina, con i colombi che gli passeggiavano intorno. Sarebbestata una pietanza soprana per i giorn<strong>ali</strong>. “Muore barbone il padre della famosascrittrice”, “L’aveva abbandonato nella solitudine e nell’indigenza” e via dicendo, conchicche di questo genere.In realtà riuscì a fare molto meglio.Rientrata dalla montagna, lo chiamai come promesso, ma non rispose. Piuttosto normale,lo faceva spesso. Riprovai ancora il giorno dopo, a ore diverse e la situazione non cambiò.Al terzo giorno, con un sentire tutto viscerale, capii che era morto.Telefonai allora a un’amica a Roma – io ero a casa mia, in campagna – e le chiesi diandare a vedere se c’era la macchina in garage. C’era. Al citofono, però, non rispondeva.Così la pregai di chiamare i pompieri, poi telefonai a mia madre e dissi: “Credo che il papàse ne sia andato.” “Dimmelo con certezza,” mi rispose, “perché devo andare al cinema conle mie amiche.”Mentre stavo per s<strong>ali</strong>re in macchina per raggiungere la capitale, qualcuno mi chiamò,dicendo: “È morto, ma pare non di morte naturale. Probabilmente è stato ucciso durantequalche incontro erotico.” Ci poteva essere un banchetto più luculliano per lo spirito daiena che aleggia nei mass media? Quando ancora ero in viaggio, sull’autostrada, i titoli deitelegiorn<strong>ali</strong> infatti strillarono: “Trovato uomo nudo morto a casa della Tamaro.”Al mio arrivo a Roma, la ressa di giorn<strong>ali</strong>sti e telecamere sotto casa sua era così tta chela questura mi mandò a prendere con un’auto civetta a piazzale Clodio. “La scientica è giàsul posto e sta facendo tutti i rilievi,” mi dissero. “L’hanno trovato nudo, pieno di sangue,con una bottiglia di vino accanto e un tavolo sfasciato.”Pare che fosse presente pure una pistola sulla scena del delitto.
Scortata dagli agenti, superai la muraglia di ash e s<strong>ali</strong>i all’appartamento, dove trovai,con mia somma felicità, come magistrato di turno, Lucia, una delle mie amiche più care, chemi disse subito. “Non preoccuparti, è tutto nelle mie mani.”Entrai e vidi mio padre disteso di traverso sotto un telo bianco; praticamente occupavatutta la casa. C’erano molte persone nella stanza, vidi anche qualcuno che stava cercando diarrampicarsi sul balcone per fare la foto milionaria: la scrittrice di libri sentiment<strong>ali</strong> chesinghiozza davanti al padre morto durante un’orgia.Non sollevai il telo perché la mia amica aveva già fatto il riconoscimento, così chiesi distare un po’ sola con lui. Mi misi in seizan accanto a lui e lo guardai. Soltanto una mano e isuoi capelli sporgevano dal lenzuolo: capelli ancora neri, sottili, da bambino, la manoidentica alla mia, soltanto un po’ più grande.Alzando gli occhi, vidi la spina del telefono staccata dal muro e capii che era cadutomentre stava cercando di raggiungere l’apparecchio per chiedere aiuto.Non lontano dal suo corpo, già segnato dalla scientica, c’erano un foglietto e unpennarello caduti a terra; prima di morire aveva cercato di scrivere qualcosa. Sicuramenteera per me, perché sapeva che sarei stata io a trovarlo. <strong>Su</strong>l foglio, soltanto una linea dritta,avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, ma io, chissà perché, intravidi l’inizio di una P. La P diperdono.Immersi in quel silenzio profondo restammo a lungo, lui e io, da soli.Mi venne allora in mente una delle ultime volte che eravamo andati a cena insieme.“Sai,” mi confessò quella sera, “per tutta la vita ho cercato di capire cos’è l’amore, ma nonce l’ho fatta. Adesso mi sento molto smarrito.” Vedendo i suoi occhi inumidirsi, non parlai,ma mi ricordai la frase che suo padre amava ripetergli appena lo vedeva: “Eri tu che dovevimorire, non Marisa!” Così presi quella grande mano ormai rigida e fredda, l’accarezzai e glidissi: “Adesso lo sai. L’amore saremmo stati noi, la vita che hai generato.”Qualche giorno dopo, nel piccolo paese in cui vivo, celebrammo il funerale di nascosto,come carbonari. Volevamo evitare la stampa che, in quei due soli giorni, si era profusa inpezzi di rara oscenità. Da quando era famosa, l’aveva abbandonato nella sua miseria, avevascritto la mezza calzetta dal manto maculato di turno.Naturalmente, si scoprì che non era stato ucciso, ma aveva avuto un’emorragia internaprovocata dalla cirrosi epatica.Per il funerale venne da Trieste anche mia madre, preoccupata che la chiesa potesseessere vuota. “Era solo come un cane,” ripeteva, “chi vuoi che venga? Sarà una tristezzatremenda.”Invece la chiesa era piena; c’erano, infatti, molte persone che volevano bene a me.Mentre seguivamo il feretro a piedi, lungo la strada contornata di querce che portava alcimitero, mio fratello minore disse: “Non ho la minima idea di chi sia la persona di cui stoseguendo la bara.”Qualche giorno dopo, mia madre mi condò che, quando sarebbe venuto il momento,avrebbe voluto essere seppellita con lui invece che con uno degli altri mariti. “Con lui, conGiovanni, il padre dei miei figli; l’uomo che ho sempre amato.”
Mia nonna se n’era andata già da tempo, purtroppo. La morte l’aveva colta nel ’92, ma lasua mente era sprofondata nel tunnel dell’Alzheimer già da otto anni.Avevamo fatto un patto, noi due: che avrebbe vissuto almeno no a cent’anni e in buonasalute, come avevano fatto sua madre e la maggior parte delle sue amiche, ma lei tradì quelpatto. A parte Illmitz, non ha potuto leggere nessun altro mio libro né rallegrarsi del fattoche fossi finalmente riuscita a pubblicarne uno, perché le tenebre l’avevano già avvolta.È stata la mia anima gemella, la grande compagna della mia vita e averla dovutaaccompagnare nel tunnel della malattia è stata una delle devastazioni della mia esistenza.La zia Letizia, che pure aveva sette anni più della nonna, morì più o meno nello stessoperiodo. Lo venni a sapere in un motel di Wolfsburg, durante un viaggio promozionale peril mio primo libro.L’ultima volta che andai a trovarla, al momento del congedo mi mise in mano una busta.Aspettai di giungere sul lungomare di Barcola per aprirla. Con la sua bella graa regolare,a matita, aveva scritto alcuni versi. Parlavano dell’impazienza snita di una madre che nonriesce a morire, a tornare vicino ai suoi figli.Camminai fino a Miramare, sforzandomi di trattenere le lacrime.Mia madre pensava di essere destinata, geneticamente e per carattere, a una lunga vita.Se ne andò invece in un’età – settantadue anni – che, per i nostri tempi, viene ormaiconsiderata ancora giovane, lasciandoci del tutto sgomenti. Eravamo cresciuti, noi gli, conla certezza che sarebbe stata lei a seppellirci. Del resto anche la bisnonna Dora – morta allasoglia dei cent’anni – quando mia nonna, sua figlia, andava a trovarla, le diceva: “Elsa, nonso come farò quando tu morirai…”Nella sua forza fuori dal comune, già da tempo si erano aperte delle crepe e, da quellecrepe, come nei grandi alberi che cadono schiantati da un fungo o da un coleottero, si erainsinuato il male che in poco più di un anno l’ha portata alla morte tra atroci sofferenze.L’essere diventata vedova – e soprattutto nonna – l’aveva negli anni un po’ addolcita.Tra una vedovanza e l’altra, avevamo ripreso a frequentarci. Quando non era costretta afare la madre, era una persona deliziosa, divertente, allegra, ironica, con cui eraimpossibile annoiarsi.Avrei dovuto odiarla per come mi aveva trattata, invece ho scelto il cammino più lungo eimpervio del perdono. Che cosa me ne sarei fatta dell’odio, una volta che lei fosse morta?Come una scheggia gelata sarebbe rimasto per sempre conficcato nel mio cuore.L’odio è un veleno di cui bisogna liberarsi il prima possibile perché, in esso, non c’èalcuna possibilità che la vita risorga.Conoscendo poi l’importanza della memoria, sapevo che sarebbe stato orribilesopravvivere avendo, al posto di una madre, un buco nero; come avrebbero potuto colmarele signore B C D E il grande vuoto che c’era alle mie spalle?Così decisi di immergermi ancora una volta nelle tenebre e di andare alla ricerca dellasignora A. Dov’era finita, infatti, l’instancabile sferruzzatrice di copertine?
La vita saggia è quella che ricerca l’unità, mia madre invece, per tutto il corso dei suoigiorni, non ha fatto che inseguire la molteplicità. Il punto di svolta credo sia stato proprio ilcrollo del sogno familiare; da lì in poi ha assunto infiniti volti, uno più infelice dell’altro.Rimasta sola, con una glia accanto che sapeva occuparsi di lei – e di cui lei non dovevaoccuparsi –, poté nalmente abbassare la guardia. Abbiamo fatto due viaggi memorabili,insieme: uno in Israele, l’altro in Namibia. D’estate, la portavo in campeggio con me.Adorava quella vita fatta di brandine cigolanti, di sabbia, di picnic con scatolette. Forse, perla prima volta nella sua vita, si sentiva libera.Un giorno, guardandola riposare sotto i pini marittimi, pensai che forse, in quell’istante,era davvero felice. E che cos’altro desidera un figlio, se non la felicità della propria madre?Credo che mia madre mi sia stata grata di non averla mai giudicata; la libertà dal giudiziole ha permesso di aprire uno spiraglio in direzione dell’amore, verso quello che avrebbevoluto essere e che non era stata capace di essere.Per i miei quarant’anni, mi regalò una radice di tiglio levigata in cui era evidentissima lagura di una madre che tiene raccolto tra le braccia un glio. Poco prima di ammalarsi,poi, furtivamente mi mise in mano una scatoletta di legno con un piccolo cuore disegnatosopra e dentro un biglietto con su scritto: “Ti voglio bene, anche se non ti capisco.”L’ho accompagnata per tutta la parte nale della sua malattia e le sono stata vicinoanche nell’istante della morte, ho sentito la sua mano diventare da calda a fredda in pochiistanti. Considero un grande privilegio poter stare accanto ai morenti.Erano le cinque e mezzo del mattino. Fuori soava una bora furiosa, una bora con nevee ghiaccio, come nel giorno in cui ero venuta al mondo. Aprii la nestra e feci entrare ilvento nella stanza, permettendo a lei di uscire. Mentre aspettavo il medico legale e fuorialbeggiava, mi ricordai quello che mi aveva condato una volta: “Mi sentivo molto sola, dabambina. Un giorno in giardino, trovai un bulbo di narciso e feci amicizia con lui, loportavo con me tutto il giorno e la sera lo mettevo sotto il cuscino.” Tutti abbiamo bisognodi perdono, abbiamo tutti bisogno di misericordia.In salotto, ho ssato a lungo, nella cesta con i suoi gomitoli, il pullover che stava facendoper me e che non sarebbe mai riuscita a completare. Come la protagonista di Sotto la neve,incredibilmente, per tutto il corso della sua vita, non ha fatto altro che sferruzzare decine dimagnifici maglioni destinati a me. In essi, forse, ha tentato di trasmettermi il calore che nonera riuscita a darmi in altro modo.Il giorno dopo la sua morte, nel suo comodino, nascosto tra altre riviste, ho trovato unnumero di Mani di fata del 1957: là dentro, intatto, c’era il disegno della mia copertina rosa,azzurra e bianca.
33.Finalmente i miei genitori, Giovanni e Anna Livia – mia madre si chiamava infatti così, inonore di Anna Livia Plurabelle dell’Ulisse di James Joyce, amico di famiglia – riposano, unoaccanto all’altra, in un piccolo cimitero di collina nell’It<strong>ali</strong>a centrale.Mia madre sorride radiosa nella foto, mentre mio padre guarda da un’altra parte comenel giorno del matrimonio. Davanti alle loro tombe c’è una panca e, quando vado atrovarli, mi siedo lì e passo un po’ di tempo con loro.Nella bella stagione porto a mia madre i suoi ori preferiti, d’inverno vado a potare lasua rosa e a togliere le foglie morte. Guardo i loro volti e cerco di capire che cosa, di loro, èrimasto in me. Di beni materi<strong>ali</strong>, essendo morti entrambi nullatenenti, mi hanno lasciatopoche cose. Da mio padre ho ricevuto un piccolo busto del Buddha in legno; un elefantinoindiano, sempre di legno; i suoi libri; la sua macchina di terza mano; un paio di milioni dilire in banca, rimasuglio della sua liquidazione; una tessera per il mese di settembre 1978Intera rete dell’Atac e uno scatolone di cartone contenente un servizio di piatti. L’eredità dimia madre, invece, è consistita in un cane, il suo, un fox terrier anziano e rabbioso – ilquale, appena arrivato da me in campagna ha prontamente sbranato i miei adorati gatti –;due anelli; un quaderno di ricette; una cesta di gomitoli di lana – gli avanzi di tutti i mieimaglioni – e uno scatolone di cartone contenente un altro servizio di piatti. Per ragioniincomprensibili, i due servizi di piatti sono quasi ugu<strong>ali</strong> – ambedue di coccio disegnato,tipici della Puglia.La scarsità di eredità materiale compensa l’abbondanza di quella caratteriale. Ora cheanch’io ho superato la metà della vita, so che ho preso molto dai miei genitori.Di mia madre, ho la forza di carattere, la capacità di risorgere sempre e in ogni mododalle dicoltà con il sorriso sulle labbra, l’allegria, la passione per ogni istante della vita;condivido con lei anche il gusto di fare le cose con le mani: la cucina, il giardinaggio, ildisegno, il ricamo e ogni sorta di bricolage.Da mio padre, invece, ho preso l’inaerrabilità, la totale indierenza per ciò che èesteriore e che eccita l’appetito dei più, la lontananza da tutte le combriccole di potere, datutte le falsità che pervertono i rapporti tra le persone. Come lui, vivo nella totaleincapacità di sottomettere i rapporti a un loro eventuale ne. Come lui, ho uno spiritorandagio, ribelle a qualsiasi forma di definizione.Tutta la pesante zavorra di negatività che hanno messo sulle mie spalle ha provocato inme una condizione di dolore alle volte dicilmente sopportabile, ma è stato proprio graziea quella zavorra che ho potuto diventare quella che sono.Se sono una persona mite, è perché so di poter essere anche estremamente violenta. Sesono coraggiosa, è solo perché il mio sentimento predominante è la paura. Se so scrivere
storie che toccano il cuore di molti, è perché il mio cuore è costantemente aperto e prontoad accogliere le inquietudini, le contraddizioni e le sofferenze del mondo.Vivere è un continuo cammino di trasformazione, è questo il segno dell’uomo. Gli anim<strong>ali</strong>vivono immersi in un’innocente circolarità, noi invece siamo sempre spinti ad andareavanti, a capire i nostri errori e i nostri difetti e saperli trasformare in pregi.Lottare perché la Luce conquisti sempre più spazio in noi, sottraendolo al buio, è ilcompito che attende ogni persona che si metta alla ricerca della vera libertà. Non avreipotuto, infatti, arontare questa straordinaria avventura se i miei genitori non mi avesserodato il dono della vita, per questo sarò loro eternamente grata.E Gianna, la compagna felice dei nostri pomeriggi, la fonte aettiva della nostrasopravvivenza?Non mi ero mai rassegnata alla sua scomparsa. Quando passavo per Trieste, speravosempre di incontrarla per la strada, consultavo l’elenco telefonico alla ricerca di un segno,un indizio. Una volta, chiesi a mia madre: “Possibile che non abbia saputo più niente diGianna?”“Ho sentito dire che si è sposata ed è andata a vivere in Austr<strong>ali</strong>a,” rispose lei, vaga.In Austr<strong>ali</strong>a! Come avrei mai potuto scovarla laggiù?Ormai mi ero rassegnata a convivere con questa voragine nel cuore, quando, un paio dianni fa, ricevetti una e-mail sul mio sito uciale. Era di Umberto, il compagno di Gianna.Mi scriveva che lei si stava lentamente spegnendo e che, da sempre, aveva vissuto con ildesiderio di poter rivedere “i suoi bambini”, ma aveva paura di disturbare, non era neppurepiù sicura ci ricordassimo di lei. Mi scriveva a sua insaputa, per vedere se era possibile darlequesta gioia prima della morte.Quella e-mail scatenò una spaventosa tempesta emotiva sia in me che in mio fratello.Soltanto in quell’istante mi accorsi che, per più di quarant’anni, avevo camminato su unasottile lastra di ghiaccio. Ora il ghiaccio si era rotto ed eravamo sprofondati nell’abisso chesi era spalancato sotto di noi. L’abisso dell’abbandono, del dolore che non conosceconsolazione.Gianna non viveva aatto in Austr<strong>ali</strong>a ma a pochi chilometri da Trieste, non lontano daquella sc<strong>ali</strong>nata di Redipuglia che tanta ansia aveva scatenato nella mia infanzia.Appena ho potuto, sono andata a trovarla. In macchina, ero molto agitata. Come sarà?,mi domandavo, ci sarà ancora qualcosa tra noi o sarà solo l’adempiere di una form<strong>ali</strong>tà?Non sapevo niente della sua vita, era ancora molto giovane quando stava con noi; magariera diventata una persona con cui non avrei avuto più molto da dire.Che sollievo quando scoprii dove abitava!Una bianca casetta di campagna, solare, con cani e gatti serenamente addormentati sulprato, contornata da un piccolo orto, un albero di cachi e una vigna.Quando entrai, vidi Gianna sdraiata sul letto in compagnia di tre o quattro gatti chefacevano le fusa e le tenevano caldo. Aveva letto e amato tutti i miei libri, mi disse, e miaveva seguita con discrezione in tutti quegli anni. Con l’amato Umberto, condivideva le mie
stesse passioni: i viaggi su due ruote, le vacanze in tenda, la coltivazione dell’orto, dellavigna, l’amore per le passeggiate, per la vita semplice e per gli anim<strong>ali</strong>. Aveva lavoratotutta la vita come infermiera e quando era andata in pensione, insieme al compagno, anchelui pensionato dei cantieri nav<strong>ali</strong>, aveva cominciato a girare per l’Europa a piedi, inpellegrinaggio.Gianna era una persona meravigliosamente libera, per questo, n da bambina, l’avevosentita così vicina. Poter tenere un’ultima volta la sua mano tra le mie è stata una graziastraordinaria.Morì due giorni prima che uscisse Per sempre, il mio ultimo libro. Quando capì che non cel’avrebbe più fatta a leggerlo, chiese a Umberto di comprarne una copia e di metterlaaccanto a lei, nella tomba.Così fece e così, finalmente, siamo insieme. Per sempre.Di tutte le persone che ho ricordato in queste pagine, la più longeva è stata proprio la piùmalaticcia, Maria, l’amica del cuore di mia nonna, la colonna del mio senile triumvirato.Se ne andò nel mese di marzo del 2011, a centotré anni.Ero andata a trovarla da poco. Da anni ormai non usciva più di casa e viveva connatasu una sedia a rotelle. Accoglieva ogni mia visita con gioia infantile: “Che coccola!” diceva,“ti ricordi sempre di me!”Come spesso accade nelle persone anziane, la sua attenzione andava e veniva mentre unvelo copriva ormai i suoi occhi, rendendoli opachi, simili a quelli dei neonati. Se ne stavaseduta tutto il giorno a ssare un albero spoglio, al di là della nestra; la sua gioiaconsisteva nell’osservare i passeri, le cince e le tortore contendersi le briciole che, ognimattina, faceva mettere sul davanzale.La penombra avvolgeva la stanza, quella mattina. Presi una sedia e le andai vicino; nonavevo mai osato darle del “tu”: me la ricordavo a scuola, con il grembiule blu, che uscivadall’aula accanto alla mia.“Maria, come passa il tempo?” le chiesi. “Le giornate sono così lunghe!”Lei si girò, mi guardò a lungo, prima di rispondere, poi sorrise: “Benedico! Benedico imiei scolari, tutti i miei scolari, soprattutto quelli che hanno più bisogno.”“Se li ricorda tutti?” domandai.“Neppure un volto ho dimenticato.”Rimase poi in silenzio. Il vento ululava, facendo tremare i vecchi inssi di legno, i ramidell’albero di fronte sembravano voler graffiare l’aria.All’improvviso, spalancò le braccia verso il cielo, agitando le mani in aria come undirettore d’orchestra, e disse: “E poi benedico la vita! Benedico gli alberi, le primule, labora, le tortore e i passeri, i bambini, le erbacce! Perché tutto è santo, tutto è benedetto.”