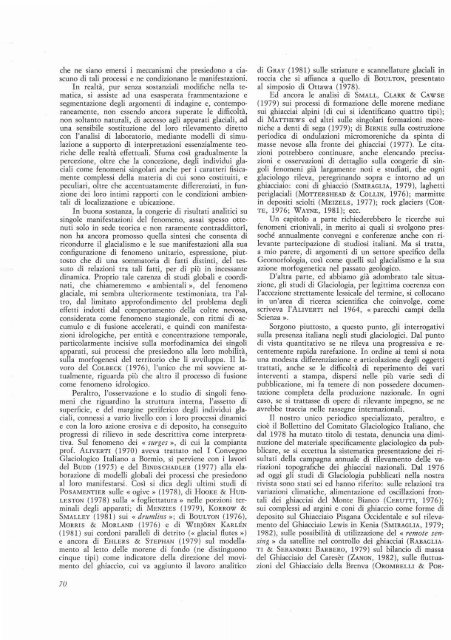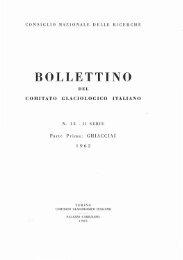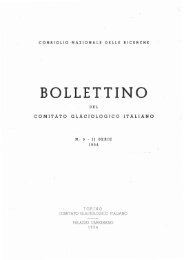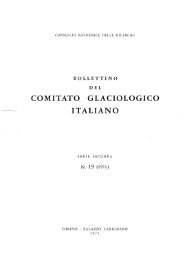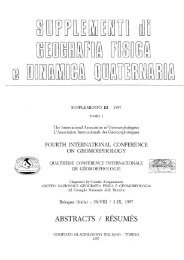Full Text (PDF) - Comitato Glaciologico Italiano
Full Text (PDF) - Comitato Glaciologico Italiano
Full Text (PDF) - Comitato Glaciologico Italiano
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
che ne siano emersi i meccanismi che presiedono a ciascunodi tali processi e ne condizionano Ie manifestazioni.In realta, pur senza sostanziali modifiche nella tematica,si assi ste ad una esasperata frammentazione esegmentazione degli argomenti di indagine e, contemporaneamente,non essendo ancora superate Ie difficolta,non soltanto naturali, di accesso agli apparati glaciali, aduna sensibile sostituzione del 101'0 rilevamento direttocon l'analisi di laboratorio, mediante modelli di simulazionea supporto di interpretazioni essenzialmente teorichedelle realta effettuali. Sfuma cOSI gradualmente lapercezione, oltre che la concezione, degli individui glacialicome fenomeni singolari anche per i caratteri fisica-. mente complessi della materia di cui sono costituiti, epeculiari, oltre che accentuatamente differenziati, in funzionedei 101'0 intimi rapporti con Ie condizioni am bientalidi localizzazione e ubicazione.In buona sostanza, la congerie di risultati analitici susingole manifestazioni del fenomeno, assai spesso ottenutisolo in sede teorica e non raramente contraddittori,non ha ancora promosso quella sintesi che consenta diricondurre i1 glacialismo e Ie sue manifestazioni alIa suaconfigurazione di fenomeno unitario, espressione, piuttostoche di una sommatoria di fatti distinti, del tessutodi relazioni tra tali fatti, per di pili in incessantedinamica. Proprio tale carenza di studi globali e coordinati,che chiameremmo «ambientali », del fenomenoglaciale, mi sembra ulteriormente testimoniata, tra l'altro,dal limitato approfondimento del problema deglieffetti indotti dal comportamento della coltre nevosa,considerata come fenomeno stagionale, con ritmi di accumuloe di fusione accelerati, e quindi con manifestazioniidrologiche, per entita e concentrazione temporale,particolarmente incisive sulla morfodinamica dei singoliapparati, sui processi che presiedono alIa 101'0 mobilita,sulla morfogenesi del territorio che li avviluppa. II lavorodel COLBECK (1976), l'unico che mi sovviene attualmente,riguarda pili che altro il processo di fusionecome fenomeno idrologico.Peraltro, l'osservazione e 10 studio di singoli fenomeniche riguardino la struttura interna, l'assetto disuperficie, e del margine periferico degli individui glaciali, connessi a vario livello con i loro processi dinamicie con la 101'0 azione erosiva e di deposito, ha con seguitoprogressi di rilievo in sede descrittiva come interpretativa.SuI Ienomeno dei «surges », di cui la compiantaprof. ALIVERTI (1970) aveva trattato nel I Convegno<strong>Glaciologico</strong> <strong>Italiano</strong> a Bormio, si perviene con i lavoridel BUDD (1975) e del BINDSCHADLER (1977) alIa elaborazionedi modelli globali dei processi che presiedonoal 101'0 manifestarsi . COSI si dica degli ultimi studi diPOSAMENTIER sulle « ogive » (1978), di HOOKE & HUDLESTON (1978) sulla « foglietta tura » nelle porzioni terminalidegli apparati; di MENZIES (1979), KORRow &SMALLEY (1981) sui « drumlins »; di BOULTON (1976),MORRIS & MORLAND (1976) e di WIBJORN KARLEN(1981) sui cordoni paralleli di detrito (« glacial flutes»)e ancora di EHLERS & STEPHAN (1979) sul modellamentoal letto delle morene di fondo (ne distinguonocinque tipi) come indicatore della direzione del movimentodel ghiaccio, cui va aggiunto il lavoro analiticodi GRAY ((981) sulle striature e scannellature glaciali inroccia che si affianca a quello di BOULTON, presentatoal simposio di Ottawa (1978).Ed ancora Ie analisi di SMALL) CLARK & CAWSE(1979) sui processi di formazione delle morene medianesui ghiacciai alpini (di cui si identificano quattro tipi);di MATTHEWS ed altri sulle singolari formazioni morenichea denti di sega (1979); di BIRNIE sulla costruzioneperiodica di ondulazioni micromoreniche da spinta dimasse nevose alIa fronte dei ghiacciai (1977). Le citazionipotrebbero continuare, anche elencando precisazionie osservazioni di dettaglio sulla congerie di singolifenomeni gia largamente noti e studiati, che ogniglaciologo rileva, peregrinando sopra e in torno ad unghiacciaio: coni di ghiaccio (SMIRAGLIA, 1979), laghettiperiglaciali (MOTTERSHEAD & COLLIN, 1976); marmittein depositi sciolti (MEIZELS, 1977); rock glaciers (CORTE, 1976; WAYNE, 1981); ecc .Un capitolo a parte richiederebbero Ie ricerche suifenomeni crionivali, in merito ai quali si svolgono pressocheannualmente convegni e conferenze anche con rilevantepartecipazione di studiosi italiani. Ma si tratta,a mio parere, di argomenti di un settore specifico dellaGeomorfologia, cOSI come quelli suI glacialismo e la suaazione morfogenetica nel passato geologico.D'altra parte, ed abbiamo gia adombrato tale situazione,gli studi di Glaciologia, per legittima coerenza conl'accezione strettamente lessicale del termine, si collocanoin un'area di rice rca scientifica che coinvolge, comescriveva l'ALIVERTI nel 1964, «parecchi campi dellaScienza » .Sorgono piuttosto, a questo punto, gli interrogativisulla presenza italiana negli studi glaciologici. Dal puntodi vista quantitativo se ne rileva una progressiva e re centemente rapida rarefazione. In ordine ai temi si notauna modesta differenziazione e articolazione degli oggettitrattati, anche se Ie diflicolta di reperimento dei variinterventi a stampa, dispersi nelle pili varie sedi dipubblicazione, mi fa temere di non possedere documentazionecompleta della produzione nazionale. In ognicaso, se si trattasse di opere di rilevante impegno, se neavrebbe traccia nelle rassegne internazionali.II nostro unico periodico specializzato, peraltro, ecioe il Bollettino del <strong>Comitato</strong> <strong>Glaciologico</strong> <strong>Italiano</strong>, chedal 1978 ha mutato titolo di testata, denuncia una diminuzionedel materiale specificamente glaciologico da pubblicare,se si eccettua la sistematica presentazione dei risultatidella campagna annuale di rilevamento delle variazionitopografiche dei ghiacciai nazionali. Dal 1976ad oggi gli studi di Glaciologia pubblicati nella nostrarivista sono stati sei ed hanno riferito: sulle relazioni travariazioni climatiche, alimentazione ed oscillazioni frontalidei ghiacciai del Monte Bianco (C ERUTTI, 1976);sui complessi ad argini e coni di ghiaccio come forme dideposito sul Ghiacciaio Pisgana Occidentale e sul rilevamento del Ghiacciaio Lewis in Kenia (SMIRAGLIA , 1979;1982), sulle po ssibilita di utilizzazione del « remote sensing»da satellite nel controllo dei ghiacciai (RABAGLIATI & SERANDREI BARBERO, 1979) suI bilancio di massadel Ghiacciaio del Careser (ZANON, 1982), sulle fluttuazionidel Ghiacciaio della Brenva (OROMBELLI & POR-70