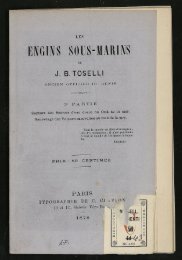Il trasferimento dell'Osservatorio astronomico di Brera a Merate
Il trasferimento dell'Osservatorio astronomico di Brera a Merate
Il trasferimento dell'Osservatorio astronomico di Brera a Merate
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
istituzioni, attori e ideali <strong>di</strong> un secolo<strong>di</strong> cultura scientifica a Milano 1863 – 1963Pasquale TucciIL TRASFERIMENTO DELL’OSSERVATORIO L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA A MERATRATEEmilio Bianchi, L’Osservatorio <strong>astronomico</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, “Milano”, 1 gennaio 1929, pp. 5-7.Quando nel 1927 entrò in funzione la succursale <strong>di</strong> <strong>Merate</strong> dell’Osservatorio Astronomico <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, si<strong>di</strong>ede finalmente risposta alla richiesta <strong>di</strong> una nuova sede che gli astronomi milanesi avevano avanzatogià pochi decenni dopo l’istituzione dell’Osservatorio, nel 1763, su progetto del padre gesuita RuggeroBoscovich.Già nel 1838 il <strong>di</strong>rettore Francesco Carlini aveva proposto <strong>di</strong> istituire una sede <strong>di</strong>staccatadell’Osservatorio sul Monte Barro presso Lecco. La sede <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, infatti, si <strong>di</strong>mostrava inadatta pervarie ragioni, tra cui l’instabilità della fabbrica, sulla cui sommità, a decine <strong>di</strong> metri <strong>di</strong> altezza, eranocollocati gli strumenti <strong>di</strong> osservazione, l’antropizzazione della zona nella quale sorgeva l’Osservatorio ele con<strong>di</strong>zioni atmosferiche.Sebbene l’area <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> fosse una zona erbosa abbastanza isolata dal resto della città, tuttavia losviluppo urbanistico la stava inghiottendo portando con sé luci (poche, almeno fino alla prima metàdell’Ottocento), vibrazioni per il passaggio <strong>di</strong> carri, inquinamento da riscaldamento domestico e,naturalmente, nebbia. Come risultato, le osservazioni non potevano raggiungere la precisione che i piùimportanti osservatori astronomici del mondo, come quelli <strong>di</strong> Parigi e <strong>di</strong> Greenwich, garantivano e nonera possibile scrutare il cielo profondo.Intorno al 1927, accanto ai problemi <strong>di</strong> struttura e <strong>di</strong> localizzazione, l’Osservatorio <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> soffrivainoltre <strong>di</strong> due altre gravi <strong>di</strong>fficoltà: la carenza <strong>di</strong> personale, acuta sin dai primi anni dell’Ottocento, e lamancanza <strong>di</strong> strumentazione adeguata. Gli strumenti importanti dell’Osservatorio erano ancora quelliacquistati da oltre mezzo secolo da Giovanni Virginio Schiaparelli: due rifrattori <strong>di</strong> 22 e 50 cm <strong>di</strong>apertura, che videro la prima luce rispettivamente nel 1874 e nel 1886.C’era infine un problema, forse il più grave <strong>di</strong> tutti: la mancanza <strong>di</strong> una visione strategica dell’attività <strong>di</strong>ricerca dell’Osservatorio. L’organico piano <strong>di</strong> ricerca elaborato da Boscovich non fu adeguato alle<strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni ambientali. Francesco Carlini, unico astronomo e <strong>di</strong>rettore dell’Osservatorio primadell’arrivo <strong>di</strong> Schiaparelli, copriva i campi più <strong>di</strong>sparati della ricerca e dell’attività astronomica: daiproblemi più astratti <strong>di</strong> meccanica celeste fino alla geodesia, al magnetismo terrestre etcetera.Ipotesi contrad<strong>di</strong>ttorie sullo sviluppo scientifico dell’Osservatorio si erano avvicendate nel corso deidecenni. Schiaparelli, nella seconda metà dell’Ottocento, aveva privilegiato le attività <strong>di</strong> ricercaastronomica in senso stretto e aveva ri<strong>di</strong>mensionato o azzerato le attività riguardanti la meteorologia,il magnetismo terrestre, la sismologia, la geodesia, la pubblicazione delle Effemeri<strong>di</strong>. <strong>Il</strong> suo successoreGiovanni Celoria, invece, nel primo decennio del Novecento, auspicava la costruzione <strong>di</strong> una succursaledell’Osservatorio che potesse ospitare proprio alcune della attività che Schiaparelli avevaprogrammaticamente trascurato.Celoria pensava a una filiale da costruire a Milano nella stessa zona nella quale dal 1927 opererà ilPolitecnico <strong>di</strong> Milano, fondato nel 1863, e dove sarebbe sorta la parte scientifica dell’istituendaUniversità degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano. Lo stesso Celoria aveva anche pensato al Palazzo Besta <strong>di</strong> Teglio inValtellina.Lo stesso appello <strong>di</strong> Celoria a proposito della cronica mancanza <strong>di</strong> mezzi rispetto, ad esempio, agliosservatori astronomici americani sottovalutava le novità che si stavano realizzando nella ricercaastronomica con l’introduzione <strong>di</strong> tematiche e metodologie fisiche nello stu<strong>di</strong>o degli oggetti celesti:l’astronomia classica stava cedendo il posto all’astrofisica.milanoCITTA’DELLESCIENZEweb: www.milanocittadellescienze.itemail: info@milanocittadellescienze.it 1
istituzioni, attori e ideali <strong>di</strong> un secolo<strong>di</strong> cultura scientifica a Milano 1863 – 1963Pasquale Tucci – L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERAL’affermazione <strong>di</strong> Celoria che l’Osservatorio <strong>di</strong> Milano fosse il più importante d’Italia per le <strong>di</strong>mensionidei suoi strumenti risultava essere una riven<strong>di</strong>cazione retorica. Quegli strumenti, infatti, erano coerenticon un modo <strong>di</strong> fare ricerca astronomica oramai in declino. Basti pensare che <strong>di</strong> là a qualche anno, nel1921, l’Osservatorio <strong>astronomico</strong> <strong>di</strong> Firenze già si chiamava Osservatorio Astrofisico quando GiorgioAbetti ne assumeva la <strong>di</strong>rezione. E’ probabile che l’errore <strong>di</strong> prospettiva <strong>di</strong> Celoria derivasse da unasopravvalutazione dei vantaggi che sarebbero potuti arrivare alla ricerca astronomica da un rapportopiù stretto con la nascente industria aeronautica - fiorente soprattutto in Lombar<strong>di</strong>a - che avevabisogno <strong>di</strong> dati meteorologici o geomagnetici.La stessa nomina <strong>di</strong> Emilio Bianchi, nel 1922, a <strong>di</strong>rettore dell’Osservatorio va inserita in questocontesto. Dal 1913 al 1919, Emilio Bianchi, bresciano <strong>di</strong> nascita e laureatosi in fisica a Padova, svolse lasua attività presso l’Istituto Centrale Aeronautico a Roma dove insegnò navigazione aerea edaeronautica agli allievi piloti dell’Esercito e della Marina e dove pubblicò un testo sulla Statica e sullaDinamica dei <strong>di</strong>rigibili. Come attesta questo suo articolo, Bianchi <strong>di</strong>ede un forte impulso allarealizzazione della nuova sede <strong>di</strong> <strong>Merate</strong>, sebbene essa rispondesse solo in parte alle esigenze <strong>di</strong> unapiù moderna e innovativa ricerca astronomica. La sede dell’Osservatorio era nella Villa <strong>di</strong> San Rocco,a<strong>di</strong>bita a convalescenziario durante la guerra. L'occasione per l’ampliamento era stata fornita dallapossibilità <strong>di</strong> ricevere gratuitamente dalla Germania in conto riparazioni danni <strong>di</strong> guerra gli strumentinecessari alla nuova sede.E’ interessante la polemica che sorse tra Bianchi e Salmoiraghi, sviluppatasi a partire dalla meta del1923 sulla stampa e negli organi competenti. L'accusa principale che Salmoiraghi rivolgeva a Bianchiera <strong>di</strong> aver preferito strumenti tedeschi a quelli prodotti dalla sua fabbrica - La Filotecnica - che tantisforzi egli aveva compiuto per sviluppare e portare ai livelli <strong>di</strong> quelli stranieri. Alla fine, dopo ulteriori<strong>di</strong>fficoltà sollevate dal governo tedesco, giunsero all'osservatorio uno strumento dei passaggi Bamberge un telescopio riflettore Zeiss da un metro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, il più grande allora in Italia. Giunsero, inoltre,altri due nuovi strumenti: un cerchio meri<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Ertel proveniente dall'Istituto Idrografico dellaMarina <strong>di</strong> Genova e uno strumento dei passaggi Salmoiraghi, acquistato forse in segno <strong>di</strong> buonavolontà dopo la polemica. Per ospitare gli strumenti furono costruite delle cupolette, mentre in unagrande cupola emisferica fu installato il riflettore Zeiss <strong>di</strong> un metro. Più tar<strong>di</strong>, nel 1935, Bianchiotteneva dalla Società E<strong>di</strong>son i mezzi necessari per costruire a <strong>Merate</strong> una cupola in cui trasferire ilrifrattore Merz-Repsold da 50 cm rimasto nella sede <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>.Nel frattempo la sede <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> aveva ripreso, dopo le <strong>di</strong>fficoltà della guerra, alcune attività. Gia nel1922, in collaborazione con le specole <strong>di</strong> Genova, Napoli e Padova, l'osservatorio milanese eseguiva laprima determinazione <strong>di</strong> longitu<strong>di</strong>ne che impiegava la ra<strong>di</strong>otelegrafia al posto della normale telegrafia.Per qualche tempo proseguirono a <strong>Brera</strong> anche i lavori <strong>di</strong> astronomia classica con le osservazioni <strong>di</strong>pianetini, stelle doppie e comete. Fu poi sostituito con un Salmoiraghi <strong>di</strong> uguale apertura il Merz da 22cm (attualmente restaurato e reinstallato nella sua cupola originaria e inserito nel percorso del MuseoAstronomico <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>). Bianchi, inoltre, potenziò il servizio dell'ora e la sezione meteorologica.I risultati scientifici, comunque, non furono esaltanti.Se scorriamo l’elenco della attività svolte a <strong>Merate</strong>, pubblicato in un articolo <strong>di</strong> Bianchi, pochi mesiprima della morte avvenuta nel 1941, notiamo come qualche eccellente spunto <strong>di</strong> ricerca siasommerso da una miriade <strong>di</strong> attività sui temi più <strong>di</strong>sparati. Accanto allo stu<strong>di</strong>o delle parallassispettroscopiche troviamo la compilazione <strong>di</strong> schedari per ricerche statistiche, ricerche sulle Pleja<strong>di</strong>,determinazione delle coor<strong>di</strong>nate geografiche, equilibrio ra<strong>di</strong>oattivo etcetera. Si ha l’impressione chemanchi un solido programma <strong>di</strong> ricerca intorno al quale articolare le attività <strong>di</strong> ricerca e l’erogazionedei servizi richiesti all’epoca a un osservatorio <strong>astronomico</strong>. E il problema non era confinato solomilanoCITTA’DELLESCIENZEweb: www.milanocittadellescienze.itemail: info@milanocittadellescienze.it 2
istituzioni, attori e ideali <strong>di</strong> un secolo<strong>di</strong> cultura scientifica a Milano 1863 – 1963Pasquale Tucci – L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERAall’Osservatorio <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>-<strong>Merate</strong> ma era generalizzato alla stragrande maggioranza degli osservatoriitaliani.La situazione cambierà solo nel secondo dopoguerra, quando nuove idee supportate da abili ricercatoririsolleveranno le sorti dell’astronomia e dell’astrofisica italiana.[24 <strong>di</strong>cembre 2009]milanoCITTA’DELLESCIENZEweb: www.milanocittadellescienze.itemail: info@milanocittadellescienze.it 3