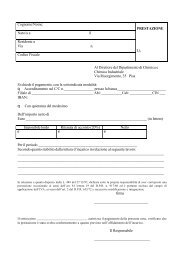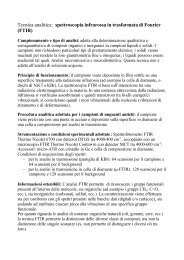Laboratorio Polimerizzazione ATRP - Dipartimento di Chimica e ...
Laboratorio Polimerizzazione ATRP - Dipartimento di Chimica e ...
Laboratorio Polimerizzazione ATRP - Dipartimento di Chimica e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO – AA 2006-07<br />
Sintesi <strong>di</strong> un copolimero a blocchi e <strong>di</strong> un copolimero statistico <strong>di</strong><br />
n-butil acrilato e stirene tramite polimerizzazione <strong>ATRP</strong>.<br />
Quesiti da <strong>di</strong>scutere ed a i quali fornire delle risposte nella relazione.<br />
A) Omopolimerizzazione <strong>di</strong> n-butil acrilato (BA) tramite la tecnica <strong>ATRP</strong><br />
1. Calcolare in quale reciproco rapporto molare sono stati impiegati i componenti della miscela <strong>di</strong><br />
polimerizzazione (sale <strong>di</strong> rame, legante, iniziatore, monomero).<br />
2. Calcolare il peso molecolare teorico dell’omopolimero che verrà poi impiegato successivamente<br />
come macroiniziatore per la sintesi del copolimeri a blocchi. Ipotizzare una conversione del<br />
100 % ed una efficienza quantitativa dell’iniziatore, semplificando per una poli<strong>di</strong>spersità PDI =<br />
1,0<br />
M w 1 ⎛ [ RX ] 0 k p ⎞ ⎛ 2 ⎞ 1<br />
(inferiore alla teorica : PDI = = 1+ + ⎜<br />
⎟ 1 1<br />
n 1<br />
⎟ ≅ +<br />
M n DP<br />
⎜<br />
⋅ ⎜ −<br />
kd<br />
[ Mt X L]<br />
⎟<br />
)<br />
+<br />
⎝<br />
⎠ ⎝ conv.<br />
⎠ DP<br />
W.A. Braunecker, K. Matyjaszewski, Prog.Polym. Sci. 32 (2007) 93<br />
3) Riportare graficamente l’andamento del peso molecolare teorico dell’omopolimero in funzione<br />
della conversione per la serie per la quale sono resi <strong>di</strong>sponibili i dati SEC e 1 H-NMR.<br />
Nello stesso grafico riportare i dati sperimentali <strong>di</strong> Mn e Conversione ottenuti rispettivamente<br />
dalle misure SEC e 1 H-NMR.<br />
Nello stesso grafico riportare i dati sperimentali <strong>di</strong> Mw/Mn in funzione della Conversione.<br />
Es.:<br />
1
4. In<strong>di</strong>care le espressioni cinetiche che descrivono i processi <strong>di</strong> inizio e propagazione. Riportare in<br />
grafico ln[M]0/[M] rispetto al tempo <strong>di</strong> reazione t.<br />
Es.:<br />
K.L.Beers, B.Woodworth, K.Matyjaszewski, J.Chem.Ed.78, 2001, 544.<br />
5. Commentare il carattere (controllato o meno) della polimerizzazione. Fare ipotesi sulle cause<br />
delle eventuali deviazioni.<br />
B) Sintesi <strong>di</strong> un copolimero a blocchi – poli(stirene-b- butil acrilato-b-stirene) e <strong>di</strong> un<br />
copolimero statistico poli(stirene-stat-butil acrilato).<br />
1. In base ai dati 1 H NMR calcolare la composizione dei copolimeri ottenuti.<br />
2. In base al valore <strong>di</strong> Mn per l’omopolimero ed al monomero stirenico alimentato, calcolare il<br />
valore atteso <strong>di</strong> Mn per il copolimero a blocchi ipotizzando una conversione ed una efficienza <strong>di</strong><br />
reinizio pari entrambe al 100 %.<br />
3. In base al dato GPC commentare la efficacia del “macroiniziatore” costituito dall’omopolimero<br />
<strong>di</strong> butil acrilato per la sintesi del copolimeri a blocchi. Commentare eventuali <strong>di</strong>screpanze tra il<br />
dato GPC e quello 1 H NMR.<br />
4. Calcolare un valore teorico <strong>di</strong> conversione per la sintesi del copolimero statistico in base ai dati<br />
SEC e 1 H NMR, ipotizzando una efficienza unitaria dell’iniziatore alogenato. Nel caso sia<br />
<strong>di</strong>sponibile il dato sperimentale <strong>di</strong> conversione, calcolare l’efficienza dell’iniziatore.<br />
Discutere brevemente che <strong>di</strong>fferenze ci si possono aspettare in termini <strong>di</strong> proprietà chimico-fisiche<br />
tra i due copolimeri sintetizzati e tra questi ed un ipotetico copolimero statistico preparato con un<br />
processo <strong>di</strong> polimerizzazione ra<strong>di</strong>calica convenzionale.<br />
E’ possibile prevedere <strong>di</strong>verse caratteristiche applicative per i due tipi <strong>di</strong> copolimeri ?<br />
2
Caratterizzazione termica dei polimeri sintetizzati con la tecnica <strong>ATRP</strong><br />
Endo (W/g)<br />
900<br />
600<br />
300<br />
0<br />
-60 -40 -20 0 20 40 60 80<br />
Temperatura (°C)<br />
Sty-b-Ba 1°H<br />
Sty-b-Ba 2°H<br />
Sty-stat-Ba 1°H<br />
Poli(butil acrilato) 1°H<br />
Determinazione della Tg <strong>di</strong> polimeri amorfi.<br />
Analisi DSC condotte raffreddando a 200°C/min (nominali) fino alla temperatura <strong>di</strong> inizio<br />
scansione, ed effettuando un primo riscaldamento a 20 °C/min, seguito da un rapido raffreddamento<br />
(200 °C/min nominali) e da una seconda scansione in riscaldamento a 20 °C/min.<br />
In generale i termogrammi successivi al primo sono comparabili, risentendo tutti della stessa<br />
“storia termica” successiva all’azzeramento della memoria termica conseguente al riscaldamento al<br />
<strong>di</strong> sopra della più alta temperatura <strong>di</strong> transizione (sia essa la temperatura <strong>di</strong> transizione vetrosa, Tg,<br />
o quella <strong>di</strong> fusione, Tf).<br />
Nel nostro caso la storia termica,consistente nel trattamento a 100 °C in stufa per seccare il<br />
polimero, seguito da un “invecchiamento” a temperatura ambiente <strong>di</strong> qualche giorno, viene<br />
annullata col primo riscaldamento spinto fino a 120 °C.<br />
Il valore <strong>di</strong> Tg determinato dalla scansione in riscaldamento è del tutto equivalente a quello che<br />
si sarebbe ottenuto registrando un termogramma in raffreddamento (alla stessa velocità <strong>di</strong> scansione<br />
<strong>di</strong> 20 °C/min). Infatti, a <strong>di</strong>fferenza delle transizioni <strong>di</strong> primo or<strong>di</strong>ne, che presentano fenomeni <strong>di</strong><br />
isteresi (<strong>di</strong>fferenza tra le temperature <strong>di</strong> fusione e cristallizzazione) <strong>di</strong> natura cinetica, legati alla<br />
natura dei cristallini (in fusione) o alla efficacia <strong>di</strong> nucleazione (in fase <strong>di</strong> cristallizzazione), nel caso<br />
delle transizioni <strong>di</strong> secondo or<strong>di</strong>ne l’isteresi termica è legata unicamente al ritardo nella risposta<br />
dello strumento, funzione della velocità <strong>di</strong> scansione.<br />
A titolo esemplificativo le analisi sui polimeri del gruppo Serri-Lisi-Montecchi hanno fornito i<br />
seguenti risultati, ottenuti da una elaborazione eseguita <strong>di</strong>rettamente sullo strumento:<br />
Poli(butil acrilato): [acronimo: PBA] Tg = -52 °C<br />
Poli(stirene-stat-butil acrilato). [acronimo: Sty-stat-BA] Tg = -11 °C<br />
Poli(stirene-b-butil acrilato). [acronimo: Sty-b-BA] Tg = -40 °C<br />
N.B. : E’ possibile che la curvatura della linea <strong>di</strong> base nell’intervallo tra 60<br />
e 70 °C per Sty-b-BA corrisponda ad una seconda transizione vetrosa<br />
3