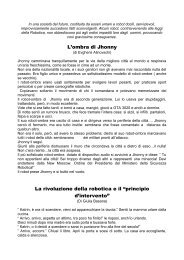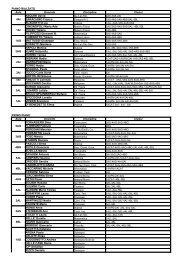leggi il testo - I.S.I.S. "V. Manzini"
leggi il testo - I.S.I.S. "V. Manzini"
leggi il testo - I.S.I.S. "V. Manzini"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Concorso internazionale “I giovani e l’Europa” – edizione 2007 (IRSE – Pn)<br />
Primo premio sezione Scuola superiore a<br />
Lodovica Comello, classe 3A Liceo scientifico<br />
Docente: M. Rossetti<br />
Scuola 2010.<br />
Per raggiungere gli "Obiettivi Lisbona" nei sistemi di istruzione e formazione in Europa si sottolinea<br />
la necessità di aumentare considerevolmente i saperi scientifici, lo studio della storia<br />
contemporanea e delle lingue straniere, le competenze informatiche. Sei d’accordo? Cosa sta<br />
facendo o cosa ti aspetteresti dalla tua scuola e dai tuoi insegnanti? Come cerchi di integrare<br />
eventuali mancanze con attività extrascolastiche, esperienze estive, ecc.<br />
Gli obiettivi comuni fissati dal Consiglio Europeo nell’incontro tenutosi a Lisbona nel 2000, ad una<br />
prima lettura, sembrano interessare quasi esclusivamente l’economia. Vi si parla di imprenditoria,<br />
mercato, competitività; la valorizzazione dell’innovazione viene considerata in ottica anzitutto<br />
economica; la medesima osservazione vale per l’impiego delle risorse energetiche rinnovab<strong>il</strong>i: ne<br />
viene sottolineata l’economicità, poi la sostenib<strong>il</strong>ità ambientale ed i positivi risvolti sulla società;<br />
anche <strong>il</strong> benessere sociale e le pari opportunità paiono conseguenti solo ad un’economia<br />
consolidata. Ma <strong>il</strong> Consiglio ha pure condiviso l’idea che le persone sono la principale risorsa<br />
dell’Europa, e che pertanto le politiche dell’Unione Europea vanno basate su di loro. In tal senso,<br />
sono strategici gli articoli del documento che riguardano i sistemi di istruzione e formazione (anche<br />
degli adulti): secondo i governanti europei, un loro adeguamento al tipo di società che si va<br />
delineando comporta particolare attenzione allo sv<strong>il</strong>uppo delle discipline scientifiche, delle<br />
competenze informatiche, delle lingue straniere, della conoscenza della storia più recente. Come<br />
giovane di oggi, e donna di domani, mi sento un grosso carico sulle spalle (che d’altronde ogni<br />
giovane di ogni tempo si è ritrovato, credo, a dover sopportare). Ho una sorta di quadro del futuro<br />
che si vuole raggiungere. E mi domando come portare avanti i progressi che l’uomo ha compiuto,<br />
come sostenere un’economia in un mondo sotto pressione, come controllare gli effetti delle scelte<br />
umane sulla società e sull’ambiente. Che cosa penso io di tutto questo? E che cosa sta davvero<br />
accadendo nel mio percorso di formazione, tale da rendermi persona competente ed occupata<br />
seriamente in qualcosa di produttivo?<br />
Nell’archivio delle mie esperienze personali di studentessa, ritrovo (forse un inizio di risposta?) un<br />
articolo di quotidiano. È una lettera ai giovani di Tullio Regge che la nostra insegnante di Lettere<br />
ha proposto in prima superiore a me e ai miei compagni di classe, per farci pensare. Appunto:<br />
pensare. Il fisico solleva una questione curiosa e problematica: ai suoi tempi si orientò allo studio<br />
della fisica perché andava di moda. “Di questi tempi però, la carica rivoluzionaria della fisica si sta<br />
esaurendo” dice Regge, “mentre la bandiera della rivoluzione è oramai in mano alla biologia”.<br />
Quello che Regge (e quindi anche la nostra prof) intende è che dobbiamo rivolgerci alle scienze<br />
senza farci contagiare da fac<strong>il</strong>i entusiasmi. Sv<strong>il</strong>uppare un senso critico, valutare le cose per quelle<br />
che sono e saper giudicare: questo è già scienza. Sapere scientifico significa documentarsi,<br />
andare alla ricerca di conferme e risposte; <strong>il</strong> miglior metodo scientifico è l’applicazione del senso<br />
critico “ossia la capacità di valutare le cose per quello che sono, senza f<strong>il</strong>tri demagogici o<br />
dogmatismi di sorta, avendo <strong>il</strong> coraggio, se necessario, di dubitare anche di quello che tutti<br />
sembrano ritenere ovvio.” E uno degli stereotipi più radicati nella nostra cultura è che materie<br />
scientifiche e umanistiche siano due mondi totalmente diversi e a sé stanti. Eppure, se potesse<br />
ricominciare, un grande ricercatore di Fisica come Tullio Regge studierebbe Storia dell’arte (è lui a<br />
dirlo!). Osservando dei dipinti di Piero della Francesca, trova tra le pennellate di colore<br />
complicatissime forme geometriche (<strong>il</strong> pentagondodecaedro!), radici quadrate nella sezione aurea,<br />
simmetria pentagonale e <strong>leggi</strong> di prospettiva… combinazioni, insomma, tra studi d’arte e calcoli<br />
matematici. E l’emozione che prova riuscendo a cogliere la bellezza di un affresco sta anche<br />
nell’apprezzare la bellezza di un’equazione fisica o di un teorema di matematica, come nel modo<br />
“in cui ci piace un brano musicale, proprio per la sua perfezione numerica e geometrica”: lo dice<br />
Regge, ma, da musicista, io so che ha ragione.<br />
1
Rovistando nel mio archivio, trovo un’altra esperienza scolastica (secondo tassello di possib<strong>il</strong>e<br />
risposta?), che ha affiancato in maniera “fondante” la lettura di Regge: la visione del f<strong>il</strong>m Big fish, di<br />
Tim Burton. Fantasia, invenzione, parole, racconto, emozione; storia di padri e di figli, del<br />
testimone invisib<strong>il</strong>e che una generazione passa all’altra: <strong>il</strong> racconto di sé. Questo f<strong>il</strong>m si collega in<br />
un certo senso al <strong>testo</strong> di cui ho parlato prima e ne integra <strong>il</strong> messaggio. “Continuando a<br />
raccontare le sue storie, un uomo si trasforma in esse”, dice la voce fuori campo nel finale.<br />
Seguendo la proiezione e riflettendo, ho rivisto <strong>il</strong> mio modo di concepire la storia; ho capito che<br />
ognuno è la storia che racconta di sé e che gli altri raccontano di lui: nella narrazione che noi<br />
facciamo del nostro passato comune troviamo noi stessi insieme agli altri. Conoscerci è già sapere<br />
come impiegare le nostre risorse, come far fronte alle debolezze, come impegnarci per un futuro:<br />
è già un buon inizio di una storia a lieto fine.<br />
Ho riportato queste due esperienze per introdurre la mia tesi. Ben venga una società delle<br />
conoscenza, ma non fondata sul mito scientifico-tecnologico, quanto piuttosto sulla valorizzazione<br />
degli intrecci critici tra i saperi, sul confronto e <strong>il</strong> raccordo con l’altro/<strong>il</strong> diverso, sull’attenzione per le<br />
persone, la loro testa e le loro storie, senza preclusioni: in questo stanno i presupposti della vera<br />
innovazione.<br />
La scuola può fare molto per noi. Naturalmente contano i saperi che propone, ma conta molto<br />
anche <strong>il</strong> metodo con cui li fa acquisire. Trovo importante lo scambio di informazioni, esperienze e<br />
buone prassi tra le scuole dalle varie parti dell’Italia e dell’Europa: <strong>il</strong> mettere a confronto le<br />
esperienze e le iniziative che ogni scuola attua, a mio avviso crea una sorta di “complicità” tra gli<br />
studenti, che possono sentirsi partecipi, invogliati ed aperti alle innovazioni.<br />
Lo scambio è fac<strong>il</strong>itato dalla conoscenza della storia contemporanea (<strong>il</strong> nostro retroterra, quello di<br />
chi ci sta vicino) e delle lingue straniere, strumento fondamentale per la condivisione di un progetto<br />
a lungo termine tra zone diverse dell’Europa. La “complicità” può contribuire - cosa per me più<br />
importante di tutte - all’abbattimento di certe barriere che oggi rappresentano l’ostacolo forse più<br />
grande per una società aperta all’innovazione tecnologica - scientifica, ma purtroppo a tutt’oggi<br />
ancorata a certe stupide, primitive convinzioni sull’altro: dai pregiudizi razziali all’imbarazzo che<br />
molti ancora provano nel vedere una coppia di omosessuali che si danno la mano. Mentre è certo<br />
che una comunità tollerante è una società già ben evoluta rispetto ad altre.<br />
In tal senso apprezzo le attività che la mia scuola (anche in collegamento con altre) sta<br />
intraprendendo, sia per quanto riguarda la scelta dei contenuti che dei metodi. Citerò le due che a<br />
mio avviso sono più interessanti nella prospettiva di Lisbona 2010, ma anche della mia tesi.<br />
Frequento un Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale, <strong>il</strong> cui curricolo è stato modificato con un<br />
progetto autonomo per far spazio all’Informatica: nel biennio per la preparazione all’ECDL, nel<br />
triennio come supporto allo studio della Matematica e della Fisica. Possiamo effettivamente<br />
contare sulla possib<strong>il</strong>ità di accedere al “nostro” computer personale anche per svolgere la prova<br />
scritta d’Italiano, svolgere e documentare attività di ricerca, metterci in contatto via blog e forum,<br />
come abbiamo fatto per la Storia <strong>il</strong> primo anno. In quell’occasione abbiamo messo a confronto <strong>il</strong><br />
nostro metodo di studio della Storia e le competenze acquisite con una classe di un altro istituto in<br />
un forum appositamente predisposto in collaborazione dalle rispettive insegnanti. È stata<br />
un’esperienza diversa dal solito e positiva, che a mio parere dovrebbe essere proposta più spesso<br />
e a più classi. L’impiego mirato di strumenti informatici, che uno studente spesso conosce bene<br />
per conto suo, è un modo per aggiornare sistemi di studio, applicati a saperi diversi: è divertente,<br />
ma soprattutto formativo, perché crea ambienti di apprendimento in cui sei obbligato a ragionare, a<br />
mettere in gioco i concetti, ad affrontare in modo problematico le conoscenze di cui parli, anziché<br />
ripetere le pagine di un manuale.<br />
Ma l’esperienza con cui vorrei chiudere è <strong>il</strong> Progetto di Educazione alla Pace: alla fine dell’anno la<br />
mia scuola, con scuole austriache, slovene, francesi e di altre parti di Italia si incontrerà a Forni di<br />
Sopra, concludendo un percorso fatto di riflessioni, giochi, letture sulle culture “altre” mirato ad<br />
avvicinare tra loro gli studenti. Noi porteremo per l’occasione dei balli popolari tipici delle varie<br />
zone del mondo, ma anche momenti di laboratorio teatrale: sarà quest’incontro l’occasione giusta<br />
2
in cui impiegare le nostre competenze linguistiche in situazione e stab<strong>il</strong>ire contatti che potranno<br />
magari avere ulteriori sv<strong>il</strong>uppi.<br />
La mia classe non ha condiviso in modo continuativo altre esperienze con gruppi diversi, ma se<br />
potessi dare un suggerimento, vorrei si incentivassero attività come queste, in particolare viaggi<br />
d’istruzione e scambi linguistici, per formare quella “complicità” fra studenti d’Europa e magari del<br />
Mondo di cui ho detto. D’altra parte suggerirei anche una valorizzazione della lingua latina (nei vari<br />
indirizzi): sono consapevole che col latino non si gira <strong>il</strong> mondo, ma l’analisi di un periodo d’autore<br />
implica ragionamenti rigorosi, quasi di tipo matematico, che allenano la mente (e questo è<br />
formativo). Per parte mia, in privato, coltivo blog, viaggi, chat e tutto quanto mi permetta di<br />
confrontarmi con i miei coetanei e conoscerli, perché ciò che assolutamente ritengo importante<br />
evitare è <strong>il</strong> rischio di “autismo” (David Goleman dixit) cui si può andare incontro in una società che<br />
è tutta tecnologia. Ma spero soprattutto che in ogni percorso di studi gli insegnanti (ancora<br />
persone), possano aiutarmi a costruire pensiero e senso critico: forse è grazie a Regge, a Big fish,<br />
al computer n. 13, alla Storia in forum, al progetto di Educazione alla Pace che potrò costruire<br />
anch’io un pezzetto di Lisbona 2010.<br />
Materiale (bibliografico e sitografico) consultato:<br />
Regge T., Giovani, vi esorto alle scienze, in TTL inserto allegato a La Stampa del 2/10/2004<br />
http://ed.europa.eu<br />
www.istruzione.it<br />
www.bdp.it<br />
3