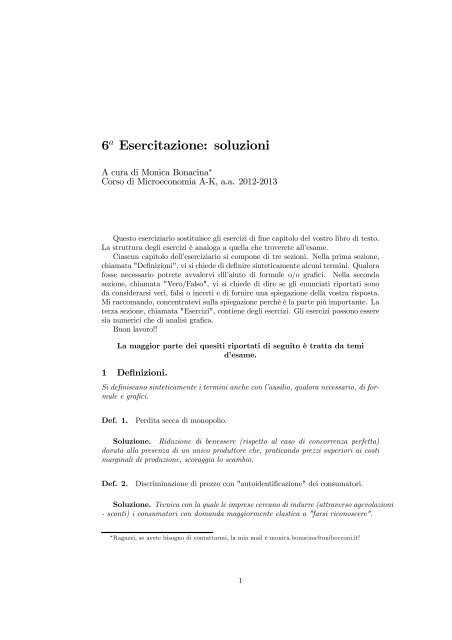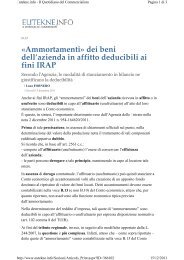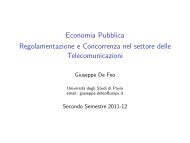Svolgimento 6 - Economia
Svolgimento 6 - Economia
Svolgimento 6 - Economia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6 Esercitazione: soluzioni<br />
A cura di Monica Bonacina ∗<br />
Corso di Microeconomia A-K, a.a. 2012-2013<br />
Questo eserciziario sostituisce gli esercizi di fine capitolo del vostro libro di testo.<br />
La struttura degli esercizi è analoga a quella che troverete all’esame.<br />
Ciascun capitolo dell’eserciziario si compone di tre sezioni. Nella prima sezione,<br />
chiamata "Definizioni",visichiededidefinire sinteticamente alcuni termini. Qualora<br />
fosse necessario potrete avvalervi dll’aiuto di formule o/o grafici. Nella seconda<br />
sezione, chiamata "Vero/Falso", vi si chiede di dire se gli enunciati riportati sono<br />
da considerarsi veri, falsi o incerti e di fornire una spiegazione della vostra risposta.<br />
Mi raccomando, concentratevi sulla spiegazione perchè è la parte più importante. La<br />
terza sezione, chiamata "Esercizi", contiene degli esercizi. Gli esercizi possono essere<br />
sia numerici che di analisi grafica.<br />
Buon lavoro!!<br />
La maggior parte dei quesiti riportati di seguito è tratta da temi<br />
d’esame.<br />
1 Definizioni.<br />
Si definiscano sinteticamente i termini anche con l’ausilio, qualora necessario, di formule<br />
e grafici.<br />
Def. 1. Perdita secca di monopolio.<br />
Soluzione. Riduzione di benessere (rispetto al caso di concorrenza perfetta)<br />
dovuta alla presenza di un unico produttore che, praticando prezzi superiori ai costi<br />
marginali di produzione, scoraggia lo scambio.<br />
Def. 2. Discriminazione di prezzo con "autoidentificazione" dei consumatori.<br />
Soluzione. Tecnica con la quale le imprese cercano di indurre (attraverso agevolazioni<br />
- sconti) i consumatori con domanda maggiormente elastica a "farsi riconoscere".<br />
∗ Ragazzi, se avete bisogno di contattarmi, la mia mail è monica.bonacina@unibocconi.it!<br />
1
Def. 3. Discriminazione perfetta o del primo tipo.<br />
Soluzione. Tecnica con la quale le imprese disponendo di tutte le informazioni<br />
circa la disponibilità a pagare dei singoli consumatori riescono ad estrarre tutto il<br />
surplus dei consumatori.<br />
Def. 4. Monopolio naturale.<br />
Soluzione. Situazione in cui, data la presenza di rendimenti di scala crescenti<br />
(ossia di economie di scala) nella produzione (in corrispondenza dell’attuale livello<br />
di domanda), è più efficiente che il bene venga prodotto da una sola impresa.<br />
Def. 5. Concorrenza monopolistica.<br />
Soluzione. Situazione molto simile a quella di concorrenza perfetta, caratterizzata<br />
da: (1) libertà d’entrata e di uscita, (2) presenza di un numero molto elevato<br />
di imprese e di consumatori, (3) prodotti imperfetti sostituti. Il bene prodotto dalle<br />
imprese presenti sul mercato, a differenza di quanto avviene in concorrenza perfetta,<br />
non è omogeneo e, quindi, non è un perfetto sostituto del bene prodotto dalle imprese<br />
rivali.<br />
Def. 6. Mark-up.<br />
Soluzione. Indicatore che consente di misurare il potere di mercato di un produttore<br />
ovvero la capacità di un’impresa di praticare un prezzo superiore al proprio<br />
costo marginale senza perdere tutti i clienti: [P-MC]/P.<br />
2 Vero/Falso.<br />
Si stabilisca se gli enunciati sono veri, falsi, o incerti. Si fornisca una spiegazione<br />
(anche grafica se opportuno) e si argomenti compiutamente la risposta.<br />
Vero/Falso 7. Un’impresa monopolista in equilibrio non produce mai una quantità<br />
in corrispondenza del tratto inelastico della curva di domanda<br />
Vero. L’output di monopolio verifica la condizione MR=MC. Il costo marginale,<br />
che misura l’aumento nel costo totale dovuto alla produzione di un’unità aggiuntiva di<br />
prodotto, è non negativo quindi anche il ricavo marginale dovrà essere non negativo.<br />
Ricordando che il ricavo marginale può essere scritto come MR=(1 − 1), dove è<br />
il valore assoluto dell’elasticità della domanda la condizione di non negatività sul<br />
ricavo marginale implica<br />
µ<br />
1 − 1<br />
<br />
≥ 0<br />
<br />
Stante la non negatività del prezzo in equilibrio, quanto sopra implica che il termine<br />
in parentesi dovrà essere non negativo ovvero che<br />
¡ ¢<br />
1<br />
1<br />
1 − ≥ 0 →− ≥−1→ ≥ 1<br />
2
Vero/Falso 8. Un’impresa che opera in regime di monopolio all’aumentare della<br />
produzione incrementa i propri ricavi in misura inferiore al prezzo dell’ultima unità<br />
venduta.<br />
Vero. L’aumento nel ricavo totale derivante dalla produzione di un’unità aggiuntiva<br />
è pari al ricavo marginale ed il ricavo marginale di un monopolista è<br />
= + <br />
<br />
in quanto dp/dq (pendenza della curva di domanda inversa) è negativo.<br />
Vero/Falso 9. Considerate un mercato in cui opera una sola impresa con costi<br />
marginali costanti e pari a 3 ed in cui la domanda di mercato ha elasticità costante<br />
uguale a -2. Il prezzo di equilibrio di mercato sarà pari a 6.<br />
Vero. In equilibrio il costo marginale deve eguagliare il ricavo marginale. ricordando<br />
che = (1 + −1 ) e sostituendo abbiamo che<br />
= → (1 + −1 )=3→ =6<br />
Vero/Falso 10. Il mercato dello stoccaggio è un monopolio naturale. Se lo Stato<br />
imponesse all’unico produttore presente sul mercato dello stoccaggio di vendere il suo<br />
prodotto ad un prezzo pari al costo marginale, il profitto del monopolista sarebbe<br />
nullo<br />
Falso. Dato che in presenza di monopolio naturale i costi medi sono decrescenti<br />
(e quindi i marginali sono sempre inferiori ai costi medi), se l’impresa fosse costretta<br />
a praticare un prezzo pari al costo marginale subirebbe delle perdite economiche.<br />
Vero/Falso 11. In presenza di monopolio il sovrappiù totale (benessere sociale) è<br />
sempre inferiore a quello che si avrebbe in concorrenza perfetta.<br />
Falso. Con discriminazione perfetta il benessere sociale è massimo (analogo a<br />
quello che si riscontra con concorrenza perfetta) anche se è tutto profitto.<br />
Vero/Falso 12. Un monopolista che è in grado di praticare una discriminazione<br />
di prezzo su due mercati adotterà un prezzo più elevato sul mercato caratterizzato<br />
dalla domanda maggiormente elastica.<br />
Falso. Un monopolista che può discriminare tra due mercati praticherà un prezzo<br />
più elevato sul mercato caratterizzato da una domanda relativamente meno elastica.<br />
Vero/Falso 13. Se un monopolista riesce discriminare perfettamente (“primo tipo”)<br />
tra i suoi acquirenti, la sua curva di ricavo marginale coinciderà con la curva di domanda<br />
di mercato.<br />
Vero. In questo caso - e solo in questo caso - l’aumento nei ricavi totali del<br />
monopolista dovuto alla vendita di una unità aggiuntiva di output è esattamente pari<br />
3
al prezzo dell’ultima unità venduta.<br />
Vero/Falso 14. Considerate un mercato in cui opera una sola impresa con costi<br />
marginali costanti e pari ad 1. Se la curva di domanda inversa è p =11− , il<br />
surplus dei consumatori in corrispondenza dell’equilibrio di monopolio sarà pari a 10.<br />
Falso. Il monopolista venderà 5 unità di output ad un prezzo pari a 6 (MR=MC<br />
implica 11-2Q=1). Quindi il surplus dei consumatori sarà SC=(11-6)×52 =252.<br />
Vero/Falso 15. Considerate un mercato in cui opera una sola impresa con =<br />
. Se la curva di domanda inversa è p =30− , la perdita secca di monopolio è<br />
pari a 25.<br />
Vero. Ilmonopolistavenderà10unitàdioutputadunprezzoparia20(MR=MC<br />
implica 30-2Q=Q); quindi il benessere sociale in monopolio sarà pari a 200, essendo<br />
SP=(10+20)×102 = 150 e SC=(30-20)×102 =50. In concorrenza perfetta sarebberostatevendute15unitàdioutputadunprezzoparia15(P=MCdacui30-Q=Q),<br />
generando un benessere complessivo di 225; dunque la perdita secca di monopolio è<br />
225-200=25.<br />
Vero/Falso 16. Il monopolista Hicks produce CD. Attualmente Hicks sta producendo<br />
il livello di output che massimizza i suoi profitti. In corrispondenza di tale<br />
livello di output, i profitti di Hicks sono pari a 2000. In seguito all’introduzione di<br />
una tassa in somma fissa sulle vendite di CD pari a 500, Hicks deciderà sicuramente<br />
di aumentare il prezzo dei CD.<br />
Falso. La tassa in somma fissa non modifica i costi marginali del monopolista;<br />
quindi non modifica la sua decisione di produzione. La sola conseguenza è una contrazione<br />
del profittodelmonopolistacheèoraparia1500(2000-500).<br />
Vero/Falso 17. Se un monopolista producesse una quantità Q tale per cui MR <br />
MC, allora il suo profitto sarebbe negativo.<br />
Falso/Incerto. Dato che in monopolio PMR, pur non scegliendo la quantità<br />
che consente al monopolista di massimizzare il proprio profitto non è detto che il<br />
monopolista subisca una perdita. Il monopolista subirebbe una perdita se e solo se<br />
PAC. Il fatto che MRMC non implica che in corrispondenza del livello di output<br />
scelto dal monopolista PAC.<br />
Vero/Falso 18. Un monopolista sceglie di produrre fintanto che il beneficio derivante<br />
dalla vendita dell’ultima unità prodotta eguaglia il costo che egli sostiene per produrre<br />
tale unità.<br />
Vero. Il monopolista produce fintanto che il beneficio dell’ultima unità prodotta<br />
(MR) eguaglia il costo che il monopolista sostiene per produrre tale unità (MC).<br />
4
Vero/Falso 19. Beck’s produce birra in condizioni di monopolio. I costi marginali<br />
di Beck’s sono MC=200+5Q mentre la domanda inversa di birra è p =900-15Q.<br />
Allora, supponendo che Beck’s scelga il livello di output in corrispondenza del quale<br />
isuoiprofitti sono massimi, i ricavi totali di Beck’s saranno pari a 1200.<br />
Falso. Il monopolista sceglie di produrre 20 unità di output (MR=MC implica<br />
in questo caso 900-30Q=200+5Q) e le vende ad un prezzo di 600. I ricavi totali del<br />
monopolista sono quindi 12000 (20x600).<br />
Vero/Falso 20. Jack vende tulipani in condizioni di monopolio. La domanda inversa<br />
di mercato di tulipani è p =100-Q. Sicuramente Jack deciderà di vendere meno<br />
di 50 tulipani.<br />
Vero. Se Jack scegliesse di produrre più di 50 tulipani si troverebbe a produrre<br />
lungo il tratto inelastico della curva di domande quindi non starebbe massimizzando<br />
isuoiprofitti.<br />
Vero/Falso 21. Un monopolista è in grado di praticare una discriminazione di<br />
prezzo del primo tipo. Se la curva di domanda inversa fronteggiata dal monopolista<br />
èP = 2100 − 20 ed i costi marginali di produzione sono pari a 100, allora il<br />
monopolista deciderà di vendere 100 unità di output.<br />
Vero. Un monopolista che può praticare una discriminazione di prezzo del primo<br />
tipo venderà lo stesso numero di unità di output che sarebbero vendute in concorrenza<br />
perfetta quindi Q=200 (ottenuto risolvendo 2100-20Q=100).<br />
Vero/Falso 22. Se un monopolista si trova di fronte ad una curva di domanda<br />
rigida, la perdita secca di monopolio è nulla.<br />
Vero. In questo caso il monopolista venderebbe esattamente lo stesso numero di<br />
unità di output che sarebbero vendute in concorrenza perfetta.<br />
Vero/Falso 23. Il bene Q viene prodotto in condizioni di monopolio. La curva<br />
di domanda è Q=100-P ed ogni unità del bene viene prodotta sostenendo un costo<br />
costante e pari a 20. In corrispondenza del livello di output che massimizza i profitti<br />
del monopolista il surplus sociale è pari a 2400.<br />
Vero. Il monopolista sceglie di produrre 40 unità di output (MR=MC implica<br />
100-2Q=20) che saranno vendute ad un prezzo pari a 60. Il surplus totale in corrispondenza<br />
d tae equilibrio di mercato è pari a (80+40)x40/2=2400.<br />
Vero/Falso 24. Un monopolista vende sigari in due mercati: A e B. La domanda<br />
del mercato A è Q=20-P mentre quella del mercato B è Q=40-2P. Potendo<br />
praticare una discriminazione del terzo tipo, il monopolista sceglierà un prezzo mag-<br />
5
giore per i consumatori che risiedono nel mercato A.<br />
Falso. Nel caso in cui il monopolista possa praticare una discriminazione di<br />
prezzo del terzo tipo sceglierà di praticare un prezzo più elevato ai consumatori che si<br />
caratterizzano per una domanda meno elastica. E’ quindi necessario calcolare i valori<br />
dell’elasticità della domanda nei due mecati. L’elasticità della domanda nel mercato<br />
A è (-1)P/[20-P] mentre l’elasticità della domanda nel mercato B è (-2)P/[40-2P]=(-<br />
1)P/[20-P]. Dal momento che per ogni livello di prezzo i due mercati si caratterizzano<br />
per un analogo valore dell’elasticità, il monopolista - pur potendo discriminare tra i<br />
due mercati - praticherà il medesimo prezzo ai due gruppi di consumatori.<br />
Vero/Falso 25. Il bene Q viene prodotto in condizioni di monopolio. La curva<br />
di domanda è Q=100-P ed ogni unità del bene viene prodotta sostenendo un costo<br />
costante e pari a 20. In corrispondenza del livello di output che massimizza i profitti<br />
del monopolista, la perdita secca della società è pari a 800.<br />
Vero. Il monopolista sceglie di produrre 40 unità di output (MR=MC implica<br />
100-2Q=20) che saranno vendute ad un prezzo pari a 60. I surplus totale in monopolio<br />
è pari a (80+40)x40/2=2400. In concorrenza perfetta sarebbero state prodotte<br />
80 unità di output in quanto le imprese avrebbero praticato un prezzo pari al costo<br />
marginale; quindi il surplus totale dell’economia sarebbe stato pari a 3200 (ovvero<br />
(100-20)x80/2). La perdita secca di monopolio è quindi 3200-2400=800.<br />
Vero/Falso 26. Si consideri il grafico sottostante dove vengono rappresentate la<br />
curva di domanda, la curva di ricavo marginale (MR) e quella di costo marginale<br />
(MC) di un mercato in cui opera un monopolista. La perdita secca di monopolio è<br />
rappresentata dall’area del triangolo ABC.<br />
P<br />
A MC<br />
B<br />
C<br />
MR<br />
Domanda<br />
Falso. La perdita secca dovua alla produzione del bene da parte di un monopolista<br />
consiste sia nel tringolo indicato che nel triangolo indicato con un tratteggio nel<br />
grafico sottostante.<br />
6<br />
Q
P<br />
A MC<br />
B<br />
C<br />
MR<br />
Domanda<br />
Vero/Falso 27. Si consideri il grafico sottostante dove vengono rappresentate la<br />
curva di domanda, la curva di ricavo marginale (MR) e quella di costo marginale<br />
(MC) di un mercato in cui opera un monopolista. Il profitto del monopolista è<br />
rappresentato dall’area del rettangolo ABCD.<br />
P<br />
D<br />
C<br />
A MC<br />
B<br />
MR<br />
Q<br />
Domanda<br />
Falso. Il profitto del monopolista è pari all’area indicata con un tratteggio nel<br />
grafico sottostante (meno, qulora ci fossero, i costi fissi sostenuti dal monopolista).<br />
7<br />
Q
P<br />
D<br />
C<br />
A MC<br />
B<br />
MR<br />
Domanda<br />
Vero/Falso 28. Un monopolista deve decidere quante unità di output produrre.<br />
I suoi costi ed i suoi ricavi totali sono rappresentati nella seguente tabella. Allora<br />
volendo massimizzare il proprio profitto, il monopolista dovrebbe produrre 3 unità<br />
di output.<br />
Quantità Ricavi totali Costi totali<br />
1 9 5<br />
2 16 9<br />
3 21 13<br />
4 24 17<br />
5 25 21<br />
Vero. Laproduzionedellasecondaunitàconsentealmonopolistaunricavoaggiuntivo<br />
di 7 (16-9=7) e comporta un costo aggiuntivo di (9-5=4). La produzione<br />
della terza unità consente al monopolista un ricavo aggiuntivo di 5 (21-16=5) e comporta<br />
un costo aggiuntivo di 4 (13-9=4). La produzione della quarta unità consente<br />
al monopolista un ricavo aggiuntivo di 3 (24—21=3) e comporta un costo aggiuntivo<br />
di 4 (17—13=4). La produzione della quinta unità consente al monopolista un ricavo<br />
aggiuntivo di 1 e comporta un costo aggiuntivo di 4. Volendo massimizzare i profitti,<br />
ilmonopolistasceglieràdiprodurre3unitàdioutputinquantolaproduzionedella<br />
quarta unità porterebbe ad una contrazione dei profitti (MRMC in corrispondenza<br />
di tale unità - come pure delle successive).<br />
Vero/Falso 29. Un monopolista deve decidere quante unità di output produrre.<br />
I suoi costi ed i suoi ricavi totali sono rappresentati nella seguente tabella. Allora<br />
volendo massimizzare il proprio profitto, il monopolista dovrebbe produrre 5 unità<br />
di output.<br />
8<br />
Q
Quantità Ricavi totali Costi totali<br />
1 20 1<br />
2 38 4<br />
3 54 9<br />
4 68 16<br />
5 80 25<br />
6 90 36<br />
7 98 49<br />
8 104 64<br />
9 108 81<br />
Falso. Nella tabella sottostante sono riportati i ricavi marginali ed i costi marginali<br />
connessi alla produzione di ciascuna unità addizionale di output.<br />
Quantità Ricavi totali Costi totali MR MC<br />
1 20 1 - -<br />
2 38 4 18 3<br />
3 54 9 16 5<br />
4 68 16 14 7<br />
5 80 25 12 9<br />
6 90 36 10 11<br />
7 98 49 8 13<br />
8 104 64 6 15<br />
9 108 81 4 17<br />
Il monopolista massimizza i suoi profitti producendo 5 unità di ouput in quanto la produzione<br />
di un’unità aggiuntiva alla quinta comporterebbe una contrazione dei profitti<br />
del monopolista essendo il beneficio derivante dalla produzione di tale unità aggiuntiva<br />
inferiore al costo che il monopolista deve sostenere per produrre tale unità.<br />
Vero/Falso 30. Un monopolista si caratterizza per le curve di costo totale (TC)<br />
e di ricavo totale (TR) indicate nel grafico sottostante. Il monopolista potrebbe<br />
massimizzare i suoi ricavi totali scegliendo di produrre un livello di output pari a<br />
Q.<br />
TR<br />
TC<br />
Q C<br />
Q B<br />
9<br />
Q A<br />
TC<br />
TR<br />
Q
Falso. In corrispondenza di tale livello, Q , non è massima la distanza tra ricavo<br />
marginale e costo marginale ed i profitti del monopolista sono massimi quando<br />
è massima la distanza tra ricavi totali e costi totali. Alternativamente potreste dire<br />
che, in corrispondenza del livello di output Q la condizione MR=MC non può essere<br />
verificata essendo le pendenza delle due curve (di ricavo totale e di costo totale)<br />
diverse.<br />
Vero/Falso 31. Nel caso in cui sia concesso al monopolista di effettuare una discriminazione<br />
perfetta (primo tipo), l’esito raggiunto dal mercato sarà efficiente nel<br />
senso di Pareto.<br />
Vero. La discriminazione perfetta induce il monopolista a produrre il livello di<br />
output socialmente ottimale (che massimizza il surplus); quindi tale equilibrio di mercato<br />
è efficiente nel senso di Pareto in quanto non sarebbe possibile incrementare<br />
ulteriormente il benessere di almeno uno dei soggetti presenti sul mercato senza eggiorare<br />
la situazione di almeno un altro.<br />
Vero/Falso 32. Un monopolista che utilizza una discriminazione di prezzo del<br />
terzo tipo impone prezzi differenti a due gruppi di consumatori. Al gruppo A vende<br />
il prodotto al prezzo p=10, mentre al gruppo B fa pagare un prezzo pari a p=20<br />
per ogni unità acquistata. Questo significa che la domanda del gruppo A è meno<br />
elastica della domanda del gruppo B.<br />
Falso.Un monopolista che ha la possibilità di segmentare due mercati (applicare<br />
un prezzo diverso per soggetti residenti in due aree geografiche distinte - o soggetti<br />
appartenenti a due gruppi chiaramente classificabili e distinguibili) adotterà un prezzo<br />
più elevato per il gruppo con domanda meno elastica. Nel caso in esame il gruppo<br />
A paga un prezzo inferiore a quello del gruppo B; dunque la domanda del gruppo A<br />
sarà relativamente più elastica della domanda del gruppo B.<br />
Vero/Falso 33. Un monopolista si caratterizza per le curve di costo totale (TC)<br />
e di ricavo totale (TR) indicate nel grafico sottostante. Il monopolista potrebbe<br />
massimizzare i suoi profitti scegliendo di produrre un livello di output pari a Q.<br />
TR<br />
TC<br />
Q C<br />
Q B<br />
10<br />
Q A<br />
TC<br />
TR<br />
Q
Falso. Illivellodioutputchemassimizzailprofittodelmonopolistasaràsicuramente<br />
inferiore al livello Q in quanto in corrispondenza del livello di output che<br />
massimizza i profitti del monopolista è massima la distanza tra ricavi totali e costi<br />
totali del monopolista (ossia le due curve devono avere la stessa pendenza).<br />
3 Esercizi.<br />
Si risolvano i seguenti esercizi.<br />
Esercizio 1. L’azienda Geko s.p.a. opera come monopolista sul mercato delle ventose<br />
e la sua funzione dei costi totali è pari a () =10+ 2 . Supponete che la<br />
domanda di mercato delle ventose sia =30− . (1) Calcolate la quantità ed il<br />
prezzo di equilibrio. A quanto ammontano i profitti della Geko e l’elasticità della<br />
domanda al prezzo in corrispondenza di tale punto di equilibrio. (2) Rappresentate<br />
graficamente la posizione di equilibrio della Geko sul mercato, indicando i profitti<br />
totali. (3) Possiamo affermare che il mercato delle ventose è un monopolio naturale?<br />
Motivate la vostra risposta in modo esauriente (analiticamente e graficamente).<br />
Soluzioni. (1) Stanti i ricavi marginali ed i costi marginali della Geko<br />
<br />
<br />
= =30−2 = =2<br />
l’equilibrio di monopolio è<br />
= → = 30<br />
4<br />
da cui un profittodellaGekoparia<br />
15 = 2 ; =30− 15 60−15 45<br />
2 = 2 = 2<br />
= − ( )= 15 45<br />
2 2 − 10 − ¡ 15<br />
2<br />
¢ 2 = 225−20<br />
2<br />
205 = 2<br />
L’elasticità della domanda in corrispondenza dell’equilibrio di monopolio è pari a<br />
= −1 <br />
= − 45<br />
15 = −3<br />
e siamo in un tratto elastico della curva di domanda.<br />
(2) Data la presenza di costi fissi il surplus del produttore non coincide con il<br />
profitto economico. Calcoliamo il valore del costo medio in corrispondenza dell’output<br />
dimonopolioedindichiamoiprofitti come differenza tra prezzo praticato e costi medi,<br />
moltiplicata per i volumi prodotti. Formalmente<br />
quindi graficamente<br />
( 15 10 15<br />
2 )= 152 + 2 =88¯3 ( 15<br />
2 )=215 2 =15<br />
P<br />
30<br />
(45/2)=P M<br />
15<br />
8.83=AC(15/2)<br />
MC<br />
MR<br />
Eq. monopolio<br />
Profitti<br />
Domanda<br />
0 (15/2)=Q M 15 30 Q<br />
11
(3) Affinché un mercato sia di monopolio naturale i costi medi devono essere<br />
decrescenti. Nel caso in esame<br />
da cui<br />
= 10<br />
+ <br />
<br />
<br />
= − 10<br />
2 +1<br />
che è decrescente in corrispondenza di livelli di produzione inferiori a √ 10 (crescente<br />
altrimenti) e raggiunge un minimo in corrispondenza di Q= √ 10; dunque non si tratta<br />
di monopolio naturale. Graficamente<br />
P<br />
30<br />
P M<br />
15<br />
minAC<br />
MC<br />
MR<br />
AC<br />
Domanda<br />
0 Q M 15 30 Q<br />
Esercizio 2. Un’impresa monopolistica fronteggia la seguente curva di domanda<br />
inversa: =56− 2, dove q indica l’offerta aggregata. L’impresa sostiene dei costi<br />
totali di produzione pari a () =40. (1) Calcolate costi marginali, ricavi marginali<br />
e quantità prodotta in equilibrio dal monopolista. (2) Calcolate il surplus del produttore<br />
in corrispondenza della quantità prodotta in equilibrio. (3) Supponete ora<br />
che il monopolista decida di acquisire al prezzo di 10 un brevetto che gli consenta<br />
di diminuire i suoi costi totali di 4 per ogni unità prodotta. Quale sarà la nuova<br />
quantità prodotta in equilibrio e quale sarà il nuovo profitto del monopolista?<br />
Soluzioni. (1) I costi marginali ed i ricavi marginali del monopolista sono rispettivamente<br />
<br />
<br />
= =40= =56−4 L’equilibrio di monopolio è dunque<br />
= → 56 − 4 =40→ =4 =48<br />
(2) Il surplus del produttore (in assenza di costi fissi coincide con il profitto) è<br />
pari a<br />
− ( )=32<br />
(3) In seguito all’acquisizione del brevetto (che porta il costo totale del monopolista<br />
a 0() =40 − 4 +10) il costo marginale di produzione sarà<br />
da cui un nuovo equilibrio di monopolio<br />
ed un relativo profitto pari a<br />
0 =36<br />
= 0 → 56 − 4 =36→ 0 =5 0 =46<br />
0 0 − 0 ( 0 )=40<br />
12
Esercizio 3. L’impresa Rintel è l’unica produttrice di semiconduttori nel paese di<br />
Silicionia. Per produrre microprocessori essa sostiene costi totali pari a =16+4<br />
ove con Q si indica la quantità totale prodotta. L’impresa si confronta con una curva<br />
di domanda di mercato =20− . (1) Calcolate e fornite una rappresentazione<br />
grafica dell’equilibrio di monopolio. (2) Supponete ora che lo Stato introduca una<br />
tassa pari a 2 per ogni unità venduta. Quali saranno il nuovo prezzo e la quantità<br />
di equilibrio in questo caso? Calcolate inoltre l’ammontare totale incassato dallo<br />
stato ed il nuovo profitto di Rintel. (3) Secondo voi il nuovo equilibrio ottenuto dopo<br />
l’introduzione della tassa è più o meno efficiente dal punto di vista sociale di quello<br />
trovato al punto 2? (Non sono richiesti calcoli)<br />
Soluzioni. (1) I costi marginali ed i ricavi marginali del monopolista sono rispettivamente<br />
= =20−2 <br />
<br />
=4= <br />
<br />
Lascio a voi la rappresentazione grafica ma vi faccio notare che la curva di domanda<br />
inversa si caratterizza per un’intercetta orizzontale (20;0), un’intercetta verticale<br />
(0;20) e pendenza -1; quella di ricavo marginale ha la stessa intercetta verticale<br />
della curva di domanda ma pendenza doppia quindi l’intercetta orizzontale sarà<br />
(10;0). La curva di costo marginale è una retta orzzontale in corrispondenza del<br />
valore 4. La quantità prodotta dal monopolista si individua rislvendo la seguente<br />
equazione MR=MC e , sostituendo tale quantità nella curva di domanda si ottiene il<br />
prezzo praticato dal monopolista. L’equilibrio di monopolio è quindi<br />
egarantisceprofittiparia<br />
= → 20 − 2 =4→ =8 =12<br />
− ( )=48<br />
(2) La tassa su ogni unità prodotta aumenta i costi di produzione del monopolista.<br />
I nuovi costi totali sono<br />
da cui i marginali<br />
il nuovo equilibrio di monopolio è<br />
() =16+ +4 =16+6<br />
() =6<br />
= () → 20 − 2 =6→ () =7 () =13<br />
Iprofitti della Rintel ed il gettito governativo sono, rispettivamente<br />
() () − ( ()) = 33<br />
e<br />
= × () =14<br />
(3) Meno efficiente in quanto alle inefficienze dovute alla presenza di un monopolista<br />
si aggiungono quelle dovute alla misura fiscale distorsiva.<br />
13
Esercizio 4. Si consideri un monopolista che serve due mercati - mercato e mercato<br />
- caratterizzati da due diverse curve di domanda. Sia =8−2 la domanda<br />
inversa nel mercato a, e = 8 − quella sul mercato b. I costi marginali (e<br />
medi) di produzione sono nulli. (1) Calcolate e fornite una rappresentazione grafica<br />
dell’equilibrio in ciascun mercato ipotizzando che il monopolista possa discriminare<br />
tra i due mercati (discriminazione del terzo tipo). (2) Supponete che il Governo vieti<br />
qualsiasi forma di discriminazione. Calcolate il prezzo praticato dal monopolista ed i<br />
profitti ottenuti. (3) Da chi verrà appoggiata la strategia governativa? Argomentate.<br />
Soluzioni. (1) L’equilibrio sui due mercati in presenza di discriminazione del<br />
terzotipoè<br />
mercato A = <br />
mercato B = → =2; =4<br />
essendo MR =8−4 eMR =8−2. Sulprimomercatoilmonopolistapraticherà<br />
un prezzo pari a 4, sul secondo il prezzo sarà pari a 4. Questo è un caso particolare in<br />
cui anche potendo praticare la discriminazione di terzo tipo (ovvero potendo scegliere<br />
un prezzo diverso per i due mercati) il monopolista sceglie il medesimo prezzo. il risultato<br />
dipende dalla forma delle curve di domanda nei due mercati. nell’esercitazione 8<br />
troverete un caso in cui il monopolista potendo discriminare tra i due mercati pratica<br />
un prezzo diverso.<br />
(2) Nel caso in cui non sia possibile la discriminazione di prezzo al punto (1), il<br />
monopolista servirà al medesimo prezzo i due mercati. La domanda complessiva in<br />
questo caso è<br />
= + =12− 3<br />
2 <br />
con conseguente ricavo marginale pari a<br />
=8− 4<br />
3 <br />
Il volume complessivo di vendite sarà Q*=6 (da ripartirsi sui due mercati) ed il prezzo<br />
a cui l’output è venduto sui due mercati è P*=4. I profitti complessivi del monopolista<br />
in questo caso sono<br />
=24<br />
mentre in presenza di discriminazione di prezzo del terzo tipo il monopolista otteneva<br />
un profitto pari a<br />
+ =8+16=24<br />
In questo caso, dato che il prezzo praticato dal monpolista sui due mercati è lo stesso,<br />
iprofitti e le vendite in presenza ed in assenza di discriminazione del terzo tipo sono<br />
gli stessi!<br />
(3) In questo caso non c’è ragione di appoggiare la strategia governativa oin<br />
quanto non produce esiti diversi da quelli altrimenti vigenti. Ma in generale, i<br />
consumatori sul mercato caratterizzato da una domanda meno elastica preferiscono<br />
un prezzo unico in quanto tale prezzo risulta inferiore a quello che il monopolista<br />
praticherebbe loro in presenza di discriminazione. I consumatori caratterizzati da<br />
una domanda maggiormente elastica invece preferiscono la discriminazione al prezzo<br />
unico in quanto il prezzo unico che verrebbe loro praticato sarebbe superiore a quello<br />
che il monopolista praticherebbe loro se gli fosse permesso discriminare.<br />
14
Esercizio 5. La curva di domanda di Idefix, monopolista nel mercato Gamma, è<br />
= − (dove a è un parametro positivo), mentre la sua funzione di costo totale è<br />
() = (dovecèunparametrocon0). (1) Definite e calcolate (sulla base<br />
dei dati a disposizione) l’equilibrio di monopolio specificando anche i profitti ottenuti<br />
da Idefix in corrispondenza di tale equilibrio. (2) Calcolate il valore dell’elasticità<br />
della domanda al prezzo in corrispondenza dell’equilibrio al punto (1)? (3) Ritenete<br />
che Idefix potrebbe aumentare i propri ricavi riducendo il prezzo? Argomentate.<br />
Soluzioni. (1) I costi medi di produzione indicano quanto costa in media ogni<br />
unità prodotta; il costo marginale indica di quanto aumentano i costi totali di produzione<br />
in seguito ad un aumento unitario nei volumi prodotti; analogamente il ricavo<br />
marginale indica di quanto aumentano i ricavi totali in seguito ad un aumento unitario<br />
nei volumi di produzione.<br />
Analiticamente<br />
P<br />
a<br />
P M<br />
= <br />
<br />
MR<br />
Eq. monopolio<br />
MC=c<br />
Domanda<br />
0 Q M a/2 a Q<br />
= ; = <br />
<br />
La quantità che massimizza i profitti è<br />
ed il prezzo di monopolio è<br />
= ; = <br />
<br />
= → − 2 = → = −<br />
2<br />
= − = +<br />
2<br />
= − 2<br />
l’Idefix in corrispondenza dell’equilibrio di monopolio ottiene profittiparia<br />
= ( ) − ( )= ¡ ¢<br />
− 2<br />
2<br />
(2) L’elasticità della domanda al prezzo in corrispondenza dell’equilibrio di monopolio<br />
è<br />
= − <br />
+ <br />
= −<br />
− <br />
siamo dunque lungo un tratto elastico della curva di domanda.<br />
(3) Idefix potrebbe aumentare i ricavi totali aumentando le vendirte in quanto<br />
in seguito ad una variazione in diminuzione dell’1% del prezzo si verificherebbe una<br />
variazione in aumento più che proporzionale nelle vendite<br />
15
Esercizio 6. Si consideri un monopolio in cui la curva di domanda (inversa) è<br />
= 100 − ed i costi totali del monopolista sono () = 250 + 2 . (1) Calcolare e<br />
fornire la rappresentazione grafica dell’equilibrio di monopolio. (2) Viene introdotta<br />
una tassa (t=20) su ogni unità prodotta dal monopolista. Si calcoli il nuovo equilibrio<br />
in termini di quantità, prezzo e profitto del monopolista. (3) In che ammontare<br />
la tassa è effettivamente sostenuta dal monopolista ed in che misura è trasferita sui<br />
consumatori?<br />
Soluzioni. (1) I costi marginali ed i ricavi marginali del monopolista sono<br />
rispettivamente<br />
<br />
<br />
= =2= = 100 − 2<br />
da cui un equilibrio di monopolio<br />
P<br />
100<br />
P M<br />
= → =25 =75<br />
MR<br />
MC=2x<br />
Eq. monopolio<br />
Domanda<br />
0 x M 50 100 x<br />
(2) La tassa modifica il costo totale di produzione che diventa<br />
da cui un nuovo costo marginale pari a<br />
( ) = 250 + 2 + = 250 + 20 + 2<br />
() =<br />
()<br />
<br />
=20+2<br />
Il nuovo equilibrio di monopolio si caratterizza per una quantità ed un prezzo<br />
e assicura al monopolista un profitto di<br />
= () → () =20 () =80<br />
() = () () − () = 1600 − 250 − 400 − 400 = 550<br />
(3) I consumatori pagano, rispetto all’equilibrio in assenza di tassa un prezzo<br />
maggiorato di 5 (80-75); dunque il monopolista è in grado di trasferire sui consumatori<br />
solo 1/4 dell’onere della tassa e sostiene effettivamente i restanti 3/4 dell’onere.<br />
16
Esercizio 7. La funzione di domanda di mercato delle biciclette è =20− . Il<br />
costo medio di produzione è pari a 2. (1) Determinate e fornite una rappresentazione<br />
grafica dell’equilibrio di mercato in presenza di un unico produttore (monopolista).<br />
(2) Determinate e fornite una rappresentazione grafica dell’equilibrio perfettamente<br />
competitivo. (3) Calcolate la perdita secca dovuta alla presenza di un monopolista e<br />
spiegatebrevementeacosaèdovuta.<br />
Soluzioni. (1) La quantità prodotta dal monopolista è tale per cui<br />
= <br />
quindi sostituendo i valori di ricavo marginale (MR=20-2q) e di costo marginale<br />
(MC=AC=2) abbiamo che<br />
e per sostituzione nella curva di domanda<br />
P<br />
20<br />
P M<br />
(2) In concorrenza perfetta<br />
2<br />
20 − 2 =2→ =9<br />
=20− 9=11<br />
Eq. monopolio<br />
MR<br />
MC<br />
Domanda<br />
0 Q M 10 20 Q<br />
= → 20 − =2<br />
da cui si ottiene una quantità pari a 18 ed un prezzo di vendita pari al costo marginale,<br />
2.<br />
P<br />
20<br />
P M<br />
2<br />
Eq. monopolio<br />
Eq. competitivo<br />
0 QM MR<br />
MC<br />
Domanda<br />
10 18 20 Q<br />
17
(3) La perdita secca (perdita netta) è dovuta al fatto che il monopolista pratica<br />
un prezzo superiore a quello competitivo disincentivando così lo scambio. Nel caso in<br />
esamelaperditadibenesseredovutaallapresenzadiunmonopolistaèpariall’area<br />
blu<br />
P<br />
20<br />
P M<br />
analiticamente la perdita secca è<br />
2<br />
Eq. monopolio<br />
Perdita secca<br />
Eq. competitivo<br />
0 QM MR<br />
MC<br />
Domanda<br />
10 18 20 Q<br />
(11 − 2) (18 − 9) 1 92<br />
=<br />
2 2<br />
Esercizio 8. Nota: il seguente esercizio va svolto solo in termini grafici.<br />
Un monopolista soddisfa una domanda lineare del suo bene, e il suo costo totale è<br />
lineare senza componente fissa. (1) Rappresentate l’equilibrio di monopolio specificando,<br />
tramite opportuni simboli, la quantità prodotta, il prezzo praticato, i profitti<br />
ottenuti, il surplus dei consumatori e la “perdita secca” sopportata dalla società. (2)<br />
Il Governo si dichiara insoddisfatto dell’equilibrio di mercato e propone l’introduzione<br />
di una licenza che consenta al monopolista di discriminare perfettamente (“primo<br />
tipo”) tra consumatori. Qual è la cifra massima che il monopolista è disposto a<br />
spendere per ottenere tale licenza? (3) Supponete che il Governo venda tale licenza<br />
per una somma pari alla cifra di cui al punto precedente meno . Di quanto varia<br />
il profitto del monopolista rispetto a quello di cui al punto (1)? E il surplus dei<br />
consumatori? E il surplus sociale?<br />
Soluzioni. (1) Nel grafico sottostante rappresentiamo la curva di domanda inversa,<br />
la curva di ricavo marginale del monopolista ed il costo marginale. La quantità<br />
prodotta dal monopolista è tale per cui MR=MC (Q M ) ed il prezzo praticato (p M )<br />
è ottenuto per sostituzione della quantità di monopolio nella curva di domanda inversa.<br />
In assenza di costi fissiiprofitti del monopolista sono pari alla somma delle<br />
aree C+D+F+G (grafico). Il surplus del consumatore è dato dalla somma delle aree<br />
A+B. La perdita secca, dovuta alla scelta del monopolista di praticare un prezzo maggiore<br />
del costo marginale (ovvero del prezzo che si avrebbe in concorrenza perfetta),<br />
18
èpariallasommadelleareeE+H.<br />
P<br />
P M<br />
A B<br />
C D E<br />
F<br />
G H<br />
MR<br />
Eq. monopolio<br />
MC<br />
Domanda<br />
0 Q M Q* Q<br />
(2) In presenza della licenza il monopolista riuscirebbe a vendere ogni unità ad un<br />
prezzo pari alla massima disponibilità a pagare dei consumatori (la curva di ricavo<br />
marginale del monopolista in questo caso coinciderebbe esattamente con la curva di<br />
domanda inversa). Complessivamente sarebberoscambiatelemedesimeunitàvendute<br />
in un mercato concorrenziale, Q*. Il monopolista riuscirebbe però ad estrarre dai<br />
consumatori tutto il surplus ottenendo un profitto complessivo pari alla somma delle<br />
aree A+B+C+D+E+F+G+H. La massima disponibilità a pagare del monopolista<br />
perlalicenzaèquindiparialladifferenza tra i profitti che lo stesso ottiene con la<br />
licenza ed i profitti al punto (1):<br />
+ + + + + + + − ( + + + ) = + + + <br />
(3)Ipotizzando che il monopolista possa acquistare la licenza ad un prezzo pari alle<br />
aree A+B+E+H-, ilprofitto del monopolista con discriminazione perfetta al netto<br />
del costo della licenza sarebbe pari a<br />
+ + + + + + + − (A + B + E + H −) = + + + + <br />
il surplus dei consumatori con discriminazione perfetta sarebbe nullo mentre si avrebbe<br />
un gettito governativo (dovuto al pagamento della licenza da parte del monopolista)<br />
per A+B+E+H-. La tabella sottostante confronta sinteticamente l’equilibrio monopolistico<br />
al punto (1) con quello con discriminazione perfetta<br />
Profitto SC Gettito Benessere<br />
(1) Discriminaz 1 ◦ tipo C+D+F+G+ - A+B+E+H- A+B+E+H+C+D+F+G<br />
(2) Monopolio C+D+F+G A+B - A+B+C+D+F+G<br />
Variazione (1)-(2) -A-B A+B+E+H- E+H<br />
Esercizio 15. Siano Q =2400-200p e Q =400+50p le curve di domanda e di offerta<br />
di latte. (1) Calcolate il prezzo e la quantità di equilibrio competitivo e fornitene<br />
una rappresentazione grafica. (2) Ritenendo troppo basso il reddito degli allevatori in<br />
corrispondenza dell’equilibrio competitivo, il Governo interviene stabilendo un sussidio<br />
(s=5) per ogni unità di latte venduto (sussidio sulla produzione). Calcolate gli<br />
19
p<br />
12<br />
8<br />
E*<br />
400 800 Q<br />
Figure 1:<br />
effetti della manovra sui volumi di vendita e sul prezzo ottenuto dagli allevatori. (3)<br />
Indicate in un opportuno grafico la perdita netta generata dal sussidio.<br />
(1) L’equilibrio di mercato è<br />
= → 2400 − 200 = 400 + 50<br />
da cui un prezzo di equilibrio pari a 8 ed una quantità di equilibrio pari a 800. La<br />
curvadidomandainversaequelladiofferta inversa sono<br />
=12− <br />
200 e = <br />
50 − 8<br />
da cui la seguente rappresentazione grafica<br />
(2)A seguito dell’implementazione del sussidio sui produttori la curva di offerta si<br />
sposta verso il basso in misura pari all’ammontare del sussidio stesso (i costi totali,<br />
e quindi i marginali, si riducono). La curva di offerta post-sussidio è<br />
() = <br />
<br />
50 − 8 − = 50 − 13<br />
da cui un volume di vendite post-sussidio pari a 1000, un prezzo versato dai consumatori<br />
(pD (s)) di 7 ed un prezzo ottenuto dai produttori (pS (s)) pari a 7+5=12.<br />
(3)Ilsussidiogeneraunaperditanettaparia(12-7)(1000-800)/2=500<br />
p<br />
12<br />
8<br />
7<br />
Perdita di<br />
benessere<br />
400 800 1000 Q<br />
20<br />
S<br />
D<br />
S<br />
sussidio<br />
D
Esercizio 16. Si consideri un monopolista che serve due mercati - mercato 1 e<br />
mercato 2 - caratterizzati da due diverse curve di domanda. Sia =12− la<br />
domanda inversa nel mercato a, e =8− quella sul mercato b. I costi marginali<br />
(e medi) di produzione sono costanti e pari a 2. (1) Calcolate e fornite una rappresentazione<br />
grafica dell’equilibrio in ciascun mercato ipotizzando che il monopolista<br />
possa discriminare tra i due mercati (discriminazione del terzo tipo). (2) Supponete<br />
che il Governo vieti qualsiasi forma di discriminazione. Calcolate il prezzo praticato<br />
dal monopolista ed i profitti ottenuti. (3) Da chi verrà appoggiata la strategia governativa?<br />
Argomentate.<br />
Soluzioni. (1) Potendo discriminare tra i due mecati il monopolista sceglierà in<br />
ciascun mercato il prezzo in corrispondenza del quale il ricavo marginale ottenuto<br />
in quel mercato eguaglia il costo marginale del monopolista. Il ricavo marginale nel<br />
mercatoaè =12− 2 mentre il ricavo marginale nel mercato b è =<br />
8 − 2. ilmonopolistasceglieràdiprodurrenelmercatoaunnumerodiunitàdi<br />
output t.c.<br />
= → 12 − 2 =2→ ∗ =5<br />
e nl mercato b sceglierà di produrre un numero di unità di output t.c.<br />
= → 8 − 2 =2→ ∗ =3<br />
Sostituendo nelle curve di domanda inversa si ottiene un prezzo del bene pari a 7 nel<br />
mercatoaeparia5nelmercatob.<br />
P<br />
12<br />
7<br />
2<br />
Equilibrio di monopolio<br />
MRa<br />
MC<br />
5 6 12 qa<br />
Domanda mercato a<br />
P<br />
8<br />
5<br />
2<br />
Equilibrio di monopolio<br />
MRb<br />
MC<br />
3 4 8 qb<br />
(2) Nel caso in cui la discriminazione sia vietata il monopolista dovrà vendere<br />
il bene allo stesso prezzo nei due mercati. Stante la forma delle curve di domanda<br />
nei due mercati, la curva di domanda complessiva che il monopolista deve soddisfare<br />
è = + =12+8− 2 ovvero =20− 2. Da cui si ottiene una<br />
curva di domanda inversa dei due mercati pari a p=10-Q/2, dove Q è la quantità<br />
complessivamente prodotta per i due mercati. Il ricavo marginale del monopolista in<br />
questo caso è MR=10-Q; quindi il monopolista non potendo discriminare tra i due<br />
mercati sceglierà di produrre complessivamente 8 unità di output (ottenuto risolvendo<br />
MR=MC) che vengono vendute ad un prezzo pari a 6. Notate che il prezzo praticato<br />
ora dal monopolista è maggiore di quello che avrebbe praticato sul mercato b e minore<br />
di quello che avrebbe praticato su mercato a. A questo prezzo sul mercato a il<br />
monopolistariusciràavendere6unitàdelbenementresulmercatobilmonopolista<br />
venderà 2 unità del bene. Il monopolista otterrà un profitto pari a 32.<br />
21<br />
Domanda mercato b
(3) Nel caso in cui il monopolista avesse potuto discriminare tra i due mercati,<br />
egli avrebbe ottenuto un profittoparia25sulmercatoaeparia9sulmercatob;<br />
quindi complessivamente il suo profitto sarebbe stato pari a 36. Dato che il monopolista<br />
avrebbe ottenuto un profitto maggiore nell’ipotesi di discriminazione tra i due<br />
merati, non appoggerà la scelta governativa di non consentirgli la segmentazione. Anlogamente<br />
i consumatori sul mercato b preferivano l’equilibrio con discriinazione tra i<br />
due mercati in quanto potevano acquistare più unità del bene ad un prezzo inferiore (la<br />
loro domanda è relativamente più elastica di quella dei consumatori sul mercato a). I<br />
soli a sostenere la strategia governativa sono quindi i consumatori sul mercato a che<br />
con il prezzo uniforme possono acquistare più untà del bene ad un prezzo inferiore (la<br />
loro domanda è relativamente meno elastica di quella dei consumatori sul mercato b).<br />
Esercizio 17. L’impresa Mesa produce tavoli da ping pong in regime di monopolio.<br />
La curva di domanda inversa è data: = 100 − 3, dove q è la quantità prodotta<br />
e p il prezzo. La sua funzione di costo totale è data da: =10. (1) Derivate la<br />
curva dei ricavi marginali (MR) e la curva dei costi marginali (MC) e rappresentatele<br />
graficamente insieme alla curva di domanda. (2) Calcolate l’equilibrio del monopolista:<br />
quantità e prezzo, e rappresentatelo nel grafico precedente. (3) Supponete ora<br />
che lo stato introduca un sussidio alla produzione pari a 6 per ogni unità prodotta.<br />
Calcolate il nuovo equilibrio in termini di prezzi e quantità. (4) Lo Stato propone<br />
all’impresa, come alternativa al sussidio, un trasferimento in somma fissa pari a 100<br />
. L’impresa accetterà l’offerta dello Stato?<br />
Soluzioni. (1) Stante la forma della curva di domanda del monopolista i ricavi<br />
marginali sono pari a MR=100-6q. I costi marginali del monopolista sono invece pari<br />
aMC=10.<br />
(2) L’equilibrio di monopolio, ottenuto risolvendo il sistema MR=MC ovvero 100-<br />
6q=10 è caratterizzato da un numero di unità prodotte pari a 15 e, sostituendo nella<br />
curva di domanda inversa, da un prezzo pari a 55.<br />
P<br />
100<br />
55<br />
10<br />
Equilibrio di monopolio<br />
MR<br />
MC<br />
Domanda<br />
100/6 100/3 Q<br />
(3) Il sussidio modifica la curva di costo del monopolista. In seguito all’introduzione<br />
del sussidio i costi del monopolista diventano pari a TC(s)=TC-sq=4q; quindi i nuovi<br />
costi marginali del monopolista sono MC(s)=4. Il nuovo equilibrio di monopolio si<br />
caratterizza per un livello di output pari a 16 (superiore al livello di output che il<br />
monopolista produceva in assenza del sussidio alla produzione) ed un prezzo a cui il<br />
bene viene venduto pari a 52.<br />
22
(4) Il trasferimento in somma fissa modifica i costi di produzione TC(S)=TC-<br />
S=10q-100, ma non altera il costo marginale di produzione; quindi il numero di<br />
unità vendute dal monopolista ed il prezzo praticato saranno gli stessi che abbiamo<br />
individuato al punto (1). Ma, rispetto a quanto ottenuto al punto (1), il sussidio in<br />
somma fissa aumenta i profitti del monopolista di un ammontare esattamente pari al<br />
sussidio. I profitti del monopolista con il sussidio in somma fissa sono pari a 775.<br />
Iprofitti del monopolista in corrispondenza del sussidio sulla produzione erano<br />
invece pari a 768. Dal momento che la misura al punto (4) consente al monopolista<br />
di ottenere un profitto maggiore, sarà da lui preferita.<br />
Esercizio 18. L’impresa “La Bolognese” è l’unica produttrice di tortellini nell’isola<br />
di Pastafrolla. Per produrre i tortellini essa sostiene costi totali pari a C = 4 + 4Q,<br />
dove Q indica la quantità totale prodotta. La domanda inversa di mercato è P = 20<br />
- Q. (1) Calcolate il costo marginale ed il ricavo marginale dell’impresa. Rappresentateli<br />
in un grafico insieme alla funzione di domanda di mercato, esplicitando tutte<br />
le intercette. (2) Qual è la quantità di tortellini offerti dall’impresa in equilibrio?<br />
Calcolate il prezzo di equilibrio e i profitti: rappresentate nel grafico il punto di equilibrio<br />
trovato. (3) Supponete che grazie ad un investimento in Ricerca e Sviluppo,<br />
l’impresa riduca i suoi costi, fronteggiando ora una funzione di costo pari a C = 4 +<br />
2Q. Calcolare la nuova quantità e il nuovo prezzo di equilibrio. (4) Indicando con I<br />
la spesa in ricerca e sviluppo, qual è il valore massimo di I per cui l’impresa troverà<br />
conveniente effettuare l’investimento?<br />
Esercizio 19. Il mercato dei filtri dei condizionatori d’aria è caratterizzato dalla<br />
presenza di una sola impresa. La funzione di domanda inversa risulta essere pari a<br />
P = 80 - q. L’impresa produttrice sostiene inoltre dei costi totali di produzione pari<br />
a: C(q) = 40q, con q che indica il numero di filtri prodotti. (1) Calcolate la quantità<br />
di filtri prodotta in equilibrio dal monopolista e rappresentatela in un grafico<br />
unitamente alle curve del costo marginale (MC) e del ricavo marginale (MR). (2)<br />
Calcolate il surplus del produttore e del consumatore in corrispondenza della quantità<br />
prodotta in equilibrio, indicandone le aree corrispondenti nel grafico precedente.<br />
(3) Descrivete che cosa si intende per perdita secca da monopolio e calcolatela in<br />
corrispondenza dell’equilibrio ottenuto al punto 2). (4) Qualora il monopolista fosse<br />
in grado di applicare una discriminazione di prezzo del primo tipo (discriminazione<br />
perfetta), a quanto ammonterebbe il surplus dei totale dell’economia? Indicatelo nel<br />
grafico specificando l’ammontare del surplus dei consumatori e del produttore.<br />
Soluzioni. (1) Il ricavo marginale del monopolista è MR=80-2q mentre il costo<br />
marginale del monopolista è MC=40. Lascio a voi la rappresentazione grafica di<br />
curva di domanda, curva di ricavo marginale e curva di costo marginale. Vi faccio<br />
notare che la curva di domanda ha intercette (80; 0) e (0; 80) e pendenza -1. La<br />
curva di ricavo marginale ha la stessa intercetta verticale della curva di domanda ma<br />
pendenza doppia quindi l’intercetta orizzontale è (40; 0). Mentre la curva di costo<br />
marginale è una retta parallela all’asse delle x in corrispondenza de valore 40. Mi<br />
raccomando ricordatevi di indicare nel grafico l’equilibrio di monopolio.<br />
L’equilibrio del monoplista, ottenuto risolvendo MR=MC, è q M =20 e p M =60.<br />
Perlerispostesuccessivelascioavoil’indicazionenelgraficodelleareediSC,<br />
SP, e perdita secca di benessere di monopolio.<br />
(2) Il surplus dei consumatori, pari alla differenza tra il prezzo massimo cui i<br />
23
consumatori sarebbero disposti ad acquistare il bene ed il prezzo effettivamente pagato<br />
moltiplicato per le unità acquistate, è 200. Il surplus del produttore, pari alla<br />
differenza tra il prezzo ricevuto ed il prezzo minimo cui il monopolista sarebbe stato<br />
disposto a cedere il bene moltiplicato per le unità di bene prodotte/vendute, è 400.<br />
(3) La perdita secca o perdita netta di monopolio è la perdita di benessere dovuta<br />
al fatto che il bene viene prodotto da un monopolista e che quest’ultimo, per aumenare<br />
ipropripofitti e vendere il bene ad un prezzo superiore al costo marginale, scoraggia<br />
lo scambio e produce un livello inferiore a quello socialmente ottimale. La perdita<br />
secca può essere calcolata come differenza tra il surplus totale che si avrebbe in concorrenza<br />
perfetta ed il surplus che si ha in monopolio (che abbiamo calcolato al punto<br />
precedente). Nel caso in esame la perdita secca è pari a 200.<br />
(4) Nel caso in cui il monopolista potesse discriminare perfettamente produrrebbe<br />
il livello di output socialmente ottimale e assorbirebbe interamente il surplus dei produttori<br />
riuscendo ad assicurarsi un profitto di 800.<br />
Esercizio 20. In un mercato monopolistico la funzione di domanda di mercato è<br />
data da X=8-p/2. La funzione di costo totale dell’unica impresa presente nel mercato<br />
èdatadaC(X)=4X+X 2 . (1) Ricavate analiticamente le espressioni delle funzioni di<br />
costo marginale e ricavo marginale del monopolista. (2) Calcolate quantità e prezzo<br />
di equilibrio del monopolio.<br />
Ipotizzate ora che, in seguito alla raccolta di informazioni sui consumatori, il monopolista<br />
riesca a praticare una discriminazione di prezzo del primo ordine o perfetta.<br />
(3) Qual è la quantità di equilibrio con la discriminazione di prezzo perfetta? (4)<br />
Con la discriminazione di prezzo perfetta, quali sono i ricavi totali del monopolista?<br />
(Per rispondere a questa domanda un disegno può essere utile).<br />
Soluzioni. (1) Il ricavo marginale del monopolista è MR=16-4X mentre il costo<br />
marginale del monopolista è MC=4+2X.<br />
(2) L’equilibrio di monopolio, in corrispondenza del livello di output t.c. MR=MC,<br />
èdatodaX =2e, sostituendo nella funzione di domanda inversa, p =12<br />
(3) Nel caso in cui il monopolista possa discriminare perfettamente tra i consumatori<br />
sceglierà di produrre lo stesso livello di output che verrebbe prodotto in un<br />
mercato perfettamente concorrenziale X*=3 (risolvendo p=MC).<br />
(4) I ricavi totali del monopolista sono pari all’area sottostante la curva di domanda<br />
fino al livello di output prodotto dal monopolista; quindi sono pari all’area di<br />
un trapezio avente base minore pari a 10, base maggiore pari a 16 e altezza 3; quind<br />
TR=(10+16)x3/2=39.<br />
24