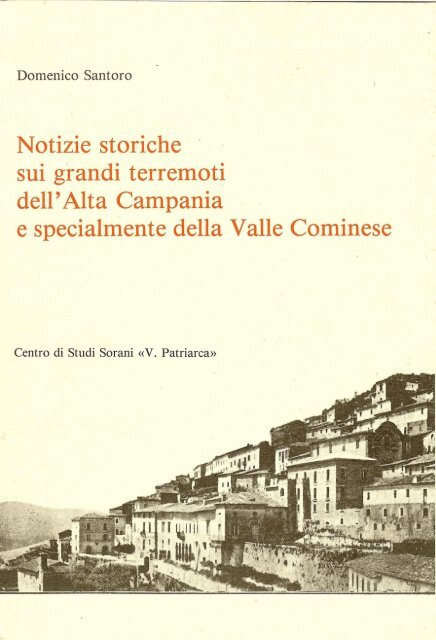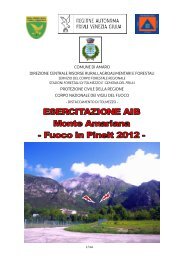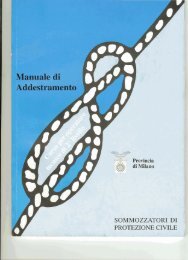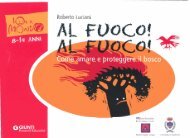Notizie storiche sui grandi terremoti dell'Alta ... - Protezione Civile
Notizie storiche sui grandi terremoti dell'Alta ... - Protezione Civile
Notizie storiche sui grandi terremoti dell'Alta ... - Protezione Civile
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Domenico Santoro<br />
<strong>Notizie</strong> <strong>storiche</strong><br />
<strong>sui</strong> <strong>grandi</strong> <strong>terremoti</strong><br />
<strong>dell'Alta</strong> Campania<br />
e specialmente della Valle Corninese<br />
Centro di Studi Sorani «V. Patriarca))
ALVITO - Palazzo Ducale ora Municipio (Sec. XVII)
a gECIALMENTE<br />
DOMENICO. SANTORO<br />
NOTIZIE STORICHE<br />
SUI GRANDI TERREMOTI<br />
DELLA VALLE COMINESE<br />
a cura di Luigi Gulia<br />
presentazione di Giuseppe Zamberletti<br />
CENTRO DI STUDI SORANI «VINCENZO PATRIARCA))<br />
60RA 1985<br />
4-1, 8<br />
T:-7,.<br />
>-L !. l-::,!
O<br />
1985 by Centro di Studi Sorani «V. Patriarca)) - 03039 Sora<br />
Per gentile concessione delle Famiglie Santoro e Celestino<br />
Tinomafia Editrice M. Pisani S.A.S. - Isola Liri (FR)
SOMMARIO<br />
VI1 Presentazione, di Giuseppe Zamberletti<br />
IX Prefazione, di Luciano Santoro<br />
XI Introduzione, di Luigi Gulia<br />
XVII Nota biobibliografica, di Gerardo Vacana<br />
<strong>Notizie</strong> <strong>storiche</strong> <strong>sui</strong> <strong>grandi</strong> <strong>terremoti</strong> <strong>dell'Alta</strong> Campa-<br />
nia e specialmente della Valle Cominese<br />
La Valle Cominese<br />
1120<br />
1 Giugno 1231<br />
17 9 Settembre 1349<br />
5 e 30 Dicembre 1456<br />
24 Luglio 1654<br />
Dal 1654 al 1873<br />
37 12 Luglio 1873. Gli ultimi <strong>terremoti</strong> del sec. XIX<br />
42 31 Luglio 1901<br />
44 13 Gennaio 1915<br />
Appendice fotografica
PRESENTAZIONE<br />
Lo riconoscono tutti i maggiori esperti mondiali: prevedere un<br />
terremoto non è ancora scientificamente possibile.<br />
Si può studiare I'evoluzione del fenomeno, stabilire il suo epi-<br />
centro e la sua intensità, si possono circoscrivere aree 'ad alto ri-<br />
schio", ove entro un certo periodo d'anni si verificherà una cata-<br />
strofepiù o meno distruttiva, ma, nonostante tutti iprogressi del-<br />
la scienza, oggi non siamo in grado di affermare con precisione<br />
quando, dove e con quale gravità il sisma arriverà.<br />
Eppure, l'attività di previsione e prevenzione rimane fonda-<br />
mentale nelsistema di <strong>Protezione</strong> <strong>Civile</strong> e la ricerca di strumenti in<br />
grado di attuarla è la nostra prima preoccupazione.<br />
Uno dei più importanti di questi strumenti è l'insieme dei dati<br />
storico-statistici che ci permette di stabilire il grado di probabilità<br />
di un evento sismico in una certa località.<br />
Fu in base a questo tipo di informazioni che nel gennaio '85, co-<br />
me tutti ricorderanno, il Dipartimento della <strong>Protezione</strong> <strong>Civile</strong>po-<br />
té lanciare il cosiddetto "preallarme sismico in Garfagnana ", che,<br />
fortunatamente, non fu seguito dalla calamità temuta, ma bappre-<br />
sentò la prima grande esercitazione di questo genere nel nostro<br />
Paese.<br />
La nostra speranza è di poter ripetere in futuro queste operazio-<br />
ni per salvare realmente vite umane.<br />
Come scriveva Domenico Santoro già nel 1915 con singolare<br />
lungimiranza, è importantissimo ((trarre dalla conoscenza delpas-<br />
sato qualche non inutile avvertimento per l'avvenire».<br />
La sua opera che, grazie al Centro di Studi Sorani, viene ora<br />
pubblicata, ci offre una serie di notizie <strong>storiche</strong> <strong>sui</strong> <strong>grandi</strong> terre-<br />
moti dell'alta Campania e in particolare della Valle Cominese, di<br />
grande interesse per una ricostruzione quanto più completa possi-<br />
bile degli eventi sismici nel nostro Paese.<br />
E' un prezioso tassello che si aggiunge al mosaico che stiamo<br />
costruendo per poter svolgere con maggiore incisività la nostra<br />
opera a salvaguardia della comunità nazionale e dei suoi beni.<br />
Quel che mi ha colpito nelle parole di questo storico temporal-<br />
mente lontano dai nostri giorni, ma tanto attuale nelle sue conce-
zioni, P appunto l 'importanza che egli attribuisce all'impegno per<br />
prevenire le calamità più che a quello per organizzare efficace-<br />
mente il soccorso a disastro avvenuto.<br />
E' quanto da anni vado ripetendo, confortato dalla consapevo-<br />
lezza che la nuova legge sulla <strong>Protezione</strong> <strong>Civile</strong>, attualmente<br />
all'esame della Camera dei Deputati, si basa appunto su questo<br />
nuovo modo di intendere il sistema rispetto alla normativa del<br />
1970.<br />
Un 'idea, questa, che mi fu chiara quando mi trovai a ragionarci<br />
non più nelle aule parlamentari, 'a tavolino" come si dice, ma<br />
operando su quei veri campi di battaglia che sono le regioni colpi-<br />
te da un grande terremoto.<br />
Prima in Friuli e poi, ancor più profondamente, in Zrpinia,<br />
compresi che dobbiamo lottare con tutte le forze per evitare che<br />
disastri così sanguinosi avvengano, mettendoci almeno nelle con-<br />
dizioni di limitarne al minimo i danni. Ciò vuol dire intensificare<br />
la ricerca scientifica, dare impulso agli studi storico-statistici, ap-<br />
plicare quanto più largamente gli adeguamenti antisismici alle<br />
strutture abitative, educare i cittadini a '%onvivereW con i terre-<br />
moti non temendoli fatalisticamente, ma conoscendoli per poter-<br />
sene difendere anche attraverso norme comportamentali semplici<br />
ma preziose.<br />
In questo.senso, l'iniziativa intrapresa dal Centro di Studi Sora-<br />
ni per la pubblicazione in volume delle ricerche svolte con estrema<br />
competenza e serietà dallo storico e letterato Santoro, viene accol-<br />
ta con grande interesse, e direi anche gratitudine, da tutti noi che<br />
siamo impegnati in questa lotta per preservare dai <strong>grandi</strong> rischi<br />
naturali e dovuti all'attività dell'uomo la vita umana.<br />
Roma, settembre 1985<br />
GIUSEPPE ZAMBERLETT<br />
Ministro per la <strong>Protezione</strong> <strong>Civile</strong>
PREFAZIONE<br />
Nell'archivio del mio avo paterno, custodito per circa sessanta<br />
anni dallo zio Beppino da poco scomparso, rinvenni tempo addie-<br />
tro un fascicolo di vecchie carte assicurato da un cordino color<br />
verde con note di corrispondenza, appunti, bollettini dell'osser-<br />
vatorio Meteorico-Aerologico-Geodinamico di Montecassino,<br />
giornali, una Gazzetta Ufficiale del Regno, .la prima stesura di<br />
questo Lavoro datata 27.7.1915 e il manoscritto definitivo.<br />
Se, come attesta la data, la spinta decisiva al1 'opera può essere<br />
stata impressa dalla pro fonda emozione suscitata dal terremoto di<br />
quel1 'anno, corrispondenze anteriori ci in formano, tuttavia, che<br />
da tempo l'Autore vagheggiava il disegno di studiare questa ternibile<br />
forza della natura forse attribuendovi per la frequenza delle<br />
manifestazioni e per gli effetti sovente devastanti il ruolo di fattore<br />
storico di imprescindibile riferimento nella ricerca delle cause di<br />
avvenimenti rilevanti per la storia della nostra contrada.<br />
Alcune pagine del manoscritto sono rimaste bianche, riservate<br />
- come dedussi dal titolo - alle notizie <strong>sui</strong> guasti del sisma del 13<br />
gennaio 1915 a Sora e a San Donato V.C. attese dalprof. Michele<br />
Biancale e dal signor L. Salvucci.<br />
Il mancato pervenimento di queste<br />
dare alle stampe l'opera incompleta dovettero suggerire all'Auto-<br />
re di soprassedere alla pubblicazione che non ebbe poi più luogo<br />
forse a causa dello scoppio della prima guerra mondiale e della<br />
improvvisa Sua scomparsa avvenuta in Foggia il 21 aprile 1922.<br />
Duole confessare che i recenti, reiterati tentativi diretti a riempi-<br />
re quel vuoto non hanno, purtroppo, ottenuto successo.<br />
Due lettere della Casa Tipografica Francesco Cellamare di<br />
L 'Aquila, rinvenute nel fascicolo, risalenti al 1928-29, rivelano<br />
che a quel tempo mio padre commissionò la stampa di 500 copie<br />
di questo volume ma l'iniziativa, per cause ignote, non andò oltre<br />
le bozze delle prime tre pagine del libro.
L 'Opera vede oggi la luce per merito del Centro di Studi Sorani<br />
«V. Patriarca» in seguito alla cortese disponibilità del suo Segre-<br />
tario Generale prof. Luigi Gulia che ebbe occasione di sfogliare il<br />
manoscritto in un incontro fortuito ma forse predestinato.<br />
Al Centro,<br />
q-V *v--.I- con la -, mia p-+ -% la gratitudine di tutti i n&oti dellyAutore.<br />
- -. . . ?--+.a<br />
-.a3 i~iir.<br />
Alvito, settembre 1985<br />
-72:<br />
.ci %
INTRODUZIONE<br />
La sorpresa di un manoscritto inedito di Domenico Santoro,<br />
custodito con sapienza dal nipote Luciano, destò giustificata cu-<br />
riosità nella fase fervida della preparazione del convegno naziona-<br />
le voluto dal Centro Studi Letterari ((Premio Val di Cornino)) nel<br />
mese di ottobre 1983, per iniziativa tenace del presidente Gerardo<br />
Vacana - autore della nota biobibliografica - che in quei giorni<br />
assumeva anche la presidenza del Liceo-Ginnasio ((Vincenzo Si-<br />
moncelli)) di Sora.<br />
Agli studiosi venuti a riferire su ((Domenica Santoro Critico<br />
Storico Poeta Educatore)) fu annunciato che il'centro di Studi So-<br />
rani avrebbe pubblicato l'inedito manoscritto come contributo al-<br />
la riflessione di quei giorni, nel. clima rinnovato di attenzione<br />
all'opera dello storico alvitano.<br />
La promessa poggiava sulla nobile generosità delle Famiglie<br />
Santoro e Celestino; la rafforzava la volontà di rendere memoria<br />
all'operosità dell'Autore; ne era complice spontanea e cordiale<br />
l'amicizia della città di Alvito.<br />
I1 manoscritto è ora testo stampato e fruibile al compimento<br />
preciso dei suoi settant'anni, essendo stato siglato dall'Autore il<br />
26 settembre 1915. E della stessa data è il numero de «La voce del<br />
Liri)), qui riprodotto come inserto.<br />
<strong>Notizie</strong> <strong>storiche</strong> <strong>sui</strong> <strong>grandi</strong> <strong>terremoti</strong> dell'alta Campania e spe-<br />
cialmente della Valle Cominese non è titolo di sapore umanistico,<br />
ha però tutta l'umana gravezza che ((pagine dolorose.. . scritte.. .<br />
L per trarre dalla conoscenza del passato qualche non inutile avver-<br />
timento per l'avvenire» - come premette il Santoro - possono<br />
suscitare in quanti di noi hanno imparato a convivere con il ri-<br />
. .<br />
L . schio sismico in anni e mesi e giorni recentissimi, educandosi a<br />
i -<br />
reagire in forme e modi più razionali, cui fa da sostegno l'intelli-<br />
genza del prevenire, secondo la sapienza biblica. Ma dramma e<br />
paura, tragedia e lutto, pianto e pietà non sfuggono ai sentimenti<br />
di chi ripercorre il filo del ricordo storico, leggendo queste pagine<br />
che appaiono come quadri di lutto della nostra terra. La mutata<br />
giurisdizione amministrativa del 1927 ha dato al territorio diverso<br />
assetto di riferimenti; la sua gente si mantiene fedele alla tradizio-
ne di una laboriosità che il nome dei secoli passati sanciva con<br />
Terra di Lavoro, sottolineando una attitudine tutta benedettina<br />
all'Ora et labora.<br />
Né al rigore dello storico potevano sfuggire queste fonti del do-<br />
lore nella vita delle popolazioni, con le notazioni psicologiche che<br />
a distanza di anni o di secoli rivelano forme di solidarietà, costu-<br />
mi, religiosità; con le notizie che ridanno volto a trasformazioni<br />
urbanistiche e architettoniche; con le citazioni che aiutano a ritro-<br />
vare forme della lingua e della sua evoluzione; senza contare ciò<br />
che più urge ai servizi di prevenzione oggi attivati dal coordina-<br />
mento della protezione civile.<br />
I giovani, che sanno per sentito dire, saranno curiosi di appren-<br />
dere dati e situazioni: i maturi vorranno rinvenire notizie, e forse<br />
nomi, degli anni della fanciullezza. Il pensiero corre immediato al<br />
terremoto del 13 gennaio 1915 che indusse lo stesso Domenico<br />
Santoro a compiere la sua ricerca durante l'estate di quell'anno.<br />
Sulla distruzione della città di Sora, che, dopo Avezzano, subì la<br />
sorte più atroce nel terremoto detto ((della Marsica)), avrebbe do-<br />
vuto scrivere - o forse scrisse - il sorano Michele Biancale<br />
(1878-1961): ce ne informa Luciano Santoro nella prefazione che<br />
precede. Quasi a colmare queste pagine rimaste bianche nel mano-<br />
scritto, veniamo in soccorso dell'Autore e dei lettori citando o ri-<br />
portando alcune testimonianze, che potranno riuscire di qualche<br />
informazione.<br />
La prima è tratta dal «Corriere della Sera)) del 15 gennaio 1915.<br />
E' un servizio dell'inviato speciale E.L., integralmente riportato<br />
anche da Bruno Vespa e Arnaldo Panecaldo nel loro Marsica<br />
1915, Edizioni Fotogramma, Roma 1984, pp. 24-28.<br />
Un primo sguardo alle rovine di Sora distrutta.<br />
L'affannosa ricerca delle vittime.<br />
(Dal nostro inviato speciale)<br />
Sora, 14 gennaio, notte.<br />
(E.L.) Sora è nei paesi di Terra di Lavoro quelio più colpito dal terribile<br />
disastro di ieri mattina. I1 terremoto l'ha sconquassata tutta, distruggen-<br />
dola. Essa non ha oggi che poche case intatte e delle più vecchie, poste alla<br />
fine delle nuove costruzioni sul ponte del Liri, là dove era l'antica cittadel-<br />
la. Quando io vi sono giunto in un treno militare, composto a Roma ed<br />
accresciuto a Roccasecca, ho avuto subito la percezione del tremendo di-<br />
sastro. La stazione è tutta diroccata [...] In mezzo ai binari sono carri di<br />
ogni sorta, carichi di bambini, di ragazzi e di donne e poi altre donne si<br />
accalcano sul marciapiede, in lacrime. Questi disgraziati attendono tia<br />
ventiquattro ore che giunga qualcuno a dissotterrare i parenti e a salvarli.<br />
XII
l'apparecchio telegrafico impiantato dall'impiegato Penne, rimasto inco-<br />
lume, che funziona ininterrottamente per trasmettere telegrammi di Sta-<br />
trasmettere qualche parola a gente lontana.<br />
Quando i soldati appaiono in paese una donna li scongiura che le rech<br />
no aiuto per disseppellire due figliole travolte nelle macerie [...l Ma fine
uttato a terra. Vide l'ultimo piano del palazzo di fronte spaccarsi, levarsi<br />
in alto e cadere in frantumi. Poi vide cadere la cupola della chiesa e le pa-<br />
reti dei palazzi vicini. Atterrito, piangendo, egli corse nel mezzo della<br />
piazza e si diede a gridare a tutta forza: «Venite in mezzo, venite in mez-<br />
zo!» Le donne che erano al mercato a queli'ora, proprio a pochi passi dal-<br />
la chiesa, cercarono di sfuggire alle pietre che precipitavano da ogni parte.<br />
Poiché la scossa durava ancora, esse si strinsero tutte insieme, piangendo<br />
e invocando aiuto. Di lì a poco tutto il paese fu sossopra, e gli scampati si<br />
diedero a correre all'impauata per le vie. Pochi animosi ebbero la presen-<br />
za di spirito di correre subito al salvataggio. Fra questi vi furono alcuni<br />
preti, i Padri Passionisti, i quali accortisi dall'alto della loro casa del crol-<br />
lo dei palazzi, scesero nel paese per dare aiuto.<br />
La loro casa era rimasta intatta. Essi, in numero di cinque o sei, insieme<br />
ai pochi carabinieri e soldati organizzarono subito una squadra di soccor-<br />
so. L'assistente Comincio anch'egli si mise a capo d'una squadra e girò<br />
dappertutto. Riuscì così a salvare sei persone, in via dei Vosgi (Volsci,<br />
n.d.c.). Infine, in un androne tutto coperto di grossi macigni, egli trovò<br />
una giovane di cui si intravedeva soltanto una mano. Sforzi erculei furono<br />
fatti per salvare la disgraziata dalla morte e per mezz'ora durarono i lavo-<br />
ri. La disgraziata supplicava con un fil di voce che non aveva più forza di<br />
resistere e che la salvassero. Ma i grossi macigni non poterono essere<br />
smossi e l'infelice mori miseramente. Ancora oggi si vedono tre dita uscire<br />
fuori da un grosso masso che la copre interamente.. .<br />
Di momento in momento la terribile sventura appariva più vasta ed il<br />
terrore si impadroniva di quanti erano scampati.. .<br />
Data l'interruzione delle comunicazioni ferroviarie essendo la linea<br />
ostruita sulla via di Avezzano, il paese è rimasto interamente abbandona-<br />
to. I morti estratti ieri furono lasciati tutto il giorno allineati sulla pubbli-<br />
ca via e stamane i carabinieri li hanno trasportati al cimitero ove sono stati<br />
deposti in attesa dell'identificazione.<br />
Quale sia il numero delle vittime non è possibile dire. Certo ammonta-<br />
vano a parecchie centinaia e da calcoli delle autorità locali parrebbe siano<br />
circa mille.. .<br />
E' andato distrutto il Monastero di Santa Chiara e il maggior numero di<br />
vittime si è avuto nella chiesa annessa dove i fedeli erano ad ascoltar la<br />
Messa. Delle otto suore una si è salvata. Le altre sono tutte perite. L'ospe-<br />
dale è rimasto intatto. Sono crollati alcuni muri e per il panico qualcuno<br />
dei ricoverati è morto.<br />
Dai paesi vicini le notizie sono tranquillanti, specialmente da Isola del<br />
Liri dove vi sarebbe solo qualche vittima e da Arpino dove non vi è alcuna<br />
vittima. Invece dove le vittime sono sempre più numerose è nelle borgate<br />
dei dintorni di Sora. In esse abitano circa ottomila individui e tre o quat-<br />
tro di queste borgate, sono interamente distrutte. Finora non si hanno<br />
particolari precisi, ma le poche notizie che si hanno, lasciano presumere<br />
che vi siano delle vittime.<br />
Le due scosse verificatesi stamane e stasera hanno atterrita la popola-<br />
zione che rimarrà tutta la notte a bivaccare sulle strade, attorno a <strong>grandi</strong><br />
fuochi. A Sora, ormai si è perduta la speranza di salvare quanti sono sotto<br />
le macerie, e poiché moltissime case presentano grave pericolo per le ope-<br />
razioni di scavo, si attende personale da Napoli e da Roma per iniziare l'o-<br />
1 XIV
pera di demolizione. Con la dinamite saranno demoliti tutti i fabbricati<br />
che minacciano di crollare da un momento all'altro. Oggi si è recato a So-<br />
ra I'on. Simoncelli, deputato del paese. La popolazione attende dal un<br />
momento all'altro l'arrivo del Re, che si prevede giungerà domani.<br />
Per le popolazioni colpite, principalmente per quelle del circon-<br />
dario di Sora, Vincenzo Simoncelli (1860-1917) chiese ed ottenne<br />
interventi governativi e provvedimenti legislativi per avviare la ri-<br />
costruzione e ridare assetto all'economia agricola della regione.<br />
Concludendo alla Camera dei Deputati (Legislatura XXIV, I tor-<br />
nata del 19 marzo 1915, in Atti Parlamentari, pp. 7535-7538) il<br />
suo discorso sulle provvidenze a favore delle popolazioni terremo-<br />
tate, il Simoncelli disse tra l'altro:<br />
Mi unisco ai ringraziamenti fatti dall'onorevole De Amicis per ciò che<br />
riguarda I'accoglimento degli altri voti tanto della deputazione abruzzese,<br />
quanto della deputazione di Terra di Lavoro; ma noi di Terra di Lavoro<br />
insistiamo per cib che riguarda le strade nazionali.<br />
Non si dica che vogliamo profittare di questo momento per trarre un<br />
beneficio che forse in altre condizioni non avremmo domandato: a somi-<br />
glianza di quello che fu fatto per Reggio e Messina, si cerchi di aiutare an-<br />
che la nostra provincia. E' assolutamente assurdo che le strade, che sono<br />
nazionali finché non entrano nella provincia di Caserta, diventino provin-<br />
ciali mentre attraversano la provincia di Caserta, per ridiventare nazionali<br />
quando ne escono. ..<br />
A questo passo del discorso, che per certi versi conserva molta<br />
attualità, fa seguito una considerazione di pregnanza morale:<br />
... è bene che il popolo si senta sempre assistito dallo Stato nei momenti<br />
della sventura, perché è amore molto bene impiegato: è amore che frutta<br />
amore.<br />
Noi ne abbiamo provato gli effetti. L'accorrere a noi dei fratelli italiani<br />
in quei tristi, indimenticabili giorni, in cui tutto ci pareva oscuro per sempre,<br />
fu un raggio di luce. Nelle notti insonni ed aspre, in cui ci pareva di<br />
stare a vegliare il grande cadavere della terra natia, sentivamo profondamente<br />
nell'animo il conforto di avere un'altra grande patria, prona su di<br />
noi per richiamarci alla vita.<br />
Citiamo come terza testimonianza del terremoto del 13 gennaio<br />
1915 una relazione scritta, per incarico del vescovo Antonio Maria<br />
Jannotta, dal cancelliere mons. Vincenzo Bruni in data 10 aprile<br />
1918 e conservata nell'Archivio della Curia vescovile di Sora. Nel<br />
documento si precisa che crollò la Chiesa di Santa Restituta re-<br />
staurata nel 1894 e sotto le macerie caddero ((vittime 12 persone)).
I1 vescovo Jannotta rientrò immediatamente da Napoli, avvertito<br />
con un telegramma trasmesso da Alvito (l'ufficio del telegrafo di<br />
Sora era crollato) dove il Capitolo della Cattedrale aveva inviato il<br />
canonico don Giuseppe Piccirilli. Telegrafò a sua volta al cardina-<br />
le Segretario di Stato segnalando la morte del suo giovane segreta-<br />
rio don Giovanni Andrea Annonj insieme con sette suore di Cari-<br />
tà nella cappella dell'antico monastero di Santa Chiara. Dopo<br />
aver confortato i feriti ricoverati nel carcere mandamentale (que-<br />
sto edificio non era crollato, «essendo ad un solo piano))), alle ore<br />
13 il vescovo celebrò in Piazza Indipendenza una Santa Messa cui<br />
assistette «una immensa calca di gente».<br />
Nella relazione si legge che gravi danni subirono il santuario<br />
della Madonna delle Grazie, la chiesa di S. Pietro Celestino, a<br />
quei tempi poco discosta da Piazza Palestro, S. Francesco, S. Spi-<br />
rito e S. Silvestro. Lesioni ebbero le case verso il pendio del monte<br />
S. Casto; crolli si verificarono al centro della città; lesionati furo-<br />
no pure 1'Episcopio e la Cattedrale.<br />
Crolli e vittime, oltre che nei centri della Valle Roveto, si regi-<br />
strarono anche nei centri delle diocesi di Aquino e di Pontecorvo.<br />
Secondo la relazione, a Castelliri ci furono 80 vittime; 40 ad Isola<br />
Liri nei pressi della Chiesa di S. Domenico; 261 le vittime estratte<br />
dalle macerie a Sora.<br />
Le<strong>Notizie</strong> Storiche.. . di Domenico Santoro non sono una lettu-<br />
ra amena né d'evasione: tutt'altro! Esse ci ammoniscono a vivere<br />
con intelligenza paziente e operosa; ci ricordano che indagare i mi-<br />
steri della natura è volontà di pace; ci invitano ad essere solidali<br />
con l'uomo amando la ricchezza del suo universo.<br />
Nell'appendice fotografica sono state raccolte volutamente po-<br />
che immagini gentilmente fornite da Luciano Santoro e dalla Bi-<br />
blioteca «Dr V. Castrucci»: alcune della città di Alvito cosi come<br />
appariva negli anni della giovinezza dell'Autore; altre, dolorose,<br />
della città di Sora a documento dello strazio del 13 gennaio 1915 e<br />
della volontà degli uomini di ricostruire la vita e ricomporre spe-<br />
ranze sostenuti dalla fiducia nella vigile provvidenza divina.
NOTA BIOBIBLIOGRAFICA<br />
Domenico Santoro nacque ad Alvito, dora provincia di Caserta, il 16-9-<br />
1868. Compi gli studi liceale ad Arpino e si laureò in lettere a Pisa nel<br />
1890, ricevendo un'impronta duratura dall'insegnamento di Alessandro<br />
D'Ancona e dello storico Amedeo Crivellucci. Dopo aver insegnato nei<br />
Ginnasi di Pisa e di Pontedera e negli Istituti Tecnici di Cagliari. Chieti e<br />
Caserta, fu preside degli Istituti ~ecnici di Sassari e di Foggia, dove morì<br />
il 21-4-1922.<br />
La passione per la ricerca erudita, trasmessagli dai suoi maestri, gli durerà<br />
tutta la vita. A Pisa si legò di un'amicizia profonda con Francesco<br />
Flamini, che ebbe per lui grande affetto e stima (singolare anche il destino<br />
umano dei due amici, nati e morti prematuramente negli identici anni).<br />
Molto importanti sono i suoi lavori storici: Le relazioni tra Pka e la<br />
Sardegna dal 1015 al 1165 e Pagine sparse di storia alvitana, ma ancora<br />
oggi fondamentale ed insostituibile 5 la monografia Della vita e delle opere<br />
di Mario Equicola per chi voglia accostarsi d'opera del grande umanirta<br />
alvitano.<br />
Il Santoro ebbe anche anima e sensibilità di poeta, e la poesia coltivò<br />
ininterrottamente dall'adolescenza alla morte. Come poeta fu sensibile al<br />
magistero formale del Carducci, ma per consonanza di carattere notevole<br />
fu su di lui anche la suggestione del Pascoli (e nella stessa collana in cui<br />
apparvero le Myricae, presso l'editore Giusti di Livorno, il Santoro pubblicò<br />
nel 1901 le Rime, che sono il suo libro di poesie più notevole). E' indubbio<br />
però che le sue poesie, molte delle quali ancora inedite, sono caratterizzate<br />
da una eleganza formale e da una sapienza stilistica che le rendono<br />
ancora oggi degne di interesse e di studio.<br />
Opere<br />
Saggistica (storia): Le relazioni tra Pka e la Sardegna dal 1015 al 1165,<br />
Roma 1896; Gian Paolo Flavio e la sua orazione per la pace di Cateau<br />
Cambrhk, Pisa 1906; Pagine sparse di storia alvitana, Chieti 1908; Sora<br />
negli Annali del Baronio, Roma 191 1; I1 viaggio di Isabella Gonzaga in<br />
Provenza, Napoli 1913.<br />
Saggistica (letteratura): Della vita e delle opere di Mario Equicola,<br />
Chieti 1906; Ilsalotto di Donna Lucia De Thomasis a Napoli, Chieti 1906;<br />
I Mille dei nostri Poeti, Città di Castello 191 0; Prime istituzioni letterarie,<br />
Lanciano 1913; Delineamenti storici dei generi letterari, Lanciano 1914.<br />
Numerosi scritti critici su Dante;sul Parzanese, sullo Zanella e su altri<br />
poeti.
Poesia: Versi, Pisa 1891; Nuovi versi, Pisa 1892; Echi lirici, Pontedera<br />
1895; Folia Labentia, 1895; Vesper adest. Traduzioni metriche da Catullo<br />
e da Tibullo, Chieti 1898; Rime, Livorno 1901; pubblicate postume le<br />
Poesie dialettali (1906-1907), a cura di G. Vacana, Casalvieri-Alvito 1982.<br />
Bibliografa essenziale<br />
MIC~LE MELILLO, in Poesie scelte di Domenico Santoro, Caserta 1923;<br />
GERARDO VACANA, in Atti del I Convegno nazionale di studi su Mario<br />
Equicola, Sora 1982. Per informazioni più ampie e aggiornate si vedano<br />
gli Atti del Convegno nazionale di studi su Domenico Santoro Critico<br />
Storico Poeta Educatore (Aivito 7-9 ottobre 1983), in corso di stampa a<br />
cura del Centro Studi Letterari ((Premio Va1 di Cornino» - Aivito.<br />
1 XVIII
D. Santoro<br />
<strong>Notizie</strong> <strong>storiche</strong><br />
<strong>sui</strong> <strong>grandi</strong> <strong>terremoti</strong><br />
dell'alta Campania<br />
e specialmente della Valle Cominese
Pagine dolorose son queste - forse monotone per il ripetersi<br />
dei medesimi casi funesti - scritte con puro intento storico, non<br />
per appagare una sterile curiosita, mia o d'altrui, ma per trarre<br />
dalla conoscenza del passato qualche non inutile awertimento per<br />
l'avvenire. La Natura, che tanti doni di ubertà, di amenità, di bellezza<br />
ha elargito alle nostre contrade, non ci ha fatto immuni dalle<br />
insidie di queila incoercibile potenza delle tenebre, che in un atti-<br />
- - - - - p p p p<br />
mo travolge e inabissa uomini e cose. Di seco70 EisEolo~eciaiF<br />
che più frequente - la voce spaventevole è uscita dalle inesplorate<br />
profondità della terra; ma è valsa a renderci, se non migliori, almeno<br />
accorti a premunirci, poiché non ci è dato prevenire l'istante<br />
della distruzione? 0, dopo più di duemila anni, non possiamo altro<br />
che ripetere ancora, col rassegnato abbandono del paziente<br />
d'Idumea: Ecce, nunc in pulvere dormiam, et, si mane me quaesieris,<br />
non subistarn ? ,.<br />
D. Santoro
C<br />
t<br />
,<br />
Introduzione<br />
LA VALLE COMINESE<br />
Nell'estremo lembo settentrionale della Campania, a piè di un<br />
contrafforte dell'Appennino che la divide dal Sangritano, s'apre<br />
la fertile Valle di Comino, alla quale fanno corona, dalle alture<br />
che la chiudono come ad anfiteatro, Alvito, S. Donato, Settefrati,<br />
. Picinisco, Atina, Vicalvi. Alvito, addossata al monteAlbeto, donde<br />
trasse il nome1, la domina naturalmente da settentrione e, durante<br />
il feudalesimo, fu la capitale del piccolo dominio. Quasi a<br />
mezzo della verde conca, si eleva e l'attraversa pressoché in tutta<br />
la sua lunghezza, una collina leggermente ondulata, su cui si allinea<br />
il villaggio di Gallinaro, determinando così due distinti bacini:<br />
l'alvitano - più propriamente cominese - e l'atinate; altri poggi<br />
minori, qua e là degradando, frastagliano il territorio, e ne rendono<br />
più vario e più ameno l'aspetto.<br />
Dei due bacini, l'atinate è. solcato dal fiume Melfa, il quale discende<br />
in più rami dal monte Pizzuto, scorre dalle balze di Picinisco<br />
al piano di Atina, accoglie sotto Villa latina il tributo del Mellarino<br />
e, più oltre, le «miste correnti» di Rio molle e di Rio nero,<br />
piega alla volta di Casalvieri, e di là, verso Roccasecca e Pontecorvo,<br />
ove sbocca nel Garigliano. Fonte di ubertà e di ricchezza, la<br />
Melfa alimentò anticamente gualchiere e molini: ai giorni nostri<br />
dà vita a una fiorentissima cartiera, fornisce d'acqua potabile Settefrati,<br />
S. Donato, Gaiiinaro ed Alvito, e somministra l'energia<br />
elettrica per l'illuminazione di Atina, di Picinisco, di S. Donato e<br />
di Gallinaro.<br />
Povero d'acque si mostra invece il versante alvitano, il quale<br />
non ha che un piccolo stagno - detto il lago - dietro gli avanzi<br />
! del Castello, e il Rio molle, or ricordato, che nasce dal colle di Ca-<br />
stagneto, ai confini tra Alvito e S. Donato, si volge ad Oriente e,<br />
t- dopo aver lambito la collina di Gallinaro, si mesce col Rio nero.<br />
l<br />
l<br />
I<br />
Ma la penuria è solo apparente, e non fu tale nei tempi andati, co-<br />
me ci è stato tramandato da varie testimonianze, di cui - quale<br />
che possa essere la relazione delle acque con gli sconvolgimenti del<br />
l Vedi le mie Pagine sparse di storia alvitana, Chieti, Iecco, 1908-09, I, pp. 23-<br />
29. Occorrendomi di citarle, le indicherb.d'ora innanzi con le iniziali P.S.
suolo - ci sembra opportuno far brevemente ricordo.<br />
Un diploma cassinese del 970 menziona il Taurino e il Giuliano,<br />
che uscivano dal monte Albeto, ai termini di Vicalviz: lacora - dice<br />
il documento -; ma dal contesto pare debba intendersi fossero<br />
piuttosto due fiumicelli allargantisi a forma di lago, che poi si restringevano<br />
e attraversavano l'adiacente campagna fino al ponte<br />
Dapino3. Dei due nomi è perduta da un gran pezzo ogni memoria;<br />
di acque scaturenti dal dorso occidentale del monte Albeto e di un<br />
lago nell'agro vicalvese non sopravvanza traccia; è rimasto soltanto<br />
da quella parte, e propriamente a mezza strada tra Alvito e Sora,<br />
il lago della ~osta,'nel quale per certo si fusero, coll'andar del<br />
tempo, i primi due4. E' formato principalmente dal Fibreno che<br />
emana da moltissime polle alle radici del monticello su cui siede<br />
quella borgata. Da quest'acqua è stata tratta la forza elettrica che<br />
alimenta l'illuminazione di Alvito. E' ingrossato dal Carpello, che<br />
sgorga a ponente di questa, circa un miglio più in suS, dopo breve<br />
cammino passa sotto il ponte Dapino ed entra nel Sorano per raggiungere<br />
il Liri. Degna di nota 5 un'opinione del Biondo secondo<br />
la quale la più abbondante e più profonda vena del Fibreno, che il<br />
Descrittore del Ducato alvitano designa come «la surgenza e fontana<br />
maggiore», deriverebbe dal Fucino6.<br />
Un altro lago, anch'esso scomparso, ma più tardi, era sul Colle<br />
la Civita, ad oriente d'Alvito, ove nel Medio Evo sorgeva la Civitas<br />
S. Urbani. I1 Castrucci, che ne apprese l'esistenza da un suo<br />
«Lacera, quae dicuntur Taurini et Iuliani, quomodo ipse aque exeunt de monte<br />
Albetu» (V. il Documento nel mio studio: Sora negli Annali delBaronio, Roma<br />
191 1, p. 37.) E nei Regesti di Pietro Diacono si legge: Lacora Zuliani et Todini qui<br />
esse videntur in finibus Vici albi. Cfr. B. SANTORO, Poche memorie del Castello di<br />
S. Urbano, Città di Castello, 1888, p. 38.<br />
~Quomodo decurrunt ipsa praedicta lacora et vadunt ad Pontem qui dicitur<br />
Dapino», doc. cit .<br />
' Tra la fine del secolo XI e il principio del XII, quando scriveva Leone Ostiense,<br />
i due laghi eran tuttavia distinti, ma sembra si fossero avvicinati al luogo che fin<br />
da allora si chiamava Posta: nome che poi passb al lago e in seguito alla borgata<br />
che sorse più tardi suli'altura sovrastante. Ecco i relativi passi di Leone, all'anno<br />
972: ~Hildebrandus, comes de Sora, [...l fecit cartam de medietate lacuum Taurini<br />
et Zuliani, qui procedunt a Posta». E più oltre: «Rachis gastaldeus de Vicalbo do-<br />
navit beato Benedicto curtem suam cum ecclesia S. Victorini, p r o p e p r a e -<br />
dictos Iacus, ubi modo Posta vocatura. L.O. Chron.<br />
Mon. Casinensis, 11, 6 (seguo l'edizione del PERTZ, M.G.H. Script. VII.)<br />
' I1 punto di confluenza del Carpelio col Fibreno era anticamente chiamato<br />
iunctura: ~quornodo currit ipsefluvius Carpello ei mittit in lacu ubi dicitur iunctura»,<br />
doc. cit.<br />
CASTRUCCI, Descrittione del Ducato d'Alvito, Napoli, 1686, p. 81.
6 che<br />
un terremoto si perse con molte altre, e per segno di questa<br />
de le fontanelle, che spiccia tuttavia tra le rocce in una campagna<br />
E chi conosce o nomina più il ruscello dei Lontri, che, or è men<br />
di tre secoli, bagnava per circa due miglia una valle da settentrione<br />
a levante del paese? Limpidissimo ruscello - scrive ancora il Ca-<br />
. strucci - «di cui l'acqua è tanto fredda che in poco tempo aggranchisce<br />
le mani e spezza il vetro [.. .] Ha il letto di minutissime<br />
petruzze e di terra porosa, che a poco a poco assorbendola, na-<br />
sconde il vago e mobile argento negl'interni repostigli della<br />
Terra9. Unico segno superstite son oggi in quella contrada le denominazioni<br />
Capo d'acqua e Valle di rio. Del resto la toponoma- ,<br />
stica rurale, in cui ricorrono parecchi altri simiglianti appellativi,<br />
.P.<br />
h<br />
quali acquara, bagnara, fontana, fonte, guado9, offre manifesta<br />
xova di luoghi anticamente percorsi dalle acque.<br />
Questa circolazione sotterranea è finalmente attestata da nume-<br />
rosi pozzi che, escavati a non molta profondith sia nell'abitato e +<br />
egli orti, sia nei poderi, servivano a dissetar la popolazione prima<br />
fosser dedotte, come s'è accennato, le pure linfe della Melfa.<br />
E fra tante sorgenti naturali sono specialmente da notarne due, ,i<br />
solforose, alle opposte estrernith delia Valle alvitana: la prima ad<br />
oriente, sotto il colle di Castagneto; l'altra ad occidente, non lungi<br />
dal Borgo sotto una lieve eminenza, detta il Collicello.<br />
CASTRUCCI, OP. cit., pp. 21-22.<br />
CASTRUCCI, op. cit., p. 37.<br />
q Acquara grande, Bagnara, Fontana Lepre, Fontana vihrla, Fontana ufa, Fontana<br />
lottora, Fontana pescopane, Fontana la Sala, Fontana rava, Fonte margiotta,<br />
Fonte della latta, Guado Carrone, Guado Eleuterio, Guado fossa micciola, Guado<br />
grande, Guado S. Croce, Pescarola, Riofeta (rivus foetidus?).<br />
. . < .- 1- r.- 7 . , --<br />
- . . . -. ' : . *.5 .L . - 17 -5 ,.,:Ss-<br />
- C<br />
.a<br />
3 ,<br />
'<br />
.-<br />
-'I -<br />
- .<br />
. .<br />
.J<br />
' l .<br />
, ,<br />
~ - . 4<br />
A'~z-*-<br />
- . l -,..:.;..-L:
Ciò premesso, accingiamoci a rievocare i più gravi <strong>terremoti</strong> che<br />
funestarono questa e le regioni limitrofe. Prenderemo le mosse dal<br />
secolo XII, che è quanto dire dall'origine di Alvitolo.<br />
'O Dei <strong>terremoti</strong> anteriori, a cominciar.dall'Era volgare, furono infesti aila<br />
Campania - e pib particolarmente alla Terra di Lavoro - quelli degli anni 97,<br />
324, 345, 801, 847, 1004 e 1071. I tre ultimi tormentarono specialmente Monte<br />
Cassino. V. BARATTA, I Terremoti d'Italia, Torino, Bocca, 1901; E. CAPOCCI, Catalogo<br />
dei <strong>terremoti</strong> avvenuti nella parte continentale del Regno delle due Sicilie: in<br />
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze naturali di Napoli, IX (1861).
Nel 1120 il Cominese apparteneva, già dal 748, alla Badia di<br />
Monte Cassino, la quale, oltre ad esservi andata sempre più affor-<br />
zando il suo dominio, ne aveva considerevolmente allargati i con-<br />
fini, a segno che nel 1022, sotto la denominazione di Contado di<br />
Cornino, detto anche Sorano, eran compresi Sora, con la rocca<br />
Sorella, e i castelli di Vicalvi, Picinisco, Atina, Settefrati, Fiorolo<br />
(oggi, S. Padre), Rio Schiavi (oggi, Fontechiari), Arpino e S.<br />
Urbano'. In seguito, per ragioni che qui non importa riferire, So-<br />
ra, Arpino, Fiorolo e Rio Schiavi ne furono distaccati, e passaro-<br />
no ad altri Signori; S. Urbano, Vicalvi, Atina, Picinisco e Sette-<br />
frati rimasero alla Badia, che vi istitui dei feudi, prima in favore<br />
dei Conti dei Marsi, devotissimi al monastero di S. Benedetto, poi<br />
anche de' Conti d'Aquino, uno dei quali - Landolfo - pose ma-<br />
no, dopo il il 1087, ad edificare il castello su la vetta del monte<br />
Albetoz. E ai piedi e su le coste di questo monte, verso la fine del<br />
secolo XI e su gli albori del XII, comincia ad apparir qualche trac-<br />
cia di solitari abitatori: un tal Bono nel 1096, una certa Netta nel<br />
11033. I1 paese, che più tardi si chiamerà Alvito, non vi era ancor<br />
sorto, e gli altri limitrofi, di origine più antica, non dovevano esse-<br />
re più che piccole borgate, ciascuna con la sua torre o fortezza e<br />
con la sua chiesa, presidii e segni della duplice potestà che i Cassi-<br />
nesi vi esercitavano; in molto maggior numero, anche fuor<br />
dell'abitato e sparse qua e là per la campagna, le chiese4, di cui<br />
' Da un documento riportato in Sora negli Annali del Baronio, p. 21, n. 3. Nessuna<br />
menzione di S. Donato. Sembra che il paese non esistesse ancora: si ha memoria<br />
soltanto di una chiesa, nel territorio di Comino, alle falde del monte Pezzullo,<br />
dedicata al Santo, onde prese nome il borgo, che venne successivamente formandovisi<br />
intorno: chiesa antichissima, donata nel 778 da Ildebrando, duca di<br />
Spoleto, al Monastero di S. Vincenzo al Volturno, in una con le sue pertinenze che<br />
toccavano il Monte Acero, oggi Forca d'Acero. Chronicon Vulturnense, I, p. 2a,<br />
p. 373.<br />
P.S., I , pp. 38-39.<br />
' B. SANTORO, OP. cit., p. 43.<br />
Oltre venti ne registrarono le cronache di Leone Ostiense e di Pietro Diacono e<br />
le carte cassinesi riferite dal Gattola: S. Angelo, in prossimitl della Melfa; S. Benedetto,<br />
una presso Vicalvi, una in S. Urbano; S. Croce, in Settefrati; S. Giuliano,
non poche avevano accanto una cella, dimora dei monaci che vi<br />
rappresentavano l'autorità badiale. Così, mentre la vita del Cominese<br />
si svolgeva sotto l'egida benedettina, la sua vicinanza a «quel<br />
monte a cui Cassino è nella costa» lo rendeva partecipe delle medesime<br />
vicende naturali.<br />
Tra le più memorabili son da annoverare i <strong>terremoti</strong> del 1120,<br />
che, irraggiandosi da S. Germano, si estesero per ampio giro alla<br />
regione circostante, e non oltre 4 bi~<br />
i <strong>terremoti</strong> - diciamo - per-<br />
ché furon molti, e si ripetettero per parecchi giorni, fino a nove,<br />
diciassette e più di venti volte5. Pietro Diacono, che ne fu testimo-<br />
ne oculare, non si diffonde gran che <strong>sui</strong> luoghi danneggiati, limi-<br />
tandosi ad annoverare soltanto: Comino6 - ove crollo<br />
un palazzo, forse, la residenza del feudatario -; Cuccuruzzo' -<br />
che ebbe rovesciata la chiesa e la «curia» - e i dintorni di Bantras<br />
nella valle di Castagneto; S. Felice, sotto S. Urbano, nel colle detto Abbate e, a poca<br />
distanza, S. Maria, S. Andrea e S. Giovanni; S. Maria, in Canneto; S. Martino,<br />
ai Colli arsicci, ad oriente del monte Albeto; S. Nazario, sulla Melfa; S. Nicola, in<br />
S. Urbano; S. Paolo, nelle pertinenze di Settefrati; la «basilica» di S. Pietro, in S.<br />
Urbano; S. Quirico, su un colle a breve tratto dal monte Albeto; S. Salvatore; S.<br />
Stefano; SS. Trinità, una presso Atina, una in S. Urbano, non lontana da quella di<br />
S. Giovanni; S. Valentino, sul fiume Mellarino; S. Vittorino, in quel di Vicalvi; ed<br />
altre.<br />
'bis «Magni terraemofus i n h a c t e r r a facti sunt». PIETRO DIACONO,<br />
Chron. casin. IV, 65. E non si ha alcunànotizia che si ripercuotessero altrove.<br />
' ~Nunc quidem novem, nunc decem et septem, nunc viginti et eo amplius [vicibN<br />
sentiremus)), PIETRO DIACONO, Chron. Casin., 1.c.<br />
«In Cornino» - legge il TOSTI (OP. cit. 11, pp. 36-37) seguito dal CAPOCCI (op.<br />
cit . p. 339) dal BARATTA (OP. cit . p. 24) e dal P.B. PAOLONI (Cronistoria sismica<br />
cassinese, in Bollett. mens. dell'Osservatorio di M.C., Marzo 1913, V, n03, pp. 11-<br />
12): i tre ultimi anzi spiegano: Comino, ora Alvito. Lasciando stare che I'identificazione<br />
t inesatta, poiché Comino era, nel medio evo, il nome non di un paese ma<br />
di tutta la Valle, ove, dopo il 1120, sorse Alvito, t da osservare che l'edizione pertziana<br />
della Cronaca di P. Diacono ha in questo punto Camino, non Comino. E il<br />
castello di Camino, donato nel 1101 a S. Benedetto dal conte Landenolfo, ritolto<br />
nel 1114 dai figli di Pandolfo di Presenzano e riconquistato quell'anno stesso<br />
dall'Abate Girardo, era in diocesi di Teano, confinante col villaggio di Galluccio.<br />
GATTULA, Acc., p. 219. Trovando nominati, subito dopo, Coccoruzzo e Bantra, si<br />
sarebbe indotti a credere che qui si tratti piuttosto di Camino, che con gli altri due<br />
paesi è a mezzogiorno di M. Cassino; ma il P. Paoloni, che, a mia preghiera, ha<br />
gentilmente confrontato il Codice manoscritto, mi assicura che la lezione vera t<br />
Comino.<br />
' Cuccuruzzo - alle falde dello spento vulcano di Roccamonfina - Cronist.<br />
sism. cass., 1. C. Ivi era una rocca e un monastero di S. Salvatore, donato nel 1066<br />
a M. Cassino. LEO OST., Chron. 111, 16; e GATTULA, Hist. Cas., p. 312.<br />
"untra, poi Vandra - che erroneamente il BARATTA (1.c.) identifica con Isernia<br />
-era posta presso la confluenza del torrente omonimo -oggi detto Peccia -
- nei quali chiese, case e campanili furono abbattuti e molte per-<br />
sone rimasero sotto le rovine -; ma mostrandoci, con altri parti-<br />
colari, qual terrore e quali apprensioni avessero occupato gli ani-<br />
mi e commosso le fantasie, ci rivela indirettamente la gravità di<br />
quel parossismo, che a qualche altro cronista cassinese fece dire:<br />
((pareva fosse giunto il giorno del giudizio^^. Già tre anni iman--<br />
W, quasi tutta l'Italia - specialmente il Veneto - era stata dura-<br />
mente provata da simile sciagura, e col racconto dei disastri, esa-<br />
gerati e confusi dalla lontananza, eran corse voci di strani fenome-<br />
ni e di prodigi: fosche nuvole color di fumo e di sangue addensate-<br />
si a poca altezza dalla terra; alberi verdeggianti sradicati e il suolo<br />
, .smosso ricopertosi di folti vapori; un bambino, non ostante l'età<br />
!tenerissima, aver parlato e vaticinato cose portentoselo: facile<br />
5uindi intendere come, nella rinnovata sovreccitazione, ottenesse-<br />
to agevolmente fede le notizie più inverosimili.<br />
Continuando dunque i <strong>terremoti</strong> - racconta Pietro Diacono -<br />
$i presentò alla Badia uno Spagnuolo, e riferì come tre volte gli<br />
fosse apparso presso Termoli S. Benedetto, e gli avesse detto: va',<br />
;ed annunzia al17Abate che inviti tutti coloro che abitano nelle terre<br />
ia lui soggette, a convenire scalzi nel mio monastero per placar con<br />
,preghiere Iddio, sdegnato delle colpe e dei delitti crescenti degli<br />
uomini: egli, con gli altri monaci, ne dia primo l'esempio. L7Aba-<br />
bandì subito il precetto, e tutti obbedirono; ma, giunti sul decli-<br />
io del monte, si fece loro incontro il diavolo, sotto forma di zop-<br />
.'ho, e li avvisò che la chiesa della Vergine e la massima parte della<br />
à erano già dirute. I pellegrini gli credettero, e in gran fretta<br />
\ornarono indietro, tralasciando le preci incominciate; senonchk,<br />
~rrivati alla città, e accortisi del17inganno, si proposero di compiein<br />
altro giorno il voto. Quand'ecco, nelle prime ore della notte<br />
tronb un'altra fortissima scossa, ed i monaci, balzando esterreratti,<br />
corsero piangendo ed ululando a prostrarsi al sepolcro<br />
a.1 loro Padre, e davanti a tutti gli altari si diedero ad iterar la saljie.<br />
Terminate le suppliche, non una pietra si mosse più. Come<br />
ib fu risaputo, dai paesi della giurisdizione benedettina tutti, a<br />
piè nudo, si recarono su al tempio ad implorare la divina clemen-<br />
.a. E immediatamente le scosse cessarono".<br />
Garigiiano. Dirimpetto, al di 18 di questo torrente, sorge Roccadevandro.<br />
AITENBACH, note alla Cronaca di L.O. Il, 15.<br />
Cronist. sism. cas.., 1.c.<br />
'O P. D., Chron. IV, 62; MURATORI,<br />
Ann. d'lt., all'anno 1117.<br />
" P. D. IV, 65.
Anche le genti del Cominese vi trassero certamente in mesta<br />
processione: di là forse più che da altre parti, sia perché più spe-<br />
cialmente colpite, sia perché di recente erano state sorprese da un<br />
fatto straordinario, che Pietro Diacono chiamò addirittura «insi-<br />
gne miracolo»: vogliam dire la visione di Alberico da Settefrati,<br />
che varcò ben presto i nativi confini e precorse, secondo alcuni,<br />
l'epopea dantescaI2. Era Alberico figlio di un nobile uom d'armi<br />
(non sembri estranea questa digressione, che giova a lumeggiar<br />
l'anima dei tempi di fronte ai <strong>grandi</strong> sconvolgimenti della natura),<br />
e toccava il lo0 anno, allorché fu colto da un deliquio che lo tenne<br />
immobile e privo di sensi per nove giorni ed altrettante notti.<br />
Rientrato in sé narro che, durante quello spazio, era stato condot-<br />
to da S. Pietro a da due Angeli a visitare i luoghi infernali e il pa-<br />
radiso, e manifestò le cose maravigliose che aveva visto ed udito:<br />
gli orribili tormenti dei dannati e le beatitudini dei giusti, e quanto<br />
l'Apostolo gli aveva fatto noto sulla corruzione del secolo e, speci-<br />
ficatarnente, sulle colpe di alcune persone viventi'" L'impressione<br />
che in quell'epoca di rozzi costumi, d'ingenua fede e di supersti-<br />
ziosa ignoranza siffatte rivelazioni destarono negli umili valligiani<br />
dovette esser vivissima; e chi sa quanti, nel pellegrinaggio a Monte<br />
Cassino, chiesero una parola di conforto al loro Conterraneo,<br />
che; dopo la visione, da quando aveva vestito il saio, aborrendo<br />
dal mangiar carne, dal ber vino, dal calzarsi i piedi, menava lassù<br />
vita di si grave austerità e di si aspra penitenza che - dice il suo<br />
confratello Pietro Diacono - nessuno poteva mettere in dubbio<br />
l2 La data precisa della visione s'ignora, ma non t difficile desumerla, con sufficiente<br />
approssimazione, da alcuni particolari che ci sono offerti dallo stesso Alberico<br />
e da Pietro Diacono, il quale collaborò con lui, verso il 1130, a stenderne una<br />
seconda narrazione, poiché la prima, scritta da certo monaco Guido, era stata da<br />
altri alterata. Sappiamo dunque da Pietro Diacono che Alberico ebbe la visione nel<br />
tempo che l'Abate Girardo governava la Badia (ossia tra il 11 11 e il 1123), e che,<br />
subito dopo, si chiuse in M. Cassino e si rese monaco a dieci anni. Alberico, a sua<br />
volta, confermando queste circostanze, aggiunge nell'epistola proemiale che fin<br />
quasi dalle fasce, per così dire, Pietro gli era stato congiunto nell'amore di Cristo.<br />
Ora, poiché questi fu dai genitori consacrato quinquenne a S. Benedetto nel 11 15,<br />
non certo avanti quell'anno incominciò la sua consuetudine con Alberico. Donde 6<br />
agevole dedurre che o questi già nel 1115 si trovasse a M. Cassino, o che vi fosse<br />
andato non molto dopo: quindi la data della visione non può che cadere intorno al<br />
1115, o forse uno o due ami pih tardi. P. D., Chron. IV, 66; e cfr. la prefazione<br />
del WATTENBACH, (Ed. PERTZ, p. 564); Epbtola Fratris Alberici in Visionem<br />
suam, in CANCELLARI, Osservazioni sopra l'originalità della D.C., Roma, 1814, p.<br />
134.<br />
Alberici visio, 8 45 in CANCELLIERI, OP. cit.
non avesse egli realmente veduto e temuto le pene dei peccatori, e<br />
contemplato la gloria dei Santi14. I<br />
Con questa manifestazione di pietà si chiuse dunque l'angoscio-<br />
so periodo sul quale ci siamo intrattenuti; ma prima che finisse il<br />
secolo XII il terremoto tornò ancora a ripetersi sette volte, negli<br />
anni 1136, 1140, 1141, 1146, 1152, 1169 e 117215. Di questi, qual-<br />
cuno fu assai forte1" se non che, stando ai laconici cenni del Cro-<br />
nista, il quale si contentò appena di registrarli, par che l'ultimo<br />
soltanto avesse origine locale17, e nessuno, ad ogni modo, fosse<br />
così intenso come quello del 1120.<br />
' P.D., 1.c.<br />
Cronist. s h. cass., 1.c.<br />
« Valde magnus» nel 1141; «maximus» nel 1172 - AN. CASS., ivi.<br />
l7 ~Maximus terraemotus fuit i n h i s r e g i o n i b u s », AN. CASS., ivi.<br />
Cfr. CAPOCCI, OP. cit. p. 340.
1 GIUGNO 1231<br />
Furono ben tristi per la Carnpania gli anni che corsero dal 1229<br />
al 1231. Accanitesi le ostilità tra il Papato e l'Impero, Gregorio<br />
IX, profittando della lontananza di Federigo 11, allora impigliato,<br />
contro sua voglia, nella spedizione di Terrasanta, nel 1239 mandò<br />
nelle nostre regioni, sotto la guida di Giovanni di Brienne, un eser-<br />
cito di chiavesegnati - così detti dall'insegna pontificale che por-<br />
tavano pe divisa - ed ebbe in sua potestà Sora, Arpino, S. Ger-<br />
mano e tutti i paesi della Valle di Comino. Ma ben poco poté go-<br />
dere di tali conquiste, poiché Federigo, disimpacciatosi dalle cose<br />
di Palestina, rapidamente tornò in Italia, e, nel Settembre dello<br />
stesso anno, radunate le sue milizie - che, in contrapposto, si<br />
chiamarono di crocesegnati - scacciò dai luoghi occupati le genti<br />
papali, riconquistò per forza il Corninese, ricuperò per dedizione<br />
Arpino e S. Germano, mise a sacco e a fuoco Sora che volle<br />
resistergli', devastò poi Brocco, Pescosolido ed Isola del Liri e, at-<br />
terratene le mura, costrinse gli abitanti a cercarsi asilo altrove2.<br />
Quetate le ire, cominciavano i nostri a riaversi appena dalle bu-<br />
fere delle scomuniche e delle armi e dalle atroci immanità, a cui<br />
s'erano abbandonati a gara chiavesegnati o crocesegnati3, quando<br />
nell'agosto del 1230, a scombuiar maggiormente gli animi ango-<br />
sciati, giunse in San Germano - e fu subito divulgata - una let-<br />
tera di certo maestro Giovanni da Toledo, che, concorde con altri<br />
astrologi di Spagna e di Etiopia, preannunziava fra sette anni, e<br />
propriamente in Settembre, un gran terremoto e malattie e morta-<br />
lità straordinaria, e battaglie ed altri spaventosi fenomeni per aria<br />
' La distruzione di Sora avvenne il 24 ottobre del 1229. Federigo datava le sue<br />
lettere: «In castris ante Soram combustam», BORNHER, Die Regesten, n. 658. Riccardo<br />
da S. Germano, cronista contemporaneo, scriveva: dora facta est cibus<br />
ignis, Campaniae militibus, qui ad civitatis ipsius defensam congregati fuerant, in<br />
Campaniam fugientibus per montana, nonnullis civium igni ferroque peremptis)),<br />
Chronicon, in Raccolta di varie croniche, diari etc. del Regno di Napoli, Napoli,<br />
Peger, 1782, pp. 237-38.<br />
RICHARDI, Chronicon, ivi, p. 241; GALEOTTI, Catalogo (cfr. P.S., p. 40); PA-<br />
LOMBO, ECC/. Atin. hist. (esemplare dattilografato) 11, p. 212.<br />
' V. a questo proposito: DEL GIUDICE, Riccardo Filangieri al tempo di Federigo<br />
11, di Corrado e di Manfredi, in Arch. St. P.N. XVI (1891) I, p. 112.
'<br />
.- --.<br />
5-<br />
- --L<br />
ed in mare: terminava, ammonendo tutti ad uscir dalle case, a fab-<br />
bricarsi delle capanne al largo e a ricoverarvisi con le famiglie4.<br />
Qual che fosse l'intento e il valore del vaticinio - probabilmente<br />
composto in odio a Federigo 11, poiché contiene in fine un'oscura'<br />
predizione di pericoli sovrastanti al suo regno5 - certo è che la<br />
domenica lo Giugno del 1231, verso mezzodì, il terremoto awen-<br />
ne; e, se, a quanto pare non cagionò morte, sparse di rovine la no-<br />
stra provincia, da Capua a Roma, rovesciando case, campanili,<br />
chiese e castelli, e, ripetendosi per oltre un mese, costrinse le po-<br />
polazioni a lasciare i loro tetti6.<br />
S. Gemano e i luoghi vicini furono più specialmente colpiti:<br />
sembra anzi che di là si propagasse l'urto, poiché si videro le ac-<br />
que di limpide farsi torbide e per due ore mutarsi in fetido fango,<br />
e la montagna sfranarsi e aprirsi il suolo, talché gli abitanti teme-<br />
vano di essere inghiottiti vivi7. ~d Atina cadde, presso che intera-<br />
mente, il tempio di S. Maria8; il che pub darci indizio che non mi-<br />
nor iattura incogliesse agli altri paesi della Valle. Grande fu il ter-<br />
rore e grande il concorso delle turbe che, per invito dell'Abate cas-<br />
sinese Landenolfo, anche questa volta salirono in processione alla<br />
Badia9: il ricordo delie recenti guerre, aggiunto forse alla sinistra<br />
predizione, teneva in dubbio quelle popolazioni - e lo storiogra-<br />
fo atinate ne fa espresso cenno - non forse si preparassero futuri<br />
RICHARDI, Chronicon, ad ann. MCCXXX, p. 247.<br />
ddem audimus de Rege siculo, quae periculosa videnturx ivi, p. 249. Del resto<br />
simili scritture si facevano allora correre cosl dai Guelfi come dai Ghibellini per<br />
gettar timori e discordie nel campo awersario.<br />
aTerraemotus iste intonuit die illo et hora praedicta, a Capua usque Romam<br />
[...l et quia duravit ultra mensem, interdum plus, interdum minus, attoniti homines,<br />
dimksis laribus et locis propri&, ne domorum illos mina contereret, ad agros<br />
exibantp. RICHARDI, Chronicon, ad ann. MCCXXXI, ivi, pp. 254-55. - Riccardo<br />
non fa cenno di vittime; tuttavia il monaco cassinese PANIIOLFO PETRUCCI, che<br />
scrisse una Cronica del Sagro monastero di Monte Casino dal I140 al 1726, dice:<br />
«Multar ecclesias aedesque quam plurimas, n o n s i n e h o m i n u m<br />
s t r a g e , p r o s t r a v i t», Cron. sism. C-. in Boll. cit., Aprile 1913, p. 12.<br />
Ma crediamo che il silenzio di Riccardo valga piii della tarda affermazione del Petrucci,<br />
anche percht questi errb nella data del terremoto che riferì al 1233 invece<br />
che al 1231.<br />
' « Terraemotus factus est subito in S. Germano et per vicina loca [. ..l qui, quod<br />
dictu et audìtu mirabile est, limpidos aquarum fontes de S. Germano in faecis foetulentae<br />
cotorem mutavit, et tal^ cotor aquarum per duas ferme horas duravit, saxa<br />
dirupit, propter quod homines timebant vivos a terra sorberi~, R~CHARDI,<br />
Chronicon, l .C.<br />
PALOMBO, 11, p, 211.<br />
RICHARDI. 1.c. e cfr. Tosn, op. cit. 11. p. 273.<br />
15
mali alla Chiesa e allYItalia o il Cielo volesse, con quel mezzo, richiamarle<br />
su la via del benelo.<br />
E non bastò; ché nel gennaio e nel febbraio del 1233 - riferiamo<br />
anche questo malanno per co.mpletare il quadro delle sventure<br />
di quegli anni - sopravvenne tanta abbondanza di piogge e di nevi<br />
e rigidezza di temperie che greggi, belve, uccelli morivano dal<br />
freddo e dalla fame. Si congelarono i fiumi, s'inaridirono gli olivi,<br />
le viti e gli alberi fruttiferi: il vino, chiuso nelle botti, a stento si liquefaceva<br />
all'azione del fuoco; il ghiaccio rendeva immobili i molini;<br />
molti furon trovati stecchiti, nel letto: dal che, un'immensa<br />
carestia e, dopo la carestia, la peste".<br />
lo PALOMBO, 1.c.<br />
RICHARDI, Chronicon, ivi, p. 207 e PAZ.OMBO, 11. p. 213.
9 SETTEMBRE 1349<br />
I1 terremoto del 9 Settembre 1349' - uno dei più tremendi che<br />
'<br />
ia Storia ricordi - segna ad un tempo la distruzione e la rinascita<br />
di Alvito. Erano circa due secoli e mezzo che su la vetta del monte<br />
i Conti d2Aquino avevano edificato il Castello, e già, all'ombra<br />
del baluardo feudale, s'era formato e prosperava rapidamente il<br />
paese, sì da superare notevolmente tutti gli altri della Valle, ed anche<br />
la vicina Sora. Ne è prova la cedola delle sowenzioni (o tabel-<br />
_ la delle imposte), a cui essi erano soggetti nel 1320. Mentre infatti<br />
S. Donato doveva annualmente 13 once, Settefrati 17, Picinisco<br />
' 13, Gallinaro 9, Atina 24, Vicalvi 12, Sora 47, il tributo di Alvito<br />
, ascendeva a 65 once2: segno evidente di maggior popolazione e di<br />
migliori condizioni economiche. Ed ecco abbattersi sul promettente<br />
rigoglio l'indeprecabile rovescio.<br />
'<br />
Amplissima fu l'estensione di quel movimento che avvolse in un<br />
turbine il Lazio e lYUmbria, le Marche e l'Abruzzo, il Molise e la<br />
I Campania, e tanta la veemenza che - scrisse l'Anonimo Cassinese<br />
- dal principio del mondo non vi fu il simile: anche pih fiero<br />
' del terremoto awenuto per la morte di Cristo3: ((sentenza, se non<br />
vera, - osserva giustamente il Tosti - abbastanza significante il<br />
gran conquasso»\ Ben a ragione, l'epigrafe apposta l'anno seguente<br />
sull'entrata della ricostruita rocca alvitana diceva: Fu tremore<br />
per le terre e generale il pericolo per le varie parti del<br />
Regno'.<br />
l Circa la data, i cronisti dissentono e per il giorno, e per l'anno. Mi sono atte-<br />
.nuto, col Ciarlanti e col Tosti, a un'antica memoria che si conserva nell'archivio<br />
della Cattedrale d'Isernia e ad un anonimo Cronista cassinese, contemporaneo O<br />
quasi, riferito testualmente nella citata Cronist. sism. cass., Bollett. maggio 1913,<br />
no 5, p. 15. Cfr. CAPOCCI, OP. cit. pp. 412-15.<br />
P.S.. 1, p. 56. L'oncia equivaleva a 6 ducati da L. 4.37.<br />
Questa terrificante impressione si trova anche in una rozza Cronaca in versi<br />
delle cose di Aquila, scritta dal contemporaneo Buccio Ranallo e pubblicata dal<br />
MURATORI, Antiq. ital. medi aevi, 1779, Vol. XVI, 349:<br />
«Dalla morte de Christo non fo meyure veduto:<br />
Appena homo trovosenci che non gisse storduto.<br />
. Da persone ottocento de Aquila fo atterrate,<br />
Che per lo terremuto forno morte e sotterrate».<br />
' Tosn, op. cit., 111, p. 49.<br />
((Tremar in terris fuit et generalepericlum / Per varias Regniparies>>, P.S., I,<br />
17
L'agitazione, manifestatasi dapprima gagliardamente la notte<br />
del 22 gennaio, così nell'Italia meridionale come nella settentrionale<br />
ed oltre Alpe6, culminò nel mattino del 9 settembre, fra le otto<br />
e le nove7. Per quanto riguarda le nostre contrade, le vetuste<br />
memorie concordemente ne deplorano gli immensi danni. I1 documento<br />
iserniese registrò laconicamente: distrusse tutta la provincia<br />
di Cominos. In Alvito le annose mura del Castello - attesta<br />
l'epigrafe or menzionata - furono interamente adeguate al<br />
suolo9; e un antico libro manoscritto riferito dal Vincenti conferma<br />
la notizia ed aggiunge: il Castello d'Alvito cadde totalmente,<br />
seppellendo molti della famiglia Cantelmo con Adenolfo d'Aquino<br />
(che era il signore della terra) e la moglie, di casa Cantelmo, coi<br />
figli e con tutta la servitù e con dodici domestici, nativi di<br />
Pescas~eroli'~. Se tale fu la sorte del più saldo e massiccio edificio,<br />
è facile immaginare che avvenisse delle piccole case aggruppate sul<br />
pendio.<br />
Non meno ne soffrirono i paesi limitrofi, come può desumersi<br />
da quel che intorno ad Atina ci ha tramandato il Palombo.<br />
Nell'ora funesta, parte della gente assisteva alle sacre funzioni,<br />
parte era uscita alla campagna per attendere alle sue faccende. I<br />
primi fecero appena in tempo a fuggire che videro le pareti abbattersi<br />
l'una contro l'altra con ingente fragore, cader la rocca e la<br />
chiesa di S. Stefano e rotolar giù dal monte sassi e macigni; gli altri,<br />
udito il tuono spaventoso, rimasero come inebetiti e quasi attaccati<br />
al terreno. La cittadina divenne subito un mucchio di macerie:<br />
della rocca, del tempio di S. Stefano e del muro di cinta non<br />
rimasero che le vestigia: della popolazione si salvarono quei pochi<br />
che o s'eran recati agli uffici divini in S. Maria e in S. Marco, o<br />
s'eran trovati fuori di casa, o abitavano nei casali: alcune famiglie<br />
furono affatto estinte, di altre soprawisse qualcuno soltanto". Fu<br />
CIARLANTI, Memorie hi<strong>storiche</strong> del Sannio, Isernia, 1644, p. 398. «Anno D.<br />
1349, de Mense Zanuarii, in nocte S. Vicentii, post cenam fuit unus terraemotus<br />
multum magnusn (Dalla citata carta d'Isernia).<br />
«In hora mediae tertiaen: (Carta d'lsernia): «Id fuit hora missae» (Anonym.<br />
Cass.).<br />
«Destruxit totam provinciam Cominii~.<br />
«Haec moenia prorsus / Sunt aequata solo, dederunt annosa ruinam)).<br />
'O P.S., pp. 36-37.<br />
l' ((Familiae Sardinella, Comprendina, Calandra, Saracina, Contuberia, AIphrada<br />
et Putaua penitus extinctae. Superstites fuerunt aliqui ex familiis Domini-<br />
cona, Luca, Mancina, Marina, Mastri Marci Dominici, Zannucii, Palomba, Pagana,<br />
Persechina, Papa, Taboleria, Todina, Vallis et Ziza*, PALOMBO, ECC/. Atin.<br />
Historia (Esemplare dattilografato) 11, p. 245.
tale la mortalità che Ristasio Cantelmo dové raccoglier uomini dai<br />
luoghi vicini e condurveli per aiutare i superstiti ad estrarre di softo<br />
alle pietre i cadaveri e i semivivi ed a ricuperar gli averi<br />
sepolti 12.<br />
Circa mille vittime ebbe S. GermanoI3, ove «le case locate su<br />
per la costa del monte stettero, le costrutte nel piano, perché molle<br />
e paludosa la terra, sprofondar~no»'~: ((strano caso invero - nota<br />
il Capocci -: non già che sia raro di trovar tali parziali preferenze<br />
dei tremuoti in una medesima città, ma perché la parte alta<br />
di S. Germano, che rimase illesa, trovasi edificata alle falde del<br />
colle, in cima al quale sorge il Monastero, che fu interamente distrutto»".<br />
A Sora, ((<strong>grandi</strong>ssime ruine)) di edifici - scrive il Villani<br />
-; il castello di Balsorano dal poggio precipitò nella valle, «con<br />
morte di quasi tutti i suoi abitanti»I6; Arpino ebbe case atterrate e<br />
gran numero di estinti16bis. Molte popolazioni - fra cui, dobbiamo<br />
ritener per certo, anche le nostre - furon alleviate, in conseguenza<br />
del disastro, dalla metà dei balzelliI7.<br />
Con animo virile, tuttavia, i colpiti si risollevarono, non ostante<br />
che all'immane catastrofe un'altra se ne aggiungesse di lì a poco, e<br />
non men deleteria; la peste, che già dal 48 faceva strage in ItaliaI8.<br />
L'anno seguente, il Castello d'Alvito era giA risorto, meglio rifabbricato<br />
e cinto di nuove e cosi salde mura che ormai da quasi sei<br />
secoli risfidano il tempo. Ne ebbe specialmente merito quello stesso<br />
Ristasio Cantelmo che sollecito accorse in ausilio ad Atinalg;<br />
ma non è a credere che egli fosse spinto da pietà o da amor di pa-<br />
l2 PALOMBO, OP. cit., p. 244.<br />
" ((Subvertit monasterium cassinense cum tota terra S. Germani, in qua mortui<br />
fuerunt homines fere mille» (Carta d71sernia).<br />
l' TOSTI, OP. cit . , p. 50. Dall'Anonimo Cassinese: «Media corruit praecipue illa<br />
pars, quae erat in plano, seu paludibus, et in ea innumera multitudo hominum ac<br />
mulierum mortua est».<br />
l5 CAPOCCI,<br />
OP. cit., p. 414.<br />
l6 M. VILLANI, Cronaca, I, 45.<br />
I6bis Dal Martyrologium Arpini, in Ecclesia S. Mariae adservatum, pubblicato<br />
dal PIERLEONI, in Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della ma<br />
morte, Roma 191 1, pp. 647 ss.: «Anno d.ni MCCCXXXXVZIZZ fuit magnus terramotus<br />
die nono mensk Septembrk, ex quo multa hedificia ceciderunt et gensplurima<br />
mortuav.<br />
l' Documenti citati dal CAPOCCI, ivi.<br />
~VALOMBO, OP. cit., p. 246.<br />
l9 ~Ristaysius tamen in melius vir nobilis ille<br />
Guantelmus egregio priscorum nomine patrum<br />
Restituit, castrumque novum, nova moenia fecitn (Epigrafe citata).
tria. Imparentato con la distrutta famiglia dei d'Aquino, tolse subito<br />
occasione dal sinistro accidente per riedificar la rocca ed assicurarsi<br />
la successione al dominio alvitano, e ne fu difatti investito<br />
dalla Regina Giovanna e dal Re Luigi20. Gli Atinati da lor volta,<br />
fecero cuor risoluto, e per cansare in avvenire un tanto pericolo,<br />
spostarono la sede della loro città, pur senza discostarsi troppo<br />
dall'antica, e precisamente intorno al palazzo che a modo di fortezza<br />
i Cantelmo andavano costruendo, tra il monte e la Collegiata<br />
di S. Maria. I1 caseggiato riuscì molto più piccolo di quello<br />
abbattuto2]; ma, cosa notevole per quei tempi, fu convenientemente<br />
disposto secondo un piano pre~tabilito~~: il che dimostra<br />
una saggia previggenza, della quale non sempre si può dar lode ai<br />
moderni.<br />
lo «Huic pro tot meritis Rex et Regina dedemnt<br />
Hoc castmm, quod tunc Adenuiphi morte vacarat.<br />
Tempora si quaeris, millenos atque tricenm<br />
Quinquaginta dabis» (ivi).<br />
" PALOMBO,<br />
1. C. ~Oppidum,<br />
remansib)<br />
uPlateis et vicis opportune dl
5 E 30 DICEMBRE 1456<br />
Nel giugno del 1456, apparve in Italia una cometa, che il volgo,<br />
come suole, temette annunziatrice di sventura: «una stella - regi-<br />
strava il Cronista bolognese - rotonda e grande come un occhio<br />
di bue, dalla quale usciva una fiamma larga a modo di coda di pa-<br />
vone, a raggi~'. Nell'agosto, tra Firenze e Siena, si scatenò un ci-<br />
clone non mai visto: «nuvoli neri, dieci sole braccia alti da terra, si<br />
raunarono, e poscia scoppiando in fulmini e baleni mossero un<br />
vento si impetuoso che portò via i tetti dalle case e chiese, molte<br />
ancora ne abbatte, sbarbicò dalle radici gran copia di alberi, ucci-<br />
se animali, e trasportò uomini e carri con le bestie ben lontano da<br />
un luogo all'altro, per aria>>? Che questi, ed altri non meno prodi-<br />
giosi, fossero segni precursori dell'orrendo terremoto che si scate-<br />
nò sul Regno di Napoli nel Dicembre nessuno potrebbe affermare;<br />
ma certamente tali furon creduti nell'opinione popolare, e non<br />
nell'opinione popolare soltanto3.<br />
Scoppiò la convulsione tellurica nella notte dal 4, che cadeva di<br />
sabato, al 5 Dicembre4, con una scossa formidabile, lunghissima;<br />
L Cron. bol. in R.I.S. XXIII, 720. Cfr. Il terremoto del 1456: in Arch. St. per le<br />
Prov. Nap. X (1885), 11, p. 345.<br />
MURATORI, Ann. d'Italia, ad annum. Cfr. Abmm.4~0, Istoria di Firenze, lib.<br />
23.<br />
L'annalista forlivese, infatti, riferisce: alia non audita nec visaper longa tempera,<br />
quae creduntur evenisse ex effectibus cometae. R.I.S. XXII: citato nell'articolo<br />
su ricordato: I1 terremoto del 1456, p. 345.<br />
Essendo questo terremoto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 Dicembre, qualche<br />
storico ne ha segnato la data al 4, donde qualche altro lo ha chiamato il terremoto<br />
di S. Barbara, la cui festa ricorre appunto il 4 Dicembre: ma quasi tutti, con maggiore<br />
esattezza, al 5, poiché la mezzanotte era già passata. Quanto aii'ora precisa,<br />
tuttavia, CB discordanza forse più apparente che reale. L'ambasciatore senese a<br />
Napoli, Bindi, annunziava il 7 Dicembre: «a dl 4 de questo, sonate le XI ore»<br />
(Arch. St. P. N., p. 349): l'ambasciatore milanese Da Treno: «Sabato passato, de<br />
nocte, circa le due hore, venendo la domenica» (Arch. St. P. N. XII (1887), I, p.<br />
151); neiie note di un altro ambasciatore milanese Francesco da Cusano, inviato<br />
dal Duca Francesco Sforza per condolersi col Re di Napoli, si trova: «a dy quatro<br />
de Dexembre, tra la X e XI hora» (Arch. St. P. N. XIII (1888), IV p. 785). Le fonti<br />
provinciali sono pih esplicite. In un antico calendario, che precede il martirologio<br />
di Usuardo, ms. nella Biblioteca degli Agostiniani di Aquila, si legge: «A. D. 1456,<br />
die 5 mensis Dicembris, circa undecimam horam noctis» (MURATORI, Ant. ital.
«durò per spacio di uno decimo d'ora e forse più» - scriveva da<br />
Napoli l'ambasciatore Senese Bindi5, col quale concorda I'amba-<br />
sciatore milanese Da Trezzo: ((Durò per tanto spatio de hora<br />
quanto se dicesse una volta e meza lo in principio erat verbum9;<br />
continuò per tutto il mese, con altre leggiere o innocue, si ripetette<br />
con forza, però eguale alla prima, a 16 ore (9 antimeridiane) del<br />
30'. I1 cataclisma, e per vastità e per intensità, fu enorme: valentis-<br />
simi poeti - dice a ragione il Bindi - affermavano «non avere<br />
lecto né in grecho, né in latino maiore ruina de questa>P. Non un<br />
angolo degli Abruzzi, della Campania, del Molise, della Basilica-<br />
ta, delle Puglie ne andò immune. Le relazioni degli ambasciatori,<br />
la narrazione di S. Antonino, vescovo di Firenze, che particolar-<br />
mente annovera i luoghi colpiti, non ostante che l'elenco sia neces-<br />
sariamente imcompleto, gli accenni che ne han lasciato i varii sto-<br />
rici riempiono l'animo di raccapriccio. Impossibile determinare<br />
con precisione quante persone perissero nei singoli paesi, poiché<br />
fra tanto sconvolgimento - e più che mai in quei tempi, in cui di-<br />
fettavano pronti mezzi di comunicazione - era ben difficile assu-<br />
mere notizie sicure; malagevole anche accertarne il numero com-<br />
plessivo, che altri fa ascendere a trenta o più mila, altri a settanta e<br />
taluno perfino a cento mila9: cifre stra<strong>grandi</strong>, chi voglia raggua-<br />
medii aevi, 775); così anche in una Historia aquilana, contemporanea, di FRANCE-<br />
SCO D'ANGELUCCIO (in MURATORI, ivi): «alli 1456, a dì 4 de Dicembre, e fo a ore 11<br />
de notte». Le 11 ore italiane corrispondono, nel mese di Dicembre, alle 4 antimeridiane.<br />
' BINDI, in Arch. St. P. N. X (1885), 11, p. 349. Così anche il Da Cusano, su citato:<br />
«durò per un decimo d'ora».<br />
DA TREZZO, in Arch. St. P. N. XII (1887) I, p. 151. Anche il Cronista bolognese,<br />
usando in un simile paragone, dice che durò lo spazio di un miserere, detto adagio,<br />
o piuttosto di un miserere e mezzo. R.I.S. XXIII, 772.<br />
((Zterum XXX die eiusdem mensis, hora XVI*, DIVI ANTONWI, ARCH. FLO-<br />
RENTINI, Chronicorum 111 Pars. Londra, 1586, 111, p. 581. I1 SUMMONTE (Historia<br />
della Città e Regno di Napoli, IV, p. 246) narra sulla testimonianza del Passaro,<br />
che nell'ora del 2' terremoto, il re Alfonso si trovava a sentir la messa nella chiesa<br />
di S. Pietro martire, e vedendo il tempio scuotersi e tutti darsi alla fuga, restò intrepido<br />
e fermo coi suoi, e fe' anche fermare il sacerdote che celebrava e voleva levarsi<br />
dall'altare. Domandato, dopo, perché non si fosse mosso, rispose con la sentenza<br />
di Salomone: corda regis in manu Domini. In tutto il resto della narrazione il<br />
Summonte segue la Cronaca di S. Antonino.<br />
BINDI, 1. C.<br />
«Temesi che questo terremoto havrà mancato in le terre de le anime XXX m»;<br />
DA CUSANO, 1. c., p. 785; nel Calendario agostiniano è notato: mortui fuerunl in<br />
regno praedicto circa 34 millia virorum ac mulierum; in un elenco, dovuto forse a<br />
un frate tedesco: «Si dice che nel paese siano rimaste morte 70 mila persone, e ciò è
gliarle alla popolazione delle città e delle borgate italiane nel secolo<br />
XV. Caddero, a cominciare dal S. Elmo fortezze e torri munitissime,<br />
mura di cinta, ponti, palazzi, conventi e templi: basterà<br />
considerare - conchiudeva la sua lettera l'oratore senese - che di<br />
quante campane erano le chiese di Napoli sole sette ne rimasero<br />
che potevan sonarelo. E questo è ancor poco: 71 fra città e castelia<br />
furono sprofondate o quasi affatto atterrate", alcune tragicamente,<br />
come Ariano, di cui non restò casa in piedi; Boviano, che fu<br />
sommersa con tutti gli abitanti dalle acque improvvisamente scaturite;<br />
Isernia, ove la gente rifugiatasi in chiesa fu tutta coperta<br />
dalle macerie; Capua, Benevento, Montecorvino, che, per giunta,<br />
fu consumata dal fuoco'2.<br />
Che dire della costernazione dei superstiti? «Se siamo vivi, non<br />
ce pare poter essere, sì siamo perterriti et alienati de la mente per<br />
la <strong>grandi</strong>ssima paura habbiamo avuta et havemo~. Così il Bindi: e<br />
tale dovette essere lo stato di tutti davanti al miserando spettacolo.<br />
Le campagne furono, per molti giorni e notti, piene di tende<br />
(più di 4500 intorno a Napoli), ove si stipavano i profughi, atterriti,<br />
oltre che dall'accaduto, dai foschi pronostici che gli astrologi<br />
andavano spargendo nuovi, prossimi disastri". I1 re Alfonso, che<br />
allora soggiornava a Foggia, credendo ai presagi di un indovino,<br />
usci a tre miglia della città, in una pianura, e quivi pose il campo<br />
con tutto il popolo, come si accampa un esercito"; poi ordinò che<br />
si facesse una processione, da Foggia al Capo di Terra d'otranto,<br />
formata da trecento giovinetti <strong>sui</strong> dodici anni, sotto la guida di vescovi,<br />
preti e gentil~omini~~. Cosa più strana accadde a Capua.<br />
S'<br />
.q accaduto in massima parte di notte)) (Arch. St. P. N. X, 11, p. 359); così anche<br />
.I nell'Historia aquilana del D'ANGELUCCIO (l. c.): «E avisovi che nci morsero in nel-<br />
- lo Reame, circa a persone 70 milia, del ditto terremuto». Invece, in una lettera del<br />
''5 marchese Ercole d'&te scritta da Foggia al fratello: ((molte città [...I furono guaste<br />
e sprofondate con molta gente che si valuta un centomila persone, piuttosto in<br />
più che in meno)), Arch. St. P. N., ivi, p. 357.<br />
'O BINDI, 1. c., p. 352.<br />
Da una nota in margine a una lettera spedita al Card. Colonna. Arch. St. P.<br />
N. X, 11, pp. 355-56.<br />
1 l2 Dalle fonti citate, pmim.<br />
'' «Così siamo stati in queste tempeste più di e nocte per vaticinio di alcuni<br />
astrologi e calculatori, li quali dicono de stranie cose de pianeti ci governano)).<br />
; BINDI, 1. C,, p. 351. E il regio segretario Talamanca al Duca di Milano: ((Sono al-<br />
*.<br />
.,- ',curie confabulationi de Astrologi che infine de questo presente mese sarà grande<br />
,(terremoto) et che farà gran male in Roma, in Horenza et in Ferrara, quod Deus<br />
. ' avertatn, Arch. St. P. N. XIII, IV, p. 783.<br />
cit. in Arch. St. P.N. X, 11, p. 357.<br />
: . 2% , 23<br />
--h--
- .-.<br />
C - -<br />
.. .<br />
notizia da testimoni oculari - ((essendo lonze de la città per duve<br />
miglie ghe aparse il Crucifisso, in aere e in croce, il qual vedendo<br />
I ..I tutti i Capoani che lì erano, tuti comenciano a cridare: misericor-<br />
i,- ì<br />
L. - dia, misericordia, e lui ghe voltò le spalle, in signum dedignatio-<br />
e--- .<br />
p + l -: nis»16.<br />
I' &CI. .<br />
Veniamo ora ai danni toccati alle terre nostre o a noi più vicine.<br />
Nella penuria, che pur dobbiamo lamentare, di particolari notizie<br />
*.<br />
,I:,' - né il Tuzii ci soccorre per Sora, né per Atina il Palombo - in-<br />
.:;' > contriamo nondimeno qualche accenno che ci permette di ritener<br />
i ' . 4 - ' .C<br />
-. .<br />
per fermo che, quale più, quale meno, furono anch'esse percosse:<br />
--il<br />
Martirologio arpinate, anzi, pone la provincia Cominii tra le<br />
l '<br />
parti del Regno più duramente flagellate, insieme col Beneventano<br />
e col M~lise'~~'~. Aivito sappiamo che fu {(distrutta in parte)), ed<br />
ebbe a deplorare ventisei vittime"; da simile eccidio fu desolato il<br />
. Castello del Duca di Sora18; ad Arpino rovinò la rocca, che era sul<br />
,I- - -.<br />
5<br />
r- - .&- monte, e la torre della Chiesa di S. Francescolg; a S. Germano, co-<br />
i. . .' =m<br />
R.- -<br />
-t . .. .- .<br />
h * '. -,<br />
me raccontò l'ambasciatore De Scanderbergh, che, recatosi a quei<br />
giorni da Roma a Napoli, vi si era trovato a passare, precipitarono<br />
chiese e campaniliz0; e simili nuove - aggiunge il Bindi - arriva-<br />
vanodai luoghi circostanti2I.<br />
L'inaudita caliunità ridestò ed accrebbe, 'qui come altrove, il<br />
-. l6 Dalle note di FRANCESCO DA CUSANO, l.~., p. 787.<br />
L. - . , l 6biS Dal Martyrologium Arpini, l .c.: «Anno D.ni MCCCCL VI, V mensis Dev?<br />
*i :*. cembris, noctis tempore, inter horas XI et XIZ fuit magnus terramotusper univer-<br />
L 5, :, sum, ex quo in regno et maxime in Valle beneventanq comitatu Molisis etprovin-<br />
- _. - ._ . - _: - cia Comini civitates et castra et hedificia plurima precipitarunt et gens permulta<br />
p ,- '. .l: ' l i<br />
4 6- -= : mortua fuit».<br />
l<br />
I.-; ; ,-, -- . ;-,!- " uAlvitu in parte destructa, viginti sex extincti sunt». Cronache di S. Antoni-<br />
,
fervore religioso, e Montecassino fu la meta delle moltitudini<br />
esterrsfatte, che tuttodì accorrevano in pellegrinaggi espiatorii a<br />
prostt-zirsi davanti al sepolcro di S. Benedett~~~.
24 LUGLIO 1654<br />
Per circa due secoli, dopo l'immensa catastrofe del 1456, le no<br />
stre regioni non patirono altro conquasso. Non è certamente da<br />
credere che per sì lungo spazio, durante il quale più che cinquanta<br />
<strong>terremoti</strong> - e qualcuno ben gagliardo - agitarono le altre parti<br />
continentali del Regno di Napoli', esse rimanessero affatto quiete:<br />
si può tuttavia ritener per fermo che, qualunque sia stato il nume-<br />
ro e la forza delle scosse, nessuna, a giudicar dal silenzio delle sto-<br />
rie e dei documenti locali, fu apportatrice di danni e di sventure.<br />
Ma, purtroppo, andava maturando un nuovo parossismo, che<br />
ruppe nella notte dal Giovedì, 23, al 24 luglio del 1654, verso le<br />
cinque ore e mezza2, e si protrasse fino al 12 Agosto. I1 suo centro,<br />
giusta l'opinione del Baratta, fu «nei pressi di Isola del Liri)), e la<br />
sua area, «da Veroli ad Alvito e da Arce a Pescosolido»': ma l'ir-<br />
radiazione si spinse assai più lontano, poiché, stando alle notizie<br />
conservateci da un Anonimo Cronista benedettino, che scrisse sot-<br />
to l'impressione viva dell'evento, si propagò da una parte fino<br />
all'agro romano, dall'altra al di là di Capua4.<br />
La notte era serena - attesta l'Anonimo, dal quale togliamo<br />
questi particolari -: solo, continui, vividi lampi solcavano il cie-<br />
lo, e la luna tramontava rosseggiante. Su le cinque ore e mezza,<br />
balenò un lampo «tanto infocato che pareva volesse abbruciare la<br />
terra», e nell'istante stesso il suolo tremò così orribilmente che il<br />
monastero sembrava «una canna agitata da più venti)), e il rim-<br />
bombo dei tetti e delle pietre cadenti e di alcune grosse palle, che<br />
ornavano la cisterna del chiostro e la balaustrata dell'atrio detto<br />
' Se ne veda l'elenco nelle opere citate dal CAPOCCI, pp. 342-47, e del BARATTA,<br />
pp. 75-137, i quali per6 non sempre concordano nelle date e nei luoghi. La Cronologia<br />
sismica cassinese (Boll. 1913, n. 10, pp. 15-16) ne registra inoltre alcuni che<br />
non son notati né dall'uno, né dall'altro.<br />
Secondo la numerazione ecclesiastica. Poiché il 23 Luglio 1'Ave Maria corrisponde,<br />
giusta il computo presente, alle ore 19,45', così le 5 ore e 1/2 coincidono<br />
con un'ora e 15' dopo la mezzanotte, cioè con un'ora e 1/4 del giorno successivo.<br />
Inesattamente quindi è stato detto da alcuni che questo terremoto avvenisse il 23<br />
Luglio.<br />
BARATTA, OP. cit., p. 785.<br />
' Cron. sism. cass., Boll. 1914, n. 2, pp. 14-15.
ilparadiso, somigliava a «tiri di bombarde)). Mentre neila Badia<br />
tutto era fuga e scompigiio e, ad accrescere il terrore, sopraweni-<br />
vano a breve intervallo due forti repliche, dail'alto del monte i<br />
monaci osservavano che «la città di S. Germano e le altre casteila<br />
convicine erano state anch'esse svegliate dal letargo, poiché per<br />
tutto si vedeano lumi e si sentivano voci che assordavano l'aria,<br />
uscendo tutti dalle case per salvarsi nella campagna, cercando cia-<br />
scheduno il confessore, perché conosceva che la morte era<br />
vicina»$. Se da quella cima l'occhio avesse potuto spaziare per ben<br />
pia ampio orizzonte, avrebbe visto, in ben maggior numero di cit-<br />
th e di villaggi, moltiplicarsi simultaneamente la tragica scena not-<br />
turna. Tutti i paesi che si trovavano nell'area su delineata - e non<br />
soltanto quelli - ricevettero, qual pih, qual meno, l'urlo tremen-<br />
do; ma intorno ad essi, il Cronista che, naturalmente, si sofferma<br />
di proposito su quel che riguarda Monte Cassino, nulla ci appren-<br />
de si speciale, e si appaga di nominarli, riferendo con qualche in-<br />
certezza, le nuove che arrivavano lassù, dove forse neppw tutte<br />
arrivavano. «Belmonte è affatto diroccato)) - scriveva egli quat-<br />
tro giorni dopo -; ((Alvito, Atina, S. Apollinare, Casale, La Po-<br />
sta, Picinisco, Settefrati, Casalvieri, Monte S. Giovanni, Rocca<br />
Guglielma, Isola e Sora (dove d i C e s i che dentro una chiesa<br />
sono morte 55 persone) hanno in parte o in tutto ricevuto il casti-<br />
go di Dio, e molte altre terre che per brevità si tralasciano, perché<br />
fino adesso si sa che il terremoto, che per anco leggermente si fa<br />
sentiree, sia stato in molte parti dell'Abruzzo, in Gaeta, Sessa,<br />
Piedimonte d'Alife e Capua, g i u d i C a n d o s i anche in Na-<br />
poli, e s i C r e d e parimenti in Roma»6.<br />
Dobbiamo dunque integrar la narrazione dell'Anonimo, attin-<br />
gendo da altre fonti.<br />
In Alvito cadde la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangeli-<br />
sta, che fu poi cominciata a restaurare dal duca Tolomeo Gallio<br />
nel 1682. Tanto, e non altro troviamo in una nota aggiunta aila ri-<br />
stampa della Descrittione del Castrucci7: evidentemente, più che il<br />
ricordo del terremoto, l'editore ebbe in mira, per fine cortigiane-<br />
sco, di tramandare ai futuri la munificenza ducale, cosicché, senza<br />
questa, non avrebbe forse neanche fatto un cenno fugace di quel-<br />
lo. Ma la rovina della chiesa fa ragionevolmente pensare che<br />
' Cron. sism. cm. ivi.<br />
Cron. s&m. cass., ivi.<br />
' Descrittione cit . , p. 25.
non ad essa sola toccasse una tal sorte.<br />
Contraddittorie son le notizie che si hanno di Sora. I1 Capocci,<br />
non so su quale testimonianza, afferma che fu «ro~esciata»~; il<br />
Tuzii, che ne pubblicb le Memorie &toriche nel 1727, dice che<br />
«cadde solo l'antica chiesa di S. Restitutang, ed aggiunge: «Del resto<br />
rimasero illese le abitazioni e le persone dei cittadini»lO. E neppure<br />
è menzione di vittime in un'epigrafe, riferita dallo stesso Tuzii,<br />
la quale fu apposta a una cappella votiva, innalzata dai Sorani<br />
neila campagna ove dimorarono fino al 3 1 Luglio per scampar dal<br />
pericolo1'. L'Anonimo cassinese, invece, registrò la voce che vi<br />
perissero «dentro una chiesa)) 55 persone: cosa poco o punto credibile,<br />
poiché non si comprende a che scopo si trovasse riunita<br />
questa gente in una chiesa, un'ora dopo la mezzanotte, ove non si<br />
voglia supporre che vi si rifugiasse in cerca di scampo e di protezione.<br />
Ma neanche è da accettar senz'altro l'asserzione del Tuzii,<br />
il quale sembra preoccupato soprattutto dall'intento di mostrare<br />
come la città dovesse la salvezza alla protezione di S. Ignazio, alla<br />
cui Compagnia egli apparteneva. Da un'altra relazione si rileva<br />
che vi si ebbero a deplorare, «a quanto si diceva)), quattrocento<br />
mortir2. Anche qui ci troviamo davanti a un «si diceva»; ma il numero<br />
è tale che ci par bene difficile potesse essere inventato, senza<br />
alcun fondamento di verità. Tutto dunque induce a conchiudere<br />
che Sora fu tra le città pia duramente colpite.<br />
' CAPOCCI, OP. cit., p. 348.<br />
La caduta della chiesa di S. Restituta è confermata dai Martyrologium Arpini,<br />
f. 38.<br />
lo TUZII, Memorie i<strong>storiche</strong>.. . di Sora, Roma, 1727, pp. 235-36.<br />
" Crediamo opportuno riportarla: «Qui dove ora è una Cappella fu già un altare.<br />
La vigilia dell'apostolo S. Giacomo, con orribilissimo terremoto, fu memorabile<br />
a Sora nel mese di Luglio dell'anno 1654. I1 terrore (sic) delle case e dei cuori tenne<br />
in turbazione, più di un giorno e di una notte, con gli scuotimenti replicati più<br />
volte. Per non restar sotto le ruine delle case, andarono gli abitanti alla campagna.<br />
Questo campo posto su la strada col suo ricovero salvò Sora, dove essa su la mezzanotte<br />
tutta concorse. Avresti veduto in queste strettezze foltissima gente che dal<br />
terremoto fuggiva, e per tutto baracche a suo scampo. Qui, con incredibile devozione,<br />
si passarono otto giorni interi in orazioni, prediche, messe, confessioni quasipubbliche<br />
e comunioni, delle quali il numero fu quasi cinquemila. Il giorno festivo<br />
di S. Ignazio (31 Luglio), fondatore della Compagnia di Gesù, terminò la campagna<br />
e la paura. Con la scorta ed aiuto di lui si ritornò finalmente alla città con riportare,<br />
in forma di processione, la Reliquia di Lui, come di Nume favorevole aile<br />
case)). Tum, 1. C.<br />
'' Si conserva manoscritta nella Biblioteca Barberiniana di Roma: è riportata<br />
dal BARATTA, OP. cit., p. 138 ed in Cron. sism. cass., p. 15.<br />
,
Trentuno - secondo la relazione medesima - furono i morti<br />
ad Isola del Liri, centoquindici ad Arpino - ove fu subissato il I<br />
quartiere di Civita, il campanile della chiesa di S. Michele con una<br />
cappella ivi eretta dalla famiglia Quadrini e le volte della chiesa di<br />
S. Antonio" -; diciannove a Castelliri, in cui sprofondarono set-<br />
te case; sette a Pescosolido; venticinque ad ArceI4: molti e molti<br />
ancora, ignorati o dimenticati, dobbiamo argomentare soccom-<br />
bessero in altri paesi sia della Terra di Lavoro, sia del Lazio (il Ca-<br />
. pocci li fa ascendere complessivamente a tremila's), se leggiamo<br />
: che si spaccò perfino il Monte Corvo, e Casalvieri fu rovinata,<br />
r Monte S. Giovanni Campano per metà adeguata al suolo, Bauco<br />
L ebbe tredici case abbattute, Veroli sessantaquattroI6. Dai dati rac-<br />
, colti, tuttoché incompleti, possiam quindi dedurre che il terremo-<br />
8 .<br />
C?.'<br />
J<br />
to del 24 Luglio 1654 va annoverato tra i più disastrosi.<br />
l3 «La notte che il terremoto fece gran danno, spallb S. Michele, ciob il Campanile<br />
vecchio e la Capella di D. Pietro Quatrino et le lamie di S. Ant. ... », dal Martyrologium<br />
Arpini, cit.<br />
'' Relazione barberiniana, 1. C.<br />
CAPOCCI, OP. cit., 1. C.<br />
Relazione barberiniana, 1.c.
DAL 1654 AL 1873<br />
Fra il terremoto del 26 Luglio 1654 e quello del 12 Luglio 1873,<br />
non ne troviamo altro che, come il primo riescisse esiziale al Co-<br />
minese e al Sorano. Senonché questi 219 anni non trascorsero tutti<br />
tranquilli, ché non mancarono, a brevi intervalli, più o meno ener-<br />
gici scuotimenti, in massima parte per ripercussione di eruzioni<br />
del Vesuvio o di altri cataclismi, prossimi o lontani1. Tra i quali,<br />
su lo scorcio del secolo XVII, due potentissimi: il beneventano,<br />
del 5 Giugno 1688, vigilia della Pentecoste (V.)2, e l'avellinese,<br />
de11'8 Settembre 1694 (V.), che durarono l'uno un miserere, l'al-<br />
tro un credo, e, per tacer degli edifizii abbattuti, disseminarono il<br />
primo forse più di 8 mila morti, presso a 5 mila il secondo3. I più<br />
terribili rovesci colpirono, naturalmente, le due plaghe originarie<br />
e le provincie finitime, ma sì ampio e poderoso fu il movimento<br />
che anche l'estrema zona della Terra di Lavoro - Sora ed Atina<br />
specialmente4 - ne subì gli effetti rovinosi, mentre nessun sinistro<br />
gravò nel 1688 su la Badia di Monte Cassino, ove pur la concus-<br />
sione fu tanto gagliarda che il P. Gattola; ripetendo una similitu-<br />
dine adoperata da altro cronista del monastero a proposito del ter-<br />
remoto del 1654, afferma aver vista la cupola della chiesa tenten-<br />
nare come una canna.al vento5. E non dovette essere un'allucina-<br />
zione, ché, a rincalzo'di questa autorevolissima testimonianza, ab-<br />
biamo una rozza narrazione, che riporto, per maggiore efficacia<br />
nella sua genuinità, a prova della singolarità del caso. «Arrivati<br />
' Di soli <strong>terremoti</strong> cassinesi, tra locali e ripercossi, si contano 51 dal 1655 al<br />
1699, circa 150 dal 1702 al 1734 e 80 dal 1735 al 1790, e non son tutti! V. Cron.<br />
sism. cass. Bull. 1914, p. 12 e PILLA, Relazione dei Terremoti etc. in Annali civili<br />
del Regno delle Due Sicilie, 1837, fasc. 28, pp. 103-105.<br />
Faremo seguire da questa iniziale la data dei <strong>terremoti</strong> connessi con le conflagrazioni<br />
vesuviane, desumendole dalla citata opera del Capocci.<br />
' CAPOCCI, pp. 349-50: BARATTA, pp. 155-161, e 173-79. Raccolgo queste cifre<br />
dagli elenchi pubblicati dal BARATTA pp. 173-79; ma esse son certamente inferiori<br />
al vero, non essendo state notate le vittime di tutti i paesi. I1 CAPOCCI dice che nel<br />
solo terremoto del 1688 queste furono «circa ventimila)), numero indubbiamente<br />
esageratissimo.<br />
"BARATTA, p. 785.<br />
Cron. sism. cass., 1. C.
sabbato, io ero andato al mercato<br />
Tomasso Colella<br />
Lumbardo, mi pareva che il cielo<br />
in piedi, et nemmeno poteva<br />
re bene, ma sbagliava nelparlare, parlando col detto Tomas-<br />
et se non era che ini trovai una mazzetta in mano, sarìa cascato<br />
volte, et questo durò da cinquanta passi; et finalmente uno<br />
aveva animo di parlare con l'altro tra di noi cosa c'era sortito.<br />
, arrivati alla casella della masseria, trovassimo Rocco Sacco,<br />
zone di M. Giuseppe capraro, colcato in terra, et li dicessimo<br />
che causa stava giaciuto in terra: esso ne rispose che voleva an-<br />
oi gli addimandassimo quanto tempo era che questo caso li<br />
, et lui rispose che haveva da un mezzo quarto d'ora circa: al-<br />
io, rivoltato al detto Tommaso li dissi che a me anco è stato<br />
to il medesimo, quahdo proprio stavamo d o colle Lumbar-<br />
, et esso anco affermò che il medesimo li era sortito, sì che niu-<br />
di noi sapevamo che cosa fosse stato. Poi ne dessino animo,<br />
caminassimo tutti tre (benché mezzo storditi) per trovare le<br />
che stavano a nettare lo grano; et ivi arrivati, le femmine<br />
hore ventuno e mez-<br />
Avevamo gran desiderio di arrivare alla terra per sapere se era<br />
tito il medesimo, dove arrivati la sera, ognuno haveva che con-<br />
trovarno dentro detta Terra, con quattro<br />
O terremoto, ma, per<br />
no, et stessimo per<br />
;. ' Cron. sisrn. cass., ivi.<br />
' MURATORI, Annali d'Italia, ad annum 1706.<br />
eno il terrore che<br />
arra un anonimo
diarista - nel 1702, appena sentito il terremoto, tutto il popolo si<br />
riversò nelle chiese, e più che nelle altre in quella del Carmine, ove<br />
fu scoperta un'immagine del Crocifisso, «et con gran divotione<br />
ognuno cercava misericordia delli loro misfatti, et piangenno si<br />
confessavano; et il Cardinale subito mandò ordine che qualsivoglia<br />
sacerdote potesse confessare, con potestà di assolvere qualsivoglia<br />
peccato reservato a detta Corte arcivescovile, sino a nuovo<br />
ordine»8. Non altrimenti a Roma, nel 1703 - scrive il Muratori -<br />
ognuno corse «ad accomodar le sue partite con Dio; molti si ridussero<br />
ad abitar sotto le tende; e il pontefice Clemente XI prescrisse<br />
varie divozioni per implorar la divina miseri~ordia»~. Furono invero<br />
tre giornate funestissime pei territori di Norcia e dell'Aquilano<br />
il 14 e il 16 Gennaio e il 2 Febbraio del 1703: sorvolando sul<br />
gran numero delle case e delle chiese spianate (in qualche paese<br />
non ne rimase in piedi pur una); basterà dire che gli estinti furono<br />
9700!1°. I1 disastro, anche per la cruda stagione in cui avvenne, ha<br />
qualche tratto di somiglianza col recentissimo del 13 Gennaio<br />
1915. «Quantunque vi è stata usata tanta diligenza per fare scavare<br />
li poveri cristiani - leggiamo nel Diario napoletano or citato -<br />
non si è potuto far di meno che non vi siano restate da molte persone<br />
vive sotto ie pietre, senza essersi potute dissotterrare. Ed infatti<br />
si son sentite per più giorni gridare le misere genti che ancora<br />
erano vive sotto le rovine, a cagione delle spesse scosse e tremuoti<br />
che spaventavano la gente, di modo che niuno voleva accostare e,<br />
non si sono potuti aiutare in modo alcuno ... Quelli che furono<br />
scavati e camparono dalle rovine, alcuni sono morti di fame, et alcuni<br />
di freddo, imperciocché mancava a molti onde cibarsi, et non<br />
havevano tutti il comodo delle tende e baracche per guarentirsi<br />
dall'estremo freddo che si sente in quelle campagne))".<br />
Tuttavia, ad eccezione di varie ma innocue scosse sentite a M.<br />
Cassino tra il 25 Maggio e il 28 Agosto dell'anno suddettoJ2, pare<br />
che né il cataclisma norciano, né l'aquilano arrivassero ai nostri<br />
confini: non però altrettanto accadde del sulmonese, che gettò la<br />
desolazione e la morte in quasi sessanta paesi intorno alla Maiella,<br />
nella Marsica e nel Molise, e seppellì oltre 2500 personet3.<br />
Diario napoletano dal 1700 al 1709, in Arch. St. P. N. X (1885) f. I, p. 124.<br />
MURATORI, ivi, ad annum 1703.<br />
'O BARATTA, pp. 188-197.<br />
Diario napoletano, ivi, fasc. 2, p. 246.<br />
'* BARATTA, p. 198.<br />
l3 BARATTA, pp. 200 - 202. Tante ne risultano dall'elenco da lui riportato; il Capocci,<br />
p. 351, le fa ascendere a 15 mila!
, - 2<br />
est'ultimo, «per la maggior vicinanza, scosse fieramente anche<br />
a», ma - afferma il Tuzii - «senza danno delle case e con uti-<br />
elle anime, per le private e pubbliche orazioni e penitenze e per<br />
i la frequenza dei Santi Sacramenti, con cui ognuno procurò di pla-<br />
care l'ira divina. Oltre a ciò - egli aggiunge - il Duca [Antonio<br />
- Boncompagni], riflettendo che il duca Ugo, suo genitore, aveva<br />
col patrocinio della Madonna SS. di Loreto salvata Sora dalla pe-<br />
stilenza, giudicò ancor egli col medesimo patrocinio salvarla dal<br />
tremuoto. Quindi, per suo consiglio congiunto col suo esempio, si<br />
fece prontamente una solenne processione con la sacra statua del-<br />
> la Vergine Lauretana, si rinnovò da tutti il voto (che il 10 Dicem-<br />
bre. sarebbe sempre riguardato come giorno festivo), e per tutti se<br />
ne riportò dalla madre di misericordia la salvezza»14. Da questo<br />
ragguaglio - nel quale, come neil'altro riguardante il terremoto<br />
del 1654, allo storico prevale l'asceta - mentre rileviamo sotto<br />
quale incubo, per la frequenza di tale calamità, si vivesse a Sora,<br />
del pari che a Napoli e a Roma, possiamo pur desumere che Sora<br />
non fosse la sola città di quel versante, ove si producessero simili<br />
effetti. Tutte le terre poste al di qua dei monti d'Abruzzo, ove ha<br />
. principio la Campania, incorsero certamente nel medesimo peri-<br />
8' E<br />
- colo e nei medesimi timori.<br />
a nuove scosse, dove più dove meno forti, esse andaron sog-<br />
e parecchie altre volte durante il secolo XVIII. Noi ci conten-<br />
L i teremo di ricordar le date delle più notevoli, con accanto il nome<br />
dei paesi in cui furon segnalate, awertendo peraltro che il non tro-<br />
varne menzionati altri non vuol dire che. unicamente a quelli le<br />
scosse rimanessero circoscrifte. S'intenderà di leggieri come spe-<br />
cialmente i più vicini, o appartenenti allo stesso àmbito geologico,<br />
non ne andassero immuni.<br />
27 Agosto 1720: Monte Cassino ed AtinaIs;<br />
N 30 Maggio, 15 Luglio, 12 Settembre ed 1 1 Ottobre 1723: S. Ger-<br />
mano e dintorni16;<br />
20 Marzo, 2 e 26 Aprile, 27 e 28 Agosto, 3 e 10 Settembre, 24<br />
Ottobre 1731: S. Germano, Piedimonte e Terelle";<br />
25 Maggio, 13 Luglio e 5 Ottobre 1759 (V,); M. Cassino18;<br />
16 febbraio, 5 Aprile, 6 e 27 Novembre 1761 (V,): M. Ca~sino'~;<br />
l4 Tum, op. cit. p. 271.<br />
IJ BARATTA, pp. 208 e 785: CAPOCCI, p. 351.<br />
l* BARATTA, p. 209.<br />
ID., pp. 217-19.<br />
'"ID., p. 246.<br />
l9 ID., ivi.
1764 (V.): S. Simeone;<br />
3-23 Giugno e 6 Ottobre 1770: Sora ed ArpinoZ0;<br />
19 Agosto 1777 (V.): Veroli, Isola, Sora, Alvito: press'a poco,<br />
l'area medesima del parossismo del 165421.<br />
1783: S. Simeone (Terr. Cal. Siculo).<br />
Ben più gravi furon le conseguenze del terremoto molisano del<br />
1<br />
26 Luglio 1805 (V.) - detto di S. Anna - il quale pareggiò pei t-<br />
suoi orrori quelli di Benevento, di Norcia, di Aquila e di Sulmona.<br />
Durò 45 secondi, rase interamente al suolo quindici paesi alle falde<br />
orientali del Matese, ne distrusse parzialmente ventuno nella<br />
provincia di Campobasso, ne sconvolse parecchi altri anche nel ;I<br />
Casertano, nel Beneventano e nell'Avellinese, e, sopra una popo- t '<br />
lazione di 205.100 abitanti, ne uccise 5573, ne lasciò feriti o malconci<br />
1528l2. Fu inteso fin nell'umbria e nelle Marche, nel Leccese<br />
e nella Basilicata, ma più che mai in tutta la Terra di Lavoro, ed<br />
apportò rovine nel Sorano e nel ComineseZ3; poco più che un r. Q-<br />
grande spavento cagionò a M. Cassino, ove non lasciò che qual-<br />
che piccola fenditura nella Chiesaz4.<br />
E, purtroppo, questo non fu, nel secolo XIX, che il primo di<br />
una non breve serie. Circa un anno dopo, il 21 Luglio del 1806<br />
(V.) tra le 10 e le 10,15' a. m.=', si rinnovò, mediocre nel Sannio e ,<br />
a Sora, lungo e violento, con replica molto sensibile, a M.<br />
CassinoZ6. E tale dovette essere anche per Alvito, come è dimostrato<br />
dalla seguente proposta, riguardante la demolizione di un<br />
campanile: «Nel 1806 - 3 1 Luglio - Risoluzione - Si propone<br />
alle SS. LL. come il tremuoto avvenuto nel dì ... di questo mese, ,<br />
alle ore 14 incirca, avendo cagionato un notabile danno alla tribu- -<br />
na della nostra chiesa e, specialmente, alla cupola del campanile,<br />
la quale, essendo formata a figura di cono ed alta circa quaranta<br />
palmi, alle replicate scosse ed urti ondolatorii è rimasta gravemen-<br />
20 CAPocc1, p. 354.<br />
21 BARATTA, p. 785.<br />
22 ID., pp. 317-23; CAPOCCI, p. 357; DEL GIUDICE, Ragguaglio deiprincipali fe-<br />
nomeni naturali avvenuti nel Regno durante il 1857: in Annali civili del Regno del-<br />
le Due Sicilie, Vol. LXII (1858), p. 144.<br />
21 BARATTA, p. 785.<br />
" ID., pp. 319-20.<br />
2' L'ora è indicata dal BARATTA,<br />
p. 326,e concorda con auella notata, all'italiqna,<br />
nel documento che si riporta più oltre.<br />
/h*<br />
26 BARATTA, pp. 325-26; CAPOCCI, l .C.<br />
34<br />
-t
te lesionata ed aperta visibilmente a due lati di settentrione ed occidente,<br />
per evitare pertanto ogni imminente pericolo e qualunque J<br />
altro guasto ulteriore, conviene che interamente si demolisca, giusta<br />
la ricognizione e perizia fatta da più esperti ingegneri))".<br />
Altra prova eloquente della profonda impressione lasciata da<br />
quel terremoto e da un altro, che successe nella notte dal 16 al 17<br />
febbraio 1809 (V.)28, ci & fornita dal culto di S. Emidio che si inoziò,<br />
o si ravvivò, in Alvito appunto tra il 1808 e il 1809, a cura della<br />
Confraternita della «Buona Morte)), e che perdura tuttorazg.<br />
Dei successivi, fino al 1873, basterà una succinta enumerazione:<br />
23 Dicembre 1835 (V.): M. Cas~ino~~;<br />
12 Aprile-6 Giugno 1837: M. Cassino. Importante periodo si-<br />
smico, che cominciò <strong>sui</strong> primi d'Aprile a Villa, a tre miglia da S.<br />
Germano, facendovi crollare alcuni muri a secco; e continuò con<br />
frequenza crescente, con varia veemenza, e con una sequela di<br />
rombi sotterranei per quasi due mesi: la fase più acuta fu il 14<br />
Maggio, domenica di Pentecoste, alle 6 a.m., quando una scossa<br />
violenta, preceduta ed accompagnata da cupi boati parve dovesse<br />
diroccar tutte le case, e costrinse monaci e cittadini a fuggir preci-<br />
pitosamente e a ridursi in campagna o sotto capanne di legno3'.<br />
Anche ad Atina - raccontano i vecchi - la cittadinanza rimase<br />
per sei mesi attendata all'aperto, per il frequente rinnovarsi delle<br />
*' E' una risoluzione capitolare, ossia una proposta fatta al Capitolo dei Cano-<br />
nici di S. Simeone: il che prova che si tratta del Campanile di questa chiesa. Già<br />
molto prima esso era pericolante, poiché della necessita di demolirne la parte supe-<br />
riore è cenno in altre risoluzioni del 1764 e del 1783, coincidenti con due <strong>terremoti</strong>,<br />
l'uno del 3 Aprile, l'altro del 1 Marzo in corrispondenza col grande cataclisma ca-<br />
labro siculo. In quella del 4 ottobre 1783 si stabilisce di rivolgersi all'universith<br />
C-, p. 358.<br />
che preceduta dal triduo si celebrava la Domenica in Albis. Nel 1837 la festa in<br />
menica di Settembre, probabilmente in conseguenza dei <strong>terremoti</strong> cassinesi di<br />
queli'anno, di cui siamo per far parola.<br />
lo BARATTA, p. 379.<br />
Dalla citata relazione deli'insigne geologo Leopoldo Pilla, mandato dal Governo<br />
borbonico a M. Cassino per studiare le cause del suddetto terremoto: in Annali<br />
civili del Regno delle Due Sicilie, N. cit., pp. 95-96.
scosse (comunicazione del signor L. Marrazza).<br />
19 Settembre 1840: Chieti, Sulmona e S ~ra~~;<br />
8 Luglio 1842, alle 5 di mattina: Camp~li'~;<br />
13 Dicembre 1849, nella notte (V.): S. Germano";<br />
2 Dicembre 1855 (V.): S. Donato e Settefrati's;<br />
1857. Dal i0 Gennaio al 16 Dicembre, quindici <strong>terremoti</strong> per-<br />
corsero l'Italia meridionale; l'ultimo, tra i più immani, si abbatté<br />
sulla Basilicata. I prodromi furoni avvertiti anche nelle nostre par-<br />
ti: a Sora, il 6 Marzo; a Cassino, 1'11 Giugno: entrambi alle 9 di<br />
sera, in senso ondulatorio e della durata di tre secondi36. Decorse-<br />
ro, in quell'anno stesso, si scatenò sulla Valle di Comino un tre-<br />
mendo uragano, che devastò tutti i seminati; a S. Donato un ra-<br />
gazzo di tredici anni restò soffocato dalle acque che irruppero fu-<br />
riosamente in una stalla. A Sora, il 27 e il 29 dicembre, il Liri per<br />
la gran piena salì all'altezza di oltre sei palmi, inondando i piani<br />
terreni delle case, e trascinando via masserizie e quanto altro vi si<br />
trovava3'.<br />
19-28 Gennaio 1863: più di trenta scosse a M. Cassino e qualcu-<br />
na a S. Germano";<br />
12 Dicembre 1872: M. Cas~ino'~.<br />
32 CAPOCCI. p. 364.<br />
ID., p. 365.<br />
34 ID., p. 367.<br />
" ID., p. 374.<br />
36 CAPOCCI, 1. c.; DEL GIUDICE, p. 134.<br />
'' DEL GIUDICE, pp. 166, 172.<br />
'"BARATTA, p. 440.<br />
39 ID., p. 456.
Tra le più vive memorie della mia fanciullezza, il terremoto del<br />
12 Luglio 1873 ha lasciato traccia indelebile. Ho ancora davanti<br />
agli occhi le tende biancheggianti negli orti e nei prati, i fuochi, le<br />
mense, i letti che si improwisavano all'aperto, l'altare, su cui tro-<br />
neggiava la statua di S. Emidio, eretto nel largo dei Cappuccini,<br />
ove si adunava implorante la popolazione impaurita; ricordo l'an-<br />
sietà con cui si aspettavano quotidianamente le notizie e le previ-<br />
sioni, che Luigi Palmieri annunziava per telegrafo dall7Osservato-<br />
rio vesuviano, e che appositi messi recavan subito a S. Donato e a<br />
Settefrati. Fra queste trepidazioni si visse per più di dieci giorni;<br />
poi, rinfrancati a poco a poco gli animi, si cominciò a rientrar nel-<br />
le case e a riprender le abitudini consuete. Eppure, non ebbe quel<br />
terremoto l'ampiezza di altri precedenti, ben più catastrofici; non<br />
fece vittime, non abbatté che pochi edifici, ma, per la lunga dura-<br />
ta della commozione tellurica, per il numero delle scosse, che, in<br />
men di sei mesi, sommarono a 116, e per la violenza di alcune su-<br />
scitò in quanti lo udirono tale spavento che gli abitanti, come si<br />
legge in una relazione di quei giorni, temevano di «non riveder più<br />
del Baratta, dal risveglio dei due<br />
ona, Villetta Barrea, Pescas-<br />
o); del Molise (Isernia e<br />
no a Napoli, e fu sentito an-<br />
in Alvito e nei Comuni limitrofi nel 1873,<br />
municipale di Alvito, n. XV.<br />
37
La prima scossa lievissima fu awertita da pochi, alle 5 del mattino;<br />
un'altra sussultoria e ondulatoria insieme, seguì violentissima<br />
alle 7, e durò circa dieci secondi. Mia madre, che in quel momento<br />
si trovava nel giardino, rammenta di aver visto in un attimo<br />
la terra aprirsi e richiudersi. Altre ne succedettero, più o meno leggiere,<br />
il giorno stesso e nei susseguenti; poi, con maggior impeto,<br />
il 18, alle ore 8 a.m.; il 20, due volte durante la notte e una volta su<br />
la sera; il 23, a breve distanza, tra 121,25 e 121,30 a.m.; il 26, dopo<br />
una pioggia dirottissima, alle 11, 15' p.m., più violenta a Sora, ad<br />
Isola del Liri e ad Arpino; quindi andarono a mano a mano affievolendosi:<br />
l'ultima fu sentita il 6 gennaio del 1874. Fu osservato<br />
che, nella campagna alvitana, «erano di molto precedute da vaghe<br />
cupe ed interrotte detonazioni: si accedeva ad udirle, specialmente<br />
di notte, ad una valle verso ponente; e, quando non si avvertiva alcuna<br />
detonazione, era segno che il resto della notte ed anche il di<br />
seguente sarebbero corsi tranquilli: il che si verificò costantementew4.<br />
Altro indizio, del resto comunissimo in simili casi, era l'irrequietezza<br />
di alcuni animali, specialmente di cani, di gatti, di polli;<br />
più notevole, l'agitazione ond'eran presi i sordomuti, che qualche<br />
momento prima urlavano e istintivamente portavan la mano alle<br />
orecchie5. Al qual proposito mi torna in mente che nel 1887, tro-<br />
L.4<br />
vandomi in Siena presente alla visita che i Sovrani fecero all'Isti- -<br />
tuto dei Sordomuti, mi colpì il fatto che questi, pochi minuti innanzi<br />
che essi giungessero, quando nessun avviso era stato dato *;:. -<br />
dell'arrivo imminente, stando schierati nell'atrio, a un tratto, senza<br />
aver ricevuto alcun ordine, con rapido movimento simultaneo . .<br />
si allinearono e si composero: avevan sentito dalle vibrazioni<br />
i<br />
L+ 4<br />
' Descrizione etc. Anche nei luoghi ove maggiormente infieri il terremoto del p?:.<br />
1857, furon notati, tra i segni precursori, ((cupi muggiti, creduti da taluno aver lor 5.:<br />
sede nelle regioni atmosferiche, da altri nelle viscere della terra)). DEL GIUDICE, OP.<br />
cit. p. 147. T >.<br />
Si legge inoltre nella citata Descrizione che, «nei giorni in cui le scosse furono<br />
più frequenti, da molti erasi acquistata la facoltà di presentirle, avvertendo, oltre<br />
ad un istantaneo mutamento d'ambiente, un certo fluido elettrico comunicarsi pei<br />
piedi e invadere il basso ventre)), e che taluno «perdeva per qualche istante<br />
l'udito)); seguita la scossa, succedeva poi «una straordinaria lassezza, specialmente<br />
nelle giunture, nell'istessa guisa che avviene a colui che abbia ricevuta una scossa<br />
elettrica)). Forse tali fenomeni erano effetto di suggestione o di sovraeccitazione,<br />
cagionata dalla inquietudine prolungata e dal pànico improvviso. Non altrimenti<br />
in qualche paese della Basilicata, nel terremoto del 1857, alcuni, ((presi da strane<br />
commozioni al sistema nervoso, si credettero assaliti da masnadieri nelle proprie<br />
case. e compirono atti di difesa, che potevano a gravi conseguenze condurre)). DEL<br />
GIUDICE, p. 150.<br />
3 8<br />
L '
.la viazza della Prefettura.<br />
~mportanti fenomeni naturali tennero dietro ai primi sussulti. I1<br />
fa, al momento della scossa maggiore, arrestò per circa venti<br />
uti il suo corso, che indi riprese, ma con acqua torbida6; anche<br />
le acque del Fibreno s'intorbidarono, e qua e là, sollevatosi l'alveo,<br />
strariparono, inondando i terreni adiacenti; altre sorgenti<br />
Imparvero e scomparvero; un pozzo, d'improvviso, si disseccò,<br />
i riempì di lì a poco7. Così, per citar qualche riscontro, a Lisboa,<br />
nel 1755, «il mare dapprima si ritirò; poi si elevò, alla riva, di<br />
-inquanta piedi»: così in Basilicata, nel 1857, «in buon numero di<br />
paesi, scemò l'acqua in alcuni pozzi, in altri mancò quasi interalente»,<br />
e «sorgenti di limpide acque furon guaste d'innanzi, e fu-<br />
10 attinte torbide e di sgrato sapore»8. Inoltre, nelle notti del 19<br />
, ,e1 20 Luglio, si videro «lunghe strisce di luce fosforescente balenare<br />
e serpeggiare sulle creste delle montagne di Casalattico e di S.<br />
Donato, e, nella notte del 20, un aerolito solcare il cielo, sostare<br />
un istante a breve distanza dalla terra e poi sparire nella direzione<br />
m di S. donato^^. Medesimamente, a Viggiano, nel '57, «nell'oscurità<br />
della notte, alcuni furon testimoni d'insolita ed infausta luce,<br />
. che dissero fin nell'interno delle case esser tale da far discernere gli<br />
oggetti collocati intorno. Altre meteore ignee furono in qiia e in là<br />
-1edute sotto forme varie e non ben dissimili, come larghe strisce,<br />
:lobi, colonne; né mancarono di quelli che dicono di aver con i<br />
opri occhi veduto globi di fuoco cadere sopra gli edifizi, altri<br />
[l'aria aperta avere osservato al sud il cielo da vivissima luce illuiiiinato»lo.<br />
Fu gran ventura che le popolazioni, come si è detto, ne uscissero<br />
iteramente incolumi. Molto invece soffrirono i fabbricati: larghe<br />
lesioni si produssero ad Atina, specialmente nella Cattedrale, nella<br />
Chiesa di S. Marco e nella Caserma dei Carabinieri; e ad Alvito,<br />
per giunta qualche rovina; a S. Donato, quaranta case rimasero<br />
guaste ed una ebbe il tetto sprofondato; a Picinisco, due furono<br />
atterrate e cinquantadue lesionatelobi" una ne cadde a Casalattico,<br />
h BARATTA, p. 462.<br />
' Descrizione etc., e BARATTA, 1. C.<br />
~ E GIUDICE,<br />
L p. 142.<br />
Descrizione etc.<br />
lo DEL GIUDICE, p. 148.<br />
lobis A Picinisco, dopo il terremoto del 1873, furon fatti togliere i merli del Castello<br />
medievale, che ne restb deturpato. Com. Boni.<br />
-3-
due a Sora; gravemente ne risentirono Settefrati, Belmonte, Isola<br />
del Liri ed Arpino, ove si dové sgombrare il Convitto Tulliano".<br />
Le altre scuole, come il Collegio di Alvito, e tutte le chiese furono,<br />
per prudenza, temporaneamente chiuse. Le conseguenze economi-<br />
che, sia per lunga interruzione di affari, sia per ristoro dei danni,<br />
pesarono in diversa misura su tutti. Agli indigenti soccorse con ge-<br />
nerosità la pubblica e la privata beneficienza.<br />
Non si chiude con questo la storia dei nostri <strong>terremoti</strong> nel secolo<br />
XIX. Ma dei successivi due soltanto hanno per noi maggiore importanza,<br />
perché prodotti dal ridestarsi dello stesso focolaio del<br />
1873, e su questi c'indugeremo alquanto. Dei rimanenti, tre furono<br />
lievi contraccolpi di perturbazioni più lontane: Isernia (6 Giugno<br />
1882), Anticoli ed Avezzano (10 Aprile 1885) e Caste1 di Sangro<br />
(26 Agosto 1889)"; due, molto più sensibili, provennero dai<br />
Colli laziali: l'uno, il 24 Agosto 1877, che da Veroli, ove fu rovinoso,<br />
si spinse fino alla media valle del Liri, urtando con impeto<br />
Isola, Arce e Cassino"; l'altro, il 20 gennaio 1892, che da Genzano,<br />
da Civita Iavinia e da Velletri, abbracciò buona parte<br />
dell'Abruzzo meridionale e della Terra di Lavoro, seguendo la linea<br />
su cui si trovano Isola, Sora, Atina e Ca~sino'~. Ma la plaga<br />
sorano-cominese fu più specialmente scossa nel 1874 e nel 1891.<br />
Minor durata, ma non minor vigore di quello del '73, ebbe il<br />
terremoto del 6 Dicembre 1874, forse epilogo del precedente, ricordato<br />
ancora col nome di terremoto di S. Nicola. Avvenne pochi<br />
minuti prima dell'Avemaria, e fu, secondo la graduazione del<br />
Baratta, rovinoso, ad Alvito, a Posta Fibreno, a S. Donato e a<br />
(iaIlimrro;foortissim, aSoEi, 4 IsolTdelLiri, ad fipino ,ad x-ce,<br />
a Monte Cassino e a S. Elia; molto forte a Ceprano, forte a<br />
Veroli e a Frosinone, mediocre o debole altrove. Ritoccò il giorno<br />
seguente, con parecchie repliche, di cui alcune, a Sora e ad Alvito,<br />
violente: si spense il dì 8 con leggiere ondulazioni1*.<br />
I1 9 Maggio 1891, ad un'ora e 15 minuti a.m., una nuova succussione,<br />
che fu anche ondulatoria, fece tremar Sora ed Isola del<br />
Liri: caddero pietre e pezzi di intonaco, si fermarono gli orologi;<br />
ivi: Descrizione etc.<br />
BARATTA, pp. 491, 521, 526.<br />
" ID., p. 473.<br />
'' ID., pp. 534, 540.<br />
'' ID., p. 465.<br />
" BARATTA,
?l<br />
/lti abbandonarono le case in preda allo spavento. Si diffuse per<br />
in vasto circuito - il cui asse maggiore, da Picinisco ai Colli la-<br />
$ali, misura circa cento chilometri -, ma con sì capricciose voluesche<br />
Vicalvi, Cassino e Roccasecca furono offesi con eguale inensità<br />
di Sulmona, la quale dista ben pih di gran lunga da Isola<br />
iel Liri e da Sora; mentre Atina, vicinissima a Vicalvi, la provò in<br />
Irado inferiore, al pari di Ceccano e di Velletri16.<br />
ID., pp. 533-34. LO stesso anno, il I Ottobre, anche Monte Cassino fu visitato<br />
i dal terremoto, e sofferse delle lesioni: ma, come in moltissimi altri casi, non ne<br />
giunse eco nei paesi vicini. BARATTA, p. 537.
3 1 LUGLIO 1901<br />
La storia sismica del secolo XX s'apre nella nostra regione col<br />
terremoto del 31 Luglio 1901, che percorse - giusta l'avviso<br />
dell'osservatorio geodinamico di Rocca di Papa, - l'area mede-<br />
sima di quello del 1873: la causa, a giudizio dello stesso Ufficio,<br />
da ascriversi «con ogni probabilità o ad assestamento di strati per<br />
mancanza di appoggio, in conseguenza dell'erosione sotterranea<br />
delle acque, o a dislocamento di strati per effetto di bradisismiv'.<br />
La fase ebbe principio il mattino con due scosse leggerissime:<br />
l'una alle 9,12', che nessuno intese, l'altra, alle 11, 15', che fu av-<br />
vertita a Settefrati; culminò con una fortissima, della durata di ot-<br />
to secondi, sussultoria e ondulatoria da N.0 a S.E., alle 11,38', la<br />
cui ripercussione giunse fino a Chieti; decrebbe con altre, molto<br />
lievi, alle 13'26' dello stesso giorno e nei seguenti2: le ultime vibra-<br />
zioni furono segnalate il 14 Agosto3.<br />
Era di Mercoledì: giornata splendida, caldissima; ma dopo<br />
mezzodì l'aria si fece afosa, e si osservò il solito intorbidamento<br />
sia del Fibreno, sia della Melfa, e, in questo fiume, non soltanto<br />
lungo il defluvio, ma nelle sorgenti stesse, poiché anche l'acqua<br />
potabile, che dalle alture di Canneto scende per apposita condut-<br />
tura a Settefrati, perdette la sua cristallina limpidezza.<br />
La violenza della scossa principale e il ricordo - vivissimo nei<br />
più - del terremoto del '73 cacciò e tenne tutti impauriti all'aper-<br />
to fino ad ora tarda, quando la popolazione di Alvito volle che il<br />
simulacro di S. Emidio fosse portato processionalmente per le vie,<br />
e lo seguì in lungo stuolo con commossa trepidazione. Taluno for-<br />
se sorriderà di benigno compatimento nel leggere, ad ogni ripeter-<br />
si di tali calamità, le solite esplosioni di sentimento religioso (che è<br />
debito di storico coscienzioso non passar sotto silenzio), ed escla-<br />
merà: ancora di queste superstizioni all'alba del XX secolo! Facile<br />
I Da una lettera del Direttore dell'Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa,<br />
conservata nell'Archivio municipale di Alvito: XV/8.<br />
lo Agosto, ore 17; 18,49' (minima); 2 Agosto, ore 15,32' (minima). Dalla let-<br />
tera citata.<br />
14 Agosto, ore 13,30 (leggerissima), 14 (sensibile). Da registrazioni della Se-<br />
greteria municipale. Ivi.
il sorridere, non altrettanto facile apprestare miglior conforto o rimedio<br />
contro un si implacabile, occulto, improvviso nemico, di I<br />
cui, almeno fino ad oggi, l'opera deli'uomo tarda, incerta, inefficace<br />
non ha saputo che, a mala pena e inadeguatamente, riparare<br />
ai terribili effetti. Questa è, del resto la psicologia del popolo. Rispettiamo<br />
chi, oppresso da un'invisibile Potenza distruttrice non<br />
trova altro lenimento che nel sollevar la sua fede a un'invisibile<br />
Potenza che sorregge e ricrea.<br />
Ed ora facciam la cronaca dei danni, ché le vite umane, ad eccezione<br />
di pochi feriti, ne uscirono fortunatamente salve. I maggiori<br />
toccarono ad Aivito e a Settefrati: altrove, o si allargarono i crepacci<br />
del '73 - come a Picinisco -, o si manifestarono poche e<br />
piccole lesioni - come a Gallinaro - ove non arrivò neppur l'eco<br />
delle repliche. Molte e gravi furono invece ad Aivito; tutte le case<br />
urbane ne rimasero segnate e, precipuamente, quelle poste a Levante;<br />
tra le altre, i palazzi Castrucci, Lecce, Sipari e Maizenga, il<br />
quale ultimo fu in diversi punti smantellato; più ancora, le coloniche,<br />
di cui parecchie andarono in sfacelo. La Chiesa di S. Simeone<br />
dovette esser chiusa al culto pei molteplici e profondi spacchi nella<br />
cupola, nel cornicione, nel coro e nella sacrestia; la Chiesa di S.<br />
Nicola e l'attiguo convento, ora Collegio municipale - massiccia<br />
e <strong>grandi</strong>osa mole eretta nel Cinquecento e restaurata due secoli<br />
dopo - riportò in ogni lato guasti serissimi.<br />
A Settefrati poi, massi precipitati dalla sommità della superba<br />
torre quadrangolare, avanzo del medio evo; prostrato un muro di<br />
cinta del vecchio fortilizio; riverso, in parte, il tetto della Chiesa<br />
- da lungo tempo non ufficiata - dei Santi Sette Fratelli, all'inresso<br />
del paese; l'antico campanile della Chiesa madre talmente<br />
osso e scardinato che, a scanso di peggiori casi, si dové diroccar-<br />
: la chiesa stessa, le case tutte, financo il cimitero, in varia misu-<br />
, scalcinati, screpolati, aperti.<br />
'I"<br />
,2*+.q++<br />
.*.L .. .L
13 GENNAIO 1915<br />
Su la fine del 1914, a cominciar dal 25 Ottobre, Isernia fu<br />
ta a varie riprese da molte scosse, una delle quali, più<br />
.<br />
delle altre, nelia notte dal 18 al 19 Dicembre, costrinse i cittadini a<br />
cercar ricovero nei paesi vicini. Invitato a rassicurare i profughi<br />
coi responsi della scienza, l'illustre P. Paoloni, direttore della Specola<br />
cassinese, scriveva il 1' Gennaio 1915: «O la forte scossa del<br />
19 Dicembre fu la principale, e in tal caso non v'* più da temere<br />
[...l oppure le scosse passate furono premonitorie, e seguirà presto<br />
qualche dkastroso terremoto, e in tal caso non sard solo Iser- ''q<br />
nia ad essere distrutta [. . .] Questo secondo caso non awerr8: ma,<br />
'1<br />
se avvenisse, non sarebbe meglio morire nel proprio paese e nelia 7<br />
propria casa? Ho detto che questo secondo caso non avverri, ma<br />
io temo che non siamo lontani da qualche disastroso terremoto<br />
dell'ltalia meridionale e centrale, come quelli del 1349, 1456,<br />
1682, 1694, 1805~'. Più che fondata sulla storia sismica - confes- :-<br />
sa poi egli stesso - una tal previsione non era «fortuita», tranne<br />
che non voglia ammettersi «fosse dettata da qualche misterioso fe- ;f<br />
nomeno psicologico~~2; ma, purtroppo, l'evento corrispose dopo<br />
soli dodici giorni, forse più rapido e più tragico che non fosse stato<br />
immaginato.<br />
Non attiene al mio proposito abbracciare in tutta la sua terrificante<br />
visione l'orrendo cataclisma marsicano: epperò, lasciando<br />
che di Sora, la quale dopo Avezzano fu la più duramente colpita,<br />
tratti particolarmente un mio amico, che assistette col cuore stra- ---<br />
*te ~mvinacte1+asuapa@ia, mi restringerò a discorrere quello<br />
che toccò alla Valle cominese.<br />
La mattina del 13 gennaio, nell'ora stessa in cui Avezzano, sov-<br />
vertita daiie fondamenta, era ridotta un cimitero, e Sora quasi tut-<br />
ta crollava, anche la nostra Valle era squassata dalla cieca Furia<br />
devastatrice. Nei giorni precedenti aveva ininterrottamente im-<br />
I Cron. sism. cass., Bollett. Dic. 1914, pp. 15-16.<br />
Ivi, p. 17.
perversato una pioggia torrenziale, accompagnata da vento impe-<br />
tuosissimo; poi, tre ore dopo la mezzanotte del 12, la pioggia ces-<br />
sò, ma il vento continuò rigido e gagliardo, con sibili che somiglia-<br />
vano a boati. Sul far del giorno, il tempo accennò a mettersi al<br />
bello, se non che, dalla parte di Sora, l'orizzonte, come fu notato<br />
da alcuni, appariva livido, plumbeo, con riflessi d'acciaio. Ed ec-<br />
co, alle ore 7,15, passare una romba cupa e veloce - effetto, for-<br />
se, della violenta perturbazione aerea prodotta dal non lontano ri-<br />
volgimento tellurico -, indi tre scosse fortissime, con direzione<br />
da N.O. a S.E. l'una dietro l'altra, che si protrassero per ventiset-<br />
te secondi, fecero sobbalzare e fuggir dalle case sinistramente<br />
scricchiolanti la gente spaventata, che invocava a gran voce S.<br />
Emidio.<br />
Erano tutti sgomenti gli Alvitani, ma ben lungi dal sospettare<br />
qual più lagrimevole sorte si fosse abbattuta a breve distanza da<br />
essi; quando, di lì a due ore, giunse da Sora una cospicua famiglia<br />
che, miracolosamente salva, chi sanguinante dalle ferite, chi pian-<br />
gente, tutti pallidi dalla commozione e dalla paura, veniva a chie-<br />
dere ospitalità ai parenti. Poco dopo, tornava un nucleo di co-<br />
scritti che, partiti all'alba, sul primo entrare nella città, erano stati<br />
respinti dall'immenso fragore e dal fitto polveri0 che s'innalzava<br />
dalle macerie, e non avevan potuto proseguire il viaggio, essendo<br />
ruinata la stazione ferroviaria e divelti i binarii. Dagli uni e dagli<br />
altri fu appresa la sciagura di Sora (di Avezzano nulla ancor si sa-<br />
peva, e solo il dì seguente cominciarono a divulgarsi incerte e con-<br />
fuse notizie della più orrenda calamità), e subito si formò una<br />
squadra di volenterosi, che senza indugio si recò ad apprestare il<br />
proprio braccio, a portare i più urgenti soccorsi di pane, di vesti,<br />
di coperte, di medicinali, poiché la cruda stagione contribuiva ad<br />
accrescer la disgrazia e a moltiplicare e ad acuire i disagi. Via via<br />
che si diffondevano i particolari raccapriccianti ed al novero delle<br />
case squarciate, cadute o cadenti si unì quello più doloroso degli<br />
estinti, dei quali alcuni noti di nome o per consuetudine di relazio-<br />
ni, altri cari per vincoli di sangue o d'amicizia, compresero gli Al-<br />
vitani da quale sterminio fossero stati risparmiati: scarso confor-<br />
to, amareggiato dal pensiero della sventura altrui, turbato dall'in-<br />
cubo di repliche imminenti.<br />
Così passò quel primo giorno sotto un cielo semivelato dalle nu-<br />
vole, tra cui, di quando in quando, rompeva uno scialbo raggio di<br />
sole. Scendeva squallida la sera quando, circa le ore 17 una nuova<br />
scossa, più breve, ma non meno potente di quella antimeridiana,
aumentò le trepidazioni e i timori. Non ostante la rigidezza della<br />
temperatura, molti vegliarono quella notte, ed altre ancora, ripa-<br />
rati alla peggio sotto il portico del secentesco palazzo ducale (adi-<br />
bito ad uffici pubblici); molti si acconciarono nei piani terreni, per<br />
poter, a un bisogno, mettersi prontamente in salvo. Da allora, le<br />
repliche, quasi sempre unite a colpi secchi e profondi, non si con-<br />
tarono più; e, quantunque, a lungo andare, la popolazione fosse<br />
preparata a sentirle, pochi eran coloro che si fossero anche abitua-<br />
ti a non paventarle: donde interruzione nel lavoro, perturbamento<br />
nel sonno, eccitazione costante; a dir breve, uno stato di preoccu-<br />
pazione angosciosa, che durò più mesi e fu vinta solamente da<br />
quelle che sopravvennero nel maggio, allo,scoppiar della guerra<br />
contro l'Austria.<br />
Di danni e di rovine ebbe anche Alvito la sua parte, quantun-<br />
que, generalmente parlando, la solidità dei fabbricati - non<br />
escluse le più recenti opere di arte muraria lungo la nuova strada<br />
carrozzabile che sale al Castello - opponesse agli urti reiterati va-<br />
lida resistenza. Poco o punto soffrirono le più vetuste costruzioni,<br />
come le mura e i torrioni del Castello medioevale, il campanile<br />
della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, il palazzo cinquecentesco<br />
del Cardinale Elvino (oggi dei Razzitti), il palazzo ducale, or ri-<br />
cordato. Altre, più moderne o modernamente riattate, qual più,<br />
qual meno cedettero: tra queste, le Chiese di S. Simeone, di S. Ni-<br />
cola (con l'annesso Collegio salesiano), di S. Maria delle Grazie,<br />
di S. Maria del Campo - questa, particolarmente cara agli Alvi-<br />
tani, sia per secolare tradizione di culto, sia per la memoria dei lo-<br />
ro morti che hanno accanto ad essa l'estrema dimora. Degli edifizi<br />
privati, la loggia Masetti dalle finestre ad arco, che coronava la<br />
porta orientale del paese, detta Iacobelli, si dovè superiormente<br />
demolire e lasciare scoperta; nella palazzina Ferrante, a Collebuo-<br />
no fu abbattuta la torretta o belvedere; nel palazzo Mazzenga pre-<br />
cipitò la volta dello scalone e restò sconnesso il piano superiore,<br />
con larghe fenditure negli spigoli e nelle pareti. Del resto nessuna<br />
casa fu assolutamente incolume, e qualcuna fu necessario atter-<br />
rarne: le rurali, poi, o perché isolate, o perché di struttura meno<br />
compatta, subirono peggior detrimento: in alcune si curvarono o<br />
si spezzaron le travi, in altre sprofondarono i tetti, non poche fu-<br />
ron rese inabitabili. Come nel terremoto del 1901, la plaga di Le-<br />
vante fu la più sconvolta: ne è prova altresì un avvallamento for-
matosi nella via che daila porta Iacobelli va alla chiesa di S. Nico-<br />
la, e un sollevamento di terreno nel campo sottoposto, ove si vide<br />
perfino qualche albero piegato o detorto dalla sua natural direzio-<br />
ne.<br />
.,r5 +r .h r++i;dr,*-*l+<br />
- . -. d - - - L::.-J. -.-d<br />
Non molto diversi i fenomeni e le conseguenze negli altri paesi<br />
valle. Ad Atina fu sentita da taluni, tra le sei e le sette, una<br />
a tenuissima, che ai più sfuggì, perché confusa col mugghio<br />
del vento: parecchi ne ebbero, insieme con una depressione nervosa,<br />
un vago presentimento che si preparasse qualcosa di anormale.<br />
La piazza S. Giovanni, ove scorrazzavano inquieti i cani, le case<br />
circostanti, la facciata della Chiesa avevano assunto un aspetto<br />
strano, che faceva pensare a uno sconvolgimento meteorico. Non<br />
1 3 tardò la scossa formidabile: la terra parve percorsa da brividi e da<br />
ondulazioni che inceppavan la fuga; le acque della Melfa divennero<br />
lutulente: i fili della luce elettrica emetteva sibili e scintille<br />
giallo-rossigne, che aumentavano la tragica impressione del momento;<br />
tutti si affrettavano, tra il grido delle donne e il pianto dei<br />
bambini, a mettersi al sicuro, implorando la protezione del patrono<br />
S. Marco e degli altri Santi. Giunsero intanto le prime voci del<br />
disastro di Sora, e immediatamente si riunì un gruppo di volenterosi,<br />
che forniti dei mezzi opportuni, mossero a quella volta per<br />
contribuire all'aiuto fraterno.<br />
Nessuna vittima, se si eccettui unicamente una vecchietta, ferita<br />
a un piede. Considerevoli furono invece i danni edilizii. Dalla<br />
sommith del Campanile della Cattedrale cadde tutto l'ornamento<br />
in fabbrica e una delle nicchie dell'orologio: moltissimi tetti, interamente<br />
o parzialmente, crollarono; gravissime lesioni si aprirono<br />
nella chiesa di S. Rocco, - in cui si staccò inoltre una parte della<br />
«rotonda» che sovrastava l'alta maggiore - nella chiesetta di S.<br />
Maria delle Grazie, nel Palazzo municipale, nella Caserma dei Carabinieri,<br />
nella settecentesca palazzina, che fu gih dei Pagano, e in<br />
quasi tutte le altre case, segnatamente nelle più modeste e in quelle<br />
formate di più corpi addossati o raffazzonati in epoche diverse.<br />
Alcuni uffici pubblici e abitazioni private dovettero esser trasferiti<br />
in baracche di legno e, più tardi, nelle casette asismiche. Lievissime,<br />
o nulle - del pari che ad Alvito - furono per contro le offese<br />
che risentirono antichi palazzi signorili e, meno degli altri, il palazzo<br />
feudale che vi eressero nel Trecento i Cantelmo - quegli<br />
stessi che rifondarono dopo il terremoto del 1349 il Castello alvi-
tano: ivi infatti si notò soltanto uno ((slittamento)) di alcune parti<br />
del manto di tegole: esempio ed ammonimento a cui spetta.<br />
A Gallinaro, forse per la natura tufacea della collina su cui sor-<br />
ge, l'intensità delle scosse fu sentita in molto minor grado che nei<br />
paesi circonvicini; tuttavia la prima, delle 7,52', vi rintronò frago-<br />
rosamente: le case sembravan traballare, i pavimenti e le pareti ri-<br />
bollire, rumoreggiar le volte come se mano ignota vi rovesciasse di<br />
sopra a migliaia pietre e macigni. I1 Parroco vide la chiesa tenten-<br />
nare da ponente a levante, come un'enorme culla con tendenza a<br />
piegarsi sul fianco occidentale. Nella contrada Via Piana, ad<br />
oriente, il livello della strada carrozzabile che mena a S. Donato,<br />
si abbassò formando una pozza, quasi una piccola voragine, del<br />
circuito di oltre cinque metri e di cinquanta centimetri di profon-<br />
dità, coperta da uno strato umido di fango grigiastro e viscido (un<br />
vulcanetto di fango?): camminandovi presso, il terreno tremava<br />
sotto i piedi. Per adeguare e solidificare la buca, bisognò scavarne<br />
lì accanto un'altra di ugual larghezza e assai più profonda, e riem-<br />
pir questa della sostanza limacciosa, quella di brecciame e di<br />
ghiaia.<br />
Non morti, non feriti, non contusi; danni materiali, in propor-<br />
zione, di minor conto che altrove; maggiori nell'agro che nell'abi-<br />
tato, ove non si lamentarono che le consuete lesioni e screpolatu-<br />
re. Una vecchia bicocca fu rasa al suolo; il tetto di una casa rurale,<br />
nella stessa contrada Via Piana, test6 menzionata, divelto con la<br />
trave maestra, si rovesciò su un'altra attigua, più bassa, e fu un<br />
vero miracolo che gli abitanti di entrambe facessero in tempo a<br />
salvarsi nei campi; un altro tetto, nella contrada Colle Molino, fu<br />
totalmente smantellato.<br />
. -<br />
Assai peggio incolse a Picinisco e alle sue venti borgate, massi- .<br />
me a quelle di S. Gennaro e di S. Giuseppe, tuttoché non vi seguis-<br />
se alcuna disgrazia di persone. Al primo attimo della scossa, gli<br />
orologi a pendolo si fermarono, si spense la luce elettrica (senza<br />
però alcun guasto alle lampade e agli apparecchi), e nelle chiese<br />
l'acqua benedetta si riversò dalle pile, bagnando il pavimento per<br />
un raggio di due metri. Grossi massi, dalle rupi e dalle balze del<br />
monte, rotolarono nella Melfa, intorbidandola. Caddero le cam-<br />
pane dell'orologio pubblico, che sormontavano l'alto e forte cam-<br />
panile della Chiesa madre, tutto di pietra lavorata, il quale, peral-<br />
tro, restò intatto; caddero in vari punti cornici e comignoli; spro-
fondò qualche tetto e qualche muro; poco mancò non crollasse il<br />
campanile dell'antichissima chiesa di S. Maria, nel cu'i atrio si<br />
conserva una lapide marmorea dei tempi romani. Delle case, nes-<br />
suna fu illesa: cento all'incirca, tra cui molte ricostruite dopo il<br />
terremoto del 1873, furono ridotte in tale condizione da renderne<br />
urgente la demolizione; lo stesso palazzo municipale, appartenuto<br />
al celebre astronomo Capocci, dové subito essere rafforzato con<br />
catene. Saldo resistette il castello medievale, anch'esso - gioverà<br />
ricordarlo - opera dei Cantelmo, deturpato nel '73, perché ne fu-<br />
rono tolti i merli lapidei che adornavano in giro la torre principa-<br />
le.<br />
Più bersagliati furono, come s'è detto, i villaggi di S. Gennaro e<br />
di S. Giuseppe: in questo, al terremoto si aggiunse una <strong>grandi</strong>ssi-<br />
ma frana; in quello, gli abitanti si ritrovarono, in gran numero, al-<br />
lo scoperto (una donna venne estratta viva di tra le macerie di un<br />
tugurio), e non potettero neppur rifugiarsi nella chiesa, che era<br />
stata alla meglio sorretta da puntelli. A ben aspra prova durarono<br />
quei miseri, per molti e molti giorni, sotto il vento e la neve, senza<br />
una tenda, senza una baracca! La sera del 23 Gennaio, una nuova<br />
scossa produsse colà nuove rovine, ed esasperò gli abitanti, che il<br />
giorno seguente, traversato l'impetuoso torrente Rava, si recaro-<br />
no al Municipio a reclamar soccorso'. E lo stesso giorno, ancora<br />
un'altra scossa e ancora un'altra nevicata: la popolazione coster-<br />
natissima usciva all'impazzata, costretta a rientrar subito nelle ca-<br />
se pericolanti, per non morir assiderata su le vie!<br />
Settefrati, oltre ai comuni danneggiamenti nel caseggiato e a<br />
quattro feriti, ebbe a deplorare il crollo delle volte in tre scuole (e<br />
fu ventura che a quell'ora non fossero incominciate le lezioni, ché<br />
altrimenti sarebbe avvenuto un eccidio di bambini) e di una parte<br />
del muro settentrionale della torre già malconcia dai fulmini e dal-<br />
le infiltrazioni di acqua e provata dal terremoto del 1901. Parve<br />
pertanto che essa costituisse una minaccia immanente ed immi-<br />
nente per la chiesa parrochiale, che sorge a breve distanza, e per le<br />
abitazioni che la circondano, e ne fu chiesto dai vicini con insi-<br />
I primi soccorsi furon recati il 23 Gennaio (undici giorni dopo il terremoto) da<br />
una commissione di cui era capo il Presidente della Deputazione provinciale<br />
comrn. Pasquale Maturi (Dal n. 27 della Tribuna, corrispondenza da Picinisco, del<br />
24 Gennaio). In seguito il Governo provvide alla costruzione di baracche e di case<br />
asismiche, ma in quantità impari al bisogno.
stenza l'abbattimento. Innegabile il pericolo, e per l'altezza del<br />
colosso, e per le ingiurie patite dal tempo e dagli elementi, e per il<br />
luogo giudicato il più sismico. del paese; tuttavia, con opportuni<br />
restauri, che non avrebbero domandato ingente spesa, si sarebbe<br />
potuto conservare uno dei pochi monumenti superstiti nella no- -;<br />
stra regione. E tale era i1 parere della Direzione delle Antichità e<br />
delle Belle Arti, ma un parere, non suffragato dai mezzi per attuarlo,<br />
non bastava: prevalse quindi 170pinione opposta de1l7- cio geodinamico, che ritenne pregiudizievole all'incolumità pub- - Y.<br />
blica l'esistenza della torre, la quale fu percid distrutta sul finire di .. 11-<br />
. . I<br />
luglio. I1 paese fu cosi rassicurato, ma perdette il suo più bell'or- .', ,?<br />
namento, che ne segnava la linea estetica di un'impronta solenne<br />
ed austera.<br />
Gravi danni furono constatati a Vicalvi: trentanove case squas-<br />
sate più di tutte le altre, e dieci di esse demolite per evitar più fune-<br />
ste conseguenze; la chiesa parrocchiale longitudinalmente lesiona-<br />
ta nella volta della navata centrale e della destra e rovinata nella<br />
cappella di S. Michele che chiude la navata sinistra. Solo il Castel-<br />
lo - altra memoria dei Cantelmo! - o, per meglio dire, le mura<br />
che ne avanzano, come ad Alvito, ad Atina, a Picinisco non rice-<br />
vette la minima offesa. Degno di particolar menzione uno spro-<br />
fondamento di circa due metri, prodottosi durante la scossa, nella<br />
contrada chiamata Sorbo, lungo la via che conduce al Castello<br />
d7Alvito. La popolazione non ebbe a rimpiangere alcuno dei suoi<br />
cari.<br />
Non cosi nel villaggio di Posta-Fibreno, che siede - già l'accen-<br />
nammo - a specchio del lago omonimo. Quivi un'intera famiglia<br />
di sette persone fu seppeliita sotto la propria casa, e tre soltanto,<br />
mercè il coraggio di due arditi giovani - Luigi Lucchese e Vitto-<br />
rio Farina - potettero esser tratte vive alla luce: le altre quattro<br />
perirono miseramente. Parecchi i feriti, che, curati prima dal far-<br />
macista Loreto Marrazza, sollecitamente accorso con altri da Ati-<br />
na, dalla Croce Rossa vennero poi trasportati e ricoverati in un<br />
ospedale di Caserta. Di un rione della borgata, che ha nome Navi-<br />
cone, pei caratteri spiccatamente sismici del suolo, fu ordinata la<br />
demolizione, e posteriormente, su ridente collina, all'ingresso del<br />
paese, nella zona denominata Terra Porta, ne fu costruito un al-<br />
tro, composto di otto gruppi di casette asismiche, capaci di dare<br />
alloggio a trentadue famiglie. Superfluo aggiungere che degli altri
i fabbricati - compresa la chiesa parrocchiale - nessuno usci im!<br />
, mune dalla tremenda scossa.<br />
tensa -, e se ne formarono delle nuove, di cui qualcuna notevole<br />
per il volume del getto: una zona di terreno lacustre, di forma cir-<br />
colare, si abbassò per un diametro di circa quindici metri, dando<br />
luogo ad un laghetto che si osserva tuttora.<br />
E Dail'aprile al giugno le scosse diventarono più rare o impercetti-<br />
bili. Nell'ultima decade del giugno, poi, l'estate si annunzib con<br />
e<br />
un tempo insolitamente e ostinatamente freddo e piovoso, tal che<br />
parea d'esser piuttosto alla fine dell'autunno. Acque dirottissime<br />
prostrarono le messi rigogliose, che promettevan copioso raccol-<br />
to, e folte nebbie nocquero allo sviluppo dei grappoli in fiore e dei<br />
frutti, preparido cosi nuove angustie e miserie. Cessate queste<br />
condiioni atmosferiche, la domenica 11 Luglio, alle 9,30, s'inizib<br />
una lunga ripresa di commovimenti tellurici, che riaccese viva-<br />
mente le sopite inquietudini. Alla prima scossa, ben forte, altre<br />
parecchie si avvicendarono nello stesso giorno e nei successivi, ed<br />
una, maggiore delle altre, il mercoledl 14, alle 9,19, che durò più<br />
di cinque secondi, fece rintoccar la campana dell'orologio pubbli-<br />
co, oscillare a lungo la croce della cupola di S. Simeone, sussultar<br />
le lampade elettriche sospese nella piazza, e a molti sembrò simile,<br />
pel rombo e per il movimento, a quella del 13 Gennaio. Più anco-<br />
ra spesseggiarono nel rimanente della settimana, quando tenui,<br />
quando robuste, quasi sempre precedute, come io stesso speri-<br />
mentai piu volte, da un persistente e molesto chiocciar di polli e la-<br />
trar di cani.<br />
Quale fosse lo stato d'animo di tutti, può desumersi da due stra-<br />
ni episodi: strani oggi a ripensarli, naturalissimi in quei momenti<br />
di palpiti tormentosi. Frequentissime scosse - non meno di dodi-<br />
ci - s'eran sentite ad Alvito e a S. Donato, durante la giornata del<br />
15 Luglio4; nella notte, che a nessuno fu apportatrice di calma,<br />
verso le 2 a.m., arrivb improvvisa un'automobile proveniente da<br />
Sora. Coloro che v'eran dentro, mandati - come si disse - dal<br />
Commissario regio (non sacon quanta opportunità a quell'ora!) a<br />
I1 P. Paolini mi scriveva, il giorno dopo, che i sismografi di M. Cassino ne ave-<br />
van registrate 14, e circa duemila dal 13 Gennaio al 16 Luglio!
prender nuova dell'accaduto, ne discesero innanzi alla Caserma<br />
dei carabinieri, e, chiamato il maresciallo, esposero lo scopo della<br />
loro venuta, quindi ripartiron veloci alla volta di S. Donato. Frat-<br />
tanto alcuni nottambuli, mossi da curiosità s'erano avvicinati e,<br />
fraintendendo qualche parola colta a volo, immaginarono che<br />
quelli fossero messaggeri di chi sa qual nuova catastrofe, e subito<br />
si sparsero per il paese a picchiar di porta in porta e a svegliar i<br />
dormenti, annunziando esser venuto dalla specola di Monte Cassi-<br />
no il preavviso che fra tre ore sarebbe avvenuto un <strong>grandi</strong>ssimo<br />
terremoto. In un attimo, la voce si propagò e, massime nel popoli-<br />
no, trovò facile credenza: moltissimi, presi insieme dalla meravi-<br />
glia, dal dubbio, dal pànico, come trascinati da un impulso irresi-<br />
stibile, si affrettarono ad uscire, e rimaser fuori fino all'alba,<br />
quando, non senza titubanza, si risolvettero a rientrare. Tre giorni<br />
dopo, nella notte dal 18 al 19, alcuni contadini alvitani, che anda-<br />
vano a mietere nel limitrofo Abruzzo, salendo la montagna di S.<br />
Donato, furono a un tratto sorpresi da un profondo boato, ac-<br />
compagnato - essi raccontarono - da sì fragoroso rotolar di<br />
massi, che non ebbero coraggio di procedere, e tornarono subito<br />
indietro, temendo di non ritrovar più in piedi le loro case.<br />
Durò questa fase dall'l l al 21 Luglio; ne cominciò una seconda<br />
il 3 Agosto, e durò fino al 17; ne seguì una terza, dal 13 al 20 Set-<br />
tembre. Così i tre mesi estivi trascorsero fra un'alternativa di tre-<br />
gua e di rinnovantesi attività sismicas. Dall'Ottobre al Dicembre le<br />
scosse continuarono sempre più lente e saltuarie6: più forte delle<br />
altre quella del 6 ottobre, che in Alvito causò la caduta di una casa<br />
PoichC questo periodo ebbe carattere peculiarmente locale, stimo utile segnar<br />
le principali scosse da me notate:<br />
I fase (11-21 Luglio): Domenica, l1 Luglio, ore 9,30'; 10; 14,15'; 22; 23,12';<br />
Lunedì, 12, ore 7; 23; Martedì, 13. ore 12,lO'; 15,14'; 17,35'; 23,50'; Merco-<br />
ledì, 14, ore 0,45'; 9,19'; Giovedì, 15, ore 2,15'; 4,25'; 4,27'; 4,29'; 6,13';<br />
14,30'; 15,7'; 15,19'; 15,43'; 17,309; 18,15'; 18,45'; Lunedì, 19, ore 2;<br />
Mercoledì, 21, ore 18,35'.<br />
I1 fase: (3-17 Agosto): Martedì, 3 Agosto, ore 14,25'; 17,20'; Mercoledì, 4, ore<br />
3,28'; 12,307; Venerdì, 6, ore1,32'; 15,30'; Venerdì, 13, ore 7; Sabato 14, ore<br />
15,45'; 20,30'; Lunedì, 16, ore 4,45'; Martedì, 17, ore 13,14'; 18,30'.<br />
I11 fase (13-20 Settembre): Lunedì, 13 Settembre, ore 7; Martedì, 14, ore<br />
15,45'; 20,30'; Mercoledì, 15, ore 6; 12; 18,5'; Lunedì, 20, ore 14,45; 14,52'.<br />
Ottobre -Mercoledì, 6. ore 18,25'; Mercoledi, 13, ore 22,307; Domenica, 24,<br />
ore 6.<br />
Novembre - Martedì, 30, ore 43'.<br />
Dicembre - Mercoledì, I, ore 2,25'; 2,30'; Venerdì, 24, ore (?).
nella borgata del Castello, e che fu sentita anche a Sora, ad Arpi-<br />
no e a Cassino: gli ultimi strascichi si protrassero fino all'Aprile<br />
del 1916.
APPENDICE FOTOGRAFICA
h. 97. TELEGRAF~ 5é~I.b STATO<br />
I1 SarC~bmmv# Ir.i.nr .>enrri ~lpnli.mblIi#A II.~~~.C.--Y<br />
, =i del .c-wo &un iaimin..<br />
ia um.r riicrur I- me~pn*-,,- oriarrpr~.mvir rcr<br />
irrcpe-nnl-l dei di.ilrmr.rld, ar.
Alvito. Via Gallia, fine sec. XIX (Archivio L. Santorb). Si noti,il campanil Ila chiesa di S.<br />
Simeone senza la preesistente cupola a forma di cono gravemente lesionata , ,,guito del terw -<br />
moto del 21 luglio 1806 e successivamente demolita (cfr. pp. 34-35). &.K'A
Alvito. Palazzo Dwde e Via Gallia, fine sec. XIX (Archivio L. Santoro)
(Biblioteca «Dr Vincenzo Castrucci~ Alvito)
I.% Li-1 -4. h<br />
- - 1.<br />
' L.<br />
"I<br />
.<br />
L-'- I-. I.