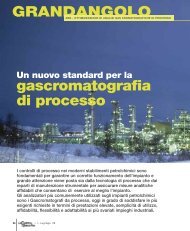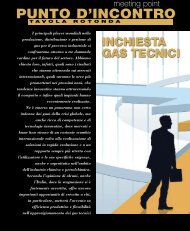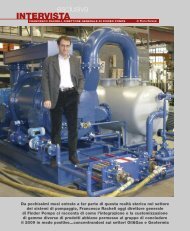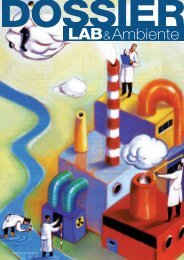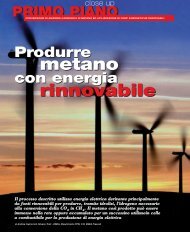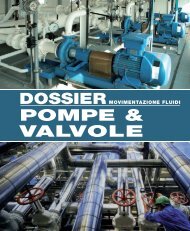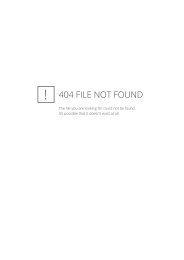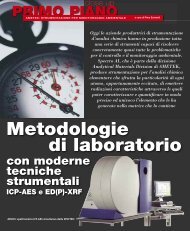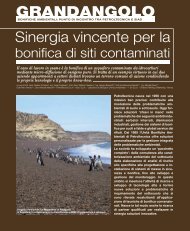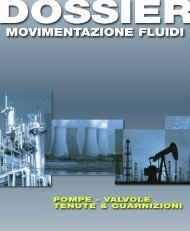LAB - Promedia
LAB - Promedia
LAB - Promedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>LAB</strong><br />
IL MONDO<br />
A.N.Te.L informa<br />
Daniela Ciuffi confermata all’unanimità<br />
come presidente dell’Associazione Nazionale<br />
dei Tecnici di Laboratorio Biomedico<br />
Il congresso nazionale, svoltosi a Roma il 18 e 19 settembre, ha profondamente<br />
rinnovato il consiglio direttivo che si appresta a varare nuove strategie per il<br />
raggiungimento del pieno riconoscimento professionale della categoria<br />
Carissimi colleghi, ben tornati<br />
dalle ferie che spero abbiate passato<br />
al meglio, l’estate è ormai<br />
alle spalle ed è tempo di ricominciare<br />
a lavorare.<br />
Il gruppo dirigente e molti altri<br />
soci presenti il 18 - 19 settembre a<br />
Roma hanno ripreso l’attività<br />
dell’ANTeL, infatti come tutti<br />
sapete il 18 settembre scorso si è<br />
svolto il congresso nazionale per<br />
il rinnovo delle cariche sociali<br />
all’interno dell’associazione,<br />
come ogni congresso che si<br />
rispetti, esso non poteva che<br />
avere dialettica con toni alti e<br />
bassi ma l’importante è aver trovato<br />
collegialmente la sintesi<br />
degli obiettivi futuri.<br />
Il nuovo consiglio direttivo si svolgerà il 27 ottobre presso l’istituto<br />
di medicina legale dell’Università la Sapienza, in quella sede si decideranno<br />
gli incarichi del nuovo gruppo dirigente che affiancherà<br />
nel lavoro la nostra presidentessa che è stata riconfermata all’unanimità<br />
in sede congressuale.<br />
Qui a lato troverete tutti i nominativi degli eletti e come sicuramente<br />
noterete c’è stato un notevole ricambio direi quasi<br />
‘generazionale’.<br />
Come potete osservare su 21 membri solo 9 sono stati riconfermati,<br />
a mio personale giudizio sta ad indicare che l’era del rilancio e del<br />
cambiamento è iniziata grazie ad una nuova linfa vitale che si è inserita<br />
nell’organizzazione.<br />
Il compito più arduo della nuova dirigenza, è quello di sviluppare al<br />
più presto capacità lungimiranti, che non siano<br />
formule semplicistiche, tecniche meccanicistiche<br />
o basate sull’imitazione.<br />
Auspico un nuovo modello dell’essere Tecnico<br />
di Laboratorio Biomedico, che sia espressione<br />
di etica, di auto-sviluppo, non solo ai vertici<br />
Associativi, ma a tutti i livelli dove operiamo.<br />
Per ottenere un risultato vincente bisogna sviluppare<br />
a mio giudizio:Impegno: ovvero far si<br />
che le esigenze personali vengano condivise e<br />
diventino l’obiettivo comune, instillando in<br />
ogni professionista il senso di appartenenza<br />
alla propria categoria ed il rispetto del codice<br />
deontologico cuore della sua Associazione. Daniela Ciuffi<br />
6 settembre 2008<br />
DEL <strong>LAB</strong>ORATORIO<br />
Competenza: acquisire e sviluppare nozioni nelle aree chiave specifiche.Coerenza:perseguire<br />
con impegno e costanza lo stesso obiettivo.<br />
Prima di intraprendere una nuova strategia o soccombere all’inedia,<br />
ritengo bisogna far valere una visione condivisa unita ad una pazienza<br />
che favorisca un orientamento a lungo termine, necessario per<br />
evitare decisioni di pancia che possono influire negativamente al<br />
raggiungimento dei nostri obbiettivi.<br />
Bisogna decidere insieme cosa cambiare, e cambiarlo radicalmente<br />
per rimettere in moto l’associazione, non possiamo e non dobbiamo<br />
illuderci che il ‘successo’ si trovi dietro l’angolo. Simili illusioni, se non<br />
abbandonate, impediscono di effettuare quel radicale intervento<br />
chirurgico da cui dipende il rilancio dell’antel e il raggiungimento<br />
dell’obiettivo.<br />
E’ necessario far emergere in tutti noi l’ambizione,<br />
la voglia di far parte del nostro team per<br />
dare dignità prima alla nostra professione e poi<br />
far crescere l’Associazione, perché solo con l’impegno<br />
di tutti possiamo puntare in alto e farci<br />
valere, sopratutto in previsione degli ordini. Più<br />
siamo, più saremo forti, e maggiore sarà la<br />
nostra rappresentanza, saremo noi ad essere<br />
parte attiva per la risoluzione dei problemi inerenti<br />
la nostra professione e non saremo spettatori<br />
quando qualcun altro deciderà per noi. E ricordate:<br />
il nostro domani dipende solo da noi!<br />
Vincenzo Troianiello, Consigliere nazionale<br />
vincenzo.troianiello@tiscali.it
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico www.antelonline.it<br />
CARTELLINO ROSSO PER LE REGIONI ABRUZZO E LAZIO<br />
Il consiglio dei ministri ha nominato un commissario<br />
esterno in Abruzzo, che avrà il compito di risolvere il<br />
deficit della regione.<br />
Gino Redigolo, ora direttore amministrativo della ASP<br />
di Reggio Calabria, dovrà ‘contenere l’incremento delle<br />
aliquote fiscali’, così recita la delibera del governo, per<br />
ricoprire il buco della Sanità della regione di 294,2<br />
milioni di euro, egli dovrà trovare il modo di ridurre la<br />
voragine anche recuperando crediti vantati dalle ASL.<br />
La crisi ha avuto una brusca accelerazione fin dal 2006,<br />
quando 196 milioni di euro stanziati per il finanziamento<br />
del servizio regionale furono ‘distratti’ verso altre<br />
destinazioni e utilizzati impropriamente anche per il<br />
pagamento delle cartolarizzazioni.<br />
Ci auguriamo per i cittadini abruzzesi che l’innalzamento<br />
oltre i massimi delle aliquote fiscali, resti solo un arma<br />
a salve a cui ricorrere.<br />
Per i cittadini laziali, nonostante lo sblocco parziale dei<br />
fondi destinati alla regione Lazio, il governo ha deciso di<br />
affiancare, comunque, un tecnico ‘sub commissario’ di propria fiducia al governatore Marrazzo.<br />
La cura anti deficit fatta da tagli a 1953 posti letto con la dismissione dell’ospedale S. Giacomo, Forlanini e Regina<br />
Margherita e la chiusura di 22 strutture private accreditate, non bastano a ridurre il debito della regione, infatti<br />
occorrono ancora 50 milioni di euro di cui venti milioni dovranno arrivare dai ticket sulle visite ospedaliere<br />
intra-moenia, altri trenta dovranno arrivare da un ‘contributo’ che i cittadini dovranno pagare per accertamenti<br />
diagnostici se eseguiti entro 15 giorni dalla prenotazione. Revisione, dunque, del ticket farmaceutico, ma<br />
anche prestazioni a pagamento al’interno degli ospedali sono la cura di cavallo che i cittadini dovranno pagare.<br />
LA ASL DI VITERBO PUNTA<br />
ALLA GESTIONE OTTIMALE DEI RISCHI<br />
Il responsabile ANTeL Regione Abruzzo<br />
F. Vittorini<br />
Un altro tassello verso la realizzazione di un moderno sistema di sicurezza e salute a tutela dei pazienti e di tutti<br />
i lavoratori dipendenti. E’ il piano generale di controllo e di verifica dei locali, degli impianti, dei macchinari e<br />
delle attrezzature, recentemente adottato dalla Ausl di Viterbo. Si tratta di uno strumento di notevole importanza<br />
il cui obiettivo principale è una ottimale gestione dei rischi che, in un sistema complesso come quello sanitario<br />
locale, sono di varia natura.<br />
Tutti meritevoli di attenzione e di controlli periodici. La stesura del piano, realizzata nell’ambito dell’area del<br />
Risk Management, è stata possibile grazie al contributo prezioso di numerose professionalità presenti nella Ausl.<br />
Operatori che, negli anni, hanno creato le premesse per un sistema di qualità importante. Il risultato è stato raggiunto<br />
dopo un ampio confronto all’interno del nucleo di coordinamento del sistema di sicurezza e salute<br />
(NCSSS). Il piano dei controlli aziendali, sostanzialmente, mappa i rischi strutturali e infrastrutturali, identificando<br />
precise responsabilità di governo e gestionali per la loro sorveglianza permanente.<br />
E’ caratterizzato da una sistematicità di controlli programmati, tesi essenzialmente a facilitare i molteplici interventi<br />
preventivi imprescindibili. Solo per far capire la complessità del sistema avviato dalla Ausl Viterbese, può<br />
essere utile citare alcuni centri di controllo interessati dal piano: il microclima delle strutture, il monitoraggio dell’inquinamento<br />
indoor (sale operatorie e strutture ad alto rischio), tutte le principali infrastrutture igienico sanitarie,<br />
i percorsi ospedalieri, le gestioni trasferite (appalti esterni della ristorazione, delle pulizie, della manutenzione<br />
e via dicendo). Per ogni processo attivato saranno individuati: un responsabile del governo del sistema, un<br />
responsabile della verifica, chi deve effettuare la verifica e con quale periodicità, la corretta conservazione della<br />
documentazione acquisita, le modalità per le richieste di manutenzione e di riparazione. Saranno effettuati,<br />
inoltre, dei controlli a campione per accettare la bontà e la regolarità delle verifiche.<br />
‘Sono convinto – commenta il direttore generale della Ausl, Giuseppe Aloisio – che tutti i dirigenti e gli operatori<br />
interessati si impegneranno per l’applicazione integrale e costante del piano adottato. Questo sforzo collettivo<br />
produrrà interventi efficaci ed efficienti nella direzione della realizzazione di condizioni di lavoro migliori e,<br />
soprattutto, di forme assistenziali più sicure.<br />
<strong>LAB</strong><br />
IL MONDO<br />
DEL <strong>LAB</strong>ORATORIO<br />
settembre 2008 7
A.N.Te.L informa<br />
a cura di Grazia Tramini<br />
I RECETTORI PURINERGICI<br />
Le molecole puriniche adenosina, ADP e ATP e pirimidiniche UDP e UTP<br />
presenti nel mezzo extracellulare, costituiscono importanti molecole segnale che<br />
mediano i più diversi effetti biologici, attraverso specifici recettori di membrana<br />
‘I recettori riconoscono una distinta entità<br />
chimica e trasducono l'informazione proveniente<br />
da quell'entità in una forma che la cellula<br />
può leggere per modulare il proprio stato<br />
fisiologico’ (Kenakin et al., 1992). Anche se<br />
molto spesso i recettori sono definiti farmacologicamente<br />
sulla base di composti sintetici, si<br />
suppone che essi, comunque, si siano sviluppati<br />
per rispondere a molecole endogene. Per<br />
questa ragione, i recettori sono normalmente<br />
denominati in base ai loro ligandi naturali.<br />
Le molecole puriniche adenosina, ADP e ATP e<br />
pirimidiniche UDP e UTP presenti nel mezzo extracellulare, costituiscono<br />
importanti molecole segnale che mediano i più diversi effetti<br />
biologici, attraverso specifici recettori di membrana denominati<br />
recettori purinergici.<br />
Aspetti storici: Il concetto di purine come molecole che mediano<br />
segnali extracellulari è stato proposto nel 1929 da Drury e Szent-<br />
Györgyi, che avanzarono l'ipotesi che l'adenosina e l'adenosina 5'monofosfato<br />
(AMP) estratte dal muscolo cardiaco provocassero<br />
blocco cardiaco, dilatazione arteriosa, diminuzione della pressione<br />
sanguigna ed inibizione della contrazione intestinale. Gillespie, nel<br />
1934, studiò quindi la relazione struttura-attività dei composti adeninici,<br />
mostrando che la deaminazione diminuiva l'attività farmacologica<br />
ed influenzava non solo la potenza, ma anche il tipo di<br />
risposta. Per esempio, l'ATP provocava nei conigli e nei gatti un<br />
aumento della pressione sanguigna, che non era osservata con<br />
l'AMP o l'adenosina. Questo diede le prime indicazioni di effetti<br />
differenziali dell'adenosina e dell'ATP e, di conseguenza, dell'esistenza<br />
di differenti recettori purinergici.<br />
Le prime indagini sugli effetti dell'adenosina e dell'ATP condotte in<br />
particolar modo sul tessuto cardiaco e sul sistema vascolare riguardano<br />
non solo contrazione della muscolatura liscia e modulazione della<br />
funzione cardiaca, ma anche aggregazione piastrinica, secrezione<br />
endocrina ed esocrina, risposte immunitarie, regolazione del dolore,<br />
neurotrasmissione e funzione trofica.<br />
Intorno agli anni 60', Burnstock propose che le terminazioni del sistema<br />
nervoso autonomo che innervano il tratto gastrointestinale non<br />
fossero nè di tipo adrenergico, ne' di tipo colinergico (Burnstock et<br />
al., 1963;) ed in seguito a questo, negli anni che seguirono, vennero<br />
realizzate numerose ricerche per caratterizzare il tipo di trasmettitore<br />
utilizzato dai nervi non adrenergici e non colinergici. Tali ricerche<br />
dimostrarono che la sostanza che soddisfaceva la maggior parte dei<br />
criteri richiesti era l'adenosina 5'-trifosfato (ATP) ed in seguito a ciò,<br />
venne coniato l'aggettivo ‘purinergico’ e venne proposta l'esistenza<br />
di una neurotrasmissione purinergica (Burnstock, 1972).<br />
A partire dalla scoperta dei recettori purinici sono stati eseguiti<br />
numerosi tentativi per effettuarne la classificazione. Con l'aumentare<br />
degli studi su questi recettori sono emersi sottotipi recettoriali<br />
nuovi ed i criteri di classificazione si sono pertanto evoluti, da criteri<br />
puramente farmacologici a criteri che riguardano la quantificazione<br />
della loro espressione, la loro localizzazione autoradiografica,<br />
il coinvolgimento dei sistemi dei secondi messaggeri e dei cana-<br />
<strong>LAB</strong><br />
IL MONDO<br />
8 settembre 2008<br />
DEL <strong>LAB</strong>ORATORIO<br />
li ionici ed infine la biologia molecolare di tali recettori ed il loro<br />
clonaggio e sequenziamento.<br />
Successivamente sono stati fatti vari tentativi per classificare questa<br />
nuova classe di recettori e nel 1978, Burnstock, in base a quattro criteri<br />
fondamentali ( 1- relativa potenza di agonisti come ATP, ADP,<br />
AMP ed adenosina; 2- azione selettiva di alcuni antagonisti, in particolar<br />
modo delle metilxantine, che antagonizzano competitivamente<br />
le azioni dell'adenosina, ma non quelle dell'ATP; 3- modulazione dell'adenilato<br />
ciclasi, da parte dell'adenosina e non dell'ATP, con conseguenti<br />
variazioni dell'AMP ciclico intracellulare; 4- induzione della<br />
sintesi di prostaglandine da parte dell'ATP, ma non dell'adenosina),<br />
postulò l'esistenza di due sottoclassi, chiamate P1 e P2, attivate rispettivamente<br />
dall'adenosina e dai nucleotidi. Attualmente tali recettori<br />
sono caratterizzati in base alle loro distinte strutture molecolari, ai<br />
loro diversi sistemi effettori, profili farmacologici, distribuzione tissutale<br />
ed omologie di sequenza.<br />
Sia i recettori P1, sia i recettori P2, sono stati ulteriormente suddivisi:<br />
i recettori P1 in quattro sottotipi, A1, A2A, A2B ed A3, tutti comunque<br />
accoppiati a proteine G; i recettori P2, in recettori ionotropi o<br />
P2X, cioè canali ionici che mediano la permeabilità veloce (entro 10<br />
ms) e selettiva ai cationi di Na+, di K+ e di CA ++ e recettori metabotropi<br />
o P2Y accoppiati a proteine-G, che inducono un inizio più lento<br />
delle risposte (meno di 100 ms) e che coinvolgono i sistemi dei secondi-messaggeri.<br />
La discriminazione tra queste ultime due classi è stata<br />
fatta sulla base di differenti risposte biologiche mediate da analoghi<br />
dell'ATP e da antagonisti selettivi. Fino ad oggi, nei mammiferi, sono<br />
stati classificati sette diversi sottotipi all'interno della classe dei P2X<br />
(P2X1-7) e otto differenti sottotipi all'interno della classe dei P2Y<br />
(P2Y1,2,4,6,11,12,13,14).<br />
Una caratteristica che accomuna tutti i sottotipi P2X, è il diretto<br />
influsso dello ione Ca2+ extracellulare, come anche del Na+ e/o del<br />
K+, promosso dalle purine attraverso i recettori canale stessi. Questo<br />
ingresso è il primo evento nel meccanismo di attivazione purinergica<br />
e rappresenta una importante risorsa di tutto il pool di Ca2+<br />
intracellulare; conseguentemente, si genera una depolarizzazione<br />
della membrana che conduce ad una secondaria apertura del canale<br />
Ca2+ dipendente la quale fornisce probabilmente il contributo<br />
più cospicuo all'influsso ed all'accumulo del Ca2+ intracellulare<br />
totale. Questo meccanismo di trasduzione non è dipendente dalla<br />
produzione e dalla diffusione di secondi messaggeri all'interno del<br />
citosol o della membrana e, pertanto, il tempo di risposta cellulare<br />
è generalmente molto rapido.<br />
Anche i sottotipi dei recettori P2Y modulano il livello degli ioni calcio<br />
intracellulari; mentre l'attivazione dei recettori P2X provoca un<br />
aumento della permeabilità soprattutto al Ca2+ extracellulare, la stimolazione<br />
dei sottotipi P2Y è stata associata primariamente all'attivazione<br />
della fosfolipasi C che conduce alla formazione di inositolo<br />
1,4,5-trifosfato (IP3) e/o alla modulazione dell'adenilato ciclasi che, a<br />
sua volta, determina un conseguente aumento del rilascio di calcio<br />
dai depositi intracellulari. I recettori P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6 sono<br />
accoppiati positivamente alla fosfolipasi C, attraverso la proteina<br />
Gq11, con la conseguente generazione dell'inositolo trifosfato (IP3)<br />
ed una successiva mobilizzazione del calcio intracellulare; al contra-
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico www.antelonline.it<br />
rio, i recettori P2Y12-14 sono accoppiati negativamente all'adenilato<br />
ciclasi attraverso le proteine Gi.<br />
I recettori P2Y11 sono accoppiati sia alle proteine Gq11 che alle proteine<br />
Gs, attivando sia la fosfolipasi C che l'adenilato ciclasi; la via di<br />
trasmissione del segnalazione in effetti, include l'attivazione dell'adenilato<br />
ciclasi con un aumento dell'cAMP ed allo stesso tempo è dipendente<br />
dalla produzione di IP3. Poiché l'attivazione dei recettori P2Y<br />
coinvolge sistemi di secondi messaggeri e/o la conduttanza ionica<br />
mediata dalle proteine G, ne deriva che il tempo di risposta cellulare<br />
è più lungo di quello mediato dai sottotipi dei P2X.<br />
Distribuzione e proprieta fisiopatologiche dei recettori purinergici : i<br />
nucleosidi extracellulari di e trifosfati (NTDPs), il prototipo dei quali è<br />
l'adenosina 5'-trifosfato (ATP), sono considerati tra i fattori epigenetici<br />
filogeneticamente più antichi che inducono una vasta gamma di effetti<br />
biologici. Nei vari tessuti, questi effetti possono influire sulla neurotrasmissione,<br />
sulla contrazione cardiaca e del muscolo liscio, sull'invio di<br />
segnali chemosensoriali, sulla secrezione e vasodilatazione, sull'attivazione<br />
della microglia, ed anche su fenomeni più complessi quali: risposte<br />
immunitarie, riproduzione maschile, contraccezione, fertilità e sviluppo<br />
embrionale.<br />
Gli NTDPs sembrano svolgere<br />
ruoli fondamentali nelle<br />
patologie neoplastiche, nell'insufficienzacardio-polmonare,<br />
nella trombosi, nel diabete,<br />
nelle malattie ossee e<br />
della pelle, nei disordini<br />
della motilità intestinale,<br />
nelle malattie dell'orecchio e<br />
dell'occhio, nell'incontinenza<br />
della vescica, nei disordini<br />
del comportamento e nel<br />
dolore.<br />
Recentemente, si è dimostrato<br />
che nel sistema nervoso<br />
centrale (SNC), oltre alle ben<br />
note funzioni di neurotrasmettitori,<br />
co-transmettitori<br />
e neuromodulatori, gli NTDPs svolgono nuovi ruoli biologici che<br />
variano dalla sopravvivenza, al rimodellamento durante la normale<br />
fase di sviluppo o alla riparazione dopo una alterazione tessutale, al<br />
coinvolgimento nelle patologie neurodegenerative acute e croniche,<br />
al danno metabolico od a quello da esocitosi.<br />
Essi sono coinvolti anche nei meccanismi neuronali innescati dalla<br />
assotomia dei nuclei precerebellari del ratto, nelle reazioni astrocitarie<br />
innescate da un insulto acuto provocato da una ferita, nella gliosi<br />
reattiva che si verifica dopo un danno traumatico del cervello, nelle<br />
risposte neuronali e gliali in seguito ad ischemia cerebrale in vitro ed<br />
in vivo. Tutto ciò accade perché, in seguito ad ischemia cerebrale o<br />
trauma metabolico si verifica un voluminoso rilascio extracellulare di<br />
ATP, di adenosina e di altri neurotrasmettitori; inoltre, l'ATP è di per<br />
se tossico nei confronti dei neuroni primari del SNC e media il segnale<br />
di ipossia o di ipoglicemica in vitro ed in vivo.<br />
Ulteriori studi hanno osservato che sostanze antagoniste dei recettori<br />
P2 sono in grado di abolire il destino di morte di neuroni primari,<br />
provocato dalla esposizione ad una eccessiva concentrazione di glutammato,<br />
ad una deprivazione del potassio sierico, ad una condizione<br />
di ipoglicemia o di ipossia chimica. L'azione esplicata dall'ATP che<br />
viene liberato dalle cellule non è diretta solo sui neuroni, ma può<br />
mediare anche i processi infiammatori della microglia, coinvolti nell'instaurazione<br />
di numerose condizioni patologiche o nella preservazione<br />
dell'integrità del SNC. Ad esempio, l'ATP provoca la secrezione<br />
del TNF e modula il rilascio dell’interleukina-1 (IL-1) dalle colture di<br />
microglia, facendo ipotizzare che il suo rilascio durante gli stati patologici,<br />
avrebbe lo scopo di amplificare la risposta pro-infiammatoria<br />
delle cellule della microglia già attivate. Inoltre, effetti tanto differenti<br />
come proliferazione, differenziazione, chemiotassi, rilascio di citochine<br />
o di costituenti lisosomiali, generazione di specie reattive dell'ossigeno<br />
(ROS) o dell'azoto, sono suscitati dall'ATP extracellulare su<br />
stimolo delle cellule del sangue.<br />
E' possibile che lo svolgimento di tante funzioni così diverse e specializzate,<br />
sia dovuto alla complessità biologica dei recettori extracellulari<br />
specifici per gli NTDPs, definiti recettori P2.<br />
E' accertato che il sottotipo recettoriale P2Y1 è ampiamente distribuito<br />
nel cuore, nel tessuto vascolare, nel connettivo, nel sistema immunitario<br />
e nel tessuto nervoso.<br />
Negli ultimi anni è stata particolarmente studiata la distribuzione tessutale<br />
e cellulare del recettore P2Y1 anche nel cervello umano e si è<br />
visto che esso è espresso abbondantemente nei neuroni piramidali<br />
dell'ippocampo e nella corteccia cerebrale. Poiché i neuroni piramidali<br />
sono tra i principali tipi cellulari che degenerano nel morbo di<br />
Alzheimer, è stata recentemente<br />
studiata la distribuzione<br />
dei recettori P2Y1<br />
nell'ippocampo, mediante<br />
tecniche di immunoistochimica<br />
su tessuto cerebrale<br />
post-mortem di pazienti<br />
affetti dalla patologia di<br />
Alzheimer e, parallelamente,<br />
di pazienti sani. I livelli<br />
di espressione di tale recettore<br />
si sono dimostrati<br />
variabili da caso a caso, ma<br />
si è riscontrata una localizzazione<br />
differenziale nel<br />
tessuto dei malati osservando<br />
una loro aumentata<br />
distribuzione in prossimità<br />
degli ammassi neurofibrillari<br />
e delle placche neuritiche, entrambi caratteristiche tipiche del<br />
morbo di Alzheimer. E' stata pertanto avanzata l'ipotesi che questo<br />
recettore possa essere coinvolto, direttamente od indirettamente,<br />
negli eventi che mediano la degenerazione dei neuroni piramidali.<br />
Tuttavia, non è ancora ben definito il ruolo delle purine extracellulari<br />
nella patologia di Alzheimer, così come nelle altre malattie neurodegenerative.<br />
Considerando la vasta gamma di differenze molecolari e farmacologiche<br />
relativa ai recettori P2, diventa evidente che conoscerne nei<br />
dettagli la fisiopatologia costituisce una vera sfida e i progetti che<br />
mirano a formulare nuovi composti farmacologici che siano sempre<br />
più selettivi, devono necessariamente tener conto delle loro eterogeneità.<br />
Vengono continuamente sintetizzati nuovi e più potenti<br />
agonisti/antagonisti per i recettori P2; tuttavia, rimangono ancora<br />
senza risposta parecchie domande fondamentali. Devono essere<br />
definite: da un punto di vista di scoperta di nuovi farmaci, quale sia<br />
l'esatta struttura di base che determina la specificità dei vari ligandi<br />
nei diversi tipi di recettori P2 e come la struttura generale dei<br />
recettori P2 possa essere tanto finemente adattata da legare una<br />
così vasta gamma di ligandi chimicamente differenti.<br />
Per quanto attiene ad un punto di vista cellulare, si deve ancora capire<br />
il motivo e le modalità con cui i differenti sottotipi dei recettori P2<br />
siano in grado di adempiere a funzioni biologiche così diverse sia singolarmente,<br />
sia in associazione eteromerica o omomerica.<br />
<strong>LAB</strong><br />
IL MONDO<br />
DEL <strong>LAB</strong>ORATORIO<br />
settembre 2008 9