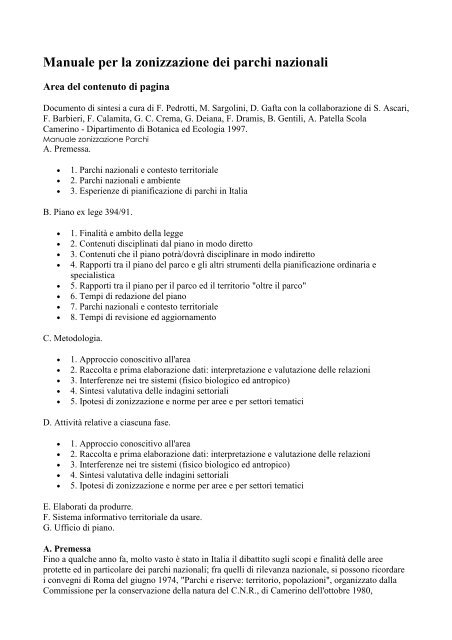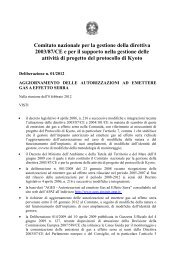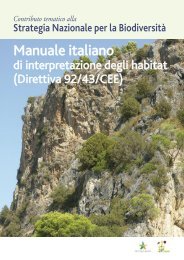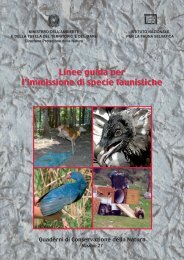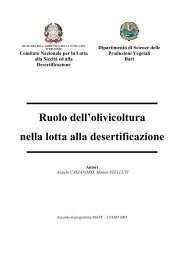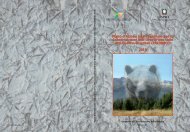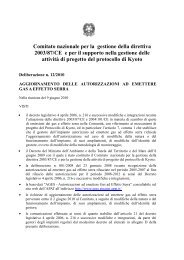Manuale per la zonizzazione dei parchi nazionali - Ministero dell ...
Manuale per la zonizzazione dei parchi nazionali - Ministero dell ...
Manuale per la zonizzazione dei parchi nazionali - Ministero dell ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Manuale</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong><br />
Area del contenuto di pagina<br />
Documento di sintesi a cura di F. Pedrotti, M. Sargolini, D. Gafta con <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di S. Ascari,<br />
F. Barbieri, F. Ca<strong>la</strong>mita, G. C. Crema, G. Deiana, F. Dramis, B. Gentili, A. Patel<strong>la</strong> Sco<strong>la</strong><br />
Camerino - Dipartimento di Botanica ed Ecologia 1997.<br />
<strong>Manuale</strong> <strong>zonizzazione</strong> Parchi<br />
A. Premessa.<br />
• 1. Parchi <strong>nazionali</strong> e contesto territoriale<br />
• 2. Parchi <strong>nazionali</strong> e ambiente<br />
• 3. Es<strong>per</strong>ienze di pianificazione di <strong>parchi</strong> in Italia<br />
B. Piano ex lege 394/91.<br />
• 1. Finalità e ambito del<strong>la</strong> legge<br />
• 2. Contenuti disciplinati dal piano in modo diretto<br />
• 3. Contenuti che il piano potrà/dovrà disciplinare in modo indiretto<br />
• 4. Rapporti tra il piano del parco e gli altri strumenti del<strong>la</strong> pianificazione ordinaria e<br />
specialistica<br />
• 5. Rapporti tra il piano <strong>per</strong> il parco ed il territorio "oltre il parco"<br />
• 6. Tempi di redazione del piano<br />
• 7. Parchi <strong>nazionali</strong> e contesto territoriale<br />
• 8. Tempi di revisione ed aggiornamento<br />
C. Metodologia.<br />
• 1. Approccio conoscitivo all'area<br />
• 2. Raccolta e prima e<strong>la</strong>borazione dati: interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni<br />
• 3. Interferenze nei tre sistemi (fisico biologico ed antropico)<br />
• 4. Sintesi valutativa <strong>dell</strong>e indagini settoriali<br />
• 5. Ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> e norme <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
D. Attività re<strong>la</strong>tive a ciascuna fase.<br />
• 1. Approccio conoscitivo all'area<br />
• 2. Raccolta e prima e<strong>la</strong>borazione dati: interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni<br />
• 3. Interferenze nei tre sistemi (fisico biologico ed antropico)<br />
• 4. Sintesi valutativa <strong>dell</strong>e indagini settoriali<br />
• 5. Ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> e norme <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
E. E<strong>la</strong>borati da produrre.<br />
F. Sistema informativo territoriale da usare.<br />
G. Ufficio di piano.<br />
A. Premessa<br />
Fino a qualche anno fa, molto vasto è stato in Italia il dibattito sugli scopi e finalità <strong>dell</strong>e aree<br />
protette ed in partico<strong>la</strong>re <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong>; fra quelli di rilevanza nazionale, si possono ricordare<br />
i convegni di Roma del giugno 1974, "Parchi e riserve: territorio, popo<strong>la</strong>zioni", organizzato dal<strong>la</strong><br />
Commissione <strong>per</strong> <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> natura del C.N.R., di Camerino <strong>dell</strong>'ottobre 1980,
"Strategia 80 <strong>per</strong> i <strong>parchi</strong> e le riserve d'Italia" organizzato dal Comitato Parchi Nazionali e Riserve<br />
Analoghe d'Italia e dalle associazioni W.W.F., Italia Nostra e Federnatura, di Roma del novembre<br />
1983, "Parchi e aree protette in Italia", organizzato dall'Accademia Nazionale <strong>dei</strong> Lincei e infine di<br />
Camerino <strong>dell</strong>'ottobre 1990 "La sfida del 10%: a metà del cammino" e organizzato dal Comitato<br />
<strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> e riserve analoghe d'Italia e dal W.W.F. Italia.<br />
Dopo il 1991, scopi e finalità <strong>dell</strong>e aree protette sono fissate dal<strong>la</strong> legge quadro n. 394, che all'art. 1<br />
stabilisce che le aree naturali protette vengono istituite e gestite "al fine di garantire e di<br />
promuovere, in forma coordinata, <strong>la</strong> conservazione e <strong>la</strong> valorizzazione del patrimonio naturale del<br />
paese, rappresentato dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno<br />
rilevante valore naturalistico".<br />
Attorno a questa realtà, rappresentata dal<strong>la</strong> natura e dalle sue risorse, <strong>la</strong> legge n. 394 prevede che le<br />
aree protette svolgano anche altre importanti funzioni, quali l'applicazione di metodi di gestione o di<br />
restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche<br />
mediante <strong>la</strong> salvaguardia <strong>dei</strong> valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e <strong>dell</strong>e attività<br />
agro-silvo-pastorali tradizionali, <strong>la</strong> promozione di attività di educazione, formazione e ricerca<br />
scientifica, nonché di attività ricreative compatibili e <strong>la</strong> valorizzazione e s<strong>per</strong>imentazione di attività<br />
produttive compatibili.<br />
Ne discende che l'area protetta è un'istituzione profondamente ancorata al<strong>la</strong> realtà territoriale e<br />
assume un'importanza molto vasta e artico<strong>la</strong>ta ove, accanto agli scopi conservazionistici, culturali,<br />
scientifici ed educativi, viene <strong>per</strong>seguita anche un'attività promozionale nei settori del turismo e<br />
<strong>dell</strong>e attività agro-silvo-pastorali.<br />
Con l'approvazione del<strong>la</strong> legge n. 394, <strong>la</strong> pianificazione territoriale del parco, attraverso il Piano del<br />
parco, è diventata uno <strong>dei</strong> momenti più qualificativi ed importanti <strong>per</strong> l'organizzazione del parco<br />
stesso e <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua gestione.<br />
A tale riguardo, è bene precisare che "nelle aree naturali protette compete priorità gerarchica al<strong>la</strong><br />
conservazione, che è valore insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro interesse", compreso<br />
quello economico; di tale primarietà, deve ovviamente tenere conto il Piano del parco. A tal fine,<br />
esso è sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione e <strong>per</strong> tale ragione le inziative economicosociali<br />
debbono ottenere il parere vinco<strong>la</strong>nte del consiglio direttivo <strong>dell</strong>'Ente Parco, ivi compreso il<br />
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico predisposto a cura del<strong>la</strong> Comunità del parco.<br />
1. Parchi <strong>nazionali</strong> e contesto territoriale<br />
Da un punto di vista generale, <strong>per</strong> quanto riguarda il tema del<strong>la</strong> pianificazione <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> si devono<br />
distinguere due momenti strettamente re<strong>la</strong>zionati: <strong>la</strong> pianificazione generale del territorio, con scelta<br />
<strong>dell</strong>e aree da destinare al<strong>la</strong> protezione, e <strong>la</strong> pianificazione del territorio <strong>dell</strong>'area protetta, cioè<br />
l'organizzazione spaziale del suo territorio compreso all'interno di una data <strong>per</strong>imetrazione.<br />
Le prime aree protette <strong>dell</strong>'Italia (<strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> storici, alcuni <strong>parchi</strong> regionali o provinciali come<br />
quello del Brenta-Adamello, alcune riserve naturali come quel<strong>la</strong> di Sasso Fratino, le oasi <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
protezione del<strong>la</strong> fauna del W.W.F.) sono state istituite sul<strong>la</strong> spinta di naturalisti che facevano<br />
riferimento a eccezionali presenze botaniche, faunistiche e ambientali.<br />
In un secondo momento, hanno visto <strong>la</strong> luce i primi censimenti di località da proteggere e i primi<br />
elenchi di <strong>parchi</strong> e riserve da istituire, sia a livello regionale che nazionale. Fra questi ultimi, ricordo<br />
<strong>la</strong> Carta <strong>dei</strong> biotopi d'Italia del<strong>la</strong> Commissione <strong>per</strong> <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> natura del C.N.R. del<br />
1971 e il Censimento <strong>dei</strong> biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in<br />
Italia, pubblicati in due volumi del 1971 e del 1979 a cura del<strong>la</strong> Società Botanica Italiana: questi<br />
primi inventari hanno sicuramente costituito un contributo fondamentale al<strong>la</strong> pianificazione<br />
naturalistica del nostro paese, <strong>per</strong> <strong>la</strong> ricchezza di dati e notizie riportate.<br />
I nuovi <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> istituiti con <strong>la</strong> legge n. 394 nascono <strong>per</strong> lo più dalle istanze provenienti dai<br />
movimenti protezionistici, sovente concretizzate in piani e progetti ufficiali a vari livelli; si pensi a<br />
quanto è stato scritto in passato <strong>per</strong> i <strong>parchi</strong> del Delta del Pò, <strong>dei</strong> Monti Sibillini o del Gennargentu,<br />
tanto <strong>per</strong> fare alcuni esempi. La legge n. 394 ha recepito le istanze precedenti e costituisce oggi <strong>la</strong>
più importante iniziativa di pianificazione naturalistica a livello nazionale che sia mai stata<br />
realizzata in Italia.<br />
2. Parchi <strong>nazionali</strong> e ambiente<br />
Allo scopo di precisare brevemente le caratteristiche ambientali generali <strong>dei</strong> territori ove sono stati<br />
istituiti i <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> nel nostro paese, si può fare riferimento al<strong>la</strong> suddivisione biogeografica<br />
<strong>dell</strong>'Italia nelle due Regioni eurosiberiana e mediterranea, ciascuna <strong>dell</strong>e quali a sua volta è divisa in<br />
provincie; i 19 <strong>parchi</strong> oggi esistenti (o in via di costituzione) sono così distribuiti:<br />
Regione eurosiberiana<br />
• Provincia <strong>dell</strong>e Alpi: Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio, Dolomiti Bellunesi;<br />
• Provincia del<strong>la</strong> Pianura Padana: Delta del Po;<br />
• Provincia <strong>dell</strong>'Appennino: Foreste Casentinesi, Monti Sibillini, Gran Sasso-Monti del<strong>la</strong><br />
Laga, Abruzzo, Maiel<strong>la</strong>, Cilento, Pollino, Ca<strong>la</strong>bria (Si<strong>la</strong> Grande, Si<strong>la</strong> Picco<strong>la</strong>, Aspromonte),<br />
Aspromonte;<br />
Regione mediterranea<br />
• Provincia adriatico-ionica: Gargano;<br />
• Provincia tirrenica: Vesuvio, Circeo, Arcipe<strong>la</strong>go Toscano;<br />
• Provincia del<strong>la</strong> Sardegna: Gennargentu.<br />
I 4 <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> del<strong>la</strong> Provincia biogeografica <strong>dell</strong>e Alpi (Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio,<br />
Dolomiti Bellunesi) appartengono a contesti territoriali molto diversi; nelle Alpi Occidentali si<br />
trovano <strong>la</strong> Val Grande e il Gran Paradiso, che confina con il Parco nazionale del<strong>la</strong> Vanoise; nelle<br />
Alpi Centrali lo Stelvio, che confina con il Parco nazionale Svizzero <strong>dell</strong>'Engadina e con i <strong>parchi</strong><br />
naturali regionali e provinciali <strong>dell</strong>'Adamello (Lombardia) e del Brenta-Adamello (Trentino); quello<br />
<strong>dell</strong>e Dolomiti Bellunesi, infine, si colloca nel<strong>la</strong> fascia prealpina <strong>dell</strong>e Alpi Orientali. I due <strong>parchi</strong><br />
del Gran Paradiso e <strong>dell</strong>o Stelvio godono di una collocazione territoriale partico<strong>la</strong>rmente<br />
favorevole, data l'esistenza di altre aree protette a non molta distanza e l'esistenza di vasti territori<br />
ancora ben conservati, <strong>per</strong> quanto sempre più antropizzati con il trascorrere degli anni.<br />
Nel<strong>la</strong> Provincia biogeografica del<strong>la</strong> Pianura Padana si trova un parco nazionale nel<strong>la</strong> zona costiera,<br />
quello del Delta del Pò, un ambiente di grande interesse naturalistico ma situato in un contesto<br />
territoriale fortemente compromesso.<br />
I 13 <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> del<strong>la</strong> Provincia biogeografica <strong>dell</strong>'Appennino sono quelli <strong>dell</strong>'Abruzzo, Foreste<br />
Casentinesi, Monti Sibillini, Gran Sasso - Monti del<strong>la</strong> Laga, Maiel<strong>la</strong>, Pollino, Ca<strong>la</strong>bria,<br />
Aspromonte, Cilento e Vallo di Diano. Il Parco <strong>dell</strong>e Foreste Casentinesi si trova nell'Appennino<br />
settentrionale e costituisce un'unità iso<strong>la</strong>ta, <strong>per</strong>ò nel contesto di una vasta area verde con buone<br />
caratteristiche di naturalità; i <strong>parchi</strong> <strong>dei</strong> Monti Sibillini, Gran Sasso-Monti del<strong>la</strong> Laga, Maiel<strong>la</strong> e<br />
Abruzzo sono tutti situati nell'Appennino centrale e sono riuniti in due gruppi montuosi confinanti:<br />
da una parte Sibillini - Gran Sasso-Laga e dall'altra Maiel<strong>la</strong> - Abruzzo, a loro volta collocati in<br />
sistemi montuosi estesi e con alto grado di naturalità. Si tratta, <strong>per</strong>tanto, di una situazione<br />
estremamente favorevole <strong>per</strong> questo gruppo di <strong>parchi</strong>, purché i territori interposti possano<br />
mantenere le loro caratteristiche attuali, <strong>per</strong> altro in parte alterate, ed evitare ulteriori processi di<br />
antropizzazione. I <strong>parchi</strong> del Vesuvio, Cilento-Vallo di Diano, Pollino, Ca<strong>la</strong>bria, e Aspromonte<br />
costituiscono altrettanti caposaldi che dovrebbero garantire <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> variabilità<br />
biologica e ambientale nelle località più importanti <strong>dell</strong>'intero Appennino.<br />
Per quanto riguarda <strong>la</strong> Regione Mediterranea, in essa si trovano i <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> del Gargano,<br />
Vesuvio (unico parco nazionale in ambiente vulcanico), Circeo (parco costiero) e Arcipe<strong>la</strong>go<br />
Toscano (parco marino), tutti con una loro propria individualità, che li rende unici in Europa; ad
essi si deve aggiungere il parco nazionale del<strong>la</strong> Sardegna (Golfo di Orosei, Gennargentu e Iso<strong>la</strong><br />
Asinara), di grandissima importanza da tutti i punti di vista.<br />
La diversità biogeografica esistente in Italia è dunque abbastanza ben rappresentata nei <strong>parchi</strong><br />
<strong>nazionali</strong> <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong> Regione eurosiberiana, sia in riferimento alle Alpi che<br />
all'Appennino, mentre non altrettanto si può dire <strong>per</strong> <strong>la</strong> Regione Mediterranea, che nel nostro paese<br />
è anche quel<strong>la</strong> maggiormente compromessa.<br />
3. Es<strong>per</strong>ienze di pianificazione di <strong>parchi</strong> in Italia<br />
L' esigenza di una <strong>zonizzazione</strong> del territorio <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> si è sentita in Italia già da molto<br />
tempo ed è stata proposta <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta nel 1955 <strong>per</strong> il Parco nazionale del Gran Paradiso, con<br />
<strong>la</strong> raccomandazione che entro i <strong>parchi</strong> venissero adattate varie zone "in rapporto agli studi<br />
naturalistici, ai visitatori ed ai montanari locali", distinguendo "una zona scientifica, una zona di<br />
disciplinato turismo e una zona di pre-parco".<br />
Soltanto parecchi anni dopo, nel 1968 e nel 1969, sono state realizzate due proposte di<br />
pianificazione dedicate ai Parchi <strong>nazionali</strong> d'Abruzzo e <strong>dell</strong>o Stelvio, denominate rispettivamente<br />
"Piano di riassetto del Parco Nazionale d'Abruzzo" e "Studi <strong>per</strong> <strong>la</strong> valorizzazione naturalistica del<br />
Parco Nazionale <strong>dell</strong>o Stelvio"; questi studi costituiscono i primi esempi di pianificazione di <strong>parchi</strong><br />
nel nostro paese.<br />
In assenza del<strong>la</strong> legge-quadro sulle aree protette, i due progetti re<strong>la</strong>tivi ai Parchi Nazionali<br />
d'Abruzzo e <strong>dell</strong>o Stelvio si erano ispirati al "Progetto di legge quadro sui <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong>" redatto<br />
dall'Associazione Italia Nostra e presentato al<strong>la</strong> Camera <strong>dei</strong> Deputati del<strong>la</strong> IV legis<strong>la</strong>tura il 4<br />
settembre 1964.<br />
Come tali, i due progetti - nati a distanza di un anno uno dall'altro - evidentemente non avevano<br />
forza di legge, anche se le Amministrazioni <strong>dei</strong> due <strong>parchi</strong> d'Abruzzo e <strong>dell</strong>o Stelvio hanno poi<br />
tentato, con alterni successi, un'applicazione <strong>per</strong> lo meno parziale e indicativa <strong>dei</strong> loro contenuti.<br />
Altrettanto si può dire <strong>per</strong> molti altri studi sul<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> di <strong>parchi</strong> che erano in progetto e non<br />
ancora istituiti, realizzati successivamente, come quelli <strong>per</strong> il Parco Nazionale del Pollino, <strong>per</strong> il<br />
Parco nazionale del Delta del Po, <strong>per</strong> il Parco nazionale del Gran Paradiso, <strong>per</strong> il Parco nazionale<br />
<strong>dei</strong> Monti Sibillini, ecc.<br />
Attualmente il dibattito scientifico in corso su tali tematiche <strong>per</strong>mette di considerare <strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong><br />
come componente essenziale ma non sufficiente <strong>per</strong> <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione di un'area protetta.<br />
In partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> necessità di normare tematismi spesso trasversali rispetto ai settori disciplinari<br />
tradizionali, affrontando problematiche capaci di su<strong>per</strong>are ogni limite di zona fissato, induce il<br />
progettista a ricercare metodologie adeguate <strong>per</strong> rispondere ai contenuti disciplinari indicati<br />
nell'articolo 12 del<strong>la</strong> legge 394/1991.<br />
Peraltro <strong>la</strong> rigida suddivisione in zone ha già messo in luce tutti i suoi limiti negli insuccessi del<strong>la</strong><br />
passata pianificazione urbanistica e territoriale.<br />
Nel<strong>la</strong> pianificazione <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> dove, rispetto all'urbanistica tradizionale si esaltano le dinamiche<br />
evolutive di significative e qualificanti presenze naturali, si rendono ancora più indispensabili criteri<br />
di analisi e di progetto interdisciplinari (coinvolgenti competenze che vanno dal naturalista allo<br />
storico) capaci di cogliere <strong>la</strong> complessa artico<strong>la</strong>zione degli equilibri ecosistemici.<br />
L'artificiosità propria del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> che porta all'individuazione di confini fra aree destinate a<br />
gestioni diverse rischia di alterare l'unità organica del territorio del parco, vocato in prima istanza<br />
al<strong>la</strong> conservazione <strong>dell</strong>e risorse naturali. Infatti, <strong>la</strong> necessità di comprendere all'interno del parco un<br />
sistema di riserve bioconnesse, che l'I.U.C.N. auspica non inferiore al 65-70% del<strong>la</strong> su<strong>per</strong>fice totale,<br />
non può considerarsi mero traguardo normativo, quanto l'essenza istitutiva del parco stesso. Le<br />
riserve dovranno considerarsi come il "cuore" ed il motivo <strong>dell</strong>'esistenza <strong>dell</strong>'intero sistema parco,<br />
<strong>la</strong> cui sopravvivenza dipende esclusivamente dai rapporti che si vengono a stabilire tra riserve e<br />
parti <strong>per</strong>iferiche.<br />
In partico<strong>la</strong>re, è necessario ricercare un governo <strong>dell</strong>'area protetta capace di garantire <strong>la</strong> rigida<br />
conservazione <strong>dell</strong>e risorse naturali all'interno dlele riserve ed il controllo del sistem di re<strong>la</strong>zioni già
esistenti o nascenti tra riserve, aree di protezione, aree di promozione, zone contigue e ambiti<br />
territoriali limitrofi. Si è in presenza, dunque, di forme di pianificazione specialistica e di settore<br />
opportunamente raccordate con <strong>la</strong> pianificazione ordinaria.<br />
È <strong>per</strong>tanto impensabile il concepimento di una metodologia di pianificazione <strong>dell</strong>e aree protette<br />
mutuabile <strong>per</strong> intero dall'urbanistica intesa come mera trasposizione <strong>dell</strong>e es<strong>per</strong>ienze di<br />
<strong>zonizzazione</strong> già realizzate nel<strong>la</strong> pianificazione ordinaria; sarà invece utile s<strong>per</strong>imentare un <strong>per</strong>corso<br />
di piano capace di soddisfare esigenze di rego<strong>la</strong>mentazione di uso, conservazione e restauro di<br />
ambiti territoriali del tutto speciali, anche se significativamente interre<strong>la</strong>ti tra di loro e con il resto<br />
del territorio nazionale.<br />
L'obiettivo del<strong>la</strong> nostra trattazione è quello di mettere in luce sinteticamente i processi conoscitivi,<br />
valutativi e decisionali orientati al<strong>la</strong> pianificazione e gestione di un parco nazionale, prospettando<br />
criteri di rego<strong>la</strong>mentazione finali capaci di alternare forme di normazione attiva a tradizionali azioni<br />
di tute<strong>la</strong>, intervenendo non solo <strong>per</strong> zone, ma anche <strong>per</strong> settori tematici e <strong>per</strong> progetti.<br />
B. Piano ex lege 394/91<br />
Al fine di delineare le attività conoscitive, valutative e decisonali mirate al<strong>la</strong> redazione del piano, si<br />
ritiene opportuno evidenziare preliminarmente i contenuti "strutturali" del<strong>la</strong> Legge Quadro sulle<br />
aree protette (L. n. 394 del 6/12/1991) che costituiscono lo sfondo normativo fondamentale <strong>dell</strong>e<br />
attività di piano da definire.<br />
In partico<strong>la</strong>re appare utile mettere in luce i "quesiti a<strong>per</strong>ti" dal<strong>la</strong> legge stessa <strong>per</strong> rintracciare nel<br />
<strong>per</strong>corso metodologico proposto eventuali "risposte" e chiarimenti.<br />
1. Finalità e ambito del<strong>la</strong> legge<br />
La legge intende garantire e promuovere, in forma coordinata, <strong>la</strong> conservazione e <strong>la</strong> valorizzazione<br />
del patrimonio naturale del paese.<br />
Nell'art.1 vengono indicate le finalità da <strong>per</strong>seguire nei territori sottoposti ad uno speciale regime di<br />
tute<strong>la</strong> e gestione ed in partico<strong>la</strong>re:<br />
• conservazione di specie animali o vegetali o forestali, di singo<strong>la</strong>rità geologiche, di<br />
formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e<br />
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;<br />
• applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una<br />
integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante <strong>la</strong> salvaguardia <strong>dei</strong> valori<br />
antropologici, archeologici, storici e architettonici e <strong>dell</strong>e attività agro-silvo- pastorali e<br />
tradizionali;<br />
• promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche<br />
interdisciplinare, nonche di attività ricreative compatibili;<br />
• difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.<br />
Il piano <strong>per</strong> il parco è uno degli strumenti che <strong>la</strong> legge mette a disposizione <strong>per</strong> il <strong>per</strong>seguimento di<br />
suddette finalità.<br />
In stretta connessione con il piano intervengono altri strumenti e diverse iniziative sia<br />
nell'organizzazione del regime di tute<strong>la</strong> e gestione del parco (Rego<strong>la</strong>mento del Parco, Piano<br />
Pluriennale economico e sociale, Misure d'incentivazione, Acquisti, espropri ed indennizzi) che<br />
nel<strong>la</strong> strutturazione <strong>dei</strong> rapporti col territorio "oltre il parco" e le altre aree protette a livello<br />
nazionale ed internazionale (zone contigue, Carta del<strong>la</strong> Natura, Programma Triennale <strong>per</strong> le aree<br />
naturali protette, Istituzione di <strong>parchi</strong> e aree di re<strong>per</strong>imento).<br />
Gli strumenti e le iniziative predette intervengono in valutazioni e scelte strettamente corre<strong>la</strong>te<br />
all'azione del piano; molto spesso i loro contenuti sono guidati ed orientati dal piano, seppure in<br />
modo indiretto. Per questo motivo, prima di costruire nel dettaglio le attività di piano, abbiamo<br />
ritenuto opportuno prenderli in esame, in aggiunta a quei contenuti che il piano dovrà disciplinare in<br />
modo diretto.
2. Contenuti disciplinati dal piano in modo diretto<br />
Il piano dovrà disciplinare una serie di contenuti in modo diretto (L.394/91, art.12, comma 1):<br />
• organizzazione generale del territorio e sua artico<strong>la</strong>zione in aree o parti caratterizzate da<br />
forme differenziate di uso godimento e tute<strong>la</strong>;<br />
• vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione re<strong>la</strong>tive con riferimento<br />
alle varie aree o parti del piano;<br />
• sistemi di accessibilità veico<strong>la</strong>re e pedonale con partico<strong>la</strong>re riguardo ai <strong>per</strong>corsi, accessi e<br />
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;<br />
• sistemi di attrezzature e servizi <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione e <strong>la</strong> funzione sociale del parco, musei, centri<br />
di visite,uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;<br />
• indirizzi e criteri <strong>per</strong> gli interventi sul<strong>la</strong> flora, sul<strong>la</strong> fauna e sull'ambiente naturale in genere.<br />
Si tratta dunque di prevedere l'organizzazione strutturale <strong>dell</strong>'intera area destinata a parco con<br />
l'approfondimento di alcune questioni specifiche.<br />
La legge fornisce precise indicazioni in merito all'artico<strong>la</strong>zione del territorio in aree o parti<br />
caratterizzate da forme differenziate di uso; infatti assegna al piano il compito di suddividere il<br />
territorio in base al diverso grado di protezione prevedendo:<br />
• 1. le riserve integrali dove l'ambiente naturale è conservato nel<strong>la</strong> sua integrità;<br />
• 2. le riserve generali orientate dove è vietato costruire nuove o<strong>per</strong>e edilizie, ampliare le<br />
costruzioni esistenti, eseguire o<strong>per</strong>e di trasformazione del territorio, ma dove è consentito<br />
utilizzare le strutture produttive tradizionali, realizzare le infrastrutture strettamente<br />
necessarie, gli interventi di gestione <strong>dell</strong>e risorse naturali e di manutenzione <strong>dell</strong>e o<strong>per</strong>e<br />
esistenti;<br />
• 3. le aree di protezione dove, in armonia con le finalità istitutive, possono continuare,<br />
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali,<br />
è incoraggiata <strong>la</strong> produzione artigianale di qualità e sono ammessi gli<br />
interventi di manutenzione e restauro <strong>dell</strong>e o<strong>per</strong>e esistenti;<br />
• 4. le aree di promozione economica e sociale, dove sono consentite attività compatibili con<br />
le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento del<strong>la</strong> vita socio - culturale <strong>dell</strong>e<br />
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte <strong>dei</strong> visitatori.<br />
Si ribadisce così una suddivisione già s<strong>per</strong>imentata, se si eccettuano piccole differenziazioni<br />
semantiche, nelle es<strong>per</strong>ienze pionieristiche <strong>dei</strong> primi piani <strong>per</strong> i <strong>parchi</strong> italiani ed in altre es<strong>per</strong>ienze<br />
inter<strong>nazionali</strong>.<br />
Al fine di evitare il concepimento del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong>, come una tecnica rigida ed arbitraria di<br />
suddivisione spaziale <strong>dell</strong>e attività sarà opportuno considerare non tanto l'elemento puntuale quanto<br />
l'ambito re<strong>la</strong>zionale cui l'elemento appartiene in una visione ecosistemica del<strong>la</strong> realtà territoriale<br />
capace di gestire così il complesso intreccio di usi e forme di gestione.<br />
3. Contenuti che il piano potrà/dovrà disciplinare in modo indiretto<br />
Il piano <strong>per</strong> il parco potrà/dovrà disciplinare una serie di contenuti in modo indiretto, come supporto<br />
ad altri strumenti e ad altre iniziative previste dal<strong>la</strong> legge stessa: Rego<strong>la</strong>mento del Parco, Piano<br />
pluriennale economico e sociale, misure d'incentivazione.<br />
3.1. Rego<strong>la</strong>mento del Parco (L.394/91, art.11, comma 2)<br />
Il Rego<strong>la</strong>mento del Parco disciplina l'esercizio <strong>dell</strong>e attività consentite entro il territorio del parco<br />
ed è "adottato dall'Ente Parco anche contestualmente all'approvazione del piano <strong>per</strong> il parco e<br />
comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo".
Il Rego<strong>la</strong>mento del Parco disciplina in partico<strong>la</strong>re: <strong>la</strong> tipologia e <strong>la</strong> modalità di costruzione di o<strong>per</strong>e<br />
e manufatti; lo svolgimento <strong>dell</strong>e attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;<br />
il soggiorno e <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; lo svolgimento di<br />
attività sportive, ricreative ed educative; lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e<br />
biosanitaria; i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<br />
in materia; lo svolgimento <strong>dell</strong>e attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di<br />
volontariato, con partico<strong>la</strong>re riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile alternativo;<br />
l'accessibilità nel territorio del parco attraverso <strong>per</strong>corsi e strutture idonee <strong>per</strong> disabili, portatori di<br />
handicap e anziani.<br />
Non è possibile <strong>per</strong> il Rego<strong>la</strong>mento del Parco disciplinare le problematiche di cui sopra senza una<br />
base conoscitiva e valutativa appropriata.<br />
Il piano potrà essere lo strumento di supporto ideale <strong>per</strong> assumere qualunque decisione rispetto alle<br />
questioni sopra elencate.<br />
3.2. Piano Pluriennale economico e sociale (L.394/91, art.14)<br />
Il Piano Pluriennale economico e sociale è e<strong>la</strong>borato dal<strong>la</strong> Comunità del Parco nel rispetto <strong>dei</strong><br />
vincoli stabiliti dal Piano e dal Rego<strong>la</strong>mento del Parco.<br />
Esso può prevedere: concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; predisposizione di<br />
attrezzature, impianti di depurazione e <strong>per</strong> il risparmio energetico; servizi ed impianti di carattere<br />
turistico-naturalistico; agevo<strong>la</strong>zione o promozione, anche in forma coo<strong>per</strong>ativa, di attività<br />
tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche; restauro, anche di<br />
beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto <strong>dell</strong>e esigenze di conservazione del<br />
parco, lo sviluppo del turismo e <strong>dell</strong>e attività locali connesse.<br />
Sarebbe auspicabile che le iniziative <strong>per</strong> <strong>la</strong> promozione economica e sociale venissero organizzate<br />
non solo "nel rispetto <strong>dei</strong> vincoli stabiliti dal piano" ma anche in stretto rapporto con il Piano <strong>per</strong> il<br />
Parco che oltretutto dovrà individuare sul territorio le aree preposte allo sviluppo ed al<strong>la</strong><br />
promozione economica e sociale (aree d).<br />
Nel <strong>per</strong>corso metodologico indicato nelle pagine seguenti re<strong>la</strong>tivamente al<strong>la</strong> costruzione del piano è<br />
stato inserito il confronto ed il raccordo con l'attuazione del piano pluriennale economico e sociale.<br />
Ciò dovrebbe avvenire sin dalle prime fasi <strong>dell</strong>'attività di piano con l'attivazione di un<br />
Coordinamento istituzionale ed in modo decisivo, al momento del<strong>la</strong> verifica.<br />
3.3. Misure d'incentivazione (L.394/91, art.7)<br />
Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco<br />
nazionale è attribuita priorità nel<strong>la</strong> concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, di alcuni interventi: restauro<br />
<strong>dei</strong> centri storici ed edifici di partico<strong>la</strong>re valore storico-culturale; recu<strong>per</strong>o <strong>dei</strong> nuclei abitati rurali;<br />
o<strong>per</strong>e igieniche ed idropotabili e di risanamento <strong>dell</strong>'acqua, <strong>dell</strong>'aria e del suolo; o<strong>per</strong>e di<br />
conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;<br />
attività culturali nei campi di interesse del parco; agriturismo; attività sportive compatibili; strutture<br />
<strong>per</strong> <strong>la</strong> utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas<br />
combustibili nonché interventi volti a a favorire l'uso di energie rinnovabili.<br />
Sarà dunque necessario "guidare" le politiche di incentivi e sviluppo <strong>per</strong> le aree protette previste<br />
dal<strong>la</strong> stessa Legge Quadro e da altre iniziative a livello locale e sovralocale (Programma triennale<br />
tute<strong>la</strong> ambientale, Fondi Strutturali). Si faccia riferimento, a solo titolo d'esempio, al<strong>la</strong> scelta <strong>dei</strong><br />
nuclei rurali, <strong>dei</strong> centri e <strong>dei</strong> manufatti storici da recu<strong>per</strong>are ed alle modalità che dovranno guidare<br />
le o<strong>per</strong>azioni di recu<strong>per</strong>o.<br />
Il piano <strong>per</strong> il parco dovrà fornire le indicazioni di base <strong>per</strong> i primi orientamenti in merito.<br />
4. Rapporti tra il piano del parco e gli altri strumenti del<strong>la</strong> pianificazione ordinaria e<br />
specialistica<br />
Il piano <strong>per</strong> il parco, pur mantenendo come pianificazione specialistica una propria autonomia<br />
valutativa e decisionale, interviene con partico<strong>la</strong>re incisività nel<strong>la</strong> definizione del sistema generale
<strong>dell</strong>e scelte sul territorio. Oltre a definire le condizioni <strong>dell</strong>e trasformazioni del sistema antropico e<br />
quindi ad intervenire sul<strong>la</strong> componente strutturale del<strong>la</strong> pianificazione, concorre in modo<br />
determinante anche a definire <strong>la</strong> componente programmatica, nel momento in cui organizza <strong>la</strong><br />
gestione del piano e fissa <strong>la</strong> scadenza <strong>dei</strong> principali obiettivi <strong>dell</strong>'attività di conservazione e<br />
valorizzazione (obiettivi a breve, medio e lungo termine).<br />
Oltretutto secondo <strong>la</strong> legge quadro sulle aree protette il piano <strong>per</strong> il parco ha effetto di<br />
"dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità <strong>per</strong> gli interventi in<br />
esso previsti, e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni<br />
altro strumento di pianificazione" (L.394/91, art.12, comma 7).<br />
Riteniamo opportuno interpretare tale stato di cogenza del piano <strong>per</strong> il parco rispetto agli agli altri<br />
piani, distinguendo due tipi di comportamento:<br />
• un'azione sostitutiva <strong>per</strong> le tematiche paesistiche, <strong>per</strong> quelle espressamente citate nell'art.12<br />
commi 1 e 2 del<strong>la</strong> L. 394/91 e <strong>per</strong> quelle emergenti a seguito <strong>dell</strong>e prime attività analitiche e<br />
valutative;<br />
• un'azione di indirizzo e coordinamento <strong>per</strong> tutti gli altri contenuti di piano al fine di<br />
assicurare comunque <strong>la</strong> necessaria compatibilità e coerenza <strong>dell</strong>'attività pianificatoria e<br />
programmatoria ai diversi livelli di governo del territorio.<br />
Si afferma dunque <strong>la</strong> necessità che l'attività di redazione del piano del parco si esplichi in concreta<br />
sinergia e rapporto di complementarietà con tutti gli altri enti preposti all'amministrazione ed al<strong>la</strong><br />
pianificazione ordinaria o di settore <strong>dell</strong>o stesso territorio.<br />
A tal fine sarebbe auspicabile <strong>la</strong> strutturazione di un coordinamento istituzionale capace di guidare<br />
le necessarie forme di raccordo tra il piano <strong>per</strong> il parco e gli altri strumenti del<strong>la</strong> pianificazione<br />
comunale e sovracomunale.<br />
5. Rapporti tra il piano <strong>per</strong> il parco ed il territorio 'oltre il parco'<br />
Come già sottolineato il piano <strong>per</strong> il parco stabilisce una stretta re<strong>la</strong>zione con le aree<br />
immediatamente limitrofe e più in generale con il grande sistema <strong>dell</strong>e bioconnessioni.<br />
La Legge Quadro prevede alcuni strumenti ed iniziative in grado di orientare, e talora<br />
rego<strong>la</strong>mentare, i suddetti rapporti (zone contigue, Carta del<strong>la</strong> natura, Programma triennale <strong>per</strong> le<br />
aree naturali protette).<br />
5.1. Zone contigue (L.394/91, art. 32)<br />
La legge Quadro prevede che le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione <strong>dell</strong>e aree naturali<br />
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscano "piani e programmi e le eventuali misure di<br />
disciplina del<strong>la</strong> caccia, del<strong>la</strong> pesca, <strong>dell</strong>e attività estrattive e <strong>per</strong> <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>dell</strong>'ambiente, re<strong>la</strong>tivi alle<br />
aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire <strong>per</strong> assicurare <strong>la</strong> conservazione <strong>dei</strong> valori e<br />
<strong>dell</strong>e aree protette stesse ...".<br />
Le attività conoscitive e valutative mirate al<strong>la</strong> redazione del piano, anche al fine di poter essere di<br />
supporto al<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disciplina <strong>per</strong> il territorio oltre confine ("zone contigue"),<br />
dovranno quindi mettere in luce l'artico<strong>la</strong>zione e <strong>la</strong> dinamicità degli ecosistemi e <strong>la</strong> complessa<br />
organizzazione <strong>dell</strong>e attività umane, evidenziando così" le connessioni tra il dentro ed il fuori e <strong>la</strong><br />
naturale estensione di fenomeni interni verso l'esterno e viceversa.<br />
A tal fine potrebbe risultare opportuno estendere il disegno del piano anche al di fuori del <strong>per</strong>imetro<br />
del parco organizzando l'attività di piano in una visione sistemica. Ciò <strong>per</strong>metterà di studiare e<br />
prevedere al meglio il rapporto tra il dentro ed il fuori, sdrammatizzando il problema <strong>dei</strong> confini.<br />
L'accentuazione <strong>dell</strong>e interconnessioni tra il dentro ed il fuori del parco non può comunque fare<br />
rinunciare al<strong>la</strong> valorizzazione "<strong>dell</strong>'identità, del<strong>la</strong> riconoscibilità e del<strong>la</strong> leggibilità del parco nel<strong>la</strong><br />
sua globalità, unitarietà e rappresentatività, rispetto al contesto territoriale".<br />
5.2. Carta del<strong>la</strong> natura (l.394/91, art. 3, comma 3)
La Carta del<strong>la</strong> Natura individua "lo stato <strong>dell</strong>'ambiente in Italia, evidenziando i valori naturali ed i<br />
profili di vulnerabilità territoriale"; <strong>per</strong>mette di identificare le linee fondamentali <strong>dell</strong>'assetto del<br />
territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali.<br />
Tale strumento <strong>per</strong>mette di stabilire effettive interazioni tra il livello del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> locale, quello<br />
nazionale e quello internazionale e <strong>per</strong>mette di andare oltre <strong>la</strong> valenza strettamente locale del<strong>la</strong><br />
protezione connettendo tra loro i <strong>parchi</strong> "in termini ecologici e funzionali".<br />
Sembra utile <strong>per</strong>tanto in fase di piano o<strong>per</strong>are anche con valutazioni e decisioni sovralocali, capaci<br />
di mettere in campo <strong>la</strong> concezione retico<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del patrimonio naturale e quindi <strong>la</strong> difesa, il<br />
potenziamento ed il recu<strong>per</strong>o del sistema <strong>dell</strong>e "bioconnessioni", alle diverse scale d'interventi<br />
possibili.<br />
5.3. Programma triennale <strong>per</strong> le aree naturali protette (L.394/91 art. 4)<br />
l Programma triennale <strong>per</strong> le aree naturali protette, sul<strong>la</strong> base <strong>dell</strong>e disponibilità finanziarie e sul<strong>la</strong><br />
base del<strong>la</strong> Carta del<strong>la</strong> natura, definisce:<br />
• quali saranno i territori che fanno parte del sistema <strong>dell</strong>e aree naturali protette d'interesse<br />
internazionale, nazionale e regionale;<br />
• il termine <strong>per</strong> l'istituzione di nuove aree naturali protette o <strong>per</strong> l'ampliamento e <strong>la</strong> modifica<br />
di quelle esistenti, individuando <strong>la</strong> delimitazione di massima <strong>dell</strong>e stesse;<br />
• il riparto <strong>dell</strong>e disponibilità finanziarie <strong>per</strong> ciascuna area e <strong>per</strong> ciascun esercizio finanziario,<br />
ivi compresi i contributi in conto capitale <strong>per</strong> l'esercizio di attività agricole compatibili,<br />
condotte con sistemi innovativi ovvero con recu<strong>per</strong>o di sistemi tradizionali, funzionali al<strong>la</strong><br />
protezione ambientale, <strong>per</strong> il recu<strong>per</strong>o ed il restauro <strong>dell</strong>e aree di valore naturalistico<br />
degradate, <strong>per</strong> il restauro e l'informazione ambientali.<br />
6. Tempi di redazione del piano<br />
La legge Quadro prevede che l'Ente Parco predisponga il piano entro sei mesi dal<strong>la</strong> sua istituzione<br />
(L.394/91, art.12, comma 3). Questa scelta del legis<strong>la</strong>tore, di porre tempi brevi <strong>per</strong> <strong>la</strong> redazione del<br />
piano, invita ad evitare quel<strong>la</strong> ricorrente tentazione di voler redigere un piano "unitario" tale da<br />
contenere al suo interno l'intero processo del<strong>la</strong> pianificazione.<br />
Certo il piano, attraverso <strong>la</strong> scelta degli obiettivi , finirà con orientare in modo diretto o indiretto,<br />
una rilevante fetta <strong>dell</strong>e attività umane. Ma questa constatazione non deve indurre a compiere<br />
l'errore di caricare il Piano di significati eccessivi sul piano economico-sociale, considerandolo il<br />
rimedio <strong>per</strong> ogni problema, e lo strumento di "recu<strong>per</strong>o" di tutti i ritardi urbanistici <strong>dell</strong>'area.<br />
Esso rappresenta uno <strong>dei</strong> momenti più significativi, ma non l'unico, del processo di pianificazione<br />
<strong>dell</strong>e aree protette; altri strumenti attuativi e gestionali intervengono ad integrazione <strong>dell</strong>'attività di<br />
piano.<br />
Ribadendo <strong>la</strong> necessità di <strong>per</strong>venire celermente al<strong>la</strong> redazione di questo primo strumento, si<br />
sottolinea <strong>per</strong>ò come il piano sia da intendere come parte di un più complesso "processo di<br />
pianificazione", che il "primo piano" (il piano <strong>dei</strong> sei mesi) avrebbe solo il compito di avviare<br />
ordinatamente e fertilmente.<br />
Questa affermazione, che nasce dal realismo normativo e dal<strong>la</strong> riflessione teorica contemporanea,<br />
consiglia di evitare il ricorso a mo<strong>dell</strong>i conoscitivi, valutativi e progettuali onnicomprensivi e rigidi<br />
(oltrechè temporalmente indeterminati) che generalmente richiedono costi e tempi elevati, e spesso<br />
<strong>la</strong>sciano <strong>la</strong> gestione vera e propria <strong>dell</strong>'area a ridosso (o in difesa) ai progetti di livello locale e/o<br />
sovralocale.<br />
7. Iter di approvazione del piano<br />
Il piano è predisposto dall'Ente Parco. L'iter di approvazione che potrebbe avere una durata<br />
massima di circa un anno si artico<strong>la</strong> cronologicamente nel seguente modo (L.394/91 art. 12 comma<br />
4):
• 1. entro 120 gg. dal<strong>la</strong> sua predisposizione è adottato dal<strong>la</strong> regione sentiti gli enti locali;<br />
• 2. entro i successivi 40 gg. è depositato presso le sedi <strong>dei</strong> comuni, comunità montane e<br />
regioni interessate;<br />
• 3. entro i successivi 40 gg. chiunque può presentare osservazioni scritte;<br />
• 4. entro i successivi 30 gg. l'Ente Parco esprime il proprio parere circa le osservazioni di cui<br />
al punto precedente;<br />
• 5. entro i successivi 120 gg. <strong>la</strong> regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e d'intesa<br />
con l'Ente Parco <strong>per</strong> quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2 e<br />
d'intesa, oltre che con l'Ente Parco, anche con i comuni interessati <strong>per</strong> quanto concerne le<br />
aree di cui al<strong>la</strong> lettera d) del medesimo comma 2), emana il provvedimento d'approvazione.<br />
Il legis<strong>la</strong>tore, prevede un procedimento partico<strong>la</strong>rmente artico<strong>la</strong>to e complesso dove <strong>la</strong> regione<br />
assume un ruolo centrale e comunque tutte le forze locali sono tenute in partico<strong>la</strong>re considerazione.<br />
Gli enti locali possono esprimere il loro parere in modo individuale o in modo collegiale, tramite <strong>la</strong><br />
Comunità del Parco in forza <strong>dell</strong>'art.10 comma 2 punto b (il parere del<strong>la</strong> Comunità del Parco è<br />
obbligatorio "sul piano <strong>per</strong> il parco di cui all'art.12").<br />
Gli enti locali, che rientrano nelle "aree di promozione economica e sociale", debbono dare<br />
l'assenso sul<strong>la</strong> definitiva approvazione del piano <strong>per</strong> quelle porzioni di territorio che rientrano in<br />
detta zona.<br />
Si nota <strong>per</strong>tanto <strong>la</strong> volontà del legis<strong>la</strong>tore di <strong>per</strong>venire, soprattutto <strong>per</strong> le aree più intensamente<br />
antropizzate, ad un confronto serrato con le comunità locali.<br />
In questa direzione, nel<strong>la</strong> proposta di <strong>la</strong>voro di seguito illustrata,va interpretata <strong>la</strong> previsione di<br />
momenti di confronto e raccordo con le politiche di sviluppo in fase di attuazione nell'area ed in<br />
partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> possibilità di creare un coordinamento istituzionale capace di seguire l'intero processo<br />
di piano, in rapporto dialogico e costruttivo con l'Ente Parco.<br />
8. Tempi di revisione ed aggiornamento<br />
È necessario prevedere tempi di revisione ed aggiornamento del piano abbastanza ravvicinati e<br />
quindi al di sotto <strong>dei</strong> dieci anni (considerato comunque come limite massimo) previsti dal<strong>la</strong> legge<br />
istitutiva, <strong>per</strong> due ordini di motivi:<br />
• 1. l'istituzione stessa del parco e quindi l'emanazione di una serie di atti preposti al<strong>la</strong><br />
conservazione determineranno repentini cambiamenti <strong>dell</strong>e dinamiche degli ecosistemi<br />
presenti e <strong>per</strong>tanto si creerano le premesse <strong>per</strong> una parziale riprogettazione <strong>dell</strong>'assetto<br />
territoriale;<br />
• 2. le revisioni frequenti e di ampiezza limitata aiuteranno a sdrammatizzare l'iter, già di <strong>per</strong><br />
sè complesso, <strong>dell</strong>'approvazione, facilitando l'ottenimento <strong>dell</strong>'ampio consenso necessario da<br />
parte degli enti locali, nel<strong>la</strong> consapevolezza che una norma sbagliata può essere in breve<br />
tempo e facilmente rimossa.<br />
C. Metodologia<br />
Nei <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> italiani dove, in analogia con molte altre aree protette europee, il territorio<br />
presenta un'ampia gamma di risorse naturali e di richieste sociali, il rapporto interattivo analisi -<br />
piano si dovrà strutturare in un ambito di competenze sempre più al<strong>la</strong>rgato ed artico<strong>la</strong>to e<br />
caratterizzato dall'interdisciplinarietà.<br />
Le caratteristiche basi<strong>la</strong>ri che dovranno contraddistinguere il <strong>per</strong>corso metodologico del processo di<br />
piano saranno dunque:<br />
• a. <strong>la</strong> ciclicità, che si esplica nel<strong>la</strong> costruzione di un processo di piano a<strong>per</strong>to, <strong>per</strong>fettibile ed<br />
aggiornabile, capace di consentire "reciproci aggiustamenti" <strong>dell</strong>'analisi e del piano, dal
primo approccio conoscitivo al<strong>la</strong> definizione <strong>dell</strong>'assetto <strong>dell</strong>'area. La ciclicità ed adeguate<br />
o<strong>per</strong>azioni di "feedback" devono guidare ed orientare tutte le attività di analisi, valutazione e<br />
proposta progettuale, evitando ogni passaggio meccanico "a cascata" dal momento analitico<br />
a quello decisionale ed ogni forma di determinismo ambientale che solo alcune forme iso<strong>la</strong>te<br />
di rigidezze pseudo-scientifiche continuano con tenacia a sostenere. Tutto ciò significa<br />
riconoscere una serie di rapporti interattivi tra le analisi, le valutazioni e le e<strong>la</strong>borazioni<br />
progettuali senza rinunciare <strong>per</strong>ò al<strong>la</strong> distinzione ed al<strong>la</strong> reciproca autonomia tra il momento<br />
analitico e quello propositivo, senza creare quindi confusione tra piano e conoscenza ed in<br />
partico<strong>la</strong>re senza delegare in alcun modo <strong>la</strong> responsabilità del<strong>la</strong> scelta progettuale;<br />
• b. l'approccio sistemico, che si esplica nel<strong>la</strong> opportunità di andare oltre <strong>la</strong> rigida<br />
c<strong>la</strong>ssificazione <strong>dei</strong> diversi settori disciplinari <strong>per</strong> analizzare e valutare i legami ed i mutui<br />
rapporti che intercorrono tra le molteplici componenti del<strong>la</strong> realtà territoriale. Tutto ciò<br />
presuppone un consistente impegno tecnico-scientifico di integrazione interdisciplinare tra i<br />
diversi sa<strong>per</strong>i coinvolti (da quelli <strong>dell</strong>'ecologo a quelli del geologo, del biologo, del<br />
pianificatore, del botanico, <strong>dell</strong>'architetto, del geografo, del paesaggista, ...) capace di<br />
evidenziare quel valore aggiunto rispetto al<strong>la</strong> somma <strong>dei</strong> sa<strong>per</strong>i, derivante dal<strong>la</strong> compresenza<br />
di valori diversi.<br />
Non esistono metodi col<strong>la</strong>udati di o<strong>per</strong>azioni interdisciplinari; il più <strong>dell</strong>e volte tutto si risolve<br />
nell'assemb<strong>la</strong>re le diverse analisi territoriali e nell'affidare <strong>per</strong>tanto al "coordinatore" <strong>la</strong> completa<br />
responsabilità del<strong>la</strong> sintesi <strong>dell</strong>e strategie d'intervento.<br />
La pianificazione <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> invece, ancor più di ogni altra es<strong>per</strong>ienza di organizzazione del<br />
territorio, necessita di efficaci politiche di tute<strong>la</strong> e sviluppo che difficilmente possono essere<br />
costruite senza una contestuale partecipazione degli es<strong>per</strong>ti di tutte le componenti naturali ed<br />
antropiche costituenti gli ecosistemi presenti.<br />
Sarà dunque opportuno s<strong>per</strong>imentare forme di <strong>la</strong>voro collegiali, ricercando accordi di linguaggio e<br />
di metodo, nonchè studiando criteri di valutazione <strong>dell</strong>e analisi raffrontabili. Considerato il costante<br />
rapporto dialettico fra conoscenza e strategia di intervento, è evidente che l'attività interdisciplinare<br />
dovrà interessare l'intero processo di pianificazione <strong>dell</strong>'area ivi compresa l'e<strong>la</strong>borazione di tutti gli<br />
strumenti attuativi essenziali soprattutto <strong>per</strong> <strong>la</strong> definizione <strong>dell</strong>e aree più intensamente antropizzate:<br />
"il progetto in senso <strong>la</strong>to, transdisciplinare, adottato da ogni settore" potrebbe divenire "lo strumento<br />
più fine <strong>per</strong> valutare <strong>la</strong> forma del piano sotto tutti i profili".<br />
Sul<strong>la</strong> base di tali premesse è possibile costruire un <strong>per</strong>corso metodologico artico<strong>la</strong>to in 5 fasi<br />
consequenziali ma con <strong>la</strong> facoltà da parte di ognuna di retroagire sulle altre.<br />
1. Approccio conoscitivo all'area<br />
È un momento preliminare ad ogni attività conoscitiva e <strong>per</strong>mette di orientare <strong>la</strong> metodologia<br />
analitica e valutativa.<br />
In questa fase vengono raccolti tutti gli studi e le ricerche utili ai fini del piano svolti sull'area<br />
oggetto di studio negli ultimi anni. Ciò al fine di evitare <strong>per</strong>dite di tempo e sprechi di risorse<br />
economiche <strong>per</strong> rifare indagini già esistenti.<br />
Quindi vengono individuate le specificità (risorse, caratteri e problemi) <strong>dell</strong>'area e le richieste<br />
sociali. Si delineano gli obiettivi del piano <strong>per</strong> il parco (e si costruisce <strong>la</strong> prima idea di parco) al fine<br />
di poter meglio delimitare il campo <strong>dell</strong>e analisi.<br />
In questa fase sarà necessario inoltre distinguere i confini amministrativi dai limiti del territorio da<br />
esaminare. Quest'ultimi infatti oltrepasseranno i confini previsti dal decreto istitutivo, includendo<br />
quei territori limitrofi che si rapportano e spesso completano gli ecosistemi presenti nell'area<br />
protetta. Tale al<strong>la</strong>rgamento <strong>dell</strong>'area è utile anche al fine di riconnettere <strong>la</strong> "rete ecologica" del parco<br />
coi sistemi di partico<strong>la</strong>re valore naturale del contesto territoriale.<br />
2. Raccolta e prima e<strong>la</strong>borazione dati: interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni
Si procede all'analisi <strong>dei</strong> diversi settori disciplinari cointeressati ordinati in tre sistemi (fisico,<br />
biologico ed antropico), corre<strong>la</strong>ti fra di loro.<br />
Vengono prese in esame le re<strong>la</strong>zioni esistenti all'interno di ciascun sistema e fra i diversi sistemi<br />
ordinate sul<strong>la</strong> base <strong>dell</strong>e problematiche prevalenti nell'area oggetto di studio e sul<strong>la</strong> base <strong>dei</strong><br />
tematismi indicati nell'art.12 del<strong>la</strong> L.394/91.<br />
Vengono "parametrizzate, pesate e valutate" (sul<strong>la</strong> base <strong>dei</strong> criteri di rappresentatività, tipicità,<br />
facilità di lettura, fragilità, rarità, rinnovabilità, naturalità, ...) le emergenze ambientali considerate<br />
nel loro ambito re<strong>la</strong>zionale.<br />
3. Interferenze nei tre sistemi (fisico biologico ed antropico)<br />
Vengono individuati, in ciascuno <strong>dei</strong> tre sistemi, gli interventi antropici già realizzati, o<br />
semplicemente previsti, che si pongono in un rapporto di conflittualità con <strong>la</strong> "naturalità" del sito<br />
interessato. Questo tipo di re<strong>la</strong>zione critica viene c<strong>la</strong>ssificato come interferenza.<br />
Le aree sedi di interferenze saranno oggetto di ulteriore approfondimento analitico, valutativo e<br />
progettuale.<br />
4. Sintesi valutativa <strong>dell</strong>e indagini settoriali<br />
Vengono individuate e valutate le unità ambientali, concepite come ambiti, riconoscibili <strong>per</strong> identità<br />
visuali e culturali, dove convivono componenti differenti ma interdipendenti. Tali unità d'ora<br />
innanzi sono denominate "unità di paesaggio", anche al fine di evidenziare <strong>la</strong> compresenza in esse<br />
di componenti non soltanto fisiche e biologiche, ma anche antropiche.<br />
Le connessioni di tipo funzionale (viste anche in previsione del<strong>la</strong> destinazione finale <strong>dell</strong>'area) che<br />
si vengono a creare fra le diverse "unità di paesaggio" orientano <strong>la</strong> delimitazione <strong>dei</strong> "complessi di<br />
unità di paesaggio": porzioni di territorio omogenee dal punto di vista funzionale.<br />
5. Ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> e norme <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
Dal<strong>la</strong> interpretazione <strong>dell</strong>e sintesi valutative e dall'esame <strong>dei</strong> complessi funzionali di unità di<br />
paesaggio è possibile <strong>per</strong>venire ad una prima "approssimazione di delimitazione" e bozza di<br />
normativa (<strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici).<br />
Ulteriori verifiche e correttivi (progetti speciali e progetti pilota, raccordo con il contesto territoriale<br />
e con gli strumenti urbanistici vigenti, raccordo con gli altri strumenti ed iniziative previste dal<strong>la</strong><br />
legge quadro, dibattito con gli attori locali ed ulteriori approfondimenti analitici) consentiranno di<br />
delimitare e di normare con accresciuto dettaglio le aree previste ai sensi <strong>dell</strong>'art.12, comma2 del<strong>la</strong><br />
L.394/91, le principali tematiche citate dal<strong>la</strong> stessa legge ed altre problematiche emerse a seguito<br />
<strong>dell</strong>'interpretazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni.<br />
L'ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> finale non sgorga in modo improvviso dalle e<strong>la</strong>borazioni <strong>dell</strong>'ultima fase;<br />
al contrario è frutto di un'implementazione progressiva <strong>dell</strong>'idea di parco originaria che si evolve<br />
secondo i seguenti passaggi: obiettivi iniziali definiti dall'ente parco (fase 1); strategie progettuali in<br />
risposta alle prime valutazioni re<strong>la</strong>zionali (fasi 2 e 3); connessioni funzionali in prospettiva di<br />
sistemi d'uso e fruizione di alcune aree (fase 4); approssimazione di delimitazione e normativa (fase<br />
5).<br />
In tal modo, pur mantenendo <strong>la</strong> distinzione più volte richiamata tra analisi-valutazione e piano, sarà<br />
opportuno considerare l'o<strong>per</strong>a degli analisti strettamente interconnessa con quel<strong>la</strong> <strong>dei</strong> progettisti,<br />
ipotizzando forme di e<strong>la</strong>borazione collegiale <strong>per</strong> ogni o<strong>per</strong>azione di pesatura e parametrizzazione<br />
<strong>dell</strong>e emergenze nel loro ambito re<strong>la</strong>zionale, comparazione valutativa <strong>dell</strong>e strategie, individuazione<br />
di conflitti e sinergie, traduzione <strong>dell</strong>e intenzioni e <strong>dell</strong>e idee in e<strong>la</strong>borazioni progettuali.<br />
D. Attività re<strong>la</strong>tive a ciascuna fase<br />
1. Approccio conoscitivo all'area<br />
Questa prima fase può essere considerata preliminare ad ogni attività conoscitiva organizzata.
Consiste in una presa di contatto con il territorio oggetto di studio <strong>per</strong> l'individuazione <strong>dell</strong>e sue<br />
caratteristiche ambientali generali, non soltanto ecologico-naturalistiche ma anche storico-culturali.<br />
Tale o<strong>per</strong>azione, essenziale al fine di orientare <strong>la</strong> metodologia analitica e valutativa <strong>per</strong>metterà di<br />
evitare <strong>per</strong>dite di tempo in tentativi di conoscenza esaustiva ed onnicomprensiva e di ordinare le<br />
diverse indagini settoriali sul<strong>la</strong> base <strong>dell</strong>e specificità emerse (risorse, caratteri e problemi).<br />
Le o<strong>per</strong>azioni da esplicare possono essere sinteticamente descritte come segue:<br />
• a. Definizione <strong>dei</strong> limiti <strong>dell</strong>'area oggetto di studio: sarà opportuno distinguere i confini<br />
amministrativi dai limiti del territorio da esaminare. Quest'ultimo probabilmente<br />
oltrepasserà iconfini previsti dal decreto istitutivo ed includerà quei territori limitrofi che si<br />
rapportano e spesso completano gli ecosistemi presenti nell'area protetta. Tale al<strong>la</strong>rgamento<br />
<strong>dell</strong>'area è utile anche al fine di mettere in contatto i sistemi di partico<strong>la</strong>re valore naturale<br />
interni al parco con quelli del territorio circostante;<br />
• b. Inquadramento biogeografico <strong>dell</strong>'area oggetto di studio: allo scopo di precisare le<br />
caratteristiche ambientali generali del territorio ove è stato istituito il parco, è necessario<br />
precisarne le caratteristiche biogeografiche; ciò può essere fatto in via preliminare<br />
riconoscendo a quale unità biogeografica appartiene il parco, a partire dalle unità di rango<br />
su<strong>per</strong>iore (regioni) fino a quelle inferiori (provincie, distretti e settori). Il territorio <strong>dell</strong>'Italia<br />
appartiene a due regioni biogeografiche e precisamente al<strong>la</strong> Regione Eurosiberiana e al<strong>la</strong><br />
Regione Mediterranea, a sua volta suddivise in diverse provincie, distretti e settori; ogni<br />
regione biogeografica presenta problemi ecologici specifici non soltanto re<strong>la</strong>tivamente al<strong>la</strong><br />
flora e al<strong>la</strong> fauna, ma anche al<strong>la</strong> stessa presenza <strong>dell</strong>'uomo, tipi di paesaggio, processi<br />
ecologici e così via;<br />
• c. Raccolta di studi e ricerche scientifiche, utili ai fini del piano, svolte sull'area oggetto<br />
d'intervento: <strong>la</strong> maggior parte <strong>dell</strong>e aree protette sono ricche di studi ed indagini realizzati da<br />
enti di ricerca e da singoli studiosi. Pertanto ogni futura attività conoscitiva non potrà<br />
ricominciare da zero di<strong>la</strong>pidando tempo e risorse economiche <strong>per</strong> rifare quanto già esiste.<br />
Un esame critico degli studi esistenti <strong>per</strong>mette di vagliare <strong>la</strong> completezza o <strong>la</strong> parzialità <strong>dell</strong>e<br />
indagini di cui si potrà disporre. Partico<strong>la</strong>re interesse acquistano anche le notizie re<strong>la</strong>tive alle<br />
proposte di carattere conservazionistico che hanno preceduto l'istituzione del parco<br />
(resoconti di congressi, re<strong>la</strong>zioni, ordini del giorno, articoli e contributi sul<strong>la</strong> stampa e sulle<br />
riviste specializzate), dalle quali si possono trarre utili indicazioni sui vari problemi di<br />
carattere ambientale che interessano il territorio del parco;<br />
• d. Prima ricognizione <strong>dell</strong>'area: prima di studiare in modo sistematico un territorio ai fini<br />
del<strong>la</strong> pianificazione, sarà necessario <strong>per</strong>correrlo, osservare ogni cosa e annotare quei segni e<br />
contenuti che emergono sin dal primo contatto con l'area oggetto di studio al fine di<br />
riconoscere le caratteristiche ambientali generali;<br />
• e. Stesura di una scheda <strong>dell</strong>e specificità <strong>dell</strong>'area capace di evidenziare: risorse, caratteri e<br />
problemi: è possibile evincere dai momenti precedenti i caratteri <strong>dell</strong>'area oggetto di studio;<br />
come vedremo nel<strong>la</strong> metodologia descritta, ogni azione conoscitiva, valutativa e decisionale<br />
è costruita su misura <strong>per</strong> i caratteri specifici <strong>dell</strong>'area e quindi <strong>per</strong> le sue problematiche più<br />
rilevanti;<br />
• f. Stesura del Documento Programmatico: è necessario conoscere con precisione le direttive<br />
"politiche" <strong>dell</strong>'ente che amministra l'area protetta prima di costruire ogni azione<br />
progettuale. Si tratterà di stendere un "Documento Programmatico" capace di sintetizzare<br />
una prima "idea di parco" e con essa una prima definizione degli obiettivi di breve, medio e<br />
lungo termine.<br />
L'idea di parco dovrà rifarsi ad alcuni valori universalmente riconosciuti: conservazione o ripristino<br />
degli equilibri esistenti; fruizione da parte del pubblico; sviluppo compatibile nelle aree più<br />
intensamente antropizzate; riconoscibilità del parco.
2. Raccolta e prima e<strong>la</strong>borazione dati: interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni<br />
Nel processo complesso e iterativo di e<strong>la</strong>borazione del piano di un Parco, gli studi scientifici sono<br />
del tutto indispensabili sia nel<strong>la</strong> fase <strong>dell</strong>'approccio conoscitivo che in quello degli approfondimenti<br />
successivi. L'intervallo di tempo re<strong>la</strong>tivamente corto nel quale deve emergere <strong>la</strong> prima ipotesi di<br />
<strong>zonizzazione</strong>, non <strong>per</strong>mette lo svolgimento di indagni esaustive. Pertanto, esse dovrebbero sfruttare<br />
in primo luogo tutti i dati bibliografici re<strong>la</strong>tivi al territorio del Parco e solo poi completare ed<br />
aggiornare le conoscenze, in modo da cogliere tutti gli aspetti essenziali e importanti ai fini di una<br />
corretta pianificazione e gestione.<br />
Soltanto <strong>per</strong> motivi didattici e logici, le brevi descrizioni <strong>dell</strong>e indagini scientifiche si presentano di<br />
seguito separate, <strong>per</strong> 3 grandi sistemi analizzati (fisico, biotico ed antropico) e poi, <strong>per</strong> settori<br />
disciplinari. In realtà, tutti gli studi scientifici si devono svolgere in una stretta corre<strong>la</strong>zione e<br />
coo<strong>per</strong>azione. Tale im<strong>per</strong>ativo è dettato anche dal<strong>la</strong> necessità di offrire al<strong>la</strong> fine una valutazione<br />
complessiva <strong>dell</strong>e qualità naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali del territorio analizzato.<br />
2.1. Sistema abiotico.<br />
2.1.1. Geologia, geomorfologia e idrogeologia.<br />
Una prima o<strong>per</strong>azione da svolgere riguarda l'inquadramento geologico generale <strong>dell</strong>' area del parco,<br />
collocata <strong>per</strong>ò in un più ampio contesto paleogeografico e geodinamico regionale. Successivamente<br />
si dovrà provvedere al<strong>la</strong> realizzazione di una carta geologica, corredata di profili e diagrammi,<br />
nonché di una descrizione accurata del<strong>la</strong> successione stratigrafica.<br />
Una prima o<strong>per</strong>azione da svolgere riguarda l'inquadramento geologico generale <strong>dell</strong>' area del parco,<br />
collocata <strong>per</strong>ò in un più ampio contesto paleogeografico e geodinamico regionale. Successivamente<br />
si dovrà provvedere al<strong>la</strong> realizzazione di una carta geologica, corredata di profili e diagrammi,<br />
nonché di una descrizione accurata del<strong>la</strong> successione stratigrafica.<br />
La carta geologica ha lo scopo di individuare e rappresentare i corpi rocciosi e i loro reciproci<br />
rapporti; essa costituisce <strong>la</strong> base <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di utilizzo pratico, cioè <strong>per</strong> <strong>la</strong> derivazione di carte<br />
tematiche, come <strong>la</strong> carta litotecnica e idrogeologica; serve, inoltre, <strong>per</strong> <strong>la</strong> evidenziazione e l'analisi<br />
<strong>dei</strong> fenomeni scientifici salienti e <strong>per</strong> <strong>la</strong> individuazione <strong>dell</strong>e emergenze.<br />
L'inquadramento geomorfologico <strong>dell</strong>'area riguarderà essenzialmente l'evoluzione del rilievo <strong>per</strong><br />
effetto <strong>dei</strong> fattori tettonici e climatici, l'influenza <strong>dell</strong>'assetto litostrutturale sul<strong>la</strong> morfogenesi, le<br />
forme ricorrenti (tettoniche, vulcaniche, di erosione, di accumulo) ed i processi morfogenetici<br />
recenti in atto. Dovrà anche essere prodotta una carta geomorfologica, con annessi profili e<br />
diagrammi a blocco.<br />
La carta geomorfologica di base deve illustrare in modo sintetico le forme del rilievo terrestre ed i<br />
depositi ad esse associati. Nel<strong>la</strong> fase di progettazione del parco può risultare di grande utilità un'<br />
analisi del territorio basata sul<strong>la</strong> scomposizione in gruppi di unità omogenee sotto l'aspetto<br />
gemorfologico, così da poterne valutare l'incidenza re<strong>la</strong>tiva, le partico<strong>la</strong>ri vocazioni e le limitazioni<br />
d'uso del suolo ad esse associate. Tale passaggio è indispensabile anche <strong>per</strong> l'individuazione <strong>dell</strong>e<br />
unità di paesaggio.<br />
Una tematica di partico<strong>la</strong>re rilevanza, sia <strong>per</strong> gli aspetti scientifici che <strong>per</strong> quelli applicativi, è quel<strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> acque su<strong>per</strong>ficiali e sotterranee. L'analisi idrogeologica <strong>dell</strong>'area destinata a parco dovrà<br />
prevedere un esame dettagliato <strong>dell</strong>'intero sistema idrografico su<strong>per</strong>ficiale e di tutti i punti di<br />
emergenza <strong>dell</strong>e acque sotterranee (sorgenti e pozzi).<br />
La carta idrogeologica costituisce <strong>la</strong> rappresentazione del<strong>la</strong> distribuzione <strong>dei</strong> tipi e gradi di<br />
<strong>per</strong>meabilità <strong>dell</strong>e rocce; è strettamente connessa con le carte litologiche, strutturali e<br />
gemorfologiche, in quanto <strong>la</strong> litologia, <strong>la</strong> tettonica e <strong>la</strong> morfologia influenzano <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione idrica<br />
sotterranea. Nel<strong>la</strong> carta idrogeologica è importante evidenziare le zone di ricarica, le direzioni di<br />
flusso e le emergenze.<br />
2.1.2. Climatologia
La su<strong>per</strong>fice re<strong>la</strong>tivamente ridotta <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> rispetto alle zone geografiche <strong>la</strong>titudinali, da<br />
una parte e, spesso, il loro ampio intervallo altitudinale, dall'altra, impone un'analisi climatologica<br />
del territorio a livello <strong>dei</strong> mesoclimi.<br />
Lo studio climatico presenta un'importanza partico<strong>la</strong>re in quanto il complesso di fattori climatici<br />
(climatopo) influisce in modo determinante sul<strong>la</strong> struttura floristica e faunistica, sulle caratteristiche<br />
<strong>dei</strong> suoli zonali, sull'uso del suolo, sul regime idrologico <strong>dei</strong> corsi d'acqua e sulle attività<br />
economiche.<br />
Ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> di un parco, lo studio climatologico è orientato verso l'aquisizione di dati<br />
re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> descrizione e cartografia <strong>dei</strong> mesoclimi, all'agressività degli estremi climatici<br />
(precipitazioni massime in 24 ore, forti ge<strong>la</strong>te, tem<strong>per</strong>ature massime canico<strong>la</strong>ri, siccità prolongate,<br />
ecc.) e alle emergenze di grande rilevanza biogeografica.<br />
L'individuazione <strong>dell</strong>e emergenze climatiche si basa soprattutto sul<strong>la</strong> comparsa di mesoclimi<br />
(topoclimi) extrazonali, cioè fuori del<strong>la</strong> normale zonalità climatica (<strong>la</strong>titudinale, altitudinale,<br />
lontananza dal mare, ecc.). Tali situazioni sono causate generalmente da una geomorfologia<br />
partico<strong>la</strong>re e sono facilmente evidenziabili mediante <strong>la</strong> cosiddetta vegetazione extrazonale. Altri<br />
casi di emergenza sono legati a condizioni idrogeomorfologiche partico<strong>la</strong>ri (<strong>la</strong>ghi, paludi, ecc.), ove<br />
sussistono topoclimi (microclimi) assai differenti dal mesoclima regionale.<br />
Allo scopo del<strong>la</strong> raccolta di dati climatici, si devono prendere in considerazione tutte le stazioni<br />
meteo che ottem<strong>per</strong>ano contemporaneamente le seguenti condizioni:<br />
• serie continue di osservazioni <strong>per</strong> una durata di almeno 30 anni, inclusi nel <strong>per</strong>iodo di<br />
riferimento ("normale");<br />
• immobilità del<strong>la</strong> stazione stessa durante il <strong>per</strong>iodo "normale";<br />
• ubicazione sul territorio del Parco oppure in aree limitrofe.<br />
Per ciascuna stazione meteo si devono raccogliere i seguenti dati: <strong>la</strong> posizione geografica (<strong>la</strong>titudine<br />
e longitudine), l'altitudine, le medie <strong>dell</strong>e tem<strong>per</strong>ature minime e massime mensili e <strong>la</strong> somma <strong>dell</strong>e<br />
quantità di precipitazioni mensili.<br />
Lo studio climatico deve concludersi con <strong>la</strong> rappresentazione cartografica e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva descrizione<br />
<strong>dei</strong> tipi climatici individuati, sempre in re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> geomorfologia e <strong>la</strong> vegetazione naturale. In<br />
questo senso, è molto rilevante evidenziare <strong>dell</strong>e soglie fitoclimatiche e i rapporti con <strong>la</strong> carta<br />
fitosociologica del<strong>la</strong> vegetazione potenziale.<br />
2.1.3. Pedologia<br />
Nel suo rapporto con le biocenosi terrestri, il suolo si costituisce come complesso di fattori edafici<br />
(edafotopo) ed, inoltre, come sopporto fisico (componente del<strong>la</strong> stazione). Il suolo, attraverso le sue<br />
proprietà fisico-bio-chimiche, condiziona il regime idrico, <strong>la</strong> composizione floristica del<strong>la</strong><br />
vegetazione, <strong>la</strong> struttura <strong>dell</strong>e zoocenosi e il modo di uso <strong>dei</strong> terreni.<br />
Ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> di un parco, lo studio pedologico del territorio mira all'acquisizione di<br />
dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> descrizione e cartografia <strong>dei</strong> tipi di suolo, al<strong>la</strong> potenzialità bioproduttiva (fertilità)<br />
<strong>dei</strong> suoli, al<strong>la</strong> predisposizione degli stessi ai processi naturali di degradazione (erosione pluviale o<br />
eolica, salinizzazione, impaludamento, ecc.) e alle emergenze meritevoli di protezione speciale.<br />
Le emergenze pedologiche derivano generalmente dal<strong>la</strong> rarità (re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> regione geografica<br />
circoscritta) e dall'età di alcuni tipi di suolo.<br />
Il primo caso riguarda <strong>la</strong> comparsa di suoli extrazonali, cioè formatisi sotto l'influenza di mesoclimi<br />
(topoclimi) extrazonali; questi suoli sostengono generalmente una vegetazione extrazonale di<br />
notevole interesse fitogeografico. Anche <strong>la</strong> comparsa sporadica di alcuni suoli azonali, come i suoli<br />
idromorfi, alomorfi, organici oppure i p<strong>la</strong>nosuoli possono costituire <strong>dell</strong>e emergenze, in quanto<br />
formano degli habitat partico<strong>la</strong>ri ospitanti biocenosi di notevole pregio naturalistico.<br />
Il secondo caso si riferisce ai paleosuoli, cioè suoli relitti che si sono formati in tempi geologici con<br />
condizioni climatiche diverse da quelle presenti.
La raccolta di dati pedologici si esegue mediante un campionamento <strong>dei</strong> suoli lungo transetti da<br />
<strong>per</strong>correre nel campo, secondo il metodo del circuito o <strong>dell</strong>e traverse parallele. Il primo metodo è<br />
utilizzato nelle zone montane e collinari, affinché i transetti possano intersecare tutte le forme di<br />
rilievo, tutti i substrati litologici e tutte le categorie di uso del suolo. Il secondo metodo è applicato<br />
nelle pianure, altipiani, ecc. e consiste nel<strong>la</strong> disposizione <strong>dei</strong> transetti in una rete rego<strong>la</strong>re. Lungo<br />
questi <strong>per</strong>corsi si stabiliscono i punti di prelievo di campioni di suolo, in modo tale da sorprendere<br />
tutta <strong>la</strong> diversità pedologica esistente; comunque <strong>la</strong> densità minima di tali punti si stabilisce a<br />
seconda del<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> cartografica adottata, del<strong>la</strong> complessità geomorfologica e del<strong>la</strong> diversità di uso<br />
del suolo.<br />
Assieme al prelievo di campioni da ciascun orizzonte pedogenetico di un dato profilo, si iscrivono<br />
anche alcuni dati direttamente rilevabili sul campo: pendenza, esposizione, altitudine, forma di<br />
microrilievo, profondità del suolo, spessore di ciascun orizzonte pedogenetico, proporzione di<br />
scheletro, ecc.<br />
Lo studio pedologico deve fornire come documento finale <strong>la</strong> carta <strong>dei</strong> tipi di suolo oppure <strong>dell</strong>e<br />
serie di suoli (complessi di unità tipologiche affini di suoli). La nota esplicativa allegata contiene <strong>la</strong><br />
descrizione di tutte le unità cartografiche di suoli, con informazioni sul<strong>la</strong> loro distribuzione in<br />
re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> geomorfologia, all'idrogeologia, al mesoclima, al<strong>la</strong> vegetazione naturale e all'uso<br />
antropico.<br />
2.2. Sistema biotico.<br />
2.2.1. Flora e vegetazione.<br />
La flora e <strong>la</strong> vegetazione costituiscono, da una parte, buoni indicatori generali <strong>dell</strong>o stato<br />
<strong>dell</strong>'ambiente e quindi l'approccio geobotanico si rileva utile nelle indagini <strong>per</strong> <strong>la</strong> pianificazione<br />
<strong>dell</strong>e aree protette; d'altra parte, sono proprio le specie e le associazioni vegetali che costituiscono il<br />
principale oggetto di protezione nei <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong>. Inoltre, lo studio geobotanico si rende<br />
necessario in quanto le fitocenosi sono determinanti <strong>per</strong> <strong>la</strong> struttura <strong>dell</strong>e zoocenosi e hanno nello<br />
stesso tempo un'influenza su alcune proprietà del suolo (qualità <strong>dell</strong>'humus, l'intensità del<strong>la</strong><br />
pedogenesi, ecc.).<br />
Ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> di un parco, l'indagine geobotanica si rende indispensabile in quanto<br />
fornisce dati riguardanti le emergenze floristiche e vegetazionali di interesse naturalistico e<br />
fitogeografico, le cenosi vegetali con importanti funzioni ecoprotettive, <strong>la</strong> ricostituzione <strong>dell</strong>e<br />
fitocenosi climax, il recu<strong>per</strong>o e <strong>la</strong> riqualificazione del paesaggio vegetale antropizzato, ecc.<br />
Le emergenze floristiche e vegetazionali da prendere in considerazione ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong><br />
sono le seguenti:<br />
• le specie rare ed endemiche;<br />
• gli alberi monumentali o legati ad eventi storico-culturali;<br />
• le fitocenosi appartenenti ad associazioni vegetali rare, endemiche oppure molto ridotte e in<br />
via di scomparsa;<br />
• le fitocenosi sviluppate in ambienti caratterizzati da fattori ecologici estremi <strong>per</strong> ciò che<br />
riguarda acqua, sali, calore, ecc., come torbiere, <strong>la</strong>gune salmastre, aree steppiche, stazioni<br />
rupestri, ecc., che ospitano specie fortemente specializzate.<br />
• le fitocenosi ad alta diversità specifica, tassonomica, ecc.<br />
La raccolta di dati floristici e vegetazionali si esegue mediante un'indagine da svolgere sul terreno,<br />
durante <strong>la</strong> quale si procede all'esecuzione di osservazioni sul<strong>la</strong> flora e di rilevamenti fitosociologici<br />
e cartografici. La scelta <strong>dei</strong> punti ove effettuare i rilievi fitosociologici si fa adottando il metodo di<br />
campionamento <strong>per</strong> zone, che sono dedotte dall'incrocio di più carte tematiche. Gli itinerari di<br />
rilevamento cartografico da <strong>per</strong>correre sul terreno si stabiliscono con il metodo <strong>dell</strong>e traverse<br />
parallele, costituite in gran parte da tratti <strong>per</strong>pendico<strong>la</strong>ri alle curve di livello.<br />
I dati acquisiti sul<strong>la</strong> flora e sul<strong>la</strong> vegetazione possono essere sintetizzati suggestivamente nelle carte<br />
floristiche e vegetazionali.
Le carte floristiche vengono generalmente e<strong>la</strong>borate <strong>per</strong> le specie rare, endemiche, di interesse<br />
fitogeografico e minacciate di estinzione, che necessitano di una partico<strong>la</strong>re attenzione <strong>per</strong> <strong>la</strong> loro<br />
conservazione.<br />
La carta fitosociologica del<strong>la</strong> vegetazione reale acquista il significato di censimento <strong>dell</strong>e<br />
associazioni vegetali e <strong>per</strong>tanto, costituisce il primo gradino di qualsiasi indagine successiva.<br />
La carta fitosociologica del<strong>la</strong> vegetazione potenziale si presta in modo partico<strong>la</strong>re al<strong>la</strong> separazione<br />
<strong>dei</strong> tipi fitoclimatici, al<strong>la</strong> valutazione <strong>dell</strong>e destinazioni d'uso e ad indirizzare correttamente le<br />
azioni di ripristino del<strong>la</strong> vegetazione.<br />
La carta fitosociologica integrata costituisce un primo livello di integrazione al<strong>la</strong> fitosociologia<br />
paesaggistica e quindi consentono <strong>la</strong> rappresentazione del<strong>la</strong> co<strong>per</strong>tura vegetale attuale nel<strong>la</strong> sua<br />
prospettiva di sviluppo e <strong>la</strong> valutazione <strong>dell</strong>'antropizzazione del territorio studiato.<br />
2.2.2. Fauna<br />
La tendenza degli animali ad occultarsi, a distribuirsi nello spazio disponibile o a formare<br />
assembramenti molto localizzati, fa sì che solo eccezionalmente essi possano imprimere un<br />
carattere partico<strong>la</strong>re ad un ambiente.<br />
L'elevato numero di specie animali presenti, spesso nell'ordine <strong>dell</strong>e decine di migliaia anche in un<br />
territorio di limitate dimensioni come un Parco, fa sì che le indagini faunistiche siano limitate<br />
generalmente ai Vertebrati. I ritmi stagionali e annuali di tali pecie animali e <strong>la</strong> loro mobilità<br />
rendono piuttosto difficili gli studi faunistici, <strong>per</strong>ò <strong>la</strong> necessità di compierli è messa in evidenza dai<br />
complessi rapporti trofici tra i fitofagi e <strong>la</strong> vegetazione e, non <strong>per</strong> l'ultimo, dal grande valore<br />
economico, ludico, estetico e naturalistico del<strong>la</strong> fauna.<br />
Pertanto, ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> di un Parco, lo studio faunistico si propone di acquisire dati sul<strong>la</strong><br />
diversità specifica, sul<strong>la</strong> distribuzione e grandezza <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni e sulle emergenze di elevato<br />
interesse naturalistico e zoogeografico.<br />
L'individuazione <strong>dell</strong>e emergenze faunistiche è orientata soprattutto verso le specie rare, endemiche<br />
oppure minacciate di estinzione.<br />
La protezione <strong>dell</strong>e specie selvatiche e l'incremento <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni fortemente ridotte nei loro<br />
effettivi dipende anche dagli ampi collegamenti tra ambienti ben preservati mediante i cosiddetti<br />
corridoi biotici. Perciò, una <strong>dell</strong>e esigenze fondamentali <strong>per</strong> realizzare una tute<strong>la</strong> faunistica<br />
efficiente è ripristinare tale continuità ambientale, soprattutto nei territori fortemente interessati<br />
dal<strong>la</strong> trasformazione agrico<strong>la</strong>.<br />
La fonte principale di dati faunistici è data dai censimenti, che <strong>per</strong>mettono di fare una valutazione<br />
numerica <strong>dell</strong>e dimensioni <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni animali. Numerose sono le metodologie utilizzate<br />
re<strong>la</strong>tive sia a censimenti completi che a censimenti campione: conteggio semplice di animali o<br />
tracce, conteggi al canto, in battuta, con fotografia, con registrazioni o stimo<strong>la</strong>zioni <strong>dell</strong>e<br />
vocalizzazioni (p<strong>la</strong>yback), ecc. Un'altra categoria è rappresentata dai censimenti <strong>per</strong> indici (conteggi<br />
o rapporti re<strong>la</strong>tivi al numero totale di animali in una determinata popo<strong>la</strong>zione), tra i quali i più usati<br />
sono gli Indici puntiformi (I.P.A.), gli Indici chilometrici (I.C.A.) e gli Indici temporali (I.T.A.).<br />
Oltre ad altri e<strong>la</strong>borati, lo studio faunistico si propone di sintetizzare i risultati sotto forma di carte<br />
faunistiche.<br />
Carte corologiche<br />
Su tali mappe, <strong>la</strong> distribuzione <strong>dell</strong>e singole specie viene rappresentata mediante una o più curve<br />
chiuse di "limite assoluto" oppure mediante una simbologia adatta ai reticoli convenzionali usati <strong>per</strong><br />
suddividere il territorio del Parco.<br />
Carte <strong>dell</strong>e vocazioni faunistiche<br />
Su queste carte vengono delimitate zone faunistiche omogenee, cioè porzioni del territorio che<br />
offrono uguale potenzialità di sopravvivenza al<strong>la</strong> selvaggina in base a criteri di produttività teorica e<br />
capacità portante. A tali zone faunistiche omogenee si assegnano punteggi di vocazione <strong>per</strong> ogni<br />
singo<strong>la</strong> specie, considerando le esigenze ecologiche di ognuna di esse, <strong>la</strong> compatibilità con le<br />
attività umane, le re<strong>la</strong>zioni interspecifiche ed il loro valore naturalistico.
2.3. Sistema antropico2.3.1. Uso del suolo<br />
L'uso del suolo viene comunemente indicato come l'analisi <strong>dell</strong>'utilizzazione del territorio, che mira<br />
soprattutto al<strong>la</strong> ripartizione territoriale <strong>dell</strong>e varie categorie di utilizzo e <strong>la</strong> loro c<strong>la</strong>ssificazione in<br />
c<strong>la</strong>ssi di produttività potenziale.<br />
La varietà degli usi agro-silvo-pastorali dipende sia dal<strong>la</strong> diversità <strong>dell</strong>e condizioni<br />
geomorfologiche, idrologiche, pedologiche e climatiche del territorio che dal<strong>la</strong> gamma di attività<br />
socio-economiche e di tradizioni storico-colturali proprie <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni locali.<br />
L'uso del suolo può condizionare le proprietà morfo-fisico-chimiche <strong>dei</strong> suoli, <strong>la</strong> struttura <strong>dell</strong>e<br />
fitocenosi e zoocenosi sostenute, <strong>la</strong> predisposizione <strong>dei</strong> terreni al<strong>la</strong> degradazione (erosione pluviale<br />
ed eolica, deposizione di alluvioni non fertili in seguito alle inondazioni, salinizzazione, ecc.) e<br />
talvolta pure le tendenze di evoluzione <strong>dell</strong>e attività socio-culturali e economiche <strong>dell</strong>e comunità<br />
umane locali.<br />
Ai fini del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong>, lo studio analitico <strong>dell</strong>'uso del suolo può rilevare dati<br />
importanti re<strong>la</strong>tivi alle attività umane tradizionali, al<strong>la</strong> produttività biologica (fitomassa) degli<br />
ecosistemi, al dinamismo del paesaggio semi-naturale e antropico e così via.<br />
Le emergenze riguardanti l'uso del suolo si limitano generalmente alle attività agro-pastorali<br />
tradizionali e specifiche <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni umane locali, che devono <strong>per</strong>ò ottem<strong>per</strong>are due<br />
condizioni fondamentali: avere una notevole rilevanza storico-culturale ed essere compatibili con le<br />
finalità protezionistiche del parco.<br />
I dati essenziali da raccogliere <strong>per</strong> ciascuna categoria principale di uso del suolo sono i seguenti:<br />
• Colture agrarie: su<strong>per</strong>fice occupata a seconda del<strong>la</strong> specie coltivata, del<strong>la</strong> densità <strong>dell</strong>e<br />
piante, del regime di irrigazione, del sistema di fertilizzazione, del<strong>la</strong> durata del ciclo<br />
colturale, <strong>dell</strong>'epoca di instal<strong>la</strong>zione, <strong>dell</strong>'età, del<strong>la</strong> produttività, ecc.<br />
• Arbusteti: su<strong>per</strong>fice occupata a seconda del<strong>la</strong> composizione floristica, <strong>dell</strong>'origine,<br />
<strong>dell</strong>'altezza media, del grado di ricoprimento, ecc.<br />
• Boschi: su<strong>per</strong>fice, categoria attitudinale, origine, regime di governo, tipo strutturale, indice<br />
di co<strong>per</strong>tura, composizione specifica <strong>per</strong>centuale <strong>dell</strong>o strato arboreo, incremento medio<br />
annuo, età media (<strong>per</strong> specie), diametro medio (<strong>per</strong> specie), altezza media (<strong>per</strong> specie) ed<br />
altezza dominante (<strong>per</strong> specie) <strong>per</strong> ciascuna particel<strong>la</strong> forestale.<br />
• Aree prative: su<strong>per</strong>fice, regime di governo, origine, indice di co<strong>per</strong>tura, composizione<br />
floristica, frequenza re<strong>la</strong>tiva <strong>dell</strong>e specie componenti, regime di irrigazione e fertilizzazione,<br />
produttività media annua di fitomassa <strong>per</strong> ciascuna parcel<strong>la</strong>.<br />
• Specchi d'acqua stagnante: su<strong>per</strong>fice occupata a seconda del livello trofico, del regime<br />
annuo di piene e magra, <strong>dell</strong>'origine.<br />
• Terreni nudi: su<strong>per</strong>fice occupata a seconda del tipo.<br />
• Aree urbane: numero <strong>dell</strong>e località, su<strong>per</strong>fice occupata, <strong>per</strong>centuale <strong>dell</strong>e zone verdi, numero<br />
di abitanti, <strong>per</strong>manenza degli abitanti.<br />
Il principale obiettivo di questa indagine è rappresentato dal<strong>la</strong> carta <strong>dell</strong>'uso del suolo, assieme ad<br />
una breve descrizione di ciascuna categoria di utilizzo, che dovrebbe includere i rapporti con <strong>la</strong><br />
geomorfologia, il tipo di suolo stesso, <strong>la</strong> vegetazione (naturale e artificiale), <strong>la</strong> fauna e le tradizioni<br />
socio-economiche <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni locali.<br />
2.3.2. Patrimonio storico culturale.<br />
L'analisi del patrimonio storico culturale prende in esame tutti quegli elementi sedimentati<br />
nell'evoluzione storica <strong>dell</strong>e società che hanno determinato <strong>la</strong> strutturazione del territorio e che<br />
possono andare dai primi significativi insediamenti e <strong>per</strong>correnze ai preziosi sistemi organizzativi<br />
degli antichi coltivi, dalle prime attività produttive agli usi e costumi consolidati nelle diverse<br />
tradizioni locali.<br />
Tali approfondimenti analitici, valutati in corre<strong>la</strong>zione con le realtà fisico naturalistiche,<br />
costituiranno <strong>la</strong> base <strong>per</strong> organizzare "metodi di gestione e restauro ambientale idonei a realizzare
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante <strong>la</strong> salvaguardia <strong>dei</strong> valori<br />
antropologici, archeologici, storici e architettonici e <strong>dell</strong>e attività agro silvo pastorali tradizionali"<br />
(L.394/91, art.1, comma3).<br />
L'analisi del patrimonio storico culturale interessa tre principali settori di approfondimento:<br />
• a. <strong>la</strong> lettura <strong>dell</strong>e tracce estese in modo piuttosto omogeneo nel<strong>la</strong> trama <strong>dell</strong>'organizzazione<br />
territoriale (<strong>per</strong>corsi, insediamenti e paesaggio agrario);<br />
o I. Tracce estese - Percorsi - Il sistema <strong>dei</strong> <strong>per</strong>corsi rappresenta una <strong>dell</strong>e prime tracce<br />
<strong>la</strong>sciate dall'uomo sul territorio <strong>per</strong>chè l'organizzazione <strong>dell</strong>e <strong>per</strong>correnze precede <strong>la</strong><br />
realizzazione di ogni altra struttura produttiva o insediativa.Tramite l'esame <strong>dell</strong>o<br />
sviluppo <strong>dei</strong> collegamenti, si rilevano le re<strong>la</strong>zioni di un dato territorio con gli ambiti<br />
contermini e <strong>la</strong> logica che ha guidato <strong>la</strong> localizzazione <strong>dei</strong> punti nodali, <strong>dell</strong>e<br />
infrastrutture e <strong>dei</strong> centri di aggregazione lungo le principali direttrici territoriali. Lo<br />
studio <strong>dei</strong> <strong>per</strong>corsi organizzati sin dall'antichità renderà più agevole <strong>per</strong>cepire il<br />
significato <strong>dell</strong>'attuale gerarchia <strong>dei</strong> <strong>per</strong>corsi e quindi le connessioni con i processi<br />
insediativi; <strong>per</strong>metterà inoltre di orientare le scelte sul potenziamento e <strong>la</strong><br />
valorizzazione di alcuni attuali <strong>per</strong>corsi o <strong>la</strong> chiusura e <strong>la</strong> trasformazione di altri.<br />
o II. Tracce estese - Insediamenti - Le strutture insediative, realizzate dall'uomo <strong>per</strong><br />
soddisfare dapprima <strong>la</strong> semplice esigenza di un ricovero temporaneo e poi di spazi<br />
sempre più specialistici <strong>per</strong> abitare, produrre e commerciare, rappresentano un altro<br />
segno storicamente impresso nel territorio. L'indagine conoscitiva del sistema<br />
insediativo dovrà concorrere ad individuare:<br />
gli aspetti qualitativi che caratterizzano "le connessioni fra un determinato<br />
insediamento ed un determinato uso del suolo" (unità insediative)<br />
re<strong>la</strong>tivamente ai seguenti ambiti: prevalentemente non insediato, con<br />
insediamenti sparsi o diffusi, nuclei insediativi e tessuti urbani;<br />
i rapporti tra gli elementi che compongono l'edificato (tessuto edilizio) ed in<br />
partico<strong>la</strong>re: edificio-lotto, edificio-<strong>per</strong>corso, edificio-edificio, edificiofunzioni<br />
e spazi po<strong>la</strong>rizzanti;<br />
gli elementi base <strong>dell</strong>'edilizia che, all'interno di una determinata area e di un<br />
determinato <strong>per</strong>iodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione<br />
comuni (tipi edilizi) e si concretizzano in : partico<strong>la</strong>ri scelte ed utilizzo di<br />
materiali, composizioni sul<strong>la</strong> base di predefiniti schemi strutturali,<br />
organizzazione di partico<strong>la</strong>ri impianti distributivi, partico<strong>la</strong>ri soluzioni<br />
formali e decorative. Tali elementi contribuiscono al<strong>la</strong> definizione di un<br />
"linguaggio edilizio" le cui "regole grammaticali" dovranno essere ben<br />
conosciute da chiunque intenda rapportarsi correttamente con l'insediamento<br />
di un determinato ambito.<br />
Per avere dunque una prima conoscenza del<strong>la</strong> struttura insediativa potrebbe<br />
essere opportuno procedere allo studio p<strong>la</strong>nimetrico (anche sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong><br />
ricerca archivistica e <strong>dell</strong>'esame cartografico) ed al<strong>la</strong> schedatura <strong>dei</strong> nuclei<br />
urbani e rurali e di alcuni singoli edifici campione.<br />
o III. Tracce estese - Paesaggio agrario - È diffusa nel panorama italiano una vasta<br />
gamma di paesaggi, variabili <strong>per</strong> il variare <strong>dell</strong>e condizioni climatiche e ambientali,<br />
ma anche in corre<strong>la</strong>zione con l'evoluzione tecnica e sociale del<strong>la</strong> cultura locale.<br />
Molto spesso il paesaggio agrario è originato dal<strong>la</strong> "naturale" estensione<br />
<strong>dell</strong>'organizzazione urbana sul territorio extraurbano ed è possibile ancora leggere<br />
nel tessuto territoriale come spesso <strong>la</strong> città ha imposto i caratteri e l'aspetto del<br />
paesaggio circostante. Oltre a questo, numerosi altri eventi nel campo socio<br />
economico e <strong>dell</strong>e tecnologie hanno segnato <strong>la</strong> storia del paesaggio agrario italiano.<br />
Nell'esame del paesaggio agrario sarà opportuno individuare, mediante indagine
cartografica e fotografica, storica ed attuale, ed opportuni rilievi sul posto, le tracce<br />
<strong>dell</strong>e passate organizzazioni territoriali. La lettura del<strong>la</strong> variegata trama del<br />
paesaggio agrario, ivi comprese le espressioni <strong>dei</strong> molteplici e differenti caratteri<br />
storici ancora rinvenibili, <strong>per</strong>metterà di orientare <strong>la</strong> gestione <strong>dei</strong> "nuovi" paesaggi da<br />
sottrarre al<strong>la</strong> generale semplificazione ed omologazione <strong>dei</strong> processi<br />
d'industrializzazione contemporanei.<br />
• b. <strong>la</strong> lettura <strong>dell</strong>e tracce puntiformi, iso<strong>la</strong>te, talvolta monumentali (elementi iso<strong>la</strong>ti di valore<br />
paesistico, architettonico ed archeologico);<br />
o Il territorio risulta connotato da una serie limitata di tipi edilizi, di tipi di uso del<br />
suolo, di tipi di sistemazioni agrarie, ecc.<br />
o Suddetti elementi base sono <strong>per</strong>ò presenti, il più <strong>dell</strong>e volte, nel<strong>la</strong> molteplicità <strong>dell</strong>e<br />
loro varie accezioni.<br />
o È possibile individuare, tra le diverse specializzazioni, elementi di partico<strong>la</strong>re<br />
valenza paesistica, architettonica ed archeologica, iso<strong>la</strong>ti rispetto al contesto<br />
territoriale.<br />
o Sono elementi che presentano caratteristiche formali ed evolutive eccezionali, non<br />
hanno una diffusione costante sull'intera area, mantengono rapporti con l'organismo<br />
territoriale di cui fanno parte e concorrono a formare l'immagine paesistica del<br />
territorio.<br />
o Sono localizzati in punti quasi sempre strategici rispetto al sistema <strong>dell</strong>e <strong>per</strong>correnze,<br />
degli insediamenti e <strong>dell</strong>'organizzazione <strong>dei</strong> poderi.<br />
o All'interno del singolo manufatto edilizio mantengono pure un ruolo ed un<br />
significato partico<strong>la</strong>ri.<br />
o La lettura <strong>dell</strong>e tracce puntiformi è di grande importanza nell'esame <strong>dell</strong>e gerarchie<br />
territoriali e nell'individuazione <strong>dell</strong>e emergenze da tute<strong>la</strong>re.<br />
• c. l'esame degli aspetti del<strong>la</strong> storia e del<strong>la</strong> cultura locale che, in modo diretto o indiretto<br />
hanno orientato l'organizzazione del territorio (storia civile e religiosa, leggende, usanze,<br />
tradizioni, prodotti tipici locali, ...). In quasi tutto il territorio italiano ed in modo partico<strong>la</strong>re<br />
nelle aree destinate al<strong>la</strong> protezione speciale <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> è radicato un forte senso del<strong>la</strong> cultura<br />
locale che si estrinseca in tradizioni, usanze e modi di vita. Sono importanti ai fini del<strong>la</strong><br />
<strong>zonizzazione</strong> <strong>dell</strong>'area, e quindi <strong>dell</strong>'organizzazione <strong>dell</strong>e attività umane, tutti quei re<strong>per</strong>ti<br />
culturali che intervengono nel<strong>la</strong> <strong>per</strong>cezione collettiva del territorio e che hanno<br />
caratterizzato <strong>la</strong> presenza storica <strong>dell</strong>'uomo sull'area oggetto di studio.<br />
Suddette peculiarità sono rinvenibili approfondendo i seguenti settori d'indagine:<br />
o storia civile e religiosa;<br />
o tradizioni <strong>la</strong>iche e religiose;<br />
o artigianato locale;<br />
o produzioni tipiche locali;<br />
o toponimi;<br />
o luoghi storici;<br />
o luoghi di culto popo<strong>la</strong>re e pellegrinaggio;<br />
o <strong>per</strong>corsi storici e religiosi;<br />
o culture alloglotte.<br />
2.3.3. Aspetti urbanistico - infrastrutturali e giuridico - amministrativi<br />
La maggior parte <strong>dell</strong>e aree protette italiane ricade in aree antropizzate dove si intrecciano<br />
numerose politiche pubbliche, alcune già attuate, altre in corso di attuazione, altre ancora<br />
semplicemente previste.
L'analisi degli aspetti urbanistico infrastrutturali e giuridico amministrativi prendendo in esame<br />
l'organizzazione attuale del territorio e le previsioni di piani e programmi urbanistici vigenti<br />
rappresenta <strong>la</strong> base conoscitiva fondamentale <strong>per</strong> costruire gli opportuni raccordi tra il piano del<br />
parco e gli altri strumenti urbanistici che già rego<strong>la</strong>no l'area o quelli semplicemente in corso di<br />
redazione.<br />
L'esame degli aspetti urbanistico infrastrutturali e giuridico amministrativi interessa diversi campi<br />
d'indagine:<br />
a. lo stato degli impianti, infrastrutture e servizi esistenti;<br />
Gli impianti, le infrastrutture ed i servizi rappresentano i capisaldi <strong>per</strong> l'organizzazione <strong>dell</strong>o spazio<br />
utilizzato dall'uomo; contribuiscono al<strong>la</strong> gerarchizzazione del territorio, esercitando un forte "grado<br />
di attrazione" sulle aree circostanti.<br />
Le indagini sullo stato <strong>dei</strong> servizi sono strettamente connesse allo stato effettivo <strong>dei</strong> fabbisogni del<strong>la</strong><br />
popo<strong>la</strong>zione che ivi risiede, in modo <strong>per</strong>manente o temporaneo, nei vari <strong>per</strong>iodi <strong>dell</strong>'anno.<br />
Sono evidenti quindi le interconnessioni esistenti con le dinamiche demografiche e socio<br />
economiche, e naturalmente con i piani e programmi urbanistici in atto nell'area. Le indagini<br />
dovranno fornire un panorama complessivo <strong>dell</strong>'intera gamma degli impianti, infrastrutture e<br />
servizi, pubblici e privati, esaminando nel dettaglio solo quelli direttamente interessati<br />
dall'istituzione <strong>dell</strong>'area protetta.<br />
Il piano del parco infatti, nel momento in cui disciplina l'organizzazione generale del territorio, e <strong>la</strong><br />
sua differenziazione in aree o parti caratterizzate da forme diverse di uso, godimento e tute<strong>la</strong>, dovrà<br />
prendere in considerazione tutto il sistema <strong>dei</strong> servizi e infrastrutture esistenti ed in partico<strong>la</strong>re:<br />
• l'accessibilità veico<strong>la</strong>re e pedonale, con partico<strong>la</strong>re riguardo ai <strong>per</strong>corsi, accessi e strutture<br />
riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;<br />
• i sistemi di attrezzature e servizi <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione e <strong>la</strong> funzione sociale del parco, musei, centri<br />
visita, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche.<br />
• Le indagini dovranno fornire l'ubicazione, le qualità tecniche e lo stato di conservazione<br />
<strong>dell</strong>e infrastrutture esistenti al fine di poter prevedere <strong>la</strong> continuità <strong>dell</strong>'utilizzo di alcune e <strong>la</strong><br />
riconversione di altre <strong>per</strong> attività confacenti coll' istituzione <strong>dell</strong>'area protetta. Dovrà inoltre<br />
essere indicato il bacino d'utenza <strong>dell</strong>e infrastrutture e <strong>dei</strong> servizi tenendo presente che<br />
alcuni di essi hanno influenze più o meno dirette su un territorio decisamente più esteso<br />
rispetto a quello direttamente interessato dall'istituzione <strong>dell</strong>'area protetta e necessitano<br />
<strong>per</strong>tanto d'indagini più al<strong>la</strong>rgate capaci di coinvolgere realtà di governo sovralocali.<br />
b. le previsioni di assetto <strong>dell</strong>'intero territorio (urbano ed extraurbano) come risulta dai<br />
programmi e dai piani generali, partico<strong>la</strong>reggiati e di settore vigenti;<br />
La legge generale urbanistica italiana (L.n.1150/42) ha individuato diversi livelli di pianificazione<br />
(dai piani territoriali di coordinamento ai piani partico<strong>la</strong>reggiati); in realtà, a distanza di mezzo<br />
secolo è possibile constatare che gli unici strumenti effettivamente o<strong>per</strong>ativi sono stati: i P.R.G.<br />
comunali (o i Programmi di fabbricazione, <strong>per</strong> i comuni ancora sprovvisti di P.R.G.) ed i piani<br />
attuativi.<br />
Negli ultimi anni alcune apposite normative (D.M.431/85, L.183/89, L.142/90, L.394/91) hanno<br />
ri<strong>la</strong>nciato <strong>la</strong> pianificazione sovracomunale e <strong>la</strong> pianificazione di settore avviando <strong>la</strong><br />
s<strong>per</strong>imentazione di "nuovi" strumenti urbanistici. Il piano <strong>per</strong> il parco, da concepire come un piano<br />
di area vasta, interessa comprensori intercomunali, interprovinciali e talvolta interregionali; o<strong>per</strong>a in<br />
un ambito territoriale soggetto a diversi livelli di amministrazione, piani e programmi.<br />
E' opportuno che il piano <strong>per</strong> il parco, garantendo l'obiettivo finale del<strong>la</strong> "conservazione e<br />
valorizzazione del patrimonio naturale" si raccordi, ed eventualmente si completi, con gli altri<br />
strumenti urbanistici e con le diverse politiche di sviluppo in corso di attuazione, o semplicemente<br />
in fase di studio.
A tal fine, limitatamente all'area protetta ed al suo hinter<strong>la</strong>nd, sarà necessario conoscere i contenuti<br />
di piani e programmi esistenti mediante l'esame <strong>dei</strong> più significativi strumenti urbanistici:<br />
• a livello comunale (piano rego<strong>la</strong>tore generale comunale, piano partico<strong>la</strong>reggiato, piano di<br />
edilizia economica e popo<strong>la</strong>re, piano di insediamenti produttivi e piano di recu<strong>per</strong>o);<br />
• a livello sovracomunale (piano territoriale di coordinamento, piano paesistico e piano di<br />
bacino);<br />
• In aggiunta ai contenuti degli strumenti urbanistici vanno presi in esame anche tutti quei<br />
progetti e politiche di sviluppo a livello comunale, intercomunale, regionale, nazionale ed in<br />
partico<strong>la</strong>re quelli a livello europeo che interessano in modo rilevante porzioni di territorio<br />
nazionale considerate "marginali o depresse" ed economicamente più svantaggiate e di<br />
frequente coincidenti con le aree destinate a speciale protezione. In partico<strong>la</strong>re ci si riferisce<br />
ai Fondi Strutturali (F.E.R.S. - Fondo Europeo di sviluppo regionale, F.S.E. - Fondo sociale<br />
europeo, F.E.A.O.G. - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, S.F.O.P. -<br />
Fondo Finanziario di Orientamento del<strong>la</strong> pesca) ed altri tipi di agevo<strong>la</strong>zioni finanziarie che<br />
sempre più frequentemente orientano le politiche di sviluppo di molte regioni italiane.<br />
c. l'individuazione del<strong>la</strong> proprietà <strong>dell</strong>e aree;<br />
La maggior parte <strong>dell</strong>e aree protette italiane ricade in territori antropizzati con marcate<br />
differenziazioni di gestione tra pubblico e privato.<br />
La conoscenza <strong>dell</strong>e proprietà <strong>dell</strong>e aree suddivise <strong>per</strong> fasce di ampiezza e del valore di mercato<br />
serve all'Ente Parco <strong>per</strong> facilitare l'attuazione <strong>dei</strong> suoi programmi urbanistici (di vincolo e/o<br />
sviluppo) e <strong>per</strong> calibrare le eventuali "trattative" che dovrà avviare con i privati.<br />
d. l'individuazione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione rivolta al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>, già o<strong>per</strong>ante nell'area a parco.<br />
Molto spesso nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione ambientale italiana <strong>la</strong> protezione del patrimonio culturale è stata<br />
separata da quel<strong>la</strong> <strong>dell</strong>e risorse e del patrimonio naturale.<br />
In tempi più recenti le azioni legis<strong>la</strong>tive volte al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> sono passate dal<strong>la</strong> conservazione <strong>dell</strong>e cose<br />
d'interesse artistico e storico o di partico<strong>la</strong>re emergenze fisico naturalistiche (L. 1089/39, L.<br />
1497/39 e D.M. 431/85) all'individuazione di aree protette in cui promuovere, in forma coordinata,<br />
<strong>la</strong> conservazione e <strong>la</strong> valorizzazione del patrimonio naturale del paese.<br />
Potrebbe essere utile, ai fini del<strong>la</strong> definizione <strong>dei</strong> diversi gradi di protezione del territorio, previsti<br />
dal piano del parco, individuare le emanazioni legis<strong>la</strong>tive rivolte al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>dell</strong>e risorse fisico<br />
naturalistiche e storico culturali, già o<strong>per</strong>anti nell'area.<br />
2.3.4. Aspetti socio-economici<br />
L'analisi e <strong>la</strong> valutazione degli aspetti socio-economici si esplica nel<strong>la</strong> descrizione socio-economica<br />
del territorio interessato, indicando stato e tendenze <strong>dell</strong>e attività produttive, comprese quelle di<br />
servizio, e con partico<strong>la</strong>re attenzione a quelle più strettamente collegate al<strong>la</strong> natura, come il turismo,<br />
e a quelle connesse all' attività degli enti di gestione del parco. Si provvederà quindi a confronti con<br />
aree simili, in modo da evidenziare le potenzialità di sviluppo ed i vincoli connessi al<strong>la</strong> presenza del<br />
parco, e <strong>per</strong> quanto possibile alle previsioni. Queste ultime saranno sempre condotte a partire da<br />
ipotesi di sviluppo raccolte nel territorio e potranno avvalersi di indagini "di mercato" sui visitatori,<br />
di mo<strong>dell</strong>i gravitazionali tendenti a stimare il potenziale di visita in funzione del<strong>la</strong> collocazione del<br />
parco, e più raramente di mo<strong>dell</strong>i econometrici di analisi del<strong>la</strong> domanda.<br />
Sarà opportuno effettuare analisi costi benefici riferite a specifici progetti di definizione <strong>dell</strong>e zone,<br />
<strong>per</strong> esempio re<strong>la</strong>tivamente all' inclusione di una determinata area in zona caratterizzata da un certo<br />
regime di protezione. Saranno stimati non solo i benefici di carattere direttamente monetario, ma<br />
anche quelli immateriali, valutati come disponibilità a pagare. Le principali tecniche utili <strong>per</strong> questi<br />
ultimi sono <strong>la</strong> valutazione contingente, che richiede interviste dettagliate a visitatori effettivi ed<br />
eventualmente potenziali, richiedendo loro valutazioni ipotetiche del<strong>la</strong> disponibilità a pagare che<br />
devono essere condotte con grande <strong>per</strong>izia; e il metodo <strong>dei</strong> costi di spostamento, che si basa sulle
spese effettivamente sostenute <strong>per</strong> <strong>la</strong> fruizione <strong>dell</strong>' area e fornisce risultati più sicuri ma<br />
solitamente meno precisi <strong>per</strong> aree ristrette.<br />
Infine, le valutazioni in ambito socio-economico possono contribuire all'ideazione e definizione di<br />
strumenti di gestione <strong>dei</strong> conflitti che spesso sorgono in riferimento al<strong>la</strong> suddivisione in zone del<br />
parco, ed ai re<strong>la</strong>tivi regimi di protezione. I principali strumenti utili sono quelli che consentono di<br />
raccogliere risorse finanziarie dai visitatori (pedaggi, ecc.) <strong>per</strong> destinarle a finalità istituzionali del<br />
parco, al sostegno di attività economiche compatibili con <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> natura, o<br />
eventualmente al<strong>la</strong> compensazione <strong>dell</strong>e <strong>per</strong>dite e <strong>dei</strong> mancati guadagni sofferti dal<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione<br />
locale <strong>per</strong> effetto del<strong>la</strong> presenza del parco stesso.<br />
3. Interferenze nei tre sistemi (fisico biologico ed antropico)<br />
Nell'esame <strong>dei</strong> territori interessati dai <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong> italiani è possibile rilevare, schematizzando,<br />
tre tipi di ambienti originati da altrettanti tipi di rapporto tra l'uomo e <strong>la</strong> natura:<br />
• 1. quelli di eccezionale valore naturale che sono sopravvissuti <strong>per</strong>chè preservati da ogni<br />
diretto contatto con l'uomo e le sue attività;<br />
• 2. quelli di altrettanto valore "naturale" che sono divenuti tali in virtù di un equilibrato<br />
rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale;<br />
• 3. quelli già degradati o in via di degrado a causa <strong>dell</strong>o sfruttamento irrazionale da parte<br />
<strong>dell</strong>'uomo.<br />
I primi sono rari e impongono drastiche forme di tute<strong>la</strong> a sostegno <strong>dei</strong> sistemi di conservazione<br />
naturale che sempre più rischiano di essere sopraffatti dalle accresciute capacità di aggressione da<br />
parte <strong>dell</strong>'uomo.<br />
I secondi, più frequenti in tutte le aree protette italiane, e più in generale in quelle europee, sono<br />
sede di contrastate ipotesi:<br />
• se venissero abbandonati dall'uomo potrebbero dare origine ad ambienti più "selvaggi", ma<br />
si favorirebbe <strong>la</strong> scomparsa di ecosistemi storicamente consolidati, determinanti essenziali<br />
del carattere di molti <strong>parchi</strong> italiani;<br />
• se l'uomo continuasse a risiedervi e ad esplicarvi le sua attività in modo incontrol<strong>la</strong>to<br />
diverrebbe sempre più difficile riuscire a mantenervi l'antico equilibrio di fronte<br />
all'affermarsi di nuovi sistemi e mezzi di uso del suolo.<br />
Gli ambienti descritti al terzo punto sono diffusi in modo puntiforme su gran parte <strong>dell</strong>e aree<br />
protette italiane. Si concretizzano in un rapporto di conflittualità fra <strong>la</strong> "naturalità" del sito ed alcuni<br />
partico<strong>la</strong>ri interventi antropici realizzati in quel sito (ai fini <strong>dell</strong>'analisi territoriale sarebbe utile<br />
prendere in esame anche interventi semplicemente previsti dai piani e programmi in atto). Questo<br />
tipo di re<strong>la</strong>zione critica, che può rilevarsi all'interno <strong>dell</strong>o stesso sistema antropico, o fra il sistema<br />
antropico e gli altri sistemi, è stato preso in esame e c<strong>la</strong>ssificato come interferenza <strong>per</strong> mettere in<br />
evidenza <strong>la</strong> dissonanza fra le qualità e l'uso di un'area.<br />
3.1. Individuazione <strong>dell</strong>e interferenze<br />
L'individuazione <strong>dell</strong>e interferenze prende in considerazione dati che riguardano l'uso del suolo,<br />
l'organizzazione <strong>dell</strong>e infrastrutture, i servizi e <strong>la</strong> fruizione turistica e l'andamento socio-economico.<br />
E<strong>la</strong>borando i dati tramite computer o mediante semplici o<strong>per</strong>azioni di sovrapposizione su base<br />
cartacea si riesce a raffrontare <strong>la</strong> carta dove sono indicati i principali interventi antropici realizzati<br />
(o semplicemente previsti) con <strong>la</strong> carta <strong>dell</strong>e caratteristiche "naturali" del parco (emergenze, valori e<br />
fragilità).<br />
Per esemplificare il processo di sovrapposizione ed interpretazione si può agire o<strong>per</strong>ando nei tre<br />
sistemi in modo distinto.
La rappresentazione <strong>dell</strong>e interferenze si realizza mediante e<strong>la</strong>borazione cartografica (carta <strong>dell</strong>e<br />
interferenze) e note descrittive <strong>per</strong> ciascun caso studio. In tal modo si riesce a visualizzare<br />
l'estensione <strong>dell</strong>e aree interessate dai fenomeni oggetto di crisi, che andranno ad indurre anche una<br />
variazione <strong>dell</strong>e eterogeneità all'interno <strong>dei</strong> tipi di unità di paesaggio. Tali aree critiche potranno<br />
essere oggetto di successivi approfondimenti analitici e progettuali.<br />
3.2. Interferenze nel sistema fisico<br />
Le interferenze antropiche nel sistema fisico prendono in considerazione tutti gli interventi diretti<br />
<strong>dell</strong>'uomo sul<strong>la</strong> geologia, geomorfologia, pedologia, idrologia, climatologia.<br />
In modo sommario, possiamo individuarne alcuni, distinti <strong>per</strong> grandi categorie:<br />
• estrazione di materiali litoidi e depositi di materiali di risulta (estrazioni in alveo, cave,<br />
miniere, discariche, scorie di <strong>la</strong>vorazioni industriali, ...);<br />
• modificazione del<strong>la</strong> geomorfologia originaria (cave, depositi di materiali di risulta,<br />
livel<strong>la</strong>zioni, eliminazione <strong>dell</strong>e rotture di pendenze <strong>per</strong> l'estendersi <strong>dell</strong>'agricoltura<br />
meccanizzata, ...);<br />
• interventi che possono originare fenomeni di erosione (deforestazione, sovrappasco<strong>la</strong>mento,<br />
sistemi di aratura inadeguati in pendio, ...);<br />
• rimaneggiamento degli orizzonti pedogenetici (escavazioni <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazione di grandi<br />
infrastrutture: viarie, fognarie, metanodotti, oleodotti, gasdotti, ...);<br />
• asportazione di orizzonti organici su<strong>per</strong>ficiali (prelievo humus forestale e torba <strong>per</strong> usi<br />
agricoli e di combustione, ...);<br />
• alterazione <strong>dell</strong>'equilibrio idrologico su<strong>per</strong>ficiale (bonifiche e prosciugamento di zone<br />
umide, sistemazione idraulica <strong>per</strong> usi agro-forestali, captazioni di sorgenti, cattura artificiale<br />
del fiume, regimazione <strong>dei</strong> corsi d'acqua, derivazioni <strong>per</strong> usi artigianali o idroelettrici,<br />
creazione di specchi d'acqua artificiali, ...);<br />
• alterazione <strong>dell</strong>e proprietà fisico-chimiche <strong>dell</strong>'acqua (creazione di invasi artificiali, scarico<br />
incontrol<strong>la</strong>to di inquinanti, utilizzo come agente termico di raffreddamento, ...);<br />
• alterazione <strong>dell</strong>'equilibrio idrogeologico degli acquiferi (prelievo <strong>per</strong> mezzo di pozzi,<br />
trivel<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong> ricerche di idrocarburi e geotermiche, drenaggi sotterranei, ...);<br />
• emissioni di fumi da fonti inquinanti (scarico <strong>dei</strong> fumi da ciminiere, da mezzi di trasporto,<br />
da centrali termiche e da impianti di riscaldamento <strong>per</strong> usi domestici, ...);<br />
• alterazione chimica del suolo dovuto all'uso non bi<strong>la</strong>nciato di pesticidi e fertilizzanti<br />
(concimazioni, disinfestazioni, diserbi, ...);<br />
• destrutturazione <strong>dell</strong>'orizzonte su<strong>per</strong>ficiale del suolo (calpestio <strong>dell</strong>'uomo, bestiame, mezzi<br />
motorizzati, ...);<br />
• emissioni incontrol<strong>la</strong>te di radiazioni nucleari (depositi di scorie radioattive, ...).<br />
3.3. Interferenze nel sistema biologico<br />
Le interferenze antropiche nel sistema biologico riuniscono tutti gli interventi diretti <strong>dell</strong>'uomo sul<strong>la</strong><br />
flora (vegetazione) e fauna.<br />
In modo sommario, possiamo individuarne alcuni distinti <strong>per</strong> grandi categorie:<br />
• raccolta massiccia di specie vegetali di partico<strong>la</strong>re interesse (piante medicinali, piante e<br />
funghi eduli, piante ornamentali, alberi di legno pregiato, piante rare o endemiche <strong>per</strong> erbari,<br />
...) oppure eliminazione totale di quelle di scarsa utilità economica (piante infestanti nelle<br />
colture, erbe a basso valore foraggero, cespugli sviluppatisi nei prati, caducifoglie di lento<br />
accrescimento, ...);<br />
• distruzione del<strong>la</strong> vegetazione naturale <strong>per</strong> scopi agricoli, industriali o turistici (dissodamenti,<br />
disboscamenti, incendi, pasco<strong>la</strong>mento eccessivo, sports all'a<strong>per</strong>to, attività escursionistiche,<br />
...);
• realizzazione di impianti agro-silvocolturali intensivi in aree situate al di fuori <strong>dell</strong>'areale<br />
naturale <strong>dell</strong>e specie utilizzate (miglioramento di prati, coniferamenti, seminagioni di prati,<br />
rimboschimenti, ...);<br />
• cattura ed uccisione in massa di specie animali di partico<strong>la</strong>re interesse (<strong>per</strong> carne, pelliccia,<br />
sport, collezione, ...) oppure di quelle considerate dannose (defogliatori, predatori di animali<br />
domestici, vettori di ma<strong>la</strong>ttie,...);<br />
• introduzione di specie animali e vegetali al di fuori del loro areale naturale oppure di razze<br />
geneticamente manipo<strong>la</strong>te (colonizzazioni, ripopo<strong>la</strong>menti, piantagioni, ...).<br />
3.4 . Interferenze nel sistema antropico (limitatamente al patrimonio storico culturale)<br />
Le interferenze antropiche nel sistema antropico prendono in considerazione quegli interventi<br />
realizzati o quelle omissioni d'intervento da parte <strong>dell</strong>'uomo che si pongono in un rapporto di<br />
conflittualità con le caratteristiche storico culturali <strong>dell</strong>'area e quindi con i segni che l'attività storica<br />
<strong>dell</strong>'uomo ha <strong>la</strong>sciato nel territorio.<br />
In modo sommario possiamo individuarne alcuni, distinti <strong>per</strong> grandi categorie:<br />
• mancanza di un'adeguata conoscenza del patrimonio storico culturale (<strong>per</strong>corsi,<br />
insediamenti, paesaggio agrario, beni paesistici, architettonici ed archeologici iso<strong>la</strong>ti, usi e<br />
costumi, ...);<br />
• abbandono al degrado fisico e tipologico del patrimonio edilizio storico (restauri non<br />
scientifici, mancata manutenzione <strong>dell</strong>'edilizia di base e specialistica, ...)<br />
• abbandono al<strong>la</strong> completa distruzione e conseguente trasformazione di alcune tracce di antico<br />
paesaggio agrario (seminativi arborati, querce camporili, campi chiusi, sistemazioni di<br />
versanti collinari: a lunette, a ciglioni, a terrazze, siepi in sistema "bocages"...);<br />
• usi impropri di aree di interesse architettonico ed archeologico (costruzione di impianti,<br />
strade ed infrastrutture in prossimità di emergenze architettoniche ed archeologiche, ...);<br />
• usi impropri di infrastrutture anticamente destinate al pascolo estivo (malghe, rifugi e case<br />
iso<strong>la</strong>te trasformate in luoghi <strong>per</strong> il turismo di massa, ...);<br />
• usi impropri e/o avviamento al degrado di aree anticamente destinate ad utilizzazioni<br />
forestali (carbonaie, punto di raccolta <strong>per</strong> <strong>la</strong> fluitazione del legname, aree con presenza di<br />
scivoli <strong>per</strong> il convogliamento a valle <strong>dei</strong> tronchi, ...);<br />
• previsioni degli strumenti urbanistici che non tengono conto <strong>dell</strong>e caratteristiche storico<br />
culturali <strong>dell</strong>'area;<br />
• <strong>per</strong>dita del significato originario degli usi civici (jus legnandi, jus pascendi, ...);<br />
• <strong>la</strong>vorazioni artigianali tradizionali in via di abbandono;<br />
• tradizioni di origine <strong>la</strong>ica e/o religiosa in via di abbandono;<br />
• mancanza di un'adeguata tute<strong>la</strong> <strong>dell</strong>e culture alloglotte.<br />
4. Sintesi valutativa <strong>dell</strong>e indagini settoriali<br />
La sintesi analitica e cartografica di tutti i dati ottenuti a seguito <strong>dell</strong>e indagini settoriali rappresenta<br />
una tappa necessaria e di massima importanza ai fini di eseguire una strutturazione ecologica del<br />
territorio, su cui verranno innescate le ipotesi di strutturazione funzionale del Parco.<br />
L'approccio transdisciplinare, che integra le informazioni corologiche e topologiche sugli<br />
ecosistemi ad un livello su<strong>per</strong>iore (del paesaggio) <strong>per</strong> lo studio <strong>dei</strong> mo<strong>dell</strong>i spazio-temporali, è<br />
considerato attualmente <strong>la</strong> base scientifica <strong>per</strong> <strong>la</strong> pianificazione, gestione e conservazione del<br />
territorio.<br />
La fase sintetica che precede l'e<strong>la</strong>borazione <strong>dell</strong>o schema di <strong>zonizzazione</strong> del Parco si basa sui<br />
concetti teorici <strong>dell</strong>'ecologia del paesaggio e utilizza come strumento di <strong>la</strong>voro l'unità di paesaggio<br />
(ecotessuto). Essa include una combinazione specifica di ecotopi assomiglianti <strong>per</strong> almeno una<br />
proprietà comune. L'omogeneità <strong>dell</strong>'unità di paesaggio si esprime più su un piano funzionale che su
quello ecologico e biocenotico. L'ecotopo è considerato invece l'unità territoriale elementare,<br />
caratterizzata dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva omogeneità ecologica e quindi dallo stesso tipo vegetazionale. Gli<br />
ecosistemi che costituiscono un'unità di paesaggio possono coprire tutta <strong>la</strong> gamma di naturalità, da<br />
quelli completamente antropici a quelli naturali.<br />
4.1. Delimitazione <strong>dell</strong>e unità di paesaggio<br />
Come tutte le c<strong>la</strong>ssificazioni ecologiche del territorio, l'identificazione <strong>dell</strong>e unità di paesaggio si<br />
basa su una sintassi (analisi formale) che sia in grado di sostenere una semantica (analisi del<br />
significato).<br />
La delimitazione <strong>dell</strong>e unità di paesaggio rimane tuttora soggettiva ed artificiale, in quanto gli<br />
ecosistemi componenti sono sistemi a<strong>per</strong>ti, con un basso grado di integralità. Pertanto, si usa come<br />
criterio pragmatico l'identità visuale e culturale <strong>dell</strong>e singole unità, che si ottiene attraverso <strong>la</strong><br />
sovrapposizione ed integrazione <strong>dell</strong>'ambiente fisico (ecotopi), <strong>dell</strong>'ambiente biotico (biocenosi) e<br />
<strong>dell</strong>'ambiente antropico. Nei Parchi, dove generalmente <strong>la</strong> vegetazione naturale è ancora ben<br />
rappresentata, l'approccio geosinfitosociologico costituisce uno strumento supplementare e molto<br />
utile <strong>per</strong> <strong>la</strong> delimitazione <strong>dell</strong>e unità di paesaggio.<br />
La delimitazione effettiva <strong>dell</strong>e unità di paesaggio richiede l'uso del<strong>la</strong> cartografia di sintesi<br />
(ambientale), che integra le carte tematiche <strong>dei</strong> singoli attributi del paesaggio. Di conseguenza, <strong>la</strong><br />
carta di sintesi risulta mediante l'aggregazione sinottica ed analogica <strong>dei</strong> dati analitici che<br />
riguardano <strong>la</strong> geologia, <strong>la</strong> geomorfologia, <strong>la</strong> pedologia, l'idrologia, <strong>la</strong> climatologia, <strong>la</strong> vegetazione,<br />
<strong>la</strong> fauna e le componenti del sistema antropico.<br />
Nel<strong>la</strong> delimitazione <strong>dell</strong>e unità si cerca di utilizzare con precedenza i lineamenti geomorfologici<br />
(spartiacque, fondovalli, faglie) e i limiti ecologici messi in evidenza dal<strong>la</strong> distribuzione <strong>dei</strong><br />
mesoclimi, <strong>dei</strong> suoli e <strong>dell</strong>e serie di vegetazione. In partico<strong>la</strong>re, le fitocenosi, attraverso <strong>la</strong> loro<br />
composizione floristica, sono indicatori fondamentali sia nel<strong>la</strong> fase di individuazione visuale che in<br />
quel<strong>la</strong> di valutazione complessa <strong>dell</strong>e unità di paesaggio, in quanto espressione tangibile ed<br />
integrata <strong>dell</strong>'intero ecosistema.<br />
4.2. Individuazione <strong>dei</strong> tipi di unità di paesaggio<br />
La ridondanza <strong>dell</strong>e unità di paesaggio distinte come unità concrete (cartografiche), ripetibili nel<br />
territorio, rende necessaria <strong>la</strong> loro riduzione ad alcuni tipi di unità di paesaggio (astratti).<br />
L'individuazione <strong>dei</strong> tipi si esegue mediante una valutazione complessa di tutte le unità di paesaggio<br />
(concrete), che costituiscono l'intero ambito territoriale. A tale fine, si fa uso di una serie di criteri<br />
nei quali fare convergere le valutazioni plurisettoriali in termini confrontabili e che possono essere<br />
raggruppati in una griglia valutativa che incrocia 4 categorie e precisamente: elementi strutturali,<br />
valenze specifiche, emergenze e interferenze antropiche.<br />
Tra gli indicatori strutturali, <strong>la</strong> tessitura rileva <strong>la</strong> composizione, <strong>la</strong> proporzione e <strong>la</strong> distribuzione<br />
<strong>dell</strong>e macchie all'interno di una unità di paesaggio, cioè <strong>dell</strong>e chiazze di vari usi del suolo. La<br />
comparazione <strong>dell</strong>e tessiture si può realizzare visualmente (in modo empirico) oppure mediante<br />
metodi più oggettivi, come il calcolo di alcuni indici di analisi strutturale.<br />
Le valenze specifiche si riferiscono alle caratteristiche naturalistico-paesaggistiche e storicoculturali<br />
<strong>dell</strong>e unità di paesaggio; tale valutazione si può eseguire mediante indici sintetici<br />
ambientali oppure sul<strong>la</strong> base di criteri prestabiliti (naturalità, diversità, rinnovabilità, resilienza,<br />
rarità, antichità, pregio artistico, ecc.).<br />
Le emergenze, già evidenziate durante le indagini settoriali, devono avere un carattere prioritario<br />
nel<strong>la</strong> valutazione, in quanto esse spesso rappresentano i motivi <strong>per</strong> i quali è stato istituito il Parco<br />
stesso.<br />
La sovrapposizione <strong>dell</strong>e interferenze antropiche prima individuate in ciascuna unità di paesaggio<br />
può rendere necessaria, in alcuni casi, <strong>la</strong> divisione o aggregazione <strong>dell</strong>e stesse.<br />
In seguito a tale valutazione, le singole unità di paesaggio distinte aquisiscono una certa omogeneità<br />
e si prestano ad una c<strong>la</strong>ssificazione numerica attraverso metodi di analisi multivariata. Come<br />
risultato, le unità di paesaggio più assomiglianti <strong>per</strong> le loro valenze specifiche sono attribuibili ad un
certo tipo. Se le unità appartenenti allo stesso tipo vengono indicate graficamente in maniera<br />
specifica, allora si ottiene una prima approssimazione cartografica <strong>dei</strong> tipi di unità di paesaggio.<br />
La successiva valutazione semantica di tali unità tipologiche e il loro confronto in termini di<br />
differenze possono rilevare nuove informazioni sul funzionamento del mosaico ambientale a diversi<br />
livelli di organizzazione multisca<strong>la</strong>re e quindi imporre una revisione <strong>dei</strong> tipi di unità di paesaggio<br />
nel senso del<strong>la</strong> loro complessità, eterogeneità, rappresentatività, ecc.<br />
Una volta stabiliti i tipi definitivi di unità di paesaggio, ciascuno di essi deve essere astratto in un<br />
mo<strong>dell</strong>o attraverso <strong>la</strong> descrizione generale e una denominazione breve di tipo diagnosi, quest'ultima<br />
basata soprattutto sulle caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e antropo-culturali. Le<br />
denominazioni-diagnosi sono utilizzate nel<strong>la</strong> legenda del<strong>la</strong> carta <strong>dei</strong> tipi di unità di paesaggio, che<br />
costituisce il documento di base <strong>per</strong> le e<strong>la</strong>borazioni ulteriori.<br />
4.3. Delimitazione <strong>dei</strong> complessi funzionali<br />
I complessi funzionali raggruppano tipi di unità di paesaggio contigui collegati da rapporti di<br />
compatibilità e complementarietà ai fini del<strong>la</strong> strutturazione funzionale del territorio. La<br />
compatibilità riguarda l'affinità di attitudini che alcuni tipi di unità di paesaggio possiedono <strong>per</strong><br />
assicurare <strong>la</strong> continuità spazio-temporale <strong>dell</strong>e funzionalità a tutto il complesso. La<br />
complementarietà riguarda invece <strong>la</strong> congiunzione di proprietà diverse che caratterizzano alcuni tipi<br />
di unità di paesaggio <strong>per</strong> il compimento <strong>dell</strong>e funzionalità attribuibili al complesso.<br />
In casi partico<strong>la</strong>ri il complesso può essere formato anche da un solo tipo di unità di paesaggio o<br />
addirittura da porzioni di unità di paesaggio. I complessi contigui devono avere funzionalità diverse<br />
- almeno in parte, mentre complessi ben separati spazialmente possono avere funzionalità simili.<br />
Per l'integrazione <strong>dell</strong>e unità di paesaggio in complessi funzionali si dovrà tener conto <strong>dell</strong>e<br />
re<strong>la</strong>zioni all'interno di ciscun sistema (fisico, biologico e antropico) e di quelle intersistemiche, che<br />
sono state evidenziate nel<strong>la</strong> fasi precedenti.<br />
Un elenco sommario ed esemplificativo di possibili emergenze ambientali, considerate nel loro<br />
ambito re<strong>la</strong>zionale, che costituiscono i capisaldi <strong>per</strong> l'organizzazione <strong>dei</strong> complessi funzionali di<br />
unità di paesaggio, è il seguente:<br />
• formazioni geologiche e strutture geomorfologiche di partico<strong>la</strong>re interesse;<br />
• fenomeni di degrado e dissesto del suolo;<br />
• paleosuoli e suoli extrazonali;<br />
• sorgenti d'acqua potabile, termale o minerale;<br />
• corsi d'acqua naturali non regimati;<br />
• topoclimi extrazonali e microclimi collegati all'idrografia;<br />
• habitat di specie animali e vegetali endemiche o rare;<br />
• cenosi vegetali ed animali di interesse naturalistico;<br />
• biodiversità elevata e complessità strutturale <strong>dei</strong> sistemi ecologici;<br />
• beni paesistici ed architettonici iso<strong>la</strong>ti;<br />
• elementi di pregio storico-culturali locali;<br />
• paesaggio agrario storico;<br />
• insediamenti umani preistorici e storici;<br />
• aspetti culturali <strong>dell</strong>e popo<strong>la</strong>zioni umane autoctone;<br />
• <strong>per</strong>corsi ed itinerari storici;<br />
• strutture già esistenti legate ad attività di gestione oppure di ricerca scientifica.<br />
La carta <strong>dei</strong> complessi funzionali di unità di paesaggio rappresenta il documento di sintesi finale,<br />
sul quale si concepiranno le varie ipotesi di <strong>zonizzazione</strong>.<br />
5. Ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> e norme <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
La nostra trattazione, pur esaminando ogni o<strong>per</strong>azione come parte di un più completo e generale<br />
"processo di piano", ha voluto porsi come obiettivo una prima tappa consistente appunto nell'ipotesi
di <strong>zonizzazione</strong>, da raggiungere in tempi brevi, anche in riferimento ai sei mesi previsti dal<strong>la</strong> legge<br />
istitutiva del piano <strong>per</strong> il parco.<br />
L'ipotesi di <strong>zonizzazione</strong>, contenente anche <strong>la</strong> normativa <strong>per</strong> aree, <strong>per</strong> settori e <strong>per</strong> progetti,<br />
rappresenta dunque uno strumento di piano, ancora a<strong>per</strong>to e <strong>per</strong>fettibile, ma già idoneo <strong>per</strong><br />
supportare le prime politiche di conservazione e valorizzazione <strong>dell</strong>e risorse naturali e culturali<br />
presenti e <strong>per</strong> dare una risposta alle richieste di vari tipi d'intervento: dalle quotidiane esigenze di<br />
cittadini ed imprenditori locali ai grandi progetti a livello nazionale ed europeo.<br />
Il varo del piano <strong>per</strong> il parco non esaurisce comunque il "processo di piano", anzi rappresenta<br />
l'avvio di una seconda tappa, decisamente più lunga rispetto ai 6 mesi del<strong>la</strong> precedente, in cui nuove<br />
e più raffinate o<strong>per</strong>azioni d'integrazione, aggiornamento e <strong>per</strong>fezionamento del piano si affiancano e<br />
innalzano <strong>la</strong> qualità <strong>dell</strong>e attività (già avviate) di gestione <strong>dell</strong>'area.<br />
5.1. Approssimazione di delimitazione e bozza di normativa <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
I vari complessi funzionali di unità di paesaggio esprimono <strong>la</strong> sintesi funzionale <strong>dell</strong>e diverse<br />
emergenze considerate nel loro ambito re<strong>la</strong>zionale; <strong>la</strong> carta che li rappresenta deriva dunque<br />
dall'interpretazione di tutte le precedenti indagini interdisciplinari sull'artico<strong>la</strong>zione e dinamicità<br />
degli ecosistemi, sulle re<strong>la</strong>zioni esistenti fra gli stessi, sulle omogeneità ed eterogeneità presenti;<br />
schematizza <strong>la</strong> vera struttura <strong>dei</strong> sistemi (fisico, biologico ed antropico) e <strong>la</strong> griglia di riferimento<br />
<strong>per</strong> costruire <strong>la</strong> prima <strong>zonizzazione</strong> del parco.<br />
Ma il passaggio dal<strong>la</strong> sintesi al<strong>la</strong> delimitazione <strong>dell</strong>e aree non è meccanico nè tantomeno<br />
automatico; più che un semplice passaggio è un processo che prevede un divenire <strong>dell</strong>'ipotesi di<br />
<strong>zonizzazione</strong>, capace di continui aggiustamenti, verifiche progettuali ed approfondimenti analitici.<br />
Si <strong>per</strong>viene ad una prima approssimazione di delimitazione <strong>dell</strong>e aree a), b), c), e d) mediante<br />
l'aggregazione di complessi di unità: in alcuni casi è anche possibile che i singoli complessi di unità<br />
di paesaggio vadano direttamente a costituire, senza ulteriori aggregazioni, le diverse aree, oppure<br />
che un solo complesso di unità appartenga a più di un'area.<br />
I criteri che guidano l'aggregazione, o <strong>la</strong> divisione, <strong>dei</strong> complessi di unità, oltre a considerare le<br />
re<strong>la</strong>zioni fisico-naturalistiche, formali e visuali, sono anche funzionali al<strong>la</strong> futura organizzazione<br />
del<strong>la</strong> gestione <strong>dell</strong>e aree e quindi alle attività che <strong>la</strong> legge quadro prevede <strong>per</strong> le aree destinate a<br />
parco.<br />
A titolo esemplificativo si può dire che potrebbero essere delimitati dapprima quei complessi<br />
funzionali di unità di paesaggio contenenti le specificità fisico-naturalistiche <strong>dell</strong>'area.<br />
Sono queste le aree sostenenti biocenosi dal valore eccezionale che concorrono al<strong>la</strong> definizione<br />
<strong>dell</strong>'identità del parco e che richiedono una "protezione <strong>dell</strong>'ambiente - sia nelle singole componenti<br />
che nelle reciproche re<strong>la</strong>zioni - rigorosa in modo da garantire che gli equilibri non siano alterati". Si<br />
riesce così a definire una prima <strong>per</strong>imetrazione <strong>dell</strong>e zone che andranno a formare le riserve<br />
integrali e le riserve generali orientate.<br />
Mentre l'individuazione <strong>dell</strong>e riserve si pone <strong>per</strong> lo più al di fuori da valutazioni re<strong>la</strong>zionali proprie<br />
del<strong>la</strong> pianificazione territoriale ed è guidata in modo univoco dagli es<strong>per</strong>ti <strong>dell</strong>e singole discipline<br />
interessate, assai più complessa è <strong>la</strong> delimitazione <strong>dell</strong>e aree più antropizzate, comprendenti anche i<br />
nuclei insediativi urbani e rurali.<br />
Su queste aree, estesamente modificate dai processi di antropizzazione, spesso d'interfaccia con il<br />
cuore del parco e quasi sempre sedi di conflittualità territoriale, il dibattito si fa partico<strong>la</strong>rmente<br />
acceso proprio <strong>per</strong> <strong>la</strong> difficoltà di circoscrivere con una linea tensioni e fenomeni interagenti con <strong>la</strong><br />
tute<strong>la</strong> e <strong>la</strong> conservazione <strong>dei</strong> più fragili ambienti vicini.<br />
Pertanto, localizzando gli ambiti re<strong>la</strong>zionali interconnessi con il sistema <strong>dell</strong>e riserve e<br />
interpretando alcuni processi antropici, storici o ancora in atto, si riesce a dare solo una<br />
<strong>per</strong>imetrazione sommaria <strong>dell</strong>e aree di protezione e <strong>dell</strong>e aree di promozione economica e sociale.<br />
Le attività umane infatti dovranno essere organizzate in modo più preciso e puntuale dopo aver<br />
sottoposto a verifica <strong>la</strong> disciplina <strong>dell</strong>e principali problematiche emerse.<br />
Al<strong>la</strong> prima approssimazione di delimitazione verrà dunque acclusa una bozza di normativa ordinata<br />
sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> suddivisione in zone prevista ai sensi <strong>dell</strong>'art.12, comma 2 del<strong>la</strong> L. 394/91, <strong>dell</strong>e
tematiche citate dal<strong>la</strong> legge stessa e di quelle problematiche più specifiche emerse a seguito<br />
<strong>dell</strong>'interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni.<br />
In partico<strong>la</strong>re si potrà osservare che <strong>la</strong> bozza di normativa <strong>per</strong> settori tematici interesserà ambiti<br />
territoriali non sempre coincidenti con le zone previste (A,B,C e D). Basti pensare ad alcuni<br />
significativi tematismi - come ad esempio: i <strong>per</strong>corsi veico<strong>la</strong>ri e pedonali, le risorse idriche, gli<br />
inquinamenti, gli interventi sul<strong>la</strong> fauna, ecc...- capaci di travalicare ogni limite di zona.<br />
5.2. Verifiche<br />
L'approssimazione di delimitazione e con essa <strong>la</strong> prima bozza di normativa <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori<br />
tematici viene a questo punto sottoposta a verifica al fine di poter garantire <strong>la</strong> gestibilità e <strong>la</strong><br />
sostenibilità <strong>dell</strong>e funzioni assegnate alle diverse zone e di poter definire con più esattezza <strong>la</strong><br />
disciplina <strong>dei</strong> principali tematismi oggetto di studio.<br />
Le o<strong>per</strong>azioni di verifica possono ricondursi a:<br />
• controlli progettuali puntuali. O<strong>per</strong>azioni progettuali appropriate dovrebbero accompagnare<br />
l'attività di piano al fine di riuscire a "mettere a fuoco" soluzioni partico<strong>la</strong>ri e<br />
contemporaneamente rapportarsi all'organizzazione generale del territorio. Potranno<br />
esplicarsi in: progetti pilota <strong>per</strong> aree campione <strong>per</strong> <strong>la</strong> disciplina di alcuni contenuti<br />
espressamente previsti dal piano (sistemi di accessibilità veico<strong>la</strong>re e pedonale con<br />
partico<strong>la</strong>re riguardo ai <strong>per</strong>corsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di<br />
handicap e agli anziani; sistemi di attrezzature e servizi <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione e <strong>la</strong> fruizione sociale<br />
del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività<br />
agrituristiche); progetti speciali <strong>per</strong> ambiti territoriali complessi, sedi di "interferenze" e/o in<br />
stato di partico<strong>la</strong>re degrado urbanistico e paesistico-ambientale;<br />
• raccordo con gli altri strumenti ed iniziative previste dal<strong>la</strong> legge quadro. Il piano <strong>per</strong> il parco<br />
dovrà divenire lo strumento conoscitivo di base <strong>per</strong> supportare scelte ed iniziative proposte<br />
dagli altri strumenti previsti dal<strong>la</strong> stessa legge e cioè: il Rego<strong>la</strong>mento del Parco, che dovrà<br />
essere adottato dall'ente parco non oltre sei mesi dall'approvazione del piano ed il Piano<br />
pluriennale economico e sociale, che dovrà essere e<strong>la</strong>borato dal<strong>la</strong> comunità del parco nel<br />
rispetto <strong>dei</strong> vincoli stabiliti dal piano e dal Rego<strong>la</strong>mento. I tre strumenti dovrebbero<br />
avanzare in modo dialogico e coo<strong>per</strong>ativo. In partico<strong>la</strong>re il piano pluriennale economico e<br />
sociale <strong>per</strong> <strong>la</strong> promozione <strong>dell</strong>e attività compatibili capace di prevedere <strong>la</strong> concessione di<br />
sovvenzioni a privati ed enti locali, l'agevo<strong>la</strong>zione o <strong>la</strong> promozione di una serie di attività -<br />
tradizionali, artigianali ecc., - se adeguatamente coordinato con le misure d'incentivazione<br />
(L. 394/91, art.7), con altri tipi di agevo<strong>la</strong>zioni che l'istituzione <strong>dell</strong>'area protetta riesce ad<br />
innescare, e con gli indirizzi progettuali di cui si fa portatore il piano, potrebbe avviare "una<br />
trasformazione economica di ampia prospettiva , progressiva, equilibrata, ecologica e<br />
tendenzialmente autopropulsiva".<br />
• raccordo con il contesto territoriale e <strong>la</strong> strumentazione urbanistica vigente. La Legge<br />
Quadro prevede che le regioni d'intesa con l'Ente parco possano disciplinare <strong>la</strong> gestione<br />
<strong>dell</strong>e "zone contigue" con piani e programmi. Probabilmente sarebbe utile estendere l'azione<br />
di raccordo oltre le zone contigue al fine di riconnettere <strong>la</strong> "rete ecologica" del parco coi<br />
sistemi di partico<strong>la</strong>re valore naturale del contesto territoriale. Documenti a livello<br />
internazionale ravvisano l'opportunità "di inserire le aree a protezione speciale nelle più<br />
ampie strategie di conservazione del<strong>la</strong> natura e riqualificazione ambientale" attivando anche<br />
forme di raccordo in ambito internazionale.<br />
La Legge Quadro prevede due strumenti capaci di stabilire effettive interazioni tra il livello<br />
del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> locale, quello nazionale e quello internazionale:<br />
o <strong>la</strong> "Carta del<strong>la</strong> Natura";<br />
o il "Programma triennale <strong>per</strong> le aree naturali protette".
Immaginando le aree protette come sistemi biologici a<strong>per</strong>ti, i cui confini quasi mai<br />
corrispondono con quelli amministrativi , sarà inoltre necessario prevedere in questa fase un<br />
adeguato raccordo normativo tra il piano del parco e gli altri strumenti urbanistici vigenti<br />
"oltre il parco". In tal senso potrebbero intervenire i singoli piani rego<strong>la</strong>tori comunali, i piani<br />
paesaggistici e, con maggiori probabilità di successo, il piano territoriale di coordinamento<br />
provinciale. Questo piano di area vasta di recente istituzione, in accordo con il piano <strong>per</strong> il<br />
parco, potrebbe contribuire al<strong>la</strong> "saldatura" tra aree protette e territorio circostante, ed al<strong>la</strong><br />
ricomposizione di "momenti e aspetti che rischierebbero altrimenti di sovrapporsi e più<br />
spesso di confliggere".<br />
• confronto e dibattito con gli enti e gli altri attori locali. La definizione di una prima<br />
delimitazione <strong>dell</strong>e aree e re<strong>la</strong>tiva normativa può divenire una base di discussione sufficiente<br />
ad aprire un confronto con gli enti territorialmente coinvolti ed a determinare <strong>la</strong><br />
partecipazione ampia ed anticipata (rispetto all'iter procedurale previsto dal<strong>la</strong> normativa) <strong>dei</strong><br />
diversi attori locali.<br />
• approfondimenti analitici. La stesura del<strong>la</strong> prima approssimazione di delimitazione (e<br />
re<strong>la</strong>tiva normativa) e <strong>la</strong> messa a punto di una serie di verifiche puntuali potrebbe far rilevare<br />
alcune significative carenze in ambito conoscitivo-valutativo. È bene <strong>per</strong>tanto prevedere in<br />
questa fase il ricorso ad eventuali mirati approfondimenti analitici<br />
5.3. Ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> e norme <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici<br />
L'ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> rappresenta l'ultima tappa del <strong>per</strong>corso di piano prospettato. Dovrà<br />
contenere <strong>per</strong>tanto <strong>la</strong> stesura finale del<strong>la</strong> proposta progettuale che si è evoluta e concretizzata<br />
passando attraverso diverse fasi: dall'idea di parco inclusa nell'approccio conoscitivo (fase 1), alle<br />
prime strategie progettuali, talora alternative, emerse dal<strong>la</strong> valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni (fasi 2 e 3);<br />
allo studio <strong>dell</strong>e connessioni funzionali nel<strong>la</strong> interpretazione <strong>dei</strong> complessi di unità di paesaggio<br />
(fase 4); al<strong>la</strong> prima approssimazione di delimitazione e bozza di normativa <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori<br />
(fase 5). In partico<strong>la</strong>re, in quest'ultima fase, verranno apportate ulteriori integrazioni ed<br />
aggiustamenti all'approssimazione di delimitazione (e bozza di normativa <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori)<br />
sul<strong>la</strong> base <strong>dell</strong>e verifiche di cui al punto precedente. La stesura finale <strong>dell</strong>'ipotesi di <strong>zonizzazione</strong> si<br />
articolerà come segue:<br />
• 1. revisione <strong>dei</strong> confini <strong>dell</strong>'area protetta e suddivisione del territorio in zone (A, B, C e D)<br />
ed eventuali sottozone a diverso grado di protezione con individuazione di normativa<br />
specifica <strong>per</strong> ognuna <strong>dell</strong>e zone e sottozone;<br />
• 2. proposta di delimitazione e di normativa <strong>per</strong> le aree contigue, come previsto ai sensi<br />
<strong>dell</strong>'art.32 del<strong>la</strong> L.394/91;<br />
• 3. normativa <strong>per</strong> settori tematici, includente almeno quelli indicati dal<strong>la</strong> legge quadro<br />
(accessibilità e <strong>per</strong>corsi veico<strong>la</strong>ri e pedonali, attrezzature e servizi <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione e <strong>la</strong><br />
funzione sociale del parco, attività ricettive, attività agroturistiche, interventi sul<strong>la</strong> flora,<br />
sul<strong>la</strong> fauna e sull'ambiente naturale un genere) e le più significative problematiche rilevate<br />
nell'interpretazione e valutazione <strong>dell</strong>e re<strong>la</strong>zioni. Questa o<strong>per</strong>azione potrebbe condurre a<br />
cartografare settori d'intervento non sempre corrispondenti alle aree di cui al punto 1);<br />
• 4. normativa <strong>per</strong> progetti (<strong>per</strong> aree speciali e aree campione). Le aree d'intervento potrebbero<br />
corrispondere con quelle utilizzate <strong>per</strong> <strong>la</strong> verifica progettuale.La valenza normativa <strong>dei</strong><br />
progetti è tale da <strong>la</strong>sciare sempre una certa flessibilità o<strong>per</strong>ativa al momento del<strong>la</strong> redazione<br />
esecutiva degli stessi.<br />
L'ipotesi di <strong>zonizzazione</strong>, con re<strong>la</strong>tiva normativa, distinta <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici, avrà <strong>la</strong><br />
valenza di piano <strong>per</strong> il parco. Sarà poi compito <strong>dell</strong>'ente parco valutare l'opportunità di dare spazio<br />
ad ulteriori progettazioni e pianificazioni settoriali a fronte di partico<strong>la</strong>ri tematiche emergenti.
È invece sin d'ora scontata <strong>la</strong> necessità di prevedere un processo di piano che continua il suo<br />
cammino attivando o<strong>per</strong>azioni di aggiornamento ed aggiustamento con tempi di revisione<br />
abbastanza ravvicinati.<br />
E. E<strong>la</strong>borati da produrre<br />
La proposta di <strong>zonizzazione</strong>, come pure tutti i precedenti passaggi del processo metodologico<br />
descritto, in qualsiasi modo si o<strong>per</strong>i (agendo su base cartacea o in forma digitalizzata), dovranno<br />
infine poter essere trasposti su base cartografica e sotto forma di re<strong>la</strong>zioni.<br />
Indichiamo quali potranno essere i principali e<strong>la</strong>borati, da considerarsi quali minimi inderogabili:<br />
• rappresentazione cartografica anche in forma digitalizzata <strong>dell</strong>'assetto attuale del territorio<br />
nei diversi approfondimenti tematici connessi ai principali settori disciplinari, alle loro più<br />
significative interre<strong>la</strong>zioni ed alle interpretazioni di valori, emergenze e fragilità, in sca<strong>la</strong><br />
1:25.000;<br />
• rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, <strong>dell</strong>e interferenze nei tre sistemi<br />
(fisico, biologico ed antropico) in sca<strong>la</strong> 1:25.000/1:10.000;<br />
• rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, <strong>dell</strong>e unità di paesaggio e <strong>dei</strong><br />
complessi funzionali di unità di paesaggio, in sca<strong>la</strong> 1:25.000/1:10.000;<br />
• rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, del<strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> <strong>dell</strong>'area, in<br />
sca<strong>la</strong> 1:25.000/1:10.000;<br />
• rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, <strong>dei</strong> principali tematismi (settori<br />
d'intervento) da normare;<br />
• rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, di eventuali interventi strategici<br />
in aree di rilevanza partico<strong>la</strong>re, in sca<strong>la</strong> 1:10.000/1:2.000;<br />
• programma finanziario di massima con indicazione <strong>dell</strong>e priorità;<br />
• progetti pilota e progetti specifici <strong>per</strong> aree campione ed aree speciali, da attuarsi attraverso<br />
singoli piani partico<strong>la</strong>reggiati o sistemi di piani partico<strong>la</strong>reggiati, in sca<strong>la</strong> adeguata;<br />
• norme di attuazione distinte <strong>per</strong> aree e <strong>per</strong> settori tematici.<br />
F. Sistema informativo territoriale da usare<br />
I sistemi di organizzazione ed e<strong>la</strong>borazione <strong>dei</strong> dati condizionano e sono a loro volta condizionati<br />
dal<strong>la</strong> metodologia descritta.<br />
Anche <strong>per</strong> questo motivo è bene accennare ai sistemi di costruzione ed utilizzazione <strong>dell</strong>e fonti<br />
informative che dovranno supportare i processi conoscitivi, valutativi e decisionali connessi al<strong>la</strong><br />
pianificazione <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong>.<br />
La redazione di un piano richiede:<br />
• acquisizione di cartografie di base;<br />
• acquisizione di dati già raccolti in precedenti es<strong>per</strong>ienze di ricerca e/o attività di<br />
pianificazione e di nuovi dati tramite rilievo diretto sul territorio;<br />
• organizzazione di o<strong>per</strong>azioni di valutazioni e sintesi alquanto complesse, connesse ad una<br />
visione sistemica del<strong>la</strong> realtà territoriale, capaci di aggregare e/o scomporre dati e<br />
informazioni interre<strong>la</strong>ti tra di loro, fino a <strong>per</strong>venire a schemi di piano "finali" capaci di<br />
accogliere successive revisioni.<br />
In partico<strong>la</strong>re, nel processo metodologico descritto <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>zonizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>parchi</strong> <strong>nazionali</strong>, sarà<br />
necessario compiere le seguenti o<strong>per</strong>azioni::
• organizzare <strong>la</strong> raccolta dati evidenziando e valutando l'elemento in quanto tale e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione<br />
che costruisce con elementi di altri sistemi;<br />
• evidenziare e valutare le interferenze antropiche nei tre sistemi (fisico, biologico ed<br />
antropico), sovrapponendo l'insieme degli interventi realizzati e/o previsti dall'uomo con i<br />
caratteri fisici e biologici e con il patrimonio storico-culturale;<br />
• evidenziare e valutare le diverse unità di paesaggio costruendo un cartografia di sintesi e<br />
rilevando l'identità visuale e culturale <strong>dell</strong>e singole unità attraverso <strong>la</strong> sovrapposizione ed<br />
integrazione <strong>dell</strong>'ambiente fisico, biotico ed antropico, anche utilizzando materiale<br />
fotografico;<br />
• aggregare le singole unità di paesaggio sul<strong>la</strong> base di criteri funzionali, <strong>per</strong> delimitare i<br />
complessi di unità;<br />
• costruire proposte di <strong>zonizzazione</strong> <strong>dell</strong>'area, verificabili ed aggiornabili.<br />
Sinora <strong>la</strong> maggior parte <strong>dell</strong>e informazioni utilizzate nel<strong>la</strong> pianificazione sono state acquisite in<br />
forma cartacea; è anche possibile rinvenire dati memorizzati su supporti magnetici ma non corre<strong>la</strong>ti<br />
ad una cartografia di base. Tali sistemi tradizionali non <strong>per</strong>mettono l'utilizzo <strong>dell</strong>e informazioni<br />
raccolte <strong>per</strong> successive e<strong>la</strong>borazioni ed analisi.<br />
Lo sviluppo <strong>dell</strong>'informatica e l'evoluzione <strong>dell</strong>e tecnologie di analisi territoriale mettono a<br />
disposizione sistemi e strumenti in grado di supportare o<strong>per</strong>azioni conoscitive e decisionali in<br />
ambiti caratterizzati dal<strong>la</strong> interdisciplinarietà (e quindi propri del<strong>la</strong> realtà territoriale).<br />
Tali strumenti, conosciuti come GIS (Geographic Information Systems) o, più semplicemente, SIT<br />
(Sistemi Informativi Territoriali) <strong>per</strong>mettono:<br />
• di gestire <strong>la</strong> cartografia di base tramite computer;<br />
• di georeferenziare i dati (attribuire ad ogni elemento le sue coordinate spaziali reali);<br />
• di effettuare collegamenti tra informazioni di diversa natura;<br />
• di e<strong>la</strong>borare le informazioni (attraverso associazioni e sovrapposizioni) secondo le finalità<br />
prefissate caso <strong>per</strong> caso;<br />
• di riportare tutte le e<strong>la</strong>borazioni su base cartografica, al<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> desiderata.<br />
In partico<strong>la</strong>re i SIT (Sistemi Informativi Territoriali) <strong>per</strong>mettono di supportare <strong>la</strong> redazione del<br />
piano del parco espletando le seguenti funzioni:<br />
• funzioni di editing o modifica di nuove entità e correzione/modifica <strong>dell</strong>e informazioni<br />
esistenti, sia grafiche sia alfanumeriche;<br />
• gestione di livelli logici: raggruppamento <strong>dell</strong>e informazioni in insiemi logici corrispondenti<br />
a significati diversi del contenuto informativo;<br />
• gestione di dati vettoriali e raster: trattamento congiunto di dati vettoriali e dati in formato<br />
raster (foto aeree, immagini da satellite, ecc.);<br />
• gestione del<strong>la</strong> topologia: adiacenza tra entità areali o connessione tra elementi lineari;<br />
• corre<strong>la</strong>zione tra elementi grafici e descrittivi: gestione automatica del collegamento fra dati<br />
grafici e descrittivi presenti in banche dati anche di tipo differenti con re<strong>la</strong>zioni di tipo m-n;<br />
• continuum spaziale: unione di mappe provenienti dal<strong>la</strong> digitalizzazione di più fogli in un<br />
unico tema geografico;<br />
• mosaico: trasformazione del continuum spaziale in un insieme di fogli;<br />
• over<strong>la</strong>y topologico: fusione verticale di più tematismi in modo da ottenere un nuovo<br />
tematismo costituito dal<strong>la</strong> somma sia <strong>dell</strong>e primitive grafiche sia degli attributi degli ntematismi<br />
fusi;<br />
• buffering: creazione automatica di fasce di rispetto;
• viste, tematismi, legende: creazione di viste o tematismi ottenuti da re<strong>la</strong>zioni con altre basedati<br />
e creazione di legende di c<strong>la</strong>ssi di valori con colorazione e graficismi definibili<br />
dall'utente;<br />
• import/export: ossibilità di scambiare dati in formati compatibili con i più diffusi programmi<br />
applicativi.<br />
Infine è importante sottolineare che i Sistemi Informativi Territoriali, dopo aver supportato <strong>la</strong><br />
redazione del piano, potranno divenire lo strumento base <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione del piano (ivi compreso<br />
l'adeguamento alle mutate caratteristiche ambientali), contribuendo all'esplicazione <strong>dell</strong>e seguenti<br />
attività:<br />
• amministrativa (ri<strong>la</strong>scio di autorizzazioni e pareri)<br />
• informativo turistica (gestione <strong>dei</strong> centri-visita, ingressi al parco, sentieristica, sportelli<br />
informativi, ...);<br />
• didattica (aule verdi, <strong>per</strong>corsi natura, ...);<br />
• ricerca scientifica (studi specifici, s<strong>per</strong>imentazioni, monitoraggi, ...);<br />
• organizzazione <strong>dei</strong> settori d'intervento (servizi di prevenzione incendi, vigi<strong>la</strong>nza, gestione<br />
faunistica, gestione forestale, manutenzione sentieri, ...);<br />
• diffusione <strong>dell</strong>e informazioni (attraverso un'architettura informativa distribuita costituita da<br />
poli di servizio collegati in rete, ...).<br />
G. Ufficio di piano<br />
La scelta di creare un ufficio di piano risponde a tre principali criteri:<br />
• 1. garantire <strong>la</strong> massima artico<strong>la</strong>zione e flessibilità <strong>dell</strong>e indagini e del progetto in rapporto<br />
alle esigenze di gestione del piano e più in generale di controllo del territorio del parco;<br />
• 2. garantire un coordinamento progettuale fattivo con i diversi soggetti istituzionali e sociali<br />
coinvolti dal piano <strong>per</strong> il parco;<br />
• 3. favorire il radicamento sul territorio di tutti i programmi di organizzazione territoriale.<br />
La struttura e l'organizzazione <strong>dell</strong>'Ufficio di Piano del Parco rispecchierà l'artico<strong>la</strong>zione del piano<br />
stesso così come prefigurato da questo documento.<br />
I profili professionali previsti all'interno <strong>dell</strong>'Ufficio di Piano sono di tre tipi:<br />
• 1. funzionari <strong>dell</strong>'Ente Parco o di enti locali coinvolti nel<strong>la</strong> e<strong>la</strong>borazione del piano;<br />
• 2. consulenti incaricati con diverse funzioni ( coordinamento scientifico, e<strong>la</strong>borazioni<br />
conoscitive e progettuali, o approfondimenti su temi specifici);<br />
• 3. neo<strong>la</strong>ureati con incarico a tempo determinato (secondo le procedure previste dal<strong>la</strong><br />
normativa vigente e già s<strong>per</strong>imentate in altri piani) in rapporto alle diverse aree d'indagine<br />
del piano.<br />
I professionisti coinvolti, in partico<strong>la</strong>re quelli di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere figure che<br />
abbiano già maturato es<strong>per</strong>ienze professionali e di ricerca di tipo interdisciplinare.<br />
Il responsabile <strong>dell</strong>'Ufficio di Piano è individuato nel<strong>la</strong> figura del direttore del parco, con funzioni<br />
di raccordo tra l'Ufficio di Piano, organi direttivi del Parco e Coordinamento tecnico-istituzionale,<br />
di cui al punto successivo.<br />
Il direttore del Parco coordinerà anche l'organizzazione generale <strong>dell</strong>'Ufficio di Piano avvalendosi<br />
<strong>dei</strong> seguenti apporti:<br />
• a. un consulente a supporto del<strong>la</strong> gestione tecnico-giuridico-amministrativa del piano;
• b. un col<strong>la</strong>boratore a supporto del<strong>la</strong> segreteria organizzativa <strong>dell</strong>'Ufficio (neodiplomato a<br />
tempo determinato).<br />
È auspicabile l'istituzione di un coordinamento tecnico istituzionale in cui siano presenti funzionari<br />
designati dagli Enti locali direttamente coinvolti nel processo di pianificazione (regioni e province)<br />
con funzione di raccordo, verifica e confronto sulle scelte progettuali del piano.<br />
È prevista <strong>la</strong> figura di un coordinatore scientifico con funzioni di direzione, raccordo e verifica degli<br />
e<strong>la</strong>borati di piano. Sarà in partico<strong>la</strong>re compito del coordinatore definire il programma o<strong>per</strong>ativo di<br />
<strong>la</strong>voro (tempistica dettagliata), <strong>la</strong> sua attuazione, <strong>la</strong> coerenza e completezza (singo<strong>la</strong> e d'insieme)<br />
<strong>dell</strong>e diverse e<strong>la</strong>borazioni del piano.<br />
Le e<strong>la</strong>borazioni tecniche del piano, così come previste dal presente documento, saranno svolte da<br />
gruppi di <strong>la</strong>voro re<strong>la</strong>tivi ai diversi "sistemi" individuati con le loro eventuali artico<strong>la</strong>zioni interne;<br />
ogni gruppo di <strong>la</strong>voro sarà composto da un consulente responsabile (con i suoi col<strong>la</strong>boratori) e da<br />
alcuni giovani neo-<strong>la</strong>ureati.<br />
È prevista <strong>la</strong> presenza di giovani neo<strong>la</strong>ureati, in rapporto alle e<strong>la</strong>borazioni sistemiche, con funzioni<br />
o<strong>per</strong>ative, tra cui quel<strong>la</strong> principale di <strong>la</strong>vorare all'informatizzazione del piano (predisposizione ed<br />
immissione dati, re<strong>la</strong>tiva costruzione di carte informatizzate). Sono previste infine consulenze ad<br />
hoc su singoli temi specialistici.<br />
Non è possibile in questa sede specificare con più esattezza quali potranno essere le professionalità<br />
coinvolte nell'attività di piano. Tale scelta dipenderà in modo diretto dai tematismi oggetto di<br />
indagine re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> specifica area protetta.