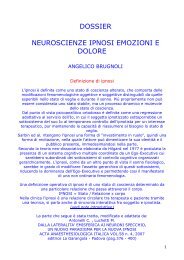Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>del</strong>l’informazione, per coordinare gli esseri umani, le cui consapevolezze sono opache<br />
le une per le altre: ognuno vive in funzione di proprie assunzioni, desideri, scopi,<br />
priorità, e non percepisce immediatamente quelle degli altri. Si pensi alla necessità che i<br />
pompieri spengano in tempi brevi un incendio. In tal caso pare opportuno che<br />
un'autorità esperta sia in grado di dare ordini efficaci.<br />
L’alternativa, per riuscire ad avere sinergie desiderate tra esseri umani, è il consenso, la<br />
coordinazione tramite contrattazione e la condivisione intorno a scopi da raggiungere e<br />
ai metodi per riuscirci.<br />
Tuttavia i dipendenti seguono le istruzioni e i cittadini seguono le leggi in misura molto<br />
maggiore di quanto sia spiegabile facendo riferimento sia a contrattazione che a<br />
meccanismi di controllo: in genere facciamo riferimento ad una confidenza implicita<br />
nelle tradizioni <strong>del</strong> “si fa così“, in convenzioni quindi che tengono nella misura in cui<br />
non vengano messe in discussione e che si basano su condizionamenti sociali – un<br />
apparato poliziesco sarebbe molto più costoso che efficace, se non fosse così.<br />
Questi condizionamenti sono economici: risparmiano al singolo il doversi prendere di<br />
volta in volta e continuamente la responsabilità di ogni piccolo gesto quotidiano,<br />
servono quindi allo stesso modo di credenze e pregiudizi.<br />
<strong>Gli</strong> esperimenti di Milgram mostrano che chi ubbidisce all'autorità lo fa perché si<br />
aspetta che gli altri se lo aspettino: sull'autorità convergono le aspettative sociali, e per<br />
questo l'autorità si rende riconoscibile con simboli che la comunicano (palazzi pomposi,<br />
rituali e segnali, come il camice bianco dei direttori <strong>del</strong>l’esperimento).<br />
Le persone controbilanciano l'autorità col senso di responsabilità individuale, ma il<br />
bisogno di sentirsi accettati dagli altri, quello che altrove chiamo la “libido sociale“<br />
(Scarpa 2009) spinge al quotidiano conformismo <strong>del</strong>l’inconsapevolezza, <strong>del</strong>l’“andare in<br />
automatico“ nel fare quel che ci viene richiesto, nel rassicurante identificarci con<br />
altisonanti titoli e nel citare autori famosi. Una fiducia rischiosa: l'autorità istituzionale,<br />
in quanto tale, ignora il sentire individuale, ed è proprio questo sentire che ci segnala<br />
immediatamente, con l’emozione, la qualità di un comportamento. Se crediamo senza<br />
ombra di dubbio che chi riveste l'autorità (il dirigente, il medico, il ricercatore) sa quel<br />
che sta facendo, <strong>siamo</strong> disponibili ad azioni che personalmente non sceglieremmo mai,<br />
per le quali non ci prenderemmo in nessun caso la responsabilità.<br />
L’osservare i propri pensieri e il proprio sentire ci esonera dalla comodità <strong>del</strong> far<br />
riferimento ad una autorità e dai rischi connessi. Osservandoli con “sguardo<br />
etnografico” (Scarpa, 2009) riusciamo a scoprire le assunzioni implicite dietro ad essi,<br />
le credenze e le aspettative. L’emozione <strong>del</strong>la sorpresa, ce ne segnalano l’esistenza:<br />
educarci ad un consapevole sentire il nostro sentire ci fa scoprire un nuovo livello di<br />
consapevolezza.<br />
Se ad esempio sento rabbia mi posso chiedere: “come mi sento nel sentire rabbia?” e<br />
scoprire la <strong>del</strong>usione, o la tristezza, che vi sta dietro. Ma posso sentirmi <strong>del</strong>usa solo<br />
sulla base di mie aspettative, che in modo posso scoprire, far venire alla luce <strong>del</strong>la<br />
coscienza. Ecco che il nostro stesso sentire rientra tra i fenomeni da osservare, come il<br />
nostro assegnare significati ad ogni cosa. Sia rendendoci conto <strong>del</strong>le nostre categorie e<br />
concetti, con Krishnamurti, sia osservando il funzionamento <strong>del</strong>la nostra mente come il<br />
fenomeno antropologico <strong>del</strong> nostro stesso creare significati, si tratta allora di „rendere<br />
visibile ciò che è già sotto gli occhi di tutti“, di far vedere quel che è „così vicino a <strong>noi</strong><br />
da rendersi invisibile“ come direbbe Michel Foucault, di smascherare pratiche<br />
quotidiane che crediamo non problematiche.<br />
<strong>Il</strong> <strong>conflitto</strong> non ci piace: non sappiamo come gestirlo, preferiamo l’armonia. Eppure, il<br />
<strong>conflitto</strong> <strong>siamo</strong> <strong>noi</strong>: il tessuto di desideri e bisogni e scopi che l'umanità intesse<br />
instancabilmente. Tuttavia, l'umanità non è che un concetto. Quelle che esistono<br />
davvero sono le persone, con un nome, un cognome e un indirizzo, strettamente<br />
Riflessioni Sistemiche - N° 4 maggio 2011 112