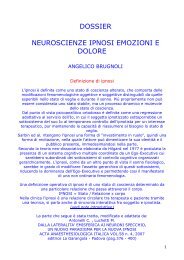Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
Il conflitto siamo noi. Gli strumenti cognitivi del pensiero sistemico e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Esseri condizionati<br />
La nostra mente, nel pensare usando i concetti con cui ci identifichiamo, crea<br />
invariabilmente il <strong>conflitto</strong>. Ed è in grado di interpretarlo sia come qualcosa di doloroso,<br />
da evitare, sia come grande occasione, come una finestra per esperire il mondo<br />
<strong>del</strong>l’altro, con le sua assunzioni e i suoi desideri, e i nostri condizionamenti. Da che<br />
cosa <strong>siamo</strong> condizionati? Tutte le idee che abbiamo di <strong>noi</strong> stessi, e di altri, sono frutto di<br />
condizionamenti: se diciamo, ad esempio, “sono italiano“, oppure “credo nell’approccio<br />
<strong>sistemico</strong>“, mi aggrappo a condizionamenti. Siamo storicamente abituati a credere che<br />
una “nazione“ esista, come esistono mele e pere, e se rispondiamo al suo appello, ad<br />
esempio in un <strong>conflitto</strong> armato, crediamo perfino che sia nostro dovere combattere.<br />
Altre frasi banali come “sono un insegnante“, o “Antonio è un cuoco“ fanno riferimento<br />
a generalizzazioni che semplificano la complessità, a caratteristiche che si ritengono<br />
condivise da chi ascolta, a interi pacchetti di pregiudizi. Credenze, concetti e pregiudizi<br />
servono alla mente per non far la fatica di osservare ad ogni passo ogni <strong>pensiero</strong>:<br />
servono ad economizzare le energie mentali, a non affaticarci. Se ho bisogno di<br />
confermarmi l’idea di me stessa, di essere “una buona insegnante“, questo mi<br />
condiziona. Sentirò avversione verso chi si comporta in modo da rendermi difficile<br />
(secondo me!) comportarmi di conseguenza: ad esempio vivrò come attacchi gli<br />
studenti che fanno baccano. Vivendoli così, andrò in automatico sulla difensiva,<br />
attaccando a mia volta. Ma ciò contraddice l’immagine di me stessa, che voglio<br />
preservare: per cui sentirò il bisogno di dar loro la colpa <strong>del</strong> mio “dover“ reagire così.<br />
Dare la colpa all’altro ci serve a preservare la nostra immagine di <strong>noi</strong> stessi, se non<br />
accettiamo parti di <strong>noi</strong> dolenti e imperfette: condizionati dal nostro dover-essere ci<br />
riesce difficile accorgerci che tutti fanno esattamente quel che al momento possono, nel<br />
sistema di interrelazioni, <strong>noi</strong> compresi. L’attaccamento all’idea di <strong>noi</strong> stessi ci<br />
impedisce la benevolenza: <strong>siamo</strong> più sensibili al nostro bisogno di conferme che alla<br />
vulnerabilità <strong>del</strong>l’altro, al suo bisogno di conferme.“Andare in automatico“, spinti da<br />
avversione e attaccamento alle nostre convinzioni è il contrario di quella libertà dai<br />
condizionamenti che secondo Krishnamurti pos<strong>siamo</strong> raggiungere con la<br />
consapevolezza e l’osservazione non giudicante. Non credere alle nostre svariate<br />
convinzioni, ma osservarle con distacco, con consapevolezza e simpatia per questi<br />
dolenti esseri umani che <strong>noi</strong> <strong>siamo</strong>, e che hanno bisogno, evidentemente, <strong>del</strong>le etichette<br />
che danno comunemente ad ogni cosa, anche a se stessi: ci può aiutare ad abbassare la<br />
nostra intrinseca conflittualità. La chiave per de-condizionarci: dare con semplicità e<br />
accettazione tutta la nostra attenzione a quel che percepiamo, situazione o emozione,<br />
senza esprimere giudizi, senza parteggiare, senza essere d’accordo o meno, senza<br />
razionalizzazioni: stare con ciò che è come è. L’insegnante che sente frustrazione in<br />
classe può ad esempio fermarsi ad osservare il suo stesso sentire. Esprimere in modo<br />
descrittivo quel che sente, se si fida degli alunni, e se non si fida: accorgersene. Notare<br />
come la tensione provenga dalle sue stesse assunzioni nei loro riguardi. Si può chiedere:<br />
“Che cosa, in me, mi porta a sentire avversione verso questa situazione? Di che cosa ho<br />
bisogno? Davvero “devo“ dimostrare di essere una brava insegnante? E quali sono le<br />
mie convinzioni rispetto ad essa?“<br />
Con-sapevolezza e co-scienza sono interessanti sinonimi: si tratta di rendersi conto di<br />
quel che si sa, di sapere quel che sappiamo, e sulla base di quali assunzioni. E’<br />
indicativo che nella nostra lingua la coscienza sia anche quella parte di <strong>noi</strong> che “sa“<br />
come non danneggiare gli altri. Chi riflette con consapevolezza sulle assunzioni dietro<br />
ai concetti che usa, si ritiene sia una persona coscienziosa, che ascolta la propria<br />
coscienza. E, se è il caso, non ubbidisce ad ordini per essa inaccettabili. Quelli<br />
accettabili, in quanto ragionevolmente spiegabili nelle loro motivazioni, non occorre che<br />
Riflessioni Sistemiche - N° 4 maggio 2011 108