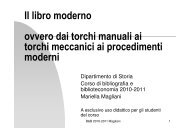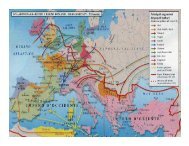(Gen 1, 1-5): Filone, Origene, Basilio - Dipartimento di Storia
(Gen 1, 1-5): Filone, Origene, Basilio - Dipartimento di Storia
(Gen 1, 1-5): Filone, Origene, Basilio - Dipartimento di Storia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
· Bibliografia<br />
Laurea triennale in filosofia a.a. 2008/2009<br />
Corso <strong>di</strong> storia del cristianesimo<br />
«In principio»: esegesi antiche del racconto del primo giorno della<br />
creazione (<strong>Gen</strong> 1, 1-5): <strong>Filone</strong>, <strong>Origene</strong>, <strong>Basilio</strong><br />
· <strong>Gen</strong> 1-2 secondo TM e LXX<br />
· Lettura giudaica e cristiana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2<br />
— <strong>Filone</strong> <strong>di</strong> Alessandria: De opificio mun<strong>di</strong> §§ 1- 34<br />
· Esegesi <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2 fra gli autori cristiani fino a <strong>Origene</strong><br />
— <strong>Origene</strong> <strong>di</strong> Alessandria: Commento alla <strong>Gen</strong>esi (ap. Eus. PE VII 20; Calc. In Tim.<br />
276-278)<br />
— <strong>Origene</strong> <strong>di</strong> Alessandria: dal De principiis (I praef. 6-10; 3, 3; II 3, 6; 9, 1; III 6, 8-9)<br />
— <strong>Origene</strong> <strong>di</strong> Alessandria: dal Commento a Giovanni (I 90-124)<br />
— <strong>Origene</strong> <strong>di</strong> Alessandria: dalle Omelie sulla <strong>Gen</strong>esi (I 1-2)<br />
— <strong>Origene</strong> <strong>di</strong> Alessandria: dal Contro Celso (VI 49-52)<br />
· <strong>Basilio</strong> <strong>di</strong> Cesarea<br />
— <strong>Basilio</strong> <strong>di</strong> Cesarea: dalle Omelie sull’esamerone (I)<br />
<strong>Basilio</strong> <strong>di</strong> Cesarea<br />
Bibliografia: fonti<br />
BASILIO DI CESAREA, Sulla <strong>Gen</strong>esi (Omelie sull’Esamerone), a cura <strong>di</strong> M. NALDINI, Milano,<br />
Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 1990 (Scrittori greci e latini).<br />
BASILE DE CÉSARÉE, Homélies sur l’Hexaéméron, texte grec, introduction et traduction<br />
de S. GIET, Paris, Les É<strong>di</strong>tions du Cerf, 1968 (Sources Chrétiennes, 26 bis).<br />
Eusebio <strong>di</strong> Cesarea<br />
EUSÈBE DE CÉSARÉE, La préparation évangelique. Livres VII, introduction, traduction et<br />
annotation par G. SCHROEDER, texte grec révisé par É. DES PLACES, Paris, Les é<strong>di</strong>tions<br />
du Cerf, 1975 (SChr 215).<br />
<strong>Filone</strong> <strong>di</strong> Alessandria<br />
Tutti i trattati del Commentario allegorico alla Bibbia, a cura <strong>di</strong> R. RADICE, con la collaborazione<br />
<strong>di</strong> G. REALE, C. KRAUS REGGIANI, C. MAZZARELLI, Milano, Rusconi, 1994<br />
(Collana I classici dello spirito).<br />
1
<strong>Origene</strong><br />
ORIGENES, Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg. übersetzt, mit kritischen und erläuternden<br />
Anmerkungen versehen v. H. GÖRGEMANNS - H. KARPP, Darmstadt, Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft, 1992 3 [1985] (Texte zur Forschung, 24).<br />
ORIGÈNE, Commentaire sur Saint Jean, 5 voll., texte grec, avant-propos, traductione et<br />
notes par C. BLANC, Paris, Les é<strong>di</strong>tions du Cerf, 1966-1992, (SCh, 120bis; 1970, SCh<br />
157; 1975, SCh 222; 1982, SCh 290; 1992, SCh 385).<br />
ORIGÈNE, Homélies sur la <strong>Gen</strong>èse, nouvelle é<strong>di</strong>tion, introduction de H. DE LUBAC – L.<br />
DOUTRELEAU, texte latin, traduction et notes de L. DOUTRELEAU, Paris, Les é<strong>di</strong>tions du<br />
Cerf, 1976 (SCh, 7bis).<br />
Origène. Contre Celse, 5 voll., introduction, texte critique, traduction et notes par M.<br />
BORRET, Paris, Les é<strong>di</strong>tions du Cerf, 1967-1976 (Sources chrétiennes, 132, 136, 147,<br />
150, 227). [Il vol. V contiene l’introduzione generale e gli in<strong>di</strong>ci]<br />
Die >Wahre Lehre< des Kelsos, übersetzt und erklärt von HORACIO E. LONA, Freiburg<br />
- Basel - Wien, Herder, 2005 (Kommentar zu frühchristlichen Apologeten. Ergänzungsband<br />
1).<br />
CELSO, Il <strong>di</strong>scorso vero, a cura <strong>di</strong> G. LANATA, Milano, Adelphi, 1994 [1987] (Piccola<br />
biblioteca Adelphi, 206).<br />
· <strong>Gen</strong>erali<br />
Bibliografia: stu<strong>di</strong><br />
BALTES, MATHIAS, !"#$%&% (Platon. Tim. 28 B 7). Ist <strong>di</strong>e Welt real entstanden oder<br />
nicht?, in ID., '()*+,-).). Kleine Schriften zu Platon und zum Platonismus, hrsg.<br />
von A. HÜFFMEIER – M.-L. LAKMANN und M. VORWERK, Stuttgart-Leipzig, B.G. Teubner,<br />
1999, pp. 303-325 (Beiträge zur Alertumskunde, 123).<br />
BALTES, MATTHIAS, Die Weltentstehung des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten.<br />
Teil I, Leiden, 1976 (Philosophia antiqua, 30).<br />
BARDET, SERGE, Ellenismo e giudaismo, in Il sapere greco. Dizionario critico, II, a cura<br />
<strong>di</strong> J. BRUNSCHWIG - G.E.R. LLOYD, e<strong>di</strong>zione italiana a cura <strong>di</strong> M.L. CHIESARA, Torino,<br />
Einau<strong>di</strong>, 2005 [1996], pp. 445-458.<br />
BERCHMAN, ROBERT M., From Philo to Origen. Middle Platonism in Transition, Chicago,<br />
Scholars Press, 1984 (Brown Judaic Stu<strong>di</strong>es, 69).<br />
BORI, PIER CESARE, L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana antica e le sue<br />
trasformazioni, Bologna, Il Mulino, 1987 (Saggi, 326).<br />
BOYS-STONES, GEORGE R., Post-Hellenistic Philosophy. A Study of its Development from<br />
the Stoics to Origen, New York-Oxford, Oxford University Press, 2001.<br />
BRISSON, LUC, Le démiurge du Timée et le créateur de la <strong>Gen</strong>èse, in Le style de la pensée,<br />
ed. M. CANTO-SPERBER - P. PELLEGRIN, Paris, Les Belles Lettres, 2002, pp. 25-39.<br />
CHADWICK, HENRY, Early Christian Thought and the Classical Tra<strong>di</strong>tion. Stu<strong>di</strong>es in Justin,<br />
Clement and Origen, Oxford, At the Clarendon Press, 1966 [su <strong>Origene</strong> le pp. 85-<br />
123]. Trad. it. ID., Pensiero cristiano antico e tra<strong>di</strong>zione classica, a cura <strong>di</strong> G. LUSINI, Firenze,<br />
La Nuova Italia, 1995 (Biblioteca <strong>di</strong> cultura, 205).<br />
2
Y.-M. CONGAR, Le thème de Die créateur dans la tra<strong>di</strong>tion chrétienne, in L’homme devant<br />
Dieu. Mélanges H. de Lubac, I, Paris, 1963, pp. 189-222.<br />
COOK, JOHN GRANGER, The Interpretations of the Old Testament in Greco-Roman Paganism,<br />
Mohr, 2004 (STAC, 23).<br />
DANIÉLOU, JEAN, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Bologna, Il Mulino, 1975<br />
[1961] (Collana <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> religiosi).<br />
DILLON, JOHN, The Middle Platonists. A Study of Platonism 80 b.C. to A.D. 220, London,<br />
Duckworth, 1977. [Nuova ed. 1996]<br />
Divine creation in ancient, me<strong>di</strong>eval and early modern thought : essays presented to the<br />
Rev'd Dr. Robert D. Crouse, e<strong>di</strong>ted by M. TRESCHOW - W. OTTEN - W. HANNAM, Leiden,<br />
Brill, 2007.<br />
H. DÖRRIE† - M. BALTES, Der Platonismus in der Antike. Grundlagen - System - Entwicklung,<br />
IV, Die philosophische Lehre des Platonismus. Einige grundlegende Axiome /<br />
Platonische Physik (im antiken Verständnis) I. Bausteine 101-124: Text, Uebersetzung,<br />
Kommentar, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann - Holzboog, 1996.<br />
H. DÖRRIE† - M. BALTES, Der Platonismus in der Antike. Grundlagen - System - Entwicklung,<br />
V, Die philosophische Lehre des Platonismus. Platonische Physik (im antiken<br />
Verständnis) II. Bausteine 125-150: Text, Uebersetzung, Kommentar, Stuttgart-Bad Cannstatt,<br />
Frommann - Holzboog, 1998.<br />
DÖRRIE, HEINRICH, Divers aspects de la cosmologie de 70 av. J.-C. a 20 ap. J.-C., in ID.,<br />
Platonica minora, München, Wilhelm Fink Verlag, 1976,pp. 89-99 (Stu<strong>di</strong>a et testimonia<br />
antiqua, 8). Prec. ed. «Revue de Théologie et de Philosophie», (1972), pp. 400-412.<br />
FESTUGIÈRE, ANDRÉ-JEAN, Le Compen<strong>di</strong>um Timaei de Galien, in ID., Études de philosophie<br />
grecque, Paris, Libraire philosophique J. Vrin, 1971, pp. 487-506 (Bibliothèque<br />
d’histoire de la philosophie). Prec. ed. in «Revue des Études Grecques», 65 (1952), pp.<br />
97-116.<br />
FURLEY, DAVID J., Cosmologia, in Il sapere greco. Dizionario critico, I, a cura <strong>di</strong> J.<br />
BRUNSCHWIG - G.E.R. LLOYD, e<strong>di</strong>zione italiana a cura <strong>di</strong> M.L. CHIESARA, Torino, Einau<strong>di</strong>,<br />
2005 [1996], pp. 346-371.<br />
HAMMAN, ADALBERT, L’enseignement sur la création dans l’antiquité chrétienne, «Revue<br />
des sciences religieuses», 42 (1968), pp. 1-23; 97-122.<br />
In Principio. Interprétations des Premiers versets de la <strong>Gen</strong>èse, Paris, Études augustiniennes,<br />
1973 (Centre d’Études des religions du Livre).<br />
LE BOULLUEC, ALAIN, Ellenismo e cristianesimo, in Il sapere greco. Dizionario critico,<br />
II, a cura <strong>di</strong> J. BRUNSCHWIG - G.E.R. LLOYD, e<strong>di</strong>zione italiana a cura <strong>di</strong> M.L. CHIESARA,<br />
Torino, Einau<strong>di</strong>, 2005 [1996], pp. 430-444.<br />
LINDESKOG, G., Schöpfer und Schöpfung in den Schriften der Apostolischen Väter, in Aufstieg<br />
und Niedergang der römischen Welt, II/27.1, hrsg. v. W. HAASE, Berlin - New<br />
York, Walter de Gruyter, 1993, pp. 588-648.<br />
PÉPIN, JEAN, Exégèse de «In principio» et théorie des principes dans l’Exameron (I, 4,<br />
12-16), in Ambrosius episcopus. Atti del congresso internazionale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> ambrosiani nel<br />
XVI centenario della elevazione <strong>di</strong> sant’Ambrogio alla cattedra episcopale (Milano,<br />
1974), I, Milano, 1976, pp. 427-482 (Stu<strong>di</strong>a Patristica Me<strong>di</strong>olanensia, 6).<br />
3
PÉPIN, JEAN, Théologie cosmique et théologie chrétienne (Ambroise, Exam. I 1, 1-4),<br />
Paris, Presses Universitaires de France, 1964 (Bibliothèque de philosophie contemporaine.<br />
Histoire de la philosophie et philosophie générale).<br />
PÉREZ DE LABORDA, A., El mundo como creación: comentarios filosóficos sobre el pensamiento<br />
de Ireneo de Lión, Orígenes y <strong>Basilio</strong> de Cesarea, «Helmantica», 46 (1995), pp.<br />
33-80.<br />
PETERS, EDWARD, What Was God Doing before he Created the Heavens and Earth?,<br />
«Augustiniana», 34 (1984), pp. 53-74.<br />
PHILLIPS, JOHN, Neoplatonic exegeses of Plato’s cosmogony (Tim. 27C - 28C), «Journal<br />
of the History of Philosophy», 35 (1997), pp. 173-197.<br />
Platons Timaios als Grundtext der Kosmologie in Spätantike, Mittelalter und<br />
Renaissance, hrsg. von TH. LEINKAUF - C. STEEL, Leuven, Leuven University Press, 2005<br />
(Ancient and Me<strong>di</strong>eval Philosophy, 34).<br />
REPELLINI, FERRUCCIO FRANCO, Cosmologie greche, Torino, Loescher, 1980 (<strong>Storia</strong> della<br />
scienza, 16).<br />
RINALDI, GIANCARLO, La Bibbia dei pagani, I, Quadro storico, Bologna, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane,<br />
1997 (La Bibbia nella storia, 19).<br />
RINALDI, GIANCARLO, La Bibbia dei pagani, II, Testi e documenti, Bologna, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane,<br />
1998 (La Bibbia nella storia, 20).<br />
RUNIA, DAVID T., Festugière Revisited: Aristotle in the Greek Fathers, «Vigiliae Christianae»,<br />
43 (1989), pp. 1-34. [segnala allusioni ad Aristotele nel corpus origeniano]<br />
SIMONETTI, MANLIO, Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica,<br />
Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1985 (Stu<strong>di</strong>a ephemeri<strong>di</strong>s «Augustinianum»,<br />
23). [pp. 9-19; 65-107; 135-156]<br />
J.C.M. VAN WINDEN, «In the Beginning». Some Observations on the Patristic Interpretations<br />
of <strong>Gen</strong>esis 1, 1, «Vigiliae Christianae», 17 (1963), pp. 105ss.<br />
J.C.M. VAN WINDEN, The Early Christian Exegesis of ‘Heaven and Earth’ in <strong>Gen</strong>esis 1,<br />
1, in Romanitas et Christianitas. Festschrift Waszink, Amsterdam, 1973, pp. 371-382.<br />
VERBEKE, GÉRARD, Some Later Views on Divine Creation and the Eternity of the World,<br />
in Neoplatonism and Christian Thought, ed. D.J. O’MEARA, Norfolk (Va), International<br />
Society for Neoplatonic Stu<strong>di</strong>es, 1982, pp. 45-53; 241-244 (Stu<strong>di</strong>es in Neoplatonism, 3).<br />
· Bibbia<br />
ALEXANDRE, MONIQUE, Le commencement du livre <strong>Gen</strong>èse I-V. La version grecque de<br />
la Septante et sa réception, Paris, Beauchesne, 1988 (Christianisme antique, 3).<br />
P. BEAUCHAMP, Création et séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la<br />
<strong>Gen</strong>èse, Paris, 1969.<br />
L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, a cura <strong>di</strong> P. MERLO, Roma,<br />
Carocci, 2008 (Frecce, 60). [pp. 19-48; 99-127]<br />
La Bible d’Alexandrie, LXX. I. La <strong>Gen</strong>èse, introduction, traduction et notes par M.<br />
HARL et ses collaborateurs, Paris, Les É<strong>di</strong>tions du Cerf, 1986.<br />
La Bible Grecque des Septante, publié par G. DORIVAL - M. HARL - O. MUNNICH, Paris,<br />
Les É<strong>di</strong>tions du Cerf, ?.<br />
4
LAMARCHE, PAUL, La Septante, in Le monde grec ancien et la Bible, sous la <strong>di</strong>rection de<br />
C. MONDÉSERT, Paris, Beauchesne, 1984, pp. 19-35 (Bible de tous les temps).<br />
SKA, JEAN LOUIS, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione<br />
dei primi cinque libri della Bibbia, Bologna, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane, 2000 (Collana biblica).<br />
TILLY, MICHAEL, Einführung in <strong>di</strong>e Septuaginta, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellaschaft,<br />
2005 (Einführung Theologie).<br />
· <strong>Filone</strong><br />
ARNALDEZ, ROGER, La Bible de Philon d’Alexandrie, in Le monde grec ancien et la Bible,<br />
sous la <strong>di</strong>rection de C. MONDÉSERT, Paris, Beauchesne, 1984, pp. 37-54 (Bible de<br />
tous les temps).<br />
BOYANCÉ, PIERRE, Philon Stu<strong>di</strong>en, in Der Mittelplatonismus, hrsg. v. C. ZINTZEN, Darmstadt,<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, pp. 33-51 (Wege der Forschung, 70).<br />
Prec. ed. in «Revue des Études Grecques», 76 (1963), pp. 79-82.<br />
CALABI, FRANCESCA, Conoscibilità e inconoscibilità <strong>di</strong> Dio in <strong>Filone</strong> <strong>di</strong> Alessandria, in<br />
Arrhetos Theos. L’ineffabilità del primo principio nel me<strong>di</strong>o platonismo, a cura <strong>di</strong> F. CA-<br />
LABI, Pisa, E<strong>di</strong>zioni ETS, 2002 (Filosofia, 55), 35-54.<br />
NIKIPROWETZKY, V., Problèmes du récit de la création chez Philon d’Alexandrie, «REJ»<br />
124 (1965), pp. 271-306.<br />
Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie. Actes du colloque international organisé<br />
par le Centre d’études sur la philosophie hellénistique et romaine de<br />
l’Université de Paris XII-Val de Marne (Créteil, Fontenay, Paris, 26-28 octobre 1985),<br />
éd. par C. LÉVY, Turnhout, Brepols, 1998 (Monothéismes et philosophie).<br />
RUNIA, DAVID T., Philo and Origen: a preliminary survey, in Origeniana Quinta. Historica,<br />
text and method, biblica, philosophica, theologica, Origenism and later developments.<br />
Papers of the 5th International Origen Congress (Boston College, 14-18 August<br />
1989), e<strong>di</strong>ted by R. DALY, Leuven, Leuven University Press-Peeters, 1992, pp. 333-339<br />
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 105).<br />
THEILER, WILLY, Philo von Alexandria und der Beginn des kaiserzeitlichen Platonismus,in<br />
Parusia. Stu<strong>di</strong>en zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Platonismus.<br />
Festgabe für Johannes Hirschberger, hrsg. v. K. FLASCH, Frankfurt a.M., Minerva,<br />
1965, pp. 199-218.<br />
THEILER, WILLY, Philo von Alexandria und der hellenisierte Timaeus, in Philomathes.<br />
Stu<strong>di</strong>es and Essays in the Humanities in Memory of Philip Merlan, ed. R. B. PALMER - R.<br />
HAMERTON-KELLY, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971, pp. 25-35. Anche in Der Mittelplatonismus,<br />
hrsg. v. C. ZINTZEN, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981,<br />
pp. 52-63 (Wege der Forschung, 70).<br />
VAN DEN HOEK, ANNEWIES, Philo and Origen: a descriptive catalogue of their relationship,<br />
«Stu<strong>di</strong>a Philoniana», 12 (2000), pp. 44-121.<br />
· <strong>Origene</strong><br />
°BEATRICE, PIER FRANCO, Ein <strong>Origene</strong>szitat im Timaioskommentar des Calci<strong>di</strong>us, in Origeniana<br />
Septima. <strong>Origene</strong>s in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts, hrsg. von<br />
5
W.A. BIENERT – U. KÜHNEWEG, Leuven, Leuven University Press-Peeters, 1999, pp. 75-<br />
90 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 137).<br />
BOSTOCK, D. GERALD, Origen’s philosophy of creation, in Origeniana Quinta. Historica,<br />
text and method, biblica, philosophica, theologica, Origenism and later developments.<br />
Papers of the 5th International Origen Congress (Boston College, 14-18 August 1989),<br />
e<strong>di</strong>ted by R. DALY, Leuven, Leuven University Press-Peeters, 1992, pp. 253-269 (Bibliotheca<br />
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 105).<br />
CHADWICK, HENRY, Origen, in The Cambridge History of Later Greek and Early Me<strong>di</strong>eval<br />
Philosophy, ed. by A.H. ARMSTRONG, Cambridge, At the University Press, 1967, pp.<br />
162-182.<br />
CROUZEL, HENRY, Un fragment du Commentaire sur la <strong>Gen</strong>ese d’Origène et la création<br />
de la matiére à partir du néant, in Agathè Elpís. Stu<strong>di</strong> storico-religiosi in onore <strong>di</strong> U.<br />
Bianchi, G. SFAMENI GASPARRO ed., Roma, L’Erma <strong>di</strong> Bretschneider, 1994, pp. 417-425.<br />
°HEINE, ROLAND, Origen’s Alexandrian Commentary on <strong>Gen</strong>esis, in Origeniana Octava.<br />
Origen and the Alexandrian Tra<strong>di</strong>tion. <strong>Origene</strong> e la tra<strong>di</strong>zione alessandrina. Papers of<br />
the 8th International Origen Congress. Pisa, 27-31 August 2001, I, ed. by L. PERRONE in<br />
collaboration with P. BERNARDINI and D. MARCHINI, Leuven University Press, pp. 63-73<br />
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 144).<br />
KOCH, HAL, Pronoia und Paideusis. Stu<strong>di</strong>en über <strong>Origene</strong>s und sein Verhältnis zum Platonismus,<br />
Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter, 1932 (Arbeiten zur Kirchengeschichte,<br />
22).<br />
°PASQUIER, ANNE, L’allégorie du ciel et du firmament chez Origène et dans un traité<br />
gnostique de Nag Hamma<strong>di</strong>, in Origeniana Sexta. Origène et la Bible. Actes du Colloquium<br />
Origenianum Sextum (Chantilly, 30 août-3 septembre 1993), é<strong>di</strong>tés par G. DORI-<br />
VAL – A. LE BOULLUEC et al., Leuven, Leuven University Press-Peeters, 1995, pp. 37-52<br />
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 118).<br />
RUIZ JURADO, MANUEL, Le concept de “Monde” chez Origène, «Bulletin de littérature<br />
ecclésiastique», 75 (1974), pp. 3-24.<br />
SCOTT, ALAN, Origen and the Life of the Stars: an History of an Idea, Oxford, Clarendon<br />
Press, 1991 (Oxford early christian stu<strong>di</strong>es).<br />
M. SIMONETTI, Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong>esi 2, 7 e 3, 21,<br />
«Aevum», 36 (1962), pp. 370-381.<br />
°VANNIER, MARIE-ANNE, Origène et Augustin, interprètes de la création, in Origeniana<br />
Sexta. Origène et la Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum (Chantilly, 30 août-3<br />
septembre 1993), é<strong>di</strong>tés par G. DORIVAL – A. LE BOULLUEC et al., Leuven, Leuven<br />
University Press-Peeters, 1995, pp. 723-736 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum<br />
Lovaniensium, 118).<br />
· <strong>Basilio</strong><br />
GIRARDI, MARIO, L’esegesi esamerale <strong>di</strong> <strong>Basilio</strong> <strong>di</strong> Cesarea e Gregorio <strong>di</strong> Nissa:<br />
l’alessandrinismo cappadoce al crocevia, in <strong>Origene</strong> e l’alessandrinismo cappadoce (III-<br />
IV secolo). Atti del V Convegno del Gruppo Italiano <strong>di</strong> ricerca su «<strong>Origene</strong> e la tra<strong>di</strong>zione<br />
alessandrina» (Bari, 20-22 settembre 2000), a cura <strong>di</strong> M. GIRARDI – M. MARIN, Bari,<br />
E<strong>di</strong>puglia, 2002, pp. 75-113 (Quaderni <strong>di</strong> «Vetera Christianorum», 28).<br />
6
RIST, JOHN M., Basil’s “Neoplatonism”: its Background and Nature, in ID., Platonism<br />
and its Christian Heritage, London, Variorum Reprints, 1985, XII. Ed. prec. in Basil of<br />
Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic, ed. P.J. FEDWICK, Toronto, Pontifical Institute of<br />
Me<strong>di</strong>aeval Stu<strong>di</strong>es, 1981, pp. 137-220.<br />
7
Traduzione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1-2 secondo il TM e secondo la LXX<br />
Traduzione secondo il testo masoretico<br />
(trad. R. Reggi)<br />
1.<br />
1. In principio creò Dio i cieli e la terra.<br />
2. E la terra fu informità e vuotezza e tenebra (era) sulla<br />
superficie dell’abisso e spirito <strong>di</strong> Dio (era) agitantesi sulla<br />
superficie delle acque.<br />
3. E <strong>di</strong>sse Dio: «Sia luce». E fu luce.<br />
4. E vide Dio la luce che (era) buona e separò Dio tra la<br />
luce e tra la tenebra.<br />
5. E chiamò Dio la luce “giorno” e la tenebra chiamò<br />
“notte”. E fu sera e fu mattina, giorno uno.<br />
6. E <strong>di</strong>sse Dio: «Sia un firmamento nel mezzo delle acque<br />
e sia separante tra acque dalle acque».<br />
7. E fece Dio il firmamento e separò tra le acque che (sono)<br />
sotto al firmamento e tra le acque che (sono) sopra al<br />
firmamento. E fu così.<br />
8. E chiamò Dio il firmamento “cieli”. E fu sera e fu mattina,<br />
giorno secondo.<br />
9. E <strong>di</strong>sse Dio: «Si raccolgano le acque sotto i cieli verso<br />
un luogo uno e si veda l’asciutto».<br />
E fu così.<br />
10. E chiamò Dio l’asciutto “terra” e la raccolta delle acque<br />
chiamò “mari”. E vide Dio che (era) buono.<br />
11. E <strong>di</strong>sse Dio: «Verdeggi la terra vegetazione, erba seminante<br />
seme,<br />
albero da frutto facente frutto per la sua specie, che il suo<br />
seme (è) in esso, sulla terra». E fu così.<br />
12. E produsse la terra vegetazione, erba seminante seme<br />
per la sua specie<br />
e albero facente<br />
frutto, che il suo seme (è) in esso per la sua specie.<br />
E vide Dio che (era) buono. 13. E fu sera e fu mattina,<br />
giorno terzo.<br />
14. E <strong>di</strong>sse Dio: «Siano luminari nel firmamento dei cieli,<br />
per separare tra il giorno e tra la notte<br />
e siano per segni e per stagioni e per giorni e anni 15. e<br />
siano per luminari nel firmamento dei cieli, per illuminare<br />
sulla terra».<br />
E fu così. 16. E fece Dio i due luminari gran<strong>di</strong>, il luminare<br />
grande per regolazione del giorno e il luminare piccolo per<br />
regolazione della notte e le stelle. 17. E pose quelli Dio<br />
nel firmamento dei cieli per illuminare sulla terra 18. e per<br />
regolare il giorno e la notte e per separare tra la luce e tra<br />
la tenebra. E vide Dio che (era) buono.<br />
19. E fu sera e fu mattina, giorno quarto.<br />
20. E <strong>di</strong>sse Dio: «Brulichino le acque brulichio <strong>di</strong> anima<br />
viva e volatile voli sulla terra sulla superficie del firma-<br />
Traduzione secondo i LXX<br />
1.<br />
1. In principio fece Dio il cielo e la terra.<br />
2. Ora, la terra era invisibile e <strong>di</strong>sorganizzata e tenebra (era)<br />
al <strong>di</strong> sopra dell’abisso e uno spirito <strong>di</strong> Dio era mosso al<br />
<strong>di</strong> sopra dell’acqua.<br />
3. E Dio <strong>di</strong>sse: «Che si generi luce» e si generò luce. 4. E<br />
Dio vide la luce che (era) bella. E separò Dio nel mezzo<br />
della luce e nel mezzo della tenebra. 5. E chiamò Dio la<br />
luce “giorno” e la tenebra chiamò “notte”. E fu sera e fu<br />
mattina, giorno uno.<br />
6. E <strong>di</strong>sse Dio: «Che si generi un firmamento a metà<br />
dell’acqua e sia separante nel mezzo dell’acqua e<br />
dell’acqua». E avvenne così. 7. E fece Dio il firmamento<br />
e separò Dio nel mezzo dell’acqua che era al <strong>di</strong> sotto del<br />
firmamento e nel mezzo dell’acqua, quella al <strong>di</strong> sopra del<br />
firmamento. 8. E chiamò Dio il firmamento “cielo”. E vide<br />
Dio che (era) cosa bella. E fu sera e fu mattina, giorno<br />
secondo.<br />
9. E <strong>di</strong>sse Dio: «Che sia radunata l’acqua, quella al <strong>di</strong> sotto<br />
del cielo in un’adunanza unica e appaia il (suolo) arido».<br />
E avvenne così. E fu radunata l’acqua, quella al <strong>di</strong><br />
sotto del cielo, nelle loro adunanze e apparve il (suolo)<br />
arido. 10. E chiamò Dio il (suolo) arido “terra” e gli insiemi<br />
delle acque chiamò “mari”. E vide Dio che (era) cosa<br />
bella.<br />
11. E <strong>di</strong>sse Dio: «Germogli la terra foraggio d’erba, seminante<br />
seme secondo (il suo) genere e secondo (la sua)<br />
similitu<strong>di</strong>ne e albero da frutto facente frutto, del quale il<br />
suo seme (sia) in esso secondo (il suo) genere sulla terra».<br />
E avvenne così. 12. E produsse la terra foraggio d’erba<br />
seminante seme secondo (il suo) genere e secondo (la<br />
sua) similitu<strong>di</strong>ne e albero da frutto facente frutto, del<br />
quale il suo seme (era) in esso secondo (il suo) genere sulla<br />
terra. E vide Dio che (era) cosa bella. 13. E fu sera e fu<br />
mattina, giorno terzo.<br />
14. E <strong>di</strong>sse Dio: «Che si generino dei luminari nel firmamento<br />
del cielo a illuminazione della terra, per separare<br />
nel mezzo del giorno e nel mezzo della notte e siano a segni<br />
e a tempi e a giorni e ad anni 15. e siano a illuminazione<br />
nel firmamento del cielo, per illuminare sulla terra».<br />
E avvenne così. 16. E fece Dio i due luminari gran<strong>di</strong>, il<br />
luminare grande ai coman<strong>di</strong> del giorno e il luminare minore<br />
ai coman<strong>di</strong> della notte e le stelle. 17. E pose quelli Dio<br />
nel firmamento del cielo per illuminare sulla terra 18. e<br />
comandare il giorno e la notte e separare nel mezzo della<br />
luce e nel mezzo della tenebra. E vide Dio che (era) cosa<br />
bella. 19. E fu sera e fu mattina, giorno quarto.<br />
20. E <strong>di</strong>sse Dio: «Facciano uscire le acque rettili <strong>di</strong> anime<br />
viventi e volatili volanti sulla terra nel firmamento del cie-<br />
8
mento dei cieli». 21. E creò Dio i mostri marini gran<strong>di</strong> e<br />
ogni anima viva guizzante <strong>di</strong> cui brulicarono le acque, per<br />
le loro specie, e ogni volatile <strong>di</strong> ala, per la sua specie. E<br />
vide Dio che (era) buono. 22. E bene<strong>di</strong>sse quelli Dio, <strong>di</strong>cendo:<br />
«Fruttificate e moltiplicatevi e riempite le acque<br />
nei mari e il volatile si moltiplichi nella terra».<br />
23. E fu sera e fu mattina, giorno quinto.<br />
24. E <strong>di</strong>sse Dio: «Produca la terra anima viva, per la sua<br />
specie; bestia e rettile e vivente <strong>di</strong> terra, per la sua specie».<br />
E così fu.<br />
25. E fece Dio vivente della terra, per la sua specie, e la<br />
bestia, per la sua specie, e ogni rettile del suolo, per la sua<br />
specie. E vide Dio che (era) buono.<br />
26. E <strong>di</strong>sse Dio: «Facciamo un uomo a immagine <strong>di</strong> noi,<br />
come somiglianza <strong>di</strong> noi, e dominino su pesce del mare e<br />
su volatile dei cieli e sulla bestia e su tutta la terra e su ogni<br />
rettile strisciante sulla terra». 27. E creò Dio l’uomo a<br />
immagine <strong>di</strong> lui, a immagine <strong>di</strong> Dio creò lui, maschio e<br />
femmina creò loro. 28. E bene<strong>di</strong>sse loro Dio e <strong>di</strong>sse a loro<br />
Dio: «Fruttificate e moltiplicatevi e riempite la terra e<br />
soggiogatela e dominate su pesce del mare e su volatile<br />
dei cieli e su ogni vivente<br />
strisciante sulla terra». 29. E <strong>di</strong>sse Dio: «Ecco <strong>di</strong>e<strong>di</strong> a voi<br />
ogni erba seminante seme che è sulla superficie <strong>di</strong> tutta la<br />
terra e ogni albero che in esso (è) frutto <strong>di</strong> albero, seminante<br />
seme; per voi sarà per cibo. 30. E a ogni vivente della<br />
terra e a ogni volatile dei cieli e a ogni strisciante sulla<br />
terra che in esso (è) anima viva (io do) ogni verde erba per<br />
cibo». E fu così.<br />
31. E vide Dio tutto ciò che fece ed ecco (era) buono assai.<br />
E fu sera e fu mattina, giorno sesto.<br />
2.<br />
1. E furono completati i cieli e la terra e ogni schiera <strong>di</strong><br />
essi. 2. E completò Dio nel giorno settimo lavoro suo che<br />
fece e cessò nel giorno settimo da ogni lavoro suo che fece.<br />
3. E bene<strong>di</strong>sse Dio (il) giorno settimo e santificò quello,<br />
perché in esso cessò da ogni lavoro suo che creò Dio<br />
per fare.<br />
4. Queste (le) origini dei cieli e della terra nell’essere essi<br />
creati, [creati.]<br />
nel [Nel] giorno del fare JHWH Dio terra e cieli;<br />
5. e ogni cespuglio del campo non ancora era nella terra e<br />
ogni erba del campo ancora non germogliava,<br />
perché non fece piovere JHWH Dio sulla terra e uomo<br />
non c’era per lavorare il suolo 6. e umido saliva dalla terra<br />
e irrigò tutta la superficie del suolo. 7. E plasmò JHWH<br />
Dio l’uomo (con) polvere dal suolo e soffiò nelle narici <strong>di</strong><br />
lui soffio <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong>venne l’uomo anima viva.<br />
8. E piantò JHWH Dio giar<strong>di</strong>no in Eden, a oriente, e pose<br />
là l’uomo che plasmò. 9. E fece germogliare JHWH Dio<br />
dal suolo ogni albero desiderabile per vista e buono per<br />
cibo e albero della vita in mezzo del giar<strong>di</strong>no e albero della<br />
conoscenza (<strong>di</strong>) bene e male.<br />
10. E fiume (era) uscente da Eden per irrigare il giar<strong>di</strong>no e<br />
lo». E avvenne così. 21. E fece Dio i cetacei gran<strong>di</strong> e ogni<br />
anima <strong>di</strong> animali rettili, che fecero uscire le acque secondo<br />
(i) generi <strong>di</strong> quelli e ogni volatile alato secondo (il suo)<br />
genere. E vide Dio che (erano) cose belle. 22. E bene<strong>di</strong>sse<br />
quelli Dio <strong>di</strong>cendo: «Crescete e moltiplicatevi e riempite<br />
le acque nei mari e gli uccelli si moltiplichino sulla terra».<br />
23. E fu sera e fu mattina, giorno quinto.<br />
24. E <strong>di</strong>sse Dio: «Faccia uscire la terra un’anima vivente<br />
secondo (il suo) genere, quadrupe<strong>di</strong> e rettili e bestie selvatiche<br />
della terra secondo (il loro) genere». E avvenne così.<br />
25. E fece Dio le bestie selvatiche della terra secondo (il<br />
loro) genere e il bestiame secondo (il suo) genere e tutti i<br />
rettili della terra secondo (il) genere <strong>di</strong> quelli. E vide Dio<br />
che (erano) cose belle.<br />
26. E <strong>di</strong>sse Dio: «Facciamo un uomo secondo<br />
(l’)immagine nostra e secondo (la) somiglianza e coman<strong>di</strong>no<br />
i pesci del mare e i volatili del cielo e il bestiame e<br />
tutta la terra e tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27. E<br />
fece Dio l’uomo, secondo (l’)immagine <strong>di</strong> Dio fece quello,<br />
maschio e femmina fece quelli. 28. E bene<strong>di</strong>sse quelli<br />
Dio <strong>di</strong>cendo: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra<br />
e dominatela e comandate i pesci del mare e i volatili del<br />
cielo e tutto il bestiame e tutta la terra e tutti i rettili che<br />
strisciano sulla terra». 29. E <strong>di</strong>sse Dio: «Ecco ho dato a<br />
voi ogni erba da seme seminante seme, che è al <strong>di</strong> sopra<br />
<strong>di</strong> tutta la terra, e ogni albero, che ha in sé frutto <strong>di</strong> seme<br />
da seme — per voi sarà a nutrimento — 30. e a tutte le bestie<br />
selvatiche della terra e a tutti i volatili del cielo e a<br />
ogni rettile che striscia sulla terra, che ha in sé anima <strong>di</strong><br />
vita e ogni erba verde a nutrimento». E avvenne così. 31.<br />
E vide Dio tutte le cose, quante fece, ed ecco (erano) cose<br />
buone assai. E fu sera e fu mattina, giorno sesto.<br />
2.<br />
1. E furono compiuti il cielo e la terra e tutto l’ornamento<br />
<strong>di</strong> quelli. 2. E compì Dio nel giorno sesto le opere sue che<br />
fece e cessò nel giorno settimo da tutte le opere sue che<br />
fece. 3. E bene<strong>di</strong>sse Dio il giorno settimo e santificò quello,<br />
perché in esso cessò da tutte le opere sue, che cominciò<br />
Dio a fare.<br />
4. Questo è il libro della generazione del cielo e della terra,<br />
quando venne all’essere, nel giorno in cui fece Dio il cielo<br />
e la terra 5. e ogni verdura <strong>di</strong> campo prima del venire<br />
all’essere sulla terra e ogni erba <strong>di</strong> campo prima del sorgere.<br />
Non, infatti, fece piovere Dio sulla terra e un uomo non<br />
c’era (per) lavorare la terra; 6. una sorgente, però, saliva<br />
dalla terra e irrigava tutta la faccia della terra. 7. E plasmò<br />
Dio l’uomo (come) polvere dalla terra e soffiò nella faccia<br />
<strong>di</strong> lui un soffio <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong>venne l’uomo ad anima vivente.<br />
8. E piantò il Signore Dio un para<strong>di</strong>so in Eden a levante e<br />
pose là l’uomo che plasmò. 9. E faceva sorgere Dio, ancora,<br />
dalla terra ogni albero gradevole al(la) vista e bello a<br />
nutrimento e l’albero della vita a metà del para<strong>di</strong>so e<br />
l’albero del sapere (il) conoscibile del bello e del malvagio.<br />
10. Un fiume, poi, esce da Eden (a) irrigare il para<strong>di</strong>-<br />
9
da là si <strong>di</strong>videva e <strong>di</strong>ventava quattro corsi. 11. Nome<br />
dell’uno (era) Pison, esso (è) il circondante tutta la terra<br />
(<strong>di</strong>) Avila, che là (c’è) l’oro 12. e l’oro della terra quella<br />
(è) buono. Là (c’è) il bdellio e pietra <strong>di</strong> onice. 13. E nome<br />
del fiume secondo (è) Ghicon, esso (è) il circondante tutta<br />
la terra (<strong>di</strong>) Etiopia. 14. E nome del fiume terzo (è) Tigri,<br />
esso (è) l’andante a oriente (<strong>di</strong>) Assur. 14. E il fiume quarto,<br />
esso (è l’)Eufrate.<br />
15. E prese JHWH Dio l’uomo e pose lui in giar<strong>di</strong>no Eden,<br />
per lavorarlo e per custo<strong>di</strong>rlo. 16. E or<strong>di</strong>nò JHWH<br />
Dio all’uomo <strong>di</strong>cendo: «Da ogni albero del giar<strong>di</strong>no mangiare<br />
mangerai, 17. ma<br />
da albero della conoscenza (<strong>di</strong>) bene e male non mangerai<br />
da esso, perché nel giorno del mangiare te da esso morire<br />
morirai.<br />
18. E <strong>di</strong>sse JHWH Dio: «Non (è) bene l’essere dell’uomo<br />
solo lui; farò per lui un aiuto (che sia) come <strong>di</strong> fronte a lui.<br />
19. E plasmò JHWH Dio dal suolo ogni vivente del campo<br />
e ogni volatile dei cieli e (li) fece andare all’uomo per vedere<br />
che cosa (egli) chiamasse ad esso e ogni (nome) che<br />
chiamasse ad esso l’uomo un’anima viva, quello (era)<br />
nome suo. 20. E chiamò<br />
l’uomo nomi a ogni bestia e a volatile dei cieli e a ogni<br />
vivente del campo. E a(ll’)uomo non trovò un aiuto come<br />
<strong>di</strong> fronte a lui.<br />
21. E fece cadere JHWH Dio torpore sull’uomo e si addormentò<br />
e prese una dalle costole <strong>di</strong> lui e chiuse carne al<br />
posto <strong>di</strong> essa. 22. E costruì JHWH Dio la costola che prese<br />
dall’uomo come donna e fece andare lei all’uomo.<br />
23. E <strong>di</strong>sse l’uomo: «Questa (è) questa volta osso da ossa<br />
<strong>di</strong> me e carne da carne <strong>di</strong> me. Questa sarà chiamata “donna”<br />
perché da uomo fu presa questa». 24. Perciò lascerà<br />
un uomo (il) padre suo e (la) madre sua e si unirà al(la)<br />
donna sua e saranno come carne una. 25. E furono loro<br />
due nu<strong>di</strong>, l’uomo e la moglie sua, e non si vergognavano.<br />
10<br />
so; da là si separa in quattro inizi. 11. Nome all’uno (è)<br />
Pison; questo (è) quello che circonda tutta la terra <strong>di</strong> Avila,<br />
là dove è l’oro; 12. l’oro, poi, <strong>di</strong> quella terra (è) bello; e<br />
là è il carbonchio e la pietra <strong>di</strong> smeraldo. 13. E nome al<br />
fiume secondo (è) Ghion; questo (è) quello che circonda<br />
tutta la terra <strong>di</strong> Etiopia. 14. E il fiume terzo (è il) Tigri;<br />
questo (è) quello che scorre <strong>di</strong>nanzi (agli) Assiri. 14. Il<br />
fiume, poi, quarto, questo (è l’)Eufrate.<br />
15. E prese il Signore Dio l’uomo, che plasmò, e pose<br />
quello nel para<strong>di</strong>so (a) lavorarlo e custo<strong>di</strong>r(lo). 16. E prescrisse<br />
il Signore Dio ad Adamo <strong>di</strong>cendo: «Da ogni albero<br />
che è nel para<strong>di</strong>so per nutrimento mangia, 17. però<br />
dall’albero del conoscere bello e malvagio non mangerete<br />
da esso; nel giorno in cui mangiaste da esso, <strong>di</strong> morte morirete.<br />
18. E <strong>di</strong>sse il Signore Dio: «Non (è) cosa bella che sia<br />
l’uomo solo; facciamogli un aiuto conforme a lui. 19. E<br />
plasmò Dio, ancora, dalla terra tutte le bestie selvatiche<br />
del campo e tutti i volatili del cielo e condusse quelli<br />
all’Adamo (a) vedere che cosa chiamerà quelli e ogni<br />
(nome) che chiamasse (con) quel (nome) Adamo<br />
un’anima vivente, questo (era) il nome suo. 20. E chiamò<br />
Adamo nomi a tutto il bestiame e a tutti i volatili del cielo<br />
e a tutte le bestie selvatiche del campo, ma per l’Adamo<br />
non fu trovato un aiuto simile a lui.<br />
21. E gettò Dio un’estasi sull’Adamo e si addormentò; e<br />
prese una delle costole <strong>di</strong> lui e riempì carne al posto <strong>di</strong> essa.<br />
22. Ed e<strong>di</strong>ficò il Signore Dio la costola, che prese<br />
dall’Adamo, in una donna e condusse quella all’Adamo.<br />
23. E <strong>di</strong>sse Adamo: «Questo ora (è) un osso dalle mie ossa<br />
e una carne dalla mia carne; questa sarà chiamata “donna”,<br />
perché dall’uomo suo fu presa questa. 24. Per questo<br />
lascerà un uomo il padre suo e la madre sua e aderirà alla<br />
donna sua e saranno i due in una carne una. 25. Ed erano i<br />
due nu<strong>di</strong>, Adamo e la sua moglie, e non si vergognavano.
Osservazioni esegetiche su <strong>Gen</strong> 1, 1-2 1<br />
Il racconto della creazione apre il libro della <strong>Gen</strong>esi (nella BH Bereshit), che è a<br />
sua volta il primo dei cinque libri che formano la Torah, termine, a partire dalla traduzione<br />
del LXX, reso abitualmente con “legge”. Nella tra<strong>di</strong>zione ebraica e cristiana fino<br />
all’età moderna è stata unanime, tranne pochissime eccezioni, la convinzione che il Pentateuco<br />
fosse opera <strong>di</strong> Mosè. Fu nel corso del XVII sec. che alcuni intellettuali misero<br />
seriamente in dubbio tale attribuzione: B. Spinoza (1632-1677), Th. Hobbes (1588-<br />
1679), R. Simon (1638-1712).<br />
Lo stu<strong>di</strong>o sistematico e l’elaborazione <strong>di</strong> ipotesi che dessero conto delle <strong>di</strong>scontinuità,<br />
incoerenze, duplicazioni e contrad<strong>di</strong>zioni presenti nel Pentateuco iniziò nel<br />
XVIII sec. e portò alla formulazione <strong>di</strong> tre modelli <strong>di</strong> spiegazione della formazione<br />
dell’attuale assetto testuale del Pentateuco:<br />
- ipotesi dei documenti: H.B. Witter (1683-1715), J. Astruc (1684-1766), J.G.<br />
Eichhorn (1752-1825); il pentateuco attuale è l’esito della composizione <strong>di</strong> più documenti<br />
completi, autonomi l’uno dall’altro e più o meno paralleli per contenuto;<br />
- ipotesi dei frammenti: A. Geddes (1737-1802), J.S. Vater (1771-1826),<br />
W.M.L. de Wette (1780-1849); il pentateuco è il risultato della fusione, ealizzata a<br />
grande <strong>di</strong>stanza dall’epoca <strong>di</strong> Mosè, <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> piccole unità testuali <strong>di</strong> tipo narrativo<br />
e legislativo;<br />
- ipotesi dei complementi: H.G.A. Ewald (1803-1875); il pentateuco è costituito<br />
da un documento <strong>di</strong> base unico, al quale sono stati aggiunti in epoche successivi elementi<br />
provenienti da altre fonti.<br />
L’esegesi storico-critica del XIX e XX secolo, a partire dalle opere <strong>di</strong> Julius<br />
Wellhausen (1844-1918), ha generalmente accolto la cosiddetta ipotesi documentaria: il<br />
pentateuco è stato prodotto dal confluire <strong>di</strong> quattro <strong>di</strong>stinte opere letterarie, rappresentate<br />
da autori <strong>di</strong> epoche, provenienze e impostazioni teologiche molto <strong>di</strong>verse:<br />
- autore jahwista (J): operante nel regno <strong>di</strong> Giuda intorno al IX sec.<br />
- autore elohista (E): operante nel regno d’Israele nell’VIII sec.<br />
- autore deuteronomista (D): la sua opera risalirebbe alla riforma <strong>di</strong> Giosia (622)<br />
- autore sacerdotale (P): attivo durante l’esilio in Babilonia o subito dopo a Gerusalemme.<br />
Questo modello è stato sostanzialmente accolto per buona parte del XX secolo,<br />
dopo alcune resistenze anche in ambito cattolico (cf. il responso della Commissione biblica<br />
del 27. VI. 1906 sull’autenticità mosaica del pentateuco), come il più persuasivo.<br />
Esso in<strong>di</strong>vidua il periodo religiosamente creativo della storia d’Israele nell’epoca monarchica<br />
(sostanzialmente J), mentre assegna all’ultimo autore (P) la funzione <strong>di</strong> redattore<br />
finale e <strong>di</strong> fondatore <strong>di</strong> una religiosità legalistica e rituale che inaugura il giudaismo<br />
postesilico.<br />
Accanto all’ipotesi documentaria, ha preso forma, grazie soprattutto agli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
H. Gunkel (1862-1932) lo stu<strong>di</strong>o del pentateuco dal punto <strong>di</strong> vista della storia delle forme:<br />
partendo dal presupposto che le attuali narrazioni hanno <strong>di</strong>etro le loro spalle una<br />
lunga tra<strong>di</strong>zione orale, la Formgeschichte si è sforzata <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le singole unità<br />
1 Cf. CAQUOT, ANDRÉ, Brèves remarques exégétiques sur <strong>Gen</strong>èse 1, 1-2, in In Principio. Interprétations<br />
des premiers versets de la <strong>Gen</strong>èse, Paris, Études augustiniennes, 1973, pp. 9-21 (Centre d’Études des religions<br />
du Livre).<br />
11
letterarie, a volte molto brevi, che le costituiscono e ricostruirne il genere letterario e il<br />
contesto vitale originario.<br />
Una me<strong>di</strong>azione fra l’ipotesi <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> pochi documenti letterari autonomi e<br />
paralleli e l’ipotesi <strong>di</strong> una vasta molteplicità <strong>di</strong> unità narrative provenienti dalla tra<strong>di</strong>zione<br />
orale può essere vista nel modello, elaborato da M. Noth (1902-1968), della Tra<strong>di</strong>tionsgeschichte.<br />
Noth ritenne <strong>di</strong> poter in<strong>di</strong>viduare cinque gran<strong>di</strong> temi che si svilupparono<br />
in rapporto al culto e alle tra<strong>di</strong>zioni dei <strong>di</strong>versi santuari dell’Israele premonarchico.<br />
Essi godettero <strong>di</strong> una lunga tra<strong>di</strong>zione orale autonoma in epoca premonarchica e solo in<br />
una fase tar<strong>di</strong>va, a partire dallo J, vennero coor<strong>di</strong>nati per formare il testo dei primi quattro<br />
libri del pentateuco (secondo lui, Dt era da considerarsi come introduzione generale<br />
all’opera storica deuteronomistica, costituita da Gs-2 Re). J, E, P non sarebbero, insomma,<br />
autori letterariamente e teologicamente creativi, ma meri compilatori <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni<br />
orali alla loro epoca largamente stabilizzate. Questi cinque nuclei tematici erano<br />
secondo Noth:<br />
- l’uscita dall’Egitto<br />
- il soggiorno nel deserto<br />
- l’ingresso nella terra<br />
- le promesse ai patriarchi<br />
- la teofania del Sinai.<br />
Sulla linea dell’impostazione <strong>di</strong> Noth si colloca il contributo <strong>di</strong> R. Rendtorff<br />
(1925- ). Parte dal presupposto che l’ipotesi documentaria (quattro documenti letterari<br />
autonomi e composti ciascuno da un autore, fusi a formare il pentateuco) non sia compatibile<br />
con l’ipotesi della Formgeschichte (una molteplicità <strong>di</strong> piccole unità <strong>di</strong> generi<br />
letterari <strong>di</strong>versi, cucite insieme da un lavoro solo redazionale posteriore) e muove, invece,<br />
dal modello della Tra<strong>di</strong>tionsgeschichte <strong>di</strong> Noth.<br />
Postula (riprendendo la vecchia ipotesi dei frammenti) l’esistenza <strong>di</strong> sei gran<strong>di</strong><br />
unità letterarie autonome, coor<strong>di</strong>nate in fase posteriore da un lavoro redazionale che le<br />
ha fuse insieme:<br />
- storia delle origini<br />
- storie dei patriarchi<br />
- uscita dall’Egitto<br />
- marcia nel deserto<br />
- pericope del Sinai<br />
- conquista della terra.<br />
A partire soprattutto dagli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Rendtorff, la datazione della composizione<br />
del pentateuco si è spostata sempre più in basso, fino a essere oggi generalmente collocata<br />
nell’esilio o nel postesilio. Non si pensa più a uno o più autori del pentateuco, ma a<br />
una molteplicità <strong>di</strong> cicli narrativi o <strong>di</strong> singoli racconti, originariamente autonomi e privi<br />
<strong>di</strong> legami reciproci, coor<strong>di</strong>nati in epoca postesilica in un tessuto narrativo unitario da<br />
una serie <strong>di</strong> redattori sacerdotali (è degno <strong>di</strong> nota il fatto che nessun profeta pre-esilico<br />
mostri <strong>di</strong> conoscere una storia compaginata <strong>di</strong> Israele dai patriarchi, all’esodo, alla conquista<br />
della terra promessa). La redazione finale del pentateuco (secondo J.P. Weinberg)<br />
sarebbe avvenuta in epoca persiana in concomitanza con l’assurgere del tempio <strong>di</strong> Gerusalemme<br />
a centro propulsore dell’intera vita religiosa, cultuale, sociale e politica <strong>di</strong> Israele.<br />
12
La narrazione della cosmogonia apre la narrazione della <strong>Gen</strong>esi, costruita come<br />
una serie <strong>di</strong> generazioni (toledot) dalle quali emerge progressivamente la stirpe <strong>di</strong> Abramo<br />
(dal cap. 12 in poi iniziano le storie <strong>di</strong> Abramo e dei suoi <strong>di</strong>scendenti). Il ricorso<br />
alla genealogia è caratteristico <strong>di</strong> società tribali, che organizzano in forma <strong>di</strong> struttura<br />
parentale le relazioni sociali e i rapporti politici. Le genealogie <strong>di</strong> <strong>Gen</strong>, però, non riguardano<br />
solo un gruppo limitato e un territorio circoscritto: hanno un respiro mon<strong>di</strong>ale:<br />
dal cap. 10, la cosiddetta “tavola dei popoli” fa <strong>di</strong>scendere da Noè, attraverso i suoi figli,<br />
tutta l’umanità nota agli autori del testo. A sua volta, Noè è collegato nei capitoli<br />
precedenti (cf. <strong>Gen</strong> 5) ad Adamo, il capostipite dell’umanità.<br />
Il bisogno <strong>di</strong> collocare Israele in una rete che abbracciasse l’umanità intera si è<br />
affacciato probabilmente con l’esperienza dell’esilio: la <strong>di</strong>spersione in mezzo a popoli<br />
lontani rese necessaria l’elaborazione <strong>di</strong> un quadro genealogico capace <strong>di</strong> includerli e <strong>di</strong><br />
metterli in relazione con Israele. Secondo M. Liverani, l’esame dei popoli menzionati in<br />
<strong>Gen</strong> 10 induce a collocare l’elaborazione <strong>di</strong> questa tavola in epoca posteriore al 690 a.C.<br />
(perché <strong>Gen</strong> 10, 7 cita il faraone etiopico Sabteka) e prima della metà del VI sec. (perché<br />
non vi è alcuna menzione dei persiani). Si può fare un’ipotesi ancora più precisa: la<br />
tavola potrebbe essere posteriore al 610, cioè alla fine dell’impero assiro, perché la<br />
struttura tripartita dell’umanità (<strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong> Sem, Cam e Yafet, i tre figli <strong>di</strong> Noè)<br />
sembra corrispondere bene alle tre gran<strong>di</strong> aree <strong>di</strong> influenza dei me<strong>di</strong> (Yafet), dei babilonesi<br />
(Sem) e degli egiziani (Cam).<br />
L’organizzazione dei rapporti fra i popoli attraverso la genealogia e la <strong>di</strong>stribuzione<br />
nello spazio dei <strong>di</strong>versi gruppi descritta in <strong>Gen</strong> rinvia, dunque, alla situazione della<br />
prima metà del VI sec. L’idea centrale è che Israele è determinato nella propria identità,<br />
prima ancora che dal possesso della terra (che potrebbe, come nell’esilio, anche venir<br />
meno), dal suo inserimento nella <strong>di</strong>scendenza <strong>di</strong> coloro, i patriarchi, che portano le<br />
promesse <strong>di</strong> Dio.<br />
<strong>Gen</strong> è strutturato in due gran<strong>di</strong> parti: 1-11 descrive le origini dell’universo e<br />
dell’umanità, 12-50 (con i gran<strong>di</strong> cicli <strong>di</strong> Abramo: 12-25, Giacobbe: 25-35, Giuseppe:<br />
37-50) si concentra su Israele e su popoli collaterali.<br />
<strong>Gen</strong> 1-2, 3 ha stretto rapporto con la teologia sacerdotale risale a non prima della<br />
fine del VI a.C. Il culmine della pericope è 2, 1-3: fondazione del sabato, istituito<br />
all’origine del mondo, come elemento centrale dell’identità del popolo d’Israele in esilio.<br />
Se si presta attenzione al ricorrere della soprascritta: «Queste sono le generazioni<br />
(toledot)» (2, 4; 5, 1; 6, 9; 10, 1; 11, 10. 27), che scan<strong>di</strong>sce i passaggi dalla creazione del<br />
mondo alla generazione <strong>di</strong> Terah, padre <strong>di</strong> Abramo, si può concludere che la pericope<br />
iniziale termina con 2, 3 e non con 2, 4a, che introduce, invece, la pericope successiva<br />
(cf. Rendtorff).<br />
Gli elementi che compongono la cosmogonia non sono originali: le tenebre primor<strong>di</strong>ali<br />
si trovano, p.e., anche in Esiodo (Theog. 116-132), anche il caos associato<br />
all’elemento liquido è comune in molte cosmogonie antiche egiziane, mesopotamiche e<br />
greche. Anche la creazione me<strong>di</strong>ante la parola non è un tratto specifico della cosmogonia<br />
biblica, né la scansione del racconto secondo un ritmo settenario. L’elemento specifico<br />
del racconto va cercato nel modo in cui l’autore ha combinato gli elementi (e le eventuali<br />
fonti scritte) che formano il materiale <strong>di</strong> costruzione del testo che leggiamo oggi.<br />
Nel suo insieme la narrazione sacerdotale della creazione evidenzia tre caratteristiche<br />
del mondo: esso è or<strong>di</strong>nato nello spazio, or<strong>di</strong>nato nel tempo, ospita la vita. Tutto<br />
questo è il risultato dell’azione <strong>di</strong> Dio, che — da solo e senza bisogno <strong>di</strong> lottare contro<br />
alcuna potenza avversa, come in altre mitologie — sconfigge il caos originario, separa<br />
le cose le une dalle altre, stabilisce relazioni spaziali e temporali, assegna alle cose la lo-<br />
13
o funzione, le nomina e, me<strong>di</strong>ante la bene<strong>di</strong>zione, infonde in esse la capacità <strong>di</strong> vivere e<br />
propagarsi.<br />
1, 1<br />
· Il verbo che traduciamo con “creare” (in greco si usa il verbo “fare, produrre”:<br />
poiéo) è in ebraico barah, che nella BH ha per soggetto esclusivamente Dio (altri verbi<br />
usati nella narrazione della creazione sono <strong>di</strong> uso più generico: asah, fare; yasar, produrre,<br />
plasmare: <strong>Gen</strong> 2, 7-8. 18-19). Barah in<strong>di</strong>ca tanto un atto <strong>di</strong> creazione originario<br />
(<strong>Gen</strong> 6, 7; Dt 4, 32; Nm 16, 30; Sal 89, 13. 48), quanto una ri-creazione escatologica<br />
(parti finali <strong>di</strong> Is, pe 4, 5; 65, 17). Ha per oggetto il cosmo nel suo insieme, sue parti significative,<br />
l’uomo. Nel racconto della creazione il verbo in<strong>di</strong>ca la creazione del cosmo<br />
nel suo insieme (<strong>Gen</strong> 1, 1; 2, 4), la creazione dell’uomo (1, 27), gli animali marini e i<br />
volatili (1, 21). Gli animali terrestri si <strong>di</strong>ce, invece, che sono fatti (asah), più propriamente<br />
Dio or<strong>di</strong>an alla terra <strong>di</strong> farli uscire (1, 24-25). P sembra dunque voler riservare il<br />
verbo barah alla creazione <strong>di</strong> quei viventi che non sono prodotti attraverso la me<strong>di</strong>azione<br />
della terra.<br />
· Un problema è costituito dalla struttura grammaticale <strong>di</strong> 1, 1-3. Le versioni<br />
antiche, compresa la LXX, considerano 1, 1 come un periodo a sé stante; ma i commentatori<br />
ebrei del me<strong>di</strong>oevo, seguiti da vari autori moderni, lo leggono come parte <strong>di</strong> un<br />
periodo più ampio: 1, 1-3, secondo Rashi; 1, 1-2, secondo Ibn Ezra.<br />
C’è una <strong>di</strong>fformità nel contenuto anzitutto: 1, 1 non contiene l’affermazione<br />
«Dio <strong>di</strong>sse:», mentre tutti gli atti creativi descritti nei vv successivi iniziano con una parola<br />
<strong>di</strong> Dio. Questo pone il problema <strong>di</strong> quale sia il posto <strong>di</strong> questo primo versetto<br />
nell’economia del racconto.<br />
Sotto il profilo grammaticale, il punto è come si deve vocalizzare il testo consonantico:<br />
la traduzione «in principio, nel principio, al principio», suppone che il termine<br />
reshit sia determinato dall’articolo (ha); in effetti una pronuncia samaritana ha barashit<br />
e in margine a un ms dell’esapla si leggeva la trascrizione /012324. Ma le versioni antiche<br />
e il TM leggono senza articolo e anche Girolamo trascrive: bresith. Se il nome è<br />
indeterminato, esso va inteso nel senso <strong>di</strong> «in un principio, in un primo tempo», oppure<br />
va inteso come un termine in stato costrutto, come un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tempo determinata<br />
da quello che segue (barah JHWH): «al principio <strong>di</strong> Dio creò» = «al principio della creazione<br />
<strong>di</strong> Dio, quando in principio Dio creò» (in questo senso lo usa Ger 26, 1; 27, 1;<br />
49, 3; dove significa sempre: «all’inizio [del regno] <strong>di</strong>...»).<br />
Vi sono espressioni comparabili a questa in Os 1, 2: «Inizio <strong>di</strong> Dio parlante = inizio<br />
delle parole <strong>di</strong> Dio»; Es 6, 28: beyom <strong>di</strong>bber JHWH = nel giorno <strong>di</strong> JHWH parlante<br />
= nel giorno in cui JHWH parlò (e non «un giorno, JHWH parlò»).<br />
Se, invece <strong>di</strong>: bereshit barah JHWH ci fosse: beyom barah JHWH, non si esiterebbe<br />
a tradurre: nel giorno in cui, quando Dio creò.<br />
<strong>Gen</strong> 1, 1 potrebbe essere allora semplicemente una proposizione subor<strong>di</strong>nata<br />
temporale; qual è la proposizione principale? Essa in ebraico è regolarmente introdotta<br />
dalla congiunzione coor<strong>di</strong>nante w_ che si trova all’inizio sia <strong>di</strong> 1, 2 sia <strong>di</strong> 1, 3:<br />
· secondo Ibn Ezra la principale è 1, 2: «Quando Dio cominciò a creare il cielo e<br />
la terra, allora la terra era deserta e vuota»;<br />
· secondo Rabbi Salomon ben Isaac (Rashi † 1005) la principale è 1, 3 e 1, 2 è un<br />
inciso: «Quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra — e la terra era deserta e vuota<br />
e tenebre erano sopra l’abisso e lo spirito <strong>di</strong> Dio aleggiava sulle acque — allora Dio <strong>di</strong>sse:<br />
Sia la luce».<br />
La lettura <strong>di</strong> Rashi sembra preferibile dal punto <strong>di</strong> vista linguistico, perché il<br />
tempo verbale <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1 e <strong>di</strong> 1, 3 si corrispondono. Se si legge così il testo, la sua<br />
14
struttura appare del tutto identica alla struttura del racconto jahvista della creazione, che<br />
inizia in 2, 4b: «Il giorno in cui Dio fece il cielo e la terra — e non c’era ancora sulla<br />
terra alcun cespuglio... — allora Dio plasmò l’uomo..».<br />
Se si mantiene la lettura tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> 1, 1 come una proposizione autonoma,<br />
esso non va inteso come l’enunciazione <strong>di</strong> un singolo atto creatore, come fanno, invece,<br />
in maggioranza gli esegeti antichi, ma come una sorta <strong>di</strong> titolo, nel quale cielo e terra<br />
sono una coppia che in<strong>di</strong>ca la totalità della creazione, tutto ciò che esiste oltre al Creatore<br />
stesso. Iniziando il suo racconto, l’autore anticipa la tesi fondamentale: «In principio<br />
Dio ha creato l’universo». Questo titolo potrebbe essere poi riecheggiato in 2, 4a (con<br />
una inclusione, che è proce<strong>di</strong>mento molto usuale nella letteratura biblica), che segnerebbe<br />
la conclusione della pericope. Proprio la presenza <strong>di</strong> questa inclusione potrebbe<br />
rafforzare la lettura <strong>di</strong> 1, 1 come proposizione a sé stante (ma cf. la posizione <strong>di</strong> Rendtorff,<br />
secondo il quale 2, 4a è l’inizio della nuova pericope, mentre la prima termina a<br />
2, 3).<br />
L’interpretazione <strong>di</strong> 1, 1 come una sorta <strong>di</strong> compen<strong>di</strong>o dell’intera opera della<br />
creazione, che poi viene precisata nei suoi dettagli nella narrazione successiva, è in<strong>di</strong>cata<br />
anche da <strong>Basilio</strong> Hom. in Hexaem. III e da Agostino Conf. XII 17, 24.<br />
1, 2<br />
Secondo l’analisi appena vista, 1, 2 può essere interpretato:<br />
· come l’inizio del racconto vero e proprio, <strong>di</strong> cui 1, 1 è il titolo<br />
· come un inciso posto tra la temporale <strong>di</strong> 1, 1 e la principale <strong>di</strong> 1, 3 (Rashi)<br />
· come la proposizione principale (Ibn Ezra)<br />
in tutti e tre i casi, questo versetto non descrive una situazione in qualche modo<br />
conseguente a un atto creativo descritto in 1, 1; esso descrive uno stato che è quello inziale<br />
dell’opera creatrice <strong>di</strong> Dio.<br />
· La frase «e la terra era tohu e bohu» è una frase nominale. La coppia <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>cati<br />
tohu (deserto) e bohu (vuoto?) si trova anche in Is 34, 11 e Ger 4, 23 («ho guardato<br />
la terra, era un tohu-bohu [LXX: $54"%]; poi verso i cieli, ma non avevano più la loro<br />
luce») e costituisce una figura retorica ricorrente nelle lingue semitiche, nella quale un<br />
concetto viene rafforzato esprimendolo me<strong>di</strong>ante una coppi a<strong>di</strong> sinonimi che rimano fra<br />
loro. Nella coppia l’elemento principale è il primo.<br />
L’etimologia <strong>di</strong> tohu rinvia alla nozione <strong>di</strong> “deserto” (in ugaritico thw e in arabo<br />
tih), come confermano le occorrenze del termine in altri luoghi della Bibbia: Dt 32, 10<br />
(«nella steppa e nel tohu» LXX: 6% #7 6189:); Is 45, 18 («Dio non ha creato la terra<br />
tohu», LXX: &;< =&%>%); Sal 107, 40; Gb 6, 18; 12, 24; dalla nozione <strong>di</strong> “deserto”, luogo<br />
nel quale ci si può smarrire, il termine passa ad assumere anche il significato <strong>di</strong><br />
“niente, vanità, illusione, menzogna” (p.e. riferito agli idoli e a chi li fabbrica): 1 Sam<br />
12, 21; Is 24, 10; 40, 17. 23; 41, 29; 44, 9; 45, 19; 49, 4; 59, 4. Il termine bohu è forse<br />
parente del verbo arabo bahiya, “essere vuoto” e del nome della dea Baau, dea madre<br />
notturna nella mitologia fenicia. Se ne può dedurre che almeno implicitamente l’autore<br />
P intenda affermare che quando Dio <strong>di</strong>ede inizio alla creazione la terra era un niente,<br />
non esisteva. Questo è, infatti, il modo in cui Aquila e Teodozione traducevano la coppia<br />
<strong>di</strong> pre<strong>di</strong>cati: $54"%.<br />
· «E tenebra al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> un abisso»<br />
Un primo cenno a una realtà in un certo senso preesistente all’opera della creazione:<br />
prima che Dio inizi a produrre il mondo, vi è tenebra che si stende al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong><br />
15
un abisso. Chiaramente, questa tenebra è connotata in un senso profondamente negativo,<br />
come <strong>di</strong>mostra il valore positivo riconosciuto alla creazione della luce (1, 4a).<br />
Quando Ger 4, 23 vuole in<strong>di</strong>care le conseguenze estreme della collera <strong>di</strong> Dio, cita il ritorno<br />
alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> tohu wabohu e l’abolizione della luce.<br />
Anche il termine “abisso” (tehom) in<strong>di</strong>ca una realtà preesistente, che Dio mo<strong>di</strong>fica<br />
in 1, 6-8 con la costituzione della volta del cielo. Il termine tehom ha la stessa ra<strong>di</strong>ce<br />
del nome Tiamat, personificazione del mare, avversario e vittima del demiurgo nella<br />
cosmologia babilonese. Anche in ugaritico la ra<strong>di</strong>ce thm in<strong>di</strong>ca una massa liquida. Nella<br />
Bibbia il termine è spesso parallelo alla parola “mare”: Gb 28, 14; Sal 33, 7; 135, 6. In<br />
generale, la profon<strong>di</strong>tà del mare suscita negli autori biblici ripugnanza e timore: Ab 3,<br />
10; Gion 2, 16; Sal 107, 26. Se in<strong>di</strong>ca una realtà sovrumana e minacciosa, tehom è però<br />
una realtà dominata da Dio e a lui assoggettata: Es 15, 8. 15; Sal 106, 9; Is 51, 10; 63,<br />
13. In alcuni casi, il termine in<strong>di</strong>ca acque che sgorgano dalla profon<strong>di</strong>tà della terra, senza<br />
però connotazioni minacciose o negative: Ez 31, 4. 15; Dt 8, 7; Gb 38, 30; Sal 78, 15.<br />
Prov 8, 27; Gb 36, 10; Sal 105, 6 evocano una concezione cosmologica secondo<br />
la quale Dio ha prodotto la terra “<strong>di</strong>segnandone” la superficie o gettandola come un abito<br />
al <strong>di</strong> sopra dell’estensione delle acque (tehom). Il racconto del secondo giorno, con la<br />
costituzione <strong>di</strong> una volta solida, serve a in<strong>di</strong>care che Dio ha provveduto alla creazione <strong>di</strong><br />
uno spazio vuoto fra le acque inferiori a quelle superiori, per permettere l’esistenza della<br />
terra, degli astri e degli esseri viventi. Il <strong>di</strong>luvio, che consisterà nell’apertura delle sorgenti<br />
dell’abisso e delle acque superiori e nella loro riunione provvisoria, riproduce un<br />
ritorno, sia pure momentaneo al caos delle origini.<br />
All’inizio della creazione si dà, dunque, un vuoto tenebroso e caotico, descritto<br />
come una massa liquida amorfa e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata, senza alto e basso, e priva <strong>di</strong> vita. In questo<br />
quadro, il primo passo per la riduzione a or<strong>di</strong>ne e forma è la produzione della luce,<br />
che è la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> possibilità del tempo, all’interno del quale si può costituire un or<strong>di</strong>ne<br />
cosmico e storico nel quale si collocano tutte le altre opere della creazione.<br />
· «Il vento/spirito <strong>di</strong> Dio volteggiava sulle acque»<br />
Le acque qui menzionate possono essere considerate un sinonimo del tehom<br />
dell’emistichio precedente. Qui viene introdotto un nuovo elemento anteriore alla creazione:<br />
un vento/spirito che plana sulle acque.<br />
Il participio presente merahephet (piel) è molto raro (in Ger 23, 9 si trova la<br />
forma del perfetto rahap e allude alle ossa che tremano) e nella Bibbia, oltre a qui, lo si<br />
trova solo in Dt 32, 11, dove descrive il volo <strong>di</strong> un uccello al <strong>di</strong> sopra del nido nel quale<br />
custo<strong>di</strong>sce i propri piccoli. È un tremare, svolazzare, muoversi che la versione dei LXX<br />
e la Vulgata rendono con termini più neutri, mentre non sembra possibile ricondurlo<br />
all’idea <strong>di</strong> un “covare”. Il soggetto <strong>di</strong> questo participio è ruah elohim. Si potrebbe intendere<br />
il termine elohim come un semplice superlativo: vento <strong>di</strong> Dio = vento gagliardo,<br />
impetuoso (Sal 80, 11 p.e. i cedri <strong>di</strong> Dio = cedri maestosi). Ma è un po’ strano che questo<br />
racconto si apra con una menzione del nome “Dio” <strong>di</strong> così scarso rilievo.<br />
L’espressione ruah elohim è molto frequente nella Bibbia e può in<strong>di</strong>care sia vento,<br />
sia soffio, sia spirito. In<strong>di</strong>ca una forza motrice che agisce sugli elementi della natura:<br />
Es 15, 10; Is 11, 15; 59, 19; Gion 1, 4; Sal 147, 18; questo ha indotto a vedere nella<br />
menziona fatta qui una sopravvivenza <strong>di</strong> un mito cosmogonico che affidava al vento una<br />
funzione nella seprazione delle acque. Se è così, si tratta in ogni caso <strong>di</strong> nulla più che <strong>di</strong><br />
un relitto verbale. Lo spirito <strong>di</strong> Dio è anche una potenza vivificatrice o rianimatrice della<br />
vita: <strong>Gen</strong> 2, 7; Sal 104, 30. È una potenza che abilita determinate persone a essere<br />
portatrici agli uomini della parola <strong>di</strong> Dio (profeti) o a compiere determinate missioni a<br />
favore del popolo (i giu<strong>di</strong>ci, Saul).<br />
16
Nel racconto <strong>di</strong> P non sembra <strong>di</strong> poter in<strong>di</strong>viduare, però, alcuna funzione specifica<br />
affidata allo spirito: tutto è fatto e detto da Dio, senza altre me<strong>di</strong>azioni. L’immagine<br />
dello spirito che svolazza sulle acque sembra pertanto esprimere semplicemente l’idea<br />
della presenza e dell’azione <strong>di</strong> Dio, come le «ali del vento» <strong>di</strong> Sal 18, 11 sono il veicolo<br />
sul quale si muove Dio.<br />
· Il racconto della creazione <strong>di</strong> P non allude in alcun modo a una creazione dal<br />
nulla, che appare soltanto in Prov 8, 22-31 (Dio è autore anche del tehom) ed è enunciata<br />
come tale in 2 Mac 7, 28. Ambivalente la posizione <strong>di</strong> Sap 11, 17, che suona come un<br />
commento a <strong>Gen</strong> 1, 2 e per il suo colorito platonizzante (Tim. 51 A) fa pensare piuttosto<br />
a una creazione a partire da una materia preesistente (anche se <strong>di</strong> per sé il testo non vieta<br />
<strong>di</strong> pensare a una materia prima creata da Dio e poi or<strong>di</strong>nata): =?@3030 ... ?A% =>39$%<br />
6B C9>1D$E FG2
Alcune osservazioni sulle caratteristiche della versione greca dei LXX<br />
Il testo biblico presenta in <strong>Gen</strong> 1-2 due racconti della creazione: nel primo essa è<br />
descritta in sei giorni che introducono al riposo del settimo, nel secondo essa avviene<br />
senza una scansione temporale precisa e con modalità <strong>di</strong>verse. La cerniera fra i due racconti<br />
è in 2, 4a-b. Il testo della LXX collega fra loro i due membri <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 2, 4, facendone<br />
un’unica frase.<br />
Gli esegeti antichi hanno riconosciuto e <strong>di</strong>scusso i problemi posti dall’apparente<br />
duplicazione del racconto della creazione:<br />
- un primo punto <strong>di</strong> vista può vedere nel secondo racconto una ripresa del primo;<br />
assumendo questa prospettiva, il peccato <strong>di</strong> Adamo ebbe luogo nel sesto giorno e in<br />
questo stesso giorno Adamo fu esiliato dal para<strong>di</strong>so: cf. <strong>Origene</strong> HLc fr. 249: «Il Cristo<br />
fu sospeso il sesto giorno perché colui che fu creato il sesto giorno e che cadde dal para<strong>di</strong>so<br />
all’ora sesta riceva <strong>di</strong> nuovo l’elezione»;<br />
- un’altra lettura è testimoniata p.e. da Teofilo <strong>di</strong> Antiochia, Ad Autol. II 23:<br />
«Dio fece l’uomo nel sesto giorno, ma non è che dopo il settimo che ne fece conoscere<br />
la plasmazione, quando ebbe realizzato il para<strong>di</strong>so...»;<br />
- una terza interpretazione vede nei due racconti due <strong>di</strong>stinte fasi dell’opera della<br />
creazione: una creazione ideale, descritta nel primo racconto, che ha preceduto la plasmazione<br />
sensibile; il modello <strong>di</strong> questa interpretazione è il Timeo <strong>di</strong> Platone, cf. <strong>Filone</strong><br />
<strong>di</strong> Alessandria e <strong>Origene</strong>.<br />
In generale, la traduzione greca è particolarmente attenta nella resa fedele del testo<br />
ebraico e della sua struttura, pe l’or<strong>di</strong>ne delle parole in <strong>Gen</strong> 1, 1 segue esattamente<br />
l’ebraico. Vi sono tuttavia un certo numero <strong>di</strong> piccoli interventi, fra i quali segnalo:<br />
- l’aggiunta della formula <strong>di</strong> compimento «e così avvenne» in 1, 7, assente nel<br />
TM;<br />
- l’unificazione dei due verbi ebraici barah (creare) e asah (fare) nel verbo greco<br />
H$I"J (fare); mentre il verbo yasar (plasmare), che viene usato nel secondo racconto (2,<br />
7-8), viene reso con il verbo greco dal significato analogo HGK33J. Così per i lettori<br />
greci si darà un’opposizione binaria fra due tipi <strong>di</strong> azione <strong>di</strong>vina: H$I"J e HGK33J, che<br />
è uno degli elementi su cui si fonda la doppia interpretazione della creazione offerta da<br />
<strong>Filone</strong> e ripresa da <strong>Origene</strong>: creazione intelligibile e plasmazione sensibile. Nei sapienziali<br />
e nel NT per esprimere la creazione da parte <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong>venterà usuale anche il verbo<br />
=?@LJ (Prov 8, 22; Sap 1, 14; 2, 23; 10, 1; 11, 17; 13, 3; Mt 19, 4);<br />
- la correzione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 2, 2: il compimento delle opere della creazione è collocato<br />
nel sesto giorno e non nel settimo (TM), evidentemente per scrupolo nei confronti<br />
dell’osservanza del riposo sabbatico;<br />
- sottolineatura del parallelismo nella formulazione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 2, 4 e 5, 1, per scan<strong>di</strong>re<br />
le <strong>di</strong>verse tappe della narrazione delle origini.<br />
Alcune scelte lessicali hanno avuto importanti ricadute sulla storia dell’esegesi<br />
del testo, perché ne hanno promosso la lettura in relazione con concetti <strong>di</strong> origine filosofica<br />
ellenica o hanno posto problemi <strong>di</strong> comprensione che hanno stimolato la ricerca esegetica:<br />
- la scelta del termine C1M8 per rendere l’ebraico reshit (cf sotto i cataloghi <strong>di</strong><br />
possibili significati del termine);<br />
18
- la resa dei termini tohu wabohu con C>10?$< =0N C=0?03=&O03?$< mantiene<br />
con l’allitterazione qualcosa del gioco sonoro dell’ebraico, che interpreta come un equivalente<br />
della nozione greca <strong>di</strong> “caos”. L’aggetivo C>10?$< evoca Plat. Tim. 51 A.<br />
Interessanti i tentativi <strong>di</strong> traduzione <strong>di</strong> altre due versioni greche antiche:<br />
Aquila: P QR #S T% ="%J90 =0N $54"%.<br />
Teodozione: P QR #S T% 4R% =0N $54"%. Il medesimo gioco <strong>di</strong> parole in Democrito<br />
fra Q"% e 92Q"% («pieno e vuoto» ap. Plut. Adv. Col. 4, 1109 a);<br />
- la resa del termine ebraico tehom, che in<strong>di</strong>ca la massa delle acque, con il greco<br />
P U/E33$< = fondo del mare, profon<strong>di</strong>tà);<br />
- la resa dell’ebraico ruah con il termine greco H%&V90, adottato anche da Aquila<br />
e Simmaco, che ha la stessa ambivalenza dell’ebraico, non permette <strong>di</strong> capire in che<br />
senso lo comprendessero i traduttori antichi, né quale funzione gli attribuissero: soffio,<br />
vento <strong>di</strong>vino/<strong>di</strong> Dio, Spirito, respiro? Per contro, l’uso del termine greco indurrà negli<br />
esegeti della LXX l’applicazione a questo testo <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> delle caratteristiche proprie del<br />
H%&V90 stoico: aria e fuoco mescolati che penetrano tutte il cosmo e lo animano; e tutte<br />
le altre interpretazioni <strong>di</strong> questo termine, <strong>di</strong> tipo materialistico o spiritualistico, che si<br />
svilupperanno in ambiente sia giudaico sia cristiano;<br />
- la resa dell’ebraico tov con l’aggettivo greco =0G>< riferito alle opere della<br />
creazione: esso in<strong>di</strong>ca ciò che ha qualità estetiche, utilità pratica e <strong>di</strong>gnità morale. La<br />
<strong>di</strong>mensione estetica <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne, associata a quella <strong>di</strong> bellezza, è particolarmente enfatizzata<br />
dalla cultura greca con il doppio valore della nozione <strong>di</strong> =>39$
La lettura giudaica e cristiana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2 2<br />
La letteratura giudaica è ricca <strong>di</strong> rinvii alla narrazione delle origini e <strong>di</strong> sviluppi<br />
dottrinali che ne <strong>di</strong>pendono. Accanto al racconto sacerdotale <strong>di</strong> Gn 1-2, 4,<br />
un’importante riflessione sul significato della creazione si trova in epoca esilica<br />
nell’opera del deutero-Isaia (Is 40-55). Nella me<strong>di</strong>tazione <strong>di</strong> questo profeta il ricordo<br />
dell’opera creatrice <strong>di</strong> Dio serve a fondare la speranza in una futura liberazione e restaurazione<br />
<strong>di</strong> Israele (cf. p.e. Is 40, 12-26): il Dio artefice del mondo, autore della liberazione<br />
dall’Egitto ha punito i peccati del suo popolo consegnandolo all’esilio, ma è pronto<br />
a intervenire ancora per salvarlo. Anche in seguito, nel giudaismo del secondo tempio,<br />
il tema della creazione sarà associato alla riflessione intorno al destino e al posto <strong>di</strong><br />
Israele nella storia, soprattutto in relazione a momenti <strong>di</strong> crisi.<br />
Un ambito letterario nel quale emerge con particolare rilievo il tema della creazione<br />
nel giudaismo post-esilico è quello della riflessione sapienziale. La contemplazione<br />
della sua opera <strong>di</strong> creatore manifesta la potenza e sovranità inaccessibile <strong>di</strong> Dio (cf.<br />
Gb 38-41). Nelle allusioni o nelle parafrasi del racconto della creazione emerge progressivamente<br />
il ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione svolto da una realtà, la sapienza/parola <strong>di</strong> Dio, che<br />
acquista quasi una sussistenza autonoma fra Dio e il cosmo (cf. Prov 8, 22-31). La sapienza<br />
ha una funzione cosmica, ma anche storica: essa presiede all’elezione <strong>di</strong> Israele<br />
ene guida il cammino nella storia dell’umanità (cf. Sir 24, 2-6; Sap 10-19). Diventa più<br />
esplicita l’idea che Dio abbia creato la totalità delle cose, compresa la materia primor<strong>di</strong>ale<br />
<strong>di</strong> cui esse sono costituite e che nell’opera della creazione siano incluse anche le<br />
creature angeliche, <strong>di</strong> cui Gn non parla. Si nota anche che il riferimento alla creazione<br />
serve a fondare una riflessione sul senso della storia e del destino presente <strong>di</strong> Israele.<br />
· Qumran deduce dalla creazione a opera <strong>di</strong> Dio, e dall’opposizione fondamentale<br />
fra luce e tenebre, un’antropologia tendenzialmente deterministica: Dio conosce e<br />
<strong>di</strong>spone ogni azione delle creature, e ogni in<strong>di</strong>viduo, ogni atto, stanno sotto l’imperio o<br />
del principe della luce o dell’angelo delle tenebre (1QH XIII 8. 10; 1 QS III 13-IV 26).<br />
· La letteratura pseudoepigrafica abbonda <strong>di</strong> riferimenti al racconto biblico<br />
della creazione: Jub 2, 1-16; 4 Esd 3, 4; 6; 2 Bar 21, 4-6; Ass. Mos. 12, 9; 2 Hen 24-33;<br />
1 Hen 21, 2; 41, 4; 89, 9.<br />
Il Libro dei Giubilei, del quale è stata conservata per intero solo la versione in etiopico,<br />
è stato composto in ebraico negli ultimi anni del II secolo a.C. da un autore vicino<br />
agli ambienti esseni. Con<strong>di</strong>vide il sentimento <strong>di</strong> riscossa nazionale che si è espresso<br />
nella rivolta dei Maccabei, ma è critico sugli esiti <strong>di</strong> quella rivolta e considera contaminati<br />
il tempio <strong>di</strong> Gerusalemme e il culto che vi si svolge.<br />
L’opera contiene una rilettura <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> ed Es ed inizia presentando Mosè sul Sinai<br />
che riceve per la me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> un angelo la Legge e la rivelazione <strong>di</strong> tutta la storia futura<br />
<strong>di</strong> Israele. La Legge e la storia dell’umanità sono riflessi, attuazioni <strong>di</strong> una Legge eterna,<br />
scritta ab aeterno da Dio nelle tavole del cielo. Jub 2, 1-16 presenta alcune sottolineature<br />
caratteristiche rispetto al racconto sacerdotale della creazione: Dio è autore<br />
della totalità della realtà e non solo or<strong>di</strong>natore del caos originario (cf. la medesima dottrina<br />
in 2 Mac 7, 28); la creazione delle creature angeliche è espressamente menzionata,<br />
2 Cf. GEOLTRAIN, PIERRE, Quelques lectures juives et chrétiennes des premiers versets de la <strong>Gen</strong>èse de<br />
Qoumrân au Nouveau Testament, in In Principio. Interprétations des premiers versets de la <strong>Gen</strong>èse,<br />
Paris, Études augustiniennes, 1973, pp. 47-60 (Centre d’Études des religions du Livre).<br />
20
insieme alla sottolineatura della trascendenza, immutabilità e perfezione del creatore.<br />
Come l’autore sacerdotale fonda nel ritmo del cosmo l’osservanza del sabato, anche Jub<br />
collega strettamente all’or<strong>di</strong>ne cosmico il ciclo festivo, adottando un calendario solare,<br />
anziché il tra<strong>di</strong>zionale calendario lunare (questo tratto si collega alla polemica contro il<br />
tempio <strong>di</strong> Gerusalemme e al culto che si celebra in esso).<br />
Interessante è anche lo stretto collegamento istituito tra le opere della creazione<br />
e la vicenda <strong>di</strong> Israele: 22 sono le opere compiute da Dio nei sei giorni della creazione e<br />
22 sono le generazioni dei patriarchi da Adamo, il primo uomo, a Giacobbe, il capostipite<br />
<strong>di</strong> Israele. per significare che in Israele e nella sua storia si compie la pienezza<br />
dell’opera <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong>spiegata nella creazione. Si può collegare questo genere <strong>di</strong> speculazioni<br />
alle interpretazioni simboliche del numero dei libri della Scrittura ebraica, che li<br />
connetteva al numero delle lettere dell’alfabeto. Giuseppe Flavio (37-100 d.C.), p.e., nel<br />
Contra Apionem (I 8, 37-41) <strong>di</strong>chiara che i giudei possiedono 22 libri (tanti quante sono<br />
le lettere dell’alfabeto) che abbracciano «la storia <strong>di</strong> tutti i tempi» e «sono considerati<br />
<strong>di</strong>vini».<br />
4 Esd e il Libro delle antichità bibliche dello pseudo-<strong>Filone</strong>, entrambi della fine<br />
del I sec., propongono una speculazione particolarmente avanzata in campo cosmologico.<br />
L’autore <strong>di</strong> 4 Esd scrive dopo la sconfitta del 70 d.C. in un quadro <strong>di</strong> desolazione<br />
per Israele e lega strettamente la me<strong>di</strong>tazione sul destino storico del proprio popolo alla<br />
rievocazione dell’opera della creazione. Il presente tragico <strong>di</strong> Israele non deve scuotere<br />
le speranze del popolo e la fiducia nell’elezione, perché esso configura il passaggio<br />
stretto e doloroso (tra il fuoco e l’acqua) attraverso il quale soltanto è possibile all’erede<br />
<strong>di</strong> un regno accedere alla cità opulenta che ha ricevuto in sorte (cf. in Mt 7 il tema della<br />
via stretta che conduce al regno).<br />
Nel racconto della creazione è interessante l’opposizione tra silenzio originario<br />
<strong>di</strong> Dio e sua parola creatrice (ritmo analogo a quello del prologo <strong>di</strong> Gv): 7, 30 <strong>di</strong>chiara<br />
al veggente che la creazione tornerà al silenzio primor<strong>di</strong>ale che ha preceduto la prima<br />
parola con la quale Dio creò la luce. Cf anche 4 Esd 6, 39-40: la parola crea il cielo e la<br />
terra quando tenebre e silenzio avvolgevano ogni cosa; è interessante osservare che nel<br />
sistema valentiniano la coppia silenzio-abisso costituisce la prima sizigia.<br />
Le antichità bibliche dello pseudo-<strong>Filone</strong> si collocano in questa linea facendo<br />
precedere la creazione, persino la creazione del Nome <strong>di</strong> Dio, dalla coppia tenebrasilenzio<br />
(Ant Bib 60, 2).<br />
· Il Nuovo testamento non contiene elementi espliciti <strong>di</strong> riflessione sulla cosmogonia<br />
<strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, con l’importante eccezione del prologo al vangelo <strong>di</strong> Giovanni, al<br />
quale il racconto della creazione offre l quadro <strong>di</strong> riferimento. Echi <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2 si colgono<br />
nei testi sul Verbo creatore (Col 1, 15-17; Eb 1, 2-3; Apoc 3, 14; 21, 6).<br />
Per quanto concerne il prologo <strong>di</strong> Gv:<br />
- Il Logos, del quale il vangelo narra la manifestazione nella carne attraverso la<br />
vicenda del Cristo, è anteriore a questa vicenda, anzi alla stessa creazione del mondo,<br />
della quale è il me<strong>di</strong>atore: il Logos è in principio ed è destinato, una volta compiuta la<br />
sua funzione storica, a tornare nella gloria del Padre (Gv 17, 5. 24).<br />
- Il prologo si inserisce nella tra<strong>di</strong>zione speculativa giudaica che, sviluppando<br />
l’idea implicita nell’affermazione «Dio <strong>di</strong>sse», aveva sottolineato il ruolo della parola/sapienza<br />
<strong>di</strong> Dio nella creazione del mondo: Sal 33, 6; Sap 9, 1; Prov 8, 22-23; Sir 24,<br />
9. Riprendendo la concezione del rapporto silenzio/parola nella creazione che si è vista<br />
in 4 Esd e pseudo-<strong>Filone</strong>, Ignazio d’Antiochia designa il Logos come colui che esce dal<br />
21
silenzio (Magn. 8, 2). Il prologo giovanneo, se marca la <strong>di</strong>stinzione fra Dio e il Logos (il<br />
Logos è infatti presso Dio), ne sottolinea esplicitamente anche l’identità: il Logos è Dio,<br />
è Dio che si rivela e si me<strong>di</strong>a alla creazione, prima, poi nella storia della salvezza attraverso<br />
l’incarnazione («Dio nessuno l’ha conosciuto, egli ce lo ha spiegato»).<br />
La funzione me<strong>di</strong>atrice del Figlio nella creazione è presente in vari altri luoghi<br />
del NT (1 Cor 8, 6; Col 1, 16; Eb 1, 2; 11, 3; 1 Pt 1, 20), ma tende a scomparire, sopraffatta<br />
dal peso maggiore della me<strong>di</strong>azione storico-salvifica del Figlio.<br />
- A <strong>Gen</strong> 1, 1 rinvia, oltre all’esor<strong>di</strong>o «in principio», anche l’opposizione luce/tenebre<br />
(Gv 1, 4-5. 9), che è anche uno dei temi importanti della speculazione qumranica<br />
sull’uomo e la storia. Sulla linea <strong>di</strong> un’esperienza interiore <strong>di</strong> illuminazione si<br />
colloca la menzione <strong>di</strong> 2 Cor 4, 6.<br />
Un rinvio meno evidente al <strong>Gen</strong> 1, 1 può essere riconosciuto nella costruzione<br />
nell’opera <strong>di</strong> Luca del racconto degli esor<strong>di</strong> della missione <strong>di</strong> Gesù (Lc 3, 21-4, 21; cf.<br />
anche At 10, 37) e degli apostoli (At 2; cf. anche 11, 5). In entrambi i racconti l’inizio<br />
(arché) del ministero <strong>di</strong> Gesù o della chiesa è preceduto dall’effusione dello Spirito. Esso,<br />
nel battesimo <strong>di</strong> Gesù (la genealogia del quale lo riconnette ad Adamo!) si presenta<br />
come una colomba, il che può richiamare allo Spirito che volteggia sulle acque <strong>di</strong> <strong>Gen</strong><br />
1, 1.<br />
· <strong>Filone</strong> <strong>di</strong> Alessandria (~ 15/10 a.C. - dopo il 40 d.C.) <strong>di</strong>scendeva da una facoltosa<br />
e influente famiglia <strong>di</strong> ebrei alessandrini. La sua lingua madre era il greco e ci sono<br />
molti dubbi che conoscesse l’ebraico. La sua vita è quasi del tutto oscura, ma si può<br />
supporre, dalle sue opere, che abbia ricevuto un’accurata formazione culturale <strong>di</strong> tipo ellenico.<br />
Delle sue vicende biografiche sono noti solo un pellegrinaggio a Gerusalemme e<br />
la partecipazione a una delegazione della comunità giudaica <strong>di</strong> Alessadria, inviata nel<br />
40 d.C. a Roma per ottenere dall’imperatore Caligola la revoca delle misure ostili prese<br />
dal prefetto <strong>di</strong> Alessandria Flacco. Le sue opere, in buona parte conservate, hanno avuto<br />
ampia <strong>di</strong>ffusione tra gli scrittori cristiani ed è a questa circostanza che si deve la loro<br />
conservazione, anche se certamente <strong>Filone</strong> non è stato il primo né l’unico rappresentante<br />
del giudaismo ellenizzato ad avere utilizzato le risorse della paideia greca per approfon<strong>di</strong>re<br />
la comprensione della tra<strong>di</strong>zione giudaica.<br />
La sua produzione letteraria può essere classificata in <strong>di</strong>versi generi (vari scritti a<br />
lui attribuiti sono tuttavia <strong>di</strong> autenticità incerta):<br />
- scritti sistematici su questioni metafisiche (De aeternitate mun<strong>di</strong>, De opificio<br />
mun<strong>di</strong>, De providentia), etiche (Quod omnis probus liber sit), psicologiche (Alexander,<br />
sive de eo quod rationem habeant bruta animalia), biografico (De Abrahamo, De Iosepho,<br />
Vita Mosis);<br />
- scritti de<strong>di</strong>cati all’esegesi biblica (Legum allegoriae, De gigantibus, De somniis,<br />
De confusione linguarum, Quaestiones in <strong>Gen</strong>esim, Quaestiones in Exodum, De<br />
decaologo, De specialibus legibus)<br />
- scritti <strong>di</strong> carattere apologetico (De vita contemplativa, Contra Flaccum, Legatio<br />
ad Gaium)<br />
Se è chiaro lo stretto rapporto che lega l’opera <strong>di</strong> <strong>Filone</strong> con la cultura ellenica,<br />
molto minore è il consenso tra gli stu<strong>di</strong>osi sulla valutazione più precisa <strong>di</strong> questo rapporto;<br />
si oscilla tra un <strong>Filone</strong> pensatore sistematico nel quadro della tra<strong>di</strong>zione greca<br />
(platonica, neopitagorica o stoica), un <strong>Filone</strong> asistematico, puro trasmettitore eru<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />
22
dottrine altrui, un <strong>Filone</strong> preoccupato anzitutto della comprensione della tra<strong>di</strong>zione giudaica<br />
e dell’esegesi delle Scritture ecc.<br />
Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> classificazioni che possono anche essere gratuite, l’opera <strong>di</strong> <strong>Filone</strong> è<br />
mossa dall’intento <strong>di</strong> promuovere presso giudei e greci la conoscenza del vero Dio (il<br />
Dio d’Israele) e una vita virtuosa, conforme alla sua volontà; non vi è in realtà per lui<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> sostanza tra l’essere filosofo in senso ellenico e l’essere un sapiente nel<br />
senso dell’osservanza della tra<strong>di</strong>zione giudaica, visto che per lui la vera e originaria conoscenza<br />
si identifica con la dottrina insegnata da Mosè (e poi appresa e utilizzata anche<br />
dai migliori tra i greci).<br />
Fondamento della sua riflessione è il testo biblico, letto nella versione dei LXX e<br />
interpretato secondo i criteri dell’esegesi allegorica corrente nella tra<strong>di</strong>zione stoica e<br />
platonica (e adottata anche in ambiente giudaico alessandrino da autori anteriori a <strong>Filone</strong>),<br />
anche se non nega valore anche alla lettera del testo biblico e delle sue prescrizioni.<br />
Evidentemente, una tale operazione non poteva essere interamente il prodotto originale<br />
<strong>di</strong> una sola persona, ma si colloca all’interno <strong>di</strong> una tra<strong>di</strong>zione che ci è mal nota, perché<br />
solo <strong>di</strong> <strong>Filone</strong> è stata conservata un’ampia parte degli scritti.<br />
Di fronte al racconto della creazione, non ne accetta un’intepretazione puramente<br />
letterale, perché essa supporrebbe una rappresentazione <strong>di</strong> Dio e della genesi del cosmo<br />
ingenua e contraria ad acquisizioni da <strong>Filone</strong> ritenute scontate (come l’incorporeità<br />
<strong>di</strong> Dio, la sua eternità, la sua trascendenza rispetto agli enti determinati...) e porrebbe<br />
anche problemi <strong>di</strong> coerenza (perché mai due racconti consecutivi e non armonizzabili?).<br />
Perciò nel De opificio mun<strong>di</strong> <strong>Filone</strong> sceglie la via <strong>di</strong> una lettura allegorica, che intende il<br />
primo racconto della creazione come descrizione della produzione del cosmo intelligibile.<br />
L’esamerone (termine che compare per la prima volta in <strong>Filone</strong>: Decal. 100; LA<br />
II 12) contiene secondo <strong>Filone</strong> le dottrine fondamentali della rivelazione biblica: esistenza<br />
e unicità <strong>di</strong> Dio, creatore del mondo, provvidente (Opif. 170-171). Nella propria<br />
esegesi, <strong>Filone</strong> si ispira tanto a tra<strong>di</strong>zioni giudaiche (ruolo me<strong>di</strong>atore della Parola <strong>di</strong> Dio<br />
e della Legge nella creazione, p.e.), quanto a mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensare e problemi tipici del pensiero<br />
ellenico (nozioni <strong>di</strong> “materia”, “tempo”, problema del rapporto tra intelligibile e<br />
sensibile, riferimenti al Timeo <strong>di</strong> Platone).<br />
L’esegesi filoniana del racconto della creazione è impostata su una doppia <strong>di</strong>stinzione:<br />
il giorno uno - i giorni successivi<br />
il primo racconto - il secondo racconto<br />
Complessivamente, nel primo racconto si delinea la creazione <strong>di</strong> una realtà formale,<br />
dei generi delle cose, anche se il giorno uno ha una posizione <strong>di</strong>stinta rispetto ai<br />
giorni successivi, perché le realtà create in esse costituiscono il Logos, che è identico al<br />
progetto intelligibile della creazione, nei suoi sette elementi fondamentali, creati tutti<br />
nel giorno uno:<br />
- cielo incorporeo<br />
- terra invisibile<br />
- idea dell’aria (tenebra)<br />
- idea del vuoto (abisso)<br />
- essenza incorporea dell’acqua<br />
- pneuma<br />
- essenza incorporea della luce<br />
23
Ciascuno <strong>di</strong> questi elementi costituisce una sorta <strong>di</strong> luogo che nel processo della<br />
creazione viene popolato <strong>di</strong> esseri determinati<br />
Nel De aeternitate mun<strong>di</strong> il problema al quale <strong>Filone</strong> cercar risposta è se il mondo<br />
sia stato creato o no e se sia o no corruttibile. Il trattato è un abbozzo incompleto ed è<br />
stata messa in <strong>di</strong>scussione la sua autenticità, ma lo si può assumere come una testimonianza<br />
atten<strong>di</strong>bile della posizione filoniana in materia.<br />
Le posizioni dei filosofi sono raggruppate in tre tesi:<br />
- il mondo è creato nel tempo ed è corruttibile (stoici e atomisti): posizione che<br />
<strong>Filone</strong> rigetta;<br />
- il mondo è eterno, increato e incorruttibile (Aristotele): <strong>Filone</strong> accetta solo la<br />
dottrina dell’eternità del mondo;<br />
- il mondo è increato nel tempo, ma è opera <strong>di</strong> un creatore ed è incorruttibile<br />
(Platone): è la tesi che <strong>Filone</strong> approva.<br />
In realtà <strong>Filone</strong> procede in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una conciliazione della posizione platonica<br />
e <strong>di</strong> quella aristotelica, interpretata nel senso <strong>di</strong> una formulazione <strong>di</strong>versa <strong>di</strong> quella<br />
platonica: il mondo è increato nel senso che non è stato fatto nel tempo, ma <strong>di</strong>pende realtmente<br />
nel proprio essere da un demiurgo. Definito il mondo come la totalità del cielo<br />
e della terra sensibili, con tutto ciò che contengono (Aet. 4), <strong>Filone</strong> <strong>di</strong>chiara, infatti,<br />
ch’esso non può essere destinato a ritornare semplicemente al non essere, se è questo il<br />
senso in cui si intende il termine “corruzione”. Il mondo è creato ed è incorruttibile (Aet.<br />
19). Dal momento che Dio stesso <strong>di</strong>chiara che la creazione è buona, non può non prendersene<br />
cura, usando tutti mezzi necessari alla sua preservazione (Opif. 9-10); e come<br />
non è pensabile che Dio venga meno alla propria bontà, così è impensabile che il mondo<br />
debba finire nel non essere.<br />
24
<strong>Filone</strong> <strong>di</strong> Alessandria<br />
La creazione del mondo secondo Mosè<br />
[Racconto della creazione e legge mosaica]<br />
[1] Fra i legislatori, alcuni <strong>di</strong>sposero senza ricercatezza e senza alcuna aggiunta<br />
le cose che ritenevano esser giuste, altri invece, avvolgendo in grande ampollosità i propri<br />
pensieri, gettarono fumo negli occhi alle masse, nascondendo la verità con finzioni<br />
mitiche 3. [2] Mosè, lasciati da parte entrambi i mo<strong>di</strong> — l’uno in quanto alieno da riflessione,<br />
<strong>di</strong>simpegnato e non filosofico, l’altro in quanto mendace e ciarlatanesco — <strong>di</strong>ede<br />
alle proprie leggi un principio pieno <strong>di</strong> bellezza e nobiltà 4, non in<strong>di</strong>cando subito ciò che<br />
bisogna fare o non fare e nemmeno — dal momento ch’era necessario dare prima<br />
un’impronta alle menti <strong>di</strong> coloro che avrebbero poi fatto uso delle leggi — plasmando<br />
dei miti o assentendo a quelli composti da altri 5.<br />
[3] Questo principio è, come <strong>di</strong>cevo, degno d’ogni ammirazione, dal momento<br />
che include una narrazione della creazione del cosmo, a partire dalla convinzione che il<br />
cosmo sia in consonanza con la legge e la legge sia in consonanza col cosmo e che<br />
l’uomo rispettoso della legge sia per ciò stesso citta<strong>di</strong>no del cosmo, dal momento che<br />
<strong>di</strong>rige le proprie azioni secondo la volontà della natura, in conformità con la quale è governato<br />
anche il cosmo intero 6.<br />
[Profon<strong>di</strong>tà speculativa del racconto della creazione]<br />
[4] La bellezza dei pensieri del racconto della creazione nessuno, né un poeta, né<br />
un prosatore, potrebbe celebrarla degnamente; essi superano, infatti, la parola e l’u<strong>di</strong>to,<br />
essendo troppo gran<strong>di</strong> e nobili per potersi adattare agli strumenti <strong>di</strong> un essere mortale.<br />
[5] Non per questo, però, devono essere taciuti, anzi, per l’amore verso Dio, bisogna avere<br />
il coraggio <strong>di</strong> parlarne al <strong>di</strong> là delle proprie forze, non <strong>di</strong>cendo nulla a partire da se<br />
stessi e <strong>di</strong>cendo — piuttosto che molte — poche cose, alle quali la ragione umana, purché<br />
posseduta dall’amore e dal desiderio della sapienza, può verosimilmente arrivare.<br />
[6] Come infatti anche il più piccolo sigillo può recare incise le immagini <strong>di</strong> grandezze<br />
colossali, così forse anche le bellezze straor<strong>di</strong>narie del racconto della creazione descritto<br />
nelle leggi, che abbagliano con il loro splendore le anime <strong>di</strong> coloro che le leggono, sa-<br />
3 Importanza della forma letteraria: una comunicazione <strong>di</strong>sadorna è indegna <strong>di</strong> un contenuto filosofico alto,<br />
ma anche il fumo (typhos) <strong>di</strong> una retorica vana denuncia il carattere fittizio del contenuto che si pretende<br />
<strong>di</strong> comunicare in quel modo. Il racconto biblico deve essere <strong>di</strong>feso nella sua verità (contro le finzioni<br />
mitiche) e nella sua nobiltà (contro chi lo accusa <strong>di</strong> essere una narrazione banale).<br />
4 Principio (arché) può essere sia il punto <strong>di</strong> partenza, sia, in senso più forte, il principio generatore,<br />
l’origine. <strong>Filone</strong> istituisce una relazione fra la cosmogonia e la legislazione mosaiche e fa <strong>di</strong>scendere<br />
l’una dall’altra. L’or<strong>di</strong>namento della natura è il primo atto <strong>di</strong> Dio e si rispecchia anche nell’or<strong>di</strong>namento<br />
legale della comunità del popolo d’Israele; idea consonante con una concezione stoica dell’or<strong>di</strong>ne politico<br />
come espressione del medesimo logos che regge l’or<strong>di</strong>ne cosmico. Cf. anche Plat. Leg. IV 719 E-722 E.<br />
5 Non mi è chiaro il senso dell’inciso: <strong>Filone</strong> intende <strong>di</strong>re che i miti sono stati inventati dai poeti con<br />
l’intento <strong>di</strong> influenzare le menti degli ascoltatori e renderli più docili, cosa che Mosè non intende fare;<br />
oppure intende <strong>di</strong>re che, mentre gli altri scrittori hanno tentato <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre i popoli all’obbe<strong>di</strong>enza alla<br />
legge inventando miti falsi, Mosè lo ha fatto proponendo un insegnamento vero sull’origine del cosmo e<br />
dell’uomo?<br />
6 Il nesso tra or<strong>di</strong>ne della natura e or<strong>di</strong>ne della società civile e politica è qui esplicitato con un lessico stoico:<br />
chi rispetta la legge mosaica si inserisce a pieno titolo anche nell’or<strong>di</strong>ne razionale, perché <strong>di</strong>vino, del<br />
cosmo creato da Dio. Mosè, me<strong>di</strong>atore della legislazione e narratore della cosmogonia, è il prototipo<br />
dell’uomo virtuoso e del filosofo. Questo § si legge in SVF III 336.<br />
25
anno in qualche modo mostrate per mezzo <strong>di</strong> segni più esigui, una volta che sia stato<br />
prima svelato ciò che non è opportuno passare sotto silenzio 7.<br />
[Natura creata del cosmo]<br />
[7] Alcuni, infatti, avendo ammirato il cosmo più del creatore del cosmo, <strong>di</strong>chiararono<br />
che il primo è ingenerato ed eterno, accusarono, invece, falsamente ed empiamente<br />
Dio <strong>di</strong> una grande inerzia, mentre si dovrebbe, al contrario, sbigottire per le sue<br />
potenze, in quanto creatore e padre 8, e non esaltare oltre misura il mondo 9. [8] Mosè, invece,<br />
giunto al vertice stesso della filosofia e istruito da oracoli sui maggiori e più essenziali<br />
principi della natura, riconobbe che fra gli esseri è assolutamente necessario vi<br />
sia, da una parte, una causa attiva e, dall’altra, una passiva e riconobbe che la causa attiva<br />
è l’intelletto dell’universo, purissimo e incontaminato, superiore alla virtù, superiore<br />
alla scienza, superiore al bene in sé e alla bellezza in sé, mentre [9] la causa passiva è <strong>di</strong><br />
per sé inanimata e immobile, ma, mossa, informata e animata dall’intelletto, si trasformò<br />
nell’opera più perfetta, questo cosmo 10.<br />
[Dottrina della creazione e provvidenza]<br />
Coloro che affermano ch’esso è ingenerato non si rendono conto <strong>di</strong> aver reciso<br />
ciò che è più utile e necessario fra quanto giova alla pietà: la provvidenza. La ragione<br />
<strong>di</strong>mostra, infatti, che il padre si prende cura <strong>di</strong> ciò che è stato generato: [10] giacché il<br />
padre ha <strong>di</strong> mira la permanenza dei figli e l’artigiano quella dei propri prodotti e ciò che<br />
è nocivo e dannoso lo allontanano con ogni espe<strong>di</strong>ente, mentre ciò che è utile e propizio<br />
desiderano in ogni modo procurarlo. Chi, invece, non ha prodotto nulla non nutre alcuna<br />
inclinazione verso ciò che non è stato fatto da lui. [11] È perciò una dottrina in<strong>di</strong>fen<strong>di</strong>bile<br />
e inutile, che procura, come in una città, l’anarchia a questo cosmo, che non ha più<br />
7 È un tema tra<strong>di</strong>zionale nell’esor<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso la <strong>di</strong>chiarazione della propria impotenza <strong>di</strong> fronte<br />
all’eccellenza dell’oggetto [vedere Curtius]. Cf. Theoph. Ad Autol. II 12: «I sei giorni nessuno potrebbe<br />
narrarli come si dovrebbe, né seguirne tutta l’economia, anche se avesse mille bocche e mille lingue, anche<br />
se dovesse vivere mille anni sulla terra, perché gli sarebbe impossibile trattare anche solo in parte degnamente<br />
questo argomento tanto la <strong>di</strong>vina sapienza è superiore in grandezza e ricchezza, questa sapienza<br />
che si trova nella descrizione dei sei giorni». L’inesauribilità dei pensieri comunicati dal racconto mosaico<br />
della creazione spiega anche la legittimità del ricorso all’esegesi allegorica: occorre sforzarsi <strong>di</strong> attingere<br />
una comprensione del testo che superi il mero dato storico e letterale. Tale attività non avrà mai fine,<br />
ma per essere legittima deve muovere dalla ragione e dall’amore, non essere frutto <strong>di</strong> invenzione e finsione<br />
spontanea. Amore e desiderio come moventi <strong>di</strong> un processo conoscitivo delle verità più alte sono temi<br />
<strong>di</strong> ascendenza platonica: Symp.<br />
8 Coppia <strong>di</strong> attributi frequentissima nel linguaggio filosofico tardo-antico per designare il demiurgo: Tim,<br />
28 C [cf. le note <strong>di</strong> Whittaker su questa coppia].<br />
9 La <strong>di</strong>scussione se il mondo sia generato o ingenerato e se questa generazione debba intendersi come inizio<br />
temporale o mera <strong>di</strong>pendenza causale dal demiurgo si svolge in ambito platonico in rapporto con<br />
l’esegesi del Timeo (Baltes, Weltentstehung); sostenitori dell’eternità del mondo sono i <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Aristotele.<br />
Per <strong>Filone</strong>, affermare che il mondo è ingenerato ed eterno significa ridurre Dio al ruolo <strong>di</strong> un<br />
principio inerte e ininfluente, il che comprometterebbe anche la dottrina della provvidenza e della retribuzione.<br />
10 Il § 8 è un’eccellente esplicitazione della prospettiva a partire dalla quale <strong>Filone</strong> considera la sapienza<br />
ellenica in rapporto con quella ebraica: Mosè è secondo lui il filosofo per eccellenza, e la dottrina che qui<br />
viene enunciata è infatti una dottrina formulata in termini tipici della filosofia greca; ma la conoscenza <strong>di</strong><br />
cui Mosè è portatore non è frutto della sua indagine, bensì dono ricevuto dagli oracoli <strong>di</strong>vini (la tra<strong>di</strong>zione<br />
giudaica identifica Mosè come profeta). La dottrina dei due principi qui abbozzata (principio intellettivo/attivo<br />
e principio materiale/passivo) è variamente rappresentata e articolata nella tra<strong>di</strong>zione platonica e<br />
stoica. Il lessico usato da <strong>Filone</strong> per in<strong>di</strong>care la causa attiva e quella passiva è stoico. L’argomento prepara<br />
le righe successive: il mondo sensibile è costituito <strong>di</strong> materia, essa però è <strong>di</strong> per sé un principio puramente<br />
passivo e ricettivo; perciò l’or<strong>di</strong>ne e la bellezza del cosmo si possono spiegare razionalmente solo<br />
riconoscendo, accanto alla causa passiva, una causa attiva, che deve essere una causa razionale e non una<br />
causalità <strong>di</strong> tipo meccanico.<br />
26
sorvegliante, arbitro o giu<strong>di</strong>ce, dal quale è legge che ogni cosa sia amministrata e governata<br />
11.<br />
[12] Il grande Mosè, però, avendo ritenuto che l’essere ingenerato è del tutto estraneo<br />
a ciò che è visibile — tutto ciò che è sensibile, infatti, si trova nella generazione<br />
e nella trasformazione e non è mai nel medesimo stato — attribuì, invece, all’invisibile<br />
e all’intelligibile l’eternità come realtà fraterna e congenere, mentre applicò al sensibile<br />
come nome appropriato “generazione”. Poiché, dunque, questo cosmo è visibile e sensibile,<br />
necessariamente dovrebbe essere anche generato; pertanto non a sproposito ne descrisse<br />
la generazione in termini assai nobilmente teologici 12.<br />
[Valore simbolico dei sei giorni della creazione]<br />
[13] Mosè <strong>di</strong>ce che il cosmo è stato prodotto in sei giorni, non perché il creatore<br />
avesse bisogno <strong>di</strong> estensioni <strong>di</strong> tempo — è verosimile, infatti, che Dio compia ogni cosa<br />
simultaneamente, non solo quando or<strong>di</strong>na le cose, ma anche quando le pensa — ma perché<br />
le realtà generate avevano bisogno <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne 13. E il numero è cosa propria<br />
dell’or<strong>di</strong>ne; fra i numeri, poi, per le leggi <strong>di</strong> natura, il più capace <strong>di</strong> generare è il 6: dei<br />
numeri che derivano dalla monade è il primo perfetto, uguale al prodotto dei propri fattori<br />
e alla loro somma, essendo la sua metà la triade, il terzo la <strong>di</strong>ade, il sesto la monade<br />
e, in una parola, è per natura maschio e femmina e nasce dall’armonia del prodotto <strong>di</strong><br />
entrambi. Infatti, tra gli esseri è maschio il <strong>di</strong>spari, mentre il pari è femmina; principio<br />
dei numeri <strong>di</strong>spari è dunque la triade, mentre la <strong>di</strong>ade lo è dei pari, e il prodotto <strong>di</strong> entrambi<br />
è l’esade.<br />
[14] Bisognava, infatti, che il cosmo, essendo la più perfetta delle realtà <strong>di</strong>venute,<br />
fosse compaginato secondo un numero perfetto, il sei, e che, <strong>di</strong>sponendosi ad avere<br />
in se stesso le generazioni derivate da un accoppiamento, ricevesse la propria impronta<br />
in riferimento ad un numero misto, il primo pari/<strong>di</strong>spari, in modo da includere in se<br />
stesso sia la forma del maschio che getta il seme, sia della femmina che riceve le geniture.<br />
[Il giorno “uno” è quello della creazione intelligibile]<br />
[15] A ciascuno dei giorni Mosè assegnò alcune porzioni del tutto, eccettuando il<br />
primo, ch’egli nemmeno chiama “primo”, affinché esso non sia numerato insieme agli<br />
11 Affermazione ricorrente nella riflessione degli autori antichi, anche pagani e cristiani, sul rapporto fra<br />
cosmologia e teologia: affermare che il mondo è ingenerato, significa per <strong>Filone</strong> sostenere ch’esso si è autogenerato,<br />
affermare cioè che la sua sussitenza è in<strong>di</strong>pendente dalla volontà e dall’azione dell’intelletto<br />
<strong>di</strong>vino; ma ciò che è al <strong>di</strong> fuori della sfera dell’intelletto <strong>di</strong>vino è necessariamente <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato, privo <strong>di</strong> orientamento<br />
e <strong>di</strong> razionalità. L’esito <strong>di</strong> questa dottrina è l’annientamento della dottrina della provvidenza,<br />
il cui esito inevitabile sul piano sociale è l’anarchia (per il nesso che lega or<strong>di</strong>ne cosmico e or<strong>di</strong>ne politico).<br />
12 <strong>Filone</strong> echeggia l’opposizione stabilita all’inizio del Timeo fra ciò che è sempre e mai <strong>di</strong>viene e ciò che<br />
sempre <strong>di</strong>viene e mai è. Solo se è possibile mostrare la <strong>di</strong>pendenza del cosmo sensibile da un atto creatore<br />
e or<strong>di</strong>natore da parte <strong>di</strong> un intelletto <strong>di</strong>vino eterno e stabile si può fondare un or<strong>di</strong>ne etico altrettanto stabile.<br />
13 Sul tema della simultaneità della creazione cf. Sir 18, 1 (W=?I3&% ?X HK%?0 =$I%7); Is 48, 13. Interpretazione<br />
allegorica dei sei giorni della creazione: il racconto mosaico non descrive una serie <strong>di</strong> giorni effettivamente<br />
succedutisi nel tempo, ma offre un insegnamento sotto forma <strong>di</strong> immagini. La <strong>di</strong>mensione propria<br />
dell’intelletto <strong>di</strong>vino è l’eterno, nel quale non si dà successione <strong>di</strong> tempo né estensione <strong>di</strong> spazio, ma<br />
assoluta coincidenza e unificazione. Il numero interviene come elemento <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne nella sfera della creazione<br />
molteplice, nella quale stabilisce relazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza e <strong>di</strong> successione. Il gusto per le interpretazioni<br />
in chiave aritmologica è proprio soprattutto della tra<strong>di</strong>zione pitagorica, che conosce in età imperiale<br />
una significatica ripresa nell’ambito del platonismo (p.e. Giamblico, Summa pythagorica).<br />
27
altri, chiamandolo invece “uno” lo designa con un nome esatto, cogliendo in esso la natura<br />
della monade e attribuendogliene la denominazione 14.<br />
Bisogna poi <strong>di</strong>re quante è possibile delle realtà comprese in esso, poiché <strong>di</strong>rle<br />
tutte è impossibile: esso include, infatti, in modo speciale il mondo intelligibile, come<br />
rivela il <strong>di</strong>scorso concernente questo giorno. [16] Poiché, infatti, Dio, in quanto Dio, conosceva<br />
in anticipo che una bella imitazione non potrebbe essere prodotta senza un bel<br />
modello e che nessuna delle cose sensibili sarebbe stata irreprensibile, se non avesse ricevuto<br />
la propria immagine in rapporto con un archetipo e una forma intelligibile, avendo<br />
voluto fabbricare questo cosmo visibile, plasmò prima quello invisibile, in modo da<br />
realizzare, usando un modello incorporeo e massimamente conforme al <strong>di</strong>vino, il cosmo<br />
corporeo, raffigurazione più giovane <strong>di</strong> un mondo più antico, che avrebbe contenuto in<br />
se stesso tanti generi sensibili, quanti sono i generi intelligibili nell’altro 15.<br />
[Il mondo intelligibile non è in un luogo]<br />
[17] Non è lecito <strong>di</strong>re o supporre che il cosmo costituito dalle idee sia in un luogo;<br />
dove esso sussista, lo sapremo seguendo un’immagine presa dalle realtà che sono<br />
presso <strong>di</strong> noi. Quando viene fondata una città, per la grande ambizione <strong>di</strong> un re o <strong>di</strong> un<br />
qualche governante che pretende un potere autocratico ed è insieme gran<strong>di</strong>oso nelle sue<br />
idee, volendo dare lustro alla propria buona fortuna, accade che si presenti un uomo che<br />
per l’educazione ricevuta è architetto e, dopo aver considerato la buona conformazione<br />
e collocazione del luogo, delinea per prima cosa in se stesso quasi tutte le parti della città<br />
che sta per essere fondata: templi, ginnasi, pritanei, piazze, porti, darsene, viuzze,<br />
l’apparato delle mura, fondamenta <strong>di</strong> case private e <strong>di</strong> altri e<strong>di</strong>fici pubblici.<br />
[18] In seguito, avendo accolto nella propria anima come su una tavoletta <strong>di</strong> cera<br />
le impronte <strong>di</strong> ciascuna cosa, porta in sé in immagine la città intelligibile. Rievocando<br />
per mezzo della memoria innata le immagini <strong>di</strong> essa e imprimendosi ancor più le sue<br />
impronte, come un bravo artigiano, volgendo lo sguardo al modello, comincia a costruire<br />
la città <strong>di</strong> pietra e legno, rendendo le realtà corporee simili a ciascuna delle idee incorporee<br />
16.<br />
14 Sia l’ebraico, sia il greco (LXX) hanno in <strong>Gen</strong> 1, 5 non un aggettivo or<strong>di</strong>nale («primo giorno»), ma un<br />
aggettivo car<strong>di</strong>nale (yom ehad, P9"10 9@0, <strong>di</strong>es unus, «giorno uno»). L’esegesi che ne dà <strong>Filone</strong> sarà poi<br />
ripresa nella successiva tra<strong>di</strong>zione alessandrina e sottolinea il carattere proprio <strong>di</strong> questo giorno, che non<br />
fa parte della serie cronologica dei giorni, ma allude a un atto creativo che precede la costituzione del cosmo<br />
materiale e si colloca in una sfera puramente intelligibile, nella quale non si dà ancora successione<br />
temporale né estensione nello spazio. Interessante l’osservazione circa la esattezza del nome, che in<strong>di</strong>vidua<br />
e designa in modo appropriato la natura propria della realtà denominata (cf. <strong>di</strong>scussioni intorno<br />
all’esegesi del Cratilo). Anche Rashi riconosce in questa incongruenza linguistica un rinvio all’unicità <strong>di</strong><br />
Dio nel proprio universo, infatti assegna la creazione degli angeli solo al secondo giorno.<br />
15 L’immagine del demiurgo che produce un mondo sensibile come imitazione <strong>di</strong> un modello ideale è presa<br />
dalla narrazione del Timeo platonico. La cosa nuova, che <strong>di</strong>venta tipica del platonismo <strong>di</strong> età imperiale,<br />
è l’affermazione che a sua volta il mondo ideale è stato prodotto dal demiurgo (dottrina del cosmo intelligibile<br />
come pensieri <strong>di</strong> Dio: cf. Armostrong). Il modello è bello e anche la sua imitazione visibile è bella:<br />
cf. Sap. 13, 3.<br />
16 <strong>Filone</strong> descrive l’attività del demiurgo attraverso la metafora della fondazione <strong>di</strong> una città (tema stoico<br />
del parallelismo fra il cosmo e una polis): c’è un re che vuole fondare una città per accrescere la propria<br />
gloria e c’è un architetto che si incarica <strong>di</strong> eseguire questo <strong>di</strong>segno progettando prima nella propria mente<br />
gli e<strong>di</strong>fici della città e poi curandone la realizzazione concreta in conformità con il progetto ch’egli ha<br />
tracciato in se stesso. In questa immagine si delinea lo schema che <strong>di</strong>venterà tra<strong>di</strong>zionale nel platonismo<br />
imperiale: il primo Dio è principio primo <strong>di</strong> tutte le cose, ma è assolutamente unitario e trascendente, intelletto<br />
demiurgico, e quin<strong>di</strong> caratterizzato da una prima forma <strong>di</strong> molteplicità, in quanto porta in se stesso<br />
il cosmo intelligibile, è il secondo <strong>di</strong>o. La metafora comunque non va forzata fino al punto da attribuire a<br />
<strong>Filone</strong> questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>teismo. La cosa decisiva è la dottrina dell’immanenza nella mente <strong>di</strong> Dio del cosmo<br />
noetico, che è l’oggetto <strong>di</strong> un primo atto creativo, quello propriamente descritto nel giorno uno. Il cosmo<br />
sensibile nasce da un secondo atto creativo, che è la traduzione all’esterno, l’oggettivazione sensibi-<br />
28
[La sede del mondo intelligibile è il logos <strong>di</strong>vino]<br />
[19] Qualcosa <strong>di</strong> simile bisogna ritenere anche a proposito <strong>di</strong> Dio, che cioè, dopo<br />
aver pensato <strong>di</strong> creare la grande città, concepì anzitutto in se stesso le impronte <strong>di</strong> essa,<br />
a partire dalle quali, dopo aver costituito il cosmo intelligibile, portava a compimento<br />
anche quello sensibile, usando l’altro come modello. [20] Come, dunque, la città le cui<br />
impronte erano delineate nella mente dell’architetto non occupava spazio all’esterno,<br />
ma era impressa nell’anima dell’artefice, allo stesso modo nemmeno il cosmo delle idee<br />
potrebbe avere altro luogo che il logos <strong>di</strong>vino, che ha <strong>di</strong>sposto in or<strong>di</strong>ne queste cose.<br />
Poiché quale altro potrebbe essere il luogo delle potenze <strong>di</strong> questo logos che fosse capace<br />
<strong>di</strong> accogliere e contenere non <strong>di</strong>co tutte, ma una sola qualsiasi <strong>di</strong> queste potenze in<br />
forma incontaminata? 17<br />
[La creazione è motivata dalla bontà <strong>di</strong> Dio]<br />
[21] Una potenza, però, è anche quella creatrice, che ha come sorgente il vero<br />
bene. Se, infatti, qualcuno volesse indagare la causa per la quale questo universo è stato<br />
fabbricato, mi sembra che non mancherebbe il proprio obiettivo affermando ciò che <strong>di</strong>sse<br />
anche qualcuno degli antichi, che cioè il padre e creatore è buono 18. Per la qual cosa<br />
egli non fu geloso della propria natura ottima nei confronti <strong>di</strong> una sostanza che non aveva<br />
<strong>di</strong> per se stessa alcuna bellezza, ma era in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare ogni cosa. [22] Essa era,<br />
infatti, <strong>di</strong> per se stessa <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata, priva <strong>di</strong> qualità, <strong>di</strong> anima, <strong>di</strong>ssimile, colma <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza,<br />
<strong>di</strong>sarmonia e <strong>di</strong>scordanza; ricevette, però, un cambiamento e una trasformazione<br />
in <strong>di</strong>rezione delle realtà opposte e migliori: or<strong>di</strong>ne, qualità, animazione, similitu<strong>di</strong>ne, identità,<br />
armonia, concordanza, tutto ciò che è proprio dell’idea migliore 19.<br />
[Dio dona quanto la creatura può ricevere]<br />
[23] Senza valersi del conforto <strong>di</strong> alcuno — chi altri v’era infatti? — ma solo <strong>di</strong><br />
se stesso, Dio conobbe che bisognava beneficare con pro<strong>di</strong>ghi e ricchi doni quella natura<br />
che, senza il dono <strong>di</strong>vino, non era capace <strong>di</strong> per se stessa <strong>di</strong> conseguire alcun bene.<br />
Egli, però, la benefica non in rapporto con la grandezza dei propri doni, questi sono in-<br />
le, degli oggetti intelligibili pensati come archetipi. Il fondamento scritturistico <strong>di</strong> questa dottrina della<br />
doppia creazione, lo si vedrà chiaramente in <strong>Origene</strong>, è la duplice menzione della creazione <strong>di</strong> cielo e terra<br />
e nel primo giorno e nei giorni successivi della cosmogonia mosaica.<br />
17 Diversamente dal Timeo platonico, <strong>Filone</strong> colloca esplicitamente il mondo delle forme nella mente <strong>di</strong><br />
Dio, cioè nel suo logos; parlare <strong>di</strong> collocazione ha un valore puramente metaforico, perché non si tratta <strong>di</strong><br />
una realtà spaziale. Le idee non sono propriamente principi, come lo sono nella narrazione timaica, perché<br />
sono a loro volta risultato <strong>di</strong> un atto creativo da parte <strong>di</strong> Dio. Resta problematico il rapporto che <strong>Filone</strong><br />
istituisce fra Dio e il Logos. La speculazione sul Logos come interme<strong>di</strong>ario della creazione ha due origini<br />
che si intrecciano: una è la tra<strong>di</strong>zione giudaica che assegna alla sapienza o alla legge questa funzione,<br />
l’altra è l’enfatizzazione del tema della parola creatrice <strong>di</strong> Dio, che si incontra p.e. in Sal 32, 6. 9; 148, 5;<br />
Sir 42, 15; Gdt 15, 14; Sap 9, 1; Eb 1, 1-3; 11, 3. Nella riflessione sul Logos come luogo delle idee è già<br />
compiuto il passaggio da parola pronunciata a ragione.<br />
18 Plat. Tim. 29 E. Nella speculazione rabbinica il tema della bontà e potenza <strong>di</strong> Dio è sviluppato in relazione<br />
ai suoi <strong>di</strong>versi nomi: Elohim = legge, JHWH = bontà; cf. A.F. Segal, Philo and the Rabbis on the<br />
Names of God, «Journal for the Study of Judaism», 9 (1978), pp. 1-28. Cf. Phil. Alex. Cher. 27 «Dio è<br />
uno, ma i suoi attributi supremi e primi sono due: bontà e potenza. Me<strong>di</strong>ante la sua bontò egli fa nascere<br />
ogni cosa, me<strong>di</strong>ante la sua potenza egli è il sovrano <strong>di</strong> tutto ciò che ha fatto nascere».<br />
19 La materia è caratterizzata da pre<strong>di</strong>cati negativi, non ha alcuna proprietà in sé, ma è pura recettività,<br />
passività. Il § 22 aggiunge però una serie <strong>di</strong> elementi che caratterizzano la materia come un principio avverso<br />
all’intelligibile, secondo lo schema dell’opposizione fra le due anime <strong>di</strong> Plat. Leg. X, che fonda le<br />
dottrine dualistiche dei principi (p.e. Plutarco, Attico, Numenio). <strong>Filone</strong> non <strong>di</strong>ce esplicitamente che Dio<br />
ha creato ex nihilo e quin<strong>di</strong> non attribuisce <strong>di</strong>rettamente a Dio la creazione anche del principio materiale<br />
passivo, ne parla come se esso fosse una realtà in<strong>di</strong>pendente e opposta al principio <strong>di</strong>vino informatore e<br />
or<strong>di</strong>natore.<br />
29
fatti incircoscrivibili e infiniti, ma in rapporto con le potenze delle realtà che ricevono il<br />
beneficio. Giacché non come per natura Dio è atto a fare il bene, altrettanto lo è ciò che<br />
<strong>di</strong>viene a ricevere il bene, dal momento che le potenze del primo sono eccedenti, mentre<br />
il secondo, essendo troppo debole per poter accogliere la loro grandezza, verrebbe meno,<br />
se Dio non avesse misurato, soppesando in modo adeguato, ciò che spetta a ciascuna<br />
cosa 20.<br />
[Identità fra mondo intelligibile e logos <strong>di</strong>vino]<br />
[24] Se si volessero usare termini abbastanza espliciti, si potrebbe <strong>di</strong>re che<br />
null’altro è il cosmo intelligibile, se non il logos <strong>di</strong> Dio già impegnato nell’atto della<br />
creazione del cosmo; la città intelligibile, infatti, non è altro che l’atto <strong>di</strong> pensiero<br />
dell’architetto che sta ragionando <strong>di</strong> creare la città 21. [25] Questa dottrina è <strong>di</strong> Mosè, non<br />
mia; perlomeno, descrivendo in seguito la generazione dell’uomo, Mosè riconosce esplicitamente<br />
che l’uomo ricevette la propria impronta secondo l’immagine <strong>di</strong> Dio. Se la<br />
parte è immagine <strong>di</strong> un’immagine [è chiaro che] anche l’intero è un’immagine; tutto intero<br />
questo cosmo sensibile, se è più grande dell’immagine costituita dall’uomo, è imitazione<br />
dell’immagine <strong>di</strong>vina, ma è chiaro allora che l’impronta archetipa che <strong>di</strong>ciamo<br />
essere il mondo intelligibile è proprio [il modello, l’idea archetipa delle idee, cioè] il logos<br />
<strong>di</strong> Dio 22.<br />
[«In principio»]<br />
[26] Dice Mosè che «in principio Dio creò il cielo e la terra» (<strong>Gen</strong> 1, 1), intendendo<br />
come “principio” non, come pensano alcuni, quello nel tempo; il tempo, infatti,<br />
non esisteva prima del cosmo, ma o si è prodotto con esso o dopo <strong>di</strong> esso. Poiché, infatti,<br />
il tempo è intervallo del movimento del cosmo, il movimento non potrebbe prodursi<br />
prima della cosa che si muove, ma è necessario che esso venga a sussistere o insieme o<br />
dopo <strong>di</strong> quella. Osare affermare ch’esso è precedente non è cosa degna <strong>di</strong> un filosofo 23.<br />
[27] Ora, se con il termine “principio” non è inteso quello <strong>di</strong> adesso, conforme al tempo,<br />
sarebbe ragionevole che fosse in<strong>di</strong>cato quello conforme al numero, in modo tale che<br />
l’espressione «in principio creò», sia uguale all’espressione «per prima cosa creò il cielo»<br />
24. Ed è in realtà ragionevole ch’esso sia giunto per primo alla generazione, essendo<br />
20 Formulazione esplicita del principio secondo il quale quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur.<br />
Dio eccede infinitamente la capacità delle creature <strong>di</strong> accoglierne il dono, e perciò compie un atto <strong>di</strong><br />
autoriduzione e limitazione nel comunicarsi alle creature.<br />
21 Si può dedurre che vi sia un Logos <strong>di</strong> Dio anteriore logicamente all’atto creatore e perfettamente semplice<br />
e un Logos che è invece attivo nel creare. La <strong>di</strong>stinzione è puramente logica, non cronologica: dal<br />
momento che la creazione intelligible avviene nell’eterno, non si dà mai un momento nel quale Dio, cioè<br />
il suo Logos, non si creatore e non produca la molteplicità delle forme, dei suoi pensieri, che inabitano in<br />
lui e si identificano anzi con lui. La città intelligibile non è un oggetto del pensiero dell’architetto, ma è il<br />
pensiero dell’architetto nell’atto del suo progettare la città. Questa dottrina è una trasposizione in termini<br />
platonici della dottrina giudaica della sapienza/legge me<strong>di</strong>atrice della creazione (Prov 8, 22). In Conf.<br />
146-147 <strong>Filone</strong> identifica il Logos e Israele: «Il Logos primogenito è il più antico degli angeli; è arcangelo<br />
e ha vari nomi, egli è in effetti chiamato Principe, Nome <strong>di</strong> Dio, Verbo, Uomo a immagine, Veggente,<br />
Israele» (cf. la ripresa <strong>di</strong> questi temi in Iust. Dial. 75, 2; 135, 1-6).<br />
22 Se Mosè <strong>di</strong>ce che l’uomo è stato fatto kat’eikona, cioè secondo, in conformità con l’immagine <strong>di</strong> Dio,<br />
se ne può dedurre che anche l’intero del quale l’uomo è una parte, cioè il cosmo sensibile, sia conforme<br />
all’immagine <strong>di</strong> Dio, sia cioè immagine <strong>di</strong> un’immagine. L’immagine della quale il cosmo sensibile è a<br />
sua volta immagine è il cosmo intelligibile, cioè il logos <strong>di</strong>vino creatore. Dunque Mosè insegna l’identità<br />
tra il modello intelligibile e il Logos <strong>di</strong>vino.<br />
23 La definizione del tempo come misura del movimento è aristotelica. Cf. quanto <strong>di</strong>ce Plutarco [o Attico]<br />
a proposito <strong>di</strong> un tempo anteriore al tempo del cosmo.<br />
24 La <strong>di</strong>stinzione dei <strong>di</strong>versi sensi <strong>di</strong> un termine, per in<strong>di</strong>viduare il significato preciso ch’esso riveste in un<br />
passo, fa parte delle procedure tipiche <strong>di</strong> commento; cf. l’ampio sviluppo che ha la <strong>di</strong>scussione intorno al<br />
significato proprio della parola arché in Orig. CIoh I qui sotto.<br />
30
la migliore delle cose <strong>di</strong>venute e costituito a partire dalla parte più pura della sostanza,<br />
perché doveva essere la <strong>di</strong>mora sacratissima degli dèi visibili e sensibili 25.<br />
[L’or<strong>di</strong>ne della creazione intelligibile]<br />
[28] Infatti, anche se il creatore creava tutte le cose simultaneamente, le realtà<br />
che venivano in modo bello all’essere avevano non<strong>di</strong>meno un or<strong>di</strong>ne: giacché non vi è<br />
alcuna bellezza nel <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne. L’or<strong>di</strong>ne, poi, è successione e concatenazione <strong>di</strong> realtà<br />
che precedono e che seguono, se non nella realizzazione, quanto meno nella concezione<br />
da parte degli artefici; in questo modo, infatti, avrebbero potuto essere compiute in modo<br />
preciso e restare salde e senza confusione reciproca 26. [29] Per prima cosa, dunque, il<br />
creatore creò il cielo incorporeo, la terra invisibile e l’idea dell’aria e del vuoto; delle<br />
quali chiamò la prima “tenebra”, perché per sua natura l’aria è nera, e l’altra “abisso”, il<br />
vuoto infatti è molto profondo e spalancato 27. In seguito creò l’essenza incorporea<br />
dell’acqua e del pneuma e, dopo tutte queste cose, come settima l’essenza della luce,<br />
che a sua volta era il modello incorporeo e intelligibile del sole e <strong>di</strong> tutti quanti gli astri<br />
portatori <strong>di</strong> luce che Dio si accingeva a costituire nel cielo 28.<br />
[Pneuma e luce]<br />
[30] Mosè considerò il pneuma e la luce degni <strong>di</strong> una posizione privilegiata:<br />
l’uno, infatti, lo chiamò «pneuma <strong>di</strong> Dio», perché il pneuma è la realtà più vivificante e<br />
della vita è causa Dio; la luce, invece, <strong>di</strong>ce Mosè che era bella in modo eminente (<strong>Gen</strong><br />
1, 4) 29. Infatti l’intelligibile è tanto più luminoso e splendente del visibile, quanto a mio<br />
avviso lo è il sole della tenebra e il giorno della notte, e quanto l’intelletto, che è la guida<br />
dell’anima tutta intera, lo è degli occhi del corpo. [31] Quella luce invisibile e intelligibile,<br />
inoltre, è venuta all’essere come immagine del logos <strong>di</strong>vino che ce ne ha spiegato<br />
la generazione; è un astro che sta al <strong>di</strong> sopra del cielo, sorgente degli astri sensibili, e<br />
non andrebbe fuori strada chi la chiamasse “splendore totale”, dal quale il sole, la luna e<br />
gli altri astri mobili e fissi attingono, secondo la potenza propria a ciascuno, la ra<strong>di</strong>osità<br />
che loro conviene, mentre quel raggio incontaminato e puro si offusca una volta che abbia<br />
incominciato a volgersi al passaggio dall’intelligibile al sensibile; nessuna delle realtà<br />
sensibili è infatti pura 30.<br />
[32] È ben detto anche che «tenebra era al <strong>di</strong> sopra dell’abisso» (<strong>Gen</strong> 1, 2): in un<br />
certo senso, infatti, l’aria è al <strong>di</strong> sopra del vuoto, dal momento che, salendo, ha riempito<br />
25 La designazione degli astri come “dèi visibili” viene dal Timeo.<br />
26 Viene confermato quanto già esposto a proposito dei sei giorni della creazione: la successione <strong>di</strong> giorni<br />
nella narrazione mosaica non in<strong>di</strong>ca una reale successione cronologica, che sarebbe impossibile, perché il<br />
tempo si dà insieme o dopo la creazione del cosmo e non prima <strong>di</strong> essa, ma una gerarchia <strong>di</strong> valore, per la<br />
quale ciò che precede ha valore superiore ed è fondamento per ciò che segue.<br />
27 Come si vede, nell’interpretazione filoniana il termine greco U/E33$< ha ormai perduto ogni relazione<br />
con le masse acquatiche designate dall’ebraico tehom e designa semplicemente uno spazio vuoto indeterminato.<br />
28 <strong>Filone</strong> in<strong>di</strong>ca qui le opere del giorno uno, intendendole come una serie <strong>di</strong> principi intelligibili dai quali<br />
deriva poi la realtà sensibile: il cielo incorporeo (perché quello corporeo viene descritto solo nel secondo<br />
giorno), la terra invisibile (il testo della LXX <strong>di</strong>ce infatti che la terra era aóratos, cioè invisibile e questo è<br />
un attributo tipico delle realtà intelligibili e incorporee), la tenebra (interpretata come il principio dell’aér,<br />
aria), l’abisso (cioè il vuoto), pneuma, acqua (la seconda menzione dell’abisso?) e luce.<br />
29 Cf. passo <strong>di</strong> Plat. Resp. VI 517 BC citato sopra a p. [].<br />
30 Il pneuma è l’elemento vivificante e, siccome la vita viene da Dio, il pneuma è un elemento <strong>di</strong>vino, infatti<br />
Mosè lo chiama «pneuma <strong>di</strong> Dio». <strong>Filone</strong> rilegge una nozione che nel pensiero stoico, ma anche platonico<br />
e aristotelico, appartiene alla sfera fisica e la interpreta in modo da rendere conto della sua collocazione<br />
nel giorno uno. Lo stesso per la luce: quella creata nel giorno uno non è la luce cosmica emessa dai<br />
corpi celesti, creati nel quarto giorno, ma una luce intelligibile, che è principio <strong>di</strong> quella cosmica ed è rivolta<br />
non agli occhi corporei, ma all’intelletto delle creature, per introdurle alla conoscenza del Logos <strong>di</strong>vino.<br />
31
<strong>di</strong> sé tutto lo spalancato, deserto e vuoto spazio che si estende verso <strong>di</strong> noi a partire dalle<br />
regioni della luna 31.<br />
[Separazione fra luce e tenebra intelligibili]<br />
[33] Dopo l’accensione della luce intelligibile, che è venuta all’essere prima del<br />
sole, la tenebra, che è il suo opposto, si ritirava, dal momento che Dio mise un muro fra<br />
<strong>di</strong> loro e le separava, ben conoscendo la loro contrarietà e la guerra che per natura si<br />
fanno. Perché dunque non contendessero fra loro, venendo sempre a contatto l’una con<br />
l’altra, e la guerra non avesse il predominio invece della pace, mettendo il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne<br />
nell’or<strong>di</strong>ne del cosmo, Dio non soltanto separò la luce dalla tenebra, ma pose anche dei<br />
limiti negli intervalli interme<strong>di</strong>, con i quali tenne lontano ciascuno dei due estremi. Restando<br />
vicini, infatti, avrebbero provocato una confusione con la loro lotta per la supremazia,<br />
attaccandosi reciprocamente per il loro grande e incessante amore per la contesa,<br />
se dei limiti costituiti nel mezzo non li avessero <strong>di</strong>sgiunti e non avessero risolto<br />
l’opposizione.<br />
[34] Questi limiti sono la sera e il mattino, dei quali l’uno, allontanando un po’<br />
alla volta la tenebra, preannuncia nella gioia che il sole sta per sorgere, mentre la sera<br />
sopraggiunge al tramontare del sole e accoglie mitemente il carico compatto della tenebra.<br />
Anche queste cose, intendo il mattino e la sera, bisogna collocare nell’or<strong>di</strong>ne delle<br />
realtà incorporee e intelligibili: non vi è assolutamente nulla <strong>di</strong> sensibile in esse, ma sono<br />
tutte idee, misure, impronte e sigilli, realtà incorporee per la generazione <strong>di</strong> altre realtà<br />
corporee 32. [35] Dopo che fu generata la luce e la tenebra in<strong>di</strong>etreggiò e si ritirò e<br />
vennero costituiti negli spazi interme<strong>di</strong> come limiti la sera e il mattino, subito si compì,<br />
secondo necessità la misura del tempo, che il creatore chiamò “giorno”, e non “primo<br />
giorno”, bensì “uno”, che è stato detto così a causa dell’unicità del cosmo intelligibile,<br />
che ha natura mona<strong>di</strong>ca 33.<br />
[...]<br />
31 L’aria è, nella fisica aristotelica, uno dei quattro elementi che compongono la sfera sublunare, quella<br />
entro la quale avvengono i fenomenti <strong>di</strong> generazione e corruzione. I cieli sono costituiti per Aristotele <strong>di</strong><br />
un’altra sostanza, l’etere, che è incorruttibile, oppure sono, nella fisica platonica, corpi interamente ignei.<br />
32 L’espressione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 5 pone un problema circa il modo in cui l’autore del testo conta i giorni: dal<br />
mattino al mattino o dalla sera alla sera (come avviene nella tra<strong>di</strong>zione giudaica)? Se il mattino al quale<br />
qui si fa riferimento è quello del secondo giorno, l’autore del testo considera un giorno come il tempo<br />
compreso fra due albe? Cf. H.R. Stroess, Does the Day Begin in the Evening or Morning?, «Vetus Testamentum»,<br />
16 (1966), pp. 460-481. <strong>Filone</strong> risolve il problema includendo la creazione del giorno e dei<br />
suoi limiti (sera e mattino) fra le opere intelligibili del giorno uno, che non ha durata temporale. Il problema<br />
si poneva in termini <strong>di</strong>versi per quegli autori, come gli esegeti <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione antiochena e <strong>Basilio</strong>,<br />
che privilegiavano una interpretazione letterale anche <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-5. Un altro aspetto <strong>di</strong>scusso dagli<br />
esegeti antichi è quello della durata dei giorni della creazione: alcuni (tra<strong>di</strong>zione antiochena, Crisostomo,<br />
ma anche Iub. 2) li considerano giorni or<strong>di</strong>nari; sulla base <strong>di</strong> Sal 89, 4 e Apc 20, si sviluppò anche una<br />
robusta tra<strong>di</strong>zione millenarista, che considerava i giorni della creazione come perio<strong>di</strong> millenari, ai quali<br />
corrispondevano altrettanti perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> mille anni nella storia attuale dell’umanità in attesa dell’ottavo (p.e.<br />
2 Hen 33, 1-2) o del settimo (ps- Barn. XV 4-5); cf. Clem. Alex. Strom. IV 25, 159; Ir. Adv. haer. V 28,<br />
3: «Tanti giorni ha richiesto la creazione del mondo, tanti millenni comporterà la sua durata totale». Sulla<br />
questione dei giorni cf. ancora Thom. STh. I, q. 74. art. 2.<br />
33 L’ambito delle realtà create e molteplici è quello della determinazione: le cose sono e hanno stabilità<br />
nell’essere solo nella misura in cui hanno determinazione reciproca e possiedono quin<strong>di</strong> limiti che determinano<br />
con precisione ciò che una cosa è e ciò che una cosa non è. Questa tesi è esposta, secondo <strong>Filone</strong>,<br />
nella desrizione mosaica della separazione della luce dalle tenebre e nella determinazione del mattino e<br />
della sera come limiti delle due realtà opposte. Il giorno uno ha natura mona<strong>di</strong>ca nel senso che, non essendo<br />
or<strong>di</strong>nato in una successione, non è inserito in una relazione ad altro, ma è interamente autosufficiente<br />
ed ha una natura corrispondente all’unicità e autosufficienza del Dio creatore. Cf. Clem. Alex.<br />
Strom. V 14, 93, 5-94, 2.<br />
32
Esegesi <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2 fra gli autori cristiani fino a <strong>Origene</strong> 1<br />
<strong>Gen</strong> 1 ha un posto rilevante nella liturgia cristiana fin da epoca piuttosto antica: i<br />
cristiani adottano il ritmo settimanale e lo spostamento dal sabato alla domenica fa emergere,<br />
accanto al tema della risurrezione <strong>di</strong> Cristo, anche quello della nuova creazione<br />
(cf. Iust. I Apol. 67, 7); il simbolo esor<strong>di</strong>sce con la dottrina <strong>di</strong> Dio creatore (cf. il Niceno-costantinopolitano:<br />
!"#$%&' "()*'"+ ,*- ./0, 1)*%2' %3 ,*- 4")5%6'); la lettura<br />
dei primi capitoli <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> accompagna la veglia pasquale.<br />
Fra II e III sec. sono stati scritti <strong>di</strong>versi commentari al racconto della creazione,<br />
ma non sono pervenuti. Anche le opere <strong>di</strong> Ippolito e <strong>Origene</strong> specificamente de<strong>di</strong>cate alla<br />
<strong>Gen</strong> sono perdute. Tuttavia è possibile raccogliere da citazioni e allusioni materiale<br />
sufficiente per ricostruire la lettura che nei primi tre secoli <strong>di</strong> storia cristiana sono state<br />
fatte <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1.<br />
· Come si è già visto in <strong>Filone</strong>, il racconto della creazione offre agli scrittori cristiani<br />
gli elementi per la costituzione <strong>di</strong> una fisica biblica. Un primo tema d’interesse è<br />
costituito dalla <strong>di</strong>scussione se la creazione debba intendersi come opera <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento<br />
<strong>di</strong> una materia informe preesistente (in questa <strong>di</strong>rezione vanno la LXX, che qualifica la<br />
terra come 47)*%"0 [Tim. 51 A] e Sap 11, 17) o come produzione dal nulla anche della<br />
materia <strong>di</strong> cui il mondo sensibile è costituito.<br />
· Un altro tema è costituito dal rapporto fra Padre e Logos nella creazione: alla<br />
luce della teologia me<strong>di</strong>oplatonica, che <strong>di</strong>stingue un primo <strong>di</strong>o assolutamente trascendente<br />
e un secondo <strong>di</strong>o demiurgico, anche gli autori cristiani vedono nell’espressione<br />
«in principio» un’allusione alla me<strong>di</strong>azione del Logos: il Padre crea «nel principio», ciò<br />
me<strong>di</strong>ante il Logos, attraverso <strong>di</strong> lui, gli enti finiti. Questa lettura suppone l’uso <strong>di</strong> Prov<br />
8, 22, la cui interpretazione cristologica è antica: Col 1, 15-16; Apoc 3, 14.<br />
· Tipicamente cristiana è l’interpretazione in prospettiva trinitaria: dell’«in principio»<br />
come riferito al Verbo; delle acque primor<strong>di</strong>ali, sulle quali planava lo Spirito come<br />
prefigurazione delle acque battesimali santificate dallo Spirito santo (cf. ancora oggi<br />
la preghiera <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione dell’acqua battesimale nella liturgia cattolica: «fin dalle origini<br />
il tuo Spirito si librava sulle acque..»); del plurale «facciamo» in 1, 26 come espressione,<br />
accanto agli altri elementi qui menzionati, della dottrina trinitaria.<br />
Giustino cita <strong>Gen</strong> 1, 1-3, combinato con Sap 11, 17, per <strong>di</strong>mostrare la <strong>di</strong>pendenza<br />
dei poeti greci e <strong>di</strong> Platone dalla rivelazione mosaica, che è loro anteriore, per quanto<br />
concerne la creazione a partire da una materia caotica originaria: 1 Apol. 59, 1-5; 10, 2.<br />
È verosimile che Giustino non si ponesse il problema del carattere increato <strong>di</strong> questa<br />
materia originaria e non percepisse l’idea <strong>di</strong> una creazione ex nihilo come un contenuto<br />
essenziale della fede biblica nel Dio creatore.<br />
Questo tema dell’anteriorità <strong>di</strong> Mosè rispetto ai sapienti, ai poeti e ai filosofi<br />
greci era già proprio dell’apologetica giudaica alessandrina: cf. Aristobulo (II a.C.)<br />
menzionato da Clem. Alex. Strom. V 15, 97, 7; I 15, 72, 4; 22, 150, 1.<br />
1 Apol. 60 legge <strong>Gen</strong> 1, 2c come riferito allo Spirito santo; la dottrina platonica<br />
dei tre re (Ep. II 312 E) e quella del Logos <strong>di</strong>sposto in forma <strong>di</strong> una X al <strong>di</strong> sopra del cosmo<br />
(Tim. 36 B) sarebbero state derivate da Platone dalla conoscenza della dottrina mosaica<br />
<strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 2 e Num 21, 8.<br />
1 Cf. NAUTIN, PIERRE, <strong>Gen</strong>èse 1, 1-2, de Justin à Origène, in In Principio. Interprétations des premiers<br />
versets de la <strong>Gen</strong>èse, Paris, Études augustiniennes, 1973, pp. 61-94 (Centre d’Études des religions du<br />
Livre).<br />
1
La questione dell’originarietà della materia <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata è ripresa da Ermogene,<br />
vissuto probabilmente in Asia Minore o Siria intorno al 170. Per rispondere alla questione<br />
dell’origine del male senza doverne attribuire a Dio la responsabilità, egli riconosce<br />
nella materia primor<strong>di</strong>ale il principio del male e del <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne nel mondo (Tert. Adv.<br />
Herm. II 4; XV 4). Le tesi principale <strong>di</strong> Ermogene sono oggi note attraverso le opere polemiche<br />
che gli hanno de<strong>di</strong>cato Tertulliano (che <strong>di</strong>pende da Teofilo) e Giosippo. La materia<br />
non è in sé malvagia, ma è <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata; l’opera della creazione ha messo or<strong>di</strong>ne e<br />
bellezza in una sua parte, ma la parte che è rimasta <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata è all’origine dei <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni<br />
nella natura e nell’or<strong>di</strong>ne etico. L’argomento scritturistico per questa dottrina era per<br />
Ermogene <strong>Gen</strong> 1, 2: terra autem erat invisibilis et incomposita (e l’imperfeto usato dalla<br />
Scrittura in<strong>di</strong>cava la durata indeterminata <strong>di</strong> questo stato originario: Tert. Adv. Herm.<br />
XXV 2; XXVII 1).<br />
Tertulliano obiettava che in <strong>Gen</strong> 1, 1 Dio crea la terra, com’è possibile che nel<br />
verso successivo la terra sia intesa come materia <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata preesistente? La risposta <strong>di</strong><br />
Ermogene era pertinente: la terra menzionata in <strong>Gen</strong> 1, 1 è in realtà prodotta a partire da<br />
uno stato anteriore, che è quello descritto in 1, 2. Altra obiezione all’esegesi <strong>di</strong> Ermogene<br />
era che i due aggettivi “invisibile e <strong>di</strong>sorganizzata” non alludono al carattere <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato<br />
della materia prima originaria, ma al fatto che la terra appena creata era ancora ricoperta<br />
dall’acqua, dunque invisibile, e priva <strong>di</strong> ornamento e vegetazione, dunque <strong>di</strong>sorganizzata<br />
(questa posizione si trova anche in Teofilo e sarà più tar<strong>di</strong> fatta propria da<br />
<strong>Basilio</strong>).<br />
La lotta contro la dottrina della materia preesistente all’opera della creazione è<br />
ampiamente presente nell’apologia <strong>di</strong> Teofilo <strong>di</strong> Antiochia Ad Autolycum (II 4), scritta<br />
probabilmente dopo il perduto trattato contro l’eresia <strong>di</strong> Ermogene che fu fonte <strong>di</strong> Tertulliano.<br />
Teofilo rimprovera a Ermogene <strong>di</strong> rendere la materia coeterna a Dio e <strong>di</strong> fare<br />
dell’azione <strong>di</strong> Dio un’attività parallela a quella degli uomini, che possono agire solo su<br />
una materia ch’essi non producono da sé. Il commento all’opera dei sei giorni si colloca<br />
in Teofilo nell’ambito <strong>di</strong> una critica complessiva alla concezione greca degli dèi, svolta<br />
all’inizio del libro II dell’Ad Autol. La fonte della polemica <strong>di</strong> Teofilo e dei passi <strong>di</strong> autori<br />
greci ch’egli cita è probabilmente un’apologia giudaica anteriore. Quello <strong>di</strong> Teofilo<br />
è il più antico commento cristiano continuo all’esamerone che ci sia pervenuto (Ad Autol.<br />
II 10-32).<br />
Ad Autol. II 10: affermazione decisa della creazione dal nulla da parte <strong>di</strong> Dio, il<br />
solo ingenerato, che ha fatto il mondo per accogliere in esso l’uomo. La presa <strong>di</strong> posizione<br />
ha <strong>di</strong> mira tesi contrarie, come quella <strong>di</strong> Ermogene.<br />
Appoggiandosi a Prov 8, 22, Teofilo vede nell’ arché citata in <strong>Gen</strong> 1, 1 il Figlio,<br />
cioè la Sapienza del Padre, che è da sempre presente nel Padre, nelle sue viscere (cf. Sal<br />
109: ex utero ante luciferum genui te) e, una volta proferita, è stata me<strong>di</strong>atrice<br />
dell’opera della creazione. Accanto all’interpretazione <strong>di</strong> arché come principio/inizio,<br />
Teofilo adotta anche l’interpretazione, sulla base del significato che la parola ha in greco,<br />
<strong>di</strong> “comando, principato”. Interessante anche l’identificazione tra Figlio e Spirito<br />
fatta da Teofilo in questo testo.<br />
Teofilo sottolinea che in <strong>Gen</strong> 1, 1 la menzione <strong>di</strong> Dio viene solo in terza posizione,<br />
dopo che Mosè ha detto che «nel principio fece»; la cosa non è casuale: secondo<br />
lui, serve a indurre rispetto e prudenza nel nominare Dio (e questa è un’in<strong>di</strong>cazione che<br />
rinvia al decalogo, dunque alla tra<strong>di</strong>zione giudaica) e a manifestare il fatto che Dio si<br />
conosce nelle opere che ha compiuto per mezzo del Figlio (il principio).<br />
2
Nella lettura <strong>di</strong> Teofilo, <strong>Gen</strong> 1, 2 non descrive uno stato anteriore, ma posteriore<br />
alla creazione della terra descritta in 1, 1; perciò ritiene <strong>di</strong> poter respingere la dottrina <strong>di</strong><br />
Ermogene circa l’originarietà della materia <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata: Dio prima crea la terra e il cielo,<br />
poi si <strong>di</strong>ce che la terra creata da Dio era invisibile e <strong>di</strong>sorganizzata (così si esprime Tert.<br />
Adv. Herm. XXVI 1, che <strong>di</strong>pende dal perduto trattato <strong>di</strong> Teofilo). La ragione per la quale<br />
la terra appena creata è invisibile non è che si tratta <strong>di</strong> una materia prima priva <strong>di</strong> qualità,<br />
ma semplicemente del fatto ch’essa è ancora coperta dalle acque (Ad Autol. II 13).<br />
Teofilo precisa che la materia va intesa come una realtà gheneté nel senso che è stata<br />
fatta da Dio e non, comeprobabilmente interpretava l’aggettivo Ermogene, nel senso<br />
ch’essa è in perpetuo <strong>di</strong>venire; <strong>di</strong>fficilmente, infatti, il cristiano Ermogene avrebbe potuto<br />
dare alla materia l’attributo aghénetos, che ne avrebbe davvero fatto una realtà alla<br />
pari <strong>di</strong> Dio.<br />
In II 11 Teofilo prosegue l’esame del racconto della creazione fino a <strong>Gen</strong> 2, 3;<br />
nel § 12 afferma che nessuno può dare una spiegazione conveniente del racconto della<br />
creazione, men che meno gli scrittori greci, che pure vi si sono ispirati. Nei §§ 13-17<br />
viene ingaggiata una polemica esplicita contro Esiodo e ripreso il commento<br />
all’esamerone.<br />
Il § 13 fa osservazioni interessanti sullo spirito che, come anima del mondo, penetra<br />
anzitutto l’elemento sottile della creazione, cioè l’acqua, e la vivifica e attraverso<br />
l’acqua che ricopre la terra e ne impregna le profon<strong>di</strong>tà, tutta la creazione è fecondata e<br />
vivificata. Lo spirito inoltre si interpone tra il cielo e la massa delle acque che ricoprono<br />
la terra, per impe<strong>di</strong>re che la tenebra dell’abisso acquatico si approssimi al cielo <strong>di</strong> Dio,<br />
poi questa funzione <strong>di</strong> filtro sarà presa dalla luce. Questo spirito vivificante assolve alla<br />
medesima funzione del pneuma stoico e non è da Teofilo identificato con la realtà <strong>di</strong><br />
Dio (II 4), <strong>di</strong>versamente da quanto accadeva con Giustino, che non aveva <strong>di</strong>fficoltà a riconoscere<br />
nello spirito librantesi sulle acque lo Spirito santo. Un’osservazione interessante<br />
anche sulla creazione della luce prima dei luminari: è la parola pronunciata da Dio<br />
a illuminare il buio della materia, con allusione al prologo <strong>di</strong> Giovanni.<br />
Teofilo introduce ancora in questo paragrafo, a proposito del fatto che Dio<br />
«chiamò la luce “giorno” e le tenebre “notte”», un tema che avrà grande fortuna nella<br />
<strong>di</strong>scussione degli esegeti cristiani in relazione al rapporto fra nomi e cose (esegesi del<br />
Cratilo): «Non è l’uomo che avrebbe potuto denominare la luce “giorno” o l’oscurità<br />
“notte”, e nemmeno le altre creature, se non avesse ricevuto questa denominazione da<br />
Dio che le aveva create».<br />
In sintesi, il contributo <strong>di</strong> Teofilo alla comprensione dell’esamerone si può riassumere<br />
in tre tesi che avranno grande influenza sugli autori successivi fino al IV sec.:<br />
- la creazione non consiste nell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> una materia preesistente, ma nella<br />
produzione dal nulla <strong>di</strong> tutte le cose;<br />
- il principio nel quale Dio crea è la sapienza <strong>di</strong> Prov 8, 22, cioè il Figlio;<br />
- lo spirito che aleggia sulle acque non è lo Spirito santo;<br />
- la spiegazione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-2 è orientata in senso letteralista, il che può spiegare<br />
come mai in seguito Clemente e <strong>Origene</strong> incontreranno fiera resistenza in certi ambienti<br />
contro la loro interpretazione allegorica <strong>di</strong> quei testi.<br />
Clemente <strong>di</strong> Alessandria offre negli Stromata vari elementi dell’interpretazione<br />
<strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-3:<br />
- per quanto concerne il problema della materia preesistente, afferma che questa<br />
dottrina è stata tratta da Platone da <strong>Gen</strong> 1, 1-2 (Strom. V 13, 90, 1); è una posizione alla<br />
quale Clemente è abbastanza vicino, ma che non sostiene apertamente per non urtare<br />
nelle obiezioni avanzate da Teofilo nel Contra Hermogenem, che conosce (li cita nelle<br />
3
Eclogae propheticae 56, 2). In Strom. II 16, 74, 1 Clemente lascia aperta la questione<br />
della materia preesistente, ma Fozio Bibl. 109 attesta che nelle Ipotiposi Clemente parlava<br />
<strong>di</strong> una materia 89)"'"0, il che suggerisce una qualche prossimità con le tesi platoniche<br />
contrastate da Teofilo.<br />
- In Strom. VI 7, 58, 1 Clemente accetta l’identificazione <strong>di</strong> Teofilo fra arché e<br />
Figlio.<br />
- Clemente accoglie da <strong>Filone</strong> l’interpretazione del giorno uno come creazione<br />
del mondo intelligibile, da cui Platone avrebbe tratto ispirazione per la propria dottrina<br />
delle idee: Strom. V 14, 53, 9.<br />
Nelle Eclogae propheticae sono conservati estratti <strong>di</strong> un’opera composta da<br />
Clemente dopo gli Stromata, le Ipotiposi; in esse commentava ampiamente il racconto<br />
della creazione.<br />
Seguendo l’esegesi <strong>di</strong> <strong>Filone</strong>, interpreta il cielo e la terra del primo giorno come<br />
creazione intelligibile, non <strong>di</strong> un mondo <strong>di</strong> forme, ma <strong>di</strong> un mondo <strong>di</strong> esseri intelligibili:<br />
angeli (i cieli) e anime umane (la terra invisibile): Ecl. 1, 1; 3, 1-3. L’identificazione del<br />
cielo con gli angeli è fondata sul fatto che nel cantico dei tre fanciulli i cieli vengono invitati<br />
a lodare Dio.<br />
Come in Teofilo, l’arché è il Figlio: Ecl. 4, 1-2.<br />
Negli Excerpta ex Theodoto 47, 2-3 Clemente è testimone anche<br />
dell’interpretazione valentiniana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1-3.<br />
<strong>Origene</strong> (~ 185-254): il suo commento alla <strong>Gen</strong>esi, composto ad Alessandria<br />
verso il 230, è andato perduto, salvo pochi frammenti (cf. il testo proveniente da Eusebio<br />
e forse quello proveniente da Calci<strong>di</strong>o). Un’annotazione in Contra Celsum VI 49 offre<br />
una traccia degli argomenti che in esso <strong>Origene</strong> trattava a proposito del primo giorno<br />
della creazione (cf. sotto). Elementi sull’esegesi del primo giorno della creazione si ricavano<br />
ancora da De principiis, Commento a Giovanni I (<strong>di</strong> epoca poco posteriore al<br />
commento alla <strong>Gen</strong>esi), dalle Omelie sulla <strong>Gen</strong>esi e da Contra Celsum, che risalgono<br />
invece agli anni ’40 del III secolo, quando <strong>Origene</strong> soggiornava a Cesarea <strong>di</strong> Palestina.<br />
CC IV 51 accenna alle intepretazioni bibliche <strong>di</strong> Numenio <strong>di</strong> Apamea, che <strong>Origene</strong><br />
considera non infondate. L’unica che ci sia nota concerne proprio <strong>Gen</strong> 1, 2a ed è<br />
ripostata da Porfirio De antro 10, dove si assimila l’immagine dello spirito che aleggia<br />
sulle acque alle anime intelligibili che si staccano dalla sfera <strong>di</strong>vina e scendono nella realtà<br />
corporea, simboleggiata dall’elemento umido.<br />
· <strong>Origene</strong> accoglie da <strong>Filone</strong> la lettura dei due racconti della creazione come due<br />
sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>spiegamento dell’opera creatrice <strong>di</strong> Dio: creazione intelligibile e plasmazione<br />
del mondo sensibile. Il primo racconto descrive la creazione intelligibile prima della<br />
fondazione/caduta (katabolé PA III 5, 4) del cosmo sensibile. Ma la lettura <strong>di</strong> <strong>Origene</strong> è<br />
più problematica <strong>di</strong> quanto possa sembrare a prima vista, soprattutto in relazione alla<br />
creazione dell’uomo e al suo peccato. Vi sono testi nei quali <strong>Origene</strong> contrappone<br />
l’uomo creato a immagine <strong>di</strong> Dio (<strong>Gen</strong> 1, 26) all’uomo plasmato dall polvere della terra<br />
(<strong>Gen</strong> 2, 7): H<strong>Gen</strong> I 13; Dial. 11-12; CIoh XX 182. Ma vi sono altri testi che leggono in<br />
<strong>Gen</strong> 2, 7 la menzione del corpo sottile che faceva da veicolo all’anima umana prima della<br />
caduta e della sua inclusione nelle tuniche <strong>di</strong> pelle (<strong>Gen</strong> 3, 21), interpretate come allusione<br />
al corpo <strong>di</strong> carne: cf. quello che scrive Procopio In <strong>Gen</strong>., PG 87, 221. Nel primo<br />
4
caso il peccato <strong>di</strong> Adamo si colloca tra il primo e ilsecondo racconto, nel secondo caso<br />
esso si colloca invece tra il secondo racconto e il dono delle tuniche <strong>di</strong> pelle 2.<br />
· Sulla nozione <strong>di</strong> “principio” <strong>Origene</strong> compiva un esame scrupoloso delle possibili<br />
interpretazioni (cf. Calci<strong>di</strong>o e CIoh sotto), venendo a identificare il principio con<br />
la Sapienza del Padre, cioè il suo Verbo, che però non è creato, ma generato ab aeterno<br />
dal Padre. In CIoh I 103-104 è <strong>di</strong> particolare interesse la considerazione del tipo <strong>di</strong> preposizioni<br />
da associare al principio: <strong>Origene</strong> esclude che si tratti <strong>di</strong> un principio dal quale<br />
Dio ha tratto le cose, mentre ammette che si tratti <strong>di</strong> un principio secondo il quale le ha<br />
create, una causa non materiale, bensì formale dunque. È possibile che quest’analisi delle<br />
preposizioni <strong>di</strong>penda dall’uso del libro <strong>di</strong> Teofilo contro Ermogene, perché anche<br />
Tertulliano Adv. Herm. 20, 2-3 fa considerazioni analoghe a quelle <strong>di</strong> <strong>Origene</strong> su questo<br />
punto. In ogni caso, si deve anche tenere presente la familiarità ai platonici del suo tempo<br />
<strong>di</strong> schemi che enumeravano le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> causa in forma preposizionale (cf.<br />
Dörrie).<br />
· Seguendo <strong>Filone</strong> e Clemente, <strong>Origene</strong> <strong>di</strong>stingue e il cielo e la terra <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1<br />
dal firmamento creato nel secondo giorno e dalla terra arida creata nel terzo. Questo cielo<br />
e questa terra sono al <strong>di</strong> là del cosmo e trascendono non solo i cieli planetari, ma anche<br />
quello delle stelle fisse. Si tratta <strong>di</strong> un cielo e una terra intelligibili, che non sono<br />
propriamente luoghi nei quali si trovano le creature intelligibili, ma si identificano con<br />
esse: H<strong>Gen</strong> I 2. Il cielo è la totalità delle creature intelligibili, la terra è il para<strong>di</strong>so nel<br />
quale Dio aveva collocato Adamo prima del peccato: HNum XXVI 5: nam et Adam in<br />
hunc locum quasi culpabilis post peccatum detru<strong>di</strong>tur qui arida nominatus est. Antea<br />
enim non fuit in arida sed in terra. Para<strong>di</strong>sus namque non est in arida sed in terra. Per i<br />
giusti questa terra costituisce l’ultima tappa <strong>di</strong> preparazione e educazione prima <strong>di</strong> essere<br />
reintegrati definitivamente nel regno <strong>di</strong> Dio.<br />
· Sulla terra invisibile e <strong>di</strong>sorganizzata Eusebio ha conservato un passo <strong>di</strong> C<strong>Gen</strong><br />
nel quale <strong>Origene</strong> prende posizione contro la dottrina della materia preesistente, usando<br />
argomenti che in alcuni luoghi richiamano Teofilo. In PA IV 4, 6 <strong>Origene</strong> si sforzava <strong>di</strong><br />
fondare questa tesi con passi delle Scritture (Sal 138, 16) o degli apocrifi (1 Hen. 19, 3;<br />
21, 1); riconosceva comunque che non a torto i due aggettivi venivano riferiti ai caratteri<br />
della materia informe, a patto <strong>di</strong> intendere ch’essa è stata creata da Dio.<br />
· Le tenebre che ricoprono l’abisso sono identificate con Satana: C<strong>Gen</strong> I 1; CIoh<br />
XXXII 313, probabilmente in opposizione allo Spirito che aleggia sulle acque.<br />
· Lo Spirito che aleggia sulle acque è nel suo senso profondo lo Spirito santo: PA<br />
I 3, 3, che rinvia a C<strong>Gen</strong>. <strong>Origene</strong> si esprime con cautela: ammette che si tratta <strong>di</strong><br />
un’interpretazione del senso spirituale e non letterale, evidentemente conosce le altre<br />
letture <strong>di</strong> questo passo e trova una soluzione che concilia la posizione <strong>di</strong> Teofilo (senso<br />
letterale) con quella <strong>di</strong> Clemente (senso spirituale). L’interpretazione <strong>di</strong> questo passo in<br />
chiave battesimale proposta da Clemente è ripresa anche in CIoh VI 169, dove si <strong>di</strong>ce<br />
che lo Spirito che aleggia sulle acque aleggia ancora oggi sulle acque battesimali e si<br />
posa in coloro che ne sono degni.<br />
2 Su questo problema cf. M. SIMONETTI, Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong>esi 2,<br />
7 e 3, 21, «Aevum», 36 (1962), pp. 370-381.<br />
5
· Merita <strong>di</strong> essere osservata con attenzione la varietà dei generi letterari e delle<br />
forme <strong>di</strong> elaborazione del pensiero nelle pagine origeniane qui tradotte: ci sono passi<br />
provenienti da commentari (C<strong>Gen</strong> e CIoh) e da trattati dal carattere sistematico (PA) o<br />
apologetico (CC), infine un testo proveniente da una raccolta <strong>di</strong> omelie (H<strong>Gen</strong>).<br />
L’interprete del pensiero origeniano deve tener conto della complessità dei problemi<br />
posti dall’adozione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong>verse (ma fino a che punto esse<br />
sono davvero <strong>di</strong>verse? i commenti biblici risentono profondamente della pratica scolastica<br />
e <strong>di</strong> problemi pertinenti alla cultura filosofica, i trattati sistematici sono ricchi <strong>di</strong><br />
annotazioni esegetiche e si fondano sull’esame puntuale <strong>di</strong> dossier biblici; e, ancora,<br />
l’omelia, oltre a essere stata con ogni probabilità sottoposta a ua rielaborazione letteraria,<br />
espone comunque contenuti dottrinali complessi che suppongono un u<strong>di</strong>torio non<br />
del tutto sprovveduto dal punto <strong>di</strong> vista dottrinale e biblico).<br />
Ci sono poi i problemi posti dal modo in cui il corpus origeniano è giunto fino a<br />
noi: la tra<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>retta (cf. le citazioni da C<strong>Gen</strong> provenienti da Eusebio e da Calci<strong>di</strong>o)<br />
e gli interventi <strong>di</strong> adattamento e adeguamento all’ortodossia nicena del traduttore<br />
latino Rufino, o le <strong>di</strong>storsioni operate, scientemente o no, in bene o in male, dagli altri<br />
testimoni.<br />
· In generale, emerge con chiarezza dalle pagine citate che <strong>Origene</strong> affronta<br />
l’esame del testo biblico a partire da un orizzonte concettuale e scientifico ellenico, che<br />
non ha <strong>di</strong>fficoltà ad utilizzare nell’interpretazione dei testi sacri e della dottrina in essi<br />
contenuta.<br />
Egli non è però ingenuo ed è perfettamente conscio dell’eterogeneità della fede<br />
cristiana e della rivelazione biblica rispetto alla cultura ellenica.<br />
L’esame della Scrittura è condotto non in modo autonomo, ma nello sforzo <strong>di</strong><br />
verificare le proprie conclusioni con il criterio della conformità alla tra<strong>di</strong>zione dottrinale<br />
della chiesa; anche se <strong>Origene</strong> <strong>di</strong>stingue in modo rigoroso ciò che in essa è vincolante e<br />
definitivamente certo e ciò che è problematico e offerto all’indagine <strong>di</strong> chi può e vuole<br />
impegnarsi.<br />
6
<strong>Origene</strong><br />
dal Commento alla <strong>Gen</strong>esi (?)<br />
(ap. Eus. PE VII 20)<br />
[Dopo aver citato un passo del trattato <strong>di</strong> Dionigi <strong>di</strong> Alessandria contro Sabellio,<br />
Eusebio cita un testo <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>, del quale non in<strong>di</strong>ca la provenienza, ma che è possibile<br />
attribuire al suo perduto Commento alla <strong>Gen</strong>esi]<br />
[Materia preesistente e onnipotenza <strong>di</strong> Dio]<br />
[Eus. PE VII 20, 1] «Se qualcuno si urta, a causa degli artigiani umani, perché<br />
non può accettare che Dio produca gli esseri senza usare come substrato una materia ingenerata<br />
— visto che nemmeno uno scultore può compiere la propria opera senza il<br />
bronzo, né un falegname senza il legno o un costruttore senza la pietra — bisogna interrogarlo<br />
sulla potenza <strong>di</strong> Dio, se, una volta che Dio ha deciso <strong>di</strong> far sussistere ciò che<br />
vuole, dal momento che la sua volontà non è priva né <strong>di</strong> mezzi né <strong>di</strong> forza, egli possa<br />
davvero far sussistere ciò che vuole 3.<br />
[Se Dio crea le qualità, perché non la materia?]<br />
[2] Per la ragione, infatti, per la quale, secondo tutti quelli che ammettono la<br />
provvidenza, Dio con la sua ineffabile potenza e sapienza, per l’or<strong>di</strong>namento<br />
dell’universo, fa sussistere come vuole le qualità, che <strong>di</strong> per se stesse non esistevano,<br />
per la medesima ragione la sua volontà è capace anche <strong>di</strong> far sì che si generi la sostanza<br />
della quale egli ha bisogno 4.<br />
[Se non è creatore, non è Dio]<br />
[3] Nei confronti <strong>di</strong> coloro che non ammettono che le cose stiano così, manifesteremo<br />
il dubbio che dai loro argomenti consegua che Dio ha avuto una bella fortuna,<br />
trovando la materia ingenerata che, se il suo essere ingenerata non gliela avesse messa a<br />
<strong>di</strong>sposizione, egli non sarebbe stato in alcun modo capace <strong>di</strong> produrre; egli sarebbe bensì<br />
rimasto non creatore, non padre, non benefattore, non buono, né alcun altro degli epiteti<br />
che a buona ragione si <strong>di</strong>cono <strong>di</strong> Dio 5.<br />
[4] Da dove, poi, sarebbe venuta la misura della quantità del substrato tale da bastare<br />
a far sussitere un cosmo <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>mensioni? Come se una qualche provvidenza<br />
3 <strong>Origene</strong> rifiuta <strong>di</strong> equiparare l’azione creatrice <strong>di</strong> Dio all’azione trasformatrice <strong>di</strong> un artigiano umano.<br />
L’argomento della potenza illimitata <strong>di</strong> Dio, che può fare sussistere tutto ciò che vuole, senza aver bisogno<br />
<strong>di</strong> altro che del proprio atto <strong>di</strong> volontà, serve a sottolineare la <strong>di</strong>fferenza fra Dio e gli esseri razionali<br />
finiti. Si osservi la <strong>di</strong>fferenza rispetto all’uso che faceva <strong>Filone</strong> dell’immagine del Dio architetto e<br />
causa attiva, che or<strong>di</strong>na e informa <strong>di</strong> sé una causa materiale passiva.<br />
4 Tutti coloro che ammettono l’esistenza della provvidenza <strong>di</strong>vina ammettono ch’essa si manifesti in<br />
un’azione or<strong>di</strong>natrice e regolatrice; in concreto, questo significa che la provvidenza conferisce alla realtà<br />
materiale del cosmo qualità ch’essa <strong>di</strong> per sé non possiede. Ma, se Dio può conferire alla materia delle<br />
qualità ch’essa non possiede, perché non dovrebbe essere in grado anche <strong>di</strong> suscitare la materia stessa che<br />
ne è il substrato? La dottrina della creazione ex nihilo sembra appartenere, secondo <strong>Origene</strong>, al deposito<br />
<strong>di</strong> verità esplicitamente tramandate dagli apostoli: PA I praef 4: «Species vero eorum quae per prae<strong>di</strong>cationem<br />
apostolicam manifeste traduntur istae sunt. Primo quod unus est Deus, qui omnia creavit atque<br />
composuit, quique, cum nihil esset, esse fecit universa».<br />
5 Secondo la tesi <strong>di</strong> coloro che affermano la preesistenza della materia, Dio, per essere tale — cioè artefice,<br />
padre, buono — avrebbe avuto necessità della materia ingenerata; ma questo contrad<strong>di</strong>ce<br />
l’autosufficienza e la potenza che devono appartenere per essenza alla <strong>di</strong>vinità. Cf. PA II 1, 4, p. 110, 17-<br />
21 Koet.: «Secundum hanc enim eorum rationem [i.e. <strong>di</strong> quelli che affermano che la pateria è ingenerata]<br />
si ponamus verbi gratia materiam non fuisse, ut isti asserunt <strong>di</strong>centes quia deus non potuerit aliquid facere,<br />
cum nihil esset, sine dubio futurus erat otiosus, materiam non habens ex qua possit operari».<br />
7
più antica <strong>di</strong> Dio gli avesse sottoposto necessariamente la materia, provvedendo a che<br />
l’arte che sussiste in Dio non si risolvesse in un nulla <strong>di</strong> fatto, mancandogli la materia,<br />
potendosi unire alla quale egli <strong>di</strong>ede forma e or<strong>di</strong>ne alla bellezza così grande del cosmo.<br />
[5] Da dove, poi, la materia è <strong>di</strong>ventata capace <strong>di</strong> accogliere ogni qualità voluta<br />
da Dio, se il medesimo Dio non se la fosse creata tanta e tale, quale voleva averla 6?<br />
[Se la materia è ingenerata, provvidenza e caso si equivalgono]<br />
[6] Accettando per ipotesi l’affermazione che la materia è ingenerata, <strong>di</strong>remo a<br />
coloro che vogliono che le cose stiano così: se, senza una provvidenza che abbia messo<br />
a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> Dio la materia, quest’ultima è <strong>di</strong>ventata quale è, nel caso in cui una<br />
provvidenza vi fosse invece stata, che cosa essa avrebbe compiuto in più rispetto al caso?<br />
[7] E se Dio, essendoci già la materia, avesse voluto or<strong>di</strong>narla, che cosa avrebbero<br />
fatto la sua sapienza e la sua <strong>di</strong>vinità <strong>di</strong> più rispetto a ciò che sussisteva a partire da una<br />
realtà ingenerata? Se, infatti, si trova che, per azione della provvidenza, si produce il<br />
medesimo risultato che sussiste anche senza la provvidenza, perché non dovremmo eliminare<br />
del tutto, anche per quel che concerne il cosmo, il produttore e l’artigiano? 7<br />
[8] Come, infatti, è assurdo nel caso del cosmo, or<strong>di</strong>nato in modo così sapiente,<br />
affermare che è <strong>di</strong>venuto tale senza un sapiente artefice, così allo stesso modo è irragionevole<br />
che la materia ingenerata sussista in questa quantità, con tali qualità e con tale<br />
recettività nei confronti del <strong>di</strong>vino Logos artefice. [9] A coloro che oppongono che nessun<br />
artefice opera senza materia, si deve <strong>di</strong>re che fanno una comparazione fra realtà <strong>di</strong>ssimili:<br />
la provvidenza, infatti, sottopone a ciascun artefice la materia a partire da un’arte<br />
precedente, umana o <strong>di</strong>vina.<br />
Questi argomenti basteranno per ora per coloro che, a causa del fatto che si <strong>di</strong>ce<br />
“la terra era invisibile e informe” (<strong>Gen</strong> 1, 2), ritengono che la natura corporea sia ingenerata».<br />
6 La materia presente nel cosmo è esattamente tanta quanta era necessaria a produrre il cosmo secondo i<br />
<strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Dio ed era fatta in modo tale da poter accogliere esattamente tutte le qualità che Dio ha voluto<br />
conferirle. <strong>Origene</strong> argomenta che una tale fortunata coincidenza si può spiegare solo o ammettendo che<br />
Dio ha fatto la materia esattamente nella misura e con le caratteristiche corrispondenti al proprio piano<br />
creativo o ammettendo che al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> Dio e della materia vi sia una provvidenza superiore, che si è<br />
adoperata per conciliare l’uno e l’altra senza residui. Questa prospettiva nega implicitamente la concezione,<br />
proposta p.e. da Ermogene, secondo la quale il male deriva da un residuo materiale non or<strong>di</strong>nato presente<br />
nel cosmo. Cf. PA II 1, 4, p. 110, 21-25 Koet.: «Quam [materiam] ei non sua provisione, sed fortuito<br />
sentiunt adfuisse; et videtur eis quod hoc, quod fortuito inventum est, sufficere ei potuerit ad tanti<br />
operis molem et ad suae virtutis potentiam, quod totius sapientiae suae suscipiens rationem <strong>di</strong>stingueretur<br />
ac formaretur ad mundum».<br />
7 <strong>Origene</strong> ripropone gli stessi argomenti mostrando le conseguenze inaccettabili della posizione dei suoi<br />
avversari, coloro che sostengono che la materia sia ingenerata. Se le cose stessero così, si verificherebbe<br />
ciò che è stato <strong>di</strong>scusso nei §§ precedenti: la provvidenza <strong>di</strong> Dio si esercita su una materia che gli viene<br />
offerta esattamente nella quantità e con le qualità che gli servono; se questa materia gli viene offerta con<br />
queste modalità dal caso, ne risulta che non vi è <strong>di</strong>fferenza tra la provvidenza e il caso; oppure si deve<br />
ammettere che la materia gli venga offerta in questa forma da un intervento provvidenziale, e allora la tesi<br />
degli avversari <strong>di</strong> <strong>Origene</strong> è confutata. L’idea che il cosmo or<strong>di</strong>nato possa essere effetto <strong>di</strong> un puro caso,<br />
nell’antichità, viene <strong>di</strong>fesa dagli epicurei, ma a <strong>Origene</strong> essa appare talmente irragionevole e mostruosa<br />
da essere <strong>di</strong> per sé inaccettabile. Cf. PA II 1, 4, p. 111, 1-12: «[...] concedatur paulisper non fuisse materiam,<br />
et deum, cum nihil esset prius, fecisse ut essent ea, quae esse voluit: quid putabimus? quia meliorem<br />
aut maiorem aut alterius generis materiam facturus esset deus, quam ex sua virtute ac sapientia proferebat,<br />
ut esset quae ante non fuerat, an inferiorem et deteriorem, en similem atque eandem ut est illa, quam<br />
isti ingenitam <strong>di</strong>cunt? Et puto cuivis facillime pateat intellectus, quod neque melior neque inferior potuisset<br />
mun<strong>di</strong> formas speciesque suscipere, nisi talis fuisset, qualis ista est quae suscepit. Et quomodo ergo<br />
non videbitur impium id ingenitum <strong>di</strong>cere, quod si factum a deo credatur, tale sine dubio invenitur, quale<br />
et illud est, quod ingenitum <strong>di</strong>citur?».<br />
8
Dal Commento alla <strong>Gen</strong>esi (?)<br />
(ap. Chalc. In Plat. Timaeum CCLXXVI)<br />
Questo testo proviene da un commento al Timeo <strong>di</strong> Platone, composto in latino, secondo il suo e<strong>di</strong>tore - J.<br />
Waszink - intorno al 400 d.C., da uno scrittore <strong>di</strong> nome Calci<strong>di</strong>o. Si <strong>di</strong>scute molto su quali siano state la<br />
data <strong>di</strong> composizione, i destinatari, le fonti <strong>di</strong> questo autore: Waszink propone una datazione tarda e una<br />
<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> Calci<strong>di</strong>o dal commento al Timeo scritto da Porfirio nella seconda metà dei III secolo; altri<br />
stu<strong>di</strong>osi pensano a una data <strong>di</strong> composizione più precoce, prima metà del IV secolo, e a una più forte <strong>di</strong>pendenza<br />
dalla tra<strong>di</strong>zione me<strong>di</strong>oplatonica (Numenio in primo luogo). Nel commento <strong>di</strong> Calci<strong>di</strong>o il nome<br />
<strong>di</strong> <strong>Origene</strong> è uno dei pochi esplicitamente citati, insieme a queli <strong>di</strong> Platone, Aristotele, <strong>Filone</strong> e Numenio.<br />
<strong>Origene</strong> fra l’altro è citato senza obiezioni, come uno scrittore autorevole, il che potrebbe <strong>di</strong>pendere da<br />
una collocazione dell’opera anteriore allo scoppio delle prime controversie antiorigeniste alla fine del IV<br />
secolo.<br />
Calci<strong>di</strong>o sta <strong>di</strong>scutendo il problema se la materia sia creata o non creata; gli unici a sostenere che la materia<br />
è creata sono gli ebrei, mentre l’altra posizione è sostenuta in vari termini dall’intera tra<strong>di</strong>zione greca.<br />
Si ritiene or<strong>di</strong>nariamente che la fonte della dottrina origeniana qui descritta sia il perduto Commento alla<br />
<strong>Gen</strong>esi <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>.<br />
Calci<strong>di</strong>o cita in altri luoghi del suo commento passi biblici, per lo più riferentisi alla <strong>Gen</strong>esi, e la filosofia<br />
degli ebrei, per mostrare che con essa concorda anche la dottrina dei greci. Ci si chiede se la fonte <strong>di</strong> queste<br />
citazioni sia la stessa dalla quale egli deriva questa pagina o no e se essa possa essere riconosciuta<br />
proprio nel Commento alla <strong>Gen</strong>esi <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>. Beatrice (1999) ha avanzato l’ipotesi che la fonte <strong>di</strong> questi<br />
riferimenti alla dottrina biblica siano piuttosto gli Stromata <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>, anch’essi perduti, dei quali però si<br />
sa che contenevano saggi <strong>di</strong> esegesi biblica e <strong>di</strong>scussioni dottrinali che armonizzavano rivelazione biblica<br />
e dottrine filosofiche.<br />
[Secondo Mosè, la materia è stata generata]<br />
[276] Gli ebrei ritengono che la materia sia stata generata. Il più sapiente <strong>di</strong> loro,<br />
Mosè, animato non da umana eloquenza, ma — comte tramandano — dall’ispirazione<br />
<strong>di</strong>vina, nel libro che è intitolato Sulla generazione del mondo parlò 8 così dal principio,<br />
secondo la traduzione dei Settanta sapienti: «All’inizio Dio fece il cielo e la terra, ma la<br />
terra era invisibile e <strong>di</strong>sadorna», oppure come <strong>di</strong>ce Aquila: «Come inizio delle cose Dio<br />
fondò il cielo e la terra, la terra, però, era vuota e nulla», oppure come Simmaco:<br />
«Dall’inizio Dio fondò il cielo e la terra, la terra, però, fu qualcosa <strong>di</strong> inerte e confuso e<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato» 9. <strong>Origene</strong>, però, afferma <strong>di</strong> essere stato persuaso dagli ebrei che la traduzione<br />
si è in una certa misura allontanata dal senso proprio; nell’originale, infatti, c’era:<br />
«Ma la terra si trovava in un certo stupefatto sbigottimento» 10.<br />
[Esegesi <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1: <strong>di</strong>versi significati del termine “inizio”]<br />
8 Il verbo profatus est potrebbe essere anche tradotto con “profetizzò”, che è coerente con la rappresentazione<br />
<strong>di</strong> Mosè come profeta.<br />
9 Calci<strong>di</strong>o traduce il termine 4)9: con “initium”, conservo anche in italiano questa traduzione. Le tre versioni<br />
che vengono presentate erano con ogni probabilità <strong>di</strong>scusse da <strong>Origene</strong> nel proprio commentario:<br />
LXX: ;' 4)9< ;!"=$>3' 1 ?3@0 %@' "()*'@' ,*- %&' ./'. A BC ./ D' 47)*%"0 ,*-<br />
4,*%*>,3E*>%"0. Aquila: ;' ,3F*G*=H I,%#>3' 1 ?3@0 >J' %@' "()*'@' ,*- >J' %&' ./'. A BC ./<br />
D' ,K'6L* ,*- "(?K'. Simmaco: ;' 4)9< I,%#>3' 1 ?3@0 %@' "()*'@' ,*- %&' ./'. A BC ./ ;.K'3%"<br />
8)."' ,*- 4B#5,)#%"'. La traduzione <strong>di</strong> Teodozione qui non è menzionata, forse perché<br />
sostanzialmente coincidente con quella <strong>di</strong> Aquila. Beatrice (1999) fa notare che, oltre a Calci<strong>di</strong>o e<br />
Girolamo, Mario Vittorino è l’unico scrittore latino che conosce la traduzione <strong>di</strong> Aquila: potrebbe<br />
conoscerla <strong>di</strong>rettamente dalla lettura <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>, oppure potrebbe conoscerla grazie alla me<strong>di</strong>azione<br />
proprio <strong>di</strong> Calci<strong>di</strong>o, che in questo caso dovrebbe essere datato prima del 360.<br />
10 Stando a J.C.M. van Winden, stupore e sbigottimento sono attribuiti nella gnosi valentiniana all’ultimo<br />
eone, Sophia, dopo il fallimento del suo tentativo <strong>di</strong> conoscere il padre originario, fallimento dal quale si<br />
genera al materia. Resta <strong>di</strong>fficile capire se e come <strong>Origene</strong> potesse ricevere una simile lettura da rabbini<br />
ebrei, ai quali il testo qui la attribuisce. Potrebbe trattarsi piuttosto <strong>di</strong> giudeo-cristiani che rileggono in<br />
chiave gnostica esegesi giudaiche <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 2 [[cf sul tema stupore nella gnosi valentiniana: Clem. Alex.<br />
Strom. II 8, 36, 2-4; 37, 4-38, 2]]<br />
9
Comunque, tutte queste traduzioni concordano in un punto, che la materia soggiacente<br />
alla totalità dei corpi sia stata generata, e interpretano le parole stesse in questo<br />
modo: che il temine “inizio” non è detto in senso cronologico — infatti prima<br />
dell’or<strong>di</strong>namento del mondo non c’è stato alcun tempo, né le alternanze <strong>di</strong> giorno e notte<br />
dalle quali gli intervalli <strong>di</strong> tempo sono stati misurati — e che del termine “inizio” vi<br />
sono molti significati 11. Come <strong>di</strong>ce Salomone che «Inizio della sapienza» sarà «il timore<br />
del Signore» (Prov 9, 10) e ancora: «Inizio della sapienza è il culto <strong>di</strong> Dio» (Prov 1, 7)<br />
e, non<strong>di</strong>meno, «Inizio <strong>di</strong> una via ottima è un’azione giusta» (Prov 16, 7); e anche nel<br />
suo elogio della sapienza celeste l’autore <strong>di</strong>ce: «Inizio della vita è il pane e l’acqua e<br />
una veste e una casa adatta a nascondere le parti intime» (Sir 29, 21) 12. In effetti, in questi<br />
passi si hanno non uno solo, ma <strong>di</strong>versi e molteplici significati del termine “inizio”.<br />
[Come si deve intendere l’«in principio»]<br />
C’è, tuttavia, un solo inizio <strong>di</strong> tutte le cose, del quale Salomone, nei Proverbi,<br />
<strong>di</strong>ce: «Mi ha creato Dio come via del suo procedere, appoggiandosi alla quale potesse<br />
compiere le proprie opere <strong>di</strong>vine e mi costituì prima del sorgere del mondo e della terra<br />
e prima della fondazione dell’abisso, prima dello scorrimento delle fonti e<br />
dell’accumulo delle montagne» (Prov 8, 22-25), in<strong>di</strong>cando apertamente che, preceduti<br />
dalla <strong>di</strong>vina sapienza, sono stati fatti il cielo e la terra e che la medesima <strong>di</strong>vina sapienza<br />
sarebbe stata l’origine dell’universo. Da questo appare che sì la sapienza è stata fatta da<br />
Dio, ma non in un qualche tempo — infatti non c’è stato alcun tempo nel quale Dio sia<br />
stato senza la propria sapienza — e che è necessario che dai pensieri degli uomini sia<br />
percepito Dio prima della sua sapienza, a causa dell’eminenza della sua natura, perché<br />
prima si conosce ciò a cui una cosa appartiene e poi la cosa stessa. E questo è quanto bisogna<br />
considerare a proposito dell’inizio 13.<br />
[Che cosa sono «cielo e terra»?]<br />
[277] Bisogna ora intendere <strong>di</strong> quale cielo e <strong>di</strong> quale terra parli la Scrittura. Coloro<br />
che si accontentano <strong>di</strong> una comprensione improvvisata pensano che siano in<strong>di</strong>cati<br />
questo cielo che ve<strong>di</strong>amo e questa terra dalla quale siamo sorretti. Invece, coloro che ricercano<br />
più in profon<strong>di</strong>tà negano che questo cielo sia stato fatto all’inizio, bensì nel secondo<br />
giorno — infatti all’inizio è stata fatta la luce ed essa è stata chiamata “giorno”,<br />
mentre in seguito è stato fatto questo cielo, che Dio che chiamato “firmamento” —; in<br />
seguito, nel terzo giorno, dopo che furono allontanate le acque, apparve il suolo arido e<br />
gli è stato imposto il nome <strong>di</strong> “terra”, perché sia evidente che né questo cielo che ci è<br />
noto, né questa terra nella quale ci troviamo sono cose fatte fin dall’inizio, ma che ve ne<br />
sono altre più antiche, che devono essere attinte dall’intelletto piuttosto che dai sensi. La<br />
Scrittura, dunque, attesta che una cosa è il vero cielo e un’altra il firmamento e, allo<br />
stesso modo, una cosa è la terra e un’altra il suolo arido.<br />
[Due interpretazioni del cielo e della terra]<br />
[278] Quale, dunque, è quel cielo che Dio fondò prima delle altre cose e quale è<br />
quella terra? <strong>Filone</strong> ritiene che sarebbero state essenze incorporee e intelligibili, idee e<br />
modelli tanto <strong>di</strong> questo suolo arido qui, quanto del firmamento; infine, <strong>di</strong>ce che prima è<br />
11 Sul fatto che il termine “inizio” non possa essere inteso in senso cronologico si è espresso anche <strong>Filone</strong>,<br />
cf. sopra. Si veda la trattazione dei <strong>di</strong>versi significati del termine arché in Aristot. Metaph. M 1, 1012 b 34<br />
ss.; e in queste pagine la ripresa del tema in Orig. CIoh I e Bas. Caes. In Hexaem. I 5.<br />
12 Traduzione strana: il termine greco 4>9$L">E'$ significa “vergogna, <strong>di</strong>sonore”.<br />
13 Il principio <strong>di</strong> cui parla la <strong>Gen</strong> non è dunque un inizio cronologico, un primo momento, ma la Sapienza<br />
<strong>di</strong> Dio, dalla quale tutte le cose derivano. Cf. su questo punto anche PA I 2, 1-2; CIoh I 109-118.<br />
10
stato fatto da Dio anche l’uomo intelligibile e il modello archetipo del genere umano,<br />
poi quello corporeo.<br />
Altri non pensano così, ma pensano che il profeta, sapendo che vi sono due generi<br />
<strong>di</strong> tutte le cose, l’uno intelligibile, l’altro sensibile, abbia chiamato “cielo” e “terra”<br />
quelle potenze che includono e contengono le due nature: “cielo” la potenza che comprende<br />
la natura incorporea, mentre “terra” quella che è sostanza delle cose e che i greci<br />
chiamano hyle 14.<br />
[Terra come “materia”]<br />
Concordano con questa opinione le parole che seguono: «la terra, però, era invisibile<br />
e informe», cioè la materia corporea, la sostanza antica del mondo, prima che,<br />
foggiata dall’abilità del Dio artefice, assumesse le forme, era allora priva <strong>di</strong> colore e <strong>di</strong><br />
ogni qualità. Ciò che è in questo stato è certamente ritenuto invisibile e informe; è poi<br />
chiamata «vuota e niente» per il fatto che, essendo capace <strong>di</strong> ricevere ogni qualità, non<br />
ne ha alcuna <strong>di</strong> propria per natura. La materia, dunque, in quanto è quella che riceve in<br />
sé tutti gli accidenti, è stata chiamata “vuota”, in quanto sembra che non possa mai essere<br />
colmata; inoltre, poiché è priva <strong>di</strong> tutto, è stata chiamata “niente”.<br />
Da Simmaco, invece, è chiamata “inerte” e “confusa”; per il fatto che da sé non<br />
è in grado <strong>di</strong> far nulla, è ritenuta inerte, per il fatto che è in grado <strong>di</strong> ricevere or<strong>di</strong>ne dal<br />
Dio creatore del mondo che la adorna. Il significato dell’espressione “stupefatta per lo<br />
sbigottimento” in<strong>di</strong>ca una certa facoltà e somiglianza con l’anima, se è vero ch’essa,<br />
conquistata dalla maestà del suo artefice e della sua autorità, se ne stupiva 15.<br />
[Materia sensibile e materia intelligibile]<br />
Perché, se è stata fatta da Dio un tempo una materia corporea informe, che la<br />
Scrittura chiama “terra”, non bisogna, credo, <strong>di</strong>sperare che ci potrà essere anche una<br />
materia intelligibile <strong>di</strong> genere incorporeo, che è stata chiamata con il nome <strong>di</strong> “cielo”.<br />
Ch’essa sia stata fatta e fatta in modo tale che ora sia quella che prima non era, lo provano<br />
in questo modo, per il fatto che agli artefici mortali viene offerta una materia preparata<br />
da altri e a questi ultimi la fornisce la natura, alla natura Dio, mentre a Dio non<br />
l’ha fornita alcuno, perché non vi è nulla <strong>di</strong> più antico <strong>di</strong> Dio. Egli stesso, dunque, costituì<br />
le risorse materiali sufficienti e utili alla fabbricazione del mondo 16. Portano molte<br />
altre prove, che sarebbe lungo esporre in modo particolareggiato.<br />
14 Questa è la tesi attribuita p.e. ad Ermogene, secondo il quale la terra in<strong>di</strong>cava la materia prima ingenerata<br />
e informe; cf. Theoph. Ad Autol. II 13; Tert. Adv. Herm. 23, 1; Orig. PA IV 4, 6. L’interpretazione attribuita<br />
a <strong>Filone</strong> si trova in Opif. 3-4 ed è quella che anche <strong>Origene</strong> sostiene, p.e. in PA II 3, 6; 9, 1; H<strong>Gen</strong><br />
I 2.<br />
15 Vengono qui descritte alcune caratteristiche fondamentali della materia: essa è assolutamente priva <strong>di</strong><br />
determinazioni (8!"#"0), e perciò è in grado <strong>di</strong> ricevere qualsiasi forma; è un principio assolutamente<br />
passivo: riceve determinazioni, ma non è in grado <strong>di</strong> produrne alcuna da se stessa; in alcuni autori viene<br />
identificata con l’anima irrazionale della quale parla Platone in Leg. X.<br />
16 Cf. per questa affermazione che Dio ha creato la materia sufficiente il passo <strong>di</strong> Eus PE VII 20, 9 citato<br />
sopra e PA II 9, 1.<br />
11
<strong>Origene</strong><br />
Dal Trattato sui principi<br />
I praef. 6-10<br />
[Il <strong>di</strong>avolo]<br />
6. Anche sul <strong>di</strong>avolo, sui suoi angeli e sulle potenze avverse la pre<strong>di</strong>cazione della<br />
chiesa ha insegnato che, sì, queste cose ci sono, ma che cosa siano e come siano non lo<br />
ha spiegato in modo sufficientemente chiaro. Presso molti, tuttavia, si ha questa opinione,<br />
che questo <strong>di</strong>avolo sia stato un angelo e che, <strong>di</strong>venuto apostata, abbia persuaso numerosi<br />
altri angeli a deviare insieme a lui e questi anche adesso vengono chiamati suoi<br />
angeli.<br />
[Il mondo]<br />
7. C’è, inoltre, anche questo nella pre<strong>di</strong>cazione della chiesa, che questo mondo è<br />
stato fatto e ha preso inizio da un determinato tempo e si deve <strong>di</strong>ssovere a motivo della<br />
sua stessa corruzione. Che cosa, però, ci sia stato prima <strong>di</strong> questo mondo o che cosa ci<br />
sarà dopo questo mondo, non è cosa manifesta alla maggioranza. Nella pre<strong>di</strong>cazione<br />
della chiesa, infatti, non viene presentato alcun <strong>di</strong>scorso chiaro su questi argomenti. [...]<br />
[La creazione degli angeli]<br />
10. C’è anche questo nella pre<strong>di</strong>cazione della chiesa: che esistono degli angeli <strong>di</strong><br />
Dio e delle potenze buone, che sono al suo servizio per realizzare la salvezza degli uomini;<br />
ma quando questi siano stati creati e come essi siano, non è stato precisato in modo<br />
sufficientemente chiaro» 17.<br />
I 3, 3 (p. 52, 3-7 Koet.)<br />
[<strong>Gen</strong> 1, 2: lo Spirito]<br />
«Lo Spirito <strong>di</strong> Dio», dunque, che, come è scritto, «si muoveva sulle acque» (<strong>Gen</strong><br />
1, 2) all’inizio della creazione del mondo ritengo non sia altri che lo Spirito santo, per<br />
quanto riesco a capire, come ho mostrato quando ho spiegato quel passo; certo, non secondo<br />
il senso storico, ma secondo la comprensione spirituale» 18.<br />
17 <strong>Origene</strong> è il primo autore cristiano a porre esplicitamente il problema <strong>di</strong> quando gli angeli siano stati<br />
creati (anche se poi non affronta la questione nel trattato <strong>di</strong> PA I 5 de<strong>di</strong>cato esplicitamente alle potenze<br />
razionali). Alla creazione degli angeli si collega la questione del loro peccato e della trasformazione <strong>di</strong> alcuni<br />
<strong>di</strong> loro in angeli malvagi, demoni. L’assenza degli angeli dal racconto della creazione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1-2 ha<br />
posto, infatti, problemi all’esegesi sia giudaica sia cristiana. Le soluzioni, in <strong>Origene</strong> stesso, oscillano fra<br />
la collocazione della creazione degli angeli nel primo o nel secondo giorno (cielo o acque al <strong>di</strong> sopra del<br />
cielo). La tra<strong>di</strong>zione antiochena, contraria all’interpretazione allegorica e alla dottrina origeniana della<br />
preesistenza delle creature razionali, ha ritenuto piuttosto che gli angeli siano stati creati insieme al cielo e<br />
alla terra (cf Teodoreto <strong>di</strong> Ciro, Quaestiones in <strong>Gen</strong>esin II-IV). La tesi della creazione simultanea degli<br />
angeli e delle prime creature, che ha il suo fondamento nella versione greca <strong>di</strong> Sir 18, 1 (I,%#>3' %N<br />
!5'%* ,"#'
II 3, 6 (pp. 121, 1-124, 25 Koet.)<br />
[I significati del termine “mondo”]<br />
«Dopo aver <strong>di</strong>scusso secondo le nostre forze del mondo, non sembra inopportuno<br />
indagare che cosa significhi la parola “mondo” in se stessa; si vede, infatti, spesso<br />
che nelle Scritture sante questa parola ha <strong>di</strong>versi significati 19. Ciò che in latino chiamiamo<br />
“mondo”, viene detto in greco kósmos; ma il termine “kósmos” in greco non significa<br />
solo “mondo”, ma anche “ornamento” 20. Per esempio in Isaia, là dove viene rivolta<br />
alle “principesse, figlie <strong>di</strong> Sion” (Is 3, 17) un’invettiva, e <strong>di</strong>ce: “al posto dell’ornamento<br />
d’oro del tuo capo avrai la calvizie, a causa delle tue azioni”, chiama l’ornamento con lo<br />
stesso termine con il quale in<strong>di</strong>ca il mondo, cioè kósmon. [...] Viene chiamato “mondo”<br />
anche l’orbe terraqueo con i suoi abitanti, come quando la Scrittura <strong>di</strong>ce che “tutto il<br />
mondo è stabilito nel maligno” (1 Gv 5, 19). [...] 21 È chiamato “mondo” anche questo<br />
universo costituito dal cielo e dalla terra, come <strong>di</strong>ce Paolo: “Passerà infatti la figura <strong>di</strong><br />
questo mondo” (1 Cor 7, 31) 22.<br />
[Un mondo al <strong>di</strong> là del mondo]<br />
Anche il nostro Signore e Salvatore in<strong>di</strong>ca, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questo mondo visibile, anche<br />
un altro mondo, che a <strong>di</strong>r la verità è <strong>di</strong>fficile descrivere e designare; <strong>di</strong>ce, infatti, il<br />
Signore: “Io non sono <strong>di</strong> questo mondo” (Gv 17, 14. 16). Come uno che proviene da un<br />
altro mondo, ha detto: “non sono <strong>di</strong> questo mondo”. Per questa ragione abbiamo detto in<br />
anticipo <strong>di</strong> quel mondo che è <strong>di</strong>fficile per noi parlarne, perché non accadesse ad alcuno<br />
<strong>di</strong> intendere che noi vogliamo sostenere l’esistenza <strong>di</strong> rappresentazioni, che i greci<br />
chiamano idéas, dal momento che è del tutto estraneo alle nostre intenzioni affermare<br />
un mondo incorporeo che sussista solo nella rappresentazione della mente e nell’incerto<br />
spazio dei pensieri 23. E non vedo come si potrà sostenere che il Salvatore venga da un<br />
mondo simile o che tutti i santi vi andranno.<br />
Non c’è dubbio, invece, che dal nostro Salvatore viene in<strong>di</strong>cato qualcosa <strong>di</strong> più<br />
glorioso e splen<strong>di</strong>do rispetto a questo mondo presente, a cui egli spinge ed esorta a tendere<br />
coloro che credono in lui. Se, però, il mondo ch’egli vuole in<strong>di</strong>care sia qualcosa <strong>di</strong><br />
separato e <strong>di</strong>stante da questo nostro mondo per luogo, qualità o gloria, oppure se esso<br />
sia sì superiore per gloria e qualità, ma sia compreso nei confini <strong>di</strong> questo nostro mondo<br />
<strong>di</strong>vinità. Qui è accennato e applicato uno dei principi car<strong>di</strong>nali dell’esegesi origeniana: ogni testo della<br />
Scrittura, oltre a un eventuale significato letterale, che non sempre è possibile decifrare o riconoscere, ha<br />
sempre un significato spirituale.<br />
19 <strong>Origene</strong> è attento ad analizzare i <strong>di</strong>versi significati con i quali un termine può essere utilizzato nella<br />
Scrittura, per vedere se ve ne sono alcuni più appropriati <strong>di</strong> altri per la comprensione del testo che sta<br />
considerando.<br />
20 Questa nota è ovviamente non <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>, che scrive per lettori greci, ma <strong>di</strong> Rufino, che adatta il testo<br />
per dei lettori latini.<br />
21 Ometto una decina <strong>di</strong> righe, che illustrano varie accezioni possibili del termine “mondo” illustrandole<br />
con passi biblici che le documentano. Verosimilmente <strong>Origene</strong> ha tratto queste definizioni da un lessico o<br />
da un manuale e le ha completate con le opportune citazioni bibliche.<br />
22 Questa definizione <strong>di</strong> mondo viene dallo stoico Crisippo: SVF II 527<br />
23 L’affermazione riportata da Gv 17, 14-16 testimonia che esiste, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questo mondo sensibile, un<br />
altro mondo e da questo altro mondo proviene il Cristo. <strong>Origene</strong> si premura <strong>di</strong> precisare che questo altro<br />
mondo non è soltanto un mondo astratto, esistente come proiezione mentale, ma è un mondo realmente<br />
sussistente. Curiosamente, egli sembra qui contestare la dottrina platonica delle idee e del mondo intelligibile<br />
con gli stessi argomenti <strong>di</strong> Aristotele, che lo critica come una inutile duplicazione del mondo sensibile,<br />
mentre tutta la metafisica origeniana è fondata precisamente sulla <strong>di</strong>stinzione platonica fra mondo<br />
sensibile, derivato, e mondo intelligibile, che ne è il fondamento, l’origine, sussistente nel Logos <strong>di</strong> Dio.<br />
13
— cosa che a me sembra più verosimile 24 — è cosa incerta e, secondo me, alquanto inusuale<br />
per i pensieri e le menti degli uomini 25.<br />
Tuttavia, da quello che Clemente Romano sembra aver voluto in<strong>di</strong>care quando<br />
<strong>di</strong>ce: “L’oceano non può essere attraversato dagli uomini, né i mon<strong>di</strong> che si trovano al<br />
<strong>di</strong> là <strong>di</strong> esso” (1 Cor 20, 8), designando al plurale i mon<strong>di</strong> che sono al <strong>di</strong> là dell’oceano,<br />
dei quali <strong>di</strong>ce che sono retti e governati dalla medesima provvidenza <strong>di</strong> Dio, egli pare<br />
averci offerto alcuni semi proprio <strong>di</strong> questa interpretazione, secondo la quale la totalità<br />
delle cose che sono ed esistono, celesti e sovracelesti, terrestri ed infere, è detta in generale<br />
un unico e compiuto mondo, all’interno del quale o dal quale si deve ritenere siano<br />
contenuti gli altri mon<strong>di</strong>, quelli che si trovano in esso. Per questo alcuni vogliono che il<br />
globo della luna, del sole e degli altri astri che chiamano planétas [i.e. pianeti, astri mobili]<br />
siano designati ciascuno per sé come “mon<strong>di</strong>”; cionon<strong>di</strong>meno vogliono che anche il<br />
globo superiore ad essi, che chiamano aplanê [i.e. sfera delle stelle fisse], sia chiamato<br />
in senso proprio “mondo” 26. Chiamano a testimone <strong>di</strong> questa denominazione il libro del<br />
profeta Baruch, perché là vi sarebbe un’evidente in<strong>di</strong>cazione relativa ai sette mon<strong>di</strong> o<br />
cieli 27.<br />
[Cielo/firmamento - Terra/arida]<br />
Essi vogliono, però, che al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> quella sfera delle stelle fisse 28 che chiamano<br />
aplanê ve ne sia un’altra che, come presso <strong>di</strong> noi il cielo contiene tutte le cose che si<br />
trovano sotto il cielo, così quella — essi <strong>di</strong>cono — per la sua immensa grandezza ed estensione<br />
racchiude gli spazi <strong>di</strong> tutte quante le altre sfere nel proprio ambito, che è superiore<br />
a tutti gli altri; in modo tale che in questa stessa sfera si trovino tutte le altre, al<br />
modo in cui la nostra terra si trova al <strong>di</strong> sotto del cielo 29.<br />
Questa sfera [i.e. la sfera delle stelle fisse] 30 si crede sia chiamata nelle Scritture<br />
sante “terra buona” (Es 3, 8) e “terra dei viventi” (Sal 26, 13; 141, 6), avente come proprio<br />
cielo quello che abbiamo menzionato sopra, nel qual cielo si <strong>di</strong>ce che vengono<br />
scritti o sono stati scritti dal Salvatore i nomi dei santi (Lc 10, 20). In questo cielo viene<br />
compresa e contenuta quella terra che il Salvatore nel vangelo promette ai miti e ai<br />
mansueti (Mt 5, 5). Dal nome <strong>di</strong> quella terra, infatti, vogliono che abbia ricevuto il nome<br />
anche la nostra terra, che prima era stata chiamata “terra arida” (<strong>Gen</strong> 1, 10), esatta-<br />
24 Parla <strong>Origene</strong> o Rufino?<br />
25 <strong>Origene</strong> accenna qui a due possibili tesi circa l’esistenza contemporanea <strong>di</strong> più mon<strong>di</strong>; la posizione<br />
stoica, alla quale egli sembra dare la preferenza, è che vi sia un unico cosmo; in Plutarco De def. or. 22-<br />
37 si trova, invece l’affermazione della loro molteplicità. Ciò che è in ogni caso notevole è che <strong>Origene</strong><br />
sta parlando dell’ “altro mondo” dal quale il Cristo proviene come <strong>di</strong> un luogo.<br />
26 Stando a questa ipotesi, la pluralità dei mon<strong>di</strong> potrebbe designare semplicemente la pluralità dei pianeti<br />
e dei cieli che loro corrispondono, anche se in senso proprio mondo sarebbe il cielo delle stelle fisse, il<br />
più esterno, che li contiene tutti; cf. CH XI 7 e la nota ad loc. <strong>di</strong> Festugière.<br />
27 Si riferisce non al libro del profeta Bar, ma all’Apocalisse <strong>di</strong> Baruch, che nella versione greca oggi nota<br />
conosce cinque cieli, anche se forse in una versione primitiva parlava <strong>di</strong> sette sfere. In CC VI 21 <strong>Origene</strong><br />
afferma che il numero <strong>di</strong> sette pianeti non è in<strong>di</strong>cato da alcuna scrittura riconosciuta dalla chiesa, il che<br />
farebbe pensare ch’egli non ritenesse canonica tale apocalisse. Interessante osservare, però, come nel suo<br />
argomentare egli non esiti a ricorrere a testi, qui Clemente Romano e Apocalisse <strong>di</strong> Baruch, che pur non<br />
essendo canonici, considera autorevoli.<br />
28 La versione <strong>di</strong> Rufino conserva l’espressione greca sphaîran.<br />
29 L’ipotesi <strong>di</strong> un’ulteriore sfera al <strong>di</strong> là del cielo delle stelle fisse è stata formulata da Tolomeo ed è connessa<br />
nel suo modello cosmologico alla spiegazione del fenomeno della precessione. Nella cosmologia<br />
me<strong>di</strong>evale questa nona sfera è entrata con il nome <strong>di</strong> primum mobile. Cf. Theiler, Die chaldäischen<br />
Orakel, Halle, 1942, pp. 23-24.<br />
30 Dal punto <strong>di</strong> vista grammaticale, il pronome con il quale si apre questo periodo non può che riferirsi<br />
alla sfera appena nominata, la nona, che abbracia il cielo delle stelle fisse; ma dal punto <strong>di</strong> vista del senso,<br />
quello che <strong>Origene</strong> scrive può riferirsi solo alla sfera delle stelle fisse e al suo rapporto con quella più<br />
esterna che la include, da qui l’integrazione posta fra [].<br />
14
mente come questo firmamento ha ricevuto il nome <strong>di</strong> cielo dal termine <strong>di</strong> quel cielo<br />
(<strong>Gen</strong> 1, 8). Comunque, <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> opinioni abbiamo trattato più ampiamente in<br />
quel luogo nel quale abbiamo indagato che cosa volesse <strong>di</strong>re che “in principio Dio creò<br />
il cielo e la terra” (<strong>Gen</strong> 1, 1). Infatti, il termine “cielo” e il termine “terra” in<strong>di</strong>cano<br />
qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso rispetto a quel firmamento che si <strong>di</strong>ce sia stato creato dopo due<br />
giorni o rispetto alla terra arida che in seguito viene chiamata terra 31.<br />
[Differenza fra ciò che non si vede e invisibile]<br />
Per quanto riguarda, poi, quello che alcuni <strong>di</strong>cono <strong>di</strong> questo nostro mondo, che,<br />
per il fatto <strong>di</strong> essere stato creato, è soggetto a corruzione e tuttavia non si corrompe, perché<br />
più forte ed efficace della corruzione è la volontà <strong>di</strong> Dio, che lo ha creato e lo mantiene,<br />
perché “su <strong>di</strong> lui la corruzione non abbia potere” (Rom 8, 20-21) 32, queste cose si<br />
possono intendere più rettamente a proposito <strong>di</strong> quel mondo che sopra abbiamo chiamato<br />
sfera aplanê, dal momento ch’essa, per la volontà <strong>di</strong> Dio, non soggiace alla corruzione,<br />
poiché nemmeno si trovano in essa cause <strong>di</strong> corruzione. Quello è, infatti, il mondo<br />
dei santi e <strong>di</strong> coloro che sono completamente purificati e non anche degli empi, come lo<br />
è questo nostro 33. Bisogna vedere se per caso non sia proprio volgendo a ciò lo sguardo<br />
che l’apostolo ha detto: “... noi che guar<strong>di</strong>amo non le cose che si vedono, ma quelle che<br />
non si vedono. Le cose che si vedono sono, infatti, temporali, invece le cose che non si<br />
vedono sono eterne. Sappiamo, poi, che, se si <strong>di</strong>ssolve l’abitazione terrestre <strong>di</strong> questa<br />
nostra <strong>di</strong>mora, posse<strong>di</strong>amo un e<strong>di</strong>ficio fatto da Dio, una <strong>di</strong>mora non costruita con le mani,<br />
eterna, nei cieli” (2 Cor 4, 18-5, 1). Dal momento che altrove <strong>di</strong>ce: “Vedrò i cieli,<br />
opera delle tue mani” (Sal 8, 4) e <strong>di</strong> tutte le cose visibili Dio, per mezzo del profeta, ha<br />
detto che “la mia mano ha fatto tutte queste cose” (Is 66, 2), mentre questa “<strong>di</strong>mora eterna”,<br />
che promette nei cieli ai santi, afferma che non è stata fatta da mani, senza dubbio<br />
mostrando una <strong>di</strong>fferenza della creazione fra le cose che si vedono e quelle che non<br />
si vedono 34. Quelle che chiama “le cose che non si vedono” non sono la medesima realtà<br />
delle cose invisibili. Le cose invisibili, infatti, non solo non si vedono, ma non hanno<br />
neppure natura tale che possano esser viste e sono quelle che i greci hanno chiamato asómata,<br />
cioè cose incorporee; queste, invece, delle quali Paolo ha detto “le cose che non<br />
si vedono”, hanno natura tale da poter essere viste, ma egli spiega ch’esse non possono<br />
ancora esser viste da coloro ai quali esse vengono promesse 35».<br />
31 Il cielo e la terra creati all’inizio (<strong>Gen</strong> 1, 1) sono dunque, secondo <strong>Origene</strong>, rispettivamente la sfera<br />
senza stelle più esterna del cosmo e la sfera delle stelle fisse; solo in un secondo momento i loro nomi<br />
sono stati applicati anche al firmamento e al suolo arido creati nei giorni successivi. <strong>Origene</strong> accoglie<br />
l’interpretazione che <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1 aveva dato <strong>Filone</strong>, con una variante: <strong>Filone</strong> insisteva sul carattere puramente<br />
intelligibile della creazione del giorno uno, mentre <strong>Origene</strong> le conferisce un carattere concreto e la<br />
inserisce nel proprio modello cosmologico. Cf. J. Pépin, «Archivum Latinitatis Me<strong>di</strong>i Aevi», 23 (1953),<br />
pp. 248-259; Théologie cosmique, pp. 390 ss.<br />
32 La tesi è platonica: Tim. 41 AB, cf. anche Attico.<br />
33 <strong>Origene</strong> immagina qui che i giusti, che hanno compiuto fino in fondo la purificazione della loro anima<br />
in vita, <strong>di</strong>morino dopo la morte in uno spazio, costituito dalla sfera delle stelle fisse, nel quale essi si preparano<br />
a compiere il passaggio definitivo e la piena reintegrazione nel regno <strong>di</strong> Dio. Sarebbe <strong>di</strong> questo<br />
cielo delle stelle fisse, la terra <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1, cioè la terra promessa, la terra buona, la terra dei viventi, che,<br />
pur essendo essa per propria natura corruttibile, perché materiale, <strong>Origene</strong>, citando Rom 8, 20-21, <strong>di</strong>ce<br />
che è resa sempiterna dalla volontà <strong>di</strong> Dio.<br />
34 Nella Scrittura si allude a realtà visibili e temporali, fatte dalle mani <strong>di</strong> Dio, ma vi sono anche luoghi<br />
nei quali si parla <strong>di</strong> realtà non fatte da mani, eterne e non visibili. Siccome nulla nella Bibbia è detto a<br />
caso o è in contrad<strong>di</strong>zione, <strong>Origene</strong> suppone che vi siano realtà create che hanno queste caratteristiche.<br />
Per la stessa ragione <strong>di</strong>stingue le cose che non si vedono dalle cose invisibili.<br />
35 In conclusione, vi è un luogo nel cosmo che non è attualmente visibile agli occhi umani, si tratta <strong>di</strong> un<br />
luogo creato, corporeo, ma conservato da Dio nell’incorruttibilità; questo luogo è la terra che è stata<br />
creata nel giorno uno e che è stata promessa dalle Scritture come luogo <strong>di</strong> soggiorno dei giusti dopo la<br />
loro morte. Questa terra celeste è a sua volta racchiusa da un cielo, quello creato nel giorno uno, che<br />
15
II 9, 1 (Koet. pp. 163, 24-165, 16)<br />
[Creazione delle creature razionali]<br />
Ritorniamo ora alla successione degli argomenti della <strong>di</strong>scussione che ci siamo<br />
proposti e consideriamo l’inizio della creazione, per quanto sia possibile al nostro intelletto<br />
considerare quell’inizio della creazione <strong>di</strong> Dio 36.<br />
In quell’inizio, dunque, si deve ritenere che Dio abbia creato le creature razionali<br />
o intellettuali — o in quale altro modo si vogliano chiamare quelli che sopra abbiamo<br />
designato come “intelletti” — in numero tanto grande quanto egli vedeva ch’era sufficiente<br />
37. È certo, infatti, ch’egli le creò in un determinato numero che aveva predefinito<br />
fra sé; non si deve pensare, infatti, come vogliono alcuni, che le creature siano infinite,<br />
perché dove non c’è fine non vi può essere alcuna comprensione e alcuna determinazione.<br />
E se fosse così, le cose create non potrebbero essere contenute e amministrate da<br />
Dio. Per sua natura, infatti, tutto ciò che è infinito è anche incomprensibile 38.<br />
Invece, come <strong>di</strong>ce anche la Scrittura, “Dio ha fatto ogni cosa secondo numero e<br />
misura” (Sap 11, 20); perciò a ragione si applicherà il numero alle creature razionali, o<br />
segna il limite della creazione sensibile. Quando in Gv 17 Cristo <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> non essere <strong>di</strong> questo mondo, alluderebbe<br />
alla propria provenienza da questa terra dei giusti che si identifica con la sfera delle stelle fisse.<br />
<strong>Origene</strong> insiste sulla <strong>di</strong>fferenza tra ciò che non si vede e l’invisibile, perché sa che nelle Scritture non è<br />
mai detto esplicitamente che Dio è incorporeo, ma ritiene che l’equivalente scritturistico <strong>di</strong> questa nozione<br />
sia appunto quella <strong>di</strong> “invisibile”; cf. PA I praef. 9: «Quaeremus tamen si vel alio nomine res ipsa,<br />
quam Graeci philosophi 4>OL*%"' (id est incorporeum) <strong>di</strong>cunt, in sanctis scripturis invenitur. Deus quoque<br />
ipse quomodo intellegi debeat requirendum est, corporeum et secundum aliquem habitum deformatus,<br />
an alterius naturae quam corpora sunt, quod utique in prae<strong>di</strong>catione nostra manifeste non designatur.<br />
Eadem quoque etiam de Christo et de sancto spiritu requirenda sunt, sed et de omni anima atque omni<br />
rationabili natura nihilominus requirendum est». Sopra <strong>Filone</strong> Opif. 12 fa la stessa equivalenza fra invisibile<br />
e incorporeo/intelligibile.<br />
36 È unanime negli esegeti antichi l’affemazione che il racconto della creazione contiene un insegnamento<br />
straor<strong>di</strong>nariamente ricco e profondo, che solo in piccola parte è possibile esplicitare.<br />
37 <strong>Origene</strong> accoglie l’interpretazione filoniana <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1: la creazione del giorno uno si riferisce non alla<br />
produzione nel tempo del cielo e della terra che conosciamo noi, ma alla creazione degli esseri intelligibili,<br />
gli intelletti creati che solo in seguito alla caduta del peccato <strong>di</strong>venteranno anime e saranno dotate <strong>di</strong>o<br />
un corpo e inserite in un universo sensibile per la loro punizione ed educazione. Questa lettura <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1<br />
non mi sembra del tutto coerente con l’interpretazione fisico-cosmologica che ne è stata data nel passo del<br />
PA citato appena sopra: se <strong>Gen</strong> 1, 1 si riferisc alla creazione intelligibile, essa non ha certamente bisogno<br />
<strong>di</strong> un luogo fisico nel quale essere collocata.<br />
38 Di questo periodo è conservata anche la versione greca, riportata nella Lettera al patriarca Mena<br />
dell’imperatore Giustiniano (p. 164, 1-6 Koet.). Il testo presenta alcune significative varianti rispetto alla<br />
versione latina <strong>di</strong> Rufino: «Nel suo primo libro Sui principi, egli aggiunge anche questa alle proprie<br />
bestemmie, <strong>di</strong>cendo testualmente: “nel principio così pensato, Dio costituì con la propria volontà un numero<br />
<strong>di</strong> sostanze intellettive tanto grande quanto egli era in grado <strong>di</strong> governare; bisogna infatti <strong>di</strong>re che la<br />
potenza <strong>di</strong> Dio è limitata e non bisogna, con il pretesto della reverenza, toglierne la determinatezza. Se,<br />
infatti, la potenza <strong>di</strong> Dio fosse infinita, <strong>di</strong> necessità essa non potrebbe comprendere se stessa: l’infinito è<br />
infatti per propria natura incomprensibile”...». Rufino ha chiaramente attenuato queste affermazioni, per<br />
evitare <strong>di</strong> attribuire a Dio esplicitamente una potenza limitata: parla infatti della creazione <strong>di</strong> un numero<br />
sufficiente <strong>di</strong> creature razionali e assegna la determinatezza non alla potenza <strong>di</strong> Dio, ma al numero delle<br />
creature. Cf. sul tema della potenza limitata/illimitata <strong>di</strong> Dio anche PA IV 4, 8. Il problema è <strong>di</strong>scusso<br />
nella teologia platonica, cf. Proclo ET 93, che assegna all’infinito una connotazione negativa, perché è<br />
razionalmente afferrabile solo ciò che è determinato. In CC IV 63, infatti, <strong>Origene</strong> afferma che il male è<br />
una realtà priva <strong>di</strong> determinazione. Resta il problema <strong>di</strong> come conciliare queste affermazioni con gli argomenti<br />
svolti nel fr. <strong>di</strong> C<strong>Gen</strong> a proposito della capacità <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong> far esistere tutto ciò che vuole; in realtà,<br />
però, in questo testo <strong>Origene</strong> afferma solo che Dio può fare ciò che vuole, non che la sua volontà è<br />
indeterminata e illimitata. Quando parla della possibilità <strong>di</strong> comprendere solo ciò che è determinato, <strong>Origene</strong><br />
non si riferisce solo al pensiero <strong>di</strong>scorsivo, ma anche all’intellezione: IV 3, 14.<br />
16
intelletti, in modo ch’esse siano in numero tale, quante possono essere amministrate,<br />
governate e contenute dalla provvidenza <strong>di</strong> Dio.<br />
[Creazione della natura corporea]<br />
La misura, poi, si applicherà convenientemente alla materia dei corpi, che bisogna<br />
credere sia stata creata da Dio in quantità tale, quanta egli sapeva poteva bastargli<br />
per l’or<strong>di</strong>namento del mondo.<br />
[Interpretazione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1]<br />
Queste sono, dunque, le realtà che al principio, cioè prima <strong>di</strong> tutte le cose, si deve<br />
ritenere siano state create da Dio. Questo è anche ciò che riteniamo sia in<strong>di</strong>cato in<br />
quell’inizio che Mosè propone in termini alquanto nascosti, quando <strong>di</strong>ce: “in principio<br />
Dio creò il cielo e la terra” (<strong>Gen</strong> 1, 1). È certo, infatti, ch’egli non parla del firmamento,<br />
né della terra arida, ma <strong>di</strong> quel cielo e <strong>di</strong> quella terra dei quali questo cielo e questa terra<br />
che ve<strong>di</strong>amo hanno poi preso i nomi».<br />
III 5, 1 (Koet. pp. 271, 12-18)<br />
[Duplice senso del racconto della creazione]<br />
«Sul fatto che il mondo è stato creato, quale altra scrittura ci potrà istruire più <strong>di</strong><br />
quella che da Mosè è stata scritta a proposito della sua origine (<strong>Gen</strong> 1)? Essa, benché<br />
contenga insegnamenti più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> quelli che la narrazione storica sembra esporre,<br />
contenga in moltissimi punti un senso spirituale e si serva del velo della lettera per trattate<br />
argomenti profon<strong>di</strong> e mistici, cionon<strong>di</strong>meno il <strong>di</strong>scorso del narratore mostra che tutte<br />
le cose visibili sono state create in un momento determinato del tempo».<br />
III 6, 8-9 (Koet. pp. 289, 23-291, 5)<br />
«[8] È ora il momento <strong>di</strong> esaminare se allora, quando “Dio sarà tutto in tutti” (1<br />
Cor 15, 28), nel compimento <strong>di</strong> tutte le cose, la totalità della natura corporea avrà un unico<br />
aspetto e se ogni sua qualità si risolverà in quella soltanto che risplenderà<br />
nell’in<strong>di</strong>cibile gloria che si deve credere apparterrà al corpo spirituale. Se, infatti, inten<strong>di</strong>amo<br />
bene quello che Mosè scrive all’inizio del proprio libro, quando <strong>di</strong>ce: “In principio<br />
Dio creò il cielo e la terra” (<strong>Gen</strong> 1, 1), che cioè questo è il principio dell’intera creazione,<br />
allora è opportuno riportare a questo principio anche la fine e il compimento <strong>di</strong><br />
tutte le cose, in modo tale che quel cielo e quella terra siano la <strong>di</strong>mora e il luogo <strong>di</strong> riposo<br />
dei pii; così che per primi abbiano in ere<strong>di</strong>tà quella terra i santi e i mansueti, poiché<br />
proprio questo è ciò che insegnano la legge, i profeti e il vangelo (Dt 4, 38; Sal 36, 11;<br />
Mt 5, 5) 39.<br />
In questa terra ritengo che si trovino le forme vere e viventi <strong>di</strong> quelle prescrizioni<br />
che Mosè trasmetteva me<strong>di</strong>ante l’ombra della legge (Ebr 10, 1). Di loro infatti è detto<br />
39 Nella realtà attuale, il corpo è dotato <strong>di</strong> una molteplicità <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> aspetti, in proporzione allo stato<br />
spirituale delle creature che in esso <strong>di</strong>morano. Quando tutte le creature razionali avranno raggiunto<br />
nuovamente la perfezione originaria, che cosa ne sarà della varietà dei corpi e delle loro qualità? Una possibile<br />
risposta è che tutte avranno un corpo glorioso identico e dotato delle medesime caratteristiche (il<br />
che pone almeno implicitamente il problema della conservazione delle caratteristiche in<strong>di</strong>viduali nella<br />
con<strong>di</strong>zione escatologica e spiega perché successivi sviluppi dell’origenismo hanno portato alla dottrina<br />
dei corpi sferici). A partire dal principio che la fine coincide con l’inizio, <strong>Origene</strong> esamina la questione<br />
accennando al significato <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1: la tera <strong>di</strong> qui là si parla è quella terra buona promessa dalle Scritture<br />
nella quale avranno <strong>di</strong>mora i santi.<br />
17
che “servono all’immagine e all’ombra delle realtà celesti” (Ebr 8, 5), coloro, cioè, che<br />
servivano sotto la legge. Ma anche allo stesso Mosè era stato detto: “Ve<strong>di</strong> <strong>di</strong> fare ogni<br />
cosa secondo la forma e la somiglianza che ti è stata mostrata sul monte” (Es 25, 40).<br />
Perciò mi sembra che, come su questa nostra terra le legge è stata un pedagogo (Gal 3,<br />
24) <strong>di</strong> coloro che dovevano da essa essere condotti al Cristo, in modo che, dopo<br />
l’educazione ricevuta me<strong>di</strong>ante la legge, potessero più facilmente ricevere le più perfette<br />
istruzioni del Cristo, così anche quella terra, accogliendo tutti i santi, prima li impregna<br />
e li conforma me<strong>di</strong>ante la <strong>di</strong>sciplina della legge vera ed eterna, in modo tale ch’essi possano<br />
assoggettarsi più facilmente anche a quelle istruzioni perfette del cielo, alle quali<br />
non può essere aggiunto alcunché; in quel cielo ci saranno in verità quel vangelo che è<br />
detto eterno (Apoc 14, 6) e quell’alleanza sempre nuova (Ebr 9, 15; 12, 24), che non <strong>di</strong>venterà<br />
mai vecchia (Ebr 8, 13) 40.<br />
[9] Si deve pertanto ritenere che nel compimento e nella reintegrazione <strong>di</strong> tutte le<br />
cose avvenga questo, in modo tale che, progredendo e innalzandosi un poco per volta,<br />
secondo misura e or<strong>di</strong>ne, esse giungano a quella terra e all’educazione che in essa si<br />
trova e per mezzo della quale possano essere preparate alle istruzioni migliori e tali che<br />
ad esse non si possa aggiungere più nulla. Infatti, dopo gli amministratori e i tutori (Gal<br />
4, 2), Cristo Signore, che è il re <strong>di</strong> tutte le cose, riceverà egli stesso il regno, cioè, dopo<br />
l’educazione impartita dalle sante potenze, istruirà egli stesso coloro che sono in grado<br />
<strong>di</strong> accoglierlo in quanto sapienza, regnando in loro fino a quando li sottoporrà al Padre<br />
che “gli ha sottomesso ogni cosa” (1 Cor 15 27-28), in modo tale che, quando essi saranno<br />
<strong>di</strong>venuti capaci <strong>di</strong> Dio, per loro “Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 28). In quel<br />
momento, <strong>di</strong> conseguenza, anche la natura corporea riceverà quella con<strong>di</strong>zione suprema<br />
alla quale non vi sarà ormai più nulla da aggiungere 41.<br />
Discussi in questi termini lo statuto della natura corporea o del corpo spirituale,<br />
lasciamo alla decisione del lettore <strong>di</strong> scegliere fra le due soluzioni quale giu<strong>di</strong>cherà la<br />
migliore. Noi qui poniamo termine al terzo libro».<br />
40 Come ci sono due terre, la nostra, il suolo arido e la terra creata in principio, così ci sono due fasi<br />
dell’economia salvifica: gli uomini che <strong>di</strong>morano sul suolo arido sono stati portati dalla Legge scritta da<br />
Mosè, le cui prescrizioni sono immagini della vera Legge, come da un pedagogo alla conoscenza del<br />
Vangelo. Grazie al Vangelo, i giusti raggiungono la vera terra, quella creata al principio, dove ricevono<br />
l’istruzione e l’educazione offerta dalla Legge vera ed eterna, che li prepara ad accogliere l’Evangelo<br />
eterno, che non sarà più superato da nulla, nel cielo vero, quello creato in principio.<br />
41 <strong>Origene</strong> sta qui considerando una ipotesi secondo la quale, nello stato escatologico, le creature, perfettamente<br />
riconciliate con il Padre e sottoposte alla sovranità del Cristo, saranno da lui consegnate al Padre,<br />
raggiungendo la perfetta reintegrazione finale, in uno stato identico alla beatitu<strong>di</strong>ne delle origini. In<br />
questo stato finale, è possibile ammettere che le creature conservino una forma <strong>di</strong> corporeità, che non ha<br />
tuttavia nulla a che vedere con la corporeità che ne caratterizza la con<strong>di</strong>zione terrestre. L’altra ipotesi alla<br />
quale fa cenno è quella <strong>di</strong> una completa abolizione della con<strong>di</strong>zione corporea<br />
18
«Nel principio era il Verbo»<br />
[Il termine “principio” ha molti significati]<br />
Commento al vangelo <strong>di</strong> Giovanni<br />
(libro I)<br />
Cap. 16<br />
90. Non solo i greci affermano che sono molte le cose significate dal termine<br />
“principio”; infatti, se uno volesse considerare questo nome raccogliendo passi da ogni<br />
luogo e, esaminando attentamente, volesse capire in ciascun luogo delle Scritture a quale<br />
realtà esso è stato attribuito, troverà che anche la parola <strong>di</strong>vina attesta il carattere polisemico<br />
<strong>di</strong> questo termine.<br />
[Principio come inizio spaziale]<br />
91. Un significato, infatti, è riferito a un passaggio, cioè si riferisce a una strada<br />
e a una <strong>di</strong>stanza; come è <strong>di</strong>mostrato dal versetto: «Principio <strong>di</strong> una via buona è fare cose<br />
giuste» 1. Essendo, infatti, la «via buona» gran<strong>di</strong>ssima, all’inizio bisogna intendere che si<br />
trova la parte pratica, che è presentata me<strong>di</strong>ante il «fare le cose giuste», mentre in seguito<br />
si trova la parte contemplativa 2, nella quale ritengo che si concluda anche il suo fine,<br />
in quella che viene chiamata “apocatastasi”, dal momento che allora non rimarrà più alcun<br />
nemico, per lo meno se è vera l’affermazione: «bisogna che egli regni fino a quando<br />
[il Padre] ponga tutti i suoi nemici sotto i suoi pie<strong>di</strong>; come ultimo nemico sarà annientata<br />
la morte» 3. 92. Allora, infatti, una sola sarà l’attività <strong>di</strong> coloro che sono giunti a Dio<br />
me<strong>di</strong>ante la Parola che è presso <strong>di</strong> Lui: contemplare Dio, affinché vengano a trovarsi<br />
nella conoscenza del Padre – avendo preso tutti esattamente la forma del Figlio – al modo<br />
in cui ora soltanto il Figlio conosce il Padre 4. 93. Se, infatti, si indagasse <strong>di</strong>ligentemente<br />
quando conosceranno il Padre coloro ai quali lo rivela il Figlio 5, che conosce il<br />
1 Prov. 16, 7 (LXX).<br />
2 La <strong>di</strong>stinzione della filosofia in due domini fondamentali, quello dell’azione e quello della contemplazione,<br />
è tra<strong>di</strong>zionale nella filosofia ellenistica e nel platonismo <strong>di</strong> età imperiale. <strong>Origene</strong> sviluppa l’idea <strong>di</strong><br />
un processo che va dalla formazione etica all’esperienza contemplativa, che ne è il compimento, poiché<br />
ha per oggetto le verità più profonde, anche in altri luoghi, p.e. il commento al Cantico dei Cantici. Cf.<br />
qui il § 208, dove <strong>di</strong>stingue le dottrine etiche e i teoremi mistici.<br />
3 1Cor. 15, 25. Il termine “apocatastasi” (ristabilimento, reintegrazione, restaurazione) si trova anche in<br />
At. 3, 20-21. La fine del mondo coincide con il ristabilimento della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> tutte le creature nel loro<br />
stato originario: la fine coincide con il principio. Lo stato originarioa è quello <strong>di</strong> creature incorporee, immanenti<br />
al Logos e immerse nella contemplazione del Padre. Dal momento che il cosmo materiale è stato<br />
creato come strumento della pedagogia <strong>di</strong> Dio nei confronti delle creature decadute, quando tale processo<br />
sarà concluso, il cosmo non sarà più necessario e Dio «sarà tutto in tutti». La prospettiva origeniana (<strong>di</strong>scussa<br />
soprattutto in De princ. II 3, 5; III 6, 1) pone dei problemi, dei quali <strong>Origene</strong> stesso è consapevole.<br />
Questa coincidenza della fine con il principio significa che anche nella con<strong>di</strong>zione escatologica le creature<br />
razionali saranno soggette a quell’instabilità del loro libero volere dalla quale è stata provocata la loro<br />
caduta originaria e che, perciò, il movimento <strong>di</strong> creazione, caduta e redenzione è ciclico?<br />
4 Il testo del passo non è sicuro. Si può anche tradurre (ma mi sembra meno probabile): «Affinché <strong>di</strong>ventino<br />
tutti precisamente Figlio, essendosi così trasformati in virtù della conoscenza del Padre, al modo in<br />
cui ora soltanto il Figlio conoscen il Padre». Il senso è comunque abbastanza chiaro: nella con<strong>di</strong>zione finale<br />
tutte le creature razionali si troveranno in uno stato <strong>di</strong> assimilazione al Verbo e saranno quin<strong>di</strong> in<br />
grado <strong>di</strong> godere <strong>di</strong>una conoscenza del Padre analoga a quella della quale ora soltanto il Figlio è dotato,<br />
perché saranno unite in<strong>di</strong>ssolubilmente a Lui, quasi a formare un’unica realtà con Lui.<br />
5 Mt. 11, 27.<br />
1
Padre, e se si osservasse che ora colui che guarda guarda «attraverso uno specchio e in<br />
modo enigmatico» 6, dal momento che ancora non ha conosciuto «al modo in cui si deve<br />
conoscere» 7, non ci si sbaglierebbe <strong>di</strong>cendo che nessuno, anche se apostolo o profeta, ha<br />
conosciuto il Padre, ma che lo conosceranno quando saranno <strong>di</strong>ventati una cosa sola,<br />
come il Padre e il Figlio sono una cosa sola 8.<br />
94. Se a qualcuno sembrasse che, chiarendo un solo significato del principio, abbiamo<br />
fatto una <strong>di</strong>gressione, dal momento che abbiamo detto anche queste cose, bisogna<br />
mostrargli che la <strong>di</strong>gressione era necessaria e utile al nostro proposito.<br />
Se, infatti, un “principio” può essere come il principio <strong>di</strong> un passaggio, sia <strong>di</strong> una<br />
via, sia <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza, e «principio <strong>di</strong> una via buona è il fare cose giuste» 9, si può sapere<br />
se 10 ogni via buona abbia in qualche modo come principio «il fare cose giuste» e se<br />
dopo il principio essa abbia la contemplazione e in che modo abbia la contemplazione.<br />
[Principio come inizio temporale]<br />
Cap. 17<br />
95. È però un principio anche quello <strong>di</strong> una generazione, che potrebbe mostrarsi<br />
nel passo «In principio Dio fece il cielo e la terra» 11; penso, però, che questo significato<br />
venga espresso in modo più evidente in Giobbe, nel versetto «Esso è il principio<br />
dell’opera plasmatrice del Signore, fatto per essere schernito dai suoi angeli» 12.<br />
96. Si potrebbe supporre che, «al principio» delle cose che si trovano nella generazione<br />
del cosmo siano stati fatti «il cielo e la terra»; ma è meglio pensare, conformemente<br />
al secondo detto, che, essendo molte le cose che si sono venute a trovare nei corpi,<br />
primo delle creature poste in un corpo sia quello che è chiamato “drago” e che da<br />
qualche parte è chiamato anche «grande mostro marino», che il Signore ha soggiogato 13.<br />
97. Ed è necessario conoscere se, quando i santi vivevano una vita del tutto immateriale<br />
e incorporea nella beatitu<strong>di</strong>ne, quello che è chiamato “drago”, essendo decaduto<br />
dalla vita pura, sia stato degno prima <strong>di</strong> tutti <strong>di</strong> essere legato alla materia e a un<br />
corpo 14, così che per questa ragione il Signore, rispondendo attraverso la tempesta e le<br />
nubi, <strong>di</strong>ce: «Esso è il principio dell’opera plasmatrice 15 del Signore, fatto per essere<br />
schernito dai suoi angeli» 16.<br />
6 1Cor. 13, 12.<br />
7 1Cor. 8, 2.<br />
8 Gv. 17, 21.<br />
9 Prov. 16, 7 (LXX).<br />
10 Il testo non è sicuro; alcuni e<strong>di</strong>tori lo correggono.<br />
11 <strong>Gen</strong>. 1, 1.<br />
12 Gb. 40, 19 (LXX). Il testo si riferisce all’ippopotamo (behemot), inteso come prototipo <strong>di</strong> una creatura<br />
brutale e mostruosa.<br />
13 Gb. 3, 8.<br />
14 Gd. 6; 2Pt. 2, 4.<br />
15 <strong>Origene</strong> <strong>di</strong>stingue la creazione (ktisis) degli esseri intelligibili, dalla plasmazione (plasma) del mondo<br />
materiale, che è successiva alla loro caduta nel peccato e ha finalità puntive e me<strong>di</strong>cinali.<br />
16 Il <strong>di</strong>scorso svolto qui da <strong>Origene</strong> concerne il <strong>di</strong>avolo, inteso come principio – cioè inizio – della generazione<br />
del mondo materiale: secondo <strong>Origene</strong> vi è omogeneità fra tutte le creature razionali, angeli, uomini<br />
e demoni, e tutte in origine avevano la medesima con<strong>di</strong>zione (che sarà anche quella finale). Le <strong>di</strong>fferenze<br />
nella con<strong>di</strong>zione attuale, legate alla <strong>di</strong>versa collocazione nel mondo sensibile, <strong>di</strong>pendono dalla <strong>di</strong>versa<br />
gravità della colpa originaria.<br />
2
98. È però possibile che il drago non sia in assoluto il principio dell’opera plasmatrice<br />
del Signore, ma che, essendo state create in un corpo molte creature «per essere<br />
schernite dagli angeli», esso sia il principio soltanto <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> questo tipo, dal momento<br />
che è possibile ve ne siano anche altre che si trovano in un corpo, ma non in questo<br />
modo: anche l’anima del sole, infatti, si trova in un corpo, così pure tutta la creazione<br />
della quale l’apostolo <strong>di</strong>ce: «Tutta la creazione soffre e geme fino ad ora nelle doglie»<br />
17. 99. E forse si riferisce ad essa il passo «La creazione è stata sottomessa alla vanità<br />
non per suo volere, ma a causa <strong>di</strong> colui che l’ha sottomessa con la speranza» 18, in<br />
modo tale che la vanità siano i corpi e il fare le cose riguardanti i corpi, il che è necessario<br />
****. Colui che si trova in un corpo, fa le cose riguardanti il corpo non per proprio<br />
volere; per questo la creazione è stata sottomessa non per suo volere alla vanità. 100. E<br />
colui che non per proprio volere fa le cose riguardanti il corpo, ciò che fa lo fa per la<br />
speranza, come se <strong>di</strong>cessimo che Paolo vuole «rimanere nella carne» non per sua volontà,<br />
ma a causa della speranza; pur preferendo, infatti, <strong>di</strong> per sé, «sciogliersi ed essere<br />
con Cristo», non era irrazionale che egli volesse «rimanere nella carne», per il vantaggio<br />
degli altri e il progresso nelle cose sperate, non solo suo, ma anche <strong>di</strong> coloro che da lui<br />
avrebbero tratto beneficio 19.<br />
101. Secondo questo significato del principio come principio <strong>di</strong> una generazione,<br />
potremo anche comprendere ciò che viene detto dalla sapienza nei Proverbi; <strong>di</strong>ce infatti:<br />
«Dio mi ha creato come principio delle sue vie in vista delle sue opere» 20. Si può ricondurre<br />
questa affermazione anche al primo significato, cioè a quello del principio <strong>di</strong> una<br />
via, perché si <strong>di</strong>ce: «Dio mi ha creato come principio delle sue vie».<br />
102. Non è neppure assurdo se si <strong>di</strong>rà che il Dio <strong>di</strong> tutte le cose è chiaramente un<br />
principio, giu<strong>di</strong>cando che principio del Figlio è il Padre e principio delle creature è il<br />
Creatore e, in assoluto, principio degli esseri è Dio. Si potrà argomentare questa affermazione<br />
me<strong>di</strong>ante il passo: «Nel principio era la Parola», intendendo con “Parola” il Figlio,<br />
che viene detto essere «nel principio» per il fatto che è nel Padre 21.<br />
[Principio come materia preesistente]<br />
103. Terzo significato è il principio inteso come “ciò da cui”, come il provenire<br />
da una materia soggiacente, per coloro che considerano la materia ingenita, ma non per<br />
noi, che siamo persuasi che Dio fece le cose che sono a partire da ciò che non era, come<br />
ci hanno insegnato la madre dei sette martiri nei libri dei Maccabei e l’angelo della conversione<br />
nel Pastore 22.<br />
17 Rom. 8, 22. Che gli astri siano animati e siano dotati <strong>di</strong> un’anima migliore <strong>di</strong> quella umana, cioè meno<br />
esposta <strong>di</strong> quella umana a lasciarsi <strong>di</strong>strarre e indurre al <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne dalle passioni e dal contatto con la materia,<br />
è dottrina largamente con<strong>di</strong>visa al tempo <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>. Plat. Leg. 898 E-899A; Phil. Alex. De opif. 73.<br />
Orig. C. Cels. V 11 afferma che gli astri pregano il Padre per mezzo del Figlio.<br />
18 Rom. 8, 20. La stessa interpretazione del corpo come “vanità” si trova in De princ. I 1, 5, p. 20, 15-19;<br />
7, 5, p. 92, 8-11 Koet.<br />
19 Fil. 1, 23-24. NB emerge qui la finalità educativa della creazione materiale: essa è orientata a favorire il<br />
progresso delle creature decadute a causa del peccato.<br />
20 Prov. 8, 22. <strong>Origene</strong> legge in questo testo una <strong>di</strong>chiarazione relativa alla generazione del Figlio da parte<br />
del Padre. Tale generazione inaugura, per così <strong>di</strong>re, l’attività <strong>di</strong> Dio che si esplica nella creazione intelligibile,<br />
realizzata per la me<strong>di</strong>azione del Figlio, che è sapienza e parola del Padre.<br />
21 Quest’ultima affermazione mi persuade poco: se si sta ragionando del principio inteso come generazione,<br />
Gv. 1, 1 non mi sembra adatto a fondare questa spiegazione, perché sembra insistere più<br />
sull’immanenza del Figlio nel Padre, che sulla sua generazione dal Padre.<br />
22 2Mac. 7, 28. Herm. Past., Mand. I 1; Vis. I 1, 16. NB L’uso della formula proposizionale (tò ex ou) per<br />
in<strong>di</strong>care il principio materiale. Che la materia sia cooriginaria è dottrina largamente attestata nel platoni-<br />
3
[Principio come forma]<br />
104. Oltre a questi significati, principio è anche il “ciò secondo cui” 23, cioè secondo<br />
la forma, in questo modo: se immagine del Dio invisibile è il primogenito <strong>di</strong> tutta<br />
la creazione, suo principio è il Padre. Allo stesso modo, anche Cristo è principio delle<br />
cose generate secondo l’immagine <strong>di</strong> Dio. 105. Se, infatti, gli uomini sono «secondo<br />
l’immagine», e l’immagine è secondo il Padre, il “ciò secondo cui” del Cristo è il Padre,<br />
mentre il “ciò secondo cui” degli uomini è il Cristo, dal momento che essi sono generati<br />
non secondo colui del quale egli è immagine, ma secondo l’immagine: a questa medesima<br />
<strong>di</strong>mostrazione si adatterà bene anche il passo «Nel principio era la Parola» 24.<br />
[Principio come elemento <strong>di</strong> una scienza]<br />
Cap. 18<br />
106. C’è anche il principio inteso come principio <strong>di</strong> una conoscenza acquisita, al<br />
modo in cui <strong>di</strong>ciamo che le lettere sono i principi della scrittura [o della grammatica?].<br />
Secondo questo significato l’apostolo <strong>di</strong>ce: «Pur dovendo essere maestri a causa del<br />
tempo che è passato, <strong>di</strong> nuovo avete bisogno che qualcuno vi insegni gli elementi del<br />
principio degli oracoli <strong>di</strong> Dio» 25. 107. Il principio, inteso come principio <strong>di</strong> una conoscenza<br />
acquisita, è duplice: o per natura o in relazione a noi 26. Come se <strong>di</strong>cessimo, nel<br />
caso <strong>di</strong> Cristo, che per natura il suo principio è la <strong>di</strong>vinità, ma in relazione a noi che, per<br />
la sua grandezza, non siamo capaci <strong>di</strong> incominciare dalla verità che lo concerne, è principio<br />
la sua umanità, ragion per cui agli infanti viene annunciato Gesù Cristo e questi<br />
crocifisso 27.Sicché da questo punto <strong>di</strong> vista si può <strong>di</strong>re che principio della scienza è per<br />
smo <strong>di</strong> età imperiale, che la ricava dalla dottrina timaica dei principi: demiurgo, para<strong>di</strong>gma, chora (= materia).<br />
Interessante anche il ricorso a due testi dei quali uno accolto nel canone delle scritture - sia pure assente<br />
da quello ebraico - e uno che invece è finito fuori del canone, ma ai tempi <strong>di</strong> <strong>Origene</strong> gode ancora <strong>di</strong><br />
una vatsa <strong>di</strong>ffusione e autorevolezza.<br />
23 Seguendo la partizione aristotelica delle quattro cause, alla causa materiale (ciò da cui qualcosa è fatto),<br />
segue ora la causa formale (ciò in virtù del quale una determinata cosa è precisamente quella cosa e non<br />
un’altra: tò kath’ho). La causa formale aristotelica viene fatta coincidere dai platonici <strong>di</strong> età imperiale con<br />
la forma platonica, l’idea, il principio trascendente e separato per la partecipazione al quale le cose sensibili<br />
sono ciò che sono. <strong>Origene</strong> in<strong>di</strong>vidua una gerarchia <strong>di</strong>scendente che richiama quella <strong>di</strong> Numenio: il<br />
Padre è principio formale del Figlio (quest’ultimo infatti è immagine del Padre, secondo Colossesi); gli<br />
uomini sono fatti «ad immagine <strong>di</strong> Dio», cioè “secondo l’immagine, conformemente all’immagine <strong>di</strong><br />
Dio”, che è il Figlio; sono cioè immagini <strong>di</strong> un’immagine.<br />
24 <strong>Origene</strong> sviluppa l’interpretazione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong>. 1, 26, in cui si <strong>di</strong>ce che Dio crea l’uomo «a immagine e somiglianza»<br />
<strong>di</strong> se stesso. Nella traduzione greca il testo è kat’eikôna = secondo l’immagine, in modo conforme<br />
all’immagine <strong>di</strong> Dio. Dal momento che immagine <strong>di</strong> Dio, secondo Ebr., è Cristo, l’uomo è creato<br />
conforme al Verbo <strong>di</strong> Dio, è perciò, per così <strong>di</strong>re, immagine dell’immagine. La dottrina platonica<br />
dell’immagine in<strong>di</strong>ca un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> successione nell’essere: ciò che è immagine è derivato e secondario rispetto<br />
al modello <strong>di</strong> cui è immagine; ma in<strong>di</strong>ca anche una relazione reale: l’immagine porta in verità in sé<br />
qualcosa del modello, nel senso che svolge, in un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> realtà <strong>di</strong>verso, la stessa funzione svolta dal<br />
modello in un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> realtà superiore.<br />
25 Ebr. 5, 12.<br />
26 Si può venire a conoscenza <strong>di</strong> qualcosa così come essa è in se stessa, nella propria natura, o così come è<br />
capace <strong>di</strong> apprenderla il soggetto conoscente.<br />
27 1Cor. 2, 2. Ciò che conosciamo per primo <strong>di</strong> Cristo è il suo essere uomo, ma questo è in realtà secondario<br />
e successivo al suo essere <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>vina, che noi, tuttavia, appren<strong>di</strong>amo solo in un secondo momento.<br />
4
natura Cristo in quanto sapienza e potenza <strong>di</strong> Dio 28, ma in relazione a noi lo è «la Parola<br />
si è fatta carne», per mettere la sua tenda fra <strong>di</strong> noi, che soltanto in questo modo siamo<br />
capaci <strong>di</strong> accoglierLa in un primo momento. 108. E forse per questo egli non è solo<br />
primogenito <strong>di</strong> tutta la creazione, ma anche «Adamo», che significa “uomo”. Che è Adamo<br />
lo <strong>di</strong>ce Paolo: «L’ultimo Adamo come spirito vivificante» 29.<br />
[Principio come principio <strong>di</strong> un’azione]<br />
Si può intendere un principio anche come principio <strong>di</strong> un’azione, nella quale azione<br />
si trova anche un fine dopo il principio. E considera se la sapienza, dal momento<br />
che è principio delle azioni <strong>di</strong> Dio, non possa essere intesa come principio in questo<br />
senso 30.<br />
[Applicazione al testo]<br />
Cap. 19<br />
Essendosi dunque presentati al momento a noi tanti significati in relazione al<br />
principio, cerchiamo in relazione a quale <strong>di</strong> essi vada preso il passo «In principio era la<br />
parola».<br />
Ed è chiaro che esso non va inteso in relazione al principio come principio <strong>di</strong> un<br />
passaggio, o come principio <strong>di</strong> una via o una <strong>di</strong>stanza; è anche evidente che non va inteso<br />
nemmeno come principio <strong>di</strong> una generazione 31. 110. D’altra parte, è possibile che sia<br />
da intendere come “ciò per opera del quale”, che è l’agente, se è vero che «Dio comandò<br />
e furono creati» 32. In un certo modo, infatti, Cristo è demiurgo; per mezzo <strong>di</strong> lui il<br />
Padre <strong>di</strong>ce: «Sia la luce» 33 e «Sia il firmamento» 34. 111. Cristo, inoltre, è demiurgo in<br />
qualità <strong>di</strong> principio, in quanto è sapienza, poiché è chiamato principio per il fatto <strong>di</strong> essere<br />
sapienza. La sapienza, infatti, <strong>di</strong>ce in Salomone: «Dio mi ha creato come principio<br />
delle sue vie in vista delle sue opere» 35, così che «nel principio» sia «la Parola», cioè<br />
nella sapienza. La sapienza è intesa nella costituzione della visione <strong>di</strong> tutte le cose e del<br />
28 1Cor. 1, 24.<br />
29 1Cor. 15, 45.<br />
30 Questo significato non è tanto lontano da quello <strong>di</strong>scusso trattando del principio inteso come generazione:<br />
in entrambi i casi è il processo temporale che viene messo in evidenza, solo che nel caso della generazione<br />
esso realizza la produzione <strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinto dal soggetto generante/creante, mentre qui si<br />
tratta solo del compimento <strong>di</strong> un’azione.<br />
31 La cosa a noi può sembrare meno evidente che a <strong>Origene</strong>: penso si possa intendere che i due significati<br />
esclusi sono in relazione con processi temporali [ghénesis va forse tradotto “<strong>di</strong>venire” piuttosto che “generazione”?],<br />
mentre il <strong>di</strong>scorso del prologo giovanneo si riferisce a una situazione anteriore alla generazione<br />
del mondo materiale e quin<strong>di</strong> del tempo e dello spazio.<br />
32 Sal. 148, 5. <strong>Origene</strong> completa così la serie delle quattro cause descritte da Aristotele nella Metafisica:<br />
causa efficiente (ciò per opera del quale - qualcosa è fatto), causa materiale (ciò da cui - qualcosa è fatto),<br />
causa formale (ciò in conformità con cui - qualcosa è fatto); quest’ultima coincide <strong>di</strong> fatto anche con la<br />
causa finale (il télos), <strong>di</strong> cui si trova un cenno nel § 108.<br />
33 <strong>Gen</strong>. 1, 3.<br />
34 <strong>Gen</strong>. 1, 6.<br />
35 Prov. 8, 22.<br />
5
loro pensiero, mentre la parola è intesa nella comunicazione agli esseri razionali delle<br />
realtà oggetto <strong>di</strong> visione 36.<br />
112. E non ci si deve meravigliare se, come abbiamo detto prima, essendo il Salvatore<br />
molti beni che si possono considerare in lui, ha in se stesso beni primi, secon<strong>di</strong> e<br />
terzi. Giovanni, parlando della Parola, ha infatti aggiunto: «Ciò che fu fatto in lui era vita»<br />
37. La vita fu dunque fatta nella Parola. Né la Parola è altro rispetto al Cristo, la Parola<br />
Dio, che è verso il Padre e per mezzo della quale tutte le cose sono state fatte, né la<br />
vita è altro rispetto al Figlio <strong>di</strong> Dio, che <strong>di</strong>ce: «Io sono la via, la verità e la vita» 38. Come<br />
dunque la vita è stata fatta nella parola, così «la parola era nel principio».<br />
113. Considera se è possibile che compren<strong>di</strong>amo secondo questo significato<br />
l’espressione «Nel principio era la parola», in modo tale che tutte le cose siano state fatte<br />
secondo la sapienza e le impronte del complesso delle nozioni che si trovano in essa.<br />
114. Ritengo, infatti, che come una casa o una nave vengono costruite secondo i<br />
piani dell’architetto e la casa e la nave hanno come principio i piani e le regole che si<br />
trovano nell’architetto, così tutte le cose sono state fatte secondo le ragioni <strong>di</strong> tutte le<br />
cose future, manifestate da Dio nella sapienza, «Egli, infatti, ha fatto ogni cosa nella sapienza»<br />
39. 115. E bisogna <strong>di</strong>re che, avendo creato, per così <strong>di</strong>re, una sapienza vivente, le<br />
prescrisse <strong>di</strong> conferire agli esseri e alla materia conformazione e forma a partire da se<br />
stessa e, aggiungo, anche l’essere.<br />
116. Non è dunque <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>re, in modo più grossolano, che principio degli esseri<br />
è il Figlio <strong>di</strong> Dio, che <strong>di</strong>ce: «Io sono il principio e la fine, l’alfa e l’omega, il primo<br />
e l’ultimo» 40. È necessario, però, sapere ch’egli non è principio secondo tutti i nomi con<br />
i quali è chiamato. 117. Infatti, come può essere principio in quanto è vita, la quale vita<br />
è venuta all’essere nella parola, che manifestamente ne è perciò il principio? Ancor più<br />
chiaramente egli non può essere principio in quanto «primogenito dai morti» 41. 118. Se<br />
esaminiamo attentamente tutte le sue denominazioni, egli è principio soltanto secondo il<br />
suo essere sapienza, dal momento che non è principio nemmeno in quanto è parola, se è<br />
vero che «la parola era nel principio». Sicché si potrebbe <strong>di</strong>re con un certo ar<strong>di</strong>mento<br />
che la più antica <strong>di</strong> tutte le denominazioni espresse me<strong>di</strong>ante i nomi del primogenito <strong>di</strong><br />
tutta la creazione è la sapienza.<br />
Cap. 20<br />
119. Dio è dunque assolutamente uno e semplice. Il nostro Salvatore, a causa<br />
della molteplicità, dal momento che «Dio lo ha stabilito come propiziatorio» 42 e primizia<br />
<strong>di</strong> tutta la creazione, <strong>di</strong>venta molte cose o forse tutte quelle secondo le quali lo invo-<br />
36 L’interpretazione cristologica dell’«in principio» ha un fondamento testuale in Prov 8, 22 citato da <strong>Origene</strong><br />
e in altri passi nei quali la sapienza (identificata dai cristiani con il Cristo, che è sapienza del Padre)<br />
è ipostatizzata e in<strong>di</strong>cata come me<strong>di</strong>atrice dell’opera della creazione; ma ha anche un fondamento grammaticale:<br />
l’espressione greca !" #$%& traduce l’ebraico bereshit, ma la preposizione be può avere valore<br />
temporale, strumentale, causale.<br />
37 Gv. 1, 4.<br />
38 Gv. 14, 6.<br />
39 Sal. 103 (104), 24.<br />
40 Apoc. 22, 13.<br />
41 Col 1, 18.<br />
42 Rom 3, 25.<br />
6
ca la creazione intera che può essere liberata. 120. E per questo egli <strong>di</strong>viene luce degli<br />
uomini, quando gli uomini, ottenebrati dalla malvagità, hanno bisogno della luce che<br />
splende nelle tenebre e che le tenebre non comprendono; se gli uomini non fossero venuti<br />
a trovarsi nelle tenebre, egli non sarebbe <strong>di</strong>venuto la luce degli uomini. 121. Lo<br />
stesso bisogna intendere anche del fatto ch’egli è primogenito dai morti. Se, infatti, per<br />
ipotesi la donna non fosse stata ingannata e Adamo non fosse caduto, l’uomo creato per<br />
l’incorruttibilità avrebbe conservato l’incorruttibilità e il Cristo non sarebbe <strong>di</strong>sceso «in<br />
polvere <strong>di</strong> morte» e non sarebbe morto, non esistendo il peccato a causa del quale bisognò<br />
ch’egli, per il suo amore per l’uomo, morisse. E non avendo compiuto queste cose,<br />
non sarebbe <strong>di</strong>venuto «primogenito dai morti».<br />
122. Si deve esaminare poi se sarebbe <strong>di</strong>ventato pastore, qualora l’uomo non si<br />
fosse reso paragonabile «alle bestie senza inten<strong>di</strong>mento e non si fosse reso simile a loro»<br />
43. Se, infatti, «Dio salva uomini e bestie» 44, salva le bestie che salva donando loro un<br />
pastore, dal momento ch’esse non sono in grado <strong>di</strong> ricevere un re. 123. Bisogna dunque<br />
esaminare, una volta radunati gli epiteti del Figlio, quali <strong>di</strong> questi sono sopravvenuti,<br />
non essendosi prodotti in quella quantità se i santi avessero iniziato e fossero rimasti<br />
nella beatitu<strong>di</strong>ne. Forse infatti rimarrebbe solo il nome <strong>di</strong> Sapienza o anche quelli <strong>di</strong><br />
Logos, Vita e certamente quello <strong>di</strong> Verità; ma non certo tutti gli altri che ha assunto a<br />
causa nostra.<br />
124. E beati sono coloro che, avendo bisogno del Figlio <strong>di</strong> Dio, sono <strong>di</strong>venuti tali<br />
da non aver più bisogno <strong>di</strong> lui come me<strong>di</strong>co che cura i malati, né come pastore o come<br />
redenzione, bensì come sapienza, logos e giustizia o se vi è un altro nome adatto a coloro<br />
che per la loro perfezione sono capaci <strong>di</strong> accogliere <strong>di</strong> lui gli aspetti migliori.<br />
Tanto sia detto a proposito dell’«in principio».<br />
43 Sal 48 (149), 13.<br />
44 Sal 35 (36), 7.<br />
7
<strong>Origene</strong>: Omelie sulla <strong>Gen</strong>esi<br />
Le omelie sulla <strong>Gen</strong>esi, conservate nella traduzione latina <strong>di</strong> Rufino (fatta intorno<br />
al 400/404), sono fra le opere esegetiche che hanno esercitato il maggiore influsso<br />
sull’esegesi latina fino a tutto il Me<strong>di</strong>oevo. Sono state verosimilmente pronunciate a<br />
Cesarea <strong>di</strong> Palestina verso gli anni ’40 del III secolo; non è dato valutare quale sia stato<br />
il grado <strong>di</strong> rielaborazione del testo pubblicato rispetto a quello pronunciato da <strong>Origene</strong>,<br />
né quanto la traduzione latina abbia mo<strong>di</strong>ficato il tenore del testo originale greco.<br />
L’elemento più rilevante in questo testo è lo sviluppo del parallelismo fra la struttura<br />
dell’universo e quella dell’uomo e l’interpretazione del racconto della creazione nella<br />
prospettiva del progresso spirituale del singolo u<strong>di</strong>tore e lettore.<br />
Omelia prima sulla <strong>Gen</strong>esi<br />
[In principio]<br />
[1] «In principio Dio creò il cielo e la terra» (<strong>Gen</strong> 1, 1). Qual è il principio <strong>di</strong> tutte<br />
le cose, se non il nostro Signore e il «Salvatore <strong>di</strong> tutti» (1 Tim 4, 10), Gesù Cristo,<br />
«primogenito <strong>di</strong> tutta la creazione» (Col 1, 15)? In questo principio, dunque, cioè nel<br />
proprio Verbo, «Dio creò il cielo e la terra», come afferma anche l’evangelista Giovanni<br />
all’inizio del proprio vangelo, <strong>di</strong>cendo: «In principio era il Verbo e il Verbo era presso<br />
Dio e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio. Tutte le cose per mezzo <strong>di</strong><br />
lui sono state fatte e senza <strong>di</strong> lui non è stato fatto nulla» (Gv 1, 1-3). Egli, dunque, non<br />
si riferisce a un qualche principio temporale, ma afferma che «nel principio», cioè nel<br />
Salvatore, sono stati fatti il cielo e la terra e tutte le cose che sono state fatte 45.<br />
[Le tenebre e l’abisso]<br />
«Ma la terra era invisibile e informe e le tenebre erano sopra l’abisso e lo Spirito<br />
<strong>di</strong> Dio era spinto sulle acque» (<strong>Gen</strong> 1, 2). «La terra era invisibile e informe» prima che<br />
Dio <strong>di</strong>cesse: «Sia la luce» (<strong>Gen</strong> 1, 3) e prima che <strong>di</strong>videsse la luce dalle tenebre, secondo<br />
quanto espone l’or<strong>di</strong>ne del racconto 46. Dal momento, però, che nel seguito Dio or<strong>di</strong>na<br />
che sia fatto il firmamento e lo chiama “cielo”, quando saremo arrivati a quel passo, là<br />
sarà spiegata la ragione della <strong>di</strong>fferenza fra cielo e firmamento e perché anche il firmamento<br />
sia stato chiamato cielo. Ora, però, <strong>di</strong>ce: «Le tenebre erano sopra l’abisso». Qual<br />
è questo abisso? Quello certamente nel quale si troverà «il <strong>di</strong>avolo con i suoi angeli»<br />
(Apoc 12, 9; 20, 3) 47. Quanto meno, questo è ciò che anche nel vangelo viene aperta-<br />
45 Rispetto alle complesse speculazioni sulla nozione <strong>di</strong> “principio” esposte nel C<strong>Gen</strong> e nel CIoh, l’omelia<br />
è molto più sintetica e semplice; le tesi fondamentali care a <strong>Origene</strong> vi sono, tuttavia, chiaramente enunciate:<br />
il principio nel quale Dio crea non è un principio temporale, ma ontologico, per così <strong>di</strong>re, ed è il suo<br />
Figlio: <strong>Gen</strong> 1, 1 viene letto in corrispondenza con Gv 1, 1-3.<br />
46 La prima spiegazione che <strong>Origene</strong> dà dei due aggettivi che caratterizzano la terra è aderente alla lettera<br />
del testo, secondo l’interpretazione che ne dava Teofilo in polemica con Ermogene: la terra è informe e<br />
invisibile semplicemente perché manca ancora la luce. Non lo <strong>di</strong>ce esplicitamente, ma questa annotazione<br />
esclude che i due aggettivi descrivano una materia preesistente sulla quale Dio esercitò un’azione solo or<strong>di</strong>natrice.<br />
47 Alcuni mss leggono «nel quale si trovava», altri «si troverà». Entrambe le lezioni sono possibili: quella<br />
scelta dall’e<strong>di</strong>tore è più vicina al testo biblico cui qui si allude, l’Apocalisse, che colloca nel futuro il<br />
combattimento finale contro Satana. La lezione con l’imperfetto sarebbe compatibile con la concezione<br />
origeniana <strong>di</strong> una creazione intelligibile precedente alla creazione del cosmo sensibile, che fu causata<br />
dalla caduta degli esseri razionali della prima creazione.<br />
8
mente in<strong>di</strong>cato, quando si <strong>di</strong>ce del Salvatore: «I demoni ch’egli scacciava lo pregavano<br />
<strong>di</strong> non or<strong>di</strong>nare loro <strong>di</strong> tornare nell’abisso» (Lc 8, 31) 48.<br />
[L’opera del giorno “uno”]<br />
Perciò Dio <strong>di</strong>ssolse le tenebre, secondo quanto <strong>di</strong>ce la Scrittura: «E Dio <strong>di</strong>sse:<br />
Sia la luce, e la luce fu fatta. E Dio vide la luce, che era buona. E Dio <strong>di</strong>vise frammezzo<br />
la luce e frammezzo le tenebre. E Dio chiamò la luce “giorno” e chiamò le tenebre “notte”.<br />
E fu sera e fu mattina. Giorno uno» (<strong>Gen</strong> 1, 3-5). Secondo la lettera, Dio chiama la<br />
luce “giorno” e le tenebre “notte”.<br />
Ma secondo la comprensione spirituale, ve<strong>di</strong>amo che cosa sia mai ciò per cui,<br />
dopo che Dio, in quell’inizio nel quale abbiamo detto sopra che «creò il cielo e la terra»<br />
e <strong>di</strong>sse anche che ci fosse la luce e «<strong>di</strong>vise frammezzo la luce e frammezzo le tenebre e<br />
chiamò la luce “giorno” e le tenebre “notte”» e <strong>di</strong>sse che «fu sera e fu mattina», non <strong>di</strong>sse<br />
«giorno primo», bensì «giorno uno» (<strong>Gen</strong> 1, 5). Perché il tempo ancora non c’era,<br />
prima che vi fosse il mondo. Il tempo, invece, comincia ad esistere a partire dai giorni<br />
successivi. Il secondo giorno, infatti, e il terzo e il quarto e tutti gli altri iniziano ad in<strong>di</strong>care<br />
il tempo 49.<br />
[Il secondo giorno: creazione del firmamento e separazione delle acque]<br />
[2] «E Dio <strong>di</strong>sse: si faccia un firmamento in mezzo all’acqua e <strong>di</strong>vida acqua da<br />
acqua. E così avvenne. E Dio fece un firmamento» (<strong>Gen</strong> 1, 6-7). Dopo aver in precedenza<br />
fatto il cielo, Dio fa ora il firmamento. Prima creò il cielo, del quale <strong>di</strong>ce: «il cielo<br />
è la mia sede» (Is 66, 1). Dopo quello, crea il firmamento, cioè il cielo corporeo. Ogni<br />
corpo, infatti, è senza dubbio fermo e solido; ed è questo ciò che «<strong>di</strong>vide fra l’acqua che<br />
è sopra il cielo e l’acqua che è sotto il cielo» (<strong>Gen</strong> 1, 7) 50. Dal momento, infatti, che tutto<br />
ciò che Dio stava per creare sarebbe stato costituito <strong>di</strong> spirito e <strong>di</strong> corpo, per questa<br />
ragione «in principio» e prima <strong>di</strong> ogni cosa si <strong>di</strong>ce che sia stato creato il cielo, cioè ogni<br />
sostanza spirituale, su cui, come su un trono e una sede, riposa Dio. Questo cielo, invece,<br />
cioè il firmamento, è corporeo. E perciò quel primo cielo, che abbiamo detto spirituale,<br />
è il nostro intelletto, che è esso stesso spirito, cioè il nostro uomo spirituale che<br />
vede e percepisce Dio. Questo qui, invece, cioè il cielo corporeo, che è detto firmamento,<br />
è il nostro uomo esteriore, il cui sguardo è corporeo.<br />
Come dunque il firmamento è stato chiamato cielo per il fatto che <strong>di</strong>vide le acque<br />
che sono al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> esso da quelle che sono al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> esso, così anche<br />
l’uomo, che è stato posto in un corpo, se sarà capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre e <strong>di</strong>stinguere quali sono<br />
le acque che si trovano al <strong>di</strong> sopra del firmamento e quali quelle che si trovano sotto il<br />
firmamento, anch’egli sarà chiamato cielo, cioè uomo celeste (1 Cor 15, 47), secondo<br />
48 Uno dei moltissimi esempi <strong>di</strong> una lettura della Scrittura basata sulla persuasione che tutto il corpo delle<br />
Scritture sia un unico messaggio coerente e continuo, sicché si può usare un testo del NT per chiarire il<br />
significato <strong>di</strong> un testo dell’AT in modo perfettamente legittimo (applicazione cristiana del principio alessandrino<br />
<strong>di</strong> spiegare Omero con Omero).<br />
49 A proposito del giorno uno <strong>Origene</strong> riprende le riflessioni <strong>di</strong> <strong>Filone</strong> su questo tema svolte <strong>di</strong> De opif. 26<br />
e 35: la menzione del giorno uno in<strong>di</strong>ca che il primo atto <strong>di</strong> creazione da parte <strong>di</strong> Dio è anteriore al tempo<br />
e avviene in una sfera anteriore ontologicamente e logicamente a quella del mondo sensibile, che apparirà<br />
solo in seguito.<br />
50 Su questa <strong>di</strong>stinzione fra cielo e firmamento cf. Pépin, Théologie cosmique, 390-417. Fra cielo e firmamento<br />
c’è la stessa relazione che c’è tra forma intelligibile e sua oggetivazione sensibile. Il cielo è una<br />
realtà intelligibile, infatti è il trono <strong>di</strong> Dio, e coincide con la creazione intelligibile; il firmamento, come<br />
<strong>di</strong>ce il suo stesso nome, è una realtà sensibile, estesa e solida. Fra cielo e firmamento c’è un rapporto<br />
analogo a quello che c’è nell’uomo tra la sua realtà originaria e più autentica, costituita dal suo intelletto,<br />
e la realtà derivata e accidentale, il corpo del quale la sua anima decaduta è rivestita durante la permanenza<br />
nel cosmo sensibile.<br />
9
l’espressione dell’apostolo Paolo, che <strong>di</strong>ce: «la nostra citta<strong>di</strong>nanza è nei cieli» (Fil 3,<br />
21) 51.<br />
Questo è dunque quello che contengono le parole stesse della Scrittura: «E Dio<br />
creò un firmamento e <strong>di</strong>vise fra l’acqua che è sotto il firmamento e l’acqua che è sopra<br />
il firmamento. E Dio chiamò il firmamento cielo. E Dio vide che è cosa buona: e fu sera<br />
e fu mattina, secondo giorno» (<strong>Gen</strong> 1, 7-8).<br />
[Volgersi all’acqua al <strong>di</strong> sopra del firmamento]<br />
Si sforzi dunque ciascuno <strong>di</strong> voi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>visore dell’acqua che è al <strong>di</strong> sopra<br />
e dell’acqua che è al <strong>di</strong> sotto, affinché, avendo intelligenza e partecipando <strong>di</strong><br />
quell’acqua spirituale che è al <strong>di</strong> sopra del firmamento, faccia scaturire «dal proprio<br />
ventre fiumi <strong>di</strong> acqua viva che zampilla per la vita eterna» (Gv 7, 38; 4, 14), separato e<br />
allontanato da quell’acqua che è al <strong>di</strong> sotto, cioè dall’acqua dell’abisso, nel quale è detto<br />
che si trovano le tenebre e in cui abitano il «principe <strong>di</strong> questo mondo» (Gv 12, 31) e il<br />
nemico «serpente con i suoi angeli» (Apc 12, 7; 20, 3), come è stato in<strong>di</strong>cato sopra 52.<br />
Per mezzo dunque della partecipazione a quell’acqua superiore, che si <strong>di</strong>ce stare<br />
al <strong>di</strong> sopra dei cieli, ciascun fedele è reso celeste, cioè, rivolge la propria mente alle cose<br />
alte e sublimi, non pensando alcuna cosa della terra, ma ricercando solo «le cose che<br />
sono lassù, dove si trova Cristo alla destra del Padre» (Col 3, 1). Allora anch’egli sarà<br />
considerato degno <strong>di</strong> ricevere quella lode da parte <strong>di</strong> Dio che qui è scritta, quando il profeta<br />
<strong>di</strong>ce: «E Dio vide che era cosa buona» (<strong>Gen</strong> 1, 8).<br />
[Il terzo giorno: apparizione della terra arida]<br />
Le cose, poi, che sono descritte in quel che segue a proposito del terzo giorno,<br />
corrispondono alla medesima interpretazione. Dice infatti: «E Dio <strong>di</strong>sse: si raccolga<br />
l’acqua che è al <strong>di</strong> sotto del cielo in un’unica raccolta e appaia il suolo arido. E così accadde»<br />
(<strong>Gen</strong> 1, 9).<br />
Affatichiamoci, dunque, a raccogliere l’acqua che è sotto il cielo e ad allontanarla<br />
da noi, affinché, una volta che ciò sia avvenuto, appaia il suolo arido, che sono le nostre<br />
opere compiute nella carne, in modo tale che «gli uomini, vedendo le nostre opere<br />
buone, glorifichino il Padre nostro che è nei cieli» (Mt 5, 16). Se, infatti, non avremo<br />
separato da noi queste acque che sono sotto il cielo, cioè i peccati e i vizi del nostro corpo,<br />
il nostro suolo arido non potrà apparire e non avrà confidenza nel procedere verso la<br />
luce. «Ciascuno, infatti, che opera il male o<strong>di</strong>a la luce e non viene alla luce, perché non<br />
vengano rimproverate le sue opere. Chi invece fa la verità viene alla luce, perché si manifestino<br />
le sue opere» e siano viste se «sono state compiute in Dio» (Gv 3, 20-21) 53.<br />
Questa confidenza non sarà data se non allontaniamo da noi come acque e non separiamo<br />
i vizi del corpo, che sono la materia dei peccati. Una volta fatto questo, il nostro<br />
suolo arido non rimarrà arido, come si mostrerà da quello che segue.<br />
51 L’interpretazione in prospettiva etico-antropologica del rapporto fra firmamento e cielo viene esplicitata:<br />
se il firmamento serve a <strong>di</strong>videre l’alto dal basso, e per questo viene chiamato cielo, anche l’uomo<br />
corporeo, se sa <strong>di</strong>stinguere alto dal basso, sarà chiamato cielo, cioè manifesta ala propria appartenenza a<br />
quella sfera nella quale, secondo Fil 3, 21, egli ha la propria vera citta<strong>di</strong>nanza.<br />
52 L’esortazione morale sfrutta il tema del duplice valore che ha nell’immaginario biblico l’acqua: essa è<br />
fonte <strong>di</strong> vita e purificazione, ma anche elemento minaccioso e mortale.<br />
53 Prosegue l’interpretazione spirituale e morale del racconto della creazione: come il firmamento, cioè il<br />
corpo, deve servire a separare le acque superiori, purificanti e vivificanti, da quelle inferiori, mortali e<br />
peccaminose, e allora meriterà <strong>di</strong> essere chiamato “cielo”, allo stesso modo è necessario che le acque inferiori<br />
vengano separate e raccolte in un solo luogo, in modo che appaia il suolo asciutto; e queso suolo<br />
asciutto, che sono le opere compiute nel corpo, se sarà davvero separato dall’acqua del peccato, meriterà<br />
<strong>di</strong> essere chiamato “terra” e sarà capace, se si impegnerà a farla fruttificare, <strong>di</strong> produrre frutti buoni.<br />
10
Dice infatti: «E l’acqua che è al <strong>di</strong> sotto del cielo si riunì nelle sue raccolte e apparve<br />
il suolo arido. E Dio chiamò il suolo arido terra e le raccolte delle acque le chiamò<br />
mare» (<strong>Gen</strong> 1, 9). Come dunque questo solo arido, una volta ch’ebbe allontanato da sé<br />
l’acqua, come abbiamno detto sopra, non rimase suolo arido, ma riceve ormai il nome <strong>di</strong><br />
terra, allo stesso modo anche i nostri corpi, se avverrà questa separazione da loro, non<br />
rimarrano suolo arido, ma saranno chiamati anch’essi terra, perché potranno portare<br />
frutto per Dio.<br />
Quin<strong>di</strong> «in principio Dio creò il cielo e la terra», in seguito, invece, creò il firmamento<br />
e il suolo arido; e il firmamento lo chiamò “cielo”, dandogli il nome <strong>di</strong> quel<br />
cielo che aveva creato in precedenza, mentre il suolo arido lo chiamò “terra”, per il fatto<br />
che gli veniva data la capacità <strong>di</strong> portare frutti. Se, dunque, qualcuno per propria colpa<br />
rimane ancora arido e non porta alcun frutto, ma «spine e rovi» (<strong>Gen</strong> 3, 18; Ebr 6, 8),<br />
come se portasse in sé alimento per il fuoco (Is 9, 19), anch’egli <strong>di</strong>venterà alimento per<br />
il fuoco. Se, invece, con il proprio impegno e la propria <strong>di</strong>ligenza, dopo aver separato da<br />
sé le acque dell’abisso, che sono i pensieri dei demoni, si mostra come terra fruttifera,<br />
deve sperare un risultato simile, che sia cioè introdotto da Dio nella «terra dove scorre il<br />
latte e il miele» (Es 3, 8; 33, 3). [...]<br />
11
<strong>Origene</strong><br />
Contro Celso: VI 49-52<br />
[Inconsistenza della cosmogonia mosaica]<br />
[VI 49] Ve<strong>di</strong>amo anche le cose che seguono, nelle quali, <strong>di</strong>chiarando la propria<br />
opinione in una sola parola e senza <strong>di</strong>re alcunché <strong>di</strong> plausibile, Celso mette sotto accusa<br />
la creazione del mondo secondo Mosè, <strong>di</strong>cendo: «E inoltre anche la sua cosmogonia è<br />
del tutto sciocca» 54. Se, dunque, egli avesse presentato il modo in cui essa gli pare<br />
sciocca e qualche argomento plausibile, ci saremmo impegnati a controbatterli; ma non<br />
mi par ragionevole portare argomenti contro la sua mera affermazione, per mostrare in<br />
che modo la cosmogonia <strong>di</strong> Mosè non è sciocca 55.<br />
Se qualcuno vuole prendere in considerazione la ragioni che ci hanno mosso,<br />
corredate degli argomenti che ci paiono <strong>di</strong>mostrativi a proposito della creazione del cosmo<br />
secondo Mosè, prenda ciò che abbiamo scritto sulla <strong>Gen</strong>esi, dall’inizio del libro fino<br />
al passo «Questo è il libro della generazione degli uomini» (<strong>Gen</strong> 5, 1). Là abbiamo<br />
tentato, a partire dalle stesse <strong>di</strong>vine Scritture, <strong>di</strong> argomentare quale sia il cielo venuto<br />
all’essere «in principio», quale la terra e che cosa sia il suo essere «invisibile e informe»,<br />
quale l’abisso e la tenebra al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> esso, quale l’acqua e «lo spirito <strong>di</strong> Dio»<br />
che «si muoveva su <strong>di</strong> essa», quale la «luce» generata e quale il «firmamento» venuto<br />
all’essere oltre al cielo nato «in principio» e così via 56.<br />
[Altre critiche al racconto delle origini]<br />
Celso <strong>di</strong>chiarò poi che «è molto sciocca anche la scrittura concernente la genesi<br />
degli uomini», senza però citarne le affermazioni, né combatterle. Penso, infatti, che<br />
non avesse argomenti capaci <strong>di</strong> confutare l’affermazione che l’uomo è stato fatto «a<br />
immagine <strong>di</strong> Dio» (<strong>Gen</strong> 1, 27). Nemmeno comprende «il “para<strong>di</strong>so” piantato da Dio e la<br />
vita precedente condotta in esso dall’uomo e quella prodottasi in seguito alle circostanze,<br />
dopo ch’egli ne fu cacciato a causa del peccato e prese <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> fronte al “para<strong>di</strong>so<br />
della delizia”».<br />
Chi afferma che queste cose sono state dette in modo molto sciocco, rivolga anzitutto<br />
l’attenzione a ciascuna affermazione e a questa: «Pose i cherubini e la roteante<br />
spada <strong>di</strong> fuoco, per custo<strong>di</strong>re la via dell’albero della vita» (<strong>Gen</strong> 3, 24) 57. Se, dunque,<br />
«Mosè scrisse queste cose senza capirci nulla, ma facendo qualcosa <strong>di</strong> simile alle cose<br />
che scrissero per scherzo i poeti della comme<strong>di</strong>a antica: “Preto sposò Bellerofonte”,<br />
“Pegaso veniva dall’Arca<strong>di</strong>a”» 58; quelli, però, mettevano insieme tali sciocchezze vo-<br />
54 Le obiezioni <strong>di</strong> Celso che <strong>Origene</strong> considera nelle pagine qui presentate vengono da una sezione del<br />
Discorso vero in cui le dottrine cristiane erano messe a confronto con la filosofia greca; in particolare VI<br />
49-65 tratta delle obiezioni contro la loro cosmogonia. Esse <strong>di</strong>monstrano da parte <strong>di</strong> Celso una certa<br />
conoscenza del testo biblico.<br />
55 Uno dei temi fondamentali della polemica antigiudaica e anticristiana <strong>di</strong> Celso è il carattere banale e la<br />
volgarità delle Scritture, che ne vieta ogni interpretazione allegorica. Lungi dall’essere il profeta celebrato<br />
da ebrei e cristiani, Mosè è per lui un mago e un cialtrone.<br />
56 <strong>Origene</strong> dà una specie <strong>di</strong> rapidp sommario degli argomenti da lui trattati una ventina <strong>di</strong> anni prima,<br />
quando ad Alessandria ha composto il C<strong>Gen</strong>. La menzione è interessante perché conferma che, a <strong>di</strong>stanza<br />
<strong>di</strong> tanto tempo, <strong>Origene</strong> non ha mo<strong>di</strong>ficato le proprie tesi fondamentali e la propria maniera <strong>di</strong> intendere il<br />
racconto delle origini, anche se qui non ritiene opportuno dare dettagli.<br />
57 Perché <strong>Origene</strong> invita Celso a riflettere proprio su questa affermazione?<br />
58 Le affermazioni assurde dei comici erano deliberate e avevano lo scopo <strong>di</strong> suscitare il riso, mentre le<br />
assur<strong>di</strong>tà che scrive Mosè sono involontarie e <strong>di</strong>pendono dalla sua poca intelligenza, che gli impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong><br />
capire il senso profondo dei miti antichi che cerca <strong>di</strong> imitare. Antea, la moglie <strong>di</strong> Preto, re <strong>di</strong> Argo, si era<br />
innamorata <strong>di</strong> Belleronfonte e, dal momento ch’egli non ricambiava il suo amore, lo calunniò presso il<br />
12
lendo far ridere. Egli, invece, che lasciò a tutto il popolo Scritture a proposito delle quali<br />
voleva persuadere i destinatari della sua legislazione ch’esse provenivano da Dio, non è<br />
plausibile che abbia scritto cose insensate e abbia fatto senza alcun inten<strong>di</strong>mento<br />
l’affermazione: Dio «pose i cherubini e la roteante spada <strong>di</strong> fuoco, per custo<strong>di</strong>re la via<br />
dell’albero della vita» o un’altra delle affermazioni da lui fatte a proposito della genesi<br />
degli uomini e interpretate filosoficamente dai sapienti ebrei 59.<br />
[Confronto fra Mosè e i sapienti antichi]<br />
[50] Di seguito a queste cose, accumulando in spoglie affermazioni «le <strong>di</strong>fferenze<br />
fra i racconti fatti da alcuni antichi sulla genesi del cosmo e degli uomini», <strong>di</strong>ce che<br />
«coloro che hanno lasciato» i nostri «scritti, Mosè e i profeti, non sapendo quale mai sia<br />
la natura del cosmo e degli uomini, hanno messo insieme un completo vaneggiamento».<br />
S’egli, dunque, avesse detto in che senso la <strong>di</strong>vine Scritture gli parevano un completo<br />
vaneggiamento, avremmo cercato <strong>di</strong> replicare con argomenti alle ragioni plausibili per<br />
le quali esse gli parevano solo una gran chiacchiera. Ora, però, facendo una cosa simile<br />
a quella che ha fatto lui e prendendoci gioco <strong>di</strong> lui, <strong>di</strong>chiareremo anche noi che Celso,<br />
non sapendo in alcun modo quale mai fosse la natura del pensiero e del <strong>di</strong>scorso che si<br />
trova nei profeti, ha messo insieme un completo vaneggiamento, intitolandolo presuntuosamente<br />
«Discorso vero».<br />
[Celso non intende il senso spirituale della dottrina mosaica]<br />
Poiché, come se fossero cose da lui pensate con chiarezza e precisione, porta per<br />
accusarci l’argomento dei giorni della creazione del cosmo, dei quali alcuni passarono<br />
prima che nascessero la luce e il cielo, il sole, la luna e le stelle, mentre altri passarono<br />
dopo la genesi <strong>di</strong> queste cose 60, osserveremo contro <strong>di</strong> lui soltanto questo: forse a Mosè<br />
è sfuggito il fatto <strong>di</strong> aver detto prima che il mondo era stato creato completamente in sei<br />
giorni e, essendosene <strong>di</strong>menticato, aggiunge a queste cose: «Questo è il libro della generazione<br />
degli uomini, nel giorno nel quale Dio fece il cielo e la terra» (<strong>Gen</strong> 5, 1) 61? Ma<br />
non è affatto plausibile che Mosè, senza capire nulla, dopo il racconto dei sei giorni, abbia<br />
affermato: «Nel giorno in cui Dio fece il cielo e la terra». Se qualcuno pensa che<br />
queste espressioni si possano riferire alla frase: «In principio Dio creò il cielo e la terra»<br />
proprio marito. Da qui si capisce l’assur<strong>di</strong>tà dell’affermazione che Preto voleva sposare Bellerofonte.<br />
Pegaso era il cavallo alato <strong>di</strong> Bellerofonte.<br />
59 <strong>Origene</strong> lungo tutto il trattato polemizza contro Celso mostrandogli che la presunta banalità e la volgarità<br />
delle Scritture, che il filosofo greco rimprovera, sono in realtà dovute alla sua incapacità <strong>di</strong> comprenderne<br />
il senso e <strong>di</strong>pendono, in ultima analisi, proprio da una carenza <strong>di</strong> spirito filosofico: <strong>Origene</strong>,<br />
cioè, polemizza contro Celso non cercando <strong>di</strong> mostrargli la legittimità o la superiorità <strong>di</strong> una forma <strong>di</strong><br />
conoscenza <strong>di</strong>versa da quella filosofica, ma mostrandogli che, se Celso fosse un vero filosofo, dovrebbe<br />
riconoscere la superiorità della sapienza comunicata dalle Scritture.<br />
60 La critica <strong>di</strong> Celso è citata più estesamente in VI 60 e sembra abbastanza ovvia: da una parte la Bibbia<br />
descrive una creazione in sei giorni, dall’altra parte afferma che gli astri dai quali <strong>di</strong>pende la successione<br />
dei giorni vennero creati solo al quarto giorno: allora com’è possibile che vi siano stati dei giorni prima <strong>di</strong><br />
allora? Per non parlare dell’assur<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un Dio che lavora un po’ per volta dando or<strong>di</strong>ni non si sa a chi...<br />
La critica ha per obiettivo mostrare che il senso letterale del testo biblico è del tutto inaccettabile e che è<br />
perciò vano cercare <strong>di</strong> darne una spiegazione allegorica. L’impossibilità <strong>di</strong> una comprensione letterale dei<br />
sei giorni è esplicitamente <strong>di</strong>scusso anche da <strong>Origene</strong> in PA IV 3, 1: «Quale uomo assennato potrebbe<br />
trovare ragionevole che vi siano stati secondo la Scrittura un primo, un secondo e un terzo giorno, con le<br />
in<strong>di</strong>cazione della sera e della mattina, quando ancora non c’erano sole e luna e stelle, e un primo giorno<br />
quando non esisteva nemmeno il cielo?». Ma Dio non è come un architetto umano, che ha bisogno <strong>di</strong><br />
tempo per sviluppare e realizzare i propri progetti (cf. Sal 148, 3). Il tema della simultaneità della creazione<br />
e della funzione or<strong>di</strong>natrice in senso logico e non cronologico della <strong>di</strong>stribuzione in sei giorni è già<br />
presente in <strong>Filone</strong> (cf. sopra nota 13 e LA I 2-4), Clemente, Strom. VI 16.<br />
61 [[Controllare la citazione: non capisco se si tratti <strong>di</strong> 2, 4 o <strong>di</strong> 5, 1 o <strong>di</strong> una contaminazione dei due testi]]<br />
13
(<strong>Gen</strong> 1, 1), sappia che prima delle frasi: «Sia la luce e la luce fu» e «Dio chiamò la luce<br />
giorno», è stato detto: «In principio Dio creò il cielo e la terra» 62.<br />
[51] Ora, però, non mi propongo <strong>di</strong> esporre la dottrina delle realtà intelligibili e<br />
sensibili e in che modo siano state <strong>di</strong>stribuite le nature dei giorni in entrambe le specie,<br />
né intendo fare ricerca sui singoli passi. Avremmo, infatti, bisogno <strong>di</strong> interi trattati per<br />
esporre la creazione del mondo secondo Mosè; cosa che, secondo le nostre possibilità,<br />
abbiamo fatto parecchio tempo prima del presente saggio contro Celso, a partire dalla<br />
situazione <strong>di</strong> parecchi anni fa, nel modo in cui ci riuscivo allora, esaminando i sei giorni<br />
della creazione del cosmo secondo Mosè. Bisogna comunque sapere che il Logos per<br />
mezzo <strong>di</strong> Isaia promette ai giusti che ci saranno giorni nella reintegrazione finale, nella<br />
quale non il sole, ma «il Signore» stesso sarà «luce eterna» per loro «e Dio sarà la loro<br />
gloria» (Is 60, 19).<br />
[Celso basa le sue critiche su dottrine eretiche, da lui fraintese]<br />
Ritengo che, avendo frainteso un’eresia perversa, che spiega malamente<br />
l’espressione «sia la luce» come se fosse stata pronunciata dal creatore in forma <strong>di</strong> preghiera,<br />
Celso abbia affermato: «Non è certo possibile che, come coloro che si fanno accendere<br />
le lucerne dai vicini, il creatore si sia fatto prestare la luce dall’alto» 63. E fraintendento<br />
un’altra empia eresia <strong>di</strong>sse anche: «Se c’era, infatti, opposto al grande Dio, un<br />
<strong>di</strong>o maledetto che faceva queste cose contro la sua volontà, perché mai gli ha prestato la<br />
luce?». Siamo tanto lontani dal volerci giustificare per queste affemazioni che, piuttosto,<br />
vogliamo mettere sotto accusa in modo più preciso la loro opinione, in quanto essi errano,<br />
e prendere posizione non nei confronti delle loro dottrine che non conosciamo, come<br />
fa Celso, ma contro dottrine che conosciamo con precisione, in parte per averle intese da<br />
loro, in parte per aver letto con attenzione i loro trattati 64.<br />
[52] Dopo queste cose, Celso <strong>di</strong>ce: «A proposito della genesi e della corruzione<br />
del cosmo, che esso sia ingenerato e incorruttibile, o che sia generato, ma incorruttibile,<br />
oppure no, io ora non <strong>di</strong>co nulla» 65. Perciò nemmeno noi <strong>di</strong>remo alcunché ora su questo<br />
62 [[Non riesco a capire in che cosa consista l’obiezione che <strong>Origene</strong> muove a Celso: in che senso queste<br />
osservazioni dovrebbero confutare le critiche del filosofo circa i sei giorni della creazione?]] Mi sembra<br />
che <strong>Origene</strong> voglia far notare come una lettura piattamente materiale del racconto della creazione conduca<br />
a esiti ancora più assur<strong>di</strong> e sconclusionati <strong>di</strong> quelli criticati da Celso a proposito dei sei giorni: Mosè,<br />
infatti, esor<strong>di</strong>sce <strong>di</strong>cendo che Dio ha fatto cielo e terra in principio, ma la luce e il giorno (che pure fanno<br />
parte del cosmo) sarebbero stati fatti dopo; il racconto è poi <strong>di</strong>stribuito su sei giorni, durante i quali Dio<br />
creerebbe ogni cosa, compreso l’uomo, ma, al termine della narrazione, Mosè tornerebbe da capo e affermerebbe<br />
che Dio creò l’uomo nel giorno stesso in cui fece cielo e terra... Sicché o Mosè era un pazzo o<br />
aveva <strong>di</strong> mira contenuti <strong>di</strong>versi da quelli letterali. [[Ma non sono affatto sicuro che sia questo ciò che qui<br />
vuole <strong>di</strong>re]]<br />
63 Clem. Alex. Ecl. 38, 1 e Orig. Orat. 24, 5 attribuiscono questa idea a Taziano.<br />
64 Evidentemente, Celso, per polemizzare contro l’inconsistenza del racconto biblico della creazione, ne<br />
citava interpretazioni correnti in alcuni gruppi che attribuivano al creatore del cosmo sensibile una posizione<br />
subor<strong>di</strong>nata rispetto a un Dio superiore (cf. Marcione): per introdurre la luce nel cosmo sensibile la<br />
deve domandare a qualcun altro... <strong>Origene</strong> accusa Celso <strong>di</strong> non conoscere nemmeno bene queste dottrine,<br />
mentre <strong>di</strong> sé <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> conoscerle con precisione per averle ascoltate e lette: interessante conferma dei contatti<br />
<strong>di</strong>retti avuti da <strong>Origene</strong> con ambienti marginali rispetto alla grande chiesa.<br />
65 Le ipotesi formulate da Celso, sia pure in termini nn del tutto chiari, sono tre: il cosmo è ingenerato e<br />
incorruttibile; il mondo è generato e incorruttibile; il mondo è generato e corruttibile. In Tim. 28 B è posta<br />
la domanda se il cosmo sensibile sia da sempre o se abbia avuto un inizio e la risposta è che esso ebbe un<br />
inizio ('(')"*"). Le opinioni dei platonici <strong>di</strong>vergevano sul senso da attribuire a questa <strong>di</strong>chiarazione:<br />
essa implicava che il mondo avesse avuto un inizio temporale o semplicemente ne esprimeva la<br />
<strong>di</strong>pendenza da una causa ontologicamente e logicamente, ma non cronologicamente anteriore? La prima<br />
delle tre posizioni esposte da Celso era sostenuta da Aristotele nel De caelo, che intendeva il Timeo in<br />
senso letterale e ne contestava la dottrina. Platonici come Alcinoo sostenevano invece un’interpretazione<br />
non letterale del '(')"*" platonico, affermando che il mondo aveva una causa dalla quale <strong>di</strong>pendeva, ma<br />
non vi era mai stato un tempo nel quale il mondo non ci fosse. La seconda posizione era sostenuta da<br />
14
argomento: la trattazione attuale, infatti, non lo richiede. Ma nemmeno <strong>di</strong>ciamo che «lo<br />
spirito del Dio» al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> tutte le cose sia «venuto a trovarsi nelle cose <strong>di</strong> qui come<br />
in mezzo a realtà estranee» in base al passo «lo spirito <strong>di</strong> Dio si muoveva sulle acque»,<br />
né <strong>di</strong>ciamo che «cose malignamente architettate da un creatore <strong>di</strong>verso dal grande Dio e<br />
contro il suo spirito, benché il Dio superiore le sopportasse, avrebbero avuto bisogno <strong>di</strong><br />
essere <strong>di</strong>strutte» 66. Perciò tanti saluti a quelli che fanno simili affermazioni e a Celso che<br />
se la prende in modo non pertinente con loro; egli, infatti, avrebbe dovuto o non farne<br />
menzione o, secondo quanto a lui sembrava buono per gli uomini, esporle in modo meticoloso<br />
e combattere contro le affermazioni fatte in modo empio da quella gente.<br />
Nemmeno noi abbiamo mai inteso <strong>di</strong>re che «il grande Dio, dopo aver dato il proprio spirito<br />
al creatore, lo richieda in<strong>di</strong>etro».<br />
Di seguito, attaccando stoltamente tali empi <strong>di</strong>scorsi, <strong>di</strong>ce: «Quale Dio dà qualcosa<br />
per poi chiederla in<strong>di</strong>etro? Il richiedere in<strong>di</strong>etro è proprio <strong>di</strong> chi ha bisogno, ma<br />
Dio non ha bisogno <strong>di</strong> nulla» 67. E a queste parole aggiunge, come se <strong>di</strong>cesse qualcosa <strong>di</strong><br />
sapiente contro qualcuno: «Perché mai, quando gli dava in prestito, ignorava che stava<br />
prestando a un malvagio?» e <strong>di</strong>ce anche: «Perché non si preoccupa che un creatore malvagio<br />
operi contro <strong>di</strong> lui?».<br />
autori come Plutarco e Attico, per i quali il mondo aveva avuto un inizio temporale reale, ma era conservato<br />
dalla provvidenza del demiurgo in modo che non si <strong>di</strong>ssolvesse. La terza posizione è solo accennata<br />
da Celso, corrisponde alle tesi dei cristiani ed è chiaramente irrilevante per lui.<br />
66 Per quanto <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nati, questi cenni mostrano come l’interpretazione dell’esamerone fosse un campo <strong>di</strong><br />
battaglia per opzioni teologiche e cosmologiche in conflitto fra loro non soltanto nel confronto fra cristiani,<br />
giudei e pagani, ma anche all’interno delle chiese cristiane, nelle quali esistevano gruppi <strong>di</strong> rigoristi<br />
che consideravano la creazione del mondo sensibile incompatibile con l’opera del Dio buono e salvatore e<br />
l’attribuivano a un demiurgo malvagio (p.e. Marcione). <strong>Origene</strong> rifiuta, però, <strong>di</strong> far assimilare le posizioni<br />
della grande chiesa a queste tesi.<br />
67 Sembra che Celso si riferisca a tesi ofite: cf. Ir. Adv. haer. I 7, 1ss.; I 36, 6ss.<br />
15
<strong>Basilio</strong> <strong>di</strong> Cesarea<br />
Nacque a Cesarea <strong>di</strong> Cappadocia intorno al 330 da una famiglia <strong>di</strong> aristocratici<br />
cristianiche, attraverso l’insegnamento <strong>di</strong> Gregorio Taumaturgo, aveva accolto in profon<strong>di</strong>tà<br />
l’influsso della teologia <strong>di</strong> <strong>Origene</strong>. Stu<strong>di</strong>ò presso Libanio a Costantinopoli e,<br />
insieme al futuro imperatore Giuliano, presso Imerio e Proeresio ad Atene, dove <strong>di</strong>venne<br />
anche amico <strong>di</strong> Gregorio Nazianzeno. Dopo la morte del padre tornò in patria, rinunciò<br />
però alla carriera civile, ricevette il battesimo e, dopo un lungo viaggio per conoscere<br />
gli ambienti monastici <strong>di</strong> Egitto, Palestina, Siria e Mesopotamia, si ritirò in una proprietà<br />
<strong>di</strong> famiglia a condurre vita ascetica insieme alla madre Emmelia, la sorella Macrina,<br />
il fratello Gregorio e l’amico Gregorio Nazianzeno e alcuni altri <strong>di</strong>scepoli. Nel<br />
364 venne or<strong>di</strong>nato prete dal vescovo Eusebio, al quale succedette nel 370. Nei <strong>di</strong>fficili<br />
rapporti con l’imperatore filoariano Valente (364-378) <strong>di</strong>ede prova <strong>di</strong> abilità politica e<br />
determinazione nella <strong>di</strong>fesa della fede ariana, ma anche <strong>di</strong> umanità e attenzione verso i<br />
poveri. Morì nel 379.<br />
La sua produzione teologica è legata soprattutto alla polemica antiariana e alla<br />
<strong>di</strong>fesa della fede <strong>di</strong> Nicea, cf. soprattutto 363 Adversus Eunomium, 375 De Spiritu Sancto;<br />
all’esperienza ascetica risalgono i Moralia, del 360, e le Regulae fusius quelle brevius<br />
tractatae che, nella versione latina <strong>di</strong> Rufino, ebbero vasto influsso anche sul monachesimo<br />
latino. È autore anche <strong>di</strong> omelie e <strong>di</strong> un vasto epistolario.<br />
Le nove omelie sull’esamerone furono pre<strong>di</strong>cate a Cesarea <strong>di</strong> Cappadocia; le<br />
prime quattro e le ultime quattro furono pre<strong>di</strong>cate, ciascuna serie, in due giorni consecutivi<br />
(un’omelia al mattino e una alla sera), mentre l’omelia centrale occupa una posizione<br />
meno chiara. Sulle circostanze <strong>di</strong> questa pre<strong>di</strong>cazione <strong>Basilio</strong> offre alcuni elementi<br />
nel corso del testo: era un periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>giuno (infatti la <strong>Gen</strong>esi era lettura tra<strong>di</strong>zionale<br />
del tempo <strong>di</strong> quaresima), l’u<strong>di</strong>torio era composto <strong>di</strong> persone <strong>di</strong> ogni certo ed era piuttosto<br />
numeroso. La datazione non è sicura, ma il tono autorevole con il quale <strong>Basilio</strong> si<br />
esprime può far pensare a un anno successivo alla sua consacrazione episcopale (370),<br />
forse proprio il 378.<br />
L’intento esegetico <strong>di</strong> queste omelie è perseguito attingendo a tutte le risorse<br />
della conoscenza scientifica, cosmologica, naturalistica che <strong>Basilio</strong> possiede. Il suo approccio<br />
al testo biblico è tendenzialmente letteralista: le acque al <strong>di</strong> sopra del cielo sono<br />
effetivamente acqua e l’uomo fatto a immagine è precisamente l’uomo in carne e ossa, e<br />
così via. In realtà, in alcuni casi <strong>Basilio</strong> deve fare eccezione a questo criterio letteralista,<br />
appellandosi a due ragioni essenziali: o la <strong>di</strong>fficoltà da parte dell’interprete <strong>di</strong> comprendere<br />
ciò che l’autore sacro ha voluto <strong>di</strong>re (p.e. che cosa ha voluto <strong>di</strong>re quando parlava<br />
dello «spirito/soffio <strong>di</strong> Dio», si riferiva al vento o allo Spirito santo?), magari a causa <strong>di</strong><br />
una lezione controversa (p.e. <strong>Basilio</strong> conosce la traduzione <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1 fatta da Aquila),<br />
o la <strong>di</strong>fficoltà per l’autore sacro <strong>di</strong> esprimere in un linguaggio umano realtà che sono <strong>di</strong><br />
per sé ineffabili.<br />
Malgrado faccia appello largamente alle risorse che gli vengono dalle conoscenze<br />
naturalistiche dei suoi tempi, <strong>Basilio</strong> non manca <strong>di</strong> esprimersi in termini prudentemente<br />
critici nei confronti <strong>di</strong> ipotesi che si contrad<strong>di</strong>cono reciprocamente e che, soprattutto,<br />
non sono in grado <strong>di</strong> avvicinare coloro che le formulano a una conoscenza vera<br />
del Dio che si rivela nell’or<strong>di</strong>ne naturale e nell’economia storica. Nell’apologetica cristiana<br />
è ricorrente l’opposizione fra la certezza che viene dalla parola <strong>di</strong> Dio e le incerte<br />
ipotesi elaborate dai filosofi (cf. Theoph. Ad Autol. III 16, 17). <strong>Basilio</strong> tiene conto del<br />
sapere scientifico e delle obiezioni che da lì possono venire al dettato della Scrittura, ma<br />
1
non si lascia coinvolgere in <strong>di</strong>scussioni troppo cavillose e polemiche che considera inutili<br />
ai fini dell’e<strong>di</strong>ficazione spirituale dell’u<strong>di</strong>torio.<br />
L’ampiezza e la meticolosità dell’esposizione <strong>di</strong> <strong>Basilio</strong> mostrano che, almeno in<br />
questa occasione, l’omelia è <strong>di</strong>venuta luogo <strong>di</strong> una formazione culturale e catechetica<br />
dell’u<strong>di</strong>torio<br />
2
Del nostro padre tra i santi <strong>Basilio</strong>, arcivescovo <strong>di</strong> Cesarea <strong>di</strong> Cappadocia<br />
Nove omelie sull’esamerone<br />
Omelia I<br />
«In principio Dio fece il cielo e la terra»<br />
1.<br />
[Esor<strong>di</strong>o: grandezza del tema proposto]<br />
[1] Un inizio conveniente per colui che si accinge a esporre la costituzione del<br />
cosmo è il premettere al <strong>di</strong>scorso un principio dell’or<strong>di</strong>namento delle cose visibili1. La<br />
creazione del cielo e della terra, infatti, deve essere trasmessa non come frutto <strong>di</strong><br />
un’aggregazione spontanea, come alcuni hanno immaginato, ma come avente da Dio la<br />
propria causa. [2] Quale ascolto può essere degno della grandezza delle cose dette? Come<br />
è conveniente che un’anima sia preparata per andare incontro all’ascolto <strong>di</strong> cose tanto<br />
gran<strong>di</strong>? Purificata dalle passioni della carne, non ottenebrata dalle ansie della vita, laboriosa,<br />
<strong>di</strong>sposta alla ricerca, attenta a vedere da ogni parte se possa trarre un degno<br />
concetto <strong>di</strong> Dio2. Ma prima <strong>di</strong> ricercare il significato preciso dei termini e <strong>di</strong> indagare<br />
quanto gran<strong>di</strong> siano i significati <strong>di</strong> queste piccole espressioni, consideriamo chi è colui<br />
che parla con noi. [3] Perché, anche se, a causa della debolezza della nostra ragione, non<br />
riusciamo a raggiungere la profon<strong>di</strong>tà del cuore dello scrittore, prestando attenzione alla<br />
cre<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> colui che parla, spontaneamente saremo condotti all’assenso verso le cose<br />
da lui dette3. [Elogio <strong>di</strong> Mosè]<br />
È dunque Mosè che fonda quest’opera, quel Mosè che, ancora lattante, ha ricevuto<br />
testimonianza <strong>di</strong> essere grazioso 4 davanti a Dio; la figlia del faraone lo adottò come<br />
figlio, lo allevò regalmente e stabilì per lui i sapienti egiziani come maestri della sua educazione<br />
5. [4] Egli, detestando il fasto della tirannia e rivoltosi all’umiltà dei suoi connazionali,<br />
preferì «subire il male insieme al popolo <strong>di</strong> Dio, piuttosto che avere il go<strong>di</strong>mento<br />
effimero del peccato» (Eb 11, 25). Quel Mosè che possedette per sua stessa natura<br />
l’amore per la giustizia, dal momento che, prima ancora che gli fosse affidato il comando<br />
del popolo, apparve punire fino alla morte i malvagi per l’o<strong>di</strong>o che nutriva contro<br />
la cattiveria. [5] Quel Mosè che fu esiliato da coloro che aveva beneficato, abbandonò<br />
lietamente i tumulti dell’Egitto, raggiunse l’Etiopia e là, tenedosi del tutto libero da<br />
ogni altra occupazione, per quarant’anni interi si de<strong>di</strong>cò alla contemplazione delle cose<br />
1 Si noti la ripetizione del termine “principio” (!"#$): chi vuole dare inizio in modo opportuno ad una<br />
esposizione dell’or<strong>di</strong>namento del cosmo lo deve fare muovendo da un principio, evitando, cioè, <strong>di</strong> attribuirne<br />
la genesi al caso.<br />
2 Criteri per avere intelligenza del testo biblico: libertà dell’intelletto dal corpo, <strong>di</strong>sponibilità a compiere<br />
un lavoro <strong>di</strong> ricerca, prudenza nel valutare se le conclusioni alle quali esso arriva siano compatibili con la<br />
pietas.<br />
3 <strong>Basilio</strong> accenna al metodo <strong>di</strong> lavoro dell’esegeta (analisi puntuale del testo alla ricerca del suo significato<br />
preciso) e ai due livelli della conoscenza possibili: si può avere fede nell’autorità <strong>di</strong> colui che propone<br />
un determinato contenuto, oppure si può avere sicenza <strong>di</strong> quel contenuto, possederne cioè le ragioni.<br />
Il primo livello è accessibile a tutti, il secondo soltanto a chi abbia una preparazione e un’attitu<strong>di</strong>ne particolari,<br />
e comunque non in relazione a tutti gli oggetti.<br />
4 Cf. Es 2, 2.<br />
5 Il tema del Mosè familiare con la scienza degli egiziani è già biblico (At 7, 22), cf. anche Phil. Alex.<br />
Mos. I 5; Clem. Alex. Strom. I 23. Viene usato da Celso contro gli ebrei e, <strong>di</strong> conseguenza, i cristiani, accusati<br />
<strong>di</strong> aver malamente scopiazzato le conoscenze che erano state raggiunte dagli altri popoli più sapienti.<br />
Gli apologeti giudei e cristiani ribaltano l’accusa e ritengono che siano stati barbari e greci a rubare<br />
la sapienza <strong>di</strong> Mosè, appropriandosene.<br />
3
che sono 6. Raggiunti gli ottant’anni, vide Dio, com’è possibile a un uomo vedere Dio, o<br />
piuttosto come a nessun altro uomo accadde mai <strong>di</strong> vederlo, secondo la testimonianza<br />
stessa <strong>di</strong> Dio: «qualora ci fosse un altro profeta fra voi per il Signore, mi farò conoscere<br />
da lui in visione e gli parlerò in sogno. [6] Non così come il mio servo Mosè, fedele in<br />
tutta la mia casa: bocca a bocca parlerò con lui, in visione e non attraverso enigmi»<br />
(Num 12, 6-8). Questi, dunque, che fu ritenuto degno della visione del volto stesso <strong>di</strong><br />
Dio, allo stesso modo degli angeli, ci parla delle cose che ha u<strong>di</strong>to da Dio 7. Ascoltiamo,<br />
perciò, parole <strong>di</strong> verità, dette non in termini persuasivi <strong>di</strong> sapienza umana, ma in termini<br />
insegnati dallo Spirito (1 Cor 2, 4. 13). Il loro fine non è la lode da parte <strong>di</strong> coloro che<br />
ascoltano, ma la salvezza <strong>di</strong> coloro che vengono istruiti.<br />
2.<br />
[Ricchezza inesauribile dell’esamerone]<br />
[1] «In principio Diò creò il cielo e la terra». La meraviglia <strong>di</strong> questo pensiero<br />
arresta il mio <strong>di</strong>scorso8. Che cosa <strong>di</strong>re per prima? Da dove incominciare la spiegazione?<br />
Confuterò la stoltezza dei profani? O celebrerò la nostra verità? Molte cose hanno trattato<br />
i sapienti greci a proposito della natura, ma nemmeno uno dei loro <strong>di</strong>scorsi è rimasto<br />
fermo e stabile, dal momento che, sempre, il secondo sovvertiva il precedente. Sicché<br />
non abbiamo alcun bisogno <strong>di</strong> confutare le loro affermazioni; bastano, infatti, l’una<br />
all’altra per confutarsi reciprocamente9. [Concezioni materialistiche dell’origine del cosmo]<br />
[2] Coloro che ignorano Dio 10 non ammisero che una causa intelligente abbia<br />
presieduto alla genesi dell’universo, ma portarono a termine quel che le seguiva in modo<br />
conforme all’ignoranza dell’inizio. Perciò gli uni ricorsero a fondamenti materiali,<br />
collocando negli elementi del cosmo la causa dell’universo; altri invece s’immaginarono<br />
che corpi in<strong>di</strong>visibili e senza parti, masse e spazi vuoti contenesso la natura delle cose<br />
visibili 11. [3] Quando questi corpi privi <strong>di</strong> parti ora si compongono insieme agli altri, ora<br />
si ricombinano, si producono la nascita e la corruzione delle cose; la causa della durata<br />
dei corpi più resistenti la offre l’intreccio più forte degli atomi. Coloro che scrivono<br />
queste cose tessono davvero una tela <strong>di</strong> ragno, ponendo principi così lievi e inconsistenti<br />
a fondamento del cielo, della terra e del mare. Non sapevano <strong>di</strong>re, infatti, «in principio<br />
Dio creò il cielo e la terra». [4] Per questo, dall’ateismo che abitava in loro furono in-<br />
6 La %&'"() *+, -,*', è insieme conoscenza intellettuale e contemplazione della vera realtà.<br />
7 La <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> Mosè rispetto a tutti gli altri profeti d’Israele, per non parlare <strong>di</strong> tutti gli altri sapienti<br />
dei popoli pagani, è in<strong>di</strong>cata dal privilegio accordatogli <strong>di</strong> vedere Dio faccia a faccia<br />
8 Cf. sopra Teofilo, <strong>Filone</strong>, <strong>Origene</strong> sull’eccellenza del tema proposto alla me<strong>di</strong>tazione. Non è fuori luogo<br />
ricordare che anche per Aristotele la meraviglia (stato d’animo ricorrente nell’esegesi esamerale <strong>di</strong><br />
<strong>Basilio</strong>) è all’origine della ricerca del filosofo (Metaph. I 2, 982 b 12; anche Plat. Theait. 155 D).<br />
9 Tema polemico molto frequente nella letteratura controversistica antica, sia nel <strong>di</strong>battito tra scuole<br />
filosofiche (cf. DL IX 88), sia nella polemica anticristiana (Celso in Orig. CC III 12; V 63) o<br />
nell’apologetica giudaica o cristiana (p.e. Iust. Dial. 2, 1-2), sia nella letteratura eresiologica: la <strong>di</strong>sparità<br />
<strong>di</strong> dottrine e la mancanza <strong>di</strong> accordo è in<strong>di</strong>cata come in<strong>di</strong>zio della falsità o della parzialità delle tesi sostenute<br />
dagli avversari, mentre l’unanimità e la concor<strong>di</strong>a nell’affermare una dottrina è un segno della sua<br />
verità.<br />
10 Coloro che ignorano Dio come causa intelligente e volontaria dell’or<strong>di</strong>ne del cosmo; l’ateismo ra<strong>di</strong>cale<br />
è un atteggiamento sostanzialmente sconosciuto nel pensiero antico.<br />
11 Cenno alle teorie <strong>di</strong> autori che riconoscono l’origine del cosmo negli elementi materiali che lo compongono,<br />
come Talete (acqua), Anassimene (aria), Eraclito (fuoco), Empedocle (le quattro ra<strong>di</strong>ci); e alle<br />
teorie degli atomisti, come Democrito, Leucippo, Epicuro.<br />
4
dotti con l’inganno a credere che l’universo fosse privo <strong>di</strong> guida e <strong>di</strong> amministrazione,<br />
come se fosse portato dalla sorte 12.<br />
[Il mistero della successione delle parole in <strong>Gen</strong> 1, 1]<br />
Affinché non patissimo anche noi il medesimo inganno, colui che compone la<br />
narrazione della creazione del cosmo subito, fin dalle prime parole, ha illuminato la nostra<br />
ragione con il nome <strong>di</strong> Dio, <strong>di</strong>cendo: «in principio Dio creò». E perché è bello<br />
quest’or<strong>di</strong>ne? 13 Per prima cosa, ha stabilito un principio, perché alcuni non ritenessero<br />
che il mondo sia privo <strong>di</strong> principio. [5] Poi ha aggiunto: «creò», perché fosse mostrato<br />
che ciò che è stato creato è una porzione minima della potenza del creatore. Come, infatti,<br />
il vasaio pur plasmando a partire dalla medesima arte migliaia <strong>di</strong> vasi, non ha esaurito<br />
né l’arte, né la propria capacità, così anche il creatore <strong>di</strong> questo universo, non avendo<br />
la propria potenza creatrice commisurata a un solo cosmo, bensì trascendente<br />
all’infinito, con la sola inclinazione della propria volontà ha portato all’essere le grandezze<br />
delle cose visibili 14. [6] Se, dunque, il cosmo ha un principio ed è stato creato,<br />
cerca: chi è colui che gli ha dato principio e chi ne è il creatore? Ma ancora <strong>di</strong> più, perché<br />
tu, cercando con ragionamenti umani, non deviassi in qualche punto dalla verità, ti<br />
ha preceduto con l’insegnamento, collocando nelle nostre anime un po’ come sigillo e<br />
filatterio il venerando nome <strong>di</strong> Dio, <strong>di</strong>cendo: «in principio Dio creò». [7] La natura beata,<br />
la bontà senza invi<strong>di</strong>a, ciò che è amabile per tutti coloro che partecipano <strong>di</strong> ragione,<br />
la bellezza degna <strong>di</strong> molto desiderio, il principio degli esseri, la sorgente della vita, la<br />
luce intellettiva, la sapienza inaccessibile, questi «in principio creò il cielo e la terra».<br />
3.<br />
[Carattere temporale del cosmo sensibile]<br />
[1] Perciò non t’immaginare, uomo, che le cose visibili siano prive <strong>di</strong> principio<br />
e, dal momento che i corpi mossi nel cielo corrono con moto circolare, ma il principio<br />
del movimento circolare non è facile da cogliere per la nostra percezione imme<strong>di</strong>ata,<br />
non credere nemmeno che sia priva <strong>di</strong> principio la natura dei corpi che si muovono circolarmente<br />
15. Anche questo cerchio, infatti, <strong>di</strong>co la figura piana compresa da un’unica<br />
linea, dal momento che sfugge alla nostra percezione e non siamo in grado <strong>di</strong> trovare né<br />
donde inizi, né dove termini, non per questo lo possiamo supporre privo <strong>di</strong> principio. [2]<br />
Ma anche se sfugge alla percezione, in verità, però, è partito da un punto colui che lo ha<br />
circoscritto a un centro e a una <strong>di</strong>stanza. Così anche tu, dal momento che le cose mosse<br />
circolarmente ritornano a se stesse, per l’uniformità senza interruzione del loro movimenti<br />
non insinuare in te l’ingannevole persuasione che il cosmo sia privo <strong>di</strong> principio e<br />
<strong>di</strong> fine. «Passa, infatti, la figura <strong>di</strong> questo mondo» (1 Cor 7, 31). E «il cielo e la terra<br />
passeranno» (Mt 24, 35). [3] Un annuncio preliminare delle dottrine riguardanti il com-<br />
12 Come già Plotino Enn. III 1, 3, <strong>Basilio</strong> respinge l’atomisomo sulla base della sproporzione fra la causa<br />
(l’incontro casuale <strong>di</strong> atomi) e il risultato (la complessa struttura del cosmo sensibile), che postula invece<br />
un intervento intelligente.<br />
13 Si potrebbe anche intendere in senso esclamatico: «com’è bello quest’or<strong>di</strong>ne!». Cf. le stesse osservazioni<br />
sull’or<strong>di</strong>ne in cui sono <strong>di</strong>sposte le parole in questo versetto fatte da Theoph. Ad Autol. II 10 [sopra].<br />
14 Il tema della libera volontà del creatore ha un rilievo particolare nella teologia cristiana, che non teme<br />
in questo caso l’antropomorfismo e rifiuta <strong>di</strong> vedere nella creazione un processo naturale e quin<strong>di</strong> necessario<br />
<strong>di</strong> espansione dal <strong>di</strong>vino, ma lo consiera l’effetto non necessario e indebito <strong>di</strong> un atto gratuito <strong>di</strong><br />
amore e potenza.<br />
15 Ciò che è senza principio è <strong>di</strong>vino e il cosmo sensibile non può essere <strong>di</strong> questa natura. Il moto dei pianeti<br />
o le figure geometriche non hanno un punto <strong>di</strong> partenza determinabile, ma questo non vuol <strong>di</strong>re che<br />
ne siano privi; allo stesso modo, il principio del cosmo sensibile, anche se non lo si può cogliere dal nostro<br />
punto <strong>di</strong> vista, è un inizio cronologico, al quale dovrà anche corrispondere una fine nel tempo delle realtà<br />
visibili. Ciò non toglie che dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> <strong>Basilio</strong> anche altre interpretazioni dell’«in principio»<br />
siano possibili e accettabili.<br />
5
pimento e la trasformazione del cosmo sono le rivelazioni ora trasmesse in breve<br />
nell’esposizione elementare fatta dall’insegnamento <strong>di</strong>vinamente ispirato. «In principio<br />
Dio creò» 16.<br />
Le cose che hanno avuto inizio nel tempo è necessario assolutamente che nel<br />
tempo abbiano compimento. Se hanno un inizio temporale, non dubitare della loro conclusione.<br />
Le geometrie e le indagini aritmetiche, le trattazioni riguardanti i soli<strong>di</strong>,<br />
l’astronomia tanto celebrata, quella impegnativa sciocchezza, a quale fine si volgono?<br />
[4] Se è vero che coloro che se ne sono occupati ritennero che anche questo mondo visibile<br />
fosse coeterno al Dio creatore della totalità delle cose, conducendo questo mondo<br />
circoscritto e dotato <strong>di</strong> un corpo materiale alla medesima gloria attribuita alla natura incircoscrivibile<br />
e invisibile, incapaci <strong>di</strong> rendersi conto che ciò le cui parti sono soggette a<br />
corruzione e cambiamento, necessariamente anche nell’intero in qualche momento dovrà<br />
sostenere le medesime affezioni alle quali sono soggette le sue parti 17. [5] Ma a tal<br />
punto «vaneggiarono nei loro ragionamenti e fu ottenebrato il loro cuore incapace <strong>di</strong><br />
comprendere e, mentre <strong>di</strong>cevano <strong>di</strong> essere sapienti, furono resi stolti» (Rom 1, 21-22)<br />
che gli uni <strong>di</strong>chiararono che il cielo sussisteva insieme a Dio dall’eternità, gli altri<br />
ch’esso era Dio, privo <strong>di</strong> principio e <strong>di</strong> fine e causa dell’economia delle singole parti 18.<br />
4.<br />
[Cecità colpevole <strong>di</strong> chi si interessa della natura e non riconosce Dio]<br />
[1] Probabilmente la sovrabbondanza della sapienza del cosmo apporterà loro un<br />
giorno un incremento nella dura condanna, perché, guardando tanto acutamente oggetti<br />
vani, si sono accecati volontariamente rispetto alla comprensione della verità. [2] Coloro<br />
che misurano le <strong>di</strong>stanze degli astri; che registrano quali <strong>di</strong> essi sono sempre visibili e<br />
settentrionali e quanti, trovandosi intorno al polo australe, sono visibili agli abitanti <strong>di</strong><br />
là, mentre restano sconosciuti a noi; coloro che sud<strong>di</strong>vidono la latitu<strong>di</strong>ne boreale e il<br />
cerchio dello zo<strong>di</strong>aco in innumerevoli intervalli; e hanno osservato con cura<br />
l’ascensione degli astri, i loro arresti e le loro declinazioni e il movimento in avanti <strong>di</strong><br />
tutti e in quanto tempo ciascuno dei pianeti compie la propria orbita; [3] <strong>di</strong> tutte le abilità<br />
una sola non riuscirono a trovarla, per poter riconoscere che Dio è l’artefice<br />
dell’universo e giu<strong>di</strong>ce giusto, che darà il degno contraccambio per le azioni compiute<br />
in vita; né seppero cogliere la nozione conseguente alla dottrina del giu<strong>di</strong>zio, quella cioè<br />
del compimento finale, poiché è necessario che il mondo cambi aspetto, se anche la situazione<br />
delle anime è destinata a trasformarsi in un altro genere <strong>di</strong> vita 19.<br />
[4] Come infatti la vita presente ha avuto una natura dello stesso genere <strong>di</strong> questo<br />
mondo, così anche la maniera <strong>di</strong> vivere futura delle nostre anime riceverà un esito<br />
adatto alla propria con<strong>di</strong>zione. Essi, però, sono tanto lontani dal prestare attenzione a<br />
queste verità, che che riversano gran<strong>di</strong> risate quando noi preannunciamo il compimento<br />
finale <strong>di</strong> questo mondo e la rigenerazione del secolo. [5] Dal momento, però, che secondo<br />
natura il principio è or<strong>di</strong>nato a precedere le cose che ne derivano, necessariamente,<br />
<strong>di</strong>scorrendo delle realtà che hanno ricevuto il loro essere dal tempo, Mosè ha premesso<br />
a tutte questa voce, <strong>di</strong>cendo: «in principio creò».<br />
16 La prima frase della Scrittura esprime già un insegnamento concernente la fine e la trasformazione del<br />
mondo sensibile!<br />
17 Eternità e assenza <strong>di</strong> generazione sono attributi <strong>di</strong>vini, che <strong>Basilio</strong> rifiuta <strong>di</strong> riconoscere al cosmo sensibile,<br />
destinato a subire lo stesso processo <strong>di</strong> composizione e <strong>di</strong>ssoluzione che coinvolge ogni sua parte.<br />
Lo stesso argomento si trova in Phil. Alex. Aet. 24; il principio che l’intero subisce il processo <strong>di</strong> nascita e<br />
morte delle sue parti è stoico (DL VII 1, a proposito <strong>di</strong> Posidonio e in riferimento non alla sostanza del<br />
cosmo, ma al suo or<strong>di</strong>namento).<br />
18 Si può cogliere qui un cenno molto sommario alla posizione peripatetica e a quella stoica.<br />
19 La dottrina del Dio unico creatore dal nulla è strettamente collegata con la dottrina della provvidenza e<br />
della retribuzione finale, da qui la sua centralità nell’ottica basiliana.<br />
6
5.<br />
[La creazione intelligibile precede il tempo]<br />
[1] C’era, infatti, qualcosa, a quanto pare, anche prima <strong>di</strong> questo cosmo, qualcosa<br />
che può essere contemplato dalla ragione, ma che è stato lasciato inespresso nella<br />
narrazione storica, perché inadatto a coloro che sono ancora bisognosi <strong>di</strong> essere introdotti<br />
e sono bambini nella conoscenza. C’era una con<strong>di</strong>zione più antica della genesi del<br />
cosmo e conveniente alle potenze sovracosmiche, una con<strong>di</strong>zione sovratemporale, eterna,<br />
perenne. [2] Il creatore e artefice <strong>di</strong> tutte le cose compì in essa come sue opere una<br />
luce intelligibile conveniente alla beatitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> coloro che amano il Signore, le nature<br />
razionali e invisibili e tutto l’or<strong>di</strong>namento delle realtà intelligibili, che trascendono la<br />
nostra ragione e delle quali non è nemmeno possibile scoprire le denominazioni. [3]<br />
Queste cose realizzano completamente la sostanza del cosmo invisibile, come ci insegna<br />
Paolo, <strong>di</strong>cendo: «in lui furono create tutte le cose, sia visibili, sia invisibili, troni, dominazioni,<br />
principati, potestà» (Col 1, 16), potenze, schiere <strong>di</strong> angeli, domini <strong>di</strong> arcangeli;<br />
quando bisognò, inoltre, anche questo mondo fu introdotto fra gli esseri, come luogo<br />
principale <strong>di</strong> istruzione ed educazione delle anime umane e poi anche, in generale, come<br />
luogo adatto alla <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> tutte le cose soggette a generazione e corruzione 20.<br />
[Natura del tempo]<br />
[4] Connaturato dunque al cosmo e agli esseri viventi e alle piante che si trovano<br />
in esso, sussiste il corso del tempo, che sempre incalza e scorre e mai si arresta nella sua<br />
corsa. Non è forse tale il tempo, del quale il passato è oramai cancellato, il futuro ancora<br />
non c’è e il presente, prima ancora <strong>di</strong> essere conosciuto sfugge alla percezione? Tale è<br />
in un certo senso anche la natura delle cose nel <strong>di</strong>venire o del tutto destinata ad accrescersi<br />
o a venire meno, ma che non ha nulla che sia in modo chiaro stabile e permanente.<br />
[5] Era dunque conveniente ai corpi degli esseri viventi e delle piante, <strong>di</strong> necessità<br />
legati a una sorta <strong>di</strong> corrente e tenuti stretti dal movimento che li conduce alla generazione<br />
o alla corruzione, essere contenuti dalla natura del tempo, che possiede un carattere<br />
proprio congenere a quello dei corpi soggetti a cambiamento. Quin<strong>di</strong> si de<strong>di</strong>cò in<br />
modo conveniente al <strong>di</strong>scorso relativo ad esso colui che sapientemente ci istruisce sulla<br />
genesi del cosmo, <strong>di</strong>cendo: «in principio creò»; cioè: in questo principio temporale 21.<br />
[I vari usi della nozione <strong>di</strong> “principio”]<br />
[6] Infatti per testimoniare ch’esso sia per antichità <strong>di</strong> generazione precedente a<br />
tutte le cose generate, egli <strong>di</strong>ce che il mondo è venuto all’essere in principio, ma dopo le<br />
cose invisibili e intelligibili, Mosè narra il principio dell’esistenza <strong>di</strong> queste realtà visibili<br />
e afferrabili con i sensi. Si chiama, infatti, principio anche il primo movimento, come<br />
«principio <strong>di</strong> una via buona è fare cose giuste» (Prov 16, 7). A partire, infatti, dalle<br />
azioni giuste ci muoviamo dapprima verso la vita beata. [7] Si <strong>di</strong>ce, poi, principio ciò da<br />
cui qualcosa si genera, [[<strong>di</strong> ciò che sussiste in essa]] come nel caso <strong>di</strong> un’abitazione le<br />
fondamenta e nel caso <strong>di</strong> una nave la carena, come è detto: «principio della sapienza è il<br />
timore del Signore» (Prov 1, 7 o 9, 10?). Il timore è, infatti, come il punto <strong>di</strong> appoggio e<br />
20 <strong>Basilio</strong> si avvicina qui alle posizioni <strong>di</strong> <strong>Filone</strong> e <strong>Origene</strong> e ammette che prima della creazione del<br />
cosmo visibile Dio abbia operato la creazione delle realtà intelligibili, le potenze angeliche, alla quale<br />
trova un cenno in Col; si osservi tutta via la clausola prudenziale «a quanto pare», che attenua<br />
l’affermazione. Anche l’idea che il mondo sensibile sia un luogo <strong>di</strong> educazione, una scuola per le creature<br />
decadute a causa del peccato viene dalla tra<strong>di</strong>zione alessandrina.<br />
21 Quin<strong>di</strong> <strong>Basilio</strong> sposa senza riserve l’interpretazione del termine !"#$ come inizio nel tempo della<br />
creazione del mondo sensibile, anche se , come si vedrà sotto, non esclude altri significati possibili. Sulla<br />
natura del tempo cf. Plat. Tim. 37 C-38 B; Aristot. Phys. IV 11, 219 b.<br />
7
il fondamento per la perfezione. Principio, poi, è anche l’arte per le opere artigianali:<br />
come la sapienza <strong>di</strong> Beseleel, per l’ornamento del tabernacolo. Principio delle azioni<br />
anche spesso il fine utile delle cose che accadono: come l’essere accetti a Dio è principio<br />
dell’elemosina e il fine posto nelle promesse è il principio <strong>di</strong> ogni attività conforme<br />
a virtù 22.<br />
6.<br />
[Applicazione al testo biblico]<br />
[1] Essendo, dunque, detto in tanti mo<strong>di</strong> il termine “principio”, considera se la<br />
presente espressione non si adatti a tutti i significati. E infatti ti sarà possibile apprendere<br />
da quale tempo ebbe inizio la costituzione <strong>di</strong> questo cosmo, se risalendo dal presente<br />
all’in<strong>di</strong>etro, ti impegnerai a trovare il primo giorno della genesi del cosmo. [2] Troverai<br />
così da dove al tempo sia giunto il primo moto, poi troverai che a mo’ <strong>di</strong> fondamenta e<br />
basi furono posti il cielo e la terra; poi troverai che c’è una ragione artefice, che ha guidato<br />
l’or<strong>di</strong>namento delle cose visibili, come ti in<strong>di</strong>ca la parola “principio”. E poi troverai<br />
che non a caso né invano, ma per un fine utile e per una grande utilità che è stato apportato<br />
a tutti gli esseri è stato pensato il cosmo, se per davvero esso è una scuola per le<br />
anime razionali e un luogo <strong>di</strong> educazione in vista della conoscenza <strong>di</strong> Dio, capace <strong>di</strong> offrire<br />
all’intelletto per mezzo delle cose visibili e sensibili un accompagnamento verso la<br />
contemplazione delle cose invisibili, secondo quanto <strong>di</strong>ce l’apostolo: «le sue opere invisibili<br />
dalla fondazione del mondo possono essere viste col pensiero me<strong>di</strong>ante le cose<br />
create» (Rom 1, 20).<br />
O forse a causa del carattere istantaneo e intemporale della creazione è stato detto:<br />
«In principio creò», perché il principio è una cosa priva <strong>di</strong> parti e <strong>di</strong> intervalli. Come,<br />
infatti, il principio <strong>di</strong> una strada non è ancora la strada, e il principio <strong>di</strong> una casa non è<br />
ancora la casa, così anche il principio del tempo non è ancora tempo, ma non è nemmeno<br />
una sua parte minima. Se qualcuno per opposizione <strong>di</strong>cesse che il principio è tempo,<br />
sappia che lo <strong>di</strong>viderà nelle parti del tempo. Queste sono il principio, il mezzo e la fine.<br />
Ma è del tutto ri<strong>di</strong>colo supporre un principio del principio. [4] E colui che <strong>di</strong>vide in due<br />
il principio, ne farà due invece <strong>di</strong> uno solo, anzi ne farà molti e infiniti, dal momento<br />
che ciò che è stato <strong>di</strong>viso può sempre essere scisso in altre parti. Affinché dunque fossimo<br />
istruiti sul fatto che il cosmo sussistette in modo intemporale contemporaneamente<br />
alla volontà <strong>di</strong> Dio, è stato detto: «in principio creò» 23. Cosa che altri traduttori, esprimendo<br />
in modo più chiaro l’inten<strong>di</strong>mento, hanno detto: «in compen<strong>di</strong>o Dio creò», cioè<br />
in modo cumulativo e in poco24. Queste dunque le cose riguardanti il principio, per <strong>di</strong>rne<br />
poche fra le molte.<br />
7.<br />
[Distinzione fra azione e produzione]<br />
[1] Poiché fra le arti le une sono dette produttive, altre sono dette pratiche e altre<br />
teoretiche. Il fine delle arti teoretiche è l’attività secondo intelletto, il fine delle arti pratiche<br />
è il movimento stesso del corpo, cessato il quale nulla più esiste e nulla rimane da-<br />
22 Viene ripreso lo schema aristotelico delle quattro cause (Aristot. Metaph. I 3, 983 a 26 s; VI 1, 1012 b<br />
34 s; la nozione <strong>di</strong> “causa” viene implicitamente identificata qui con la nozione <strong>di</strong> “principio”: Metaph.<br />
IV 1, 1013 a 16s.): causa efficiente (inizio del movimento), materiale (ciò da cui si genera qualcosa),<br />
formale (la sapienza), finale (il fine utile).<br />
23 Sembra che qui l’interprete proponga un punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>verso: prima sottolineava il carattere temporale<br />
della creazione del cosmo, ora sembra concentrare la propria attenzione sulle caratteristiche dell’atto<br />
della creazione, che non può avvenire nel tempo, perché è esso stesso la con<strong>di</strong>zione del sorgere del<br />
tempo. [Non sono convinto che le due prospettive siano armonizzabili]<br />
24 <strong>Basilio</strong> accenna qui alla traduzione del primo versetto <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> fatta da Aquila secondo criteri <strong>di</strong> rigido<br />
letteralismo: ., /&0)1)(2 3/*45&, 6 %&78.<br />
8
vanti agli occhi <strong>di</strong> chi osserva: giacché il fine della danza o del suono del flauto non è<br />
alcunché <strong>di</strong> altro e l’attività ha in se stessa il proprio termine: [2] nelle arti produttive,<br />
invece, anche una volta cessata l’attività, resta il suo prodotto; come nel caso<br />
dell’architettura delle costruzioni, della metallurgia o della tessitura e <strong>di</strong> altre arti simili,<br />
che, anche se non sia presente l’artigiano, manifestano in modo adeguato in se stesse le<br />
regole dell’arte e ti è così possibile ammirare l’architetto dalla casa, così pure il fabbro e<br />
il tessitore. [3] Affinché, dunque, fosse mostrato che il cosmo è un’opera d’arte, proposta<br />
alla contemplazione <strong>di</strong> tutti, in modo tale che per mezzo <strong>di</strong> esso fosse riconosciuta la<br />
sapienza <strong>di</strong> colui che l’ha creato, il sapiente Mosè non ha utilizzato un’altra espressione<br />
riguardo ad esso, ma ha detto: «in principio creò», non <strong>di</strong>sse «agì», né «fece sussistere»,<br />
ma «creò» 25. [4] E per il fatto che molti fra quanti hanno immaginato che il cosmo sussista<br />
dall’eternità insieme a Dio non hanno ammesso ch’esso sia venuto all’essere per opera<br />
sua, ma che, essendo come un’ombra <strong>di</strong> Dio, esso sia venuto a sussistere spontaneamente<br />
(e riconoscono sì che Dio ne è la causa, ma non per deliberazione, come il corpo<br />
è causa dell’ombra e il corpo luminoso lo è della luminosità), per correggere, dunque,<br />
un tale inganno, il profeta si è servito <strong>di</strong> questi termini precisi, <strong>di</strong>cendo: «in principio<br />
Dio creò» 26.<br />
[Cielo e terra alludono alla totalità del cosmo sensibile]<br />
[5] Dio non si limitò a offrire questo al mondo, cioè la causa della sua esistenza,<br />
bensì creò, in quanto buono, ciò che è utile, in quanto sapiente, ciò che è sommamente<br />
bello e, in quanto potente, ciò che è più grande. Quasi quasi, infatti, Mosè ti ha mostrato<br />
l’artigiano alle prese con la sostanza della totalità delle cose, mentre armonizzava l’una<br />
all’altra le singole parti delle cose e portava a termine l’universo in modo che fosse concorde,<br />
consonante e in armonia con se stesso. [6] «In principio Dio creò il cielo e la terra».<br />
A partire dai due estremi, ha alluso enigmaticamente all’esistenza dell’universo, assegnando<br />
al cielo la precedenza nella generazione e affermando che la terra è seconda<br />
nell’esistenza 27. [7] Sicché, anche se non ha detto nulla a proposito degli elementi, del<br />
fuoco, dell’acqua e dell’aria, devi comprendere da solo con la tua intelligenza per prima<br />
cosa che tutte le cose sono state mescolate con tutte, e nella terra troverai anche l’acqua,<br />
l’aria e il fuoco, se è vero che dalle pietre scaturisce il fuoco, dal ferro, che ha anch’esso<br />
la propria genesi nella terra, per natura brilla in virtù dello sfregamento un fuoco abbondante.<br />
[8] Il che è anche degno <strong>di</strong> meraviglia: come il fuoco, essendo presente nei corpi,<br />
vi si nasconda senza fare danno; ma una volta provocato a uscire all’esterno, è capace <strong>di</strong><br />
consumare quegli oggetti che fino a quel momento lo avevano custo<strong>di</strong>to. Che la natura<br />
dell’acqua sia presente nella terra lo mostrano gli scavatori <strong>di</strong> pozzi; e la natura dell’aria<br />
la mostrano i vapori che si innalzano da essa quando, essendo umida, è stata scaldata dal<br />
sole. [9] Inoltre, se per natura il cielo occupa il luogo più alto, mentre la terra è la realtà<br />
più bassa, poiché verso il cielo si muovono le cose leggere, mentre per natura si volgono<br />
alla terra le cose pesanti, e l’alto e il basso sono l’uno l’opposto dell’altro, colui che ha<br />
25 Se il cosmo sensibile è scuola delle creature, ciò che in esso viene loro insegnato è riconoscere attraverso<br />
le opere visibili l’eccellenza del creatore invisibile che le ha fatte; questa la ragione delle osservazioni<br />
sulla tripartizione delle attività umane (cf. Plat. Pol. 258 BE; Aristot. Metaph. VI 1, 1025 b 20 ss.;<br />
Top. VI 6, 145 a 15). Cf. Pépin, Théologie cosmique, 344-347.<br />
26 La produzione del mondo da parte <strong>di</strong> Dio non è l’esito spontaneo <strong>di</strong> un’attività intrinseca alla natura <strong>di</strong>vina<br />
(si poteva leggere in questo senso la concezione plotiniana della <strong>di</strong>pendenza della realtà sensibile dal<br />
primo principio: p.e. Enn. IV 8, 6), ma il prodotto <strong>di</strong> un atto volontario e deliberato con il quale Dio decide<br />
<strong>di</strong> manifestare se stesso. Creazione e rivelazione sono i due momenti <strong>di</strong> un’unica economia <strong>di</strong>vina.<br />
27 Diversamente da <strong>Filone</strong> e <strong>Origene</strong>, <strong>Basilio</strong> non pensa che cielo e terra in <strong>Gen</strong> 1, 1 si riferiscano a realtà<br />
<strong>di</strong>fferenti dal cielo e dalla terra sensibili (firmamento e suolo arido); essi hanno qui semplicemente la<br />
funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care in modo abbreviato, attraverso i suoi punti estremi, la totalità della creazione cosmica.<br />
9
icordato le realtà per loro natura massimamente <strong>di</strong>stanti fra loro ha implicitamente fatto<br />
riferimento anche a tutte quelle che riempiono lo spazio interme<strong>di</strong>o fra loro. Sicché non<br />
devi cercare la spiegazione delle singole cose particolari, ma intendere le cose taciute a<br />
partire da quelle dette esplicitamente.<br />
8.<br />
[Che cosa insegna la Scrittura sulla natura del cielo]<br />
[1] «In principio Dio creò il cielo e la terra». L’indagine circa l’essenza <strong>di</strong> ciascun<br />
essere, <strong>di</strong> quelli che sono oggetto della nostra contemplazione o <strong>di</strong> quelli che ricadono<br />
sotto la nostra percezione sensibile, introduce nell’esegesi del testo un <strong>di</strong>scorso<br />
lungo e deviante, sì da dover spendere nell’esame <strong>di</strong> questo problema più parole <strong>di</strong> tutte<br />
le altre che converrebbe <strong>di</strong>re a proposito delle altre questioni oggetto <strong>di</strong> ricerca. E inoltre,<br />
non sarebbe nemmeno <strong>di</strong> alcun vantaggio per l’e<strong>di</strong>ficazione della chiesa il soffermarsi<br />
lungamente su questo tema 28. [2] Ma sull’essenza del cielo ci bastano le parole<br />
dette da Isaia; egli con parole semplici ci ha offerto una sufficiente intelligenza della sua<br />
natura, <strong>di</strong>cendo: «colui che ha fissato il cielo come fosse fumo» (Is 51, 6), cioè colui che<br />
per la costituzione del cielo ha dato esistenza a una natura sottile, non solida né spessa.<br />
Anche a proposito della figura del cielo ci è sufficiente quel che viene da Isaia, che a<br />
gloria <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong>ce: «colui che ha posto il cielo come una cupola» (Is 40, 22).<br />
[Insegnamento della Scrittura sulla natura della terra]<br />
[3] Anche riguardo alla terra convinciamoci della stessa cosa, a non darci troppo<br />
pensiero <strong>di</strong> quale mai sia la sua essenza, a non passare il tempo cercandone con ragionamenti<br />
il substrato e a non ricercare una qualche natura priva <strong>di</strong> qualità, che esista per<br />
sé senza qualità, ma persua<strong>di</strong>amoci a sapere bene che tutte le cose che si colgono in essa<br />
con il ragionamento sono state or<strong>di</strong>nate alla ragione del suo essere e ne portano a compimento<br />
l’essenza. [4] A un nulla, infatti, arriverai, se cerchi <strong>di</strong> toglierne con il ragionamento<br />
ciascuna delle qualità che in essa sussistono. Se, infatti, rimuoverai il nero, il<br />
freddo, il pesante, il solido, le qualità relative al gusto presenti in essa o altre, se ve ne<br />
sono, che si possono riconoscere in essa, il substrato che rimarrà non sarà nulla 29. Né ti<br />
esorto, una volta che hai messo da parte questi problemi, a ricercare quest’altra cosa, su<br />
quale base poggi la terra.<br />
[Ipotesi sulla posizione della terra nel cosmo]<br />
[5] Anche così, infatti, la ragione avrà le vertigini, dal momento che il ragionamento<br />
non arriverà ad alcun termine su cui ci sia accordo. Qualora, infatti, tu <strong>di</strong>ca che<br />
l’aria è <strong>di</strong>stesa come una coltre al <strong>di</strong> sotto della superficie della terra, avrai il problema<br />
<strong>di</strong> come questa natura molle e piena <strong>di</strong> vuoti possa sopportare <strong>di</strong> essere schiacciata a un<br />
peso così grande, e non scivoli via da ogni parte, sfuggendo alla compressione, <strong>di</strong>ffondendosi<br />
al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> ciò che la schiaccia. [6] Di nuovo, qualora tu supponga che sia<br />
l’acqua ciò che è posto al <strong>di</strong> sotto della terra, anche in questo caso sarai alla ricerca <strong>di</strong><br />
come ciò che è pesante e denso non si immerga attraverso l’acqua, una realtà tanto superiore<br />
per peso sia trattenuta dalla natura più debole. Oltre a cercare anche la base<br />
28 Le <strong>di</strong>scussioni scientifiche non costituiscono un valore in sé, ma hanno senso solo nella prospettiva<br />
dell’e<strong>di</strong>ficazione, cioè del progresso spirituale <strong>di</strong> coloro che le ascoltano. Affermazione che rischia <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ventare sprezzante, ma che è giustificata dal contesto e dal genere letterario del <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> <strong>Basilio</strong>.<br />
29 I §§ 3-4 dalla terra passano all’esame della nozione <strong>di</strong> “materia” intesa in termini peripatetici e stoici<br />
come substrato assolutamente privo <strong>di</strong> qualità, ma capace <strong>di</strong> accoglierle tutte (cf. aristot. Metaph. VII 3,<br />
1029 a 20; VIII 2, 1042 b 9). <strong>Basilio</strong> sembra raicalizzare la posizione, affermando che, eliminando tutte le<br />
qualità, si arriva al nulla (qualcosa del genere in Calc. In Tim. [?]).<br />
10
dell’acqua stessa e a doverti <strong>di</strong> nuovo domandare su quale base impermeabile e resistente<br />
poggi il suo ultimo fondamento 30.<br />
9.<br />
[1] E se supponi che un secondo corpo, più pesante della terra, impe<strong>di</strong>sca che la<br />
terra cada verso il basso, penserai che anche quello abbia bisogno <strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> simile<br />
che lo trattenga e non lo lasci precipitare. E anche se, inventando, riuscissimo a sottoporre<br />
qualcosa anche a quello, <strong>di</strong> nuovo il nostro intelletto andrà alla ricerca del sostegno<br />
<strong>di</strong> quest’ultima cosa e così cadremo all’infinito, sempre <strong>di</strong> nuovo escogitando degli<br />
altri supporti per quelli che abbiamo <strong>di</strong> volta in volta trovato 31. [2] E quanto più avanti<br />
proce<strong>di</strong>amo nel ragionamento, tanto più grande è la potenza resistente che siamo costretti<br />
a introdurre, perché possa sostenere tutto insieme ciò che le sta sopra. Perciò metti<br />
dei limiti al tuo ragionare, perché il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Giobbe non tocchi anche alla tua ansia<br />
<strong>di</strong> scoprire, mentre vai indagando ciò che non si può cogliere, e anche tu non venga da<br />
lui interrogato: «A che cosa sono attaccati i suo anelli?» (Gb 38, 6). [3] Ma, qualora tu<br />
ascolti nei Salmi: «Io ho fissato le sue colonne» (Sal 74, 4), considera che è stata chiamata<br />
“colonne” la forza che sostiene la terra. Il detto «sui mari ne pose le fondamenta»<br />
(Sal 23, 2) che cosa mostra, se non che tutt’intorno alla terra è <strong>di</strong>ffusa la natura<br />
dell’acqua? Come, dunque, essendo l’acqua scorrevole e per natura portata a cadere verso<br />
il basso, rimane sospesa e non scorre da nessuna parte? Tu però non pensi che il medesimo<br />
problema o anche maggiore, lo pone alla ragione la terra che rimane sospesa da<br />
se stessa, pur essendo per natura più pesante. [4] Ma, sia che ammettiamo che la terra<br />
sia per se stessa, sia che <strong>di</strong>ciamo ch’essa è fissata sull’acqua, è necessario che non ci allontaniamo<br />
in alcun caso dal ragionare piamente, ma confessiamo che tutto viene tenuto<br />
insieme dalla potenza del creatore. Questo, dunque, è necessario che <strong>di</strong>ciamo a noi stessi<br />
e a coloro che ci interrogano su che cosa questo inesauribile e insopportabile peso<br />
della terra sia appoggiato: «Nella mano <strong>di</strong> Dio sono i confini della terra» (Sal 94, 4).<br />
Questa è la cosa più sicura che possiamo <strong>di</strong>re per la nostra intelligenza e utile a coloro<br />
che ci ascoltano.<br />
10.<br />
[1] Alcuni tra i fisici si compiacciono già <strong>di</strong> sostenere presuntuosamente che la<br />
terra rimane immobile anche per tali cause. Per il fatto che essa ha occupato lo spazio al<br />
centro dell’universo e, a causa della <strong>di</strong>stanza identica in tutte le <strong>di</strong>rezioni rispetto agli<br />
estremi, non avendo motivo <strong>di</strong> inclinare da una parte più che dall’altra, necessarimante<br />
rimane ferma su se stessa, dal momento che l’uguaglianza che la circonda da ogni parte<br />
le rende del tutto impossibile l’inclinazione verso qualchecosa. [2] La terra ha ricevuto<br />
in sorte la regione centrale non a capriccio ne per caso, ma questa posizione è per la terra<br />
naturale e necessaria. Dal momento, infatti, che il corpo celeste occupa l’estremità<br />
dello spazio verso l’alto, i pesi che, essi <strong>di</strong>cono, supporremmo cadere dall’alto, si raccoglieranno<br />
in realtà da tutte le parti verso il centro. Ed è chiaro che il punto verso il quale<br />
le parti sono condotte è anche quello dove si raccoglierà l’intero. [3] Se pietre e legno e<br />
tutti i corpi <strong>di</strong> terra sono condotti verso il basso questa sarà anche la posizione propria e<br />
conveniente per la terra tutta intera; e se qualcuno dei corpi leggeri è portato via dal centro<br />
chiaramente sarà mosso verso la regione superiore. Sicché il movimento proprio dei<br />
corpi più pesanti è quello verso il basso; ma la ragione ci ha mostrato che il basso è la<br />
parte centrale. Non ti stupire, dunque, se la terra non precipita da nessuna parte, dal<br />
momento che occupa il centro come suo luogo naturale. [4] È infatti assolutamente ne-<br />
30 Per queste due ipotesi cf. Aristot. De cael. II 13, 294 ab.<br />
31 Cf. Aristot. De cael citato sopra?<br />
11
cessario che essa rimanga nel proprio spazio oppure che si allontani dalla propria sede<br />
con un movimento contro natura 32.<br />
Se qualcuna <strong>di</strong> queste affermazioni ti sembra plausibile, trasferisci la tua ammirazione<br />
alla sapienza <strong>di</strong> Dio che ha or<strong>di</strong>nato cosi queste cose. Infatti, la stupefazione <strong>di</strong><br />
fronte alle cose più gran<strong>di</strong> non <strong>di</strong>minuisce anche qualora sia stato scoperto il modo in<br />
cui avviene uno <strong>di</strong> questi fatti straor<strong>di</strong>nari; e se ciò non accade, almeno la semplicità<br />
della fede sia più forte delle <strong>di</strong>mostrazioni razionali 33.<br />
11.<br />
[Ipotesi sulla natura del cielo]<br />
[1] Queste stesse cose potremmo <strong>di</strong>rle anche a proposito del cielo, dal momento<br />
che trattati formulati nei mo<strong>di</strong> più <strong>di</strong>versi sono stati composti dai sapienti del mondo intorno<br />
alla natura del cielo. E alcuni hanno detto che esso è composto a partire dai quattro<br />
elementi, in quanto è tangibile, visibile e partecipa della terra per la sua resistenza,<br />
del fuoco, perché lo si può vedere, e degli altri elementi a causa della mescolanza34. Altri,<br />
avendo respinto questo <strong>di</strong>scorso, considerandolo inverosimile, introdussero una<br />
quinta natura corporea per la costituzione del cielo inventandosela da sé35. [2] Secondo<br />
costoro, esiste qualcosa, il corpo etereo, che non è né fuoco, essi <strong>di</strong>cono, né aria, né terra,<br />
né acqua, né affatto alcuno degli elementi semplici; poiché il moto proprio agli elementi<br />
semplici è quello rettilineo, dal momento che i corpi leggeri sono portati verso<br />
l’alto, mentre quelli pesanti verso il basso. Ma né il movimento verso l’alto né il movimento<br />
verso il basso è identico alla rotazione circolare; ed essi <strong>di</strong>cono che il movimento<br />
rettilineo è massimamente <strong>di</strong>stante rispetto alla rotazione circolare. [3] Di quei corpi,<br />
però, dei quali i moti naturali sono <strong>di</strong>versi, <strong>di</strong> questi, essi <strong>di</strong>cono36, è necessario che<br />
siano <strong>di</strong>verse anche le essenze. Tuttavia non ci è possibile supporre nemmeno che il<br />
cielo sia un composto da quei corpi primi che chiamiamo elementi, dal momento che le<br />
realtà composte da elementi <strong>di</strong>fferenti non possono avere un moto uniforme e privo <strong>di</strong><br />
costrizioni, giacché ciascuno dei corpi semplici che sono presenti nei corpi composti<br />
riceve dalla propria natura un impulso <strong>di</strong>verso dagli altri. [4] Perciò per prima cosa a<br />
fatica i corpi composti sono mantenuti in un movimento continuo, per il fatto che gli<br />
elementi opposti non possono avere un movimento armonico e concorde comune a tutti;<br />
ma quello proprio all’elemento leggero è nemico <strong>di</strong> quello più pesante. Quando, infatti,<br />
siamo mossi verso l’alto, siamo appesantiti dall’elemento terrestre; quando siamo<br />
condotti verso il basso, facciamo violenza all’elemento igneo, trascinandolo in basso<br />
contro la sua natura. [5] Questo trascinarsi degli elementi in <strong>di</strong>rezioni opposte è<br />
principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione. Infatti, ciò che è costretto ed è contro natura, dopo aver<br />
32 Cf. Aristot. De cael. II13 295 b.<br />
33 <strong>Basilio</strong> de<strong>di</strong>ca una lunga <strong>di</strong>scussione alle questioni cosmologiche: posizione della terra rispetto agli altri<br />
elementi (aria e acqua) e sua collocazione nel cosmo, ma alla fine non si pronuncia per una tesi piuttosto<br />
che per un’altra, raccomandando solo ai propri u<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> conservare nei confronti della natura un atteggiamento<br />
pio, che consiste nel venerare in essa la potenza del Creatore. Fra coloro che respingevano<br />
l’interpretazione del cielo e della terra <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1 come realtà intelligibili, c’è prima <strong>di</strong> <strong>Basilio</strong> Teofilo <strong>di</strong><br />
Antiochia (Ad Autol. II 13), che si basa su Is 40, 22 per interpretare il cielo come un coperchio, una volta<br />
che racchiude il firmamento e ricopre, insieme ad esso, le acque e la terra; il fatto che Dio cominci la costruzione<br />
dell’universo dal tetto e non dalle fondamenta ne manifetsa la potenza superiore a quella degli<br />
architetti umani. Cosma In<strong>di</strong>copleuste Top. christ. II 6 immagina il cielo <strong>di</strong> <strong>Gen</strong> 1, 1 come una grande<br />
volta che copre il firmamento, che a sua volta copre la terra piatta, formando una costruzione che<br />
richiama quella dell’arca dell’alleanza; oppone questa visione alla concezione pagana <strong>di</strong> un cosmo<br />
sferico.<br />
34 Cf. Plat. Tim. 31 B-32 C.<br />
35 Cf. Aristot. De cael. I 2, 269 b 13<br />
36 Precisazione prudenziale (cf. anche sotto il § 6): <strong>Basilio</strong> espone nel dettaglio gli argomenti aristotelici,<br />
ma non perché li con<strong>di</strong>vida o li reputi migliori <strong>di</strong> altre teorie, come mostra la sbrigativa e liquidatoria<br />
conclusione al termine.<br />
12
zione. Infatti, ciò che è costretto ed è contro natura, dopo aver opposto per poco resistenza,<br />
e anche questo per costrizione e a fatica, ben presto si <strong>di</strong>scioglie nelle parti da<br />
cui è stato composto, poiché ciascuna delle parti che si erano riunite ritorna alla propria<br />
regione. [6] A causa <strong>di</strong> queste, come essi <strong>di</strong>cono, necessità logiche, dopo aver respinto i<br />
ragionamenti dei predecessori, coloro che suppongono una quinta natura corporea per la<br />
generazione del cielo e degli astri che vi si trovano dovettero affidarsi ad una propria<br />
ipotesi. Un altro, però, <strong>di</strong> questi esuberanti nelle invenzioni plausibili sorgendo nuovamente<br />
contro costoro ha <strong>di</strong>sperso e <strong>di</strong>ssolto queste dottrine, ed ha introdoto al loro posto<br />
una propria opinione. Se mettessimo mano a parlare adesso <strong>di</strong> queste cose cadremo anche<br />
noi nella loro stessa loquacità.<br />
[Conclusione e invito alla lode]<br />
[7] Ma noi, lasciando che quelli si confutino l’uno con l’altro, messo da parte per<br />
quanto ci riguarda il <strong>di</strong>scorso relativo all’essenza, prestando fede a Mosè che «in principio<br />
Dio creò il cielo e la terra», glorifichiamo l’ottimo artefice <strong>di</strong> tutte le cose generate<br />
con sapienza e arte e, a partire dalla bellezza delle cose visibili, compren<strong>di</strong>amo colui che<br />
è superiore alla bellezza, dalla grandezza <strong>di</strong> questi corpi sensibili e delimitabili deduciamo<br />
per analogia colui che è infinito, superiore alla grandezza e trascendente ogni<br />
pensiero nell’abbondanza della sua potenza 37. [8] E infatti, anche se ignoriamo la natura<br />
delle cose generate, ciò che da ogni parte cade sotto i nostri sensi è una cosi grande fonte<br />
<strong>di</strong> meraviglia 38 che anche l’intelletto più acuto apparirebbe inferiore rispetto alla minima<br />
fra le cose <strong>di</strong> questo mondo, per quanto riguarda il poterne dare una degna spiegazione<br />
o il rendere la dovuta lode al suo creatore, al quale sia ogni gloria, onore e potenza<br />
nei secoli dei secoli. Amen.<br />
37 Ritornano le tesi <strong>di</strong> Rom 1, 20-22.<br />
38 Ancora il tema della meraviglia.<br />
13