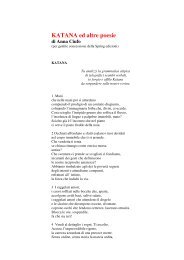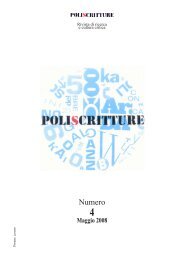L'ombra in poesia Appunti su Verbale di Michele ... - poliscritture
L'ombra in poesia Appunti su Verbale di Michele ... - poliscritture
L'ombra in poesia Appunti su Verbale di Michele ... - poliscritture
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’ombra <strong>in</strong> <strong>poesia</strong><br />
<strong>Appunti</strong> <strong>su</strong> <strong>Verbale</strong> <strong>di</strong> <strong>Michele</strong> Ranchetti<br />
<strong>di</strong> Ennio Abate<br />
<strong>Michele</strong> Ranchetti (1925-2008), stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> storia della Chiesa, <strong>di</strong> Wittgenste<strong>in</strong>, Heidegger e Freud,<br />
saggista, poeta, traduttore <strong>di</strong> Celan e Rilke, è morto il 2 febbraio. L’avevo <strong>in</strong>terrogato nel 2005 per<br />
«Poliscritture» (Cfr. n. zero, maggio 2005 o <strong>su</strong> www.<strong>poliscritture</strong>.it) <strong>su</strong> Non c’è più religione (Garzanti<br />
2003), libro <strong>in</strong> cui svolgeva un <strong>di</strong>scorso drastico e spietato <strong>su</strong> quello che più tar<strong>di</strong> avrebbe chiamato «il<br />
<strong>di</strong>sagio nella civiltà cristiana» (Cfr. il numero monografico de «L’ospite <strong>in</strong>grato», 2, 2006, da lui<br />
curato). Con questi appunti <strong>su</strong>ll’immag<strong>in</strong>e che mi sono costruita <strong>di</strong> lui e la <strong>poesia</strong> del <strong>su</strong>o <strong>Verbale</strong><br />
(Garzanti 2001) qui lo ricordo. [E.A.]<br />
Ora già tutto è <strong>di</strong>ventato breve:<br />
la luce, il passo e lo stesso mio corpo<br />
e breve è il tempo e breve la <strong>di</strong>stanza<br />
tra me e la f<strong>in</strong>e se anche la durata<br />
della vita è immensa<br />
(Ranchetti, <strong>Verbale</strong>)<br />
1.<br />
Ranchetti, uomo cresciuto <strong>in</strong>teramente nell’epoca del Libro, espone <strong>in</strong> <strong>Verbale</strong> una verità quasi<br />
<strong>in</strong>sopportabile. Ci cozzo contro quando leggo versi come questi: «tu vivi, viviamo, nell’altro / lato del<br />
foglio che riceve il senso / dal <strong>su</strong>o contrario e quando tu lo ve<strong>di</strong> / è tar<strong>di</strong> per la vita, hai compiuto / tutto<br />
il tragitto, sei al <strong>di</strong> là / <strong>di</strong> te stesso, sei te stesso morto». 1 Tale verità egli la coglie <strong>in</strong> quei «momenti <strong>di</strong><br />
un giro a vuoto mentale» 2 permessi solo dalla <strong>poesia</strong> e non è «trasmettibile, né convertibile <strong>in</strong> una<br />
forma <strong>di</strong>versa (filosofica, religiosa, estetica)». 3 Non può dunque essere “narrata” o “spiegata” (il che<br />
comporterebbe una <strong>di</strong>stensione temporale più o meno arbitrariamente decisa). Per lui può essere<br />
fissata soltanto <strong>in</strong> «momenti(frammenti)» 4 . E perciò <strong>Verbale</strong> non è il ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> uno scienziato:<br />
quella verità, rimug<strong>in</strong>ata dentro per una vita <strong>in</strong>tera e tutta <strong>in</strong>teriore, ha solo <strong>in</strong> <strong>su</strong>perficie tratti<br />
oggettivi; va sentita; a descriverla sfugge o appare ovvia, banale.<br />
2.<br />
Già dalla scelta dei tre eserghi <strong>in</strong>iziali 5 so cosa <strong>in</strong>contrerò <strong>in</strong> questa raccolta: nube (ombra), malattia,<br />
morte dell'animale (dell’uomo). 6 Vado <strong>in</strong>contro a una scarnificazione del mondo, alla <strong>su</strong>a assenza. Lo<br />
spirituale esclude il secolare («exivi / da seculo», p. 55). In <strong>poesia</strong> - e <strong>in</strong> maniera ancora più decisa che<br />
1 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>, pag. 96, Garzanti, Milano 2001<br />
2 M. Ranchetti, La mente musicale, pag. 7, Garzanti, Milano 1988<br />
3 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>, pag. 133, Garzanti, Milano 2001<br />
4 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>, pag. 133, Garzanti, Milano 2001<br />
5 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>:<br />
Ecce nubes lucida obumbravit eos (Matteo, XVII,5)<br />
Il pensiero <strong>di</strong> volermi aiutare è una malattia (Kafka, Il cacciatore Gracco.)<br />
Qual è quella cosa che ha occhi da cane, coda da cane,<br />
orecchie da cane e non è un cane?<br />
Una cagna.<br />
No, un cane morto.<br />
(Indov<strong>in</strong>ello per bamb<strong>in</strong>i.)<br />
6 Mengaldo dal canto <strong>su</strong>o <strong>in</strong><strong>di</strong>vidua questi temi: «le venature cristologiche, il cont<strong>in</strong>uo confronto io / tu o “altro”, la morte e<br />
specialmente la morte della madre» (P.V. Mengaldo, Poesie recenti <strong>di</strong> Ranchetti. Una testimonianza <strong>in</strong> Anima e paura. Stu<strong>di</strong><br />
<strong>in</strong> onore <strong>di</strong> <strong>Michele</strong> Ranchetti, p. 433, Quo<strong>di</strong>libet, Macerata 1988.<br />
1
nei <strong>su</strong>oi scritti <strong>in</strong> prosa - la storia, la politica, l'<strong>in</strong>dustria, la lotta <strong>di</strong> classe, la “realtà” (ciò che ha<br />
occupato - ancora occupa - la mia mente e logora i corpi <strong>di</strong> tanti) - sono abolite. Qui Ranchetti volge<br />
ancora più decisamente le spalle a quoti<strong>di</strong>anità, cronaca e storia. Rispetto a lui, che ha cont<strong>in</strong>uato<br />
attivamente a pensare e ad agire nell’habitat del pensiero religioso cattolico, noi che ci siamo voluti<br />
adulti e moderni, rimaniamo separati.<br />
3.<br />
Ranchetti è rimasto cattolico, dunque? Credo <strong>di</strong> sì. Ma con un cattolico che, scrivendo Praevalebunt 7 o<br />
Intellettuali e Chiesa cattolica: tesi (ora <strong>in</strong> Non c’è più religione 8 ), ha svelato il nichilismo<br />
del«cattolicesimo <strong>di</strong> questi <strong>in</strong>izi del terzo millennio», 9 atei, agnostici o non credenti possono, se non<br />
<strong>in</strong>tendersi, confrontarsi al <strong>di</strong> fuori dai mille equivoci che <strong>in</strong>aci<strong>di</strong>scono i correnti <strong>di</strong>scorsi che si fanno <strong>su</strong><br />
“ritorno della religione”, “ateismo devoto”, “teocon”.<br />
4.<br />
Per la <strong>su</strong>a “nostalgia <strong>di</strong> cristianesimo”, Ranchetti sta però <strong>su</strong> un altro piano rispetto a un Fort<strong>in</strong>i o a un<br />
Ernst Bloch, che, prospettando un possibile e reciproco <strong>in</strong>veramento utopico sia del dramma religioso<br />
che <strong>di</strong> quello mondano, hanno avuto ai miei occhi il merito <strong>di</strong> sp<strong>in</strong>gersi più <strong>di</strong> lui verso un possibile<br />
punto <strong>di</strong> confluenza tra cristianesimo antico e marxismo moderno. La <strong>su</strong>a a-mondanità è così netta che,<br />
al confronto, la religiosità <strong>di</strong> un Bloch o <strong>di</strong> un Fort<strong>in</strong>i non possono apparire che "teatrali", il che – credo<br />
– spieghi la <strong>su</strong>a <strong>di</strong>sattenzione al primo e le <strong>su</strong>e rimarcate riserve nei confronti del secondo. 10 Non c'è<br />
posto <strong>in</strong> Ranchetti per la contrad<strong>di</strong>zione nella storia. Il dramma <strong>in</strong> lui resta solo religioso. E perciò,<br />
coerentemente, anche <strong>in</strong> <strong>poesia</strong> egli resp<strong>in</strong>ge una «poetica [che non abbia] carattere <strong>di</strong> esperienza<br />
particolare», com’è quella fort<strong>in</strong>iana, f<strong>in</strong>o a giu<strong>di</strong>carla «ri<strong>su</strong>ltato <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> ragione, sia pur <strong>di</strong><br />
ragione poetica» che preclude «quelle cadute verticali nell’immag<strong>in</strong>azione poetica (e sia pure un Grand<br />
Hotel Abgrund)» che <strong>in</strong> <strong>poesia</strong> per lui sono l’essenziale. 11 Quando la sp<strong>in</strong>ta poetica si affaccia nella<br />
mente <strong>di</strong> Ranchetti, il dramma storico, pur da lui <strong>in</strong>dagato soprattutto <strong>su</strong>l versante della storia della<br />
Chiesa, è del tutto accantonato e vanificato: «l'assenza / si <strong>in</strong>troduce ed è l'essenza – egli scrive - e la<br />
luce è «luce del morto <strong>in</strong> te, luce / luce perpetua del compito, luce / precipua d'ombra, contro luce». 12<br />
4.<br />
Devo <strong>di</strong>re che buona parte del mio breve carteggio con Ranchetti è avvenuto all’ombra <strong>di</strong> Fort<strong>in</strong>i: io,<br />
impressionato com’ero stato dal tono sicuramente fuori dal coro del <strong>di</strong>scorso da lui tenuto durante la<br />
commemorazione <strong>di</strong> Fort<strong>in</strong>i che si ebbe all’Università <strong>di</strong> Siena nel 1995, 13 lo <strong>in</strong>calzai poi proprio <strong>su</strong>i<br />
7 Cfr. La rivista del manifesto, n. 10 ottobre 2000. Oppure:<br />
http://www.larivistadelmanifesto.it/php3/ric_view.php3?page=/archivio/10/10A20001018.html&word=Ranchetti;Praevale-<br />
bunt<br />
8 M. Ranchetti, Non c’è più religione, Garzanti, Milano 2003.<br />
9 M. Ranchetti, Non c’è più religione, pag. 14, Garzanti, Milano 2003.<br />
10 Le numerose volte che ho riletto Franco Fort<strong>in</strong>i esorcista (<strong>in</strong> Ranchetti, Scritti <strong>di</strong>versi II, pag. 233, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> storia e<br />
letteratura, Roma 1999) ho notato (e lo scrissi anche a <strong>Michele</strong>) l’ambivalenza (reciproca, credo) del rapporto tra questi due<br />
<strong>in</strong>tellettuali. Ranchetti espone i <strong>su</strong>oi sentimenti contrad<strong>di</strong>ttori («forte nostalgia» per gli <strong>in</strong>contri con Fort<strong>in</strong>i e <strong>in</strong>sofferenza per<br />
il «dover sottostare senza colpa alcuna, al <strong>su</strong>o giu<strong>di</strong>zio»), mostrando quanto poco sia stato co<strong>in</strong>volto dalla passione che Fort<strong>in</strong>i<br />
metteva nei campi culturali da lui praticati (marxismo, letteratura e politica), tanto da centrare il ritratto-bilancio del “fratello<br />
maggiore” <strong>su</strong> pochi ricor<strong>di</strong> personali, privilegiando al massimo la soggettività dell’approccio.<br />
11 M. Ranchetti, Scritti <strong>di</strong>versi II, pag. 236, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> storia e letteratura, Roma 1999.<br />
12 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>, pag. 98, Garzanti, Milano 2001. Aggiungo, a riprova <strong>di</strong> questa <strong>su</strong>a a-mondanità, che <strong>in</strong> Sopra una<br />
qualsiasi rivoluzione (Scritti <strong>di</strong>versi II, pag. 215) m’impressionò il tono <strong>di</strong>staccato con cui il personaggio centrale, un giovane<br />
borghese, decide <strong>di</strong> prender parte agli avvenimenti, <strong>di</strong> guardarsi attorno e cercare «chi per dottr<strong>in</strong>a o per <strong>in</strong>gegno spiccasse fra<br />
gli altri, degno del <strong>su</strong>o affetto e della <strong>su</strong>a confidenza» (pag. 215), pronto a seguire «un ideale, fosse pure violento». Quando<br />
entra <strong>in</strong> contatto con altri giovani che, assieme agli «uom<strong>in</strong>i della strada e delle fabbriche <strong>in</strong> accese conversazioni... trattavano<br />
via via i problemi cui deve attendere l’uomo moderno, se tale vuole essere: massa e lavoro, abolizioni <strong>di</strong> leggi e <strong>di</strong> miti erano i<br />
temi che ricorrevano <strong>di</strong> frequente», il lessico stesso <strong>di</strong> questo scritto mi pare <strong>in</strong><strong>di</strong>care tutta l’estraneità e la <strong>di</strong>ffidenza<br />
dell’autore verso l<strong>in</strong>guaggio politico corrente <strong>di</strong> allora (e <strong>di</strong> adesso). La <strong>su</strong>a attenzione si rivolge alla figura del giovane capo<br />
capace <strong>di</strong> «trovare la risposta adatta, la soluzione attesa» (pag. 216) e <strong>su</strong>bito dopo al punto <strong>di</strong> conflitto tra l’economia, «un<br />
sapere economico, <strong>di</strong> già fatto collettivo», e «l’etica e il sapere religioso», arrivando a negare ogni valore alla lotta fra le classi:<br />
«un nemico non v<strong>in</strong>ce un nemico, un male l’altro male: sostituire non significa certo <strong>in</strong>tendere né <strong>di</strong>struggere» (pag. 217).<br />
2
giu<strong>di</strong>zi che egli aveva dato e <strong>di</strong>ede <strong>su</strong>ccessivamente <strong>su</strong> <strong>di</strong> lui. Ad apparentarloai miei occhi a Fort<strong>in</strong>i<br />
restava forse solo l’<strong>in</strong>quietud<strong>in</strong>e del loro pensiero. Ma <strong>in</strong> Ranchetti – è chiaro - il pensiero si muove<br />
attorno a un’«<strong>in</strong>cr<strong>in</strong>atura» tutta <strong>in</strong>teriore. 14 Ed è per questo che mi sembrava così pronto a cogliere la<br />
sofferenza (l'«odore <strong>di</strong> malato <strong>di</strong> mente» 15 ) o a scovare <strong>in</strong> Fort<strong>in</strong>i «una fragilità.. nell’ambito degli<br />
affetti, non della ragione». 16 Dalla con<strong>di</strong>zione degli anni Novanta, che anch'io ho com<strong>in</strong>ciato a chiamare<br />
<strong>di</strong> esodo ma senza possibilità <strong>di</strong> meta o <strong>di</strong> progetto (per chissà quanto tempo), mi è sembrato possibile<br />
mi<strong>su</strong>rarmi con Ranchetti per tentare un fort<strong>in</strong>iano «buon uso delle rov<strong>in</strong>e», che a me <strong>in</strong> parte<br />
sembravano assimilabili, del comunismo e del cristianesimo. Volevo cercare <strong>di</strong> confrontare la «f<strong>in</strong>e<br />
della speranza politica» <strong>di</strong> Fort<strong>in</strong>i (ma anche mia e d'altri) con il processo <strong>di</strong> ammutolimento forzato<br />
dell'«<strong>in</strong>terrogazione religiosa» che Ranchetti aveva rias<strong>su</strong>nto <strong>in</strong> Non c’è più religione. Gli epigoni <strong>di</strong><br />
entrambe le gran<strong>di</strong> narrazioni mi parevano vivere ora una solitud<strong>in</strong>e comune. E il cattolicesimo <strong>di</strong><br />
Ranchetti non era per me, come ho detto, una barriera, tanto m’ero conv<strong>in</strong>to, leggendo i <strong>su</strong>oi scritti, che<br />
egli lo aveva vis<strong>su</strong>to con una libertà impensabile per quello istituzionale e se ne andasse <strong>di</strong>staccando. 17<br />
5.<br />
Tornando a <strong>Verbale</strong>. Nella Postfazione Ranchetti parla <strong>di</strong> figure che hanno agito nella <strong>su</strong>a esperienza e<br />
con le quali ha stabilito «un'alleanza affettiva e teoretica». 18 Sono le fonti del <strong>su</strong>o sentire: familiari,<br />
amici, conoscenti (le allusioni più chiare paiono quelle riferibili ai genitori, ai figli), già fattisi però<br />
pensiero. E qu<strong>in</strong><strong>di</strong> conoscere i nomi <strong>di</strong> alcuni <strong>su</strong>oi reali <strong>in</strong>terlocutori– come aveva lui stesso precisato<br />
nella precedente raccolta, La mente musicale - non aggiunge molto <strong>di</strong> più a quanto i versi passano. 19<br />
13 Scrissi <strong>in</strong> quell'occasione:<br />
Abbiamo amato un poeta “fragile”<br />
Ranchetti è stato il solo<br />
a spogliar Fort<strong>in</strong>i da mantelle letterarie<br />
e religiosizzanti<br />
parlare <strong>di</strong> letteratura/<br />
è un alibi<br />
questo commercio con l’Olimpo cristiano/<br />
Fort<strong>in</strong>i l’o<strong>di</strong>ava<br />
tragica / esemplare<br />
è l’empietà dei <strong>su</strong>oi ultimi versi<br />
c’era una fragilità <strong>di</strong> fondo<br />
nell’ambito degli affetti<br />
certo/ se abbiamo da <strong>di</strong>fendere<br />
la Letteratura<br />
o l’anti-Letteratura<br />
la Religione o la Laicità<br />
la caverna psicoanalitica <strong>di</strong> Ranchetti<br />
<strong>in</strong> pochi la si frequenterà<br />
14 M. Ranchetti, <strong>Verbale</strong>, pag. 108.<br />
15 Idem, pag. 100.<br />
16 M. Ranchetti, Scritti <strong>di</strong>versi II, pag. 237, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> storia e letteratura, Roma 1999.<br />
17 In particolare gli posi questi miei problemi <strong>in</strong> una lettera del 22 gennaio 2002. Durante una <strong>su</strong>ccessiva telefonata, <strong>in</strong> cui gli<br />
chiesi perché non avesse risposto alle mie numerose obiezioni, <strong>Michele</strong> mi spiazzò, <strong>di</strong>chiarandomi – e non ho motivo <strong>di</strong><br />
pensare che lo facesse per <strong>di</strong>plomatismo - che egli non era portato a pensare <strong>di</strong>alogando e controbattendo. Resta il fatto che<br />
non rispose neppure alle obiezioni che gli feci <strong>su</strong> un altro <strong>su</strong>o ritratto fort<strong>in</strong>iano (Cfr. Nei d<strong>in</strong>torni <strong>di</strong> Franco Fort<strong>in</strong>i. Un <strong>in</strong>izio<br />
<strong>di</strong> riflessione <strong>in</strong> «Poliscritture» n. 1 maggio 2006) né a quelle che mossi al <strong>su</strong>o Fort<strong>in</strong>i e Milani (<strong>in</strong> «Antologia Viesseux», n.31,<br />
gennaio- aprile 2005). Dopo il nostro rapporto si andò <strong>di</strong>luendo, lasciandomi il dubbio: ero stato troppo maldestro<br />
<strong>in</strong>calzandolo con obiezioni eccessivamente “filofort<strong>in</strong>iane” oppure mi ero addentrato <strong>in</strong> una zona <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso non <strong>di</strong>alogabile<br />
fra due <strong>in</strong>tellettuali vic<strong>in</strong>i e <strong>di</strong>stanti?<br />
18 <strong>Verbale</strong>, pag. 133.<br />
19 A conferma trovo anche il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Mengaldo: «<strong>Michele</strong> non fa che mac<strong>in</strong>are pochi elementi nello stesso tempo<br />
esistenziali e concettuali, e anzi l’esistenza non esiste quasi <strong>in</strong> lui se non rum<strong>in</strong>ata <strong>in</strong>teriormente, sicché si può quasi <strong>di</strong>re che le<br />
“cose”, e se vogliamo la “realtà”, come la chiamiamo, nella <strong>su</strong>a <strong>poesia</strong> non esistono». E più avanti: «per <strong>di</strong>rla tutta: [si tratta<br />
<strong>di</strong>] una <strong>poesia</strong> <strong>in</strong> cui sì, l’esistente ha significato solo se giustificato dalle categorie del pensiero e dello spirito» (P.V. Mengaldo,<br />
Op. cit. pag. 434).<br />
3
6.<br />
In <strong>Verbale</strong> colgo un'assenza <strong>di</strong> soggetto e <strong>di</strong> soggetti. È occultamento o assenza <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>ce o pensa?<br />
Piuttosto un s<strong>in</strong>tomo, credo, del volersi Ranchetti poeta impersonale, vagante, accanitamente<br />
<strong>in</strong>trospettivo, rispecchiante «dolore». La lotta che occupa <strong>in</strong>teramente il campo della <strong>su</strong>a mente<br />
musicale, <strong>in</strong>castrata <strong>in</strong> un «corpo vuoto e pesante», 20 è quella <strong>in</strong>teriore 21 : «il vivo / <strong>in</strong> me e il morto / <strong>in</strong><br />
me si contendono / ciò che <strong>di</strong> me rimane». 22 Di sicuro qui ci sono i «verba et nom<strong>in</strong>a» della tra<strong>di</strong>zione<br />
cristiana, come egli avverte, ma l'abbreviazione <strong>di</strong> quella è quasi stenografica. (E a me poi appare<br />
carbonizzata, 23 tanto che non riesco ad afferrare più "detti" o "citazioni" che, spesso ad <strong>in</strong>izio <strong>poesia</strong>,<br />
ancora la segnalano. M’accorgo che <strong>su</strong> <strong>di</strong> essi il pensiero del poeta si mette a lavorare, non con un<br />
approfon<strong>di</strong>mento graduale, ma con abbreviazioni che trovo fulm<strong>in</strong>anti e spaesanti 24 ).<br />
7.<br />
Per chi verbalizza Ranchetti? Sento nella <strong>su</strong>a <strong>poesia</strong> l'assenza del noi, <strong>di</strong>ciamo pure del fantasma che<br />
tanto ha agitato fra Otto e Novecento almeno la parte dei poeti e degli <strong>in</strong>tellettuali che mi sono scelto<br />
come riferimento. Egli era fuori da ogni retorica del noi o della “fraternità”. Qu<strong>in</strong><strong>di</strong> mancano <strong>in</strong> questi<br />
versi l’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong>dattico, la volontà <strong>di</strong> colloquio, la fiducia nel cercare assieme agli altri. Manca pure la<br />
sp<strong>in</strong>ta a per<strong>su</strong>adere qualcuno della verità che egli vuole, scrivendo, salvare dalla <strong>di</strong>struzione del tempo.<br />
Non <strong>di</strong>co che c’è solipsismo nella <strong>su</strong>a scrittura, ma, soprattutto nella <strong>poesia</strong>, una solitud<strong>in</strong>e vis<strong>su</strong>ta <strong>in</strong><br />
mo<strong>di</strong> estremi nel pensiero e nel l<strong>in</strong>guaggio.<br />
8.<br />
In <strong>Verbale</strong> (ma credo <strong>in</strong> tutte le <strong>su</strong>e poesie) la saldatura fra sentire e pensare religioso è compatta. Una<br />
sensibilità elementare e orig<strong>in</strong>aria (<strong>in</strong>fantile <strong>in</strong> senso assoluto) si sarà irrobustita attraverso <strong>su</strong>ccessive<br />
acquisizioni e se<strong>di</strong>mentazioni culturali del tutto coerenti e senza eclettismo alcuno. Da uomo che «ha<br />
letto tutti i libri», come sostiene Giu<strong>di</strong>ci? 25 No. Nell’<strong>in</strong>tervista che gli feci nel 2005, Ranchetti riferì<br />
senza imbarazzo o baldanza che Marx (e credo tutto il filone illum<strong>in</strong>ista) lui non l’aveva mai accostati. 26<br />
E la conferma che guardasse <strong>in</strong> altra <strong>di</strong>rezione e ad altri scopi la trovo rileggendo questi versi: «la salute<br />
non è / affidata al conoscere» 27 ; «la <strong>poesia</strong> si annulla / nell’esistente, la ragione penetra / solo<br />
nell’oggi». 28 Ranchetti è stato lettore soltanto <strong>di</strong> libri che rientravano <strong>in</strong> un campo conoscitivo che egli<br />
sentiva <strong>su</strong>o. E la lettura che ne faceva è quella rallentata e approfon<strong>di</strong>ta del traduttore, cioè <strong>di</strong> un<br />
lettore potenziato, perché costretto cont<strong>in</strong>uamente a tornare <strong>su</strong>i <strong>su</strong>oi passi, a limare, a puntualizzare.<br />
8.<br />
In <strong>poesia</strong>, Ranchetti abbrevia. In modo rigorosamente <strong>in</strong>tellettuale l’ansioso <strong>su</strong>o percorso <strong>di</strong> vita<br />
(term<strong>in</strong>e da lui svalutato, se non <strong>di</strong>leggiato 29 ) e d’esperienza (term<strong>in</strong>e non assente dal <strong>su</strong>o lessico, ma<br />
accompagnato da una forte consapevolezza del «limite», e cioè della morte <strong>in</strong>combente come <strong>su</strong>a<br />
conclusione 30 ) viene contratto e accorciato. Sappiamo che esso è stato lungo e multiforme, ma, <strong>in</strong><br />
coerenza con il pr<strong>in</strong>cìpio religioso della <strong>su</strong>a <strong>poesia</strong>, egli rias<strong>su</strong>me la vicenda («le orig<strong>in</strong>i / i parenti<br />
20 In La mente musicale, 33, pag. 33.<br />
21 Ancora Mengaldo: «Ranchetti, se Dio vuole, non è poeta “sperimentale”, ma <strong>in</strong>troverso». ( P.V. Mengaldo, Op. cit. pag. 435)<br />
22 <strong>Verbale</strong>, pag. 72.<br />
23 È questa la conclusione a cui mi pare lui stesso sia arrivato <strong>in</strong> Non c’è più religione, Garzanti, Milano 2003.<br />
24 Cfr.: «Se mi tieni la mano...» (pag. 13); «ci sei / ti ho visto» (pag. 16); «In Para<strong>di</strong><strong>su</strong>m deducant te / angeli» (pag. 21); «un<br />
cusc<strong>in</strong>o <strong>di</strong> legno» (pag. 22); «Le mie ultime volontà» (pag. 29); «Potestas <strong>in</strong>terpretan<strong>di</strong>» (pag. 30); «La giustizia imputata»<br />
(pag. 32); «Vuoi essere tu solo a non amarti» (pag. 35); «Liberi tutti» (pag. 86); «Non hanno più v<strong>in</strong>o» (pag. 101).<br />
25 Cfr. risvolto <strong>di</strong> copert<strong>in</strong>a <strong>di</strong> <strong>Verbale</strong>.<br />
26 Nell’<strong>in</strong>tervista del 2005 Ranchetti mi precisò che alla lettura <strong>di</strong> Wittgenste<strong>in</strong> e Freud, i due maestri che egli aveva cercato «al<br />
<strong>di</strong> fuori della professione <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> appartenenza religiosa», era arrivato «per caso, nel senso concreto del term<strong>in</strong>e»: tramite<br />
un ebreo poi convertitosi al cattolicesimo o per il lavoro <strong>di</strong> traduzione dal tedesco delle opere freu<strong>di</strong>ane trovato presso la<br />
Bor<strong>in</strong>ghieri. Nulla <strong>di</strong> simile era avvenuto Marx.<br />
27 <strong>Verbale</strong>, pag. 26.<br />
28 <strong>Verbale</strong>, pag. 28.<br />
29 L’antivitalismo <strong>di</strong> Ranchetti mi pare <strong>di</strong> coglierlo <strong>in</strong> questi versi: mentre gli altri vivono / come immortali nel nulla una forza<br />
[?] cerca <strong>di</strong> per<strong>su</strong>adere tutti / qui e ora a morire / senza perdere tempo ancora a vivere (pag. 99). Oppure <strong>in</strong> questi: Vivo <strong>in</strong><br />
una cassa / da vivo: morto / sarò risorto (pag. 60).<br />
30 <strong>Verbale</strong>, pag. 39: : «Non si può immag<strong>in</strong>are / come del lungo it<strong>in</strong>erario resti / solo la f<strong>in</strong>e».<br />
4
modesti, la severa / pratica <strong>di</strong> pietà religiosa e civile», pag, 39) nel nulla, nella morte, <strong>in</strong> quella che<br />
Mengaldo chiama «”metafisica”» 31 .<br />
9.<br />
In questo «percorso conoscitivo, fissato <strong>in</strong> punti <strong>di</strong> illum<strong>in</strong>azione e <strong>di</strong> ombra» a me pare che Ranchetti<br />
abbia voluto mi<strong>su</strong>rarsi soprattutto con le ombre, con «i punti morti <strong>di</strong> luce», fiducioso che,<br />
connettendosi tra loro, essi <strong>di</strong>ano luogo (non <strong>di</strong>ce: possono o potrebbero…) a «momenti (frammenti) <strong>di</strong><br />
chiarezza». Di ombra, <strong>di</strong> oscurità (del l<strong>in</strong>guaggio stesso), s<strong>in</strong> dalla prima lettura delle <strong>su</strong>e poesie, ne ho<br />
trovata tanta. E mi sono chiesto quanto ciò fosse dovuto a mia ignoranza o al <strong>di</strong>stanziamento del<br />
mondo cristiano-cattolico-borghese <strong>di</strong> Ranchetti. Ma è davvero più “<strong>in</strong>telligibile” oggi questa <strong>su</strong>a<br />
<strong>poesia</strong> a un cattolico o a un cristiano? Tanta ombra non sarà dovuta al <strong>su</strong>o sporgersi (ricorro ancora a<br />
Giu<strong>di</strong>ci) «nell'al<strong>di</strong>là <strong>di</strong> ogni oltranza dell'esserci» che l’ha portato <strong>in</strong> Non c’è più religione? alla stessa<br />
negazione o messa <strong>in</strong> dubbio del pensare religiosamente? Chi afferma, comunque, che Ranchetti<br />
rientrerebbe <strong>in</strong>teramente <strong>in</strong> «quella grande tra<strong>di</strong>zione mistica (che ebbe, da noi, <strong>in</strong> Clemente Rebora il<br />
<strong>su</strong>o estremo grande testimone)» 32 mi pare che addolcisca l’<strong>in</strong>tero <strong>su</strong>o percorso. Davvero l’”oscurità”<br />
ranchettiana è apparentabile a una «laica noche oscura», come hanno scritto <strong>in</strong> occasione della <strong>su</strong>a<br />
morte vari commentatori?<br />
10.<br />
Non sono <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> <strong>in</strong>tendere la qualità <strong>di</strong> quest'ombra ranchett<strong>in</strong>a (e – lo ammetto – della stessa<br />
oscurità per me <strong>di</strong> tanti <strong>su</strong>oi versi). Eppure da questa mia <strong>di</strong>fficoltà non ho tratto alcun sentimento <strong>di</strong><br />
rifiuto nei confronti <strong>di</strong> questa <strong>poesia</strong>. Anzi, proprio perché tanto ostica (sicuramente più dei <strong>su</strong>oi Scritti<br />
<strong>di</strong>versi 33 ), mi sp<strong>in</strong>ge a fissare con precisione i miei «non capisco» (i miei “limiti”).<br />
11.<br />
Ranchetti, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> tanti poeti che vogliono metterci la vita, <strong>in</strong> <strong>poesia</strong> ci mette la morte. Non è il<br />
primo. Dante da vivo ha immag<strong>in</strong>ato un viaggio <strong>di</strong> purificazione e <strong>di</strong> r<strong>in</strong>ascita (alla vita, ad una vita<br />
ancora umana, ma più consapevole del <strong>di</strong>v<strong>in</strong>o) nel mondo dei morti. Ma quello <strong>di</strong> Ranchetti non è un<br />
viaggio. Non c'è «tragitto» («la <strong>di</strong>stanza fra il tuo corpo e il mio è già tragitto», pag. 34), né «progetto»<br />
(«Qui, perduto il carattere / del qualsiasi progetto, riconosco / solo l’assenza <strong>di</strong> un tragitto», pag. 30).<br />
La <strong>su</strong>a mi pare un'operazione più drastica anche <strong>di</strong> quella che fece Leopar<strong>di</strong>. Nel poeta <strong>di</strong> Recanati, il<br />
sentimento <strong>di</strong> morte e la <strong>di</strong>sperazione lasciavano <strong>in</strong>travedere la vita (che spettava magari agli altri più<br />
che a lui). Qui no. Il “piacere della vita”, ogni piacere, è negato. Ranchetti non si f<strong>in</strong>ge morto (come ad<br />
es. fa Giu<strong>di</strong>ci <strong>in</strong> una nota <strong>poesia</strong>). Non pensa da morto la vita, come fa Leopar<strong>di</strong>. Nella vita sta da<br />
«sasso», da «albero». 34 Mi pare che egli pensi da morto la morte. Ci dà una <strong>poesia</strong> mortificata,<br />
r<strong>in</strong>secchita, scheletrica (come lo sono le immag<strong>in</strong>i <strong>di</strong> corpi umani e <strong>di</strong> animali – specie alcuni gall<strong>in</strong>acei<br />
- che egli fissò <strong>in</strong> <strong>di</strong>segni che tanto richiamano il primo Paul Klee 35 ). Avrà accolto – come <strong>di</strong>cono -<br />
quasi solo Rebora, ma sottoponendo la <strong>su</strong>a lezione a una ulteriore depurazione (delle immag<strong>in</strong>i, ad es.).<br />
La <strong>su</strong>a <strong>di</strong>stanza dai mo<strong>di</strong> poetici più con<strong>su</strong>eti è enorme: dove un poeta <strong>di</strong> solito mette un’immag<strong>in</strong>e,<br />
Ranchetti mette un pensiero. E non credo si sia mai occupato <strong>di</strong> poetica o <strong>di</strong> tecniche poetiche. La<br />
biografia, la sociologia, almeno nel <strong>su</strong>o caso, aiutano f<strong>in</strong>o ad un certo punto. Sì, è un borghese, è un<br />
cattolico, ma ciò non spiega questo tipo <strong>di</strong> <strong>poesia</strong>. E davvero queste sono ancora poesie? La domanda<br />
non è provocatoria, perché qui la letteratura viene cancellata. Egli le volta le spalle, guarda altrove, non<br />
“l’attraversa” neppure, come si <strong>di</strong>ce. Si tratta, <strong>in</strong>vece, <strong>di</strong> una stenografia dell'anima che delira e, per<br />
afferrarne il co<strong>di</strong>ce (se il lettore ha la tenacia o la fiducia <strong>di</strong> poterlo afferrare...), bisognerebbe rifare<br />
tutto il «percorso conoscitivo» che l'autore afferma <strong>di</strong> aver abbreviato e «fissato <strong>in</strong> punti <strong>di</strong><br />
illum<strong>in</strong>azione e <strong>di</strong> ombra».<br />
31 P.V. Mengaldo, Op. cit. pag. 433.<br />
32 Ancora Giu<strong>di</strong>ci nel risvolto <strong>di</strong> copert<strong>in</strong>a <strong>di</strong> <strong>Verbale</strong>. Secondo me, il percorso <strong>di</strong> Rebora è <strong>in</strong>verso a quello <strong>di</strong> Ranchetti, tant’è<br />
che per il primo si conclude con il sacerdozio, mentre Ranchetti nella Prefazione <strong>di</strong> Non c’è più religione arriva a una<br />
conclusione antitetica: «Di fronte a queste autorità religiose e civili l’unica virtù che può forse recuperare un senso religioso<br />
alla vita, se mai un senso religioso fosse necessario, e non è affatto detto, è la <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza “cieca e assoluta” per<strong>in</strong>de ac<br />
cadaver. Letteralmente. Forse il resto verrà da sé» (pag. 14).<br />
33 M. Ranchetti, Scritti <strong>di</strong>versi, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> storia e letteratura, Roma 1999.<br />
34 <strong>Verbale</strong>, pag. 91.<br />
35 Cfr. M. Ranchetti, Scritti <strong>in</strong> figure, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> storia e letteratura, Roma 2002.<br />
5
12.<br />
Questa <strong>poesia</strong> <strong>in</strong>timorisce e <strong>in</strong>ceppa il pensiero (almeno il mio) per l'accoglienza piena che dà al<br />
pensiero <strong>di</strong> morte. Per avvic<strong>in</strong>armi ad essa quanto mi è possibile, devo pensare ai legami avuti con corpi<br />
<strong>di</strong> persone che mi sono state vic<strong>in</strong>e ma che ora sono uscite dalla mia esperienza <strong>di</strong>retta (allontanatesi o<br />
morte). La <strong>poesia</strong> <strong>di</strong> Ranchetti <strong>in</strong>vita a sostare con queste ombre, a <strong>in</strong>terrogarle, ad ascoltarle, frenando<br />
ogni impaziente tentativo <strong>di</strong> svelare, illum<strong>in</strong>are, pensare per agire. <strong>L'ombra</strong> ranchettiana si fonde <strong>in</strong><br />
parte con alcune delle mie ombre. (In particolare, per avvic<strong>in</strong>arla, posso far riemergere immag<strong>in</strong>i<br />
d'<strong>in</strong>fanzia cattolica, sia pur vis<strong>su</strong>ta a un livello populistico-attivistico, da Azione Cattolica anni ’40-’50,<br />
ben <strong>di</strong>stante da quello storico-teoretico <strong>di</strong> Ranchetti 36 ). Qui il “cristianesimo” <strong>di</strong> Ranchetti (la <strong>su</strong>a parte<br />
non dottr<strong>in</strong>aria, <strong>in</strong>tendo) non è poi così lontano da quello che credo <strong>di</strong> aver vis<strong>su</strong>to nel rapporto prima<br />
fisico e poi <strong>di</strong> memoria con mia madre (e la figura della madre è centrale anche <strong>in</strong> Ranchetti e <strong>in</strong><br />
<strong>Verbale</strong>) o con altre figure della mia <strong>in</strong>fanzia e adolescenza (la parte “premoderna” della mia<br />
esperienza).<br />
13.<br />
Ad allontanarmene o ad entrare con essa <strong>in</strong> una sorta <strong>di</strong> “competizione” è <strong>in</strong>vece la parte “moderna”<br />
della mia esperienza <strong>di</strong> immigrato <strong>in</strong> una metropoli. Che resiste, malgrado le sconfitte esistenziali e<br />
politiche che me ne sono venute. È come se, pur <strong>su</strong>bendo la presa <strong>di</strong> quella “<strong>in</strong>cr<strong>in</strong>atura” che Ranchetti<br />
ha sondato tanto <strong>in</strong> profon<strong>di</strong>tà, da qui mi venisse ancora la sp<strong>in</strong>ta a contrapporre alla <strong>su</strong>a <strong>poesia</strong> la<br />
ricerca <strong>di</strong> “qualcosa” a livello storico-politico e non “<strong>in</strong>teriore”. La verità dell’angoscia <strong>di</strong> morte che la<br />
<strong>su</strong>a <strong>poesia</strong> mette <strong>in</strong> primo piano non credo <strong>di</strong> volerla sfuggire. L’aver rimodellato convulsamente nelle<br />
forme della modernità (ora sconfitta) la prospettiva <strong>di</strong> vita <strong>in</strong>teriore, che il cattolicesimo aveva dato<br />
anche a me, non ha significato perderla. Ho cont<strong>in</strong>uato, ri<strong>di</strong>mensionata, a sentirla. Come sento vic<strong>in</strong>a<br />
l’altra saggezza possibile (quella vis<strong>su</strong>ta da Ranchetti), perché non si confonde con la ritualità<br />
sociologica ed esteriore dei preti e della Chiesa.<br />
14.<br />
Il timore che mi <strong>su</strong>scita questa <strong>poesia</strong> <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce solo quando arrivo alla conclusione (provvisoria e<br />
<strong>in</strong>certa) che ho seguito una via non del tutto imparagonabile a quella <strong>di</strong> Ranchetti. Comunismo e<br />
cristianesimo hanno avuto per me profonde aff<strong>in</strong>ità (almeno un certo cristianesimo e un certo<br />
comunismo) e, malgrado il “<strong>di</strong>sagio nella civiltà cristiana» e la “morte del comunismo”, la loro<br />
vic<strong>in</strong>anza mi pare assodata. Ignoro però se, come e quando possa essere ripresa e sviluppata.<br />
36 Nel confrontare l’ombra della <strong>su</strong>a <strong>poesia</strong> con le mie nel 2001 <strong>in</strong> una <strong>poesia</strong> ho scritto:<br />
Su Ranchetti (leggendo La mente musicale e <strong>Verbale</strong>)<br />
M'<strong>in</strong>timi<strong>di</strong>sce la <strong>poesia</strong> dell'uomo religioso<br />
che il mondo s'è strappato dagli occhi<br />
e conserva come <strong>in</strong>cubo e reliquia <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua morta.<br />
Ho praticato da bamb<strong>in</strong>o altri eremitaggi<br />
quasi addosso alla morte<br />
con terrore <strong>di</strong> fiabe contad<strong>in</strong>e <strong>su</strong>lla pelle però:<br />
sempre <strong>in</strong>comprensibile mi fu il lat<strong>in</strong>o dei preti.<br />
Dagli esili <strong>in</strong> sé<br />
uscii esplodendo <strong>in</strong> quoti<strong>di</strong>ani ora <strong>di</strong>menticati.<br />
6