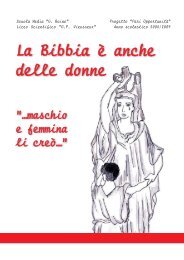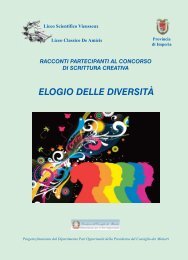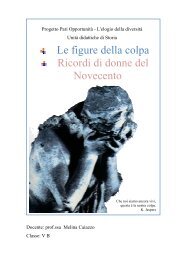Laboratorio di Filosofia - Badano e Caiazzo - Liceo Imperia
Laboratorio di Filosofia - Badano e Caiazzo - Liceo Imperia
Laboratorio di Filosofia - Badano e Caiazzo - Liceo Imperia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Progetto Pari Opportunità - L'elogio della <strong>di</strong>versità<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità plurale<br />
«La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e<br />
il vecchio: questi infatti mutando son quelli e quelli <strong>di</strong> nuovo mutando son questi».<br />
Eraclito, DK 22<br />
Docenti organizzatori: Clau<strong>di</strong>o <strong>Badano</strong> e Melina <strong>Caiazzo</strong>
Sommario<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Premessa .......................................................................................................................... 3<br />
Modalità <strong>di</strong> lavoro .......................................................................................................... 5<br />
Il paradosso della nave <strong>di</strong> Teseo .................................................................................... 7<br />
Testi ................................................................................................................................ 10<br />
Identità nel tempo ......................................................................................................... 13<br />
Testi ................................................................................................................................ 15<br />
Identità multipla ........................................................................................................... 17<br />
Il gioco delle identità: l’Enrico IV <strong>di</strong> Pirandello/Bellocchio ..................................... 20<br />
Esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione ................................................................................................. 22<br />
Bibliografia essenziale .................................................................................................. 24<br />
2
Premessa<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
L'idea <strong>di</strong> sperimentare un laboratorio <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong> è nata all'interno del Progetto<br />
scolastico Pari opportunità. L'elogio della <strong>di</strong>versità. In realtà, essa matura<br />
dall'esigenza <strong>di</strong> rispondere alla naturale vocazione <strong>di</strong>a-logica e teoretica della<br />
<strong>di</strong>sciplina, al <strong>di</strong> là della più consueta e sperimentata metodologia della <strong>di</strong>dattica ad<br />
impostazione storicistica, comunemente adottata a scuola.<br />
La modalità <strong>di</strong> svolgimento degli incontri ha seguito, in linea <strong>di</strong> massima, il<br />
modulo della Philosophy for children 1 , ovverosia un metodo che propone l'attività <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scussione filosofica che parte dalla curiosità e dall'idea <strong>di</strong> una “comunità <strong>di</strong> ricerca”,<br />
in cui i ragazzi sono incoraggiati a “con – filosofare”, attraverso la giuda dei “docenti<br />
facilitatori”. L'insegnante, infatti, abbandonando la veste cattedratica del depositario <strong>di</strong><br />
un sapere oracolare, si fa me<strong>di</strong>atore e garante: avviando l'indagine della maieutica<br />
socratica, veicola le domande e, rimanendo al <strong>di</strong> fuori del “cerchio” della comunità <strong>di</strong><br />
ricerca, vigila sul rispetto reciproco dei presenti e sul livello teoretico dei saperi.<br />
La <strong>di</strong>sposizione degli alunni, conformemente a quanto detto, è <strong>di</strong> tipo circolare:<br />
ogni partecipante deve poter vedere gli altri, senza le file create dai banchi <strong>di</strong> scuola. È<br />
il “volto dell'altro”, per usare un'espressione levinassiana, che deve suscitare interesse,<br />
rispetto in quanto tale e possibilità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre dubbi, domande ed emozioni.<br />
Nel nostro caso, gli “schematismi” legati al gruppo classe sono stati superati<br />
dall'unione trasversale <strong>di</strong> più classi <strong>di</strong> quarta liceo scientifico (IV A, B, E, F, D). Il<br />
numero dei presenti ad ogni incontro è stato me<strong>di</strong>amente <strong>di</strong> una dozzina.<br />
Il tema che abbiamo scelto, l'identità plurale, si inserisce nel contesto del<br />
Progetto a partire dalla problematizzazione dei concetti <strong>di</strong> identità e <strong>di</strong>versità: prima<br />
ancora <strong>di</strong> pensare alle forme <strong>di</strong> rispetto delle pari opportunità nei rapporti fra i sessi,<br />
all'interno dei gruppi sociali e via <strong>di</strong>cendo, è necessario chiedersi socraticamente “chi è<br />
il <strong>di</strong>verso?”, “in rapporto a cosa stabilisco la <strong>di</strong>versità?”, “se l'opposto del <strong>di</strong>verso è<br />
1 La Philosopy for chilren (P4C) è un curricolo che è anche un movimento educativo. E’ stato creato<br />
intorno agli anni ‘70 da Lipman, un professore <strong>di</strong> logica alla Columbia University <strong>di</strong> New York e<br />
fondatore dell’Institute for the Advancement of Philosophy for children, Montclair State University,<br />
New Jersey, USA. Cfr. Matthew Lipman, Educare al pensiero, ed. Vita e Pensiero 2005; Il prisma dei<br />
perché, ed. Liguori 2004.<br />
3
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
l'identico...ci può essere <strong>di</strong>versità nell'identità?”. In altre parole, il processo <strong>di</strong><br />
decostruzione delle fondamenta porta a chiedersi se, prima ancora <strong>di</strong> concepire l'altro<br />
come una <strong>di</strong>versità astratta e antitetica rispetto al mio io, non posso pensare la mia<br />
stessa identità come <strong>di</strong>versa rispetto a sé. Posso essere <strong>di</strong>verso da me? Sono tollerante e<br />
accetto, in linea <strong>di</strong> principio, ancor prima che sul piano fattuale, che la mia identità sia<br />
un processo in costruzione e in continuo rapporto con un'altra <strong>di</strong>versità che può<br />
<strong>di</strong>ventare parte della mia identità (tema del rapporto con gli altri)? Come si raccolgono<br />
le fila del sé in evoluzione (identità nel tempo)? E ancora: l’immagine che abbiamo <strong>di</strong><br />
noi stessi coincide con quella che gli altri hanno <strong>di</strong> noi (i ruoli sociali: l'identità<br />
multipla)? L’unità numerica è criterio costitutivo nel definire l’identità in<strong>di</strong>viduale<br />
(ipotesi dell'ingegneria genetica; la clonazione: identità numerica)?<br />
Riman<strong>di</strong>amo ulteriori esempi e il materiale utilizzato ai documenti seguenti.<br />
Nell' ultimo dei quattro incontri, abbiamo fatto vedere il film Enrico IV <strong>di</strong> Marco<br />
Bellochio (1984), con successiva <strong>di</strong>scussione finale e la ripresa dei temi<br />
precedentemente affrontati.<br />
Lungi dal pensar <strong>di</strong> aver esaurientemente affrontato il tema, ci auguriamo<br />
solamente <strong>di</strong> aver dato ai ragazzi l'opportunità <strong>di</strong> riflettere filosoficamente e <strong>di</strong> aver<br />
suggerito loro eventuali spunti <strong>di</strong> riflessione personale e possibili percorsi <strong>di</strong> ricerca.<br />
4
Modalità <strong>di</strong> lavoro<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
ESERCITAZIONI INTERROGATIVI - QUESTIONI<br />
1) Compilare la tabella (tratta da D.<br />
Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia<br />
come cura <strong>di</strong> sé, Cortina 1995) con gli<br />
in<strong>di</strong>catori proposti e riferiti a due <strong>di</strong>versi<br />
perio<strong>di</strong> della vita (quello delle me<strong>di</strong>e<br />
inferiori e quello attuale); confrontare poi<br />
le due colonne, per enuclearne gli elementi<br />
<strong>di</strong> continuità o <strong>di</strong>scontinuità<br />
2) Analizzare - in rapporto a situazioni<br />
personalmente vissute – espressioni del<br />
linguaggio or<strong>di</strong>nario come: “un uomo che<br />
si è fatto da sé”; “vivere la propria vita”;<br />
“questa non è la mia vita!”; “voglio vivere<br />
la mia vita”; “in quella occasione non ero<br />
io”; “ho reagito così, perché ero fuori <strong>di</strong><br />
me”; “ accettando quel compromesso, sono<br />
venuto meno a me stesso”<br />
3) Sulla scorta dei documenti posti in<br />
lettura sviluppare un confronto sulla<br />
questione, al centro dell’attuale <strong>di</strong>battito<br />
bioetico, relativa alla clonazione ed alla<br />
possibilità <strong>di</strong> riprodurre cellule ed<br />
organismi animali/umani<br />
4) Dopo aver composto piccoli gruppi,<br />
ognuno descriva per iscritto i tratti<br />
caratteristici della nostra personalità e<br />
confronti poi la scheda redatta con quella<br />
che gli altri componenti del gruppo hanno<br />
compilato su <strong>di</strong> lui<br />
5) Re<strong>di</strong>gere il <strong>di</strong>ario <strong>di</strong> una giornata-tipo,<br />
analizzando i nostri comportamenti in<br />
connessione al tipo <strong>di</strong> esperienza/attività<br />
svolte nelle <strong>di</strong>verse fasce della vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana<br />
6) Svolgere le attività <strong>di</strong> laboratorio<br />
proposte (scheda tratta dal manuale <strong>di</strong><br />
scienze sociali A. Cavalli, A. Pichierri, R.<br />
Albano, R. Sciarrone, Capire la società,<br />
Continuità biografica attraverso le età della<br />
vita:<br />
in che misura posso considerarmi sempre<br />
la stessa persona, pur mutando<br />
considerevolmente i contesti spaziotemporali<br />
della mia esperienza <strong>di</strong> vita?<br />
L’identità come insieme <strong>di</strong> storie<br />
successive<br />
Autenticità/in autenticità e natura sociale<br />
della personalità:<br />
con quali criteri identifichiamo il nostro io<br />
autentico, a cui facciamo implicitamente<br />
riferimento tutte le volte che definiamo un<br />
nostro comportamento in autentico?<br />
In che misura la nostra personalità è frutto<br />
<strong>di</strong> scelte autonome o piuttosto <strong>di</strong><br />
esperienze vissute e richieste <strong>di</strong> altri<br />
(genitori)?<br />
Identità numerica:<br />
l’unità numerica è criterio costitutivo nel<br />
definire l’identità in<strong>di</strong>viduale? Se in un<br />
ipotetico futuro l’ingegneria genetica fosse<br />
in grado <strong>di</strong> riprodurre un in<strong>di</strong>viduo in<br />
numero molteplice <strong>di</strong> esemplari, avremmo<br />
a che fare ancora con una sola persona<br />
oppure no?<br />
I ruoli e l’attribuzione sociale della<br />
personalità:<br />
l’immagine che abbiamo <strong>di</strong> noi stessi<br />
coincide con quella che gli altri hanno <strong>di</strong><br />
noi? Fino a che punto la propriocezione è<br />
congruente con la percezione <strong>di</strong> cui ci fa<br />
oggetto lo sguardo esterno?<br />
L’io multiplo: quanti/quali <strong>di</strong>fferenti strati<br />
sono racchiusi nella nostra personalità e<br />
quanti/quali ruoli assumiamo nel corso<br />
della nostra vita sociale?<br />
Divisione sociale/sessuale del lavoro<br />
5
Loerscher 2004)<br />
7) Dividersi in gruppi che al loro interno<br />
<strong>di</strong>scutano delle tematiche della con<strong>di</strong>zione<br />
femminile, dell’omosessualità, del<br />
transessualismo, come se fossero dei<br />
comitati incaricati <strong>di</strong> avanzare proposte<br />
legislative a tutela della specifica categoria<br />
<strong>di</strong> persone. All’interno <strong>di</strong> ogni gruppo<br />
ognuno esponga le proprie opinioni,<br />
avendo previamente sintetizzato quelle <strong>di</strong><br />
chi lo ha preceduto. Venga infine redatta da<br />
ogni gruppo una posizione comune, da<br />
<strong>di</strong>scutere poi collettivamente<br />
8) Compilare una scheda dettagliata che<br />
raccolga tutte le proprietà che, a nostro<br />
avviso, caratterizzano la nostra personalità<br />
nella sua “irripetibile singolarità”. Iniziare<br />
quin<strong>di</strong> a sottrarre una ad una le proprietà<br />
in<strong>di</strong>cate, per in<strong>di</strong>viduare il momento in cui<br />
l’in<strong>di</strong>viduo interessato “cessa <strong>di</strong> essere se<br />
stesso”.<br />
Sviluppare il tema, traendo spunti <strong>di</strong><br />
riflessione<br />
dalla considerazione del quadro clinico<br />
delle sindromi dei malati <strong>di</strong> Alzheimer e<br />
dalla lettura dell’esperienza della tortura<br />
subita, narrata da J. Améry nel saggio<br />
“Prigioniero ad Auschwitz” (Bollati<br />
Boringhieri ed.)<br />
9) Prendere in esame la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
sdoppiamento – volontario ed involontario<br />
– della personalità narrata nel romanzo <strong>di</strong><br />
Louis Stevenson “Il dottor Jeckill e mister<br />
Hyde” e decifrarla sulla scorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti<br />
teorie filosofiche della identità in<strong>di</strong>viduale<br />
(es. quella <strong>di</strong> Locke e quella <strong>di</strong> Leibniz)<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Identità sessuale e <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> genere<br />
Educarsi all’ascolto: capire le ragioni degli<br />
altri<br />
Il “mind-body problem”; dove ha sede il<br />
nostro io: nel cervello, nella mente, nella<br />
coscienza?<br />
Cosa ci caratterizza in maniera specifica:<br />
gli attributi fisici, quelli “spirituali”, quelli<br />
caratteriali-comportamentali?<br />
Colui che patisce episo<strong>di</strong> – temporanei o<br />
duraturi - <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta della memoria rimane<br />
sempre la stessa persona, <strong>di</strong>venta un’altra<br />
persona o cessa <strong>di</strong> essere una persona?<br />
“Fedeltà” morale e limiti <strong>di</strong> possibilità<br />
fisica: con<strong>di</strong>zioni patologiche ed<br />
esperienze estreme<br />
Teorie filosofiche sulla identità<br />
in<strong>di</strong>viduale/personale: <strong>di</strong>fferenze<br />
specifiche<br />
6
Il paradosso della nave <strong>di</strong> Teseo<br />
La nave <strong>di</strong> Teseo<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
“Il vascello sul quale Teseo si era imbarcato con gli altri giovani guerrieri,<br />
e che egli riportò trionfalmente ad Atene, era una galera a trenta remi,<br />
che gli Ateniesi conservarono fino ai tempi <strong>di</strong> Demetrio <strong>di</strong> Falera. Costoro<br />
ne asportarono i vecchi pezzi, via via che questi si deterioravano, e li<br />
sostituirono con dei pezzi nuovi che fissarono saldamente all’antica<br />
struttura, finché non rimase neppure un chiodo o una trave della nave<br />
originaria. Anche i filosofi, <strong>di</strong>scutendo dei loro sofismi, citano questa nave<br />
come esempio <strong>di</strong> dubbio, e gli uni sostengono che si tratti sempre dello<br />
stesso vascello, gli altri che sia un vascello <strong>di</strong>fferente”.<br />
Della nave <strong>di</strong> Teseo si parla nelle “Vite” <strong>di</strong> Plutarco (Plutarco, Vite, volume<br />
primo, §§ 22–23). Si narra che la nave in legno sulla quale viaggiò il mitico eroe greco<br />
fosse conservata intatta nel corso degli anni, sostituendone le parti che via via si<br />
deterioravano. La chiglia <strong>di</strong> essa fu così continuamente riparata, sottraendo vecchie<br />
tavole e travi e sostituendole con altre nuove. Giunse quin<strong>di</strong> un momento in cui tutte le<br />
parti usate in origine per costruirla erano state sostituite, benché la nave stessa<br />
conservasse esattamente la sua forma originaria.<br />
Il problema filosofico posto dal Paradosso della nave <strong>di</strong> Teseo è quello della<br />
identità attraverso il tempo. Se immaginiamo che la nave conservata dagli Ateniesi<br />
abbia subito la sostituzione <strong>di</strong> tutti i pezzi, la nave ricomposta a partire dai pezzi<br />
asportati risulterà in tutto e per tutto simile alla nave <strong>di</strong> partenza. La questione che si<br />
pone è la seguente: la nave completamente sostituita è rimasta la nave <strong>di</strong> Teseo oppure<br />
no? Ovvero: l’entità – la nave – , mo<strong>di</strong>ficata nella sostanza ma senza variazioni nella<br />
forma, è ancora proprio la stessa entità? O gli somiglia soltanto?<br />
Oltre che alla nave <strong>di</strong> Teseo, le stesse domande possono essere applicate anche<br />
ad altri casi simili. Ad esempio la scrupolosa conservazione <strong>di</strong> alcuni antichi templi<br />
giapponesi – anch’essi principalmente in legno, come la nave <strong>di</strong> Teseo – , per i quali ci<br />
si può domandare se siano ancora templi originali. Gli shintoisti giapponesi sembrano<br />
avere idee chiare al riguardo. Infatti il loro tempio più importante, il tempio <strong>di</strong> Ise –<br />
costruito in legno come la nave <strong>di</strong> Teseo – , ogni venti anni viene abbattuto e ricostruito<br />
completamente con lo stesso <strong>di</strong>segno architettonico su un terreno a fianco del<br />
precedente. Tale cerimonia detta shikinen sengu, al fine <strong>di</strong> ricordare che tutto muore e<br />
risorge, ed il tempio da essi è considerato originale ma rinato.<br />
Un filosofo del ‘600 inglese, Thomas Hobbes, aggiunse una complicazione<br />
all’argomento, supponendo che un uomo avesse tenuto da parte tutte le tavole e travi<br />
rimosse, avendo cura <strong>di</strong> rimetterle insieme in maniera assolutamente in<strong>di</strong>stinguibile da<br />
come erano prima che venissero rimosse dalla nave <strong>di</strong> Teseo. Il problema in questo<br />
modo si complica ulteriormente. Una volta che tutte le travi e tutte le tavole – e,<br />
possiamo immaginare, tutte le altre componenti della nave <strong>di</strong> Teseo – siano state<br />
7<br />
Plutarco, Vita <strong>di</strong> Teseo, 2.2
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
rimosse, questo signore si ritroverà con una nave che è assolutamente in<strong>di</strong>stinguibile<br />
dalla nave <strong>di</strong> partenza, e che per <strong>di</strong> più è fatta della stessa materia. Quale delle due navi<br />
così ottenute è la nave <strong>di</strong> Teseo? Quale delle due navi potrebbe ancora <strong>di</strong>rsi “la nave <strong>di</strong><br />
Teseo”? Con quale delle due navi si imbarcherebbe Teseo?<br />
[Nota. Di questo problema, nelle sue duplici componenti, vi è testimonianza<br />
nella storia della filosofia in una serie <strong>di</strong> autori, che giungono fino al presente. Ad esso<br />
si accenna in:<br />
Platone (Fedone 54a); Xenofane (Memorabilia 4.8.2); Eracliteo: (Frammenti 41-42: il<br />
Fiume); Leibniz (Nuovi Saggi II-xxvii-4 sgg.); Hobbes (prima sezione <strong>di</strong> Elementorum<br />
Philosophiae ed anche De corpore, II-xi-7). Fra i contemporanei <strong>di</strong> area “analitica” cfr.<br />
Chisholm (1976), che sostiene l’“essenzialismo mereologico”, cioè il punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong><br />
chi crede che la nave sia effettivamente <strong>di</strong>versa ad ogni benché minimo cambiamento <strong>di</strong><br />
parti]<br />
In queste domande viene appunto ad espressione la questione metafisica<br />
dell’effettiva persistenza dell’identità originaria <strong>di</strong> una entità, le cui parti cambiano nel<br />
tempo: dopo che – col passare del tempo – tutti i suoi pezzi componenti sono cambiati<br />
con altri uguali o simili, essa rimane davvero sé stessa come un tutto unico oppure no?<br />
Se l’identità d’una cosa è data dalle parti che la compongono, la nave che Teseo sta<br />
usando, cambia identità, mentre egli la utilizza? Non siamo <strong>di</strong> fronte a più navi che si<br />
rimpiazzano, man mano che i pezzi sono sostituiti? E Teseo, come uomo, non si<br />
mo<strong>di</strong>fica forse anch’egli in continuazione, come il famoso fiume <strong>di</strong> Eraclito (nel quale<br />
“non scorre mai la stessa acqua” e dove “non ci si può mai tuffare due volte nello stessa<br />
liquido”)?<br />
Se vale il principio per cui l’identità <strong>di</strong> una cosa è data dalle parti che la<br />
compongono, allora la nave continua a cambiare, ossia, quella che Teseo usa come la<br />
sua nave continua a cambiar identità: anziché una nave che perdura nel tempo abbiamo<br />
una sfilza <strong>di</strong> navi che si rimpiazzano l’una all’altra man mano che i giorni passano e i<br />
pezzi vengono sostituiti. Ma se le cose stanno così, allora anche Teseo continua a<br />
cambiare identità.<br />
Il rompicapo della nave <strong>di</strong> Teseo, a<br />
cui si fa tra<strong>di</strong>zionalmente riferimento nella<br />
letteratura sulla metafisica del cambiamento,<br />
solleva <strong>di</strong>scussioni anche in ambito<br />
“analitico”. Per un quadri<strong>di</strong>mensionalista gli<br />
oggetti materiali si estendono nel tempo<br />
proprio come si estendono nello spazio,<br />
hanno parti temporali proprio come hanno<br />
parti spaziali; per contro, un filosofo <strong>di</strong><br />
orientamento tri<strong>di</strong>mensionalista esclude che<br />
gli oggetti abbiano parti temporali,<br />
affermando che ogni oggetto è interamente<br />
presente ad ogni istante <strong>di</strong> tempo in cui<br />
esiste. Il principio in base al quale l’identità<br />
<strong>di</strong>acronica si fonda sulla continuità spaziotemporale<br />
suggerisce che la nave <strong>di</strong> Teseo sia la prima, x, ma l’assoluta identità<br />
materiale suggerisce che la nave <strong>di</strong> Teseo sia la seconda, y. Su quali basi scegliere? Ecco<br />
che <strong>di</strong> nuovo ci troviamo <strong>di</strong>nnanzi a un caso che sembra giustificare un’asserzione <strong>di</strong><br />
indeterminatezza. È indeterminato se la nave <strong>di</strong> Teseo sia identica a x o a y.<br />
8
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
[Problemi aggiuntivi:<br />
Ha importanza che la nave <strong>di</strong> Teseo non sia più quella vera, se Teseo la conduce<br />
e se va verso la meta da lui prefissata?<br />
Che importanza ha che l’acqua del fiume <strong>di</strong> Eraclito non sia più la stessa, se<br />
conoscere il corso del fiume fa sì che sappiamo sempre dove trovare l’elemento liquido<br />
che a noi serve?<br />
A che servono le percezioni non percepite <strong>di</strong> Hume, che esistono senza che ci sia<br />
un io (una posizione anticipata <strong>di</strong> secoli dal monismo bud<strong>di</strong>sta della non-mente) oppure<br />
gli istanti atemporali <strong>di</strong> Borges, che esistono singolarmente senza che ci sia un tempo<br />
che li unifica (a cui si potrebbero aggiungere i punti senza lo spazio), se noi siamo esseri<br />
che vivono spazio e tempo, con sensi limitati?]<br />
Come si vede, il problema a cui il <strong>di</strong>lemma ci pone <strong>di</strong> fronte è, più precisamente,<br />
un intreccio <strong>di</strong> problemi. A quello principale riguardante “l’identificazione <strong>di</strong> un<br />
soggetto” e la sua “reidentificazione nel tempo” si aggiunge, infatti, quello circa i criteri<br />
sui quali fondare la <strong>di</strong>stinzione tra “parti accidentali” e “parti essenziali” e quello del<br />
rapporto fra parti e tutto.<br />
Il paradosso va in primo luogo considerato in rapporto all’identità della nostra<br />
stessa persona, che nel corso degli anni cambia ampiamente, sia nella sostanza che la<br />
compone sia nella sua forma, ma nonostante ciò sembra rimanere quella stessa persona.<br />
Esso però può essere anche rivolto anche ad altre questioni: ad esempio, la<br />
cultura.<br />
Come qualsiasi “aggregato” esistente in questo mondo, neanche la cultura è un<br />
aggregato stabile. Il corpo umano, ogni giorno, vede morire proprie cellule, sostituite da<br />
altre o neppure più sostituite. Le cellule invecchiano e, alla fine, l’essere muore. Così,<br />
una cultura perde pezzi, ne acquista altri, si mo<strong>di</strong>fica, muore e le sue parti si possono<br />
riaggregare per costituire altro <strong>di</strong>fferente.<br />
Quando parliamo <strong>di</strong> una qualsiasi cultura non possiamo mai pensare ad un<br />
aggregato stabile. Ciò che fonda l’identità è la con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> qualcosa da parte <strong>di</strong><br />
esseri umani. L’identità è una idea con<strong>di</strong>visa. Questa con<strong>di</strong>visione non è scontata.<br />
Inoltre, una cultura è fatta, in ogni caso, pure da apporti esterni: la nave dovrà ricevere<br />
continuamente tavole e travi nuove, se vorrà restare a galla. Altrimenti, affonderà. E<br />
l’eventuale nave ricostruita con le parti antiche (il legno marcio) non potrà comunque,<br />
più prendere il mare. Al massimo, potrà finire in un museo o in un santuario. Che la<br />
nave sia <strong>di</strong>versa non ha alcuna importanza, quando è stata mitizzata. In effetti, la nave <strong>di</strong><br />
Teseo (una nave a trenta remi), anche se non fu più completamente quella originaria, fu<br />
conservata dai Cretesi fino all’età ellenistica, mentre all’eroe venne assegnato un luogo<br />
sacro e fu istituita una festa – Oschophoria – per commemorare la sua impresa.<br />
9
Testi<br />
Eraclito, Frammenti<br />
«Una e la stessa è la via all'in su e la via all'in giù» DK B 111<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
«La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il<br />
vecchio: questi infatti mutando son quelli e quelli <strong>di</strong> nuovo mutando son questi» DK 22<br />
«Acque sempre <strong>di</strong>verse scorrono per coloro che s'immergono negli stessi fiumi» DK B<br />
91<br />
«Nello stesso fiume non è possibile scender due volte» DK B12<br />
Platone, Fedone, 74 a-79a (con tagli):<br />
«Ve<strong>di</strong> allora, rispose Socrate, se la cosa sta così. C’è qualche cosa, è vero? <strong>di</strong> cui noi<br />
affermiamo che è uguale: e non già voglio <strong>di</strong>re <strong>di</strong> legno a legno, <strong>di</strong> pietra a pietra o <strong>di</strong><br />
altro simile; bensì <strong>di</strong> cosa che è <strong>di</strong> là e <strong>di</strong>versa da tutti questi eguali, <strong>di</strong>co l’eguale in sé.<br />
Possiamo <strong>di</strong> questo eguale in sé affermare che è qualche cosa, o non è nulla affatto?<br />
-Dobbiamo affermarlo sicuramente, <strong>di</strong>sse Simmia; proprio così.<br />
-E conosciamo anche ciò che esso è in se stesso?<br />
-Certo, rispose.<br />
-E <strong>di</strong> dove l’abbiamo avuta questa conoscenza? Non l’abbiamo avuta da quegli uguali <strong>di</strong><br />
cui si parlava ora, o legni o pietre o altri oggetti qualunque, a vedere che sono uguali?<br />
Non siamo stati indotti da questi uguali a pensare a quell’uguale, che è pur <strong>di</strong>verso da<br />
questi? O non ti pare che sia <strong>di</strong>verso? Considera anche da questo punto. Pietre uguali e<br />
legni uguali non accade talvolta che sembrino, anche se gli stessi, a uno uguali e a un<br />
altro no?<br />
-Sicuramente.<br />
-E <strong>di</strong>mmi, l’uguale in sé si dà mai il caso che appaia <strong>di</strong>suguale e insomma l’uguaglianza<br />
<strong>di</strong>suguaglianza?<br />
-Impossibile, o Socrate.<br />
-Infatti non sono la stessa cosa, <strong>di</strong>sse Socrate, questi uguali e l’uguale in sé.<br />
-Mi par bene, o Socrate.<br />
-Ma pure, <strong>di</strong>sse, è proprio per via <strong>di</strong> questi uguali, benché <strong>di</strong>versi da quell’uguale, che tu<br />
hai potuto pensare e fermare nella mente la conoscenza <strong>di</strong> esso uguale, non è vero?<br />
Verissimo, <strong>di</strong>sse.<br />
-E come <strong>di</strong> cosa o simile o <strong>di</strong>ssimile da codesti, no?<br />
-Precisamente.<br />
Perché non fa <strong>di</strong>fferenza, aggiunse. Basta che tu, veduta una cosa, riesca da codesta<br />
vista a pensarne un’altra, sia essa simile o <strong>di</strong>ssimile, ecco che proprio qui, <strong>di</strong>sse, in<br />
questo processo, tu hai avuto necessariamente un caso <strong>di</strong> reminiscenza.<br />
-Benissimo.<br />
-E <strong>di</strong>mmi, riprese, succede a noi qualche cosa <strong>di</strong> simile rispetto a quegli uguali che<br />
osserviamo nei legni e negli altri oggetti eguali <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>scorrevamo or ora? Ci appaiono<br />
essi così uguali come appunto è l’eguale in sé, o <strong>di</strong>fettano in qualche parte da esso,<br />
quanto ad essere tali e quali all’eguale, o non <strong>di</strong>fettano in nulla?<br />
-Molto anzi, egli <strong>di</strong>sse, ne <strong>di</strong>fettano.<br />
-E allora, quando ad uno, veduta una cosa, viene fatto <strong>di</strong> pensare così: “Questa cosa che<br />
ora io vedo tende ad essere come un’altra, e precisamente come uno <strong>di</strong> quegli esseri che<br />
10
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
esistono per se stessi, e tuttavia ne <strong>di</strong>fetta, e non può essere come quello, e anzi gli<br />
rimane inferiore, ebbene, chi pensa così, non siamo noi d’accordo che colui ha da<br />
essersi pur fatta dapprima, in qualche modo, un’idea <strong>di</strong> quel tale essere a cui <strong>di</strong>ce che la<br />
cosa veduta s’assomiglia, ma da cui è, in paragone, <strong>di</strong>fettosa?<br />
-Necessariamente.<br />
-E allora, <strong>di</strong>mmi, è avvenuto anche a noi qualche cosa <strong>di</strong> simile, o no, rispetto agli<br />
uguali e all’eguale in sé?<br />
-Certo.<br />
-Dunque è necessario che noi si sia avuta già prima un’idea dell’eguale; prima cioè <strong>di</strong><br />
quel tempo in cui, vedendo per la prima volta gli eguali, potemmo pensare che tutti<br />
questi uguali aspirano sì a essere come l’eguale, ma gli restano inferiori.<br />
-E’ proprio così.<br />
-E quin<strong>di</strong> siamo d’accordo anche in questo, che non da altro s’è potuto formare in noi<br />
questo pensiero, né da altro è possibile che si formi, se non dal vedere e toccare o da<br />
qualcun’altra <strong>di</strong> queste sensazioni; ché tutte valgono ora lo stesso.<br />
-Valgono lo stesso, o Socrate, rispetto a ciò che ora vuol <strong>di</strong>mostrare il nostro<br />
ragionamento.<br />
-Ma naturalmente proprio da queste sensazioni deve formarsi in noi il pensiero che tutti<br />
gli eguali che cadono sotto <strong>di</strong> esse sensazioni aspirano ad essere quello che è l’eguale in<br />
sé e a cui tuttavia rimangono inferiori. O come vogliamo <strong>di</strong>re?<br />
-Così.<br />
-Dunque, prima che noi cominciassimo a vedere e u<strong>di</strong>re insomma a far uso degli altri<br />
nostri sensi, bisognava pure che già ci trovassimo in possesso della conoscenza<br />
dell’eguale in sé, che cosa realmente esso è, se poi dovevamo, gli eguali che ci<br />
risultavano dalle sensazioni, riportarli a quello, e pensare che tutti quanti hanno una loro<br />
ansia <strong>di</strong> essere come quello, mentre poi gli rimangono al <strong>di</strong> sotto.<br />
_da quello che s’è detto, o Socrate, bisogna concludere così.<br />
-Or dunque, subito appena nati, non vedevamo noi, non u<strong>di</strong>vamo, non avevamo tutti gli<br />
altri sensi?<br />
-senza dubbio.<br />
-e non bisognava anche, abbiamo detto, che, prima <strong>di</strong> tutto ciò, fossimo già in possesso<br />
della conoscenza dell’uguale in sé?<br />
Sì.<br />
-E dunque, come pare, già prima <strong>di</strong> nascere noi dovevamo essere in possesso <strong>di</strong> questa<br />
conoscenza.<br />
-Così pare.<br />
-Se dunque è vero che noi, acquistata questa conoscenza prima <strong>di</strong> nascere, la portammo<br />
con noi nascendo, vorrà <strong>di</strong>re che prima <strong>di</strong> nascere e subito nati conoscevamo già, non<br />
solo l’eguale e quin<strong>di</strong> il maggiore e il minore, ma che tutte insieme le altre idee; perché<br />
non tanto dell’eguale stiamo ora ragionando quanto anche del bello in sé e del buono in<br />
sé e del giusto e del santo, e insomma, come <strong>di</strong>cevo, <strong>di</strong> tutto ciò a cui, nel nostro<br />
<strong>di</strong>sputare, sia interrogando sia rispondendo, poniamo questo sigillo, che è in sé. Per cui<br />
risulta necessariamente che <strong>di</strong> tutte queste idee noi dobbiamo aver avuta conoscenza<br />
prima <strong>di</strong> nascere.<br />
(…)<br />
-Torniamo ora, egli <strong>di</strong>sse, a ciò <strong>di</strong> cui ragionavamo precedentemente. Quell’entità in sé,<br />
<strong>di</strong> cui interrogando e rispondendo siamo soliti dare definizione, permane<br />
invariabilmente costante o è variabile? L’eguale in sé, il bello in sé, e insomma ogni<br />
data cosa che è in sé, l’ente, c’è mai il caso che subisca una qualsiasi mutazione?<br />
Oppure, ciascuna <strong>di</strong> queste cose che è in sé, che è uniforme in sé e per sé, permane<br />
11
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
invariabilmente costante, e non si dà mai il caso che in niente e in nessun modo subisca<br />
una qualsiasi alterazione?<br />
-Necessariamente, o Socrate, <strong>di</strong>sse Cebète, permane invariabilmente costante.<br />
-E <strong>di</strong>mmi: che pensi tu delle infinite cose come uomini, cavalli, vesti, e così via <strong>di</strong> tutte<br />
le altre quali esse siano o eguali o belle, e insomma <strong>di</strong> tutte quante alle quali <strong>di</strong>amo lo<br />
stesso nome che alle cose in sé? Permangono esse costanti, oppure, al contrario, non si<br />
dà mai che conservino lo stesso rapporto, né esse rispetto s se stesse, né le une rispetto<br />
alle altre, e insomma non siamo mai in nessun modo costanti?<br />
-Vero anche questo, <strong>di</strong>sse Cebète: non sono mai allo stesso modo.<br />
-Bene: e tu queste cose puoi toccarle, puoi vederle, puoi comunque percepirle con gli<br />
altri sensi: ma quelle che permangono costanti non c’è altro mezzo col quale tu le possa<br />
apprendere se non col pensiero e con la me<strong>di</strong>tazione: perché quelle <strong>di</strong> queste specie<br />
sono invisibili e non si possono percepire con la vista. Non è vero?<br />
-Perfettamente vero, egli <strong>di</strong>sse, è questo che <strong>di</strong>ci.»<br />
12
Identità nel tempo<br />
Quale criterio accerta la continuità della nostra identità personale?<br />
A) La memoria → teoria della continuità psicologica<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
B) Il corpo (o il cervello) → teoria della continuità fisica<br />
(<strong>di</strong> carattere empirico-riduzionista: al limite, è il dna che ci identifica)<br />
C) Il riconoscimento altrui → teoria costruzionista<br />
D) Autocoscienza → teoria soggettivistica<br />
(riconosco come mie le esperienze che compio;<br />
grammatica in prima persona: “io ho fatto…”)<br />
E) Processo storico → teoria genealogica<br />
[chiarimento sulla teoria D): qui si pone non tanto il problema della identità, quanto<br />
piuttosto quella della identificazione; domanda: come faccio a determinare una mia<br />
qualità (es. alto o basso) se sono il solo abitante del mondo?; casi da cui si può derivare<br />
il problema: i reduci e gli emigranti (mutamento ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong> professione e <strong>di</strong><br />
riconoscimento sociale connesso); la scelta della professione, oltre che le congenialità<br />
personali, implica anche lo status che la società ad essa accorda; fra gli elementi che un<br />
lutto richiede <strong>di</strong> elaborare vi è anche la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> coli che era il testimone privilegiato<br />
della nostra presenza nel mondo]<br />
Possibili obiezioni<br />
Obiezione <strong>di</strong> B ad A: casi <strong>di</strong> amnesia / sindrome <strong>di</strong> Alzheimer / caso paradossale: chi –<br />
credendosi Napoleone – conosce alla perfezione la vita <strong>di</strong> Napoleone e si comporta in<br />
modo assolutamente coerente al suo stile, è Napoleone?<br />
Come possiamo escludere quest’ultima eventualità?<br />
Criterio dell’unicità numerica (da considerare più sotto)<br />
La nostra memoria non è un archivio perfetto; ciò <strong>di</strong> cui non ci ricor<strong>di</strong>amo non fa parte<br />
<strong>di</strong> noi; posso essere giu<strong>di</strong>cato e punito solo per i reati che ricordo. L’intero e<strong>di</strong>ficio<br />
giuri<strong>di</strong>co si fonda, però, sul presupposto che la persona responsabile degli atti sia una.<br />
Unica variabile (da considerare più sotto): l’incapacità <strong>di</strong> intendere e volere<br />
Obiezione <strong>di</strong> A a B: casi <strong>di</strong> deformazione fisica; la biologia ha <strong>di</strong>mostrato che nel corso<br />
<strong>di</strong> una vita nella loro quasi totalità le cellule <strong>di</strong> un corpo si rigenerano; caso paradossale:<br />
nell’ipotesi che sia possibile trapiantare il cervello, per un errore chirurgico il cervello<br />
del signor Brown viene reimpiantato sul corpo del signor Robinson; che persona<br />
otteniamo; a casa <strong>di</strong> quale moglie andrà, alla sera, la nuova persona?; e, nel caso<br />
commetta un reato, che verrà arrestato e giu<strong>di</strong>cato?<br />
13
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Obiezione <strong>di</strong>o C) a D): l’io è una espressione in<strong>di</strong>cale (ha significato solo quando venga<br />
accertato chi la pronuncia); l’enunciato “Ora, ho capito!” non ha senso se pronunciato<br />
solipsisticamente,. Ma solo entro in contesto <strong>di</strong> un gioco linguistico (ad esempio quello<br />
scolastico)<br />
Obiezione a D): non essere ciò che si crede <strong>di</strong> essere (“Il grande Gatsby”: il<br />
doppiogiochista ed il terzogiochista); esistenza <strong>di</strong> uno strato inconscio della coscienza<br />
Tutto quanto detto finora risponde al quesito su quale sia il criterio che accerta la<br />
continuità della nostra identità personale, presupponendo che la nostra identità sia una.<br />
Ma è possibile abbandonare questo presupposto e sviluppare una nuova fase della nostra<br />
riflessione, assumendo un’ipotesi del tutto <strong>di</strong>versa: che l’io non sia uno, ma molteplice.<br />
La nuova domanda è allora la seguente: l’in<strong>di</strong>viduo è un in-<strong>di</strong>viduo?<br />
Etimologia <strong>di</strong> “in<strong>di</strong>viduo”<br />
Teorie sulla molteplicità della identità:<br />
A) Concezione federativa: l’identità è il risultato <strong>di</strong> una connessione <strong>di</strong> esperienze<br />
successive, senza che vi sia un io ad esserne il titolare; siamo un’aggregazione <strong>di</strong><br />
successivi io; identità numerica, ma non qualitativa (continuità non-lineare)<br />
B) Personalità multipla<br />
C) Strati <strong>di</strong>versi della personalità<br />
Il doppio; l’inconscio (Rimbaud: “Je suis un autre”)<br />
14
Principio <strong>di</strong> identità degli in<strong>di</strong>scernibili<br />
Testi<br />
Il principio <strong>di</strong> identità degli in<strong>di</strong>scernibili <strong>di</strong> Leibniz recita:<br />
Eadem sunt, quorum unum potest substitui alteri salva veritate<br />
(cose che possono essere sostituite l’una all’altra, senza che la<br />
verità ne risulti alterata, sono le stesse). Se ogni pre<strong>di</strong>cato che<br />
vale per x vale anche per y, allora x ed y sono un solo ed identico<br />
ente. In natura non esistono, cioè, due entità che possano<br />
<strong>di</strong>fferire solo numero: se così fosse, non vi sarebbe una ragione<br />
sufficiente per spiegare l’esistenza dell’una piuttosto che<br />
dell’altra; i due enti sarebbero quin<strong>di</strong> uno stesso ente.<br />
Principio dei mon<strong>di</strong> possibili come entità sistemiche<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
«Io intendo per Mondo la serie e la connessione <strong>di</strong> tutte le cose esistenti, affinché non si<br />
<strong>di</strong>ca che parecchi mon<strong>di</strong> potevano esistere in tempi e in luoghi <strong>di</strong>fferenti. Infatti bisogna<br />
contarli tutti insieme come un mondo o, se si preferisce, come un Universo. E quando si<br />
riempissero tutti i tempi e tutti i luoghi rimarrebbe sempre vero che si sarebbe potuto<br />
riempirli in una infinità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong> e che vi sarebbe una infinità <strong>di</strong> mon<strong>di</strong> possibili fra i<br />
quali bisogna che Dio abbia scelto il migliore, perché egli non fa nulla senza agire<br />
secondo la ragione suprema(…)Qualche avversario, non potendo rispondere a questo<br />
argomento, risponderà forse alla conclusione con un argomento contrario, sostenendo<br />
che il mondo sarebbe potuto essere senza il peccato e senza il dolore; ma io nego che<br />
allora sarebbe stato il migliore. Perché bisogna riflettere che tutto è connesso in<br />
ciascuno dei mon<strong>di</strong> possibili: l’Universo, qualunque fosse per essere, è tutto d’un pezzo,<br />
come un Oceano; il minimo movimento estende il suo effetto a qualunque <strong>di</strong>stanza, <strong>di</strong><br />
modo che Dio ha tutto regolato in anticipo e una volta per tutte, avendo previsto le<br />
preghiere, le buone e le cattive azioni e tutto il resto, e ciascuna cosa ha contribuito<br />
idealmente, prima della sua esistenza, alla decisione che fu presa sull’esistenza <strong>di</strong> tutte<br />
le cose. Di modo che nulla può essere cambiato nell’Universo (come accade in un<br />
numero) tranne la sua esistenza o, se si preferisce, la sua in<strong>di</strong>vidualità numerica. Cosí se<br />
il piú piccolo male che accade nel mondo, non accadesse, non sarebbe piú questo<br />
mondo, che tutto sommato e soppesato, è apparso il migliore al Creatore che l’ha<br />
scelto».<br />
(G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pagg. 462-463)<br />
15
Principio dell’io come fascio <strong>di</strong> sensazioni<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
“Noi non siamo altro che fasci o collezioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti<br />
percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapi<strong>di</strong>tà, in<br />
un perpetuo flusso e movimento. I nostri occhi non possono<br />
girare nelle loro orbite senza variare le nostre percezioni. Il<br />
nostro pensiero è ancora più variabile della nostra vista, e tutti<br />
gli altri sensi e facoltà contribuiscono a questo cambiamento;<br />
né esiste forse un solo potere dell’anima che resti identico,<br />
senza alterazione, un momento. La mente è una specie <strong>di</strong><br />
teatro, dove le <strong>di</strong>verse percezioni fanno la loro apparizione,<br />
passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un’infinita<br />
varietà <strong>di</strong> atteggiamenti e <strong>di</strong> situazioni. Né c’è, propriamente,<br />
in essa nessuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi <strong>di</strong>fferenti, qualunque<br />
sia l’inclinazione naturale che abbiamo ad immaginare quella semplicità e identità. E<br />
non si fraintenda il paragone del teatro: a costituire la mente non c’è altro che le<br />
percezioni successive: noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste<br />
scene vengono rappresentate, o del materiale <strong>di</strong> cui è composta”.<br />
(Hume, I libro del Trattato sulla natura umana)<br />
16
Identità multipla<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Il problema <strong>di</strong> decidere fra alternative (ad es. tesi A o B: ve<strong>di</strong> primo incontro) c’è<br />
solo fino a quando presupponiamo che l’identità sia una. Se invece iniziamo a pensare<br />
che non sia così, allora il problema <strong>di</strong>viene quello <strong>di</strong> capire come si fa a tenere assieme<br />
le <strong>di</strong>verse figure dell’identità. Il problema è simile a quello iniziale, ma non del tutto:<br />
allora, infatti, ci domandavamo quale dei profili della personalità fosse quello autentico;<br />
ora partiamo, invece, dall’ipotesi tutti quei profili siano dentro <strong>di</strong> noi alla pari.<br />
→ Il doppio<br />
L.S. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde.<br />
Lettura dei brani in cui si delineano due <strong>di</strong>verse scene: quella della trasformazione<br />
volontaria e quella della trasformazione involontaria.<br />
Esercitazione: applicare due <strong>di</strong>verse teorie filosofiche dell’identità – quella <strong>di</strong> Locke e<br />
quella <strong>di</strong> Leibniz – al caso, considerato nelle sue due <strong>di</strong>verse eventualità, e rispondere al<br />
quesito: il dottor Jekill e del signor Hyde sono la stessa persona?<br />
(ve<strong>di</strong> scheda allegata su il <strong>di</strong>lemma logico dell’identità)<br />
Il racconto lungo<br />
<strong>di</strong> Stevenson si conclude<br />
con il dubbio <strong>di</strong> Jekill<br />
circa l’interrogativo se<br />
Hyde, inse<strong>di</strong>atosi nel suo<br />
corpo, troverà a sua volta<br />
il coraggio <strong>di</strong> uccidersi.<br />
Nota: attinenza<br />
della situazione<br />
prefigurata col percorso<br />
biografico dello stesso<br />
autore (cfr. Lo strano caso<br />
del Dottor Stevenson e <strong>di</strong><br />
Mister Myers)<br />
Esercitazione: prendere in esame le due ipotesi e tirare le conclusioni relative.<br />
→ Identità numerica / <strong>di</strong>scontinuità qualitativa<br />
Il principio <strong>di</strong> identità degli in<strong>di</strong>scernibili (ve<strong>di</strong> scheda allegata) sostiene che se<br />
due entità hanno le stesse proprietà, allora esse sono una stessa entità: se ogni pre<strong>di</strong>cato<br />
<strong>di</strong> x vale anche per y, allora x = y. La funzione del principio è quella <strong>di</strong> avvalorare la tesi<br />
che se in natura si dessero due enti talmente identici da non poter decidere quale sia<br />
l’originale e quale la copia, allora non vi sarebbe ragion sufficiente per decidere quale<br />
dei due dovrebbe esistere: ragion per cui la <strong>di</strong>fferenza solo numero viene da Leibniz<br />
esclusa dall’ambito del reale.<br />
Come si vede, nell’argomento leibniziano è presente il criterio della identità<br />
17
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
numerica.<br />
Confronti: dato che l’attuale sviluppo della ricerca me<strong>di</strong>co-scientifica ha reso<br />
attuale la possibilità <strong>di</strong> riprodurre cellule ed organismi animali, come viene a prefigurarsi<br />
– nei casi <strong>di</strong> clonazione – il rapporto fra copia ed originale?<br />
Se noi potessimo clonarci, ci rifaremmo correggendo qualche <strong>di</strong>fetto?<br />
Presupponendo la nozione leibniziana <strong>di</strong> mondo possibile come totalità sistemica (non si<br />
può mutare un elemento interno ad una totalità, senza mutare la totalità stessa; il<br />
mutamento <strong>di</strong> un elemento ci condurrebbe ipso facto all’interno <strong>di</strong> un’altra totalità),<br />
saremmo <strong>di</strong>sposti a cambiarci con un altro, che possiede qualche qualità <strong>di</strong> cui noi siamo<br />
privi?<br />
→ L’identità narrativa<br />
Fra le tesi filosofiche sulla identità, significativa è quella del filosofo scozzese<br />
Hume, per il quale l’io non è che un fascio o collezione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti percezioni, tenute<br />
assieme da una funzione rimemorativa (ve<strong>di</strong> scheda allegata). Di qui trae origine la<br />
cosiddetta la tesi “federativa”, che configura la personalità come una repubblica tenuta<br />
assieme dai vincoli reciproci fra i suoi membri. Secondo la concezione della identità<br />
narrativa, noi siamo un testo: personaggi <strong>di</strong> un copione aperto, che ha nella coscienza il<br />
suo centro <strong>di</strong> gravità narrativa.<br />
Esercitazione: sulla scorta dell’argomento logico noto come “paradosso del<br />
mucchio”, ognuno provi a re<strong>di</strong>gere una scheda con l’elenco delle sue do<strong>di</strong>ci proprietà<br />
più caratterizzanti; inizi poi a sottrarle una per una, al fine <strong>di</strong> rispondere al quesito:<br />
quando si cessa <strong>di</strong> essere qual che si è?<br />
→ La personalità multipla<br />
A partire dagli anni settanta ha iniziato a manifestarsi in forme sempre più<br />
evidenti quella che oggi è stata identificata nei<br />
manuali <strong>di</strong>agnostici internazionali come MPD<br />
(Multiple Personalità Disorder), cioè la sindrome da<br />
personalità multipla. Essa è venuta alla ribalta<br />
pubblica, anche e soprattutto in occorrenza <strong>di</strong> casi<br />
ed episo<strong>di</strong> drammatici. Taluni psicologici ipotizzano<br />
peraltro che questa sindrome sia l’estremizzazione<br />
<strong>di</strong> una tendenza, che abita normalmente all’interno<br />
<strong>di</strong> tutti noi: la fantasticheria o rêverie. Essa è in atto<br />
sia nei voli pindarici della nostra fantasia, sia nella<br />
assunzione dei <strong>di</strong>versi ruoli che possiamo<br />
interpretare nel “teatro del mondo”<br />
[ve<strong>di</strong> etimologia del termine “persona” dalla<br />
dramatis persona, cioè dalla maschera che l’attore<br />
18
indossa in teatro]<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Esercitazione / <strong>di</strong>scussione:<br />
– analizzando i casi <strong>di</strong> cronaca giu<strong>di</strong>ziaria i cui protagonisti sono portatori della<br />
sindrome MPD, quali decisioni prenderemmo, se fossimo noi a dover giu<strong>di</strong>care?<br />
– Re<strong>di</strong>gendo un sintetico <strong>di</strong>ario <strong>di</strong> una giornata quoti<strong>di</strong>ana-tipo, possiamo<br />
in<strong>di</strong>viduare comportamenti anche eterogenei in relazione ai <strong>di</strong>versi ruoli che ci<br />
troviamo ad assumere?<br />
19
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Il gioco delle identità: l’Enrico IV <strong>di</strong><br />
Pirandello/Bellocchio<br />
– Nel corso <strong>di</strong> una corsa carnevalesca il<br />
protagonista cade da cavallo e batte la testa al<br />
suolo; qualche ora dopo, è preso da un accesso<br />
aggressivo d’ira: episo<strong>di</strong>o da cui origina la sua<br />
immedesimazione nel personaggio nei cui panni<br />
si era calato. Come stabilire se, nei vent’anni<br />
successivi, si ha a che fare con la stessa o con<br />
un’altra persona?<br />
Identità Plurale<br />
– La finzione è tale da far aderire perfettamente il<br />
protagonista al personaggio? Come allora<br />
<strong>di</strong>mostrare che egli non è Enrico IV? E con quali<br />
criteri in<strong>di</strong>viduare quale è la copia e quale<br />
l’originale? [scrive Pirandello, in una lettera del<br />
1921 a Ruggero Ruggeri, l’interprete a cui voleva<br />
affidare il ruolo principale «Circa vent’anni<br />
ad<strong>di</strong>etro, alcuni giovani signori e signore<br />
dell’aristocrazia pensarono <strong>di</strong> fare per loro <strong>di</strong>letto, in tempo <strong>di</strong> carnevale, una “cavalcata<br />
in costume” in una villa patrizia: ciascuno <strong>di</strong> quei signori s’era scelto un personaggio<br />
storico, re o principe, da figurare con la sua dama accanto, regina o principessa, sul<br />
cavallo bardato secondo i costumi dell’epoca. Uno <strong>di</strong> questi signori s’era scelto il<br />
personaggio <strong>di</strong> Enrico IV; e per rappresentarlo il meglio possibile, s’era dato la pena e il<br />
tormento d’un stu<strong>di</strong>o intensissimo, minuzioso e preciso, che lo aveva per circa un mese<br />
ossessionato»].<br />
– Nell’ipotesi avvalorata in conclusione del film il protagonista ha finto <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>ventato<br />
pazzo. In questo caso siamo dunque in presenza <strong>di</strong> uno sdoppiamento della personalità<br />
che prevede l’elemento della volontarietà. Secondo quale teoria della personalità si tratta<br />
dunque della stessa persona? Gli altri però non sanno che quella del protagonista è una<br />
recita. Quale teoria potrebbe allora obiettare che si ha a che fare con una sola persona?<br />
– La scelta intenzionale per una vita artefatta è motivata dalla volontà <strong>di</strong> sottrarsi alla<br />
propria identità precedente, così come era riconosciuta dagli altri; la finzione mira<br />
dunque al contempo a suscitare negli altri un interrogativo sull’artificio reale – uno<br />
sdoppiamento ipocrita – della loro stessa identità (la leggenda del “re è nudo”; scena<br />
finale: “è pazzo o non è pazzo?”: qui la mo<strong>di</strong>fica operata da Bellocchio del testo<br />
pirandelliano, mira ancor <strong>di</strong> più a rendere grottesco il doppio gioco fra verità e finzione,<br />
autenticità ed inautenticità). Quale criterio <strong>di</strong> identità ispira in questo senso il<br />
protagonista?<br />
– Il film rimanda inoltre ad un intreccio che lega il problema dell’identità a quello del<br />
tempo [questo emerge in un passaggio del dramma: «Dovevate sapervelo fare da voi<br />
l’inganno; non per rappresentarlo davanti a me, davanti a chi viene qua in visita <strong>di</strong> tanto<br />
in tanto; ma così, per come siete naturalmente, tutti i giorni, davanti a nessuno [...] Per<br />
quanto orren<strong>di</strong> i miei casi, e orren<strong>di</strong> i fatti; aspre le lotte, dolorose le vicende: già storia,<br />
non cangiano più, non possono più cangiare, capite? Fissati per sempre»]. (Pier<br />
Damiani: è possibile retroagire nel tempo su ciò che è già accaduto? L’identità come<br />
narrazione: se io sono un testo, posso mutare <strong>di</strong> significato ad una scena pregressa in<br />
rapporto ad un senso che solo lo svolgimento successivo ha rivelato). Le manifestazioni<br />
20
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
del protagonista vogliono testimoniare che egli è rimasto fissato all’identità dei 26 anni:<br />
quella ritratta nel quadro. Sono svariati i paradossi che in questo senso ne conseguono.<br />
Al protagonista è comunicata la notizia della morte della madre: ma se ha ventisei anni,<br />
egli precede <strong>di</strong> fatto l’evento che non è ancora accaduto; la critica a Matilde “tu ve<strong>di</strong> i<br />
fantasmi!” intende invece stigmatizzare una rievocazione che riattualizza un passato<br />
avvenuto; l’intreccio fra questo aspetto temporale e la finzione conduce all’effetto<br />
massimamente ironico che vede il protagonista tentare <strong>di</strong> appartarsi con quella che era la<br />
giovane <strong>di</strong> allora (che – fra l’altro – è l’unico personaggio mosso da un moto <strong>di</strong><br />
spontanea umanità: il bacio); teoria dello psicoanalista, il controtrauma: riproducendo la<br />
scena originaria cha ha scatenato la crisi <strong>di</strong>ssociativa, l’effetto choc può staccare il<br />
protagonista dalla adesione al suo doppio <strong>di</strong>ssociato (il ruolo del fattore emotivo nelle<br />
sindromi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione, <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> memoria e <strong>di</strong> “fissazione”). Peraltro, è lo stesso<br />
personaggio che in un momento <strong>di</strong> sfogo lamenta il carattere coattivo della sua<br />
fissazione (carattere limitativo della identificazione per ruolo)<br />
21
Esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
Appunti <strong>di</strong> una lezione (II incontro) scritti dall'alunna Lorenza Ugo (IV B)<br />
1) Chi si crede Napoleone E' Napoleone?<br />
Edoardo: chi si identifica con Napoleone lo conosce, ma Napoleone non conosceva il<br />
suo "sostituto". Non c'è una conoscenza reciproca.<br />
Giulia: Napoleone ha vissuto nel suo periodo e ha compiuto in prima persona le sue<br />
gesta. Il suo "sostituto" invece non è inserito nella stessa realtà in cui visse<br />
Napoleone,dunque è solo una copia (IDENTITA' NUMERICA; UNICITA': coincidenza<br />
tra corpo e identità, una volta morto il corpo la persona non esiste più, chi ne assume la<br />
personalità è solo una copia, un sostituto).<br />
2)Ho due persone, Mr Brown e mr Robinson. Estraggo i loro cervelli e li inserisco nel<br />
corpo sbagliato. Chi E' il nuovo in<strong>di</strong>viduo ottenuto?<br />
Debora: il cervello ha il predominio sul corpo e gli fa fare quel che vuole: dunque la<br />
mente identifica l'identità dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
Sonia: se però il cervello nell'istante in cui non si trova in nessun corpo si "resetta" e<br />
<strong>di</strong>mentica la sua vita precedente, allora l'in<strong>di</strong>viduo verrà riconosciuto dagli altri e si<br />
sostituirà all'altro,quello vero, assorbendone l'identità.<br />
Giulia Z.: se però "Brownson", il nuovo in<strong>di</strong>viduo, non ricorda nulla, visto che si è<br />
"resettato", allora potrebbe incominciare una nuova vita ne' da Brown ne' da Robinson.<br />
3)Se Brownson dovesse commettere reato, CHI, la mente o il corpo del colpevole,<br />
dovrebbe essere arrestato?<br />
Giulia Z.: viene condannata la mente che guida il corpo, anche se le conseguenze le<br />
subisce il corpo <strong>di</strong> un innocente.<br />
Lorenza: ma allora il corpo non ha valore. Il corpo non è altro che un oggetto, nel<br />
nostro caso è l'arma del delitto e dunque il nuovo in<strong>di</strong>viduo è effettivamente identificato<br />
dalla nuova mente (per rispondere alla domanda precedente).<br />
Sonia: il cervello "resettato" non ha più legami con il corpo originario, quin<strong>di</strong> non ci<br />
sono problemi: la mente è la vera colpevole, il corpo è solo un "contenitore mobile" per<br />
la mente.<br />
PERO' NOI SIAMO SOLITI IDENTIFICARE I CORPI, NON LE MENTI.<br />
Fabio: cosa accadrebbe se reinserisco il cervello originario "resettato" nel suo corpo?<br />
Simone: pero' quando noi <strong>di</strong>ciamo che il cervello si "resetta" prima <strong>di</strong> inserirlo nel<br />
nuovo corpo, allora an<strong>di</strong>amo contro la nostra tesi, per la quale noi uniamo un corpo con<br />
la mente (con tutte le cose in esse contenute) <strong>di</strong> un altro in<strong>di</strong>viduo.<br />
4)INDIVIDUO= NON DIVISO, UNICO. Ma noi a volte non sembriamo noi. Siamo<br />
un'unità o siamo tante persone in uno stesso corpo?<br />
Alice: quando mi stupisco delle mie azioni <strong>di</strong>co: "non ero io", "ero fuori <strong>di</strong> me", "non<br />
ero in me".<br />
Lorenza: quando decido consapevolmente <strong>di</strong> comportarmi <strong>di</strong>versamente dalle mie<br />
abitu<strong>di</strong>ni sono sempre io o è qualcuna <strong>di</strong> queste altre identità che convivono in me a<br />
prendere il sopravvento?<br />
22
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
SE DICO "NON ERO IO"ALLORA CHI ERO? IO SONO DUE PERSONE E HO<br />
CAMBIATO "PERSONA"? la psicoanalisi si occupa dello stu<strong>di</strong>o dei vari Strati della<br />
personalità.<br />
Debora: visto che noi abitualmente non usiamo tutto il potenziale del nostro cervello,<br />
questa nuova persona deriva dall'uso <strong>di</strong> una parte ignota del nostro cervello.<br />
Giulia: però ci sono situazioni in cui mi comporto in un certo modo (magari<br />
istintivamente) ma col senno <strong>di</strong> poi avrei reagito in modo <strong>di</strong>verso.<br />
MA SE SONO PIU' PERSONE, QUALE E' QUELLA AUTENTICA? O SONO<br />
TUTTE AUTENTICHE?<br />
DOCTOR JECKILL & MISTER HIDE<br />
Secondo Liebniz sono la stessa persona, poiché abitano lo stesso corpo, non ci sono<br />
contemporaneamente, occupano lo stesso spazio. (IDENTITA' DEGLI<br />
INDISCERNIBILI).<br />
Secondo Locke invece non sono la stessa persona, perché sono <strong>di</strong>versi, non hanno le<br />
stesse caratteristiche fisiche, oltre alle <strong>di</strong>fferenze psicologiche (uno è un uomo normale,<br />
l'altro è piccolo, basso e brutto).<br />
SE LA SCIENZA CI CLONASSE, CHI SAREBBE L'ORIGINALE E CHI LA COPIA?<br />
SE NOI POTESSIMO MIGLIORARCI (CHIRURGIA, ecc...) E POI CI<br />
CLONASSIMO PER LASCIARE UN NOI "MIGLIORE DI NOI" LO FAREMMO?<br />
SE POTESSIMO DIVENTARE UN ALTRO SAREMMO DISPOSTI A CAMBIARCI?<br />
Forse, ma noi siamo legati a noi, i nostri ricor<strong>di</strong>, belli e brutti, ai nostri pregi e ai nostri <strong>di</strong>fetti,<br />
insomma A TUTTO CIO' CHE FA DI NOI NOI.<br />
23
Bibliografia essenziale<br />
<strong>Laboratorio</strong> <strong>di</strong> <strong>Filosofia</strong><br />
Identità Plurale<br />
• C. Taylor, Ra<strong>di</strong>ci dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Feltrinelli,<br />
Milano 1993<br />
• M. Di Francesco, La coscienza, Laterza, Bari-Roma 2005<br />
• D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura <strong>di</strong> sé, Raffaello Cortina,<br />
Milano 1995<br />
• Davide Sparti, Soggetti al tempo, Feltrinelli, Milano 1996<br />
• Id., Identità e coscienza, Il Mulino, Bologna 2000<br />
• R. Rutelli, Il desiderio del <strong>di</strong>verso. Saggio sul doppio, Liguori, Napoli 1984<br />
• F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari-Roma 2001<br />
• M. Clarke, I paradossi dalla A alla Z, Raffaello Cortina, Milano 2004<br />
24