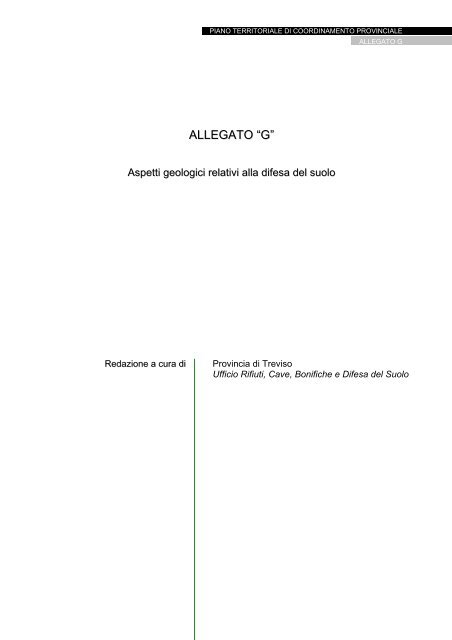ALLEGATO “G” - Provincia di Treviso
ALLEGATO “G” - Provincia di Treviso
ALLEGATO “G” - Provincia di Treviso
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
<strong>ALLEGATO</strong> <strong>“G”</strong><br />
Aspetti geologici relativi alla <strong>di</strong>fesa del suolo<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….<br />
Redazione a cura <strong>di</strong> <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong><br />
Ufficio Rifiuti, Cave, Bonifiche e Difesa del Suolo
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
INDICE<br />
1 PREMESSE...............................................................................................................................................5<br />
2 CONTENUTI DEL PTP PRECEDENTE .................................................................................................5<br />
3 ALTRI STUDI SULLA FRANOSITA’ LUNGO I VERSANTI ..............................................................7<br />
4 DATI SUGLI EVENTI FRANOSI ...........................................................................................................8<br />
5 METODOLOGIA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTCP RELATIVAMENTE ALLE<br />
AREE SOGGETTE A INSTABILITA’ DA FRANA ......................................................................................13<br />
6 NUOVI CONTENUTI DEL PTCP .........................................................................................................15<br />
3<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….
1 PREMESSE<br />
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
Le problematiche della <strong>di</strong>fesa del suolo inerenti la franosità interessano principalmente la<br />
parte montuosa e collinare del territorio provinciale, quella fascia che comprende verso Nord-<br />
Ovest circa un terzo della superficie della provincia. Va inoltre precisato che la situazione dei<br />
<strong>di</strong>ssesti lungo i versanti qui risulta, sia per numero che per estensione, meno preoccupante che<br />
in altre province del Veneto, come è il caso <strong>di</strong> Belluno o Vicenza.<br />
Un’analisi delle criticità relative a questo specifico ambito della <strong>di</strong>fesa del suolo rivolta<br />
all’aggiornamento del Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento <strong>Provincia</strong>le, inevitabilmente, si<br />
sviluppa a partire dallo stato attuale delle conoscenze in materia: esse sono rappresentate<br />
innanzitutto dallo stu<strong>di</strong>o realizzato dal dott. geol. Vittorio Fenti per il PTP vigente, risalente al<br />
1989; è poi necessario prendere in considerazione i dati e le informazioni contenute nei Piani<br />
<strong>di</strong> Assetto Idrogeologico (P.A.I.), elaborati negli ultimi anni dalle Autorità <strong>di</strong> Bacino, i quali<br />
sono l’esito - per lungo tempo atteso - <strong>di</strong> quella norma che doveva costituire il punto <strong>di</strong> svolta<br />
nel travagliato settore della <strong>di</strong>fesa del suolo (Legge 18 maggio 1989, n. 183).<br />
Inoltre, affinché i fattori <strong>di</strong> criticità in<strong>di</strong>viduati restituiscano le reali problematiche del<br />
territorio, andranno valutati anche i dati relativi agli eventi franosi registrati fino ai giorni<br />
nostri; le fonti a <strong>di</strong>sposizione sono molteplici (dati raccolti dalla <strong>Provincia</strong>, banche dati degli<br />
uffici regionali, del C.N.R., l’archivio nazionale A.V.I., ecc.), ma il progetto che si propone <strong>di</strong><br />
riunirle è l’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (I.F.F.I.), che costituisce il primo catasto<br />
omogeneo e aggiornato delle frane sull’intero territorio nazionale e in seno al quale sono<br />
destinati a confluire anche i dati raccolti dalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> tramite l’attività<br />
dell’ufficio Difesa del Suolo.<br />
2 CONTENUTI DEL PTP PRECEDENTE<br />
Oltre a fornire un inquadramento geologico-strutturale relativo al territorio provinciale e a<br />
descrivere con elevato dettaglio la serie stratigrafica e le proprietà tecniche delle rocce, il<br />
professionista incaricato ha proposto una sud<strong>di</strong>visione della provincia in quattro settori, in<br />
base alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche, ricollegabili a gran<strong>di</strong> linee all’età delle<br />
rocce affioranti:<br />
settore montano e pedemontano (rocce giurassiche e cretacee);<br />
settore collinare (rocce terziarie e quaternarie);<br />
settore dell’alta pianura;<br />
settore della bassa pianura.<br />
Ai fini della nostra analisi trascuriamo gli ultimi due settori, costituiti da depositi sciolti del<br />
Quaternario che non sono interessati dal rischio <strong>di</strong> frana in senso strettamente geologico e<br />
geomorfologico, mentre possono presentare problematiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto che afferiscono<br />
piuttosto alle tematiche del rischio idraulico.<br />
La parte montuosa prealpina si trova al limite Nord-Ovest della provincia e comprende la<br />
dorsale che dal Monte Cesen si estende fino al Col Visentin e i massicci del Monte Grappa e<br />
del Monte Millifret; essa viene completata dalla fascia <strong>di</strong> territorio pedemontano, dalla Valle<br />
5<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….
del Piave e dalla Val Lapisina. Morfologicamente il paesaggio è dominato da scarpate<br />
rocciose, versanti ripi<strong>di</strong> e valli molto incise, se sono presenti litotipi calcarei compatti; dove le<br />
rocce sono fittamente stratificate o marnose, i rilievi assumono forme a dosso, sono levigati e<br />
caratterizzati da scarsa roccia affiorante; tra i depositi, vanno ricordati i detriti <strong>di</strong> versante.<br />
Relativamente alla <strong>di</strong>namica geomorfologica, frequenti sono i <strong>di</strong>ssesti in roccia: si riscontrano<br />
crolli e ribaltamenti, piccoli <strong>di</strong>stacchi e rotolamento <strong>di</strong> massi; poco frequenti altre tipologie <strong>di</strong><br />
frana.<br />
La parte collinare più settentrionale è costituita da serie <strong>di</strong> dossi e creste intercalate a valli,<br />
originati da una serie monoclinale <strong>di</strong> strati (da Valdobbiadene a Vittorio Veneto, tra Fregona e<br />
Cor<strong>di</strong>gnano e nei Colli Asolani e <strong>di</strong> Cornuda); verso la pianura le colline assumono una<br />
morfologia più dolce e arrotondata (a Onigo, tra Colbertaldo e Solighetto, a Conegliano, a<br />
Colle Umberto). Tale <strong>di</strong>fferenziazione <strong>di</strong>pende dal prevalere <strong>di</strong> formazioni più o meno<br />
ero<strong>di</strong>bili; si va dalle rocce terziarie clastiche a forte componente terrigena (argilliti, arenarie,<br />
conglomerati, calcareniti e marne) ai depositi <strong>di</strong> copertura quaternari intravallivi, <strong>di</strong> origine<br />
morenica, alluvionale, lacustre e colluviale. Un <strong>di</strong>scorso a parte va fatto per la Collina <strong>di</strong><br />
Montebelluna ed il Montello, le cui forme sono <strong>di</strong> derivazione strutturale (blanda anticlinale<br />
con riattivazione neotettonica) e influenzate dai fenomeni carsici. A tutte queste litologie e<br />
depositi corrisponde un’energia del rilievo estremamente variabile che va da una morfologia a<br />
creste e <strong>di</strong>rupi ad ampie superfici orizzontali.<br />
Per quanto concerne l’assetto geomorfologico, bisogna <strong>di</strong>stinguere in base ai <strong>di</strong>versi<br />
litotipi rinvenibili. Le formazioni arenacee e le marne calcaree presentano in genere una bassa<br />
suscettibilità al <strong>di</strong>ssesto e, comunque, sempre a carattere superficiale; le argille e le marne<br />
argillose evidenziano una spiccata tendenza alla franosità che si esplica con <strong>di</strong>ssesti <strong>di</strong>ffusi,<br />
ripetuti e capaci <strong>di</strong> attivarsi anche su superfici a debole acclività (frana per colata o per<br />
scorrimento roto-traslativo); nei conglomerati le frane e le erosioni hanno un’incidenza e una<br />
variabilità tipologica strettamente correlata alla loro locale giacitura (strati orizzontali o<br />
variamente inclinati) ed hanno il loro esito più pericoloso nel crollo <strong>di</strong> volumi rocciosi<br />
consistenti (oltre il metro cubo); tra i depositi, infine, i materiali <strong>di</strong> origine morenica mostrano<br />
una propensione al <strong>di</strong>ssesto piuttosto elevata con frequenti smottamenti superficiali,<br />
movimenti <strong>di</strong> reptazione (creep) e scorrimenti rotazionali.<br />
Il citato stu<strong>di</strong>o del 1989, per ogni gruppo litologico <strong>di</strong> formazioni, entra nel dettaglio delle<br />
varie <strong>di</strong>namiche morfologiche e in<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> volta in volta le località interessate all’interno della<br />
porzione <strong>di</strong> territorio provinciale su in<strong>di</strong>viduata (viene in<strong>di</strong>cato anche il riferimento alla<br />
tavoletta I.G.M. 1:25.000, alla cui scala era stato impostato lo stu<strong>di</strong>o).<br />
A completamento e sintesi del lavoro svolto era stata elaborata la Carta Geomorfologica<br />
(Tav. 1.1 del Piano) in cui, su un fondo che rappresentava la <strong>di</strong>stribuzione geolitologica delle<br />
formazioni rocciose e dei depositi sciolti, era stata sovrapposta l’ubicazione delle situazioni <strong>di</strong><br />
instabilità, secondo le seguenti forme <strong>di</strong> erosione e <strong>di</strong> accumulo:<br />
scarpate <strong>di</strong> erosione attiva, scarpate <strong>di</strong> erosione non attiva;<br />
scarpate morfologiche d’altro tipo modellate nel substrato lapideo;<br />
nicchie <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> frane attive o recenti, nicchie <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> frane antiche o<br />
quiescenti;<br />
testate <strong>di</strong> bacino in fase <strong>di</strong> arretramento;<br />
bacini erosivi e franosi circoscritti o con <strong>di</strong>ssesti idrogeologici generalizzati;<br />
<strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> blocchi o massi isolati;<br />
solchi <strong>di</strong> erosione attiva, solchi <strong>di</strong> erosione non attiva o perio<strong>di</strong>ca:
depositi <strong>di</strong> frana recenti, depositi <strong>di</strong> frana antica;<br />
detriti <strong>di</strong> falda, conoi<strong>di</strong> detritiche e loro parte attiva;<br />
depositi morenici.<br />
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
Un limite <strong>di</strong> questo lavoro può forse essere in<strong>di</strong>viduato nel fatto che il complesso dei risultati<br />
e delle considerazioni prodotti deriva principalmente dalla fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o delle foto aeree della<br />
<strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> (volo 1968 in scala 1:20.000 circa e verifiche sul volo 1983-1985 in<br />
scala 1:33.000 circa), mentre sono stati riservati limitati tempi e risorse ai controlli e rilievi <strong>di</strong><br />
campagna, effettuati solo per risolvere <strong>di</strong>screpanze emerse tra fotointerpretazione, dati<br />
bibliografici e dati <strong>di</strong> derivazione comunale (P.R.G.C.). Tale impostazione è risultata una<br />
scelta obbligata in rapporto alle scadenze e alle risorse economiche a quel tempo stabilite<br />
dall’Ente.<br />
In fase <strong>di</strong> aggiornamento del Piano, lo stu<strong>di</strong>o andrà integrato con nuovi dati cartografici<br />
acquisiti attraverso i lavori recentemente realizzati da altri enti (perimetrazioni <strong>di</strong> aree a<br />
<strong>di</strong>fferente rischio o pericolosità <strong>di</strong> frana) e con dati <strong>di</strong> archivio relativi agli eventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />
storici.<br />
3 ALTRI STUDI SULLA FRANOSITA’ LUNGO I VERSANTI<br />
Sulla base delle in<strong>di</strong>cazioni della L. 183/89 e delle <strong>di</strong>sposizioni delle norme statali da essa<br />
derivate, le Autorità <strong>di</strong> Bacino hanno realizzato e approvato i Piani <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico<br />
che forniscono, tra l’altro, le conterminazioni delle aree <strong>di</strong> pericolosità geologica lungo i<br />
versanti. Più precisamente, l’Autorità dell’alto Adriatico - competente sui cinque bacini dei<br />
gran<strong>di</strong> fiumi del Nord-Est che vanno dall’Isonzo al Brenta-Bacchiglione – ha redatto, in<br />
collaborazione con i competenti uffici della Regione Veneto, i P.A.I. del Fiume Livenza, del<br />
Fiume Piave e del Fiume Brenta, ciascuno dei quali ricade parzialmente nella fascia montana<br />
e collinare <strong>di</strong> nostro interesse.<br />
Utilizzando una metodologia mutuata dalla procedura svizzera B.U.W.A.L. e adattata<br />
all’ambito territoriale in stu<strong>di</strong>o, sono state perimetrale alla scala 1:5.000 le aree franose ed è<br />
stato loro associato uno specifico livello <strong>di</strong> pericolosità (crescente da P1 a P4); sono state<br />
utilizzate procedure <strong>di</strong> valutazione della pericolosità <strong>di</strong> tipo geomorfologico a partire da<br />
classificazioni <strong>di</strong> alcuni parametri riguardanti le frane già avvenute in un determinato sito<br />
(velocità, volumi coinvolti, probabile tempo <strong>di</strong> ritorno), successivamente incrociate tramite<br />
apposite tabelle. Per ciascuna categoria <strong>di</strong> pericolosità geologica sono state in<strong>di</strong>cate delle<br />
misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a, cui sottoporre le aree risultate incluse.<br />
Queste informazioni ricavabili dagli elaborati cartografici dei P.A.I. andranno ad integrare la<br />
cartografia del P.T.C.P. in fase <strong>di</strong> revisione.<br />
Come era già stato fatto nel precedente Piano, sarà necessario procedere nuovamente alla<br />
consultazione dei Piani Regolatori Generali dei Comuni della zona <strong>di</strong> interesse, in particolare<br />
gli elaborati a carattere geologico e geomorfologico (Tavv. 10.1, 10.2, 10.4 e 10.9); a quel<br />
tempo erano state incontrate <strong>di</strong>fficoltà a causa della <strong>di</strong>somogeneità degli stu<strong>di</strong> analizzati e per<br />
la lacunosità <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong> essi, ma malgrado questi limiti la consultazione era risultata<br />
fondamentale quale metodo <strong>di</strong> taratura dei dati ricavati dall’indagine fotogeologica.<br />
Analogamente dovrà essere effettuato un confronto con gli elaborati geologici riguardanti<br />
territori provinciali a<strong>di</strong>acenti; il dott. Fenti aveva potuto giovarsi solamente della Carta<br />
7<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….
Litologico-Tecnica in scala 1:25.000 della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Pordenone e della Carta Geolitologica<br />
in scala 1:25.000 della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Venezia.<br />
E’ appena il caso <strong>di</strong> ricordare che la <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> ha da pochi mesi iniziato i lavori per<br />
l’elaborazione della Carta Geomorfologica del territorio provinciale <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> in<br />
collaborazione principalmente con l’Università <strong>di</strong> Padova - Facoltà <strong>di</strong> Geografia e con<br />
l’A.R.P.A.V.; purtroppo i tempi previsti per lo sviluppo e la conclusione del lavoro non sono<br />
compatibili con le scadenze molto più ravvicinate previste per l’aggiornamento del P.T.R.C..<br />
4 DATI SUGLI EVENTI FRANOSI<br />
L’insieme delle informazioni sugli episo<strong>di</strong> franosi avvenuti nel passato consente <strong>di</strong> realizzare<br />
un catasto cartografico che in<strong>di</strong>vidua gli ambiti territoriali che sono stati interessati dai<br />
fenomeni con maggior frequenza ed intensità (aree vulnerate).<br />
Sono numerosi i progetti finalizzati alla creazione e gestione <strong>di</strong> catasti dei <strong>di</strong>ssesti, promossi<br />
dalle amministrazioni e dai centri <strong>di</strong> ricerca interessati. Tralasciando la trattazione relativa a<br />
tutti gli enti che hanno avuto o hanno competenza sulla sistemazione dei <strong>di</strong>ssesti lungo i<br />
versanti (Genio Civile e gli altri uffici regionali, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Forestali<br />
Regionali, Comunità Montane, ecc.), esamineremo solo i progetti, coor<strong>di</strong>nati a livello<br />
nazionale o regionale, che si sono proposti <strong>di</strong> dare organicità alla grande mole <strong>di</strong> dati<br />
<strong>di</strong>sponibili.<br />
Un prima fonte <strong>di</strong> riferimento per un approccio storico al rischio geologico che insiste sul<br />
territorio della provincia <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> è rappresentato dai risultati conseguiti dal progetto<br />
nazionale A.V.I. (censimento delle Aree Italiane Vulnerate da calamità idrogeologiche) a suo<br />
tempo commissionato dal Ministro per il Coor<strong>di</strong>namento della Protezione Civile al Gruppo<br />
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche (CNR-GNDC), al fine <strong>di</strong> realizzare un censimento e catalogazione delle aree<br />
storicamente colpite da eventi <strong>di</strong> piena e da frane in Italia.<br />
Il Rapporto <strong>di</strong> Sintesi redatto nel 1994 per la Regione Veneto nell’ambito del Progetto<br />
AVI riporta informazioni <strong>di</strong> eventi catastrofici riferibili al periodo compreso tra il 1918 e il<br />
1990; successivamente si è provveduto ad aggiornare ed estendere nel tempo la ricerca dei<br />
dati. Tutte le notizie censite sono andate a costituire un archivio <strong>di</strong>gitale contenente oltre<br />
17.000 informazioni relative a frane ed oltre 7.000 informazioni su inondazioni; durante la<br />
fase <strong>di</strong> aggiornamento sono state reperite anche numerose informazioni <strong>di</strong> eventi verificatisi<br />
prima del 1991. L’archivio <strong>di</strong>gitale creato nel 1992 è stato messo a <strong>di</strong>sposizione degli utenti<br />
attraverso la rete Internet.<br />
Si riporta una tabella ricavata dall’archivio A.V.I. delle calamità geologiche avvenute<br />
lungo i versanti che hanno interessato la provincia <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong>, con in<strong>di</strong>cazione della data in<br />
cui si è manifestato l’evento, del comune e della località principale colpita:
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
Data Comune Località colpita<br />
17/8/1995 Segusino Comune <strong>di</strong> Segusino<br />
//1/1991 Conegliano Conegliano-Calle Scoto De<br />
Scoti<br />
11/2/1991 Vittorio Veneto Sant’Augusta-versante nord del<br />
colle<br />
//6/1990 Valdobbiadene Santo Stefano-lungo la strada<br />
nuova delle Grave<br />
12/6/1972 Vittorio Veneto Comune <strong>di</strong> Vittorio Veneto<br />
16/10/1960 San Pietro <strong>di</strong> Feletto San Pietro <strong>di</strong> Feletto<br />
14/5/1937 Vittorio Veneto Costa<br />
12/5/1911 Fregona Osigo<br />
//3/1911 Vittorio Veneto San Floriano<br />
// Cor<strong>di</strong>gnano Cava Pare<br />
Un’altra fonte <strong>di</strong> dati storici è lo stu<strong>di</strong>o a livello regionale realizzato in collaborazione<br />
dall’Istituto <strong>di</strong> Geologia Applicata del C.N.R. <strong>di</strong> Padova e dal Dipartimento per la Geologia e<br />
le Attività Estrattive della Segreteria Regionale per il territorio. Nel lavoro “Centri abitati<br />
instabili della Regione Veneto - prima indagine conoscitiva”, sono esposti i risultati della<br />
ricerca sui <strong>di</strong>ssesti che interessano, in particolare, i centri abitati della nostra regione.<br />
Per ciascun centro abitato instabile sono state preparate schede informative nelle quali si<br />
evidenzia: l’ubicazione del sito su base topografica scala 1:25.000; la tipologia dei <strong>di</strong>ssesti; le<br />
conseguenze dei <strong>di</strong>ssesti; l’anno, il mese e il giorno dell’evento o, in caso <strong>di</strong> più eventi, <strong>di</strong><br />
quello <strong>di</strong> maggior rilievo; la ripetitività dei <strong>di</strong>ssesti; i provve<strong>di</strong>menti intrapresi.<br />
Di seguito si riporta l’elenco dei comuni interessati da franamenti con l’in<strong>di</strong>cazione dei danni<br />
provocati dagli eventi stessi:<br />
Comune Frazione Tipologia <strong>di</strong>ssesto Conseguenze <strong>di</strong>ssesto Ripetitività <strong>di</strong>ssesto Data<br />
Fregona Breda Franamenti • Lesioni e danni ad Più volte<br />
abitazioni e strutture<br />
20/10/1963<br />
• Interruzione viabilità<br />
Cor<strong>di</strong>gnano Villa <strong>di</strong> Franamenti Lesioni e danni ad Una sola volta 24/7/1987<br />
Villa<br />
abitazioni e strutture<br />
Conegliano C.se<br />
Speran<strong>di</strong>o<br />
Franamenti Lesioni e danni ad<br />
abitazioni e strutture<br />
9<br />
Più volte //1977<br />
Nelle schede tratte dal lavoro citato viene riportata la localizzazione delle aree interessate dai<br />
<strong>di</strong>versi <strong>di</strong>ssesti:<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….
Comune Fregona<br />
Frazione Breda<br />
Data 20/10/1963<br />
Tipologia del <strong>di</strong>ssesto Franamento<br />
Conseguenze del <strong>di</strong>ssesto • lesioni e danni ad abitazioni e<br />
strutture<br />
• interruzione viabilità<br />
Ripetitività del <strong>di</strong>ssesto più volte
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….…………<br />
Comune Cor<strong>di</strong>gnano<br />
Frazione Villa <strong>di</strong> Villa<br />
Data 24/07/1987<br />
Tipologia del <strong>di</strong>ssesto Franamento<br />
Conseguenze del <strong>di</strong>ssesto lesioni e danni ad abitazioni e strutture<br />
Ripetitività del <strong>di</strong>ssesto una sola volta<br />
11<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………….
Comune Conegliano<br />
Frazione C.se Speran<strong>di</strong>o<br />
Data //1977<br />
Tipologia del <strong>di</strong>ssesto Franamento<br />
Conseguenze del <strong>di</strong>ssesto lesioni e danni ad abitazioni e strutture<br />
Ripetitività del <strong>di</strong>ssesto più volte<br />
12
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….………<br />
Con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 è stata, tra l’altro, trasferita dalla Regione alle<br />
Province la competenza sui pronti interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa idrogeologica e per il consolidamento degli<br />
abitati. Nel corso del 2001 il neonato ufficio Difesa del Suolo della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong> ha<br />
cominciato a dare riscontro alle segnalazioni provenienti da Comuni o da privati citta<strong>di</strong>ni e ad<br />
intervenire in somma urgenza, nel caso dai sopralluoghi fosse risultata una situazione <strong>di</strong> pericolo<br />
effettivo per la pubblica incolumità; da allora a fine 2005 sono pervenute 70 segnalazioni riferibili a<br />
situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto lungo i versanti e sono stati realizzati 30 interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza.<br />
Mappatura dati ufficio Difesa del Suolo<br />
Evidentemente questo catasto, essendo informatizzato e georeferenziato, rappresenta una fonte <strong>di</strong><br />
informazioni <strong>di</strong> particolare rilievo, in quanto è tenuto in costante aggiornamento e consente controlli<br />
e verifiche <strong>di</strong>rette sui dati. Anche questo archivio è in procinto <strong>di</strong> essere integrato nel già citato<br />
Progetto I.F.F.I..<br />
L’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani si propone <strong>di</strong> fornire un quadro completo ed aggiornato<br />
sulla <strong>di</strong>stribuzione delle frane sull’intero territorio nazionale attraverso la raccolta e la<br />
omogeneizzazione dei dati (ad oggi circa 400.000 eventi); esso è coor<strong>di</strong>nato dal Sevizio Geologico<br />
Nazionale ed è portato avanti, per il Veneto, dagli uffici regionali della Direzione Difesa del Suolo e<br />
Protezione Civile e della Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua.<br />
L’informatizzazione <strong>di</strong> tutte le notizie raccolte prevede la costituzione <strong>di</strong> una banca dati composta<br />
da un archivio alfanumerico e da un archivio cartografico collegati tra loro; al primo è associato un<br />
archivio iconografico contenente documentazione che descrive visivamente il fenomeno franoso.<br />
5 METODOLOGIA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTCP<br />
RELATIVAMENTE ALLE AREE SOGGETTE A INSTABILITA’ DA<br />
FRANA<br />
Si ritiene che le fasi <strong>di</strong> indagine da seguire per l’adeguamento del Piano per quanto attiene a questo<br />
specifico argomento, possano ricalcare quelle della prima stesura, con un taglio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong>verso,<br />
maggiormente rivolto all’aggiornamento e all’integrazione dei dati, all’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> specifici<br />
aspetti:<br />
Raccolta dati e ricerche bibliografiche<br />
Un’attenzione particolare andrà rivolta ai P.A.I. elaborati dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino dell’Alto<br />
Adriatico, dove questi contengono informazioni, soprattutto <strong>di</strong> tipo cartografico, sull’instabilità<br />
lungo i versanti.<br />
Consultazione Piani Regolatori Generali Comunali e elaborati geologici <strong>di</strong> territori provinciali<br />
a<strong>di</strong>acenti<br />
Tenendo conto che sono trascorsi parecchi anni dalla precedente ricognizione, si dovrebbe<br />
riscontrare un livello <strong>di</strong> informazioni maggiore nelle relazioni e nelle tavole degli stu<strong>di</strong><br />
geologici e geomorfologici dei piani comunali. Lo stesso si prevede anche per gli elaborati delle<br />
Province confinanti (in particolare Pordenone, Belluno e Vicenza).<br />
Stu<strong>di</strong>o fotointerpretativo<br />
13<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………
La lettura stereoscopica delle foto aeree rappresenterà ancora una volta la fase principale <strong>di</strong><br />
analisi del territorio e si concentrerà maggiormente sull’utilizzo del materiale derivante da voli<br />
più recenti rispetto a quelli 1968 e 1983-85 a suo tempo utilizzati, che sono stati da poco<br />
acquistati dall’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le: si tratta <strong>di</strong> fotogrammi in bianco e nero e a colori<br />
scattati tra il 2001 e il 2004; a questi si aggiungono anche le serie <strong>di</strong> ortofoto <strong>di</strong>gitali a colori del<br />
programma “it2000” e del successivo “it2000 Nuova Release” del 2004.<br />
Oltre all’aggiornamento cartografico delle forme ricollegabili all’instabilità geomorfologica,<br />
sarà quin<strong>di</strong> possibile effettuare un confronto tra <strong>di</strong>verse epoche per verificare lo stato <strong>di</strong> attività<br />
dei fenomeni (attivi, inattivi, quiescenti) e la loro propensione a ripetersi nel corso degli anni.<br />
In questa fase ci si potrà avvalere del complesso dei dati <strong>di</strong> archivio georeferenziati, <strong>di</strong>sponibili<br />
negli uffici e reperiti all’esterno, per dare riscontro alle informazioni interpretate attraverso le<br />
immagini. Così sarà, inoltre, possibile in<strong>di</strong>viduare i settori del territorio interessati dai fenomeni<br />
franosi con maggior frequenza ed intensità, allo scopo <strong>di</strong> assegnare un <strong>di</strong>verso livello <strong>di</strong><br />
vulnerabilità a ciascuna zona interessata da <strong>di</strong>ssesti.<br />
Controlli e rilievi <strong>di</strong> campagna<br />
Essi rivestono un ruolo <strong>di</strong> rilievo per chiarire le <strong>di</strong>screpanze che possono emergere dal confronto<br />
dei vari set <strong>di</strong> dati (bibliografia, cartografia consultata, fotointerpretazione, dati <strong>di</strong> archivio); o,<br />
più banalmente, vi si ricorre per quelle zone che sono caratterizzate da un estesa copertura a<br />
bosco, la quale non consente la visione <strong>di</strong>retta del suolo sul supporto fotografico; servono anche<br />
per definire l’effettiva situazione <strong>di</strong> siti risultati potenzialmente instabili alla luce degli elaborati<br />
cartografici, ma per i quali non vi sono riscontri <strong>di</strong> archivio. In generale, consentono un<br />
controllo <strong>di</strong>retto (taratura) <strong>di</strong> tutte le informazioni che si ricavano in<strong>di</strong>rettamente con le altre fasi<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Per contro, queste verifiche, estese a tutta la parte <strong>di</strong> territorio <strong>di</strong> interesse, comportano un<br />
considerevole impegno in termini <strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> risorse economiche Va, pertanto, tenuto<br />
presente che il livello <strong>di</strong> qualità dei risultati <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o come quello che si va ad intraprendere<br />
<strong>di</strong>pende dalle risorse destinate a questa delicata fase <strong>di</strong> lavoro.<br />
Elaborazione della cartografia<br />
Oltre alla carta che riporta la geologia del substrato roccioso e dei depositi superficiali, per la<br />
fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o andranno pre<strong>di</strong>sposti altri livelli <strong>di</strong> informazioni (layer): anzitutto quelli dei temi<br />
strettamente legati all’instabilità dei versanti (forme <strong>di</strong> superficie e informazioni <strong>di</strong> archivio), <strong>di</strong><br />
cui si è già trattato; inoltre verranno aggiunti altri tematismi reperibili presso gli uffici<br />
provinciali o derivanti da elaborazioni informatiche su dati esistenti; in fase <strong>di</strong> lavoro, più layer<br />
potranno essere combinati all’interno <strong>di</strong> una stessa carta a seconda delle esigenze <strong>di</strong><br />
rappresentazione o interpretative, avendo come solo limite quello della leggibilità, alla scala<br />
adottata, <strong>di</strong> tutte le informazioni riportate.<br />
Segue un primo elenco dei temi <strong>di</strong> interesse, che potrà essere ampliato in base alle necessità <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o:<br />
− (aggiornamento e integrazione delle) forme <strong>di</strong> superficie rappresentative dei processi <strong>di</strong><br />
instabilità lungo i versanti;<br />
− dati P.A.I. e dati <strong>di</strong> archivio;<br />
− vegetazione e uso del suolo;<br />
− piovosità;<br />
− sismicità;<br />
− acclività;<br />
− esposizione.<br />
I risultati delle varie fasi <strong>di</strong> indagine verranno rappresentati su una cartografia riassuntiva alla<br />
scala 1:50.000.<br />
14
6 NUOVI CONTENUTI DEL PTCP<br />
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….………<br />
15<br />
<strong>ALLEGATO</strong> G………………<br />
Di pari passo con la raccolta e l’analisi dei dati territoriali verranno sviluppati alcuni argomenti in<br />
tema <strong>di</strong> sicurezza idrogeologica lungo i versanti:<br />
− In<strong>di</strong>viduazione delle aree potenzialmente soggette al pericolo correlato all’instabilità dei<br />
versanti, ottenibile attraverso un incrocio ragionato (overlay mappping) <strong>di</strong> più tematismi<br />
reperiti, quali geolitologia, topografia, acclività, piovosità, dati <strong>di</strong> archivio, ecc.; esse andranno<br />
ad aggiungersi ai siti già interessati da eventi franosi; stesura delle relative carte tematiche. A<br />
questo proposito, vale la pena ricordare quanto più su detto sull’importanza <strong>di</strong> dare un adeguato<br />
peso anche alla fase delle verifiche <strong>di</strong> campagna delle informazioni ricavate a tavolino o per via<br />
informatica.<br />
− Proposte <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> priorità da applicare nella programmazione degli interventi a favore delle<br />
aree in <strong>di</strong>ssesto e <strong>di</strong> quelle risultate potenzialmente instabili. Per le situazioni già inserite nei<br />
P.A.I., andrà preso a riferimento il grado <strong>di</strong> pericolosità assegnato a ciascuna <strong>di</strong> esse a seguito<br />
delle operazioni <strong>di</strong> perimetrazione e <strong>di</strong> classificazione.<br />
− Definizione <strong>di</strong> linee generali <strong>di</strong> intervento, alle quali rifarsi nella progettazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />
sistemazione o <strong>di</strong> attenuazione delle problematiche <strong>di</strong> instabilità, considerando le situazioni <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ssesto più ricorrenti.<br />
− In<strong>di</strong>cazioni da utilizzare nella pianificazione territoriale, in presenza <strong>di</strong> aree potenzialmente già<br />
instabili, da parte degli strumenti urbanistici dei Comuni ancora da re<strong>di</strong>gere (eventuale<br />
adeguamento <strong>di</strong> quelli esistenti). Anche a questo proposito, andrà tenuto conto <strong>di</strong> quanto già<br />
prescritto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino nelle norme <strong>di</strong> attuazione dei P.A.I., con riferimento ai vari<br />
livelli <strong>di</strong> pericolosità in<strong>di</strong>viduati da questi piani.<br />
− Proposte per incentivare il rilancio delle operazioni <strong>di</strong> cura e conservazione del territorio in aree<br />
che risultano da tempo trascurate dall’uomo e dalle istituzioni: manutenzione dei boschi,<br />
ripristino <strong>di</strong> terreni boschivi degradati da incen<strong>di</strong>, reintroduzione <strong>di</strong> colture collinari tipiche non<br />
più praticate, ecc.<br />
− Definizione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> monitoraggio per singole aree in <strong>di</strong>ssesto o per l’intera fascia<br />
montana e collinare della provincia.