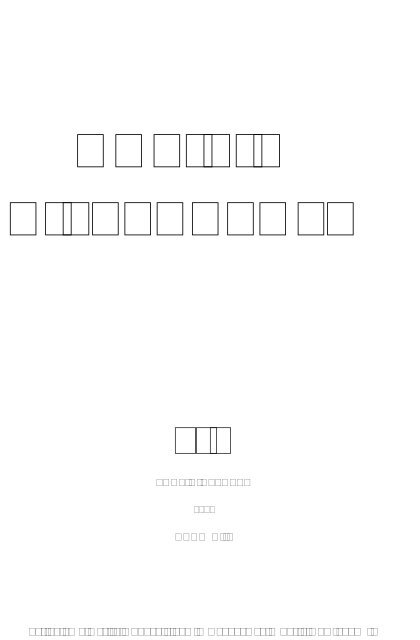Leggi - I Cistercensi
Leggi - I Cistercensi
Leggi - I Cistercensi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTIZIE<br />
CISTERCENSI<br />
4-5<br />
LUGLIO-OTTOBRE<br />
1975<br />
ANNO VIII<br />
Periodico bimestrale - Spedizione in Abbonamento Postale - Gruppo IV
NOTIZIE CISTERCENSI<br />
Direttore:<br />
P. Goffredo Viti<br />
Redazione:<br />
PP. Certosa di Firenze<br />
Consiglio di Redazione:<br />
P. Placido Caputo<br />
P. Malachia Falletti<br />
P. Vittorino Zanni<br />
Responsabile:<br />
Agostini Carlomagno<br />
Conto corrente 5/7219<br />
Periodico bimestrale di vita cistercense<br />
Abbonamento annuo: Italia L. 3.000<br />
Abbonamento annuo: Estero L. 4.000<br />
Amministrazione: Certosa del Galluzzo - 50124 Firenze - tel. 055/28.92.26
L'ABATE E LA DIREZIONE SPIRITUALE<br />
di Malachia Falletti<br />
Introduzione<br />
La parola « crisi », nella sua accezione più abusata di « tentennamento<br />
nel buio alla ricerca di qualcosa» è diventata un po' la chiave di<br />
volta di ogni discorso sulle istituzioni e forme di vita, sia nel campo<br />
civile che in quello religioso. Non si tratta di una realtà propria del<br />
momento storico in cui viviamo, ma certamente essa oggi ha preso<br />
uno sviluppo tutto particolare da rasentare la patologia.<br />
« Fin dalla sua prima origine la Chiesa vive in un clima di crisi.<br />
Le sue molteplici divisioni sono le cicatrici di crisi passate e mai<br />
risolte. Discussioni, controversie, anatemi, eresie, scismi hanno<br />
spesso caratterizzato la storia di una chiesa che dovrebbe invece<br />
essere un focolaio di amore e di unità nel mondo. Perciò la crisi<br />
che squassa oggi la chiesa cattolica romana e, in certa misura anche<br />
le altre chiese occidentali, non è fenomeno nuovo. Anzi è addirittura<br />
un fenomeno naturale e positivo. I periodi senza la crisi nella<br />
Chiesa, quando poi capitano, in generale sono epoche di sonno e di<br />
abbandono che preparano dei risvegli della coscienza evangelica<br />
tanto più dolorosi, quanto più ilsonno sia stato profondo e lungo » 1<br />
Tra le realtà che maggiormente risentono di questo clima, possiamo<br />
situare senza dubbio 1'« autorità », e di conseguenza ogni relazione che<br />
in qualche modo si innesti in questa realtà: «maestro-allievo », «magistero-popolo<br />
di Dio », «sacerdote-fedele », «superiore-suddito ».<br />
« Dentro la Chiesa - scrive P. Balducci - si è aperto uno<br />
spazio, stupendo e terribile: lo spazio concreto che c'è tra il modo<br />
concreto di essere chiesa - poniamo essere preti - e la parola di<br />
Dio, dichiarata norma normans, con la quale la chiesa stessa deve<br />
confrontarsi. Essa si è messa sotto il giudizio permanente della<br />
Parola di Dio. Lo stesso magistero è sotto la norma normans.<br />
Si tratta di vedere sul piano pratico dell'obbedienza, come risol-<br />
1 B. BESRET, Per una nuova Chiesa, Cittadella Ed. Assisi 1972, p. 11. Per quanto<br />
riguarda la crisi del sacerdozio cfr. E. BALDUCCI, La fede della fede, Cittadella Ed.<br />
Assisi 1975, p. 7 e ss.<br />
- 105
vere questo rapporto ... Non basta ormai dare una disposizione<br />
per ottenere obbedienza. La nostra esigenza di raffrontare un ordine<br />
alla Parola di Dio non è abusiva, è essenziale. E se in quel<br />
rapporto l'ordine non ci appare per niente coerente, noi ci sentiamo<br />
abbastanza tranquilli fuori dell'orbita della obbedienza.<br />
Perché l'obbedienza fondamentale è quella alla Parola di Dio.<br />
Questa lacerazione è appena cominciata, si aprirà sempre più» 2.<br />
Possiamo dissentire alquanto su alcune affermazioni, ma sulla<br />
sostanza del fatto non si può che concordare con l'autore.<br />
In questo contesto, il tema proposto: «L'abate e la direzione spirituale<br />
», richiamando la relazione « maestro-discepolo », « padre-figlio »,<br />
acquista un interesse del tutto eccezionale, anche se, d'altra parte non<br />
ci lascia molta speranza di riuscire a. proporre soluzioni facilmente<br />
accettabili .<br />
1. ABATE E DIREZIONE SPIRITUALE NELLA REGOLA DI SAN BENEDETTO<br />
Per partire, nella nostra ncerca, da un punto fermo, dobbiamo<br />
considerare il ruolo dell'abate nella direzione spirituale secondo il<br />
progetto benedettino, quale ci appare nella Regula Benedicti, specialmente<br />
se raffrontata con la precedente Regula Magistri 3. La RB infatti,<br />
non è la codificazione delle idee e delle invenzioni di San Benedetto,<br />
ma è la cristallizzazione di formule a sua volta diluibili, di una tradizione<br />
e di una esperienza di secoli.<br />
Non dobbiamo dimenticare che il Concilio Vaticano II ha invitato i<br />
religiosi al rinnovamento della vita religiosa col ritorno al genuino<br />
« spirito » dei fondatori, pur lasciando cadere tutti gli elementi caduchi<br />
dalla sua realizzazione che i tempi e il loro evolversi hanno manifestato<br />
come non perenni 4.<br />
A riguardo della funzione della Regola di Benedetto nell' oggi della<br />
2 E. BALDUCCI, La fede della fede, Cittadella Ed. Assisi 1975, p. 15.<br />
3 Sulla relazione tra le due regole cfr. A. DE VOGUÉ,La Règle de Saint Benoìt, Ed.<br />
du Cerf 1972, 6 volumi; A. DE VOGuÉ, La Règle du Mattre, Ed. du Cerf 1964, 3 volumi.<br />
In queste due opere si troverà anche tutta la bibliografia recente al riguardo.<br />
4 «Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una fisionomia e<br />
una propria funzione. Perciò fedelmente si interpretino o si osservino lo spirito e le<br />
finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni... » PC 2 b) Deh. 708.<br />
- 106-
storia le tendenze ed i pareri in campo monastico sono estremamente<br />
divergenti, andando dalla considerazione della RB come libro attualissimo,<br />
a quello della RB come monumento storico con un influsso sul<br />
presente limitato ai capitoli cosiddetti « spirituali ».<br />
Dom Sigardo Kleiner, abate generale dell'Ordine Cistercense, ha recentemente<br />
scritto nella prefazione del suo libro di intrattenimenti sulla<br />
Regola:<br />
« Le présent livre se propose de montrer les bonnes raisons<br />
que nous avons de nous attacher à St. Benoi, La Règle en effet n'a<br />
pas besoin d'ètre reformée ou contournée pour étre up to date,<br />
il faut tout simplement savoir la lire comme un vieux livre millénaire<br />
doit ètre lu aujourd'hui. Les saintes Ecritures ne sont pas non<br />
plus périmées parce qu' elles se présentent dans un vètement<br />
vétuste » 5.<br />
L'abate benedetetino Dom Van der Wielen concorda con questa<br />
tesi, motivando questa attualità con i concetti moderni di collegialità e<br />
democrazia che sarebbero condivisi in pieno dalla RB 6. Checché ne sia<br />
del giudizio, la motivazione sembra però non reggere ad una critica più<br />
severa e all'esegesi del testo della RB, come si può leggere in uno scritto<br />
dell'Abate Primate dell'Ordine benedettino sul ruolo che deve assumere<br />
l'abate in una società democratica 7.<br />
Molto critica, infine, è Maria Giovanna Dore in un articolo che però<br />
con più punti interrogativi che soluzioni. Essa scrive:<br />
« Come si presenta la Regola di San Benedetto di fronte all' oggi,<br />
di fronte a noi, al punto in cui ci troviamo nell'evoluzione del monachesimo,<br />
nel dissenso e nell'allontanamento dalla regola? Dò per<br />
scontata la inevitabilità e la saggezza persino, di tale allontanamento,<br />
indicando con questa parola tutto ciò che ha messo il monachesimo<br />
su strade nuove e diverse rispetto alla Regola. Per cogliere<br />
le distanze, le differenze, le opposizioni esistenti tra la RB e noi<br />
basta conoscere sufficientemente, modestamente la Regola nella sua<br />
espressione letterale, leggerla come sta scritta e conoscere, sia pure<br />
approssimativamente, i momenti liturgici, ascetici, disciplinari, che<br />
percorrendo abbattendo e costruendo l'area del moderno monache-<br />
5 S. KLEINER, O. Cist., Dieu premier servi, Ed. Téqui - Paris 1974 p. 21.<br />
6 A. VAN DER WIELEN, OSB, L'abbé uicaire du Christ, in Collectanea Cisterciensia,<br />
31 (1969) p. 128.<br />
7 R. WEAKLAND, OSB, L'abbé sans une societé démocratique, in Collectanea Cisterciensia,<br />
31 (1969) p. 102-108.<br />
- 107-
simo ... L'abate di oggi è concepito e realizzabile come quello della<br />
Regola? La concezione dell'autorità è identica o somigliante alla<br />
nostra? .. Quale utilizzazione concreta può farsi, oggi, dei capitoli<br />
relativi? O nessuna o quasi nessuna! Ci sembra di utilizzarli, ma<br />
non è autenticamente vero. Ci manca forse il coraggio di riconoscerlo?<br />
... Non sono pochi i capitoli in cui può e potrà essere utilizzata<br />
la sostanza ispiratrice, ma non altro. Molti quelli che non<br />
hanno più alcun mordente effettivo su di noi. Quasi tutti, se si eccettuano<br />
gli «spirituali» hanno qualche cosa che disturba, che<br />
ostacola l'adesione contemporanea o nella direttiva pedagogica o nei<br />
dettagli pratici ... Sotto l'aspetto esistenziale Regola e monachesimo<br />
odierno mancano di contatti reciproci, non fanno corpo insieme» 8.<br />
Qualunque sia la nostra posizione di fronte alla RB, come benedettini<br />
è necessario vedere quel'era la concezione del Santo legislatore circa<br />
l'abate per quel che riguarda la direzione spirituale dei suoi monaci, al<br />
fine di stabilire come questa concezione sia ancora realizzabile oggi, e<br />
sotto quali forme.<br />
Monastero: Scbola Dominici seroitii<br />
Il monastero, secondo Benedetto, è la « schola dominici servitii ».<br />
In essa quindi vige una relazione essenzialmente verticale: maestro-discepolo.<br />
La ragione per cui alcune persone si radunano per formare una<br />
scuola, è data dal fatto che vi è qualcuno che ha qualcosa da insegnare<br />
e una disciplina da imporre. Trattandosi poi non di una scuola comune,<br />
ma di una « schola dominici servitii », il maestro deve essere un uomo<br />
che conosce la volontà di Dio: un uomo ripieno dello spirito della divina<br />
parola, che cammina nella volontà divina e che è in grado di guidare gli<br />
altri sulla medesima strada. Egli è il « doctus in lege divina» e come<br />
tale appartiene alla categoria dei dottori, quindi a una delle categorie<br />
dei carismatici di cui parla San Paolo. L'abate non è quindi tale nella<br />
linea gerarchica, ma nella linea carismatica.<br />
Nell'eremitismo orientale questa soluzione, codificata poi nella RB,<br />
è estremamente evidente. Il rapporto tra i monaci è sempre tra anziano<br />
e discepolo: colui che è giunto, sotto la guida di un anziano, ad acquistare<br />
la sapienza e ilmodo di vivere la volontà di Dio, che si è assuefatto<br />
8 M. G. Doas, LA Regola oggi, in Vita Monastica, n. 104 p. 54-57.<br />
- 108-
al colloquio personale con Dio nella preghiera e nell'ascolto della sua<br />
parola nella lettura della Sacra Scrittura, che ha appreso le sante astuzie<br />
per sconfiggere il Tentatore, diventa a sua volta maestro nei riguardi<br />
di altri principianti che vogliono, come lui, trovare Dio.<br />
Una differenza verrà subito a fare sentire il suo peso diversificando<br />
il ruolo dell'« abba » nell'eremitismo orientale, da quello dell'abate di<br />
un cenobio, sia quello di Pacomio, sia in seguito quello di Benedetto:<br />
il rapporto estremamente semplice nel primo caso, ridotto quasi esclusivamente<br />
alla cura spirituale del discepolo, si moltiplica e si complica<br />
quando i discepoli diventano numerosi, creando anche molti problemi<br />
di organizzazione e sussistenza.<br />
Christi enim agere creditur vices in monasterio<br />
Si è spesso voluto assimilare la posizione dell' abate nel monastero<br />
a quella del « paterfamilias » romano nell'ambito della famiglia romana.<br />
Nulla di più inesatto. L'abate non è la manifestazione di una autorità<br />
propria, nativa, come era il paterfamilias, poiché « Christi agere creditur<br />
vices in monasterio ».<br />
« Le nom d'abbé, qui signifie « père », réfère donc celui qui<br />
le porte au Christ mème. C'est du Christ que l'abbé tient sa mission,<br />
c'est lui qu'il représente. Le nom d'abbé évoque moins la paternité<br />
du supérieur à l'egard de ses disciples, que sa qualité de représentant<br />
de l'unique « abba » qui est le Christ en personne. Certes le<br />
abbé est père, mais il ne s'agit la que d'une paternité déléguée » 9.<br />
In questo modo si trova la formula per non contravvenire al comando<br />
di Gesù: «non chiamerai nessuno « padre mio» sulla terra».<br />
È chiaro però che tutta la vita e l'organizzazione della società cenobitica<br />
ricadeva sull'abate: i discepoli rimettevano nelle sue mani tutte le<br />
preoccupazioni di ordine spirituale e materiale per dedicarsi, sotto la<br />
sua guida, alla ricerca della volontà di Dio.<br />
« La sujection à un abbé est le signe efficace d'un renoncement,<br />
de sort che l'abbé doit, pour répondre à la requète la plus profonde<br />
de son fils spirituel, consentir à prendre sur lui une autorité plénière,<br />
9 A. DE VOGÙÉ, OSB La Communauté et l'Ab bé dans la Règle de St. Benoit,<br />
Desclée - Paris - 1961, p. 139.<br />
- 109-
à laquelle n' échappe aucun des éléments de sa personalité et de son<br />
exsistence » 10.<br />
Nessuno potrà sostituire l'abate in questo ufficio 11.<br />
Potrà e dovrà avere degli aiuti, ma il peso della responsabilità ultima<br />
sarà sempre sulle sue spalle, perché è lui che deve rispondere davanti a<br />
Dio di tutti gli atti dei suoi discepoli, nessuno escluso, dal momento<br />
che si suppone che i discepoli siano docili e obbedenti alle sue parole,<br />
ai suoi insegnamenti, ai suoi comandi.<br />
« Il n'y a dans le monastère, en quelque sorte, qu'une seule<br />
volonté, et par suite une seule responsabilité. Les disciples se sont<br />
confìès à un homme capable, espèrent-ils, de faire triompher en<br />
toute circostance la volontè de Dieu sur la sollicitation du diable et<br />
de la chair. Ils ont mis leur volonté dans celle de l'abbé, parce que<br />
la volonté de I'abbé est unie a celle de Dieu. Soustraire quelque<br />
chose à l'autorité de ce maitre de vie chrétienne serait les frustrer<br />
dans leur attente » 12.<br />
In questo senso nulla di più falso che assimilare la società cenobitica<br />
benedettina ad una società democratica 13. Lo stesso capitolo « De<br />
adhibendis ad consilium fratrihus » nulla toglie all'autorità unica dell'abate<br />
come animatore e guida della comunità. Anche se vi si ribadisce<br />
che egli è ecclesia quaerens in quanto non deve agire in nome proprio,<br />
ro A. DE VOGuÉ, La Communauté et l'Abbé dans la Règle de St. Benott, Desclée -<br />
Paris 1961, p. 149.<br />
11 «Le supérieur est le chef de la Congregation; il est la tète d'un corps duquel<br />
tous ses frères sont les membres et les parties; et comme le propre de la tète dans le<br />
corps humain est de gouverner, de conduire, de former tous les mouvements et toutes<br />
les actions et que, tout se rapportant à elle, il ne se passe rien dont elle ne soit l'origine<br />
et le principe, il faut aussi que dans una communautée reglée tout se fasse par les<br />
ordres et dans la dépendance du supérieur, qu'il dispose de toutes les choses pour la<br />
utilité et pour le bien des particuliers: qu'il applique les sujets et qu'il ordonne de leurs<br />
occupations et de leurs exercices; qu'il dirige leur conscience, qu'il règle leur piété et<br />
qu'il n'y ait rien sur quoi sa vue et sa diréction ne s'étende. C'est ce que pensait Saint<br />
Benoit quand il declare que le supérieur doit tenir la place et faire le fonctions de<br />
Jésus Christ dans le Monastère, qu'il atout dans sa disposition et que il n'y a rien<br />
qui ne soit soumis a ses ordres » A. J. LE BOUTHILIER DE RANCÉ, De la saintété et des<br />
deooirs de la vie monastique, Paris - Duprat 1846 p. 160-161.<br />
12 A. DE VOGiiÉ, O. c. p. 151.<br />
13 «Souvent les décision s'élaborent dans la recherche commune, et dans ce cas<br />
l'abbé les homologue s'il juge qu'elles s'accordent au dessein de salut du Père en faveur<br />
de ses fils. Mais il peut arriver, il arrive, que la recherche commune aboutisse à un<br />
impasse, ou qu'une rnajorité l'emporte sur une minorité dont les avis sont cepedant plus<br />
évangéliques que ceux de la majorité, Le ròle de l'abbé prends alors toute sa signification;<br />
c'est de son obéissance que va dépendre la qualité d'aroour de la coromunauté.<br />
C'est à lui de discerner dans la prière, la réfléxion et la dialogue avec ses frères, la<br />
volonté du Père sur sa communauté », F. X. HANIN, OCSO, Autorité et obéissance bier<br />
et bauioud'bai, in Collectanea Cisterciensia, 31 (1969) p. 118.<br />
- 110
ma quale vicegerente di Cristo, il modo di ricerca e l'interpretazione<br />
della volontà dell'unico maestro è di sua spettanza esclusiva, che in<br />
ultima analisi « quod vult facit ».<br />
Certo quanto più numerosi sono i discepoli, tanto più l'abate<br />
deve sentire il bisogno di farsi aiutare da alcuni confratelli più sperimentati<br />
e «spirituali », con i quali deve «partiri onera sua ». In<br />
questa richiesta di aiuto, però, due punti restano ben fermi.<br />
Non si tratta, innanzitutto di creare uffici autonomi, sia che si<br />
tratti di decani, priori, cellerari, maestri dei novizi..., ma soltanto di<br />
suscitare collaboratori suoi, che agiscono in piena dipendenza da lui e<br />
restano nell'ambito dell'azione da lui programmata.<br />
« Il est intéressant de constater qu'au chapitre 58 St. Benoit<br />
ne parle pas de « maitre » des novices », de « magister ». L'ancien<br />
député aux novices n'est pas maitre dans le sens où ce mot convient<br />
a l'abbé. Certes, le maitre des novices doit enseigner, puisque lui<br />
aussi, sans aucun doute, doit montrer a ses élèves les choses dures<br />
et àpres sur le chemin de Dieu. Mais il n'est pas un maitre ayant<br />
sa doctrine personnelle; il doit enseigner dans la ligne doctrinale de<br />
l'abbé » 14.<br />
La figura del Priore, quale contraltare dell'abate, in quanto eletto<br />
dagli stessi monaci che avevano scelto l'abate, non è mai stata gradita<br />
a Benedetto che nella Regola ha parole durissime contro una simile<br />
situazione.<br />
In secondo luogo, non si tratta di scegliere degli esperti per varie<br />
incombenze materiali e organizzative, ritenendo per sé la parte più<br />
specificatamente spirituale, qual'è la direzione spirituale sia generale<br />
rivolta al gruppo, sia speciale, rivolta al singolo individuo. La regolamentazione<br />
della vita del cenobio, le relazioni con le persone esterne,<br />
con l'autorità civile, coi poveri, l'amministrazione dei beni materiali<br />
non sono momenti che esulano dal suo magistero e dalla sua azione<br />
come direttore delle anime. Certo è necessario che usi tutte le arti per<br />
non far mancare nulla ai suoi figli, per non creare turbamenti nella<br />
comunità o tra la comunità e il mondo in cui essa è inserita; ma ha<br />
inoltre il dovere di insegnare come, in tutte queste cose e circostanze,<br />
si debba essere soggetti al Padre che sta nei cieli, come si debba vivere<br />
la fede nella realtà e certezza che siamo tutti figli di Dio, di quell'unico<br />
Padre che provvede a tutti i nostri bisogni e che fa piovere sul giusto<br />
e sul malvagio.<br />
14 S, KLEINER, O. Cisto Dieu premier servi, Ed. Téqui - Paris 1974 p. 247.<br />
- 111-
Tutto nel monastero appartiene alla schola dominici servitii e tutti<br />
i collaboratori dell'abate devono essere innanzitutto uomini spirituali<br />
che sappiano tradurre nell'ufficio a loro affidato, il mandato di insegnare<br />
quanto il maestro, cioè l'abate deve insegnare.<br />
Basti al riguardo notare con quale amore nella Regola Benedetto<br />
tracci la figura del cellerario: «CeIlerarius monasterii eligatur de con-:<br />
gregatione sapiens, maturus moribus, sobrius, timens Deum, qui omni<br />
congregationi sit sicut pater » (RB 31). Queste doti sono richieste in<br />
lui perché non si lasci irretire dalla tentazione di diventare un «menager<br />
», un uomo d'affari, ma anche e soprattutto perché con il suo<br />
comportamento nel disbrigo degli affari deve insegnare ai fratelli in<br />
modo effettivo la fiducia in Dio, il distacco dalle cose passeggere e il<br />
vero senso della povertà.<br />
Tutta la vita e tutta l'attività dell'abate resta quindi quella di<br />
direttore spirituale. Spetta a lui, è sua responsabilità di cui dovrà rendere<br />
conto a Dio, la formazione di coloro che si sono affidati a lui<br />
per essere guidati nelle vie del Signore. Che poi lui si faccia aiutare<br />
da altri nella realizzazione di questo suo compito riguarda solo lui<br />
e la sua prudenza.<br />
« Dans l'école du service du Seigneur l'abbé est responsable de<br />
tout, mais il peut se choisir des auxiliaires, la Règle considère ceci<br />
comme allant de soi (21.1-2; 27.2; 31.1-2; 32.3; 36.10; 47: 1,<br />
53.21; 58.6; 65.15). Chacun recevra la part de responsabilité pour<br />
son propre bien et celui de tous. C'est le principe de subsidiarité:<br />
l'autorité laisse à chacun de servir à la mesure de sa capacité. L'abbé<br />
n'intervient que pour suppléer aux insuflisances. Le moine n'est<br />
donc pas un simple instrument au service de la communauté, et<br />
l'esprit d'initiative est mis en valeur pour le bien commun. Un supérieur<br />
qui sait se faire aider, s'assure par la une plus grande liberté<br />
pour vaquer à ses taches propres. Chargé de supervisier, s'il<br />
s'occupe de tout, il perdrà le controle de l'ensemble et il fallira sa<br />
mission » IS.<br />
Si può notare al riguardo come divergano dall'idea benedettina<br />
alcune forme di monachesimo moderno, che vanno considerate quindi<br />
come momenti di ricerca di nuove strutture di vita monastica, più che<br />
di vita benedettina in particolare. In esse non si tratta più di un gruppo<br />
IS A. VAN DER WIELEN, OSB, L'abbé, oicaire du Cbrist, in Collectanea Cisterciensia<br />
31 (1969) p. 133.<br />
- 112-
di discepoli alla scuola di un maestro, ma piuttosto di una équipe alla<br />
ricerca solidale della volontà divina.<br />
Parlando di Bose E. de Giorgis scrive: «Qui si dà molto<br />
spazio allo studio del monachesimo e della sua ricca tradizione<br />
occidentale e soprattutto orientale, poiché essa permette di evidenziare<br />
quali fondamenti abbia la «koinonia» per dei celibi che<br />
hanno una totalità di vita in comune; per quanto riguarda la condizione<br />
interna della piccola comunità piemontese, si è arrivati alla<br />
conclusione che nessuno può essere chiamato maestro o padre, per<br />
cui le decesioni sono prese in comune nei capitoli settimanali del<br />
sabato e nei due capitoli generali che si tengono in primavera ed<br />
in autunno. La comunità cerca così di valorizzare i carismi di ognuno:<br />
al presidente si riconoscono unicamente i carismi della saldezza<br />
e del discernimento spirituale che sono in relazione al servizio del<br />
progetto comunitario » 16.<br />
E nell'« Esortazione al fratello che entra in comunità » (corrisponde<br />
in senso lato alle nostre Regole e Costituzioni) si legge:<br />
« Questa obbedienza a Dio si manifesta però anche in obbedienza<br />
concreta, visibile alla comunità, cioè ai fratelli. Senza l'obbedienza<br />
alla chiesa il cristiano sarebbe un settario, senza obbedienza<br />
alla comunità, il primo cerchio della chiesa per te, tu non saresti<br />
incorporato pienamente al corpo visibile di Cristo. La comunità è<br />
assistita dallo Spirito Santo promesso ad ogni membro che proclama:<br />
Cristo è il Signore. È la comunità, dunque, che per te esprime<br />
ordinariamente la volontà di Cristo nel chiederti l'obbedienza<br />
e nell'indicarti la via da percorrere » 17.<br />
In questo contesto la figura del superiore, o meglio, secondo la<br />
espressione usata, «di chi presiede all'unità », è sì ancora quella del<br />
direttore spirituale, ma non in qualità di vicario di Crsto, ma in quanto<br />
delegato a questo dalla comunità, in quanto direttamente è alla comunità<br />
dei fratelli che spetta questo compito, e a lei esso dovrà ritornare<br />
quando si presenti un grave caso.<br />
«Nella comunità tutti hanno dei carismi. Egli deve avere<br />
quello della saldezza. È a lui, dunque, che manifesterai le tue pas-<br />
16 E. DE GXORGIS, Riflessioni di un laico su alcune esperienze di monachesimo contemporaneo,<br />
in Vita monastica 115 (1973) p. 240-241.<br />
17 «Esortazioni al fratello che entra in comunità» Estratto da Servitium 5 (1971)<br />
p. 18-19.<br />
- 113-
seggere esitazioni, i tuoi dubbi, le tue crisi, le tue difficoltà. Egli<br />
è là per questo. Se ogni volta che tu provi tali difficoltà ti rivolgessi<br />
alla comunità per risolverle, tu comprendi: creeresti una situazione<br />
di perenne crisi e di incertezza paralizzante nella comunità.<br />
Dato il numero dei fratelli, si può dare per certo che ogni giorno<br />
uno è in difficoltà. Svuotare questa in comunità non aiuterebbe la<br />
vita comune. Dunque tu ti rivolgerai a lui con confidenza, con semplicità<br />
esporrai la tua situazione, ed egli col suo carisma ti aiuterà<br />
a vedere chiaro e ti confermerà nella vocazione ricevuta. Se la tua<br />
difficoltà è grave e non passa, allora sarà nel Consiglio che tu la<br />
esporrai e da questo accetterai l'aiuto e la decisione» 18.<br />
Confessione e direzione<br />
Bisogna però fare una chiara distinzione tra confessione sacramentale<br />
e direzione spirituale, poiché si tratta di due realtà diverse. Non<br />
entriamo nella complicata questione della forma del sacramento della<br />
penitenza al tempo di S. Benedetto. Certo l'abate non era necessariamente<br />
sacerdote 19, come il sacerdozio non era richiesto per gli anziani<br />
che l'abate deputava ad aiutarlo nel suo ufficio di direttore di anime di<br />
cui parla nella Regola (4.50; 46.5; 7.44). Non si trattava infatti di una<br />
confessione dei peccati per ottenere il perdono di Dio, ma per essere<br />
curati ed aiutati nel cammino della perfezione da colui che sa « guarire<br />
le proprie e altrui ferite ». Non si parla quindi per l'abate, di esercitare<br />
una potestà di ordine, ma piuttosto di esercitare il carisma particolare<br />
della direzione. Di conseguenza quanto si dice dell'abate vale per la<br />
badessa.<br />
«Les restncnons qu'il faut faire dans certaines cas ne s'irnposent<br />
pas du fait d'une différence de position, mais de formation.<br />
Mais l'abesse doit, elle aussi, étudier les Saintes Ecritures, s'instruire<br />
et savoir à quelle source équiser » 20. E non si può negare<br />
che « il y peut y avoir dans une communauté des moniales aptes<br />
à donner de hons et sages conseils spirituels » 21.<br />
18 « Esortazioni...» p. 21.<br />
19 A. DE VOGUÉ, O. c. p. 166.<br />
20 S. KLElNER, O. c. p. 252.<br />
21 Id. ibid. p. 252.<br />
- 114-
Museo archeologico?<br />
Così considerata la figura dell'abate può a pnrna vista apparire<br />
come un reperto archeologico o un pezzo da museo. L'evoluzione<br />
che ha subito nella storia l'istituzione abbaziale, ha fatto di lui una<br />
figura troppo spesso assai diversa da quella rappresentata da S. Benedetto,<br />
se non addirittura, in certi periodi, diametralmente opposta.<br />
Non intendo parlare sempre di decadimenti o di abusi, ma è una constatazione<br />
che va fatta.<br />
Anche se ci soffermiamo a considerare il termine dell'evoluzione<br />
giuridica, esaminando le disposizioni del codice di diritto canonico<br />
che toccano anche l'abate, notiamo subito come la concezione di<br />
S. Benedetto sia completamente stravolta.<br />
Il canone 518dice: «Caveant superiores ne quem subditum aut<br />
ipsi per se aut per alium, vi, metu, importunis persuasionibus aliave<br />
ratione inducant ut peccata apud se confiteatur ».<br />
A parte il fatto che qui si parla di confessione sacramentale e<br />
non di direzione, si suppone un clima di oppressione che non è ammissibile<br />
tra colui che ha qualche cosa da dare e chi liberamente viene<br />
a lui per ricevere.<br />
Il canone 530, paragrafo primo è più attinente e dice: «Omnes<br />
religiosi superiores districte vetantur personas sibi subditas quoquo<br />
modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam ».<br />
Questo canone vieta di indurre a fare qualche cosa che per S. Benedetto,<br />
invece, è nell'ordine stesso delle cose. Se un malato si pone<br />
liberamente in cura da un medico, non deve essere indotto a farsi curare,<br />
ma sarà lui evidentemente che si comporterà in modo che il<br />
medico lo possa efficacemente curare. Si tratta quindi evidentemente<br />
di due situazioni esaminate, e di due concezioni del superiore, assai<br />
lontane tra di loro, pur nella superficiale e apparente uniformità.<br />
Il paragrafo secondo dello stesso canone, anche se più positivo, è<br />
ancora ben lontano dallo spirito di S. Benedetto. Esso dice: «Non<br />
tamen prohibentur subditi quominus libere ac ultro aperire animum<br />
suum superioribus valeant; imo expedit ut ipsi filiali cum fiducia superiores<br />
adeant eis, si sint sacerdotes, dubia quoque et ansietates suae<br />
conscientiae exponentes », dove si esprime sotto forma di desiderio<br />
quello che per S. Benedetto è una realtà basilare. C'è tuttavia l'espressione<br />
« si sint sacerdotes », che pone una confusione tra elemento sacramentale<br />
ed elemento puramente umano anche se, come nota il P. De<br />
- 115-
Vogiìé, l'espressione «dubia quoque et anxietates» non corrisponda<br />
esattamente al concetto di «direzione spirituale» 22.<br />
2. ABATE E DIREZIONE SPIRITUALE DA SAN BENEDETTO AI GIORNI<br />
NOSTRI<br />
Il Codice di diritto canonico non è altro che l'espressione di una<br />
evoluzione (comprensiva di progressi e di involuzioni) le cui fasi sarebbe<br />
interessante esaminare per scoprire le cause reali e varie che<br />
hanno prodotto il passaggio dalla figura del «padre del monastero »,<br />
«maestro dei discepoli» che venivano a mettersi alla sua scuola,<br />
esemplare della vita spirituale, unico luogotenente dell'unico Maestro,<br />
alla reale figura dell'abate nell'attuale vita monastica.<br />
]. De Punet, alla voce abbé del Dictionnaire de spiritualité, è<br />
piuttosto ottimista al proposito, negando vi sia stata evoluzione, e<br />
affermando che di mutazione non vi era bisogno. Egli afferma:<br />
« Basée, comme elle l'est, sur la foi à la paternité divine et sur la<br />
reconnaissance du ròle providentiel que possède le père dans<br />
la famille, cette conception n'avait pas à ètre modifìée et elle<br />
demeure, après des long siècles, telle que le saint legislateur se<br />
l'était formée » 23.<br />
Egli porta a conferma del suo assunto alcune testimonianze di<br />
abati che nel corso dei secoli furono veramente la realizzazione della<br />
figura abbaziale benedettina. Ora nessuno nega che nel corso dei secoli<br />
la figura dell'abate quale era concepita da S. Benedetto sia stata<br />
realizzata, anche se degli elogi riportati, forse una parte siano da attribuirsi<br />
al genere letterario e da considerarsi come tale. Ma si potrebbero<br />
portare esempi contrari non meno numerosi, tali da rendere nulla<br />
la testimonianza addotta. Importante è invece considerare il movimento<br />
nel suo insieme e non in alcuni esemplari di perfezione o imperfezione<br />
colti qua e là negli avvenimenti storici.<br />
Già nel secolo XVI in due commenti alla Regola si cerca di<br />
enucleare la causa del decadimento dell'ufficio abbaziale. Sei sono i<br />
motivi addotti dal cardinale de Turrecremata:<br />
22 A. DE VOGUÉ, O. c. p. 173 Cfr. tuttavia P. GUTIERREZ, De manifestazione<br />
conscientiae et directione spirituali in religione, in Commentarium pro religiosis, 1955<br />
pp. 153-154.<br />
23 J. DE PUNET, Abbé in Dictionnaire de Spiritualité T. L col. 55.<br />
- 116-
« Primum si in propria persona terenis negociis intendit et in spiritualibus<br />
vicarium point. Secundum, si non timet fratres suos periculo<br />
exponere ut temporalia bona servare valeat: ut cum fratres<br />
iuvenes et leves ponit in officiis exterioribus. Tertium, si cum<br />
magnis expensis muros erigit et mores negligit. Quartum, si quotidianas<br />
expensas frequenter computat, animarum vero detrimenta<br />
ve! profectus ignorato Quintum, etsi quando conveniunt fratres ad<br />
capitula, de rerum temporalium conservatione vel multiplicatione<br />
est tractatus primus; de Ordinis vero reformatione ultimus ve!<br />
nullus. Sextus, si sollicite provideantur quae necessaria sunt corporibus,<br />
de his vero non curatur, quae sunt necessaria animabus » 24.<br />
Una prova più recente addotta dall'autore a sostegno della sua<br />
tesi, sono i testi legislativi o paralegislativi degli ultimi tempi, che<br />
ci mostrano come la figura dell'abate sia rimasta quella descritta da<br />
S. Benedetto. Dopo quarant'anni noi siamo in grado di citare ancora<br />
altri testi recentissimi, scritti dopo il movimento inziato dal Concilio<br />
Vaticano II, ma questo non ci permette di condividere il suo ottimismo.<br />
Dai testi legislativi, dalle dichiarazioni programmatiche alla realtà vissuta<br />
il passo è molto lungo. Anche i testi legislativi hanno un loro<br />
genere letterario e spesso ricalcano vecchie formule, conoscendo però<br />
bene il significato pratico che esse rivestiranno nella realtà. La crisi<br />
stessa dell'autorità, penetrata profondamente anche nei monasteri fa<br />
che spesso i Capitoli si affannino a stabilire formule che nella realtà<br />
non riescono a trovare una adeguata realizzazione. Oggi, invece si deve<br />
guardare più ai fatti che ai progetti.<br />
Detto questo, si deve però notare che lo stesso diritto attuale e<br />
le forme ad esso ispirate nella legislazione monastica, contraddicono la<br />
tesi del De Punet.<br />
Scrive l'abate primate della Confederazione benedettina:<br />
« On pourrait tout aussi bien dire che l'ultime responsabilité repose<br />
sur I'abbé, La modification de cette idée, sous l'effet du Droit<br />
Canon et des Déclaration de chaque Congrégation, n'est pas sim-<br />
24 Card. DE TURRECREMATA, In Regulam S. Benedicti, Coloniae Agrippinae 1575,<br />
p. 66. Un testo simile è quello dell'abate SMARAGDO nell'opera Expositio in Regulam S.<br />
Benedicti Col. Agripp. 1575 p. 319 dove si legge: «Non enim debet abbas dissimulare,<br />
id est nescire se fingere rem, de qua in districto exanime rationem debet Domino reddere;<br />
neque parvipendere debet salutem monachorum suorum et pro magno existimare<br />
curam rerum terrenarum; neque minus curare debet de salute animarum sibi commissarum<br />
et plus gerere curaro de substantia rerum »,<br />
- 117-
plement accidentelle de sa nature, elle est essentielle. Des cas<br />
sant spécifiquement énumérées, pour lesquels le consentement du<br />
chapitre, exprimé par vote secret, est absolument nécessaire pour<br />
que l'abbé puisse agir. Dans ce cas, le droit de l'Eglise pIace le<br />
pouvoir de décision entre les mains des membres du chapitre ou<br />
du conseil des anciens. La responsabilité de la décision repose<br />
donc sur ceux qui, de par la loi, doivent prendre cette décision.<br />
Ceci apporte une modification évidente de l'ésprit du chapitre III<br />
de la Règle, et cette modification n'a nullement été introduite sous<br />
l'effet des récentes influences democratiques. Peu de commentateur<br />
de la Règle et peu d'auteurs de spiritualité bénédictine ont<br />
abordé les nombreuses ramifications spirituelles nées de ce changement<br />
d'esprit apporté par le droit de l'Eglise au chapitre III<br />
de la Règle » 2S.<br />
Inattualità dell'abate direttore spirituale<br />
È chiaro che l'evoluzione storica non può essere in sè un fattore<br />
negativo. L'uomo muta continuamente e la mentalità dell'uomo<br />
del VI secolo differisce molto da quella di uno del XIV secolo e più<br />
profondamente ancora da quella di un uomo del secolo XX. L'evoluzione<br />
è quella presa di coscienza dei mutamenti indotti dalla storia per<br />
adattare ad essi realtà e valori anteriori, permettendo così a vecchie<br />
istituzioni di continuare a vivere e non solo a vegetare. Dove c'è vita<br />
c'è pure cambiamento; solo la morte e la sclerosi portano all'immobilità.<br />
La domanda che dobbiamo porci è quindi questa: in quale maniera<br />
può continuare a vivere oggi la figura dell'abate quale ce l'ha proposta<br />
San Benedetto? In che modo pratico, reale e realizzabile, l'abate<br />
può rivestire le sue funzioni inderogabili di essere il padre, il maestro,<br />
il direttore di spirito dei suoi monaci?<br />
È questo un interrogativo molto grosso, cui non posso certamente<br />
dare una risposta esauriente, alla cui soluzione cercherò di proporre<br />
alcuni elementi o punti di ricerca affinchè collo sforzo comune si trovino<br />
delle direttive nelle quali l'abate trovi ben definita la sua fisionomia,<br />
acquistando in seno alla famiglia monastica quella centralità<br />
e quell'influsso che gli sono propri.<br />
2S R. WEAKLAND, OSB, L'abbé dans une societé démocratique, in Collectanea Cisterciensia,<br />
31 (1969) p. 102.<br />
- 118-
In che senso l'abate è direttore spirituale<br />
Lasciamo da parte la direzione spirituale strettamente intesa, che<br />
dai singoli monaci può essere richiesta all' abate, ricorrendo a lui e<br />
aprendogli completamente la propria coscienza, per ottenere il suo<br />
giudizio e la sua direttiva. Questa è infatti la forma più perfetta e<br />
totale di esplicitazione della paternità, ma non è possibile nè esigibile<br />
da parte dell'abate da tutti i suoi monaci. Ci dobbiamo invece chiedere<br />
qual'è la forma di direzione che egli essenzialmente può e deve esercitare<br />
sui suoi monaci per poter meritare ancora il nome di «padre»,<br />
« abba » che Benedetto gli attribuisce.<br />
a) TRASMISSIONE DELLA PAROLa DI DIO<br />
L'Abate « vices Christi agere in monasterio creditur ». Deve quindi<br />
essere il primo ad ascoltare e meditare sulla parola di Dio per poterla<br />
dare ai suoi figli, sia come gruppo, sia singolarmente, nei diversi<br />
bisogni che si manifestano. Non si tratta evidentemente dello studio<br />
scientifico, storico, teologico, esegetico della parola di Dio, che può<br />
essere fatto bene e anche meglio da un esperto, ma della lettura esistenziale<br />
della parola di Dio, applicata al momento presente, come luce<br />
del proprio pensiero e della propria azione.<br />
Perchè i fratelli, come vuole San Benedetto, credano che egli<br />
fa le veci di Cristo, devono poter scorgere nel suo modo di agire, nel<br />
suo prendere delle decisioni, nel suo guidare singoli e comunità, una<br />
relazione viva alla Parola di Dio, meditata e sofferta.<br />
Non è la personalità forte dell'abate che dimostra la sua legazione<br />
di Cristo, ma la sua disponibilità e apertura alla parola di Dio.<br />
Dietrich Bonnhoeffer ha una pagina meravigliosa al riguardo:<br />
«Nessuno può in alcun modo redimere il fratello, nè dare a Dio il<br />
prezzo del riscatto di esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo<br />
caro e non sarà mai sufficiente (Salmo 49, 8). Questa rinuncia ad ogni<br />
possibilità propria è appunto la premessa e la conferma dell'aiuto liberatore<br />
che solo la parola dì Dio può dare al fratello. Non è in mano<br />
nostra la vita del fratello, non possiamo tenere unito ciò che vuole<br />
spezzarsi, non possiamo tenere in vita, ciò che vuole morire. Ma Dio<br />
congiunge ciò che sta per spezzarsi, crea la comunione dove regna la<br />
separazione, dona grazia mediante il giudizio. Egli ha messo la sua<br />
- 119-
parola sulla nostra bocca. Vuole che venga annunziata da noi. Se impediamo<br />
la sua parola, il sangue del fratello peccatore ricadrà su di<br />
noi. Se annunzieremo la sua parola, Dio salverà per mezzo nostro il<br />
fratello. Chi converte un peccatore dall'errore della sua vita, salverà<br />
l'anima di lui dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati (Giac.<br />
5, 20).<br />
Chiunque di voi vorrà essere primo, sarà servo di tutti (Marco<br />
lO, 43). Gesù ha legato ogni autorità nella comunità al servizio? Vera<br />
autorità c'è solo dove si compie il servizio dell'ascoltare, aiutare, portare<br />
e annunziare la parola.<br />
Ogni culto per una persona che si estende a particolari qualità,<br />
ad eccezionali capacità, forze, talenti di un altro - anche se si tratta<br />
di qualità spirituali - è un sentimento terreno che non trova posto<br />
nella comunità cristiana, anzi 1'avvelena.<br />
Se oggi si sente tanto spesso la necessità di «figure episcopali»,<br />
di «personalità sacerdotali », di persone che abbiano vera autorità, lo<br />
si deve soprattutto al fatto che si prova il bisogno di ammirare un<br />
uomo, di imporre una autorità umana e visibile, perchè la vera autorità<br />
derivante dal servizio ci sembra troppo umile. E questo è segno<br />
«di malattia spirituale» 26.<br />
b) COMUNIONE DI VITA<br />
Tutto questo richiede dall'abate una comunione di vita che permetta<br />
un contatto continuo e senza troppi diaframmi col discepolo.<br />
L'abate-prelato con un tenore di vita tutto particolare (ma sempre<br />
meno oggi) incute un senso di rispetto, ma non apertura di coscienza;<br />
l'abate-menager, sempre addaffarato sarà un buon organizzatore della<br />
vita economica, ma non un padre dal quale si attende che dal tesoro<br />
della parola e dell'esperienza personale «proferat nova et vetera »;<br />
dall'abate impegnato nelle public-relations e nei contatti cogli enti<br />
governativi e autorità locali non ci si aspetta il tempo da dedicare<br />
alla riflessione e al colloquio '11. Semplicità di vita, spiritualità e di-<br />
26 D. BONHOEFFER, La vita comune, Ed. Queriniana - Brescia - 1973 pp. 135-136.<br />
'11 «Fu in modo del tutto semplice che nell'antica tradizione dell'Oriente cristiano<br />
i maestri di vita spirituale dovettero ricevere il nome di Padre o Abate. Essi non erano<br />
solo dei maestri di dottrina, ma forgiatori di vita spirituale, capaci di modellare i propri<br />
- 120-
sponibilità sono elementi che servono a costruire un ambiente atto<br />
all'esperienza religiosa che deve sorgere tra abate e monaco.<br />
Che dire quindi a riguardo della prelatura abbaziale? Per Benedetto<br />
il pater monasterii è l'abbas, mentre il prior non è che un aiutante<br />
dell'abate, e come tale non è pater monasterii. Nel decorso dei secoli<br />
il priore divenne non più il luogotenente dell'abate e sotto la sua responsabilità,<br />
ma figura autonoma di padre del monastero. Questo è<br />
attualmente istituzionalizzato nel diritto monastico: le due figure di<br />
« abate» e «priore» (conventuale) non si distinguono per qualche<br />
elemento sostanziale che riguardi la relazione ai fratelli, ma per l'elemento<br />
accidentale dell'uso dei pontifìcali. In questo modo sensim sine<br />
sensu si è venuto a porre l'accento della figura abbaziale su un elemento<br />
esterno e spurio a discapito dell'elemento fondamentale. Ora il<br />
diritto ha certamente una funzione normativa, ma ne ha anche una<br />
pedagogica, per cui sarà difficile recuperare la vera figura dell'abate<br />
se il diritto non eserciterà questa sua funzione pedagogica unificando<br />
la figura del « pater monasterii » nella figura unica dell'abbas, togliendo<br />
la caratterizzazione apparentemente primaria della dignità prelatizia<br />
e quasi episcopale 28.<br />
figli spirituali innanzitutto sul modello di Cristo (e non su quello proprio). Non si<br />
tratta sempre di sacerdoti, ma di «uomini di Dio» che senza cercarlo direttamente,<br />
sapevano suscitare la confidenza, consolare, sopportare, rimproverare tanto più efficacemente<br />
quanto più agivano liberi da passioni umane e spinti da un puro amore di Dio.<br />
Era certamente molto difficile istituzionalizzare un tale legame. L'abate dei monasteri,<br />
perdendo di vista ciò che lo faceva Padre dei suoi monaci, si trasformò spesso in amministratore,<br />
padrone di casa, signore e anche principe. Non è facile mantenersi nelle<br />
altezze della vita spirituale. E' giocoforza riconoscere d'altronde che col tempo e col<br />
progredire della cultura monastica il padre dei monaci non poteva esere colui che ad<br />
un tempo comunicava l'esempio e la dottrina e provvedeva agli alimenti. Quando il<br />
figlio ha cominciato a frequentare la scuola media superiore e a stringere legami con<br />
adulti fuori delle cerchia familiare, formandosi un proprio modo di giudicare il mondo<br />
e gli uomini, viene necessariamente il tempo in cui il padre non è più tutto e neppure<br />
l'unico modello da imitare. Allo stesso modo divenne sempre più necessario che il<br />
monaco non fosse più così tributario del modello fornito dall'abate. Ciò del resto non<br />
aboliva quel vincolo, di natura più spiritgale e umana che non era dovuto innanzitutto<br />
alla cultura profana del superiore ». G. CRUCHON,SI, Cl sacerdote consigliere spirituale<br />
e psicologo Marietti - Torino 1972 p. 26-27.<br />
28 La stessa benedezione abbaziale ha preso un carattere ambiguo anche se, da un<br />
punto di vista liturgico le cose sono state chiarite col nuovo rito di benedizione abbaziale.<br />
Non si tratta più, infatti, di una quasi-consacrazione episcopale, ma di un rito nel<br />
quale il neo eletto riceve una particolare benedizione colla quale, opere operantis ecclesiae,<br />
ottiene una grazia particolare per esercitare il suo ufficio di pater monasterii.<br />
Benedizione che ha un senso vero fino a quando il soggetto è pater monasterii e non<br />
ha più senso quando egli diventa soggetto di un altro «pater ». E se veramente si<br />
crede nell'efficacia della benedizione non si comprende perché il pater monasterii che si<br />
chiama «priore conventuale» ne debba essere privato.<br />
- 121-
c) CONTATTO PERSONALE<br />
L'abate deve avere un contatto pastorale con i singoli componenti<br />
della comunità. Dovendo aiutare il singolo a realizzare la propria vocazione<br />
entro l'ambito della vocazione comunitaria, ed avendo questa<br />
modalità diverse da individuo ad individuo, non la potrà realizzare se<br />
non mediante un contatto reale a livello psicologico. Il fatto di essere<br />
in carica e rivestito di autorità non è sufficiente a rendere l'individuo capace<br />
di questo influsso di cui parliamo. La persona ha veramente autorità,<br />
nel senso ampio e spirituale del termine, solo quando ispira a<br />
chi entra in relazione con essa credibilità e confidenza. Ma allora si<br />
dovrà ancora parlare di paternità? L'autorità si sente soddisfatta quando<br />
è riuscita a stabilire sui binari tracciati la vita dei singoli componenti<br />
la comunità. La paternità va oltre:<br />
«Nè la mia reputazione, nè la mia accortezza mi garantiscono<br />
contro l'esperienza di fallimento dell'altro, che se ne andrà deluso<br />
per non aver trovato in me discernimento e speranza per la<br />
sua vita. È soprattuto la delusione dell' altro che è decisiva quando<br />
si tratta di autorità. Posso anche avere la coscienza tranquilla;<br />
ho fatto tutto ciò che poteva dipendere da me, mi sono dato senza<br />
calcolo. Il mio onore di persona onesta è salvo, ma la mia autorità<br />
no, perché l'altro se ne è andato deluso» 29.<br />
Non sarà certamente facile, nè possibile che il pater monasterii<br />
riesca a creare questa simpatia con tutti quelli che sono alla sua scuola.<br />
Ma allora il contatto personale e pastorale servirà ad orientare discretamente<br />
verso gli altri, verso coloro che con lui collaborano nella stessa<br />
linea, col medesimo suo disegno, nel formare una unità di indirizzo<br />
in seno alla medesima « schola dominici servitii ».<br />
E a questo riguardo una domanda si impone.<br />
Quando inizia e quando ha termine la paternitas dell' abate?<br />
Se egli fosse un presidente della repubblica monasteriale, se fosse<br />
un presidente del consiglio conventuale dei monaci, la temporaneità<br />
della sua carica sarebbe evidente. Ma egli è il « padre », anche se di<br />
una paternità spirituale. È concepibile una paternità a scadenza triennale,<br />
sessennale? Anche in questo punto il diritto monastico dovrebbe<br />
essere pedagogico. Per giungere ad una soluzione bisognerà enucleare<br />
29 R. MEHL, De l'autorité' des ualeurs, in J. M. T TILLARD, Superiori religiosi in un<br />
tempo di povertà, Dehoniane - Bologna 1974 p. 22.<br />
- 122-
l'elemento fondamentale dell'autorità abbaziale, perdurante il quale, e<br />
solo allora, perdura anche l'ufficio abbaziale.<br />
Attualmente l'elezione e la sua accettazione determina l'inizio<br />
della paternità dell'abate, ed essa perdura, unire quaesito, per un dato<br />
tempo stabilito dal testo costituzionale. Si tratta di elementi giuridici<br />
che però, se da un Iato garantiscono la certezza, elemento fondamentale<br />
del diritto, non sono in grado di garantirne l'autenticità.<br />
Fino a quando perdura il carisma della paternità spirituale, perdura<br />
l'autorità abbaziale, se questo viene meno ipso facto cade anche lo<br />
ufficio.<br />
Può considerarsi ancora pater monasterii, soltanto per lo ius<br />
quaesitum un abate che vede contestare la sua condotta, ripresi i suoi<br />
metodi, privato della fiducia della maggior parte della comunità?<br />
Certo quando si tratta di istituzionalizzare tutto questo, si trovano<br />
non lievi difficoltà, ed è forse per questo che molte comunità moderne<br />
non vogliono venire istituzionalizzate, per poter con maggior vivacità<br />
e con formule sempre nuove, tradurre nella vita queste realtà.<br />
Una domanda però, a questo riguardo si pone. È possibile che un<br />
padre diventi figlio, forse anche di uno dei suoi figli? Non è questo<br />
contro ogni legge di natura? Può un abate diventare discepolo di un suo<br />
discepolo?<br />
La provvisorietà del carisma della paternità spirituale non meravigliava<br />
affatto i primi monaci che ammettevano con semplicità il passaggio<br />
dallo stato di padre a quello di figlio, quando la realtà esistenziale<br />
lo richiedeva.<br />
« Un eremita prudente e saggio desiderava abitare nel deserto di<br />
Celle, ma non vi era alcuna cella a disposizione. Ora c'era nel luogo<br />
un anziano che, oltre alla sua, aveva una cella isolata. 10 chiamò e<br />
gli disse: «Abita qui fino a quando non avrai trovato una cella »,<br />
poi se ne andò. Come accade quando viene uno straniero, molti<br />
vennero da lui per trarne profitto spirituale, ed egli accoglieva<br />
tutti. L'anziano che aveva concesso la cella fu preso da una forte<br />
gelosia e cominciò a mormorare: «lo - diceva - vivo qui da<br />
lunghi anni una vita ascetica durissima e nessuno viene a me.<br />
Questi è qui solo da qualche giorno e tutti vanno da lui! » Disse<br />
allora al suo discepolo: «Va a dirgli di andarsene perché la cella<br />
mi serve ». Il discepolo ubbidl, ma con intelligenza disse all'eremita:<br />
«Il mio abate mi manda per avere tue notizie ». L'eremita<br />
gli rispose: «Digli che preghi per me perché soffro di stomaco ».<br />
Ritornato dal suo abate il giovane gli disse: «L'eremita mi ha<br />
- 123-
assicurato di avere in vista una cella e che quindi presto se ne<br />
andrà ». Due giorni dopo, l'anziano inviò di nuovo il discepolo<br />
all'eremita con l'incarico di dirgli: «Se non te ne vai vengo io<br />
con ilbastone e ti caccio fuori! ». Ilgiovane giunto dall'eremita gli<br />
riferì: «Il mio abate ha appreso della tua malattia, ne è molto<br />
afflitto e mi ha mandato per avere tue notizie ». Gli disse l'eremita:<br />
«Digli che, grazie alle sue preghiere sto meglio ». Ritornò<br />
quindi e disse all'abate: «Mi ha detto di chiederti di attendere<br />
fino a domenica e se ne andrà », Giunta la domenica e vedendo che<br />
l'eremita non se ne andava, l'anziano prese il bastone e si avviò per<br />
cacciarlo in malo modo. Il discepolo gli disse: «Ti precedo per<br />
vedere che non si trovino colà degli altri fratelli che abbiano a<br />
scandalizzarsi ». Corse dunque e disse all'eremita: «Il mio abate<br />
viene a consolarti e a portarti nella sua cella ». Vedendo la grande<br />
carità dell'anziano, l'eremita si avviò incontro a lui e chinandosi<br />
quando era lontano gli disse: «Non ti affaticare, padre che io vengo<br />
verso di te ». Dio che vide la condotta del giovane monaco, toccò<br />
il cuore dell'abate che, buttato il bastone, corse ad abbracciare<br />
l'eremita. Lo salutò con molta effusione e lo condusse nella sua<br />
cella come se niente fosse stato.<br />
L'anziano disse al discepolo: «Non gli hai riferito nulla di quanto<br />
ti avevo detto? » «No », rispose l'altro. L'anziano ne fu felice.<br />
Comprese di essersi lasciato vincere dalla gelosia e da quel momento<br />
lasciò in pace l'eremita. Poi si buttò ai piedi del suo discepolo e<br />
disse: «Tu sei mio padre e io tuo discepolo, perché le nostre anime<br />
sono state salvate dal tuo modo di comportarti » 30.<br />
d) FORMA GREGIS<br />
L'abate deve riacquistare in seno alla comunità il posto che gli ha<br />
dato S. Benedetto, quello del « magister », mostrando se stesso come<br />
incarnazione dell'ideale, non certamente nel suo stadio ultimo di realizzazione,<br />
ma nello stadio intermedio di tensione ad esso.<br />
L'abate è « doctor » non in quanto conosce la legge divina, o in<br />
quanto sa spiegarla alla sua comunità, ma in quanto sa informarne la<br />
sua vita, le sue decisioni, i suoi orientamenti pratici. È questa una<br />
30 Traduzione da «Les sentences des pères du désert » Nouveaux recueil - Abbaye<br />
St. Pierre de Solesme - 1970 p. 68-69.<br />
- 124-
direzione spirituale che, al di là delle difficoltà dei contatti personali,<br />
giunge a toccare 1'animo dei confratelli aiutandoli a sistemarsi nella<br />
volontà di Dio, imbevendosi del suo spirito.<br />
Le parole rivolte alla comunità ed anche i colloqui personali coi<br />
monaci non potranno dare all'abate sicurezza di essere riuscito a penetrare<br />
nella profondità della loro coscienza per darle una direzione, se<br />
non fosse accompagnata da una condotta talmente aderente alla Parola<br />
di Dio, da assicurare i discepoli che quello che diceva non era soltanto<br />
« flatus vocis », ma manifestazione consapevole della volontà di Dio.<br />
Un abate che mostri grande cura e interesse per i beni materiali ai<br />
quali subordini certe esigenze di ordine spirituale; che sia pronto e<br />
disponibile ad incontri con ricchi, con le personalità, e disdegni o dedichi<br />
pochi momenti ai poveri; che dimostri di amare i piaceri e sia alieno<br />
da ogni spirito di sacrificio; che desideri che venga esteriormente riconosciuta<br />
la sua dignità, e non sopporti l'umiliazione o l'essere messo<br />
alla stregua dei meno abbienti (mezzi di comunicazione, di locomozione,<br />
abitazione, precedenza ...), come potrebbe presentarsi «magister » nella<br />
scuola del servizio divino, come colui che vices Christi agit dirigendo<br />
verso il Signore quelli che erano affidati a lui?<br />
L'abate acquisterà il suo vero posto soltanto ritornando ad essere<br />
vicegerente di Cristo, colui che lascia trasparire attraverso la sua persona,<br />
non la sua volontà, i suoi istinti, non se stesso, ma la figura di Cristo.<br />
Questo non riuscirà forse a farlo diventare il confidente di tutti i suoi<br />
monaci, potrà però farlo essere il vero direttore spirituale della sua<br />
comunità.<br />
« Sa fonction est en effet un veritable service de l'Esprit. Il n'a<br />
pas à imposer aux autres ses propres préferences, à leur démander<br />
d'ètre parfait de la façon dont il rève pour eux. Ce serait encore<br />
gouverner à la manière des paiens (cfr. Luc. 22, 25, 27) et introduire<br />
l'esprit de domination, si contraire à l'evangile, dans le domain<br />
spirituel. Le père doit etre à l'écoute de l'Esprit dans ses<br />
fils, les aider à en discerner les inspirations authentiques et à les<br />
suivre. Il doit aussi savoir s'adapteer avec respect à leurs faiblesses,<br />
atteindre le mouvement de Dieu, ne demander a chacun que<br />
ce qu'il peut donner, sans pactiser avec les fautes et sans cesser<br />
de promouvoir avec tact le progrès de tous. A cet égard, son<br />
éxemple et sa prière pour ses fils auront ancore plus d'importance<br />
que ses instructions et ses exhortations » 31.<br />
31 P. DESEILLE, Guide spirituel in Collectanea Cisterciensia 31 (1969) p. 275.<br />
- 125-
In questo ambito si nota ancora una volta come sia stridente la<br />
affermazione dello jus acquisitum ad essere il padre del monastero, ius,<br />
che tradisce un concetto di dominazione, mentre si tratta di un servizio,<br />
il più grande e il più gravoso, ma sempre un servizio per il quale non<br />
è sufficiente una investitura canonica e nemmeno la recezione di un sacramentale,<br />
ma si richiede un particolare carisma dello Spirito.<br />
CONCLUSIONE<br />
La Regola di San Benedetto ci presenta l'abate nella sua triplice<br />
funzione: incaricato della Parola: colui che deve ridire' la parola alla<br />
comunità; è pastore che ha cura di tutti, specialmente di quelli che<br />
sono più bisognosi; è il preposto alla casa di Dio, perché dia a tutti<br />
il necessario.<br />
Credo che, al di sopra di queste tre funzioni, ed elemento catalizzatore<br />
di tutte, vi sia l'ufficio di direttore spirituale. Nella casa di<br />
Dio tutto ha rilevanza spirituale e, sia quando spiega la parola di Dio,<br />
che quando si prende cura dei bisognosi o cura gli affari di casa, l'abate<br />
è sempre e prima di tutto direttore di spirito dei suoi figli.<br />
In ogni momento egli è la lucerna ardens et lucens, alla quale tutti<br />
devono guardare per informare la 'propria vita e la propria condotta<br />
e dirigersi là dove Cristo li ha destinati.<br />
- 126-
BERNARDO DI CHIARAVALLE<br />
(1090 - 20 agosto 1153)<br />
di JEAN LECLERCQ<br />
1. BIOGRAFIA<br />
Le fonti che ci fanno conoscere la sua vita sono i suoi scritti, la Vita<br />
prima s. Bernardi redatta dal 1145 al 1166 (ed. P. L., 185, 225-368) e<br />
numerose testimonianze contemporanee. Nacque a Fontaine, presso Digione<br />
(Francia), da Tescellino il Sauro e da Aleth di Montbard, in una<br />
famiglia di piccola nobiltà. Affidato verso il 1098 ai canonici di St. Vorles<br />
di Chatillon, che si incaricarono della sua educazione. Nel 1111 decise di<br />
ritirarsi a Citeaux, seguito dai fratelli e dallo zio, che vi entrarono all'inizio<br />
del 1112. Nel giugno 1115 Stefano Harding lo inviò a fondare Clairvaux,<br />
che a sua volta fondò la sua prima figlia, Trois-Fontaines, nel 1118,<br />
e la seconda, Fontenay, nel 1119: così, fino alla morte, san Bernardo<br />
fonderà, popolerà o affilierà all'Ordine 164 monasteri. Partecipò attivamente<br />
al concilio dei Templari e a quello d'Etampes nel 1130 nel<br />
quale avvicinò l'assemblea a Innocenzo II anziché all'antipapa Anacleto<br />
II. Accompagnò il papa in Francia nel 1130-1131; si recò a difenderne<br />
la causa presso i nobili del mezzogiorno della Francia nel 1132; su richiesta<br />
del pontefice si recò a Pisa nel 1133, intervenne in suo favore<br />
a Genova e in altre città d'Italia, e lo accompagnò a Roma. Nel 1135,<br />
partecipò alla Dieta di Bamberga, al Concilio di Pisa e si portò nell'Italia<br />
del Nord per 'difendere la causa di Innocenzo II. Nel 1137, venne richiamato<br />
a Roma dal papa e dai cardinali, rientrò quindi a Clairvaux, e nel<br />
1138 contribuì a por fine allo scisma. Nel 1140, arringò gli studenti di<br />
Parigi ed ebbe parte decisiva nel Concilio di Sens che denunciò gli errori<br />
di Abelardo. Nel 1145 si recò nel mezzogiorno della Francia per combattere<br />
gli errori di Pietro di Bruys e del suo discepolo Enrico. Dal 1146<br />
al 1147, viaggiò in Francia e in Germania per prepararvi la seconda crociata.<br />
Nell'aprile 1148, a seguito del Concilio di Reims, richiese la condanna<br />
degli errori attribuiti a Gilberto Porretano. Nella primavera del<br />
1153, Bernardo, ammalato, si recò in Lorena per dirimere un conflitto.<br />
Morì a Clairvaux il 20 agosto 1153.<br />
* Note biografiche tratte dal volume Studi su S, Bernardo nell'ottavo centenario della<br />
Canonizzazione, Bibliotheca Cisterciensis, voI. 6, pp. 9-12, Roma 1975.<br />
- 127-
II. OPERE<br />
Circa 500 lettere, scritte tra il 1116 e il 1153, delle quali un<br />
« corpus» ufficialevenne edito a Clairvaux nel 1145. Numerosi sermoni<br />
sulle feste, raccolti per la maggior parte dallo stesso Bernardo in una<br />
collezione che costituisce un commentario dell'anno liturgico: ai quali<br />
si aggiungano 125 Sermoni su soggetti diversi, tre serie di Sentenze e 8<br />
Parabole. Una serie di 86 Sermoni sul Cantico dei cantici, cominciata nel<br />
1135, edita in diverse collezioni successive, e lasciata incompleta. Trattati:<br />
Sui gradi dell'umiltà e della superbia (prima del 1124-1125); Apologia<br />
dedicata a Guglielmo di Saint-Thierry e diretta contro gli abusi<br />
attribuiti a Cluny (verso il 1124-1125); Sull'amore di Dio (tra il 1126 e<br />
il 1141); Sulla grazia e il libero arbitrio (tra il 1126 e il 1135); Sul precetto<br />
e la dispensa (prima del 1143-1144); Vita di san Malachia, arcivescovo<br />
di Armagh in Irlanda (tra il 148 e il 1152); cinque libri Sulla<br />
considerazione, dedicati a papa Eugenio III (tra il 1148 e il 1153).<br />
Opuscoli diversi, tra i quali il Prologo del!'antifonario in uso presso le<br />
chiese cistercensi (tra il 1135 e il 1147). Una edizione critica delle opere<br />
complete di san Bernardo è in corso di pubblicazione: 7 volumi sono<br />
stati pubblicati dal 1957 al 1973; il volume VIII e gli Indici sono in<br />
via di completamento.<br />
III. CARATTERE E FUNZIONE STORICA<br />
San Bernardo ebbe una natura estremamente ricca di doni diversi:<br />
delicato di salute, ma pieno di energia, possedette un carattere molto coraggioso,<br />
facilmente portato a dominare; fornì prove di competenza in<br />
campi assai diversi come l'architettura, la miniatura, la musica, la poesia.<br />
la letteratura, la teologia. La grazia gli fece utilizzare questi talenti in<br />
favore del rinnovamento del monachesimo e della riforma della Chiesa.<br />
Ma gli capitò d'essere trasportato dal suo temperamento ad abusare del<br />
suo potere di persuasione e del suo ascendente; talvolta ne fu cosciente<br />
e ne mostrò dispiacere, parlò di se stesso con « houmour », perfino con<br />
ironia, ossia con umiltà, ed è per questo che un personaggio cosi umano<br />
è nel medesimo tempo un uomo di Dio, un santo. La migliore iniziazione<br />
alla dottrina di san Bernardo rimane S. Bernard théologien, Roma (Analecta<br />
S. Ord. CistoIX, 3-4) 1953.<br />
Il suo influsso si esercitò ugualmente in campi molto diversi: sulla<br />
dottrina della vita monastica in generale e, in particolare, sulla funzione<br />
- 128-
della Regola e dell'autorità abbaziale; sull'interpretazione teologica del<br />
fenomeno cistercense; sulla riforma degli ordini monastici e canonicali;<br />
sulla giustificazione dell'ordine dei templari; sulla propaganda efficace<br />
in favore dell'ordine cistercense e soprattutto di Clairvaux e delle sue<br />
fondazioni. Si interessò pure della riforma della liturgia cistercense. Più<br />
volte si rivolse a principi e a prelati per risolvere confitti, o imporre monaci<br />
cistercensi o claravallensi a sedi episcopali. Propose una dottrina<br />
della violenza limitata e la sua applicazione alle varie guerre dell'epoca.<br />
Promosse la riforma del clero, dei prelati e della curia romana. Per 25<br />
anni, san Bernardo fu senza alcun dubbio il personaggio più importante<br />
della Chiesa del suo tempo.<br />
IV. INSEGNAMENTO<br />
Bernardo ha esposto una vasta teologia, relativa alla maggior parte<br />
dei soggetti dibattuti nel suo tempo. Ma il suo modo di trattare i problemi<br />
è sempre « monastico » nel senso che deriva dalla riflessione che un<br />
monaco fa sulla propria esperienza spirituale e quella dell'ambiente che<br />
meglio conosce per trarne lezioni che abbiano valore universale. Muove<br />
dalla constatazione che l'uomo si sente profondamente peccatore, ma mediante<br />
la fede, sa di essere perdonato, redento da Cristo, ilcui Spirito può<br />
restaurare in lui l'immagine di Dio, che il peccato ha oscurato, ma non<br />
distrutto. L'ascesi consiste nell'accordare liberamente la propria volontà<br />
a questa opera di restaurazione: in questo si realizza l'imitazione di<br />
Cristo. La partecipazione ai sacramenti conferisce a tale sforzo l'efficacia<br />
per la salvezza. Con la meditazione delle Scritture, essa costituisce la<br />
condizione per un atteggiamento amoroso alla presenza a Dio che si<br />
esprime nella preghiera e può condurre all'esperienza dell'estasi o uscita<br />
da sé, e che talvolta produce il bisogno di comunicarsi con altri con<br />
qualche forma di attività apostolica. Bernardo parla relativamente poco<br />
della Vergine Maria e dell'umanità di Cristo, ma i pochi passi che vi<br />
dedica sono così belli, che a lungo, è stato ritenuto « Dottore mariano »,<br />
e « Dottore della devozione all'umanità di Cristo »: questi titoli si fondano<br />
su scritti non autentici, a lui posteriori, di più facile lettura dei<br />
suoi, e che passarono sotto il suo nome.<br />
Bernardo è «Dottore mellifluo » nel senso tradizionale di questo<br />
termine, che secondo l'immagine ispirata da Origene, designava colui che<br />
ha il dono di « far colare », dalla lettura della Sacra Scrittura, il senso<br />
spirituale. Tutta la dottrina di san Bernardo è fondata sulla Sacra Serit-<br />
- 129-
tura, specialmente su san Giovanni e Paolo, poi sui padri greci e latini,<br />
in particolare Origene, sant'Agostino e san Gregorio. Il suo insegnamento<br />
generalmente non è sistematico, ma è denso, profondo, originale,<br />
da meritargli veramente il titolo di teologo.<br />
Anche il suo stile è interamente nutrito della Bibbia e trabocca della<br />
sua poesia. Nello stesso tempo è estremamente personale, ricco di ogni<br />
sorta di artifici letterari, talvolta raffinatissimo. A questo si deve in gran<br />
parte la diffusione e il successo degli scritti di san Bernardo.<br />
V. INFLUSSO E SOPRAVVIVENZA<br />
La fama di san Bernardo fu così grande, fin dal suo tempo, che ancor<br />
prima della morte si previde la sua futura canonizzazione e si fece<br />
scrivere la sua vita, il cui primo libro fu redatto da Guglielmo di Saint-<br />
Thierry che lo precedette nella morte. La sua canonizzazione fu preparata<br />
fin dal 115.5 e ottenuta da Alessandro III nel 1174. Le opere di<br />
Bernardo non cessarono d'essere copiate - ne rimangono ancora più di<br />
1500 manoscritti -, poi stampate, tradotte, studiate. A. Wilmart ha<br />
potuto scrivere che « l'abate di Clairvaux ha esercitato, mediante i suoi<br />
scritti, un influsso icomparabile. Lo stesso sant'Agostino, che ha lasciato<br />
molte più opere, è ben lungi dall'aver avuto un'uguale fortuna », e H.<br />
Bremond ha potuto parlare di san Bernardo come « di un uomo straordinario<br />
del quale noi viviamo ancora almeno tanto quanto di sant' Agostino<br />
». Amici e avversari della Chiesa non hanno cessato di citarlo e di<br />
invocare la sua autorità, a più o meno giusto titolo, in favore delle loro<br />
idee. La storia del suo influsso postumo, più volte narrata, è estremamente<br />
ricca, e i numerosi studi che gli sono dedicati anche oggi dimostrano<br />
l'attualità del suo messaggio.<br />
VI. BIBLIOGRAFIA<br />
L. JANAUSCHEK,Bibliograpbia bernardina, Vienna 1891 ristampata<br />
a Hildesheim nel 1959) segnalava 2761 titoli fino al 1890. JEAN DE LA<br />
CROIXBOUTON,Bibliographie bernardine (1891-1957), Parigi 1958, ne<br />
aggiungeva 1072. E. MANNING,Bibliographie bernardine, (1957-1970) in<br />
« Documentation Cistercienne » vol. 6, Abbay Saint-Rémy, ne aggiunge<br />
225. J. LECLERQ,Saint Bernard in our times, Oxford 1973 (e I ntroduction<br />
a un volume di prossima pubblicazione in «Cistercian Publica-<br />
- 130-
tions »), ha indicato aggiunte fino al 1972. Un tentativo di sintesi e<br />
bibliografia sommaria in J. LECLERCQ,S. Bernard et l'esprit cistercien<br />
(di prossima pubblicazione in inglese nelle « Cistercian Publications », e<br />
in italiano). La più recente raccolta di studi dedicati a san Bernardo (ve<br />
ne sono dieci) è Bernard 01 Clairuaux. Studies presented to [ean Leclercq,<br />
Washington D. C. 1973, Cistercian Studies, 23.<br />
- 131-
PSICOLOGIA E VITA SPIRITUALE IN SAN BERNARDO *<br />
di JEAN LECLERCQ<br />
Il metodo psicologico può essere applicato a Bernardo di Chiaravalle<br />
per scoprire in lui meccanismi più o meno coscienti e motivazioni non<br />
sempre espresse; ma questo è stato fatto altrove 1. Qui si dovranno piuttosto<br />
valutare questi dati in rapporto ai valori cristiani che affermava<br />
di servire: è possibile conoscere in qual misura psichismo ed intenzione<br />
si siano in lui integrati? Nella sua personalità si incontrano infatti queste<br />
due componenti, e noi dobbiamo avere il coraggio di considerarle entrambi.<br />
Vi è in lui un santo, ma anche, e in primo luogo, un uomo che va<br />
valutato nel modo più obiettivo possibile. Cominciando una serie di<br />
lavori pratici relativi allo studio psico-storico di diversi suoi testi, un<br />
membro del gruppo di ricerca ammetteva che vi era stato, fin dall'inizio,<br />
un pregiudizio favorevole, essendo fuori discussione che si trattava di un<br />
santo. Si dovette pertanto far osservare che la storia è, in qualche modo,<br />
una scienza profanatrice rispetto a tali idee preconcette.<br />
In occasione dell'VIII centenario della morte di' S. Bernardo, nel<br />
195.3, venne pubblicata un 'opera voluminosa e pregevole nella quale<br />
erano illustrati molti aspetti della sua vita e della sua attività. Una appendice<br />
aveva per titolo: «L'éme de Bernard. L'bomme et le saint» 2. Ma<br />
in quelle pagine, come dice il titolo, si trattava solo dell'anima e mai del<br />
temperamento; i singoli paragrafi erano preceduti dal nome di una virtù<br />
illustrata poi nel testo; non vi era però cenno né a deficenze, né a difetti,<br />
né a peccati. Bernardo appariva come un santo; ma ci si domandava se<br />
non fosse stato dimenticato, in lui, l'uomo; e nella misura in cui ciò era<br />
vero, ci veniva presentato un Bernardo mai esistito.<br />
Oggi, il progresso dell'ecclesiologia e della storiografia cristiana ci<br />
porta a studiare come la santità, che viene da Dio, e il peccato, che è<br />
dell'uomo, si concilino in ogni cristiano e nella Chiesa 3. Tuttavia, specialmente<br />
verso coloro che hanno avuto successo in un campo o nellaltro,<br />
o in più settori, è difficile riuscire ad essere imparziali: la maggior<br />
* Il presente articolo è stato pubblicato nel volume Studi su S. Bernardo di Chiaravalle<br />
nell'ottavo centenario della canonizzazione, Bibliotheca Cisterciensis, vol. 6, pp. 215-<br />
243, Roma 1975. Ringraziamo le Edizioni <strong>Cistercensi</strong> per la concessione.<br />
1 Littérature et psychologie, in corso di pubblicazione.<br />
2 Bernard de Clairuaux, Paris 1953, p. 659-667.<br />
3 ROBERT KRESS, Ecclesiology and Mental Healtb, in The American Ecclesiastical<br />
Rewiew, 167 (1973), p. 91-101.<br />
- 132-
parte dei contemporanei di Bernardo che ci hanno parlato di lui, lo<br />
hanno fatto con ammirazione, largamente condivisa nei secoli successivi.<br />
Oggi molti storici tendono ad essere severi nei suoi confronti. È possibile<br />
giungere ad un giudizio equanime? I suoi scritti contengono gli elementi<br />
per un'analisi psicologica della crescita spirituale dell'uomo, e da<br />
queste opere è possibile ricavare una teoria 4. Ma in pratica in quale misura<br />
ha saputo vivere conforme a tale teoria? E come ha saputo conciliare<br />
la realizzazione e il compimento del suo io con l'unione a Dio?<br />
Non si può tentare di rispondere a. questi interrogativi mantenendosi<br />
sulle generali. D'altra parte non è neppur possibile analizzare ogni<br />
suo comportamento alla luce di tutti i suoi scritti. Bisognerà dunque<br />
tentare di caratterizzarne alcuni, rivelatori dei suoi conflitti interiori, per<br />
vedere se, e in qual misura, ha saputo risolverli s.<br />
1. INTENSITÀ DEI CONFLITTI INTERIORI<br />
1. Contraddizioni a proposito della vicenda di Morimond<br />
Ed ecco subito uno dei primi conflitti nei quali Bernardo si trovò<br />
immischiato: quello provocato da Arnoldo, abate cistercense di Morimond,<br />
che, con un gruppo dei suoi monaci, era partito per fondare<br />
altrove un monastero. Bernardo si era opposto a quel progetto e ci teneva<br />
assolutamente che Arnoldo ritornasse. Ma questi aveva ottenuto il permesso<br />
da Roma. Mori mentre era in viaggio per la Palestina.<br />
Bernardo gli aveva innanzitutto inviato la Lettera 4&,rivelatrice e<br />
della sua psicologia e di certe concezioni proprie del suo tempo. Gli<br />
comunica dapprima il grande dolore provocato in tutti gli amici dalla<br />
decisione presa da Arnoldo di andarsene: Bernardo gli muove rimprovero,<br />
apparentemente senza rispetto per la libertà personale con cui ha fatto<br />
la sua scelta, e la prima ragione che invoca è che Arnaldo abbandonando<br />
i monaci rimasti a Morimond li ha lasciati come pecore destinate a restare<br />
senza pastore. Non fa cenno alla responsabilità di coloro che partono<br />
con lui: come se non contassero affatto; si identificano semplicemente<br />
con lui. Ciò suppone che l'abate sia insostituibile e che i monaci abbiano<br />
soltanto una parte secondaria. Resta cosi più facile esercitare una pres-<br />
4 ROBERT P. STEPSIS, Fulfillment 01 Sei! and Union with God in the Writings 01<br />
Bernard 01 Clairuaux, in Tbe American Benedectine Rewiew, 24 (1973), p. 348-364.<br />
S Sui fatti, Bernard de Clairuaux, op. cit., p. 125-133; sui testi di Bernardo che vi<br />
si riferiscono, Littérature et psychologie.<br />
- 133-
sione psicologica su Arnoldo, prima lusingandolo come « una colonna»<br />
dell'ordine cistercense, ed accusandolo poi di non aver consultato gli<br />
altri abati e di essersi circondato di giovani monaci lasciandosi senza dubbio<br />
influenzare da loro. Bernardo non nega la sua buona intenzione, a meno<br />
che non si tratti di una concessione di carattere letterario. Concludendo<br />
offre la sua mediazione al fine di ottenere una decisione meglio motivata:<br />
non si oppone a che Arnoldo se ne vada; ma al modo in cui lo fa.<br />
In questa lettera la motivazione di Bernardo è valida nella misura in cui,<br />
secondo la concezione del tempo, egli si preoccupa del bene spirituale<br />
dei monaci ai quali è indispensabile la presenza di Arnoldo: ha saputo<br />
dar prova in una situazione concreta d'una certa osservazione, e perfino<br />
di una certa penetrazione (insight); ma non manifesta alcuna « empathie<br />
» verso la persona stessa di Arnoldo: non tenta affatto di « sentire<br />
con lui » le ragioni che lo hanno spinto a partire: ciò che gli importa è<br />
che lui ritorni, ristabilendo così la situazione oggettiva che considera<br />
normale.<br />
Molto diverse sono le lettere scritte, allo stesso proposito, dopo la<br />
morte di Arnoldo: Bernardo parla molto di lui nella più lunga, la 7 3<br />
,<br />
indirizzata al monaco Adamo che era partito con lui, e nella 6\ inviata<br />
all'arcivescovo di Colonia. In quest'ultima vi sono espressioni durissime<br />
per Arnoldo, che ha agito non per Cristo ma per se stesso, che ha scelto<br />
i monaci migliori per farne suoi complici, e così di seguito. Come si<br />
spiega la differenza tra le motivazioni che gli sono attribuite e le<br />
valutazioni di Bernardo a suo riguardo? Nella lettera 4 3 , Bernardo aveva<br />
dichiarato che ara una colonna dell'ordine; qui invece non riconosce in<br />
lui nulla di buono. Inconsciamente deforma i fatti perché vuole ottenere<br />
il ritorno di Adamo; deve dunque mettere in cattiva luce lui e Arnoldo,<br />
diversamente l'arcivescovo di Colonia, al quale si rivolge, non interverrà<br />
per farlo ritornare: Bernardo scrive in modo da convincerlo. Ma così facendo<br />
non proiettava forse su Arnoldo la collera provocata dalla sua<br />
resistenza, e che considera come una disobbedienza? Non tenta di discernere<br />
con giusta critica quanto di giustificato vi poteva essere nella<br />
decisione di Arnoldo: non vuole vedere alcunché di buono nelle sue<br />
motivazioni. Aveva forse delle prove per giudicarlo così? Un meccanismo<br />
di difesa non lo portava forse a contraddirsi sfigurando la realtà? Infatti<br />
se tutto quello che Bernardo dice ora di Arnoldo era vero, avrebbe dovuto<br />
rallegrarsi della sua partenza come di una benedizione per il suo monastero<br />
e per l'Ordine.<br />
10 stesso tipo di reazione inconscia traspare nella lettera T', indirizzata<br />
ad Adamo. All'inizio Bernardo afferma di non voler fare apprez-<br />
- 134-
zamenti su Arnoldo, ora morto, e il cui giudizio spettava solamente a Dio.<br />
Ma a questo atteggiamento obiettivo e sereno segue ben presto l'irritazione.<br />
Arnoldo è accusato di aver disperso il suo gregge, turbato la pace<br />
della sua comunità, e d'essersi comportato come un bandito: nuova contraddizione<br />
nel linguaggio di Bernardo. Egli offre, certo, qualche giustificazione<br />
alle invettive contenute in questa seconda parte della lettera:<br />
per suscitare l'obbedienza di Adamo e dei suoi compagni, vuol fare loro<br />
comprendere fino a che punto illoro abate, Arnoldo, si era reso colpevole.<br />
Ma aveva il diritto, Bernardo, di ricorrere, sia pur per un fine che considera<br />
legittimo, a mezzi che non lo sono affatto, ed in particolare alla<br />
calunnia? Inoltre vi è conraddizione tra la condotta che Bernardo rimprovera<br />
ad Arnoldo, ad Adamo e ai membri del loro gruppo, e quella<br />
adottata verso i monaci che vengono a Clairvaux da altri monasteri. Ai<br />
primi rimprovera la partenza come intrinsecamente cattiva, come decisa<br />
senza permesso, contro l'istituzione cistercense ed ilbene dei suoi membri;<br />
la stessa autorizzazione papale non ha alcun valore perché, richiedendola,<br />
Arnoldo era animato da intenzione cattiva e, accordandola, il papa era<br />
stato tratto in inganno dalla menzogna e vinto dall'importunità. I seguaci<br />
di Arnoldo hanno agito contro il loro voto di stabilità, ritenuto più importante<br />
di quello d'obbedire al proprio abate. A riguardo invece dei monaci<br />
che desideravano passare a Clairvaux, Bernardo si pone la domanda del<br />
perché liriceve, ed ammette che è difficile vederci chiaro. Tenta di rispondere<br />
- per verità in modo poco convincente - che Dio è dappertutto,<br />
che coloro che cercano la salvezza hanno il diritto di passare ad un monastero<br />
più fervente. La lettera termina con una specie di minaccia profetica,<br />
proferita in nome di Dio: coloro che ritorneranno avranno la vita,<br />
gli altri morranno. Alla base di tutta questa argomentazione sta la convinzione<br />
che la vita condotta nell'Ordine cistercense, e soprattutto a<br />
Clairvaux, ha estrema importanza per la gloria di Dio e il bene degli<br />
uomini, un po' come se fuori di Clairvaux non vi fosse salvezza.<br />
Questi sono i dati che emergono dalle lettere di Bernardo. Ed è<br />
chiaro che non si può valutare l'intero problema su quest'unica fonte:<br />
bisognerebbe poter sentire anche l'altra parte, conoscere da Arnoldo, da<br />
Adamo e dagli altri le loro motivazioni. Ma è possibile pervenire ad un<br />
equo giudizio su Bernardo stesso andando al di là delle ragioni coscienti<br />
che egli dà del suo intevento? Non vi è nulla che meriti considerazione<br />
nei suoi moventi profondi? Innanzi tutto va riconosciuta l'importanza che<br />
accorda alla motivazione interna anche quando fa di questo principio<br />
una applicazione ingiustifìcata: occorre discernere con chiarezza la volontà<br />
di Dio, non si deve agire con rimorso o nel dubbio: vi è tutta una<br />
- 135-
esigenza di sincerità e di responsabilità che neppure una dispensa papale<br />
può dispensare. Ciò che conta è l'intenzione: nessuna autorizzazione può<br />
rendere buono ciò che, in se stesso, è cattivo. Tutti questi principi affermati<br />
da Bernardo sono esatti; resta da vedere se i casi concreti a proposito<br />
dei quali li invoca corrispondano alla presentazione che ne fa.<br />
Giustissima è pure l'idea sviluppata nella lettera T", secondo la quale<br />
è più importante obbedire a Dio che agli uomini: Adamo avrebbe dovuto<br />
rifiutare di seguire il suo abate per sottomettersi a Dio. A ciascuno la<br />
propria responsabilità, dice Bernardo: io non posso sostituirmi a lui. E<br />
in tutta la lettera cerca di costringere Adamo ad un esame del « perché»<br />
della sua partenza, vuole fargli scoprire il fondo della sua interna motivazione,<br />
e riconoscere che avrebbe dovuto cercare di discernere più chiaramente<br />
la volontà di Dio, invece di lasciarsi trascinare dalla persuasione<br />
e dall'esempio di Arnoldo, contro la sua coscienza e il suo autentico<br />
volere.<br />
Ed infine Bernardo non ha forse ragione di insistere sull'importanza<br />
della carità, il cui effetto deve essere non la divisione tra i membri di<br />
una comunità ma la loro unione? Senza dubbio la sua dottrina dell'intenzione<br />
è esatta, ma agisce sempre, e specialmente in questa circostanza,<br />
in conformità ad essa? La sua pratica è conforme su questo punto al suo<br />
insegnamento? A questi interrogativi si può rispondere affermativamente<br />
in base a quanto appare dalle sue motivazioni coscienti: egli pratica<br />
sempre quanto esige dagli altri. Ma al di là di questi motivi espliciti, che<br />
sono buoni, non vi potrebbero essere in lui impulsi inconsci e non sufficientemente<br />
maturati che non coincidono con le ragioni da lui stesso<br />
adottate? Non è forse proprio questo il caso dei suoi moti di collera, o<br />
delle invettive contro Arnoldo, dopo la morte, per non essere riuscito a<br />
farlo tornare? Nelle sue espressioni sono state rilevate diverse contraddizioni.<br />
E di una di queste fu cosciente, dal momento che aveva sentito il<br />
bisogno di giustificare la sua condotta a proposito dei religiosi che passavano<br />
a Clairvaux da altri monasteri. Ma fino a che punto si rese conto<br />
che le lodi ad Arnoldo nella lettera 4 a non potevano accordarsi con i biasimi<br />
successivi? Che l'abate di Morimond abbia meritato questi elogi o<br />
questi rimproveri, è compito degli storici stabilirlo, nella misura in cui i<br />
documenti lo consentono: l'analisi psicologica dei testi non dispensa mai<br />
dal ricorrere a tutti i mezzi di informazione disponibili. Non può essere,<br />
oltre tutto, che gli elogi attribuiti ad Adamo ancor vivo corrispondessero<br />
ad una esigenza di cortesia? Tuttavia, a giudicare da queste lettere di<br />
Bernardo, non è possibile non rilevare in lui alcune contraddizioni che<br />
sembrano essergli sfuggite ed alcuni conflitti non risolti. Si ha l'impres-<br />
- 136-
sione che, almeno in questo caso, egli avrebbe avuto bisogno di quella<br />
specie di terapia o di esercizio di discernimento degli spiriti che talora<br />
praticava, in modo eccellente, verso gli altri.<br />
2. Carità e passioni umane nella lettera a Roberto<br />
Nella lettera la, indirizzata al cugino Roberto, il quale era passato<br />
da Citeaux a Cluny, Bernardo ripete più volte che se cerca di farlo tornare<br />
è a motivo della carità 6. E si può credere che tale fosse la sua volontà.<br />
Ma vi è soltanto carità in lui? Non traspaiono forse, tra le righe, bisogni<br />
inconsci, e, in particolare, una certa possessività? Ha saputo porre queste<br />
passioni al servizio della carità? E se ha avuto carità per Roberto e Clteaux,<br />
si è mostrato ugualmente caritatevole verso Cluny? Non è forse<br />
accaduto, in questo caso, a Bernardo come a tanti altri - compresi noi<br />
stessi, cosi spesso - di credere di lasciarsi guidare da valori oggettivi<br />
mentre si lasciava trasportare da impulsi inconfessati? Possedeva un temperamento<br />
da capo, da « leader », e lo aveva mostrato portando con sé a<br />
Clairvaux tutti i suoi fratelli e uno zio. Ora Roberto era suo cugino, ed<br />
era duro per lui vedere un membro della sua famiglia opporgli resistenza;<br />
egli insiste a lungo sul fatto che si sente suo padre, che nei suoi confronti<br />
è nelle stesse condizioni della madre alla quale Salomone fece rendere<br />
il figlio (n. lO). In altre parole si comporta come uno che è frustrato,<br />
ferito nel proprio orgoglio. Ed è bello vedere come, in questa lunga lettera,<br />
dà libero corso ai più svariati e diversi sentimenti. A poco a poco<br />
infatti, verso la fine della lettera, lo si vede unicamente preoccupato del<br />
bene di Roberto: lo spinge la carità e tutto il resto si integra in essa.<br />
3. Ricerca della gloria di Dio e affermazione dell' io<br />
Dopo aver notevolmente contribuito a porre termine allo scisma<br />
che opponeva Anacleto a Innocenzo II, Bernardo approfitta del prestigio<br />
acquisito presso il papa per fargli approvare la nomina di un suo parente,<br />
Goffredo di la Roche-Vanneau, monaco di Clairvaux, a vescovo di Langres,<br />
al posto di un monaco di Cluny, eletto a quella sede 7. In quella<br />
occasione redige una serie di lettere che rivelano in lui una reale aggressi-<br />
6 Cf. Bernard de Clairoaux, p. 193-203 e Littérature et psychologie.<br />
7 Sugli avvenimenti, GILES CONSTABLE, The Disputed Election ai Langres in 1138}<br />
in Traditio, 13 (1957), p. 119-152; Littérature et psychologie.<br />
- 137-
vità, di cui non è qui il caso di studiare nuovamente le manfestazioni 8.<br />
Consideriamo piuttosto le intenzioni di Bernardo. Ora quanto più appare<br />
poco scrupoloso nella sua versione dei fatti, tanto più si dice sicuro<br />
di quella che è la volontà di Dio di cui desidera la realizzazione; non<br />
ammette che altri la concepiscano diversamente da lui: la ragione è dalla<br />
sua parte e bisogna che gli altri la pensino come lui. È sicuro di far tutto<br />
per la gloria di Dio; e quanti la pensano diversamente da lui hanno torto.<br />
Il suo candidato è « l'uomo che piace a Dio» 9. Parimenti, alla fine della<br />
lettera 346 relativa alla elezione di York, si legge: «Non dico questo da<br />
me stesso, ma secondo la testimonianza di coloro che sono mossi dallo<br />
spirito di Dio ». In quest'ultimo caso, la pretesa di essere il fedele ed<br />
unico rappresentante del pensiero di Dio è tanto più insistente dal momento<br />
che le formule di questa frase non solo sono reminiscenze bibliche<br />
ma sono in parte improntate a quanto Cristo affermava di se stesso.<br />
Le prime parole: Non loquor hoc a me ipso, sono direttamente ispirate<br />
a diverse espressioni di Gesù nel Vangelo di Giovanni (7,17; 8,25-28;<br />
38; 12, 49-50, ecc.) e soprattutto alla seguente: Verba quae ego loquor<br />
vobis a meipso non loquor ... Il seguito: sed testimonium illorum riprende<br />
un termine che spesso Gesù applicò a se stesso, in S. Giovanni.<br />
La finale: qui Spiritu Dei aguntur, si trova in una frase di S. Paolo ai<br />
Romani (8, 14) che si conclude con l'affermazione: ii sunt filii Dei. In<br />
questi casi, Bernardo sembra attribuire ilmonopolio dello Spirito Santo a<br />
quanti la pensano come lui: in questa come in molte altre lettere, Bernardo<br />
identifica volentieri le sue amicizie con quelle del Signore; raccomandando<br />
all'arcivescovo di Lione l'abate di la Bénisson-Dieu, dichiara:<br />
« Quanto farete in suo favore, è a me, o meglio a Gesù Cristo stesso che<br />
lo farete » lO. Appare così come un uomo molto deciso e sicuro di sé:<br />
opporsi a lui è opporsi a Dio; tutti devono capire che la sua volontà è<br />
quella di Dio.<br />
4. Suscettibilità e tendenze dominatrici nel conflitto con Abelardo<br />
Sappiamo quanto furono complesse le circostanze che prepararono e<br />
affiancarono la condanna di Abelardo nel 1140 da parte di quello che<br />
enfaticamente denominiamo il Concilio di Sens, poiché, in realtà, quell'assemblea<br />
contava solo sei vescovi, riuniti in presenza del re di Francia<br />
8 Epist., 164.<br />
9 Epist., 169.<br />
io Epist., 173.<br />
- 138-
e di un concorso di popolo convenuto soprattutto da quella città. La dottrina<br />
attribuita ad Abelardo su diversi punti del dogma e della morale<br />
non era che un aspetto di un vasto insieme di elementi d'ordine psicologico<br />
e spirituale, su problemi che si agitavano nell'ambito monastico,<br />
politico, ecclesiastico, e che da tempo opponevano i due protagonisti Il.<br />
Gli argomenti di carattere dottrinale furono esposti da Bernardo soprattutto<br />
nella lunga lettera in forma di trattato nella quale denunciava<br />
a Innocenzo II gli errori di Abelardo. Sembra ormai certo che prima di<br />
redigerla non abbia compiuto un esame minuzioso e personale degli<br />
scritti del suo avversario, ma che si sia affidato, con eccessiva fiducia, alla<br />
presentazione fattagli da Guglielmo di Saint-Thierry che, da lunga data,<br />
aveva ritenuto l'insegnamento di Abelardo pericoloso per l'integrità della<br />
fede. E siccomeentravano in gioco altri elementi non teologici, molte ragioni<br />
invocate da Bernardo, là come altrove, contro Abelardo, non erano<br />
che argomenti ad hominem, nel duplice senso che da una parte tentava<br />
di colpire i punti deboli della personalità di Abelardo e dall'altra si<br />
rivolgeva parimenti ai membri della curia romana, destinatari delle lettere,<br />
nei loro punti vulnerabili.<br />
Alla controversia dottrinale sottostava, in verità, un conflitto di tendenze,monastiche.<br />
Senza dubbio Abelardo, in alcuni suoi scritti, rivelava<br />
un senso della semplicità e della austerità ed uno spirito riformatore<br />
molto simile al programma cistercense messo in luce da san Bernardo 12.<br />
Ma come era antifemminista in teoria 13, e, in pratica, difensore dei valori<br />
femminili 14, così, di fatto, era più vicino a Cluny che a Citeaux. E questo<br />
non era sconosciuto né a Bernardo né all'ispiratore dei suoi scritti contro<br />
Cluny e contro Abelardo, Guglielmo di Saint-Thierry, un benedettino<br />
dall'anima cistercense. Fu lui che spinse Bernardo a lanciarsi nella controversia<br />
dottrinale. In questo campo, forse l'abate di Clairvaux non era<br />
in un primo tempo irritato quanto il suo amico; ma volle fargli piacere<br />
Il La storia di questo conflitto continua ad esere studiata, e, in particolare,<br />
recentemente da J. MIETHKE, Abaelards Stellung zur Kircbenreiorm. Eine biograpbiscbe<br />
Studie, in Francia. Forscbungen zur Westeuropiiischen Gescbicbte, l (1972) p. 158-192,<br />
con ampia bibliografia.<br />
12 Lo mettono in rilievo i testi cbe bo analizzato con il titolo «Ad ipsam sopbiam<br />
Christum ». Le témoignage monastique d'Abelard, in Reoue d'ascetlque et de mystique,<br />
46 (1970), p. 165-167, 1. S. [ean Baptiste et le propbétisme monastique, e in<br />
particolare, il lungo sermone, in forma di trattato, per la festa di S. Giovanni Battista,<br />
ed. P. L., 178, 582-607.<br />
13 Il fatto cbe Abelardo sia stato «moins féministe que la plupart des auteurs<br />
spirituels» del suo tempoè stato rilevato da R. JAVALET, Image et ressemblance au XII<br />
siècle, Paris 1967, I, p. 241.<br />
14 Cf. «Ad ipsam sophiam Cbristum »... , loc. cit., II, Moniales et diaconesses, p.<br />
164-181.<br />
- 139-
senza prevedere, probabilmente, che la questione avrebbe assunto vaste<br />
proporzioni. Ed è in questa occasione che egli lasciò trasparire chiaramente<br />
un'altra sua tendenza profonda, ugualmente contraria a una di quelle<br />
che credeva scoprire in Abelardo: Bernardo, di sua natura, inclinava più<br />
a contemplare il mistero che a scrutarlo o a cercare di spiegarlo;<br />
Abelardo invece non temeva di porre nuovi problemi nel campo della fede<br />
e di servirsi, per rispondervi, di un metodo che sembrava attribuire maggior<br />
valore allo sforzo razionale che all'accettazione d'una tradizione. Tutto<br />
questo urtava le aspirazioni più intime dell'uomo di fede e di preghiera<br />
quale era Bernardo. E godendo allora di un prestigio che gli conferiva<br />
autorità nel campo della politica ecclesiastica, se non in quello della<br />
teologia, egli fa appello soprattutto ad argomenti d'ordine « tattico» più<br />
che dottrinali.<br />
Si preoccupa in particolare di mettere in guardia, a priori, i suoi<br />
lettori contro Abelardo e i suoi insegnamenti. Egli « condiziona », per<br />
così dire, i suoi destinatari con la paura: «La causa è di Cristo, afferma<br />
per esempio all'inizio di una lettera al cardinale Guido, anzi Cristo stesso<br />
è la causa, e la verità si trova in pericolo, si dividono le vesti di Cristo,<br />
si lacerano i sacramenti della Chiesa ... ». Se ciò era esatto, era quanto<br />
bastava per impressionare un alto dignitario, scarsamente informato sulle<br />
dottrine incriminate: come avrebbe potuto sottrarsi a questa sorta di<br />
ricatto? Così Bernardo s'affrettava ad indicargli le conseguenze di tali<br />
premesse: «Se sei figlio della Chiesa, se non misconosci il suo petto materno,<br />
non lasciare tua madre in pericolo, non sottrarre le tue spalle nel<br />
momento del dolore » 15.<br />
Bernardo mira in tal modo ad influenzare, con termini energici, i suoi<br />
corrispondenti, ponendoli di fronte alle loro tremende responsabilità:<br />
« Agite secondo la posizione che accupate, scrive egli ancora a tutti i cardinali<br />
e vescovi della curia romana, secondo la dignità di cui siete rivestiti,<br />
del potere che avete ricevuto, in modo che colui che vuole innalzarsi fino<br />
al cielo, precipiti fino all'abisso ... »: ed è solo l'inizio di una lunga frase<br />
sullo stesso tono ... 16. Talora Bernardo va anche oltre per questa strada, e<br />
i suoi intenti raggiungono l'adulazione, come quando scrive al vescovo<br />
di Palestrina: «Vi comunico le angustie e i gemiti della sposa di Cristo,<br />
con grande confidenza, perché so che siete amico dello sposo e che siete<br />
pieno di gioia alla sua voce. Sono pienamente sicuro nel Signore, conoscendovi<br />
nell'intimo, che non cercate le cose vostre ma quelle di Gesù Cri-<br />
IS Epist., 334, P. L., 182, 538-539.<br />
16 Epist., 188 2, P.L., 182, 353.<br />
140 -
sto. Pietro Abelardo si rivela nella sua vita, nei discorsi e nei libri, vero<br />
persecutore della fede cattolica e nemico della croce di Cristo ... » 17.<br />
Un altro procedimento utilizzato da Bernardo in questa polemica<br />
consiste nel porre il pericolo dottrinale in relazione con quello di ordine<br />
politico, associando Abelardo ad Arnaldo da Brescia il quale aveva criticato<br />
la ricchezza della curia e tentato di sollevare il popolo di Roma<br />
contro il papa. Innocenzo II resta così, a priori, mal disposto nei suoi<br />
confronti. Bernardo glielo descrive come protettore di Abelardo, allo stesso<br />
modo di colui che portava le armi con le quali Golia si preparava ad<br />
affrontare Davide, e sviluppa il parallelo tra questi due nemici di Cristo,<br />
della Chiesa, del papato e della verità 18. In forza di tali considerazioni,<br />
Bernardo può presumere che Abelardo sarà condannato e ritenerlo tale<br />
prima ancora che il papa abbia emesso la sentenza: alla fine di questa<br />
stessa lettera a Innocenzo II tratta già l'accusato da scismatico e da eretico,<br />
e lusinga nuovamente il papa: alludendo allo scisma di Anacleto nel<br />
quale Bernardo aveva avuto una parte di cui poteva ora vantarsi, aggiunge:<br />
« Il Signore Vi ha veramente provato nello scisma e Vi ha conosciuto<br />
abile. Ma, perché non manchi proprio nulla alla vostra corona, ecco che<br />
sono scoppiate le eresie. E perciò, a completamento delle vostre virtù, e<br />
perché non vi si trovi inferiore ai grandi vescovi, vostri antecessori, catturatele<br />
per noi, o Padre, finché sono piccole, le volpi che demoliscono la<br />
vigna del Signore ... » 19.<br />
In tal modo, con ogni mezzo, e in base a considerazioni che non sono<br />
affatto di carattere dottrinale, Bernardo tenta di imporre il suo giudizio<br />
ai suoi corrispondenti e ai suoi lettori, essendo prevedibile che le sue lettere<br />
circolassero e che alcune sarebbero state un giorno pubblicate, come<br />
avrebbe egli stesso fatto qualche anno più tardi. E simili argomenti egli<br />
dovette utilizzare per far pressione sui vescovi giunti a Sens alla vigilia<br />
di riunirsi in concilio per ascoltare Abelardo e giudicarlo. Ora costui veniva<br />
a presentarsi non per ricevere una sentenza prefabbricata, ma per<br />
avere l'occasione di difendersi. Di fronte all'impossibilità di farlo egli<br />
appellò a Roma, ponendo i vescovi in una situazione delicata. In realtà<br />
ilre ed essi stessi, con molti altri, in Francia, desideravano l'indipendenza<br />
delloro paese nei confronti di Roma. D'altra parte, il papa e la curia romana<br />
erano ben lieti del ricorso che dava risalto alloro potere. Così Bernardo<br />
dovette, ben presto, scrivere al più gran numero possibile di membri<br />
della curia per ottenere da essi che Abelardo, ancor prima del suo<br />
17 Epist., 331, P.L., 182, 536.<br />
18 Epist., 189, 3, P.L., 182, 855.<br />
19 Ibid., 5, 356.<br />
- 141
arrivo a Roma, fosse « già giudicato» e condannato come eretico. Non<br />
entrarono pertanto solo in gioco le considerazioni derivate dalla psicologia<br />
di Bernardo ma egli utilizzò tutto il suo talento e la sua passione per<br />
fondere argomenti di carattere dottrinale con altri tratti dal gioco complesso<br />
della politica religiosa.<br />
Tale ambiguità di fatto era costante nel suo modo di denunciare l'avversario:<br />
a volte critica le sue dottrine, a un livello speculativo, a volte<br />
attacca la sua persona, utilizzando un vocabolario biblico, facendo esprimere<br />
dalla Scrittura quando lui stesso vuoI dire: «Il maestro Pietro Abelardo,<br />
monaco senza regole, prelato privo di zelo, non mantiene una linea<br />
retta, né si lascia imbrigliare da alcun ordine. È un tipo pieno di<br />
contraddizioni: interiormente un Erode, all'esterno un Giovanni; tutto<br />
ambiguità, del monaco non ha nulla se non ilnome e l'abito ... »20.Questo<br />
dovrebbe bastare a far giudicare i suoi partigiani e i suoi alleati. Ora verso<br />
la fine di questa stessa lettera al cardinale Ivo, si legge questo ammonimento:<br />
«Tuttavia non si dà nessun pensiero perché si vanta che i cardinali<br />
e i preti della curia sono diventati suoi seguaci, e prende a difesa<br />
dell'antico e del nuovo errore coloro dai quali dovrebbe temere di essere<br />
giudicato e condannato ». Parimenti come gli amici di Abelardo sono i<br />
nemici del bene della Chiesa così gli amici di Dio devono essere i suoi oppositori:<br />
«Se qualcuno possiede lo spirito di Dio, si ricordi di quel versetto:<br />
O Signore, non ho forse odiato coloro che ti odiano, e mi sono consumato<br />
contro i tuoi nemici? » 21.<br />
Un altro modo seguito da Bernardo per discreditare Abelardo consiste<br />
nell'applicargli titoli ingiuriosi tendenti ad identificarlo con i peggiori<br />
eretici: Ario, Pelagio, Nestorio 22. Senza dubbio si trattava di un tema<br />
tradizionale, e che non provava nulla, ma sufficiente, agli occhi di spiriti<br />
poco critici, a squalificare un avversario. Va tuttavia sottolineato che<br />
Bernardo non si richiama mai al passato personale di Abelardo, la cui avventura<br />
amorosa con Eloisa avrebbe potuto offrire un facile motivo di<br />
disprezzo. Un difensore di Abelardo, Pietro Berengario, non tarderà<br />
invece a comportarsi diversamente nei confronti di Bernardo rimproverandogli<br />
le sue debolezze giovanili 23. Nel riserbo dell'abate di Clairvaux<br />
in questo campo c'è un senso di dignità che lo onora.<br />
20 Epist., 193, P.L., 182, 359. S. Bernardo forse allude qui al fatto che Abelardo<br />
aveva esposto le sue idee sul monachesimo nel sermone su S. Giovanni Battista<br />
ricordato più sopra, alla nota 12.<br />
21 I bid., citando il.Salmo 138, 21.<br />
22 Epist., 331, P.L., 182, 537, ecc.<br />
23 Apologeticus contra Beatum Bernardum, P. L., 178, 1857 AB.<br />
- 142-
Contemporaneamente Bernardo cerca di giustificare il suo attacco:<br />
se vuole imporre le sue idee, egli afferma, è perché crede sinceramente<br />
che siano le migliori. Si paragona cosi a Davide, ai profeti, a san Paolo.<br />
In previsione di eventuali rimproveri per il suo intervento nel processo,<br />
paragona la parte da lui svolta a quella dei servi di Dio di cui parla l' Antico<br />
e il Nuovo Testamento. E proietta su Innocenzo II il suo ruolo e le<br />
sue idee; ed è talmente persuaso che queste siano giuste da chiedere al<br />
papa di farle proprie. Tenta in tutti i modi di giustificare il suo atteggiamento<br />
cosi che non valga solo ai propri occhi ma possa essere accettato<br />
dagli altri.<br />
Ma, in realtà, che cosa tenta di giustificare? Non si tratta forse in<br />
parte, e inconsciamente, di proprie esigenze, e in particolare di una indubbia<br />
tendenza a dominare gli altri, e in questo caso, da una parte Abelardo<br />
e dall'altra il papa e i membri della curia? Quando ha trovato una<br />
via che ritiene la migliore - si tratti di vita monastica, di dottrina o di<br />
politica - vi si attiene a rischio di non poter cogliere altri aspetti della<br />
realtà. Non solo, ma desidera che tutti l'adottino con il pericolo di non<br />
rispettare sufficientemente la personalità di coloro che la pensano diversamente.<br />
Diventa in tal modo facilmente troppo dogmatico nell'esporre<br />
le proprie opinioni e nel formulare giudizi. Vi è tuttavia in questo atteggiamento<br />
un aspetto coraggioso; non può vivere in uno stato di ambiguità<br />
cosciente, voluta e accettata, anche se, inconsciamente, neppur<br />
la sua condotta ne va esente. In forza di questo carattere assoluto, e per la<br />
sincera convinzione di essere nel vero, è estremamente sensibile alle critiche<br />
di cui sa di essere oggetto da parte di Abelardo e dei suoi discepoli,<br />
ed anche da parte di alcuni membri della curia: tale suscettibilità traspariva<br />
nelle lettere scritte in quel frangente.<br />
Più tardi, quando pubblicherà il suo registro, cercherà di attenuare<br />
certe sue espressioni. E questo per varie ragioni: preoccupazione di non<br />
ripetersi, di pubblicare i testi più personali, ossia quelli alla cui redazione<br />
aveva contributo più dei notai, in particolare di Nicola di Montieramey<br />
al quale aveva accordato un'eccessiva fiducia di cui ben presto avrà motivo<br />
di rammaricarsi. Ma non si può forse anche ritenere che si sia pentito<br />
di certe violenze verbali in lettere alle quali preferì non assicurare<br />
una larga diffusione? Tuttavia nel momento in cui le aveva dettate o<br />
ne aveva delineato il canovaccio, nel fuoco della polemica, aveva dato<br />
prova di coerenza e di costanza. Vi aveva profuso non solo le sue idee,<br />
ma le sue passioni, i suoi sentimenti e le sue emozioni al servizio delle<br />
sue convinzioni. Quasi che temesse di vedersi paragonato ad altri, e soprattutto<br />
al dialettico indubbiamente superiore che era Abelardo, si era<br />
- 143-
attenuto strettamente, con rigore, allo schema di pensiero e alla linea di<br />
condotta adottata fin dall'inizio della controversia. Una specie di rigidità<br />
inflessibile 1'aveva reso impenetrabile all' apporto degli altri, inaccessibile<br />
alle loro obiezioni. Non accettava di considerare questa disputa, non esente<br />
da elementi passionali da entrambe le parti, se non allivello di fede,<br />
e, su questo piano si sentiva sicuro. Ma questo sentimento non nascondeva<br />
forse una certa paura inconscia per la propria stabilità? È difficile<br />
dirlo. Certamente intendeva rimanere fedele a se stesso e a ciò che a lui<br />
appariva come una esigenza di Dio, al quale solo spetta valutare la parte<br />
avuta in questo conflitto, sia da Abelardo che da Bernardo, per l'amore<br />
della verità.<br />
II. L'UMILTÀ, CONDIZIONE DELL'AZIONE<br />
Dopo aver rilevato un certo numero di aspetti piuttosto negativi, sarà<br />
bene non dimenticare quelli positivi; e a tale proposito si impongono<br />
alcune osservazioni preliminari: innanzitutto se consideriamo Bernardo<br />
solo nei suoi rapporti con gli avversari rischiamo di misconoscere le sue<br />
relazioni con gli amici, con tutti coloro ai quali non ha ragione di opporsi,<br />
o ai quali vuoI rendere un servizio o semplicemente compiacere; nelle<br />
sue «lettres d'humanité », di confidenze personali o di consigli spisituali,<br />
si rivela sotto un altro aspetto, affettuosissimo, che non sempre ha<br />
attirato sufficientemente l'attenzione di quegli storici che si interessano<br />
soprattutto dei fatti 24.<br />
Inoltre è molto difficile analizzare atteggiamenti nei quali gli elementi<br />
psicologici sono costantemente uniti a considerazioni d'ordine soprannaturale:<br />
tutto è strettamente collegato; e tuttavia siamo costretti<br />
ad isolare alcuni aspetti nell'impossibilità di parlare contemporaneamente<br />
di tutto. Nondimeno non si deve perdere di vista l'unità nella quale si<br />
fondono tutti questi stati d'animo. Ci sarà solamente possibile proporre<br />
qui una serie d'« approches », e le ripetizioni, inevitabili in questo genere<br />
di ricerche, porranno in risalto alcuni dati più importanti. L'esposizione<br />
sarà necessariamente molto sfumata, e da parte nostra dovremmo chiederci<br />
in ogni istante che cose ne penserebbe Bernardo stesso. Non si potrà<br />
evitare una interpretazione parziale, ma è la sola via per far progre-<br />
24 Con il titolo S. Bernard. Lettres cboisies, ho presentato una scelta di queste<br />
, lettres d'humanité ' tradotte da E. DE SOLMS, Narnur 1962.<br />
- 144-
dire le nostre conoscenze in questo campo: l'importante è che esse abbiano<br />
costantemente come punto di partenza i testi stessi.<br />
Infine, occorrerà accordare molto valore ai Prologhi, non tanto dal<br />
punto di vista della loro conformità con la tradizione letteraria 2S, né da<br />
quello dei meccanismi psico-dinamici dei quali si scopre il procedimento<br />
26, ma dal punto di vista delle intenzioni che Bernardo manifesta: possono<br />
rivelare tutto un itinerario spirituale, e, comunque, Bernardo vi si<br />
abbandona come ad una specie di continua auto-terapia. Con queste cautele<br />
pare di poter considerare la vita interiore dell' abate di Clairvaux come<br />
segnata da una tensione, sempre presente in lui, tra l'umiltà e la<br />
carità: con la prima prende coscienza dei propri limiti e verifica la purezza<br />
delle sue intenzioni, con la seconda prende la decisione di agire<br />
per servire.<br />
1. Coscienza dei propri limiti<br />
Fin dall'inizio della sua carriera letteraria, in quella « opera prima»<br />
dedicata ai Gradi dell'umiltà e della superbia, egli ha dato questa definizione:<br />
«L'umiltà è la virtù per la quale l'uomo si disprezza perché possiede<br />
una perfetta conoscenza di sé medesimo ». Tale definizione ha trovato<br />
in lui realizzazione? e in che modo? Se si leggono molti suoi testi,<br />
e specialmente i Prologhi, appare posto continuamente di fronte ad una<br />
grave alternativa: o agire nel senso richiestogli - e specialmente quando<br />
scrive - ed allora prevede di attirarsi gloria; oppure rifiutare perché è<br />
ben consapevole di rischiare d'essere criticato qualora il risultato non<br />
corrisponda alla aspettativa che in lui si ripone. Si lascia condizionare<br />
da quest'ultima o si mantiene libero nei suoi confronti? Prende una<br />
decisione ma non senza avere chiaramente considerato due ipotesi: se<br />
parla non si comporta più con umiltà, se tace è inutile. Questa sua capacità<br />
di coglier si così come è, con i suoi doni e i suoi limiti - e di giudicarsi<br />
con quella forma di humour che consiste nel prendere distanza<br />
da se stessi - lo porta a domandare che si preghi perché possa evitare<br />
due scogli: che non si riempia di orgoglio se raccoglierà «gloria», e<br />
che non si lasci deprimere e scoraggiare se non si attirerà che « ignominia<br />
»27; la forza stessa di questo vocabolario tradisce l'acutezza della tensione<br />
che percepisce in sé e la lucidità con la quale la considera.<br />
2S Recueil d'études sur S. Bernard, III, Roma 1968, p. 13-32.<br />
26 Literature and Psychology. III: Expressed motioations.<br />
27 S. Bernardi opera, III, Roma 1963, p. 16.<br />
- 145-
Un mezzo per risolvere questa antinomia consiste nel sottomettersi<br />
al giudizio altrui, e Bernardo lo fa volentieri, come nel Prologo del trattato<br />
Sulla grazia e il libero arbitrio 28: questo equivale a riconoscere che<br />
non sa tutto, che altri sono più competenti di lui ed hanno il diritto<br />
di criticarlo. È riscontrabile, in Abelardo, ad esempio, una tale preoccupazione<br />
di apparire agli altri cosi come si è e di accettare le loro correzioni?<br />
Nel Prologo dei sermoni di Quaresima sul Salmo 90, e in tutta<br />
l'opera, Bernardo parla della tentazione come di una prova alla quale<br />
egli è sottoposto esattamente come i monaci ai quali si rivolge 29. Rifugge<br />
la parte dell'uomo perfetto, che non conosce né dubbi né esitazioni 30. Ora<br />
nell'anno 1139,quando redige questi testi 31, egli è ormai un uomo di<br />
Chiesa, la cui capacità si è rivelata nella parte avuta nel risolvere lo scisma<br />
di Anacleto; e ben presto agirà contro Abelardo come uno sicuro di sé.<br />
Sa di essere molto stimato. Non gli occorse forse coraggio per manifestarsi<br />
ai suoi monaci, e in pubblico, con tanta sincerità?<br />
Così, nel Prologo del Libro sul precetto e la dispensa egli appare,<br />
per usare la terminologia cara alla tematica esistenziale, come un uomo<br />
problematico: è diviso, e non ne fa mistero. Confessa di aver a lungo<br />
esitato prima di rispondere alle reiterate richieste con le quali lo si « forzava<br />
» (cogitis) sia a mostrare la propria incapacità come pure a venir<br />
meno alla carità. Ma quando ha preso, autonomamente, la decisione di<br />
accettare, si lancia, per così dire, con coraggio, « come in un abisso dal<br />
quale - Dio lo sa - non è sicuro di emergere» 32. È rivelatore il fatto<br />
che, sollecitato da due monaci che non nomina, invia il suo trattato alloro<br />
abate, non senza aver giudicato severamente quei due quidam. La coscienza<br />
della propria autorità lo porta a tenerla in onore anche presso gli<br />
altri superiori, senza avere forse per i problemi dei semplici religiosi il<br />
rispetto che oggi ci attenderemmo. Manifesta tuttavia un certo distacco<br />
da quanto sta per scrivere, nel contenuto e nell'espressione, e moltiplica<br />
le formule di modestia.<br />
2. Importanza delle intenzioni.<br />
Vien fatto di chiedersi se 1'analisi minuziosa delle proprie motivazioni<br />
e di coloro che lo supplicano di scrivere, sia ancora presente quan-<br />
28 Ibid., p. 165.<br />
29 lbid., IV, Roma 1966, p. 383-492.<br />
30 Sull'esperienza che Bernardo afferma di fare della propria misena, ho raccolto<br />
alcuni testi in Aspects du monacbisme bier et autourd'bui, Paris 1968, p. 261-277.<br />
11 Su questa cronologia, S. Bernardi opera, IV, p. 119.<br />
32 Ibid., III, p. 253-254.<br />
- 146-
do si trova nel vivo di un conflitto. E sembra, invero, che sia cosciente<br />
dell'illusione sempre in agguato che lo può portare ad intervenire a proprio<br />
vantaggio: lo prova il fatto che se ne difende. Nelle lettere ai papi,<br />
in occasione dell'elezione di York, non cessa di sottolineare che egli agisce<br />
nell'interesse della Chiesa e non per interesse personale. Non può<br />
certo ignorare la presenza in lui di ragioni umane e di una certa tendenza<br />
ad influenzare; una lettura inserita nel Breviario di York, ancora oggi,<br />
rimprovera agli avversari di Guglielmo Fitzherbert d'essere stati troppo<br />
desiderosi di potere 33. Ma, d'altra parte, non è forse prova di maturità<br />
utilizzare a pieno 'l'energia interiore al servizio di una causa che crede<br />
giusta, quasi una sorta di pedagogia destinata a spingere gli altri - ivi<br />
compresi e innanzitutto i papi - a servirla nel solo modo che ritiene<br />
efficace? Ora uno dei mezzi di pressione da lui usati consiste nell'insistere,<br />
non solo sulla causa in questione - in questo caso, il bene oggettivo<br />
della Chiesa di York - ma sulla diversa motivazione dei sostenitori<br />
dell'uno e dell'altro candidato: coloro che stanno dalla mia parte, scrive<br />
a Innocenzo II nella lettera 347,« non cercano i propri interessi, ma quel-'<br />
li di Gesù Cristo. Solo l'amore di Dio li spinge: non credo che i loro stessi<br />
peggiori nemici possano sospettarli d'essere mossi, in questa controversia,<br />
da interesse privato o da rancore personale. Se qualcuno dunque è per<br />
Dio, sia dalla loro parte» 34. Una tale sfida lanciata al papa suppone quanto<br />
meno che agli occhi di Bernardo le intenzioni abbiano la loro importanza.<br />
3. Il coraggio dell'azione.<br />
Una volta riconosciuti i propri limiti e verificate le motivazioni, Bernardo<br />
passa all'azione. E, a prestargli fede, ciò gli costa. Nei suoi Prologhi<br />
manifesta questa specie di paura che prova ogni qual volta sta per<br />
intraprendere un'opera. Una tale paura potrebbe essere paralizzante, come<br />
quella che agisce da freno quando un paracadutista teme di lanciarsi<br />
nel vuoto. Se si ferma al timore che prova non riesce a compiere<br />
alcun movimento; se invece lo supera, rivela la propria capacità di affrontare<br />
un pericolo. Cosi Bernardo, se vince la sua titubanza a scrivere,<br />
ad agire, può cominciare a costruire la sua personalità; il suo io in piena<br />
espansione gli consente di dominare le varie paure che prova e che ma-<br />
13 Citato da BRUNO SCOT ]AMES, St. Bernard 01 Clairuaux, Londra 1957, p. 151.<br />
34 P.L., 182, 552.<br />
- 147-
nifesta fin dal Prologo del trattato Sui gradi dell'umiltà. Da questo momento<br />
rivela una percezione molto realistica di se stesso; la sua personalità<br />
ha raggiunto uno sviluppo sufficiente per impegnarsi secondo le proprie<br />
possibilità - si quem possem, communicare fructum sermonis 35. Ma,<br />
con una formula di san Giovanni già citata dalla Regola di san Benedetto,<br />
egli indica chi gli darà la forza: la carità; non si tratta soltanto per lui<br />
di realizzarsi, ma di superarsi e di andare a Dio.<br />
E lo riafferma ben presto nel Prologo delle omelie I n lode della Vergine<br />
Madre 36: bisogna saper fare di necessità virtù; le parole necesse est)<br />
necessitas e necessaria, che usa in sole tre righe, sono rivelatrici di questa<br />
specie d'obbligo impostogli da parte degli altri e le cui circostanze, in<br />
questo caso, favoriscono la realizzazione, poiché, ammalato, vive al margine<br />
della comunità e gode del tempo libero richiesto per la redazione.<br />
Non si lascia tuttavia condizionare né dalle richieste che riceve né dalle<br />
circostanze: si riserva la libertà - dum tamen ex hoc non impediar -<br />
di soddisfare alle esigenze della sua devozione.<br />
Questamedesima « necessità» alla quale acconsente è invocata ancora<br />
nel Prologo dell' Apologia 37 e nella lettera che presenta questo trattato<br />
a Guglielmo di Saint-Thierry 38. Il senso molto forte che egli ha dell'autorità<br />
appare, all'inizio di quasi tutti i suoi scritti, nel fatto che afferma di<br />
aver ricevuto l'ordine di scrivere e di esservisi sottomesso. Ciò sarà forse<br />
dovuto all'educazione ricevuta in una famiglia nobile, in un ambiente<br />
di cavalleria dove si era abituati a comandare? È certo, comunque, che<br />
vi è in lui una inclinazione al comando: assume perciò maggior risalto<br />
la sua capacità di obbedire, per servire, quando ha compreso che tale è<br />
il suo dovere. Afferma chiaramente all'abate di Saint-Thierry: «Finora,<br />
quando mi hai ordinato di comporre un'opera o l'ho fatto mio malgrado<br />
o non vi ho per nulla acconsentito » 39: in tal modo rivendicava la sua<br />
totale indipendenza, il diritto che si attribuisce di rifiutare, e l'uso che<br />
talvolta ne fa. Tuttavia la ricchezza della sua personalità deriva proprio<br />
dal fatto che in lui si conciliano e il dominatore e il servitore.<br />
Quella parte di « timidezza» che è in lui mette subito in azione un<br />
meccanismo di difesa, lo porta ad agire per reazione, e può perfino renderlo<br />
aggressivo nell'affermare la propria autonomia. Considera poi le<br />
due possibilità che gli si offrono: trattandosi di una « causa urgente»<br />
35 S. Bernardi opera, III, p. 16.<br />
36 Ibid., IV, p. 13.<br />
37 Ibid., III, p. 81.<br />
38 Ibid., p. 15.<br />
39 Ibid.<br />
- 148-
che Guglielmo di Saint-Thierry gli sottomette come un dovere, non rifugge<br />
dalle sue responsabilità; darà ai cistercensi e ai cluniacensi l' ammonimento<br />
che gli si richiede. Ma è come esporsi a un nuovo pericolo di cui<br />
è del tutto cosciente e che denuncia con lucidità, non senza una punta<br />
di esagerazione che è poi una forma di humour: quello di erigersi a « giudice<br />
del mondo intero ». Ed anche questa tendenza dovrà essere da lui<br />
purificata, domata, ed ancor prima riconosciuta. Ai suoi occhi pertanto,<br />
nel momento in cui con calma decide di intervenire, non è affatto facile<br />
passare all'azione; occorre infatti il controllo di tutte le ragioni che lo<br />
spingono a farlo. In questi casi Bernardo si rivela realmente maestro di<br />
se stesso: riesce a dominare i suoi impulsi spontanei e a conciliare le intenzioni<br />
con le azioni.<br />
4. La libertà di parola.<br />
Questo modo d'essere sincero con se stesso gli dà il diritto ad esserlo<br />
verso gli altri. Così, fin dal paragrafo dell'Apologia che segue l'introduzione,<br />
in cui si è messo in discussione nel modo che abbiamo visto,<br />
si lancia in un'invettiva contro l'ipocrisia: la parola Vae, ispirata alle maledizioni<br />
del Vangelo e dell' Apocalisse, si ritrova qui cinque volte, con<br />
formule di cui l'ultima è la seguente: Vae, inquam, semel, et uae iterum<br />
... 40 Questo linguaggio energico, d'una violenza studiata e voluta, è<br />
ben conforme al suo modo di agire.<br />
La preoccupazione di chiarezza, e di franchezza, non è soltanto in<br />
lui esigenza letteraria; è un bisogno psicologico che può diventare un<br />
mezzo di « costruire la carità », come Bernardo ne esprime il desiderio<br />
nel Prologo del suo trattato Sulla grazia e il libero arbitrio: a proposito<br />
di un argomento che è « oscuro », vuole tentare di realizzare il comando<br />
della Scrittura: «Coloro che fanno luce su di me, avranno la vita eterna<br />
»41. Questo stile di chiarezza è il suo stile di vita.<br />
E saprà usare, all'occorrenza, la sua franchezza con tutti. Nel Prologo<br />
della lettera 42, Sulla condotta e la funzione dei vescovi, diretta a<br />
uno dei più eminenti prelati di Francia, l'arcivescovo di Sens, che gli ha<br />
chiesto lo scritto, rifiuta ogni scelta compiacente 42: denuncia senza ambiguità,<br />
per tutta la lettera, quanto crede dover rimproverare ai dignitari<br />
ecclesiastici del suo tempo; lottando in questo modo contro ogni forma<br />
40 Apologia, 2, ibid., p. 82.<br />
41 Ibid., p. 165; cita Eccli 24, 31.<br />
42 P.L., 182, 803.<br />
- 149
di mediocrità, corre il grave rischio di attirarsi l'antipatia dell'alto clero,<br />
nel momento stesso in cui ne ha bisogno, non foss'altro nell'interesse delle<br />
sue abbazie in via di fondazione. Ma, con coraggio, non teme di esporsi<br />
anche a questa eventualità. D'altronde, come già all'inizio dell'Apologia,<br />
egli citerà una gran quantità di parole della Scrittura.<br />
Ma questo modo di procedere non è forse per lui un mezzo per rifugiarsi<br />
sotto un' autorità capace di proteggerlo? O forse gli consente di<br />
dar libero corso, al riparo delle parole sacre, alla propria aggressività? O<br />
ancora, si rendeva forse conto che i propri pensieri potevano apparire<br />
come una verità a lui, un messaggio troppo personale, che vuol rendere<br />
universale facendolo esprimere o confermare dal portavoce di Dio? Queste<br />
diverse possibilità si trovano senza dubbio realizzate nella sua opera:<br />
occorre però in ciascun caso determinarne la portata. Non si può tuttavia<br />
fare a meno di ammirare l'enorme ricchezza di parole di Dio di cui fa<br />
uso. Altre volte Bernardo filtra, per così dire, i propri impulsi attraverso<br />
il linguaggio sacro. In molti punti afferma che si deve sperimentare quanto<br />
si legge nella Scrittura; ed è quanto egli fa: interiorizza fortemente<br />
in se stesso una quantità di versetti della Bibbia, li « vive» con intensità,<br />
e li fa suoi. Questo comporta evidentemente il pericolo, richiamato più<br />
sopra a proposito dell'affermazione di sé, di identificare la parola di Dio<br />
con le proprie aspirazioni, invece di conformare quest'ultime alle intenzioni<br />
degli autori ispirati. Non vi è mai nulla di assolutamente puro<br />
quando l'uomo si esprime per bocca di Dio. Ma, certamente, una delle<br />
fonti dell'energia spirituale di Bernardo deriva dalla convinzione di potersi<br />
appoggiare ad un' autorità che lo supera. .<br />
III. I VALORI CRITERI DELL'AZIONE<br />
Quest'ultima considerazione ci porta ad una constatazione alla luce<br />
della quale tutta la condotta di Bernardo si chiarisce e in parte si spiega;<br />
egli ha coscienza di avere un messaggio da annunciare, è convinto di dover<br />
servire realtà che lo superano; ossia dei valori, nel senso attribuito da<br />
molti filosofi e soprattutto psicologi a questa parola per designare dati<br />
oggettivi ritenuti preferibili alle vedute soggettive.<br />
1. La ricerca del senso<br />
Notiamo anzitutto che Bernardo è dotato di una straordinaria capacità<br />
ad interpretare in prospettiva religiosa, ed anche sacra, gli avveni-<br />
- 150-
menti e le circostanze della sua vita. Ciò appare fin dal Prologo alle<br />
omelie In lode della Vergine Madre} se - come sembra - è vero quanto<br />
afferma con tanta insistenza Guglielmo di Saint-Thierry, nel libro I della<br />
Vita prima) sulla predilezione che la madre di san Bernardo, Aleth, aveva<br />
per lui, e sull'attaccamento che egli le conservò anche dopo la morte, avvenuta<br />
quando aveva quattordici o quindici anni. Nei primi tempi del suo<br />
abbaziato è costretto dalla malattia a curarsi o a riposarsi al di fuori della<br />
vita comune, e questo gli offre « un po' di tempo libero »: gli « piace»<br />
pertanto - libet - per « soddisfare alla propria devozione» cedere ad<br />
un impulso tante volte percepito dal suo spirito - quod saepe animum<br />
pulsavit - parlando della Vergine Madre 43. Vien spontaneo chiedersi, da<br />
un punto di vista psicologico, se un temperamento cosi forte, cosi autonomo,<br />
non sentisse un bisogno di dipendenza affettiva, come quella di<br />
un figlio verso la madre, quando tra loro vi siano stati dei rapporti come<br />
quelli descritti da Guglielmo di Saint-Thierry: Aleth aveva desiderato per<br />
lui quella totale donazione a Dio che l'aveva condotto nella solitudine<br />
di Citeaux; ed eccolo, ora, temporaneamente al di fuori della comunità,<br />
e solo con Dio. Si potrebbe cosi comprendere come egli abbia considerato<br />
questa situazione contingente come una esperienza spirituale, alla quale<br />
dare un senso mettendola in relazione con la Madre di Dio.<br />
Uguale insistenza sulla « devozione », sullo « zelo per la preghiera »,<br />
è presente nella lettera indirizzata a Guglielmo di Saint-Thierry che gli<br />
aveva chiesto di scrivere l'Apologia 44. Ma anche qui, come nella prima<br />
pagina di questo stesso trattato, riemerge la necessità che egli prova di<br />
dare una interpretazione ai fatti, alle richieste degli amici, e di cogliervi<br />
altrettanti segni della volontà di Dio alla quale non può rifiutare di sottomettersi<br />
4S.<br />
Nei due Prologhi citati, ha affermato la priorità che ritiene doversi<br />
accordare alla preghiera. All'inizio delle omelie sulla Vergine Madre,<br />
egli rende esplicito un altro suo criterio decisionale, altrove sempre implicito,<br />
che consiste nel servizio dei fratelli: fratrum quorum me profectibus<br />
deservire necesse est 46. Parimenti nel Prologo alla lettera 77, in<br />
forma di Trattato sul Battesimo) in risposta alle domande postegli da<br />
Ugo di San Vittore, afferma di volersi comportare da « servo di Dio» 47.<br />
Se accetta di scrivere, non lo fa per compiacere ad un amico, maestro pur<br />
43 S. Bernardi opera, IV. p. 1.3.<br />
44 Ibid., III, p. 64.<br />
4S Ibdi., p. 82.<br />
46 Ibid., p. 13.<br />
47 Ibid., VII, p. 184.<br />
- 151-
degno di rispetto, ma perché il desiderio di servire è profondamente radicato<br />
in lui.<br />
2. Il bisogno di superamento<br />
Il primo valore al quale si consacra è l'amore di Dio che si esprime<br />
nella preghiera e che costituisce non l'oggetto di una conoscenza speculativa<br />
ma una realtà vissuta, una esperienza; trattarne è quanto si può<br />
fare ad un tempo « di più dolce, di più sicuro e di più utile », come<br />
l'esprimono tre comparativi assoluti nel Prologo del trattato Sull'amore<br />
di Dio 48. Bernardo pone quest'amore al di sopra di tutto, ma vi coglie<br />
altresì il mezzo per realizzare pienamente il proprio io, realizzarsi superandosi.<br />
Ciò non si attua con le sole proprie forze: è necessaria la grazia,<br />
che dev'essere implorata per lui. Nella seconda redazione del sermone<br />
24 Sul cantico dei cantici - un vero prologo scritto dopo un lungo<br />
intervallo a causa di un soggiorno a Roma in occasione dello scisma -,<br />
Bernardo ripete che è « debitore» agli altri, che « vive dei loro meriti »,<br />
che egli può continuare a servire solo « se Dio rispondendo alla sua fedele<br />
supplica, gli concede di dare anche quello che non ha »49. E molto<br />
spesso, nel corso di questa grande opera, domanderà che si preghi perché<br />
la possa condurre a buon termine. Questo procedimento era conforme alla<br />
tradizione patristica; ma qui sembra esservi qualche cosa di più di un<br />
tema letterario: la convinzione che Bernardo ha di non realizzarsi interamente<br />
se non aprendosi a ciò che è al di sopra di lui.<br />
Ancora una volta egli mira ad integrare le esperienze ecclesiali compiute<br />
nell'unità della sua vita d'unione a Dio e della sua riflessione contemplativa.<br />
E si intuisce anche che il bisogno che prova di parlare continuamente<br />
della sua scarsa capacità di scrivere non è un semplice artificio:<br />
umiliandosi, facendo professione di modestia, stabilisce in sé una<br />
certa coerenza tra la sua timidezza e il suo bisogno di dominare, tra una<br />
vita di intensa attività e l'aspirazione alla contemplazione. Con questa<br />
forma di ascesi, che rimedia ad una sorta di tensione e perfino di contraddizione<br />
interna, egli non cessa di rifare la sintesi di se stesso: non può<br />
vivere in perpetuo conflitto con gli altri; ha bisogno di unità che ricerca<br />
e trova in Dio.<br />
48 Ibid., III, p. 119.<br />
49 Ibid., I, Roma 1957, p. 151.<br />
- 152-
3. Verso la maturità dell' età adulta<br />
Tale unità ottenuta con il superamento costituiva già il tema dominante<br />
del primo dei Sermoni sul Cantico: «la saggezza umana », spiegava,<br />
non è sufficiente a dare un significato all'esistenza di coloro che<br />
« si occupano di Dio » e passano la vita a « meditare la sua legge » so.<br />
Quest'uomo il cui stile rivela insieme il taglio dell'artista e la passione<br />
per ilbello, ha il coraggio di far passare in seconda linea e le lettere e la<br />
conoscenza intellettuale di Dio. L'intero sermone d'introduzione diviene<br />
un canto che esalta le meraviglie di Dio, e che scaturisce, con una<br />
convinzione che non può essere finta, dalla riconoscenza, dalla gioia,<br />
dall'esperienza di una personalità totalmente aperta ai valori più alti; il<br />
suo è un desiderio di « esperienza»; a lettori ormai adulti, capaci di nutrimento<br />
solido, vuol insegnare a compiere, per cosi dire, il salto dalla conoscenza<br />
alla vita vissuta. Vien fatto di chiedersi se lui stesso abbia realizzato<br />
questo programma, o quanto meno abbia capito che questo era il<br />
punto centrale al quale avrebbe dovuto tendere tutto il suo insegnamento.<br />
A questo proposito ha formulato in maniera perfetta quella legge di psicologia<br />
secondo la quale« l'età matura» - perjecta aetas - che succede<br />
allo stadio infantile dell' anima puerilis, non si raggiunge solo con il passare<br />
degli anni, ma si acquista al prezzo di una esperienza interiore, fatta<br />
di sforzi e di meriti: annos dico meritorum, non temporum SI.<br />
In questo primo sermone Bernardo aveva già indicato un frutto di<br />
questa maturità: essa sola consente di affrontare senza pericolo la lettura<br />
e il commento di questo «canto epitalamico », di questo «canto<br />
nuziale» che è il Cantico dei cantici. Essa sola rende possibile la sublimazione<br />
con la quale potrà, in tutta l'opera, parlare senza vergogna né colpa<br />
delle gioie dell'amore umano ed elevarsi, da esse, alla contemplazione del<br />
mistero della carità.<br />
Altro indice della maturità è quel senso di libertà che conserva nei<br />
confronti di quanto si pensa di lui, sia esso in bene o in male. Nel primo<br />
caso - come nella lettera 87 al canonico Ogiero - sa ricondurre a giuste<br />
proporzioni le lodi rivoltegli 52. Nel secondo, gli basta sapere di aver<br />
agito secondo coscienza per accettare, senza scoraggiarsi, le critiche che<br />
gli vengono mosse: cosi si comporta all'inizio del secondo libro della<br />
Considerazione, a proposito di coloro che l'accusano d'aver causato lo<br />
so Ibid., p. 3-8.<br />
51 uu., p. 8.<br />
52 Con il titolo Le tbème de la jonglerie cbez S. Bernard et ses contemporains, in<br />
Reoue d'bistoire de la spiritualité, 48, (1972), p. 385-399, ho analizzato la lettera 87.<br />
- 153-
smacco della seconda crociata 53. Talvolta prevede le critiche tutelandosi<br />
in anticipo, come nel Prologo del Libro dei cavalieri del Tempio, in lode<br />
della nuova milizia: «Se vi è qualcuno al quale ciò non piace, o pare insufficiente,<br />
questo non riguarda la mia volontà, che non ha fatto torto<br />
alla tua, nei limiti delle mie conoscenze» 54. Ciò che lo « interessa» è di<br />
mettersi a disposizione del suo amico e parente Ugo di Payns, maestro dei<br />
Templari; la sua fama di scrittore passa in seconda linea. Parimenti nel<br />
I sermone sul Cantico afferma di credere alle istanze di un amico, che<br />
noi sappiamo essere il certosino Bernardo di Portes 55. E all'inizio della<br />
seconda redazione del sermone 24, dopo l'interruzione causata dal terzo<br />
viaggio a Roma, protesta nuovamente la sua incapacità a continuare a<br />
scrivere intorno ad un soggetto sublime dopo essere stato assorbito da<br />
preoccupazioni diverse e molto meno importanti 56. Vi è senza dubbio in<br />
tutto questo una parte di modestia apparente, divenuta tema letterario.<br />
Ma nulla proibisce di riconoscervi anche una parte di sincerità: è prova<br />
infatti di maturità riconoscere i propri limiti e attribuire maggior valore<br />
alla retta volontà anziché alla competenza.<br />
IV. L'INTEGRAZIONE DEI BISOGNI AI VALORI<br />
1. Progresso precoce e mai finito<br />
Gli aspetti finora rilevati potranno forse aiutarci a formarci un'idea<br />
esatta di ciò che fu, per Bernardo di Clairvaux, la santità. Non si tratta<br />
di sapere se si è fatto bene a canonizzarlo oppure no. In tutte le Chiese<br />
la dichiarazione ufficiale della santità, da quando viene praticata, risponde<br />
parzialmente a criteri sociologici, e talvolta politici, in base ai quali si<br />
valuta la parte avuta da cristiani e da cristiane, e non soltanto per il fatto<br />
che le loro virtù sono ritenute in grado eroico (senza pecca) ", « Un tempo<br />
», ha scritto per esempio Evdokimov, « i Principi santi venivano canonizzati<br />
non in virtù della loro santità personale, ma per la loro fedeltà ai<br />
carismi del potere reale esercitato al servizio del popolo cristiano » 58. Nel<br />
53 S. Bernardi opera, III, p. 410-413.<br />
54 uu.. p. 213.<br />
S5 Cf. Recuieil d'études sur S. Bernard, I, p. 194-196.<br />
56 S. Bernardi opera, I, p. 151.<br />
57 Cf. P. DELOOZ, Sociologie et canonisations, La Haye 1969, e il resoconto che ho<br />
fatto di altri lavori dello stesso autore, con il titolo: Deux nouueaux Docteurs de<br />
l'Eglise, in La vie spirituelle, 123 (1970), p. 136-138.<br />
58 P. EVDOKIMOV, L'amour fou de Dieu, Paris 1973, p. 134.<br />
- 154-
caso di Bernardo, gli stessi contemporanei, essendo evidente quanto egli<br />
compiva sotto i loro occhi, hanno ritenuto che si comportasse in conformità<br />
ai suoi carismi, di portata eccezionale, come monaco, abate e uomo<br />
di Chiesa. Non solo, ma tutto il suo insegnamento orale e scritto trasmetteva<br />
al suo tempo e alla posterità un programma di santità: è chiaro<br />
che in questa prospettiva lo si doveva canonizzare.<br />
Ma come ha vissuto lui stesso questo programma, e con quale consonanza<br />
tra la virtù privata e l'attività pubblica? Questa è la domanda<br />
che si pone a conclusione di una ricerca di verità che tenta di discernere<br />
la realtà del santo attraverso l'immagine che ci è stata data di lui<br />
o che è stata ricavata dalla sua dottrina. È a questo sforzo che una certa<br />
analisi psicologica può contribuire, discernendo al di là delle idee espresse,<br />
gli impulsi e le motivazioni profonde. Ora appare abbastanza chiaro<br />
che in tutta la sua vita siano coesistite passioni umane accanto ad una<br />
evoluzione durante la quale non cessò di purificarsi e quindi di progredire,<br />
secondo una formula da lui stesso adottata e che D. Knowles<br />
gli applica: « In virtù o in amore nessuno rimane mai lo stesso; non avanzare<br />
significa retrocedere» S9. Lo stesso storico aggiungeva: «San Bernardo,<br />
nel 1150,non è più ilBernardo del 1120;nel giovane abate possiamo<br />
scoprire eccesso, esagerazione, violenza, retorica; ma nei confronti<br />
del santo giunto alla sua maturità il nostro giudizio dovrebbe farsi<br />
molto circospetto » (J().<br />
In realtà :fin dai suoi primi scritti egli presenta ad un tempo i segni<br />
di un temperamento portato alle forme estreme e prove di equilibrio<br />
nelle idee. E lo stesso fatto si riscontra nelle opere dei suoi ultimi anni,<br />
come la Considerazione. Lui stesso, come abbiamo notato, insegnava<br />
che la maturità proviene dall'esperienza interiore più che dal numero degli<br />
anni. È il frutto di una lotta costante, che può essere iniziata precocemente<br />
ma che non si esaurisce mai. Per tutta la vita è stato un uomo<br />
battagliero, che ha conosciuto smacchi e successi, sofferenze e gioie.<br />
Ancora adolescente è in lutto per sua madre; ormai giovane riesce a<br />
convertire i suoi parenti all'osservanza cistercense; giovane abate subisce<br />
la delusione di vedere il cugino Roberto preferire Cluny a Citeaux e<br />
Arnoldo di Morimond essere infedele a quello che considera come l'unico<br />
modo legittimo di essere fedele a una vocazione. E forse negli ultimi<br />
anni le pene si fanno ancor più pesanti con il tradimento del suo notaio<br />
S9 D. KNOWLES, Tbe Historian and Cbaracter and Otber Essays, Cambridge 1963,<br />
p. 7. ~ , i":<br />
60 D. KNOWLES, op. cit., p. 8. " ..<br />
- 155-
preferito, Nicola di Montieramey, l'insuccesso della crociata, i contrasti<br />
tra lui e il suo vecchio discepolo Eugenio III, infine la morte di molti<br />
suoi parenti ed amici. Ma queste tristezze non gli impediscono di conservare<br />
quella gioia ardente che si manifesta, ad esempio, negli ultimi<br />
Sermoni sul Cantico.<br />
Soltanto un esame minuzioso di tutti i suoi scritti e di quelli che lo<br />
riguardano, seguendo l'ordine cronologico - per quanto è possibile conoscerlo<br />
- autorizzerebbe a dire se è possibile stabilire, e in che senso,<br />
una evoluzione nello sforzo di conciliare il suo temperamento con il suo<br />
ideale. Nell'attesa che venga intrapresa quest'ampia analisi, era legittimo,<br />
in questa sede, seguire un ordine cronologico approssimativo - come<br />
nella prima parte di questa esposizione - e condurre la ricerca su un<br />
certo numero di comportamenti che simbolizzano tutta la sua condotta,<br />
considerati da diversi punti di vista e in campi diversi. In tal modo è<br />
stato possbile suggerire una certa evoluzione, ideale o logica, che va<br />
dalla constatazione di conflitti interiori al loro superamento in funzione<br />
di valori sopra-individuati. Era necessario soprattutto che ogni osservazione<br />
o interpretazione si appoggiasse su testi ben precisi. Ora, dopo<br />
aver proceduto ad una specie di smantellamento dell'insieme psicologico,<br />
letterario e spirituale, costituito dalla testimonianza di Bernardo su se<br />
stesso, è ormai tempo di tentare la ricostruzione della sua personalità.<br />
2. Bisogni e motivi<br />
Nel tentativo di cogliere come si organizzi la personalità di Bernardo,<br />
sembra di poter distinguere tre livelli. A quello che maggiormente gli<br />
sta a cuore, ed in tal senso si può designare come superiore, si collocano<br />
i valori da lui coscientemente professati: stima per il modulo di vita cistercense,<br />
zelo della Chiesa ed impegno al suo servizio, carità che ispira<br />
il desiderio di dare ad ognuno i consigli spirituali adeguati, amore di<br />
Dio e bisogno di preghiera. Tali motivazioni ed altre dello stesso genere<br />
s'ispirano direttamente ai principi del Vangelo, cosi spesso citato: sete<br />
di giustizia e volontà di far del bene agli altri. Questo è il livello spirituale,<br />
quello in cui, in definitiva, si raggiunge la santità.<br />
A livello psicologico, - che, in se stesso, non ha nulla a che vedere<br />
con la santità - si rileva in Bernardo un certo numero di bisogni spontanei<br />
(needs), di spinte di temperamento (drives), che si possono ricondurre<br />
ad una tendenza aggressiva e ad una propensione a dominare.<br />
A un livello intermedio operano due meccanismi di difesa con l<br />
- 156-
quali Bernardo cerca di giustificare i suoi bisogni accordandoli con i<br />
suoi motivi: è l'intero campo della razionalizzazione delle tendenze,<br />
dello sforzo che si compie per giustificarne le manifestazioni, ed è, per<br />
conseguenza, quello dell'ascesi delle intenzioni. In ciò occorre lucidità e<br />
coraggio; la prima è questione di umiltà, e il secondo di distacco da se<br />
stesso: è necessario superarsi per azzardarsi ad una azione conforme ai<br />
principi che si professano.<br />
Se il livello spirituale è quello in cui si accede alla santità, se quello<br />
psicologico offre il materiale da utilizzare per giungervi, il livello delle<br />
giustificazioni ragionate e volute è quello in cui la grazia e lo sforzo umano<br />
si congiungono nel tentativo di dominare, domare, purificare ed unificare<br />
le tendenze spontanee, anarchiche e inconscie. Ma è anche quello<br />
in cui può introdursi l'illusione di legittimare con principi presentati come<br />
oggettivi i bisogni di un temperamento. Si può dire che è il campo in<br />
cui si realizza veramente la lotta per la santità: si tratta di passare, per<br />
così dire, dall' aggressività alla passione, o se si preferisce, dalle passioni<br />
umane a una grande passione per Dio e per la sua opera nel mondo, passione<br />
che, a sua volta, ingloberà ed utilizzerà tutti i dinamismi psichici<br />
di un uomo di carne e di sangue, integrandoli all'ideale che si è prefisso.<br />
3. Un uomo di Dio che resta uomo<br />
Ha saputo Bernardo realizzare questa integrazione? La risposta non<br />
può essere semplicemente affermativa o negativa, ma implica delle sfumature.<br />
Dopo un esame oggettivo, il più imparziale possibile, di molti<br />
suoi comportamenti - in attesa che si compia per tutti - sembra di<br />
poter concludere che Bernardo ha realizzato questa integrazione, ma<br />
con le due riserve seguenti: anzitutto non fu spontanea ma richiese uno<br />
sforzo continuo; inoltre non fu mai completamente raggiunta. In questo<br />
campo infatti non si può mai parlare di successo totale e assoluto: la<br />
riuscita consiste nello sforzo; e suppone altresì la coscienza e l'accettazione<br />
dell'insuccesso. Ed è quanto si verifica in Bernardo.<br />
Era perfettamente cosciente di non essere affatto perfetto: non solo<br />
lo sapeva, ma lo diceva, lo scriveva, perché voleva che lo si sapesse. E noi<br />
comprendiamo quanto questa confessione fosse necessaria: fino ai nostri<br />
giorni le sue opere sono giudicate ammirevoli; sarebbe stato sorprendente<br />
che lui stesso ignorasse il suo talento. E qualora si fosse verificato,<br />
l'insistenza dei contemporanei nel lodare il suo stile e il suo pensiero lo<br />
- 157-
avrebbe reso ugualmente consapevole 61. Inoltre non poteva evitare di<br />
constatare di essere stimato, e, cosa alla quale ogni uomo è ancor più sensibile,<br />
di essere amato: molte testimonianze in questo senso sono già state<br />
raccolte. Goffredo d'Auxerre, che l'aveva bene conosciuto, ed aveva assistito<br />
a molte sue predicazioni reali - e non solo trascritto i suoi sermoni<br />
ormai redatti - testimonia la sua tendenza ad essere radicale: alla<br />
tiepidezza, Bernardo preferiva il fervore o magari la freddezza 62. E tuttavia<br />
era sempre incoraggiante, pieno di bontà, di accondiscendenza e<br />
di gioia 6J. Ed era apprezzato se non da tutti certo da molti, ed in ambienti<br />
molto diversi. Abbiamo la prova che sapeva mantenersi distaccato<br />
dal giudizio che gli uomini davano di lui 64.<br />
Molti anni prima della sua morte, veniva considerato come un santo,<br />
tanto che si decise di far scrivere la sua vita a sua insaputa, nec ipso<br />
sciente. Ma se lo avesse saputo, che ne avrebbe pensato? In altre parole,<br />
Bernardo di Clairvaux sapeva di essere san Bernardo? Non poteva certo<br />
ignorare di essere un grande scrittore, un grande abate, un grande uomo<br />
di Chiesa. Ma pensava fors'anche di essere grande nell'ordine della santità?<br />
No certamente se ciò suppone l'assenza di tentazioni o di errori:<br />
ne ha parlato pubblicamente, a proposito di se stesso, delle une e degli<br />
altri 6S. Forse avrebbe approvato il giudizio dato su di lui da un gruppo<br />
di psicologi che hanno lavorato sui suoi testi. A uno di questi che, riferendosi<br />
specialmente al suo modo di reagire nel Cantico dei cantici, affermava:<br />
«È uomo al cento per cento », ho chiesto: «È anche un santo?<br />
», e la risposta affermativa fu unanime. Ho insistito: «Ma è santo<br />
al cento per cento? ». E il primo interlocutore in risposta, senza esitazio-<br />
61 In Etudes sur S. Bernard, Roma (Analecta S. Ord. Cist., IX, 1-2) 1953, p. 123-<br />
124, e Recueil d'études sur S. Bernard, I, p. 350-351, ho raccolto qualche loro testimonianza.<br />
62 Citato da F. GASTALDELLI,Ricerche su Goffredo d'Auxerre, Roma 1970, p. 156-157.<br />
63 Alle testimonianze da me citate in questo senso con il titolo S. Bernard et<br />
la dévotion ioyeuse, in S. Bernard bomme d'Eglise, Paris 1953, p. 238-240, si possono<br />
aggiungere quelle di GUGLIELMODI SAINT-THERRY,Vita prima S. Bernardi, c. I, p. 33,<br />
P.L., 185, 246: «modo illo suo generoso arridens nobis »; CLAREMBALDOn'ARRAs:<br />
«jucundae recordationis abbas Bernardus », citato da H. VAUPEL, Clarembaldus von<br />
Arras und Water von Mortagne, in Zeitschrift fur Kircbengescbicbte, 65 (1953-.1954'f<br />
p. 134; GOFFREDOD'AuXERRE,Super Apocalypsim, VII, ed. F. GASTALDELLI,Roma 1970,<br />
p. 116, 115: «Quam dulcissime nobis pater noster Bernardus dum adviveret ... »; Godescalco,<br />
abate dei Premostratensi di Seelan, in diocesi di Praga, in una lettera in cui,<br />
nel 1184, riferisce al Capitolo di Citeaux su una visione che ha avuto: «Cum ecce<br />
subito flos et gemma ordinis vestri, sanctus Bernardus, quem nunquam in carne videram,<br />
hilariter apparuit et instrumenta duorum baculorum, quos cruccas vocant, ostendit,<br />
quibus suffultus, eum intra iucundissirnum palatium secutus sum ... »,<br />
64 Si veda la lettera 87 e l'articolo citato più sopra par. III n. lO.<br />
6S SU queste tentazioni, Aspects du monacbisme, loc. cit.; nella lettera 70, Bernardo<br />
confessa un violento scatto di collera: cf. Etudes sur S. Bernard, p. 190-191, e Recueil<br />
d'études sur S. Bernard, II, Roma 1966, p. 319-326.<br />
- 158-
ne: « Al cento per cento ha la volontà di esserlo ». Ora non è forse questo<br />
che conta, agli occhi di Dio e di coloro che cercano di giudicarlo come<br />
farebbe Dio? E in qual misura ha realizzato questo suo fermo volere? È<br />
il segreto di Dio. Quanto' a lui, la prova della sua santità sta senza dubbio<br />
nel fatto che non ha mai affermato di esservi pervenuto.<br />
Se qualche volta ha ceduto all'ironia e perfino al sarcasmo nei confronti<br />
degli altri, non ha mancato spesso di manifestare dell'humour verso<br />
se stesso. Gli storici dovrebbero conservare lo stesso atteggiamento nei<br />
loro giudizi. Constatando la sua abilità nelle manovre politiche, il talento<br />
letterario che poneva al suo servizio, sono portati ad essere severi nei<br />
suoi confronti, a diffidare dei motivi che egli diceva puri: lo erano in<br />
realtà? Era così staccato, così libero di spirito, come affermava? Dio solo<br />
lo sa. Egli ha certamente parlato bene della purezza d'intenzione, ha<br />
messo tutto il suo impegno nel raccomandarla agli altri; ha tutta una<br />
dottrina su questo argomento. Ma in che misura l'ha praticata? C'è<br />
sempre stata coerenza tra la sua dottrina spirituale, le attitudini psicologiche,<br />
la condotta politica, e le sue idee? Non oseremmo affermare che sia<br />
sempre avvenuto così.<br />
Ma questo parziale insuccesso gli impediva forse di essere insieme<br />
un peccatore e un uomo giustificato? In certi casi si è compiaciuto ad<br />
esprimere la sua collera non meno che il suo zelo per gli interessi del Signore<br />
e della Chiesa, ed era quello per lui un mezzo di confermarsi nella<br />
convinzione che serviva una causa giusta: salvo il caso in cui se ne pentiva<br />
- come nei confronti del suo fratello Bartolomeo, secondo la testimonianza<br />
della lettera 70 -, dà l'impressione che le sue collere siano controllate,<br />
e perfino volute; sono mezzi per lui di raggiungere lo scopo.<br />
Forse nella lotta era poco scrupoloso sui mezzi da utilizzare. Ora, è sufficiente,<br />
per essere un santo, avere delle rette intenzioni ordinate alla<br />
carità? Si può avere nello stesso tempo il cuore puro e le mani sporche?<br />
Più d'uno storico pensa che quelle di Bernardo non siano sempre state<br />
pulite, e senza dubbio, se avesse conosciuto ciò che sanno gli storici, ne<br />
avrebbe convenuto: avrebbe ammesso di non essere sempre stato sufficientemente<br />
informato sui fatti, le circostanze, le dottrine, le persone. Ma<br />
il santo è forse necessariamente un essere perfettamente equilibrato e<br />
un cristiano che non commette peccato, supposto che un tal uomo sia<br />
mai esistito, salvo il caso unico in cui Dio si era unito a lui personalmente?<br />
Non osiamo qui richiamare il mistero delle collere di Gesù, di<br />
colui che, solo, fu completamente santo: quoniam tu solus sanctus, tu<br />
solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Cbriste.<br />
E se vi è eccesso, ad esempio, nel modo in cui Bernardo ha identi-<br />
- 159
ficato la volontà di Dio con la propria, non vi sono forse anche delle<br />
attenuanti? Non era forse stato a lungo superiore, in un tempo in cui<br />
l'esercizio dell'autorità implicava questo pericolo, più ancora che in altre<br />
epoche? Il suo autoritarismo non deve far dimenticare il suo spirito di<br />
servizio, non meno che la sua aggressività i numerosi casi in cui ha riportato<br />
la pace. E, nell'insieme, non dovremmo forse leggere i suoi scritti<br />
ricollocandoli in un contesto storico di cui faceva parte una certa intolleranza,<br />
o, come diremmo oggi, un certo integralismo? La santità si riconosceva<br />
in quel tempo soprattutto nella realizzazione di grandi cose; e<br />
questo lo ha fatto. Per esempio, la sua opera di fondatore di monasteri<br />
non scaturiva forse da un bisogno di realizzazione, di perfezione, e dal<br />
suo fascino personale, anziché dalla sua aggressività e dalla tendenza a<br />
dominare, ad influenzare? Possiamo solo azzardarci a porre domande<br />
simili, la cui risposta ci sfugge come sfuggiva a lui. Ci troviamo qui infatti<br />
ai confini imprecisi che uniscono e distinguono la personalità umana<br />
e la santità, che è dono dello Spirito Santo. La personalità, in Bernardo, è<br />
forte, e si può anche affermare che è retta; e ne presenta tutti gli indizi:<br />
fiducia in se stesso, autonomia e libertà nei confronti dell'ambiente, capacità<br />
di decisione e di iniziativa, coscienza dei propri limiti, intuizione<br />
dei bisogni del mondo, facoltà di interessarsi ai più diversi problemi e<br />
tutti parimenti elevati. In verità il bilancio è positivo: vi sono più luci<br />
che ombre.<br />
E tuttavia, tra salute psichica e santità sussiste una zona che rimane<br />
oscura agli occhi degli uomini, una distanza mai superata che impedisce<br />
che una personalità, sia pur completamente sana, coincida con una vita<br />
cristiana interamente santa. San Bernardo ci insegna che si può essere un<br />
uomo di Dio senza cessare d'essere un uomo. Un santo può essere un<br />
uomo, o una donna, che è normalmente senza vizi, ma non senza difetti,<br />
né - e non bisogna temere d'ammetterlo - senza peccati. Il santo è<br />
un cristiano che resta un peccatore, nel modo singolare in cui ciascuno<br />
lo è con i suoi doni e i suoi limiti, la grazia del perdono che ha ricevuto,<br />
la forma d'umiltà che gli è stata accordata a prezzo di umiliazioni che<br />
restano il suo segreto. Se Bernardo ha posseduto questa umiltà, la sua<br />
relazione con Dio è perfetta. Quello stesso Dio che lo ha fatto aggressivo<br />
lo ha reso anche umile, non senza che lui stesso si sia sforzato di divenire<br />
meno aggressivo e più umile. Chi oserebbe pronunciarsi su questo<br />
mistero?<br />
La tradizione insegna che la santità suppone l'unità, ma non sopprime<br />
i contrasti e che ha il suo culmine nell'umiltà, non nella « grandeur<br />
». Un monaco siriano del VII secolo, Isacco di Ninive, ha scritto:<br />
- 160-
« Colui che riconosce i suoi peccati è più grande di chi risuscita un morto<br />
... Colui che riconosce la propria debolezza è più grande di chi vede gli<br />
angeli. Colui che, solitario e contrito, segue il Cristo è più grande di chi<br />
gode del favore delle folle nelle chiese ... »66 Bernardo aveva conosciuto<br />
l'applauso delle folle; aveva spesso ricevuto l'approvazione dei grandi. Ma<br />
ciò per cui ha mostrato di essere un santo, fu la conoscenza delle proprie<br />
deficienze e la confessione delle proprie debolezze, e la sua fedeltà nel<br />
seguire il Cristo, malgrado queste.<br />
66 ISACCO DI NINIVE, Discorsi, 34.<br />
(Sono grato a Velerio Cattana per la traduzione italiana di questa relazione).<br />
- 161-
JEAN DE LA CROIXBOUTON,O.C.S.O.<br />
STORIA DELL'ORDINE CISTERCENSE<br />
(ventunesima puntata)<br />
L'INSEGNA DELLO SPIRITO DEL SECOLO<br />
Dopo le difficoltà talora durissime degli inizi, la maggior parte<br />
delle abbazie furono in grado di equilibrare pressappoco le loro esigenze<br />
con le loro risorse. « In tal modo si raggiungeva quell'ideale di<br />
ricchezza senza profitto, di proprietà di tutto riposo e nello stesso<br />
tempo quella libertà di azione che era necessaria alle opere di carità,<br />
che costituiscono lo scopo essenziale della missione dell' abbazia»<br />
(R. FOSSIER, L'esser économique de Clairvaux, in « Bernard de Clairvaux<br />
», p. 114). Tuttavia è raro che questo ideale e un tale equilibrio<br />
abbiano resistito per molto tempo. Se i soccorsi agli infelici e le opere<br />
di carità sono sempre stati l'onore delle abbazie, di ciò non sopravvive<br />
un gran che avanti la fine del secolo XIII, per il fatto che un gran numero<br />
di monasteri erano recidivi negli inconvenienti già lamentati per<br />
l'abbazia di Molesme e si trovavano irretiti negli affari secolari. Le<br />
cause di un tale regresso sono molteplici. Se ne possono individuare<br />
principalmente tre: 1) la gelosia suscitata propriamente dai successi<br />
dei cistercensi, che si traduceva in processi e rivendicazioni senza fine;<br />
2) la sete di guadagno che s'insinuava in seno all'Ordine; 3) la sensibilissima<br />
diminuzione del numero dei conversi che gettò le abbazie<br />
in preoccupanti imbarazzi.<br />
CONTESTAZIONI E PROCESSI<br />
E' un fatto ovunque constatato che gli eredi degli antichi benefattori<br />
delle abbazie, sia perché spinti dalle strettezze a seguito di guerre<br />
e di crociate, sia che fossero invasati dalla cupidigia di ricuperare delle<br />
terre di cui il lavoro cistercense aveva decupletato il valore, si diedero<br />
le mani d'attorno per contestare le donazioni fatte dai loro antenati.<br />
Alle numerose donazioni che riempiono i «cartari» del secolo XII<br />
e della prima metà del XIII fa seguito una caterva di cause giudiziarie<br />
(« querellae », « contestationes ») riguardanti sia la legittima proprietà<br />
dei terreni, sia la loro delimitazione.<br />
Talvolta questo clima di controversia si è manifestato prestissimo.<br />
Per ciò che riguarda il monastero di La Ferté, nel solo periodo<br />
- 162-
incluso fra gli anni 1160-1178 si contano 22 contestazioni provenienti<br />
dai villici e 16 avanzate dai nobili. Tutti i cartari danno testimonianza<br />
della rarefazione delle elemosine (che a partire dal secolo XIII vengono<br />
elargite di preferenza agli Ordini Mendicanti) e del moltiplicarsi dei<br />
processi e delle contese. Citeaux ha delle difficoltà a proposito di Corcelles<br />
(1214-1221), di Blaisy-Haut (1228), di Tarsul (1228-9), della·<br />
Melleroye (1229-33) ecc. La Trappa viene coinvolta in processi negli<br />
anni 1202, 1210, 1213, 1230, 1235, 1244, 1247 ecc. Nel 1260, con<br />
il pretesto dei loro privilegi ed usanze, i cittadini di Rouen pretendono<br />
di poter impedire agli Abbati di Beaubec, Vaux-de-Cernay, Mortemer,<br />
Val-Ste-Marie e di Bonport di scaricare e vendere i loro vini a Rouen,<br />
nonostante una concessione reale della quale altrove gli Abbati predetti<br />
non avevano mai fatto uso (Registro degli «Olim », voI. 1, 484, 1).<br />
Nel 1263 il vescovo di Saìnt-Paul-Trois-Chàteaux chiede la protezione<br />
di Alfonso di Poitiers, conte di Tolosa, a favore dell'abbazia di Aiguebelle<br />
che era stata oggetto di molte ingiustizie e persino di rapine da<br />
parte dei vicini (Chartes d'Aiguebelle, p. 219). Nel 1269, il podestà<br />
di Senlis contesta ai monaci di Froidmont il diritto di fare un taglio di<br />
legname nella foresta di Hez con il pretesto che il re era intenzionato<br />
di farne eseguire uno da parte sua. Esempi di questo genere sono innumerevoli.<br />
LO SPIRITO DI GUADAGNO<br />
Senza dubbio la ricchezza acconsentiva di fare elemosine più abbondanti;<br />
di certo la riunione in gruppo delle particelle fondiarie non<br />
si poteva effettuare in genere se non a prezzo di denaro. Ciò non toglie<br />
che in molti casi i monaci diano l'impressione di essersi lasciati dominare<br />
dalla frenesia di possedere. Un esempio fra i molti: quello dell'azienda<br />
agricola monastica a « signoria» di Ouges, di proprietà dell'abbazia<br />
di Citeaux: «Fu nel 1202 che i <strong>Cistercensi</strong> ricevettero una<br />
prima donazione nel territorio di Ouges: una rendita di trenta sestari<br />
(antica misura per le granaglie) delle decime dei poderi; donazione che<br />
fu integrata nel 1218 con una analoga. Queste donazioni attirarono<br />
forse l'attenzione dei monaci di Citeaux sui vantaggi dei terreni di<br />
Ouges? Nel 1225 fecero acquisto della signoria. Durante i trentacinque<br />
anni che seguirono l'abbazia accrebbe il suo possesso in quel di<br />
Ouges grazie a dei doni, ma essa fece un solo scambio e gli acquisti<br />
furono rari.; Al contrario verso il 1260 ha inizio un periodo di vigorosa<br />
espansione ben organizzata ... e nel corso dei quarant'anni successivi<br />
Citeaux, con instancabile pazienza, acquista campo su campo».<br />
- 163-
(O. MARTIN-LoRBER, « Une communauté d'babitants dans une seigneurie<br />
de Citeaux aux Kll I« et XIVe siècles » in Ann. de Bourgogne, 1958,<br />
XXX, p. 19). 10 stesso avviene a Clairvaux (vds. l'opera di Arbois di<br />
Jubainville, pp. 288-298). Leditore dello Cbartrier ancien de Fontmorigny<br />
ha studiato i diversi modi di costituzione del possesso, modi che<br />
egli sintetizza in tre categorie: 1. donazioni (che possono essere «fra<br />
vivi », «gratuite », «onerose », «condizionate », «remunerative»,<br />
« testamentarie») 2. contratti (vendite a carattere perpetuo o temporaneo,<br />
scambi, enfiteusi acconsentite all'abbazia) e 3. privilegi (pp. 45-<br />
47). A Clairvaux, il primo acquisto risale al 1153, a Preuilly al 1167,<br />
a Fontmorigny al 1200 eccetera. I monaci acquistano! I Capitoli Generali<br />
si inquietano a causa di una tale malattia, e fino dal 1190 stigmatizzano<br />
questa « cupiditatem semper acquirendi qua impetimur » (n. l).<br />
Ormai è fatta proibizione di qualsiasi acquisto di terreni o di possedimenti<br />
immobiliari. Il divieto è ripetuto nell'anno successivo (1191,<br />
n. 42). Nel Capitolo del 1192 vengono inflitte due sanzioni (nn. 21 e<br />
51). Nuova proibizione di acquisti negli anni 1205 (n. 5) e 1206 (n. 9).<br />
Nel 1214 il Capitolo prende una decisione in forma solenne: «Anno<br />
ab Incarnatione MCCXIV Statutum est in Generali Capitulo, ut nullus<br />
audeat deinceps terras, vineas, furnos, vel molendina emere vel<br />
acquirere, nisi in puram eIeemosynam et soIlemnem donationem nobis<br />
donata fuerint» (n. 54). La decisione fu rinnovata l'anno seguente<br />
(1215, n. 65). Fu ritrattata nel 1216 (n. 2), ma ripristinata con delle<br />
attenuazioni nel 1229 (n. 4) e nel 1230 (n. lO) e promulgata ancora<br />
in forma solenne nel 1239 (n. 4), nel 1240 (n. 1) ecc. Il male era in<br />
tale stato di progresso che il Capitolo sembra non fosse più in grado<br />
di dominare le infrazioni.<br />
Quanto al commercio propriamente detto, esso pure era vietato.<br />
Per « commercio» non s'intendeva la vendita e lo scambio all'ingrosso<br />
dei prodotti dell'abbazia, come usa fare ogni produttore, bensì la vendita<br />
al dettaglio, che costituisce la forma di lavoro propria del commerciante<br />
a scopo di lucro (teoria alquanto ridicola: come a dire che<br />
nello scambio e soprattutto nella vendita all'ingrosso non si potessero<br />
realizzare cospicui guadagni! (nota del traduttore p. P.M.A.) ... Orbene,<br />
il Capitolo Generale dovette ben presto intervenire a proposito delle<br />
vendite di vino «al minuto», o «dettaglio». Nel 1190 l'Abbate di<br />
Tamié fu privato per 40 giorni dell'onore di occupare il suo stallo in<br />
coro e per 6 giorni messo « a colpa leggera », dei quali 1 a « pane ed<br />
acqua», per aver venduto una certa quantità di vino «ad brocam »,<br />
cioè « alla staffa », nelle sue fattorie (n. 36). Gli Abbati di Fontainejean<br />
e di Aubepierre furono ammoniti per lo stesso motivo dai Capitoli<br />
- 164-
del 1205 e 1206. Nel 1270 fu presa una decisione che ha del pittoresco:<br />
« Nessun membro dell'Ordine acquisti del vino per rivenderlo a prezzo<br />
maggiorato, nessuno osi prendere in affitto una casa per farvi vendere<br />
del vino, soprattutto a Parigi dove ha sede la fonte e l'eccellenza<br />
della scienza ecclesiastica e del potere regale, affinché lo specchio del<br />
nostro Ordine glorioso non appaia deturpato da macchie agli occhi di<br />
tali personaggi» (n. 8). Ciò che è detto del vino può esserlo anche di<br />
altri prodotti, e particolarmente della lana, oggetto di importanti contrattazioni<br />
(vds. R. A. DONKIN«T he disposal 01 Cistercian W ool in<br />
England and Wales during the twelfth Centuries » in « Citeaux in de<br />
Nederlanden », 1957, VIII).<br />
LA DIMINUZIONE DEI CONVERSI<br />
E' un fatto che non può essere messo in dubbio: l'economìa cistercense<br />
era basata principalmente sui conversi che gestivano le fattorie.<br />
Orbene, le loro vocazioni, che erano state tanto numerose nel<br />
secolo XII, si fecero rare nella seconda metà del secolo XIII. Fino dal<br />
1237 il Capitolo Generale autorizzò gli Abbati che avevano meno di<br />
otto conversi ad assumere dei secolari per i servizi delle cucine, ciò<br />
che fino allora era vietato. Tuttavia v'erano delle abbazie provviste di<br />
conversi molto numerosi. A Dunes, sotto il governo dell' Abbate Nicola<br />
di Bailleul (1232-1254) se ne contavano 284. Sotto l'Abbate Arnoldo<br />
di Ghistelle (1240-1273), l'abbazia di Villers ne aveva 300.<br />
Al contrario il monastero di Royaumont disponeva più di monaci che<br />
di conversi. E' comunque certo che il numero dei conversi fu in continua<br />
diminuzione dopo che il Capitolo Generale del 1274 generalizzò<br />
la disposizione presa fin dal 1237: «Essendosi constatato che al momento<br />
attuale l'Ordine soffre a motivo della carenza di fratelli conversi<br />
e che conviene d'altronde occupare quelli disponibili in mansioni più<br />
importanti e più dignitose, sarà permesso di utilizzare per i servizi<br />
culinari degli aiutanti laici di buona riputazione (n. 12). Si è spesso<br />
insistito sui disordini lamentati a carico dei conversi in un certo numero<br />
di abbazie (JAMES S. DONNELLYThe decline 01 tbe Medieval Cistercian<br />
Laybrotherhaod, New York, 1949, p. 95). E' ben vero che se<br />
fra i conversi si trovano religiosi di eminente virtù, vi si constata<br />
pure un certo numero di «soggetti dal temperamento feudale, indomabile,<br />
ribelle e persino violento» (J. CANIVEZ,Citeaux, col. 923). La<br />
loro formazione monastica aveva talvolta lasciato a desiderare. Agli<br />
albori dell'Ordine non era prescritta alcuna particolare condizione per<br />
diventare conversi, e sembra anche che non fosse stabilita un'età fissa<br />
- 165-
se non quella determinata per i monaci, cioè i 15 anni compiuti. In<br />
seguito si dimostrò maggiore prudenza e si richiese l'età di 18 anni nel<br />
1201 (e forse fin dal 1157, benché il decreto che porta tale data non<br />
faccia esplicita menzione dei conversi). La facilità con la quale i conversi<br />
venivano ricevuti, i crescenti bisogni delle coltivazioni dei terreni<br />
cistercensi, talora il desiderio, d'altronde molto umano, di favorire<br />
qualche infelice, fecero sì che si ammettessero nei monasteri dei conversi<br />
senza una vera vocazione religiosa. Il Capitolo Generale del 1224<br />
riporta un decreto che parla diffusamente delle aberrazioni alle quali<br />
talora si giunse: «non si ammetterà ad essere converso se non chi è in<br />
grado di compensare, nell'adempimento degli incarichi affidatigli, il<br />
lavoro di un salariato» (n. 1).<br />
Le cause della diminuzione dei conversi sono complesse: carenza<br />
di autentiche vocazioni religiose, l'attrattiva verso nuovi Ordini (i<br />
Domenicani, al contrario dei <strong>Cistercensi</strong>, avevano a quel tempo un<br />
grande numero di conversi), il moltiplicarsi dei certificati di liberazione<br />
dallo stato di servitù che offrivano ai servi della gleba ed ai contadini<br />
migliori condizioni di vita che essi non trovavano più nelle abbazie<br />
come nel secolo precedente; tutti questi motivi esercitarono un effetto<br />
negativo in relazione all'incremento delle vocazioni di conversi. Furono<br />
anche segnalati dei provvedimenti inibitori da parte dei Capitoli Generali<br />
con la conseguenza di proteste dei fratelli conversi, ed in particolare<br />
la proibizione di bere vino, sidro e birra nelle fattorie, ma<br />
solamente acqua. Infine fu posta in rilievo la preferenza data da certi<br />
Abbati, ai fini della coltivazione dei terreni, a degli imprenditori laici<br />
che ingaggiavano, per i lavori agricoli, dei servi. Fu questa la causa<br />
o la conseguenza della diminuzione dei conversi? In un'epoca in cui<br />
gli abitanti dele città strappano ai principi le libertà comunali e numerosi<br />
signori affrancano i loro servi, si resta sorpresi al vedere le<br />
abbazie cistercensi che vanno contro corrente. «La Chiesa in ritardo<br />
», fu scritto, facendo questa strabiliante constatazione: «è sintomatico<br />
che le ultime concessioni di affrancamento dalla servitù vengano<br />
concesse finalmente dalle abbazie fino allora restie e la cui opposizione<br />
talvolta cesserà solo per la minaccia di tumulti (« L'Alta<br />
Marna» op. cito p. 55). Senza dubbio non pochi «servi» si votarono<br />
volontariamente al lavoro nella abbazie (« si campa mica male<br />
sotto il pastorale degli Abbati »...) e gli archivi ci danno una esplicita<br />
conferma di donazioni di questo tipo. Ma non è raro il caso d'imbattersi<br />
in donazioni molto meno spontanee. Nel 1218 un tale Lorenzo<br />
di Béru fece dono all'abbazia di Reigny di tutti i suoi possessi in terreni<br />
e servitù ch'egli aveva nel territorio di Dornecy, in cambio di<br />
166 -
100 soldi, di due buoi e di una vacca. Episodi simili sono menzionati<br />
negli archivi di molte abbazie; ad esempio, in quelli di Pontigny, di La<br />
Ferté, di Maizières, tanto per limitarci alla sola Borgogna. C'è da dire<br />
che le abbazie accettavano il dono di servi con l'ovvia intenzione di<br />
restituirli alla libertà; nel frattempo però li utilizzavano per le opere<br />
agrarie. Nel 1280, Guido di Maligny, nobile cavaliere, cedette in assoluta<br />
proprietà ai religiosi di Pontigny la sua serva Ermengarda, detta<br />
«La Verduse» (« L'ortolana? »), unitamente ai figli ed alla loro futura<br />
posterità ... Nel 1295 gli stessi religiosi acquistarono, sempre da Guido<br />
di Maligny, la metà della signoria di Montigny, come pure dei forni,<br />
boschi e servi nel territorio di Souilly. Nel 1392 a Souilly si trovano<br />
ancora dei servi di Pontigny. E' peraltro doveroso aggiungere che nel<br />
1345 i monaci accordarono le lettere di sgravio dalla servitù ai loro<br />
servi di Montigny, ma l'abbazia teneva ancora dei servi giacché nel<br />
1366 ebbe luogo una transazione fra le abbazie di San Germano e di<br />
Pontigny in merito all'assegnazione dei rispettivi servi (Archivi Yonne,<br />
serie H, passim).<br />
LE OPERE DI CARITA', L'OSPITALITA' e L'ELEMOSINA<br />
Per apprezzare convenientemente il ruolo che le abbazie cistercensi<br />
ebbero in particolar modo nel secolo XIII, non conviene mantenersi<br />
nel quadro, un poco pessimista, delle precedenti considerazioni ed esposizioni<br />
di fatti. Anche se talvolta si lasciarono irretire dallo spirito secolare,<br />
i <strong>Cistercensi</strong> mai dimenticarono che la carità verso il prossimo<br />
costituisce la forma più tangibile del loto apostolato e che il duplice<br />
dovere dell'ospitalità e dell'elemosina era loro imposto in virtù dello<br />
stesso precetto domenicale, come appunto afferma il Signore in Matt.<br />
XXV, 35-43.<br />
Nel 789 Carlo Magno aveva rammentato a tutti i suoi sudditi laici<br />
e preti, vescovi e monaci, il loro dovere di provvedere all'istituzione,<br />
in varie località, di posti di accoglienza destinati agli ospiti, ai pellegrini<br />
ed ai poveri. Questa preoccupazione, spesso negletta dai laici, fu per i<br />
monasteri, fin dapprima dell'epoca carolingia, una tradizione già antica,<br />
consacrata in tutte le Regole monastiche antiche. Mons. Lesne cita in<br />
proposito numerosi esempi (vds. Les Eglises et les monastères centres<br />
d'accueil, d'exploitation et de peuplement, in «Hist de la Proprieté<br />
eccI. en France », voI. VI, particolarmente a p. 99 e sgg.). Noi ci limiteremo<br />
ad alcuni punti di riferimento nella storia dell'ospitalità monastica<br />
in Occidente.<br />
- 167-
L'OSPITALITA' BENEDETTINA<br />
S. Benedetto aveva espressamente ed a più riprese stabilita la<br />
condotta da tenere nei confronti degli ospiti (vds. Reg. capp. XXXI,<br />
LXII, LIII, LVI) e facendo menzione anche dei poveri e dei pellegrini<br />
(capp. LIII, LV, LXI). La « Concordia Regularum », composta<br />
da Benedetto da Aniano, riunì in un medesimo capitolo (LX, vds. Migne<br />
PL, 203, col. 1215-1224) tutti gli articoli sparsi qua e la nelle Regole<br />
monastiche dell'Oriente e dell'Occidente e riguardanti il modo di<br />
ricevere gli ospiti. Si tratta di un autentico «Codice dell'Ospitalità ».<br />
Queste opere di carità rivestirono tre modalità principali: 1. l'ospitalità<br />
che veniva concessa ai pellegrini ed agli ospiti di passaggio; 2. la distribuzione<br />
di elemosine agli indigenti; 3. l'istituzione di veri e propri<br />
ospizi che ebbero il nome di «xenodochia» o di «hospitalia», che<br />
erano ben distinti dalle residenzi conventuali e che erano rifugi permanenti<br />
riservati ai poveri ed ai pellegrini. Nel monastero c'era il portinaio<br />
- «senex sapiens », secondo la Regola di S. Benedetto -<br />
incaricato di ricevere chi stava arrivando e di effettuare tra di loro una<br />
prima selezione al fine di accertare una certa priorità da porre in atto<br />
nella distribuzione degli aiuti. La Regola confermava forse in germe la<br />
distinzione fra due servizi di ospitalità, inculcando in modo particolare<br />
la cura dei poveri e dei pellegrini « atteso che quando trattasi di ricchi<br />
il loro stesso rango è sufficiente a renderli degni di onore ». Comunque<br />
sia, la discriminazione fra ospizio dei poveri e foresterìa dei ricchi e dei<br />
nobili si notò nell'epoca carolingia. Lo storico di S. Ayoul riferisce circa<br />
la fondazione fatta a Rabias di un « hospitale nobilium » e d'un « xenodochium»<br />
per i poveri. Numerosi documenti comprovano resistenza<br />
della distinzione di questi due servizi, dei quali il primo era affidato al<br />
portinaio ed ai suoi aiutanti (è ilservizio della« porta », detta anche « porta<br />
dei nobili» o «cella degli ospiti »), il secondo all'ospitaliere (che soprintendeva<br />
all' «ospizio dei poveri» o «casa dell'elemosina»). La<br />
planimetria del monastero di San Gallo mette in evidenza la « cella degli<br />
ospiti» situata nella porzione settentrionale del convento, mentre la<br />
« casa dei poveri» è posta a sinistra, in posizione più maldestra. La<br />
« cella degli ospiti» era generalmente una costruzione ampia, tale da<br />
poter ricevere gli ospiti, il loro bagaglio ed i servitori. Si sa che a Cluny<br />
la parte della casa riservata agli uomini comprendeva 40 letti e 40 servizi<br />
igienici (latrinae). L'altra parte, dove prendevano alloggio le contesse<br />
ed altre dame, era fornita di 30 letti e 30 latrine (« cum latrinis XXX »),<br />
Nella « cella degli ospiti» soggiornavano anche i postulanti addetti al<br />
servizio di questo settore del monastero. Il « xenodochium » (casa dei<br />
- 168-
poveri e dei pellegrini) era una costruzione più modesta quantunque decente.<br />
Era qui, e non alla « porta» propriamente detta, che si faceva la<br />
distribuzione delle elemosine. Fra i poveri, gli uni se n'andavano il giorno,<br />
(eadem die recedentes), ma la maggior parte, introdotti nella casa a loro<br />
destinata, vi trascorrevano almeno una notte tornando l'indomani e dopo<br />
di aver ricevuto vestiti e viveri, compreso un pane per il viaggio (« ad<br />
viaticum »). I poveri, che erano anche ammalati, erano assistiti nel « xenodochium<br />
», che talvolta era provvisto di un'infermeria.<br />
A Cluny si era soliti distinguere fra 1'« elemosiniere », capo di un<br />
vasto servizio che aveva l'incarico di ricevere e di fare refezione ai poveri<br />
ed ai viaggiatori appiedati, e 1'«ospitaliere » (« hostellarius » o « custos<br />
hospitum ») cui era demandata la mansione di ricevere gli ospiti di riguardo.<br />
Il primo, dopo ciascun pasto, faceva il giro delle tavole dei<br />
monaci per raccogliere gli avanzi e distribuirli ai poveri. Una volta alla<br />
settimana egli girava per il borgo di Cluny per accertarsi se per caso vi<br />
fosse qualche povero costretto a tenere il letto. In tale circostanza si<br />
recava lui stesso a fargli visita, a meno che non si trattasse di una donna.<br />
Ancora: costui faceva le distribuzioni quotidiane ai poveri sopravvenuti,<br />
e la cucina della comunità teneva conto della parte riservata agli indigenti.<br />
I processi-verbali delle visite annuali dei priori cluniacensi ci riferiscono<br />
dei dettagli interessanti nel merito dei quali non possiamo entrare,<br />
circa il modo con cui veniva praticata l'elemosina (vds. Valous in<br />
« Il Monachesimo cluniacense », voI. I, p. 163 e segg.). Mentre tutti i<br />
poveri, i pellegrini appiedati, i chierici di basso rango erano affidati alla<br />
cura dell« elemosiniere », gli ospiti di riguardo ed i pellegrini a cavallo<br />
(ed anche i postulanti) erano assegnati all'« ospitaliere » che disponeva<br />
di uno o due monaci come aiutanti e di un certo numero di servitori : un<br />
capo, un cuciniere, un portinaio, uno sguattero, un asinaio, che provvedeva<br />
alle varie commesse) ecc, La lista (menu) dei pasti era curiosamente<br />
disciplinata (almeno verso il 1340) secondo la dignità dei conviviali. Il<br />
servizio degli ospiti di riguardo e quello dei poveri beneficavano di donazioni<br />
e fondazioni distinte.<br />
L'OSPITALITA' A CtTEAUX<br />
La vivissima preoccupazione di custodire la solitudine e la separazione<br />
dal mondo che caratterizzano lo spirito dei Fondatori di Citeaux,<br />
e la loro ferma risoluzione di erigere monasteri unicamente in località<br />
lontane dal frastuono mondano, non potevano tuttavia indurre i religiosi<br />
a trascurare il dovere essenziale della carità verso il prossimo non meno<br />
- 169-
che le prescrizioni imperative della Santa Regola: « Omnes supervenientes<br />
Hospites tanquam Christus suscipiantur » (cap. LIII). Cosl pure è<br />
interessante rilevare che un tale problema costituì una delle primarie sollecitudini<br />
di quei Santi Fondatori: « questi nuovi soldati di Cristo, poveri<br />
con Cristo povero, si domandarono in che modo e con quali mezzi (quo<br />
ingenio, quove artificio seu exercitio) avrebbero potuto mantenere se stessi<br />
e gli ospiti ricchi e poveri che sarebbero sopraggiunti e che la Regola<br />
impone di ricevere come fossero Cristo medesimo» (vds. « Exordiunm<br />
parvum », cap. XV). Notiamo, fra parentesi, la tradizionale discriminazione<br />
fra ospiti ricchi e poveri.<br />
La «Carta Charitatis » fa esplicita menzione dell'« Hospicium »<br />
(cioè della Casa degli Ospiti). Fra i luoghi regolari dei quali deve essere<br />
provvista ogni abbazla è prescritta la « Cella hospitum » e quella<br />
del portinaio. Si faceva peraltro una grave riserva: fuori della porta del<br />
monastero non doveva assolutamente essere eretta alcuna casa di abitazione,<br />
salvo le costruzioni riservate agli animali. In questo caso però non<br />
si tratta della « Cella degli Ospiti» della quale si è parlato più sopra,<br />
ma molto probabilmente del « xenodochium » o « Ospizio dei Poveri »,<br />
analogo a quelle costruzioni ospitaliere che non poche abbazie benedettine,<br />
soprattutto nelle Congregazioni di « Sassovivo » e della « Grande<br />
Sauve », si erano annesse con scopo caritativo senz'altro lodevole, ma<br />
molto estraneo allo spirito di S. Benedetto.<br />
- Ufficio del portiere. I <strong>Cistercensi</strong> restituirono al « portiere» l'importe<br />
ruolo che gli attribuiva S. Benedetto (di qui il rimprovero che essi<br />
fecero ai Cluniacensi, rivolgendosi a Pietro il Venerabile, di non mettere<br />
sempre alla custodia della porta monastica un «senex sapiens »), Il<br />
portiere dunque doveva dire « Deo gratias » ogniqualvolta udiva bussare<br />
alla porta, poi pronunciava la parola « Benedicite» e, fatto questo, si<br />
informava circa il motivo della visita. Quindi pregava il visitatore di<br />
attendere e nel frattempo andava in cerca dell' Abate, che veniva di persona,<br />
oppure inviava un monaco a fare, unitamente al portiere, l'accoglienza<br />
dell'estraneo secondo il cerimoniale prescritto dalla Regola. Ma il<br />
portiere cistercense era incombenzato soprattutto di quell'oflicio, e incarico,<br />
che a Cluny si usava affidare ad un particolare dignitario: «l'elemosiniere<br />
». Era il portiere ad essere incaricato di elargire soccorso agli<br />
indigenti e che, per tale motivo, era tenuto ad avere sempre del pane a<br />
disposizione in portineria. Aveva pure l'incombenza di raccogliere gli<br />
avanzi dei pasti dei monaci e quello di distribuire le « pulmenta defunctorum<br />
», coè tre porzioni che rappresentavano il cibo che sarebbe spettato<br />
agli ultimi tre religiosi defunti, e ciò senza pregiudizio delle altre<br />
numerose distribuzioni (cf. Capitolo Generale del 1185 n. 13, D'Arbois<br />
- 170-
di [ubainoille, Etat interieur ... , p. 205). Esisteva sì nell'ordine un « elemosiniere<br />
» o « pietanziere », ma iI suo ruolo era semplicemente quello<br />
di disciplinare la distribuzione delle pietanze (cioè piatti supplementari<br />
che in certi giorni venivano concessi alla comunità). In effetti negli archivi<br />
di Clairvaux un cospicuo numero di documenti classificati « porta» sono<br />
delle fondazioni elemosinarie il cui reddito veniva distribuito dal portinaio.<br />
Quarantasei documenti denomnati « elemosine» riguardano la distribuzione<br />
delle pietanze. Nell'Ordine l'ufficio di «elemosiniere» fu<br />
soppresso nel 1289.<br />
Il dovere dell'elemosina non fu tanto rammentato dai Capitoli Generali,<br />
quanto piuttosto sottoposto ad una certa regolamentazione, ossìa<br />
restituito a limiti ragionevoli. Questa è la miglior prova che esso non fu<br />
mai trascurato. Al momento dell'arrivo degli Abbati al Capitolo Generale,<br />
una moltitudine di poveri, di lebbrosi e di altri infelici, la sola vista dei<br />
quali suscitava ribrezzo, aveva preso l'abitudine di invocare ad alta voce<br />
la pietà degli Abbati chiedendo loro l'elemosina; cosa che non andava<br />
esente da abusi e che causava scandalo fra la gente dabbene in quanto<br />
fra i mendicanti s'infilavano dei soggetti poco raccomandabili (vds. Capitolo<br />
Generale del 1240, n. l O e del 1260, n. lO). Un provvedimento<br />
del Capitolo del 1217 dimostra che quest'affluenza di secolari era considerevole<br />
(n. 7). Gli archivi abbaziali fanno talvolta allusione a poveri che<br />
venivano soccorsi tutti i giorni e ogni settimana (cf. l'abbaza di Foucarmont,<br />
archivio della Senna Marittima, G. 842).<br />
OSPIZIO DEI POVERI<br />
Sospinti da un grande spinto di carità, molti monasteri eressero<br />
degli ospizi per i poveri. L'abbazia di Michelstein, in diocesi di Halberstadt,<br />
ne aveva uno nel 1218. Aiguebelle aveva un ospizio a Roussas,<br />
ad una lega e mezza dalla abbazia; questa casa dei poveri era servita<br />
da alcuni conversi e le rendite di terreno erano destiante ad essa. Un<br />
testo delle decisioni del Capitolo Generale del 1226 (n. 4) sembra consideri<br />
la cosa come normale. Gli archivi dell'Eu re conservano il Cartario<br />
dei poveri dell'ospizio dell'abbazia di Bonport. Esso contempla<br />
il periodo fra il 1254 ed il 1388 e comprende la trascrizione di 24 atti<br />
di donazione, di cessione di acquisti in diverse parrocchie a vantaggio<br />
dell'abbazia. Secondo le disposizioni dei contratti, questi beni erano da<br />
destinarsi ai poveri dell'ospizio dell'abbazia: «ad usus pauperum pauperis<br />
hospicii predicte domus (Bonport, archivio dell'Eure, H. 181).<br />
La stessa lebbra - una delle piaghe del Medio Evo - non vide i Ci-<br />
- 171-
stercensi indifferenti. Stando ad un documento del 1256, l'abbazia<br />
« Della Grazia di Dio », in diocesi di Saintes, sembra abbia fondato a<br />
Benon-en-Saintonge un lebbrosario, o specie di villaggio per i lebbrosi,<br />
comprendente delle case (« domus », « herbergamenta ») ed un piccolo<br />
possedimento di vigneti e terreni, il tutto gravato da lievi tributi a<br />
vantaggio dell'abbazia (L'abbaye de la Grace-Dieu in, Arch. Hist. de la<br />
Saintonge et dell'Aunis, XXVII, 1898, pp. 40 e 165). Non poche abbazie<br />
ebbero pure il loro lebbrosario per venire in aiuto agli infelici<br />
colpiti dal male. Torneremo su questo punto al periodo successivo. La<br />
riputazione dei monaci cistercensi in tema di carità era ben consolidata<br />
allorché il vescovo di Patrasse, in Grecia, chiese ed ottenne dal Capitolo<br />
Generale dei monaci e due conversi per il governo di un ospedale che<br />
l'alto prelato si apprestava a costruire (n. 50).<br />
L'Herbert, in «De miraculis » (lib. III, PL. 185, col. 1358 D)<br />
tesse l'elogio di un infermiere dei poveri « in hospicio », il quale curava<br />
gli ammalati non come fossero degli estranei o dei mendicanti, ma come<br />
suoi signori e come fossero Cristo stesso. In altro punto, la vita di S. Ugo<br />
di Bonneveaux fa menzione del « confessore dei poveri» (A. DIMIER,<br />
S. Hugues de Bonneueaux, p. 44, nota 1).<br />
I CISTERCENSI E IL PAPATO<br />
I rapporti fra i <strong>Cistercensi</strong> ed i Papi del secolo XIII sono stati<br />
esposti da J. Canivez (« Citeaux », colI. 933-940). Si è già parlato della<br />
Bolla «Parvus Fons» di Clemente IV (1265), come pure si è fatto<br />
cenno alle troppo numerose legazioni affidate dai Papi ai <strong>Cistercensi</strong>,<br />
ciò che provocò le lagnanze di quest'ultimi. Ma la risposta di Onorio III,<br />
del 5 dicembre 1219, che dispensava i <strong>Cistercensi</strong> da queste missioni<br />
confidenziali, non fu per niente mandata ad effetto. « Insomma, scrive<br />
J. Canivez, si trattò unicamente di buone parole. In opposizione a quella<br />
promessa rassicurante, le delegazioni continuarono ad affluire. L'Abbate<br />
di Citeaux, in particolare, fu incombenzato come per l'addietro di missioni<br />
diplomatiche talora molto difficili.(rif. in Canivez, op. citocol. 935).<br />
FAVORI PONTIFICALI<br />
Numerose bolle fanno menzione dei favori concessi all'Ordine, ciò<br />
che costituisce una testimonianza della stima che i Sommi Pontefici non<br />
cessarono mai di tributargli. Si è visto persino INNOCENZOIII (1198-<br />
- 172-
1216) proporre i <strong>Cistercensi</strong> a modello per tutti gli altri Ordini: il<br />
Concilio Lateranense (can. 12) fa obbligo a tutti gli altri Ordini Religiosi<br />
di convocare per l'avvenire un Capitolo Generale ogni tre anni a somiglianza<br />
di quanto è in uso a Citeaux. Allo scopo di assuefarsi a tale<br />
direttiva, sarà chiesta la presenza di due Abbati cistercensi del vicinato<br />
che dirigevano i dibattiti. Innocenzo III ambiva che l'Ordine di<br />
Citeaux fosse irreprensibile agli occhi di tutti (J. Canivez, col. 934) e<br />
non nascondeva la sua predilezione per l'abbazia di Fossanova. ONO-<br />
RIOIII (1216-E227) diede a Citeaux la prova di una benevolenza superlativa,<br />
al punto che il Capitolo Generale del 1227 (anno della morte<br />
del Papa) decretò un anniversario solenne da celebrarsi ogni anno il<br />
18 marzo per l'eterno riposo dell'anima di Onorio papa. Numerose Bolle<br />
di questo pontefice hanno chiaramente per oggetto la prosperità dell'Ordine.<br />
Per acconsentire alle abbazie l'abituale abbondanza delle loro<br />
elemosine, il papa confermò la loro dispensa dall'obbligo delle decime.<br />
La Bolla « Cum praeter pauperum victum» del 1219 andava oltre e<br />
concedeva agli Abbati la facoltà di dispensarsi dalle prescrizioni dei<br />
legati apostolici per quanto aveva riferimento alla procura finanziaria<br />
ed al diritto di esazione a beneficio delle persone stesse dei legati e del<br />
loro seguito. GREGORIOIX (1227-1241) formulò diverse bolle nell'intento<br />
di conservare l'esenzione e fece aggregare all'Ordine un cospicuo<br />
numero di abbazie femminili. Fu Gregorio IX che, con la bolla del<br />
27 novembre del 1229 indirizzata all'Abate di Claivaux, lo autorizzò<br />
a percepire una parte delle « decime novali » (derivate cioè da terreni<br />
messi nuovamente a coltura) pari a quella che tale Abbate introitava di<br />
già sulle antiche decime. Un tale prelevamento sulle decime era già in<br />
uso, ma il privilegio pontificio aprì la porta al completo, ed il Capitolo<br />
Generale del 1230 (n. 3) autorizzò le abbazie a togliere la decima sulla<br />
terre altrui contrariamente agli statuti primitivi. INNOCENZOIV (1243-<br />
1254), il cui pontificato fu caratterizzato soprattuto dalla lotta contro<br />
Federico II di Germania, visitò numerose abbazie cistercensi nel corso<br />
del viaggio che egli fece per recarsi al Concilio da lui convocato a Lione<br />
nel 1245. Dopo tale Concilio egli scrisse particolarmente al Capitolo<br />
Generale al fine di rendere edotti i <strong>Cistercensi</strong> che le sentenze contro<br />
l'imperatore non erano state emanate a cuor leggero (Mahn « L'Ordine<br />
Cistercense », p. 241). Egli teneva per certo e con ragione che gli Abbati<br />
convenuti a Citeaux avrebbero portato nei loro paesi una tale convinzione,<br />
e che l'avrebbero divulgata. Era un eccellente modo di fare per<br />
esautorare gli argomenti esibiti da Federico nel suo manifesto indirizzato<br />
ai principi. Questo Papa prese le difese dei <strong>Cistercensi</strong> contro taluni<br />
vescovi gelosi delle immunità e dei privilegi dell'Ordine. Certe Bolle,<br />
- 173-
più volte inviate a particolari abbazie, dispensarono dall'esame episcopale<br />
i monaci presentati dai loro Abbati alle S. Ordinazioni. Rammentiamo<br />
infine, come s'è già detto in precedenza, il ruolo di prim'ordine che<br />
Innocenzo IV ebbe nella fondazione del «Collegio S. Bernardo» di<br />
Parigi. Il «bollario» di ALESSANDROIV (1254-1261) contiene una<br />
cospicua quantità di tali documenti inviati all'Ordine. È questo Papa<br />
che prescrisse una maggior solennità nella liturgia (uso di piviali, tunicelle,<br />
dalmatiche e ciò con la bolla « Vestra » del 20 giugno 1257) e che<br />
concesse all' Abbate di Citeaux ed ai Quattro Primi Padri il privilegio<br />
di conferire gli Ordini Minori ai loro religiosi (Bolla «Habitantes»<br />
del 13 giugno 1260), privilegio del quale peraltro il Capitolo Generale<br />
esitò a far uso per il timore delle possibili difficoltà che sarebbero potute<br />
emergere da parte dell'episcopato. URBANOIV (1261-1264), il papa<br />
della festa del « Corpus Domini », ebbe ad occuparsi delle difficoltà sorte<br />
nel 1263 fra l'Abbate di Citeaux e quello di Clairvaux e che furono<br />
appianate dalla Bolla « Parvus Fons » emanata dal suo successore CLE-<br />
MENTE IV (1265-1268). Quest'ultimo, egualmente ben disposto verso<br />
i <strong>Cistercensi</strong> ai quali fra l'altro affidò il compito di riformare l'abbazia<br />
benedettina dei SS. Cosma e Damiano nela diocesi di Zagabria e che<br />
canonizzò la cistercense S. Edvige, non manca peraltro di rammentare<br />
loro certi obblighi, come quello di intervenire annualmente al Capitolo<br />
Generale, o quello di venire in aiuto della loro Casa-Madre che allora<br />
attraversava una crisi finanziaria. GREGORIOX (1271-1276) esentò<br />
nuovamente i <strong>Cistercensi</strong> dall'obbligo di elargire dei sussidi per la Terra<br />
Santa. I suoi otto successori, fino a BONIFACIOVIU eletto nel 1294,<br />
furono per breve tempo al governo della Chiesa. Si rimprovera a NICO-<br />
LA IV (1288-1292) (come d'altronde a Innocenzo IV) di essere stato<br />
propenso all'approvazione di donazioni di rendite ecclesiastiche fatta a<br />
favore di abbazie cistercensi, benché la cosa fosse notoriamente contraria<br />
alle primitive istituzioni dell'Ordine, ma questo papa nella bolla « Plantatus<br />
in agro Domini» del 9 dicembre 1291, tesse un bell'elogio dell'Ordine:<br />
« inter alia germinantia dicti agri tamquam sidereo nitore refulgens<br />
plenis donis virtutum spiritualiter et temporaliter noscitur abundare<br />
», per cui egli dichiara di prendere sotto la sua speciale protezione<br />
tutti i monasteri ed i loro beni.<br />
DIFFICOLTA' CON LA SANTA SEDE<br />
Esse furono molto rare. A seguito della lamentanza di un vescovo<br />
unghesere contro i <strong>Cistercensi</strong>, che non volevano sospendere l'acquisto<br />
di vigneti che fino a quel momento pagavano la decima al prelato, In-<br />
- 174-
nocenzo III fece noto al Capitolo che se tali rimproveri si fossero ripetuti<br />
il prossimo Concilio Generale non solo sarà indotto a porre un<br />
limite ai loro privilegi, ma addirittura a sopprimerli per intero « dato<br />
che chi abusa di un favore non è degno di conservarlo» (lettera del<br />
26 giugno 1213). In effetti la minaccia ebbe parziale esecuzione col<br />
canone 55 del Concilio Lateranense del 1215 che ridusse l'esenzione<br />
dale decime sui « novali » e quelle gravanti sui terreni acquistati prima<br />
del Concilio. L'applicazione di questo canone sollevò d'altronde varie<br />
difficoltà, benché il contenuto della norma conciliare fosse molto chiaro:<br />
1) i beni che saranno acquistati in futuro dai <strong>Cistercensi</strong> pagheranno la<br />
decima, anche se saranno coltivati dai monaci o comunque a loro spese;<br />
2) quelli che sono stati acquistati prima del 1215 non pagheranno la<br />
decima purché siano coltivati dai monaci o a loro spese; 3) i terreni<br />
« novali » saranno egualmente esenti. In relazione a tutto un complesso<br />
di risposte della Santa Sede su punti controversi, Mahn conclude: «In<br />
tutta questa faccenda il papato fa sempre mostra di una duplice preoccupazione:<br />
a) di conservare i privilegi dei <strong>Cistercensi</strong> (cioè di mantenere<br />
la sua prerogativa, che è giustamente quella di concedere privilegi);<br />
b) di evitare che questi Religiosi non finiscano, abusando dei loro privilegi,<br />
col causare dei disordini nella Chiesa» (o. c. p. 116).<br />
Un conflitto di maggiore entità si ebbe a proposito della decima<br />
in Sicilia. Allorché questa decima, ordinata nel 1264 per finanziare la<br />
spedizione di Sicilia trasformata in crociata contro Manfredi, fu estesa<br />
il 25 aprile a tutti ed in tutti i paesi, il Cardinale Guido di Saint-Laurent<br />
« in Lucina » vecchio Abbate di Citeaux, protestò dichiarando che se il<br />
suo Ordine fosse stato costretto al pagamento, tutte le abbazie sarebbero<br />
state poste nella necessità di rinunciare alle loro elemosine ed alla<br />
loro abituale ospitalità. D'altro canto allorché il re di Francia era partito<br />
per la Terra Santa col medesimo favore di prelievo della decima, i<br />
<strong>Cistercensi</strong> ne erano stati esentati. Ma Urbano IV non si lasciò convincere:<br />
«E sta bene, egli avrebbe gridato, se non hanno pagato per l'addietro,<br />
pagheranno ora ». Il Capitolo Generale del 1265 diede incarico<br />
ai primi 5 Abbati di negoziare la cosa e, se necessario, di mettersi in<br />
viaggio per Roma. La morte di Urbano IV, sopravvenuta nel frattempo,<br />
diede un po' di respiro, ma il nuovo Papa, Clemente IV, dopo avere il<br />
15 marzo 1265 deciso di sospendere la percezione della decima siciliana<br />
sui beni dell'Ordine, annullò tale favore con effetto dal 30 del mese<br />
stesso. Due riunioni abbaziali in marzo ed in aprile del 1266 riuscirono<br />
ad ottenere una ulteriore dilazione. Il Capitolo Generale del 1267 conferì<br />
i pieni poteri all'Abate di Citeaux al fine di giungere ad una soluzione.<br />
Il Capitolo del 1268 sembrò apportatore di una definizione e<br />
- 175-
decise di concentrare il denaro a Parigi, durante l'ottava dell'Epifania.<br />
Nel frattempo il re San Luigi aveva notificato il 4 luglio 1268 di aver<br />
ricevuto dall'Abbate di Citeaux e dai suoi coabbati la somma di 20.000<br />
lire parigine a titolo gratuito, per sopperire aIe spese della crociata, e<br />
che di conseguenza proibiva che si prendesse una tale liberalità a pretesto<br />
per tassare l'Ordine. Al contrario nel 1269 Carlo d'Angiò, re di<br />
Sicilia, imputò alle remore dei <strong>Cistercensi</strong> l'impossibilità in cui egli si<br />
trovava di pagare i Fiorentini. Nel 1272 i primi cinque Abbati furono<br />
nuovamente incaricati di negoziare la cosa. È solo nel 1273, dopo nove<br />
anni di resistenza, che i <strong>Cistercensi</strong> si decisero di sottomettersi agli ordini<br />
di Roma versando una quota-parte della decima siciliana.<br />
I PROCURATORI PRESSO LA CORTE PAPALE E IL PROTET-<br />
TORE DELL'ORDINE<br />
La necessità di regolare gli affari correnti con la Santa Sede e la<br />
difficoltà che talvolta presentava il viaggio a Roma, determinarono l'Ordine<br />
ad istituire nella Città Eterna dei rappresentanti permanenti. Dal<br />
Capitolo del 1220 fu deciso che due chierici residenti a Roma sarebbero<br />
stati scelti «ad impetrandum et contradicendum». Si noti che<br />
non si tratta di religiosi ma di chierici « assidui in Curia Romana». Gli<br />
Abbati di Casamari e di S. Martino-dei-Monti di Viterbo sono incaricati<br />
di stabilire i loro onorari che saranno a carico di tutto l'Ordine.<br />
Si stabilì nel 1230 che il loro salario non doveva superare la somma<br />
di 12 marchi, secondo la stima del Cardinale Raniero Capucci e dell'Abbate<br />
di Viterbo. Questi procuratori venivano nominati annualmente,<br />
e sembra che uno o due Abbati avessero il mandato, dal Capitolo Generale,<br />
per la loro scelta. Certi Abbati, avendo degli affari speciali da<br />
trattare a Roma, vi inviavano anche un procuratore di loro scelta. Nel<br />
secolo seguente ci fu motivo di lamentele a causa della molteplicità di<br />
tali mandatari. Gli affari più importanti e più spinosi (ad esempio quello<br />
della decima siciliana) furono trattati da uno o più Abbati inviati espressamente<br />
a Roma.<br />
Nella Corte papale, l'Ordine utilizzò anche i servizi di un « Cardinale<br />
Protettore ». Non v'è dubbio che il Collegio dei Cardinali contasse<br />
fra i suoi componenti, e quasi sempre, qualche cistercense, e frequentemente<br />
più d'uno di questi anziani cistercensi rivestiti della porpora intervennero<br />
direttamente in favore del loro Ordine, ma fu solo nel 1260<br />
che una esplicita norma del Capitolo Generale decretò al Cardinale di<br />
San Lorenzo in Lucina il titolo di « Protector Ordinis ». Era un inglese,<br />
- 176-
di nome Giovanni Tolet, antico monaco cistercense. Alessandro IV ricorda<br />
quasi sempre nelle sue bolle che è su domanda del suo caro figlio,<br />
il Cardinale Giovanni del titolo di S. Lorenzo «in Lucina », che egli<br />
concede questo o quel privilegio. Talvolta il Papa si compiace di mettere<br />
in rilievo lo zelo con il quale il Cardinale difende presso di lui gli<br />
interessi dell'Ordine. Gli Statuti dei Capitoli Generalimolto spesso fanno<br />
accenno del «Protettore dell'Ordine », ma soprattutto a far data dal<br />
secolo XV. Essi ci hanno conservato i nomi di alcuni cardinali incaricati<br />
dalla Santa Sede di esercitare tale ofìicio e dei quali alcuni ebbero un<br />
ruolo ragguardevole.<br />
CITEAUX E LE CROCIATE (1)<br />
La parte avuta da Citeaux nelle preparazione della dodicesima e<br />
tredicesima crociata è stata esposta più sopra. Vedremo ora il ruolo<br />
avuto dai <strong>Cistercensi</strong> nelle crociate del secolo XIII, dapprima in quelle<br />
propriamente dette e che avevano per obiettivo la Terra Santa, in seguito<br />
nelle lotte contro gli eretici denominate « Crociate degli Albigesi<br />
», infine nelle diverse spedizioni missionarie nel Nord-Europa, battezzate<br />
talvolta con il nome di crociate. Se l'ideale della crociata non<br />
poteva lasciare indifferenti i figli di S. Bernardo, la loro partecipazione a<br />
queste imprese poneva certi problemi. Le preghiere ed i sacrifici dei<br />
monaci erano assicurati ai crociati senza restrizione. Gli aiuti richiesti<br />
per finanziare le spedizioni costituirono talora un onere molto gravoso.<br />
Ma l'invio di Abbati, di monaci o di conversi per accompagnare le<br />
spedizioni e per partecipare alla predicazione erano cose talmente estranee<br />
alla vocazione cistercense - malgrado alcuni precedenti - che si<br />
comprendono le esitazioni dei Capitoli Generali ad accogliere istanze<br />
di questo genere. Diciamo che ciononostante la risposta fu generosa: i<br />
<strong>Cistercensi</strong> seppero comprendere le direttive dei Sovrani Pontifici e mettere<br />
il bene generale della Chiesa al di sopra delle loro personali preferenze.<br />
È il caso di aggiungere che questa situazione anormale ebbe<br />
relativamente breve durata e che non riguardò che un ristretto numero<br />
di abbazie. La contropartita dei sacrifici autorizzati fu un incremento<br />
delle donazioni fatte in occasione della crociata. Molte di esse erano<br />
in un primo tempo condizionate, come quella di un tale cavaliere Pietro<br />
de La Ferèt che aveva donato per testamento ai monaci di Pontigny<br />
due specchi d'acqua: se egli fosse morto durante il viaggio i monaci<br />
avrebbero posseduto le due vie d'acqua alle condizioni previste dal testamento;<br />
se invece avesse fatto ritorno dovevano essergli restituite<br />
- 177-
(anno 1230). Non si sa se questo Pietro abbia fato ritorno dalla Terra<br />
Santa; molti altri cavalieri d'altronde non tornarono più.<br />
CROCIATE IN TERRA SANTA<br />
Fin dal tempo della sua elezione al Supremo Pontificato (gennaio<br />
1198), Innocenzo III chiese con insistenza l'aiuto delle preghiere dei<br />
monaci (lettera « Dum solum », 21 maggio 1198, indirizzata a Citeaux,<br />
Claivaux, ai Premostratensi e a S. Vittore di Parigi). In luglio una nuova<br />
lettera, datata da Rieti, indirizzata al Capitolo Generale di Citeaux<br />
dove erano convenuti più di 500 Abbati. Il papa pregava i Padri capitolari<br />
di scusare I'Abbate di Sambucina se egli faceva uso delle sue<br />
prestazioni pastorali quale predicatore della crociata in Sicilia unitamente<br />
al Vescovo di Siracusa. Infatti Innocenzo III era già passato<br />
all'azione e stava organizzando una nuova crociata. Egli decretò per tutte<br />
le case cistercensi l'imposta della «cinquantesima ». L'Ordine promise<br />
una somma totale di 2 .000 marchi - di che il Papa ringraziò i <strong>Cistercensi</strong><br />
- ma la realizzazione pratica di quest'aiuto soffri dei ritardi ed<br />
il Capitolo Generale del 1203 fu costretto a chiamare all'ordine coloro<br />
che non avevana ancora versato « quod promissum est ad usus Terrae<br />
Jerosolymitanae », dispensando peraltro da tale onore gli Abbati di<br />
taluni paesi (1203, n. 27). I ritardatari e gli altri Abbati dovevano pure<br />
essere provvisti di denaro allorché sarebbero tornati al Capitolo dell'anno<br />
seguente nel caso che fosse fatta richiesta di un versamento<br />
supplementare. Ma fino dal 1201 era stata rivolta al Capitolo Generale<br />
una richiesta più delicata con le istanze congiunte del marchese di Montferrat,<br />
del conte di Fiandra (il futuro imperatore di Costantinopoli) e del<br />
conte di Blois con il consenso della Santa Sede. Diversi Abbati cistercensi<br />
erano stati designati come predicatori della crociata: quelli di Salem<br />
e di Neuburg per la provincia di Magonza, quello di Sittichenbach: per le<br />
provincie di Magdeburgo e di Brema, quello di Mellifont per l'Irlanda,<br />
quello di Riévaulx per l'Inglilterra, e soprattutto l'Abbate Martino di<br />
Pairis, predicatore per la Germania, che accompagnò la spedizione in<br />
qualità di Legato pontificio. Si domandava anche che alcuni <strong>Cistercensi</strong><br />
potessero essere compagni di viaggio dei crociati. Il Capitolo del 1201 si<br />
rassegnò: «ad mandatum Summi Pontificis et ad preces Marchionis ...<br />
conceditur », autorizzando nel contempo gli Abbati di Vaux-de-Cernay,<br />
di Perseigne, di Loos e di Cercanceaux ad unirsi ai crociati ed a portare<br />
con sé del personale e le necessarie attrezzature secondo i suggerimenti<br />
dei loro Padri Immediati (1201, n. 37). Il Capitolo dell'anno successivo<br />
dispensò le Case, i cui Abbati erano partiti, di farsi rappresentare al<br />
- 178-
Capitolo Generale. I loro Padri Immediati gliene avrebbero comunicate<br />
le decisioni (1202, n. 38). Benché la crociata fosse stata sviata dal suo<br />
obiettivo causa l'ambizione dei Veneziani ed avesse fallito l'intento di<br />
prendere Costantinopoli per colpa dei crociati d'Occidente, 17 luglio<br />
1203, ilCapitolo Generale di quell'anno non volle accogliere la domanda,<br />
che gli era stata rivolta, di far rientrare alle loro rispettive Case gli Abbati,<br />
i monaci ed i conversi che erano partiti per la crociata (1202, n.<br />
47). Quanto ad Innocenzo III abbiamo già visto per l'innanzi che egli<br />
faceva assegnamento su Citeaux per sollevare in Oriente un'ondata di<br />
simpatia verso la Chiesa Romana e che incoraggiava le fondazioni monastico-cistercensi<br />
nei paesi greci.<br />
LA QUINTA CROCIATA (1219-1221), auspicata fino dal 1213<br />
dallo stesso Innocenzo III, fu caldeggiata in Siria da Giacomo di Vitry,<br />
amico dei <strong>Cistercensi</strong>, in Francia da Folco di Tolosa, antico monaco di<br />
Grandselve e Abbate di Thoronet, in Germania da Bernardo, monaco di<br />
Heisterbach ecc. Su richiesta del Duca di Brabante, il Capitolo Generale<br />
del 1217 autorizzò l'Abbate di Villers ad accompagnarlo in Terra Santa<br />
(n. 73). Un'analoga richiesta del re di Ungheria di farsi accompagnare<br />
da due monaci e da un converso era stata accolta dal Capitolo del 1212,<br />
(n. 66). A parte queste petizioni e legazioni, le Case dell'Ordine si limitarono<br />
a mettere a disposizione dei contributi in denaro. È noto che<br />
questa quinta crociata, chiamata «l'Ungherese », si ridusse ad essere,<br />
secondo R. Grosset, un'imponente parata militare attraverso la Galilea<br />
che non portò a nulla di fatto.<br />
LA SESTA CROCIAr A (1228-1229), quella di Federico II, fu una<br />
impresa islamofìla, antifrancese e, perché scomunicata dal Papa, non ebbe<br />
alcun cistercense nelle sue file. Onorio III tuttavia nutriva delle speranze,<br />
e con la bolla « Cum praedicandae Crucis» del I" marzo 1224 aveva<br />
dato l'incarico al vescovo di Lund, in Danimarca, al prevosto di Arles<br />
in Provenza, ed all'Abbate di Aiguebelle, in diocesi di Sarnpaolo-Tre-Castelli<br />
(Saint-Paul-Trois-Chàteaux) di organizzarne la predicazione. Il Pontefice<br />
accordò loro numerosi privilegi, fra i quali quello di commutare<br />
il voto di pellegrinaggio a S. Giacomo, di assolvere quei criminali che<br />
erano disposti a farsi crociati, di obbligare coloro che avevano emesso il<br />
voto di partecipare alla crociata a mantenerlo, di organizzare almeno<br />
una volta al mese delle processioni solenni nei luoghi ritenuti convenienti<br />
di far cantare quotidianamente in tutte le chiese il salmo « Deus venerunt<br />
gentes» (Bollario « Danicum », n. 189, Chartes d'Aiguebelle, n. 52).<br />
Certi Abbati furono talvolta incaricati di raccogliere aiuti finanziari<br />
- 179-
per la Terra Santa. Ad esempio, nel 1238 il re di Navarra e conte di<br />
Champagne, avendo ricevuto dagli Ebrei e da altre persone, suoi sudditi,<br />
una cospicua somma di denaro e vedendosi nell'impossibilità di restituirla,<br />
a loro od agli eredi, si determinò a disporne « in subsidium Terrae<br />
Sanctae »: l'Abbate di ]ouy, in diocesi di Sens, eebbe l'incarico da<br />
Gregorio IX di soprintendere a tale adempimento. Al contrario, il 15<br />
marzo 1251 Innocenzo IV diede incarico agli Abbati di Fontenay, di<br />
Echarlis e di Maizières di raccogliere nelle provincie di Lione, Sens e<br />
Baurges il danaro che dovevano versare coloro che desideravano di essere<br />
prosciolti dal voto di partecipazione alla crociata e di donarne 5.000<br />
marchi d'argento al duca di Borgogna ed al Signore di Bourbon.<br />
LE CROCIATE DI SAN LUIGI (la settima, 1248-1252, e l'ottava,<br />
1270) ebbero ripercussioni più immediate su Citeaux. Nel dicembre<br />
del 1244, nel corso di una grave malattia, il re aveva fatto voto di partire<br />
per la crociata. Il voto reale venne ben presto a conoscenza, ed al Concilio<br />
Generale di Lione Innocenzo IV si diede premura di interessarvi<br />
tutta la Cristianità. Nel medesimo anno, il Capitolo Generale decretò per<br />
tutto l'Ordine solenni preghiere da effettuarsi durante la Messa Conventuale:<br />
il salmo « Deus venerunt gentes », seguito da preghiere per i<br />
cristiani prigionieri in Terra Santa e per la salute del re (1245, n. 2). Nel<br />
1247 il Capitolo impose per la stessa intenzione una processione col<br />
canto dei salmi penitenziali per ogni venerdì (1247, n. 4). La faccenda<br />
delle tassazioni era stata disciplinata dallo stesso re. Orbene, il re aveva<br />
fatto domanda a Innocenzo IV di esentarne i <strong>Cistercensi</strong>, i Certosini, i<br />
Templari, gli Ospitalieri e l'Ordine di Fontevrault. San Luigi s'imbarcò<br />
a Aigues-Mortes il 25 agosto 1248. La crociata ebbe fine nel 1252, ma le<br />
preghiere per la Terra Santa rimasero un'intenzione permanente dell'Ordine,<br />
ed il Capitolo Generale del 1258 diede disposizione di continuarle.<br />
La seconda crociata di San Luigi, quella che R. Grosset chiamò con il<br />
nome di « Errore di Tunisia» e che terminò così tragicamente con la<br />
morte del re, fu rassegnata nell'Ordine da un raddoppiamento di preghiera.<br />
Il Capitolo Generale ordinò per ilre e per i crociati una processione al<br />
primo giorno di ogni mese col canto del responsorio « Aspice Domine ».<br />
La processione dei VII salmi al venerdì e la « Salve Regina » dopo Compieta,<br />
per le medesime intenzioni, furono conservate fino al Capitolo<br />
seguente (n. 75). Questo stesso Capitolo autorizzò gli Abbati della Frisia<br />
a celebrare una Messa « de Sancta Cruce » in tutte le loro abbazie « pro<br />
peregrinis Terrae Sanctae» (n. 54). La morte del santo re fu molto<br />
compianta a Citeaux: egli era stato un grande amico ed un insigne benefattore<br />
dell'Ordine. Il Capitolo del 1271 (n. 72) decse che si sarebbe<br />
- 180-
celebrato per lui un duplice servizio di suffragio il primo ed il secondo<br />
anno (dell'anniversario). Inoltre annualmente in tutte le Case dell'Ordine<br />
si celebrerà il suo anniversario l'indomani della festa di S. Bartolomeo.<br />
Tutti i preti che celebreranno la Messa in quel giorno, la diranno<br />
per quelle intenzioni (per gli altri Uffici celebrati nell'Ordine vds. P. A.<br />
Dimier « San Luigi e Citeaux » pp. 196-199). Le preghiere per la Terra<br />
Santa furono mantenute dai Capitoli del 1272 (nn. 4 E42), del 1274<br />
(n. 1), del 1290 (n. 20); degli aiuti finanziari votati fu rammentata frequentemente<br />
l'obbligazione (1275, n. 17, 1278, n. 20, 1279, n. 76,<br />
1280, n. 22, 1282, n. 40). Gli è che al Concilio Ecumenico di Lione del<br />
1274 era stata decisa una nuova crociata che, venuta meno la possibilità<br />
della sua realizzazione nel 1287 e 1289, non ebbe mai luogo. La conquista<br />
di S. Giovanni d'Acri, avvenuta il 28 maggio 1291, pose fine al<br />
dominio franco in Terra Santa.<br />
I PRODROMI DELLA « CROCIATA DEGLI ALBIGESI»<br />
I <strong>Cistercensi</strong> ebbero una partecipazione più attiva alla « Crociata<br />
degli Albigesi ». Nella storia dell'Ordine questa partecipazione diretta<br />
dei nostri confratelli ad un'impresa avente per oggetto la difesa della<br />
Fede, segna una tappa importante, che fortunatamente fu di breve durata<br />
atteso che i Domenicani vi si sostituirono ai nostri. S. Bernardo si era<br />
preoccupato delle dottrine eretiche che taluni predicatori ambulanti diffondevano<br />
in svariate contrade e particolarmente nella Francia meridionale.<br />
Egli aveva sollecitato Ildefonso, conte di Saint-Gilles, a non permettere<br />
che Enrico, discepolo di Pietro di Bruis, propalasse i suoi errori<br />
per mezzo dei suoi accoliti (lett. n. 241). Parimenti scriveva agli abitanti<br />
di Tolosa di allontanare dalla loro città gli eretici (lett. n. 242). Transitando<br />
per la Linguadoca dopo il suo viaggio del 1145, il Santo aveva fatto<br />
assegnamento su Bertrando ed i monaci di Grandselve ai fini della lotta<br />
contro l'eresia dilagante. Essa, ridotta al silenzio per breve tempo, riprese<br />
a serpeggiare dopo la morte del grande Abbate di Clairvaux. Nel 1177<br />
Raimondo V conte di Tolosa, scrisse al Capitolo di Citeaux per supplicare<br />
i Padri di aiutarlo non solo con le loro preghiere, ma anche con una<br />
azione diretta ed efficacecontro l'eresia che era penetrata fin nel santuario,<br />
dato che dei preti e persino dei vescovi ne erano stati sedotti (Raccolta<br />
Storica Gallica, XIII, 140). Raimondo riteneva che gli eretici non<br />
si sarebbero arresi che alla forza, e si augurava che i <strong>Cistercensi</strong> sollecitassero<br />
in tal senso il re di Francia. Nel frattempo ebbe inizio una missione<br />
contro gli Albigesi. L'Abbate di Clairvaux, Enrico di Marcy, vi<br />
- 181-
partecipò ed anzi prese l'iniziativa di lanciare un manifesto per denunciare<br />
le malefatte dell'eresia e per dare un rendiconto dei risultati - per<br />
la verità piuttosto meschini - della missione. Nel 1180, nuova missione.<br />
Questa volta Enrico di Marcy, diventato cardinale e legato pontificio, era<br />
a capo di un'armata che riportò qualche successo. Ma legato e predicatori<br />
si erano appena appena dipartiti, che gli eretici ripresero con audacia<br />
la loro opera di proselitismo. Nel frattempo si chiese a Mastro Alain,<br />
il « Dottore universale », diventato semplice converso cistercense, di fissare<br />
per iscritto il contenuto preciso dei dogmi cattolici maggiormente<br />
presi di mira dagli eretici. Alain indirizzò quattro libri « De fide catholica»<br />
a Guglielmo VI, signore di Montpellier, e più tardi monaco di<br />
Grandselve.<br />
Citeaux e le crociate (2)<br />
I PRODROMI DELLA «CROCIATA DEGLI ALBIGESI» (Seguito)<br />
Agli inizi del secolo XIII questi sforzi non avevano prodotto dei<br />
risultati apprezzabili ed il nuovo conte di Tolosa, Raimondo VI, figlio del<br />
precedente, se proprio non favoriva l'eresia, come si disse, tuttavia si<br />
mostrava nei suoi confronti di un'eccessiva tolleranza. Quanto all'episcopato,<br />
esso restava inerte, tanto che gli eretici guadagnarono a poco a<br />
poco tutta la nobiltà dell'Alta Linguadoca e sedussero la massa del popolo.<br />
Che fare per estirpare il male? Non potendo fare assegnamento sui<br />
vescovi usciti per la maggior parte da famiglie altolocate del paese, e più<br />
o meno contaminate, non potendo contare sul clero parrocchiale, troppo<br />
spesso ignorante e privo di zelo, e dopo di avere, in una lettera indirizzata<br />
a Raimondo VI, definito chiaramente ciò che egli intendeva per<br />
eresia e manifestata la sua intenzione di una rigorosa severità, Innocenzo<br />
III fece appello ai <strong>Cistercensi</strong>. Fin dall'inizio de! suo pontificato egli<br />
aveva inviato nel Mezzogiorno dei monaci cistercensi in qualità di legati:<br />
Reniero Guido ai quali non tardò ad associare Pietro di Castelnau, antico<br />
arcidiacono di Maguelonne, ed attualmente monaco di Fontfroide,<br />
poi nel 1203 un altro cistercense di nome Raoul. In una lettera inviata<br />
all'Abbate di Citeaux Arnaldo Amalrico, che aveva buona conoscenza del<br />
paese per essere stato Abbate di Grandselve dal 1198 al 1201, il papa<br />
tracciò un quadro della situazione ed espresse la sua consolazione di poter<br />
trovare dei religiosi disposti a lottare, con la parola e con l'esempio, contro<br />
gli eretici (PL, 215, 358). Ben presto, come testimonia Pietro monaco di<br />
Vaux-de-Cernay e storico della crociata, una dozzina di Abbati cistercensi<br />
e numerosi monaci si trovarono nella Linguadoca. Furono tenute delle<br />
- 182-
conferenze in contradditorio con gli eretici. Esse però non ebbero alcun<br />
risultato. « La ragione del loro fallimento, scrive molto giustamente A.<br />
Fliche, non fu di ordine intellettuale, che anzi nella discussione essi<br />
avevano frequentemente prevalso sui loro avversari, tuttavia avevano iI<br />
torto di circondarsi, se non proprio di un fasto eccessivo, almeno di un<br />
certo benessere in contrasto con l'austera semplicità di quegli eretici<br />
chiamati « I Perfetti ». Durante l'estate del 1201 a Castelnau, Dìdaco,<br />
vescovo di Osma, che era presente ad una riunione di Abbati cistercensi,<br />
non esitò a criticare il modo di incedere su cavalcature dei predicatori<br />
ortodossi, ch'egli opponeva al portamento degli oratori Càtari che, diceva,<br />
andavano di villaggio in villaggio a piedi nudi accontentandosi di un<br />
nutrimento più che modesto, che si imponevano per una santità almeno<br />
apparente e per lo spettacolo di una povertà e d'un'austerità evangeliche<br />
(« Storia della Chiesa, vol. X », « La Cristianità romana» p. 121).<br />
Bisognava riformare i metodi. Dìdaco ed il suo compagno Domenico,<br />
previa approvazione di Innocenzo III, si diedero a tale riforma, mentre<br />
nel frattempo i Legati cistercensi perseguivano un'opera di risanamento<br />
del clero dando l'esempio di una vita veramente apostolica, camminando<br />
a piedi, chiedendo l'elemosina come dei poveri di Cristo Gesù. Malgrado<br />
questi lodevoli sforzi, le conversioni furono poco numerose ed un certo<br />
scoraggiamento incominciò a serpeggiare fra i predicatori cattolici. Nel<br />
corso del 1207 la maggior parte di essi fecero ritorno alle loro abbazie,<br />
ad eccezione dell' Abbate di Vaux-de-Cernay, Guido di Chevreux, e dell'Abbate<br />
di Citeaux, Arnaldo-Amalrico.<br />
LA CROCIATA (1209-1218)<br />
A questo punto della situazione fu decisa una crociata. La prima<br />
vittima ne fu il Legato Pietro di Castelnau, assassinato il 15 gennaio<br />
del 1208 nel momento in cui si apprestava a passare il Reno. L'opinione<br />
pubblica accusò Raimondo VI di essere l'istigatore di questo delitto. La<br />
cosa per altro non è assolutamente provata. Ad ogni buon conto, Raimondo,<br />
sentendo il peso dell'accusa che pesava su di lui, fece un voltafaccia<br />
non privo di notevole abilità: offrì la propria sottomissione e si<br />
propose anche di prendere la croce e di associarsi così alla guerra santa.<br />
Questa « Guerra Santa» si ridusse in realtà ad una guerra feudale. Non<br />
entreremo nei particolari di queste campagne sanguinarie delle quali iI<br />
primo episodio ed anche uno dei più orrendi, fu il « Sacco di Béziers»<br />
(21 luglio 1209) nel corso del quale settemila, fra donne, bambini e<br />
vecchi rifugiati nella Chiesa della Maddalena, furono selvaggiamente mas-<br />
- 183-
sacrati. Se è falso che l'Abbate di Citeaux, Legato pontificio, abbia pronunciato<br />
la celebre frase attribuitagli: «Uccideteli tutti, Dio sarà bene<br />
in grado di riconoscere i suoi! », è invece purtroppo corrispondente a<br />
verità che il Legato, scrivendo a papa Innocenzo III, non abbia trovato<br />
una parola per marchiare d'infamia una tale carneficina. Ad una sola voce,<br />
durante gli anni che seguirono, gli storici rimproverano ad Arnaldo di<br />
Citeaux ed agli altri Legati la loro intransigenza ed il loro compiacimento<br />
per Simon di Montfort divenuto capo militare, e senza scrupoli, della<br />
crociata. Innocenzo III avrebbe voluto risparmiare Raymondo VI di Tolosa<br />
e soprattutto impedire alla crociata di trasformarsi in guerra di conquista.<br />
La legazione di Pietro da Benevento (gennaio-aprile 1214) sembrò<br />
sul punto di ristabilire la pace, ma la guerra riprese. Essa non aveva<br />
più motivo religioso. È noto come il 25 giugno 1218 all'assedio di Tolosa,<br />
l'ultimo baluardo che gli restava da conquistare, Simone di Montfort fu<br />
ucciso da una pietra lanciata da un bastione. Suo figlio, Amaury, conscio<br />
della sua impotenza, mise la sua causa nelle mani del re di Francia, preparando<br />
così l'annessione della Linguadoca alla Francia. La pace si ristabilì<br />
lentamente. Pietro di Castelnau non era stato il solo a versare il<br />
sangue. L'Abbate di Eaunes, Stefano, mentre era in viaggio accompagnato<br />
da due monaci e da un converso, fu attaccato: l'Abbate ed il<br />
converso Ildebrando furono uccisi, uno dei due monaci fu lasciato semivivo,<br />
mentre l'altro riuscl a fuggire. Questi avvenimenti ebbero delle<br />
ripercussioni a Citeaux. Gli Abbati di Pin e di Perseigne, unitamente<br />
all'arcivescovo di Tours, furono incaricati nel 1208 di negoziare una<br />
tregua tra la Francia e l'Inghilterra per consentire a Filippo-Augusto di<br />
prendere parte alla crociata contro gli Albigesi. Nel 1216 il Capitolo<br />
Generale si ritenne in dovere di porre in atto il provvedimento di vietare,<br />
a chiunque appartenesse all'Ordine, di alzare un sol dito contro<br />
l'autorità del Signore Simone conte di Montfort « Miles Jesu Christi »,<br />
ciò che autorizza a supporre che la condotta di questo stravagante capocrociata<br />
non era esente dal suscitare delle critiche. D'altronde il medesimo<br />
Capitolo (n. 61) delegò due fra gli Abbati più moderati a ristabilire<br />
la pace fra il conte di Montfort ed il Signore di Narbonne. Quest'ultimo<br />
non è che Arnaldo-Amalrico, l'antico Abbate di Citeaux, diventato nel<br />
1212 Arcivescovo di Narbonne. I due amici d'un tempo si disputavano<br />
con accanimento il titolo di « Duca di Narbonne ». Il 2 aprile del 1215<br />
il Papa aveva stabilito che il Ducato sarebbe restato all'Arcivescovo,<br />
ma il conte fece orecchie da mercante. Ne seguì una pioggia di scomuniche,<br />
di appelli al Papa e di violenze. La faccenda non era ancora<br />
terminata alla morte di Simone. È doveroso ammettere che Arnaldo-<br />
Amalrico era dotato di un temperamento bellicoso. Non l'abbiamo forse<br />
- 184-
visto nel 1212 fare una stravagante impresa alla testa di un'armata, riprendere<br />
ai Mori la fortezza di Calatrava (30 giugno) e partecipare alla<br />
battaglia de « Las Navas de Tolosa» (14 luglio), della quale indirizzò<br />
una relazione al Capitolo Generale? Tre mesi dopo la morte di Simone<br />
di Montfort, il Capitolo diede incarico agli Abbati di Bithaine, di Noirlac<br />
e di Chalivoix di accertarsi sul posto circa la condotta degli Abbati e<br />
dei monaci predicatori di far rientrare alle loro Case quelli che non<br />
fossero in possesso di una specialissima autorizzazione del Capitolo Generale<br />
(1218, n. 35). Quanto al resto, secondo la richiesta di Amaury de<br />
Montfort, l'Ordine continuò a celebrare annualmente il 2 giugno un<br />
anniversario in suffragio di Simone di Montfort.<br />
OPERE MISSIONARIE ED EVANGELIZZAZIONE<br />
Sono poco noti i tentativi di certi cistercensi per diffondere il Vangelo<br />
nelle contrade più settentrionali dell'Europa. Si è già parlato dell'opera<br />
cistercense nel paese di Wendes. Nella seconda metà del secolo<br />
XII, un monaco di Amelunxborn, Bernone, era stato consacrato vescovo<br />
da Adriano IV che lo aveva autorizzato a predicare in suo nome la vera<br />
Fede al popolo slavo degli Abotridi. Egli si fece aiutare dai monaci del<br />
monastero cui aveva appartenuto. Questo vescovo contribui alla fondazione<br />
dei cenobi di Doberan e di Dargun e, nel corso di 35 anni, sparse<br />
con uno zelo infaticabile la Parola di Dio nel territorio della sua missione<br />
ed oltre. Morl nel 1191. L'attività apostolica di Bertoldo, antico<br />
Abbate di Loccum e vescovo di Brema che subì il martirio in Livonia<br />
nel 1198, l'abbiamo già riportata più sopra. Dopo la morte del Beato<br />
Mainardo, che aveva evangelizzato la Livonia, egli ottenne da Celestino<br />
III la facoltà di succedere al predetto Beato, e parti con alcuni dei suoi<br />
monaci alla testa di una piccola armata che aveva raccolta. Divenne vescovo<br />
di Brema nel 1190 e morl martire il 24 luglio 1198. L'abbazia di<br />
Dunamunde, detta anche di « Monte S. Nicola », in Livonia, eretta dal<br />
vescovo Alberto di Riga, fu quasi un avamposto in un paese da poco<br />
convertito alla Fede. Il suo primo Abbate corrisponde ad un nome celebre<br />
dell'apostolato cistercense: Thierry di Treiden. Fu un monaco della<br />
abbazia di Porto-Santa-Maria, nella diocesi di Brema, ed il braccio<br />
destro dei vescovi B. Mainardo e Alberto di Riga. Diventato Abbate di<br />
Dunamunde, ottenne dalla S. Sede l'autorizzazione ad associarsi dei<br />
monaci e fra questi numerosi cistercensi. Si dice che non fu mai in<br />
grado di sedere sul suo seggio episcopale nella Città di Leale. Fini col<br />
dover fuggire davanti alla ferocia dei barbari e si uni alla crociata che<br />
185 -
ilre di Danimarca aveva organizzata. Dei falsi convertiti lo massacrarono<br />
nella sua tenda nell'anno 1218, credendo di sopprimere il re. Scrive il<br />
suo biografo: «Speriamo che questo equivoco gli sia valso ad essere<br />
associato ai martiri ». Bernardo di Lippe, vescovo di Selbourg (1140-<br />
1224), fu uno dei prelati più ragguardevoli del suo tempo. Tornato sano<br />
e salvo dalla Crociata, prese l'abito monastico a Marienfeld, a seguito<br />
di un voto. Già settantenne, dopo 12 anni di vita nascosta, ottenne di<br />
partire per la Livonia come missionario a fianco del vescovo Alberto di<br />
Riga. I monaci di Dunamunde lo ebbero Abbate come successore di<br />
Thierry di Treiden. Nel 1216 fece ritorno in Westfalia ed in Renania,<br />
soggiornò ad Heisterbach dove raccontò le sue avventure al celebre Cesario,<br />
che parla di lui nel suo « Dialogus Miraculorum », quindi s'incamminò<br />
per il paese della Duna a fianco dei crociati del conte di Holstein.<br />
Onorio III credendolo in buona fede vescovo della Lettonia, lo confermò<br />
in tale dignità permettendogli di concedere indulgenze a quanti avessero<br />
preso parte alla Crociata della Lettonia. In effetti egli non era ancora<br />
vescovo, e la consacrazione episcopale la ricevette dal suo secondo figlio,<br />
Ottone, vescovo di Utrecht. Dopo innumerevoli peregrinazioni in Frisia,<br />
in Lettonia ecc., all'età di oltre 82 anni fece ritorno in Westfalia per<br />
arruolare dei crociati. Morì nella sua diocesi il 30 aprile del 1224. Il<br />
monaco Cristiano dell'abbazia di Oliva, è un'altra grande figura di missionario<br />
cistercense. Quando nel 1206 l'Abbate di Lekno-Wongrovitz si<br />
recò in territorio prussiano per riscattare dei monaci tenutivi in cattività,<br />
incontrò delle anime disposte a ricevere la verità della Fede. Allora<br />
fece domanda al papa Innocenzo III per avere la facoltà di far predicare<br />
il Vangelo. Innocenzo III gliela concesse con una lettera datata 26 ottobre<br />
1206, indirizzata ai vescovi ed agli abbati della Polonia, nella<br />
quale aggiunge: « ...ipsi auctoritate apostolica indulgemus ut fratres Cisterciensis<br />
Ordinis secum assumat et alios etiam qui cum eo voluerint<br />
accedere ad hoc opus ministerii salutaris, ut cum ipso evangelizent et<br />
baptizent ... » (PL, 215, 1011). L'Abbate scelse dunque alcuni monaci<br />
di Oliva e di Wongrovitz, fra i quali Filippo e Cristiano. In una lettera<br />
al Capitolo Generale datata lO agosto 1212, Innocenzo III si lamenta<br />
del fatto che Filippo, Cristiano ed i suoi compagni non trovavano nelle<br />
abbazie cistercensi l'accoglienza che erano in diritto di attendersi, come<br />
a dre che quei cistercensi predicatori vi erano malvisti. Il Capitolo diede<br />
incarco all'Abate di Morimond per tale faccenda raccomandandogli di<br />
soddisfare il desiderio del Sommo Pontefice senza però che « rigor Ordinis<br />
nostri enervetur ». Una tale tolleranza acconsenti ai missionari di<br />
proseguire nella loro opera. Il monaco Filippo fu massacrato dai pagani,<br />
ma Cristiano, eletto vescovo di Prussia nel 1215, lavorò per lunghi anni.<br />
- 186-
Il suo progetto era di costruire un clero indigeno, ma non fu né compreso,<br />
né aiutato. Fu tenuto prigioniero per 6 o 7 anni (1233-140) ed i Cavalieri<br />
Teutonici, ch'egli aveva bensì chiamati ma che non approvavano il suo<br />
metodo pastorale, non mossero un dito per liberarlo. Tuttavia fu spalleggiato<br />
da Gregorio IX che inviò dei Domenicani sul1uogo, ma Innocenzo<br />
IV, sulla base di false informazioni, gli indirizzò degli amari rimproveri.<br />
Affranto a motivo di queste ingiustizie più ancora che per l'instancabile<br />
lavoro, il vecchio vescovo, che fu un autentico precursore dell'apostolato<br />
moderno, si ritirò, come si ritiene, nel monastero di Sulejow,<br />
dove mori poco dopo il 4 dicembre 1244.<br />
FINE DELLA QUARTA PARTE<br />
(Traduzione dal francese di P. FULVIO ANDREOTTI, O. CIST.)<br />
- 187-
JEANDE LA CROIXBOUTON<br />
NOTEPER UNABIBLIOGRAFIADELLASTORIADELL'ORDINECISTERCENSE<br />
Riportiamo quattro schede «supplemento» che il P. Bouton ha<br />
inserito nell'edizione della sua Storia dell'Ordine cistercense e indichiamo<br />
i riferimenti alle puntate della nostra rivista (N. d. R.).<br />
r Supplemento<br />
Bibliografia per « La vita contemplativa in Oriente. Asceti - Vergini<br />
- Monaci », in riferimento alle puntate 1-3 della nostra rivista:<br />
ALLARDPaul: Saint Basile (Coll. Les Saints), Paris, Lecoffre, 7.a édiz.<br />
1939.<br />
AMANDDom David: L'ascèse monastique de saint Basile de Césarée,<br />
Ediz. de Maredsous, 1948, 364 pp.<br />
BARDYG.: Saint Antoine, in Dict. de Spiritualité, t. I, col. 702-708.<br />
BARDYG.: Saint Basile, idem, col. 1273-1283.<br />
BARDYG.: Les origines des écoles monastiques en Orient, in Mélanges<br />
Jos. de Ghellinck. Gembloux, Duculot, 1951, pp. 293-309.<br />
BARDYG.: Ascètes, in Dict, Droit canonique, t. I, Paris, 1935, col.<br />
1072-1084.<br />
BARDYG.: La vie spirituelle d'après les Pères des trois premiers siècles.<br />
Paris, s. d. (1935), in 8°, 318 pp.<br />
BERLIERE Dom U.: l'ordre monastique des origines au Xli siècles.<br />
Paris et abbaye de Maredsous, 2a édiz., 1921.<br />
BESSE Dom J. M.: Les moines d'Orient antérieurs au concile de Cbalcédoine.<br />
Paris et Poitiers, 1900, 554 pp.<br />
BESSE Dom J. M.: Bref conspectus du Monachisme orientai, in Dict.<br />
Théol. catb. art. Basile, col. 455-459.<br />
BOONDom A.: Pacbomiana latina (Bibl. Rev. Hist. eccl. Louvain, fase.<br />
7), 1932.<br />
BOUYERLouis: La vie de saint Antoine. Edt. de Fontenelle, 1950. Eccellenti<br />
punti di vista per l'inizio del monachesimo.<br />
BREMONDJ.: Les Pères du désert. Paris, Gabalda, 2 vol., 1927.<br />
BUTLERDom C.: The Lausiac History 01 Palladius. Cambridge, 1898.<br />
- 188-
CAMELOTTh.: Virgines Christi. La Virginité aux premiers siècles de<br />
l'Eglise, in La vie Spirituelle, t. XXX, 1944, stampato a parte, Paris<br />
1944, in 160,96 pp. (Le coeur et la Croix t. V).<br />
CAVALLERAF.: Apopbtegmes, in Dict. de Spiritualité, t. I, col. 765-770.<br />
CAYREF.: Précis de Patrologie, 2 voI., 1930 et 1931.<br />
CLERCQCharles de: L'influence de la règle de saint Pacbàme en Occident,<br />
in Mélanges ... Louis Halphen. Paris, 1951, pp. 169-176. Questa<br />
influenza fu relativamente minima.<br />
DANIEL-Rops: L'Eglise des Apàtres et des Martyrs. Paris, Fayard, 1948.<br />
DRAGUETRené: Les Pères du désert, Paris, PIon, 1949.<br />
DUPONT-SOMMERS.: Nouveaux aperçus sur les manuscrits de la Mer-<br />
Morte. Paris, Libr. Maisonneuve, 1953.<br />
GENIER R.: Vie de saint Euthyme le Grand (377-473). Les moines et<br />
l'Eglise en Palestine au V.e siècle. Paris, 1909.<br />
GIET S.: Les idées et l'action sociales de saint Basile. Paris, 1941, in 8°,<br />
XXI-454 pp.<br />
GOBILLOTPh.: Les origines du monachisme cbrétien et l'ancienne religion<br />
de l'Egypte, in Recherches de Science Religeuse, T. X (1920),<br />
pp. 303-354; T. XI (1921), pp. 29-86, 168-213, 328-361; T. XII<br />
(1922), pp. 46-68: Saint Pacàme a-t-il été moine de Sérapis?<br />
GOUGAUDL.: Ermites et recluso Etudes sur d'anciennes formes de vie<br />
religieuse, Ligugé, 1928.<br />
GRIBOMONTD. J.: Histoire du texte des Ascétiques de saint Basile. Bibliothèque<br />
du Muséon. Louvain, 1953, 348 pp.<br />
HERMANSDom V.: Apophtegmata seu Verba seniorum, in Collectanea<br />
OCR. 1948, X, 35-53.<br />
]ACQUINA. P.: Histoiree de l'Eglise. Paris, DescIée, t. I et II, 1928 et<br />
1936.<br />
]AEGERWerner: Two discouered Works al ancient christian Literature:<br />
Gregory 01 Nyssa and Macarius. Leyde, BrilI, 1954, 301 pp.<br />
]ANINR.: La Géographie ecclésiastique de l'Empire byzantin, t. III. Les<br />
églises et les monastères de Constantinople. Paris, 1953, 610 pp.<br />
LABRIOLLEP. de: Les débuts du monacbisme, in Histoire de l'Eglise<br />
colI. Fliche et Martin, t. III, p. 209-303. Buona bibliografia.<br />
LADEUZEP.: Etude sur le cénobitisme pacbàmien pendant le IVe et la<br />
première moitié du Ve siècle. Louvain, 1898.<br />
- 189-
LAVAUDBenoit: Antoine le Grand) Père des Moines. Ediz. de l'Abeille,<br />
Lyon, 1943.<br />
LEBRETON]. et R. ARNOU: Contemplation dans la Bible et Contemplation<br />
cbez les anciens pbilosopbes du monde gréco-romain in Dict, de<br />
Spiritualité, fase. XIII, col. 1645-1716 et 1716-1762.<br />
LEcLERcQ Henri: Monachisme, in idem, t. XI, col. 1774-1847.<br />
LECLERCQHenri: Vestale cbrétienne, in idem, t. XV, col. 2985-2989.<br />
LEFORT L. Th.: Les Vies coptes de saint Pacbàme et de ses premiers<br />
successeurs, trad. di L. Th. Lefort (Bibliothèque du Muséon, voI. 16),<br />
Louvain, 1954.<br />
LEFORTL. Th.: Les premiers monastères pacbàmiens, exploration topograpbique,<br />
in Le Muséon, t. 52, 1939, pp. 279-407.<br />
MALONEEdw. E.:The Monk and the Martyr (Studies in Christian Antiquity,<br />
12). Washington, Catholic Univo of America Press, 1950, 8°,<br />
XXI - 157 pp.<br />
MARCHALL.: Esséniens, in Suppl. al Dici. de la Bible, t. II, col.<br />
1109-1138.<br />
MARINM. A.: Les Vies des Pères des désert d'orient. Ediz. L. Veuillot,<br />
6 voI. Paris, Vivès, 1862-64.<br />
MARIN abbé: Les moines de Costantinople. Paris, 1897. Da usare con<br />
cautela.<br />
MELLET Fr. M.: L'itinéraire et l'idéal monastique de saint Augustin.<br />
Paris, s.d. (1934).<br />
METHODED'OLYMPE saint: Convivium decem oirginum, in Migne PG.<br />
t. XVIII, col. 27-220. Ediz. G.N. Bonwetsch, sotto il titolo greco Symposium,<br />
in Die griecbiscben cbristlicben Schriflsteller der ersten drei<br />
[abrbunderte, 1917, n 8° XLII-578 pp.<br />
METZ René: La consécration des oierges dans l'Egiise romaine. Etude<br />
d'bistoire de la liturgie. Paris, Presses Unversitaires de France, 1954,<br />
in 8°, 501 pp. Esauriente su questa materia. Molti riferimenti sulle<br />
prime comunità di vergini nel secolo IV.<br />
NGUYENNGOGNGAI: Au son des gongs) in Témoignages (La Pierre-<br />
Qui-Vire ,n° 43), maggio 1954, pp. 206-213. Mostra ilcarattere ateo del<br />
monachesimo buddista contemporaneo.<br />
NIGGWalter: Vom Geheimnis der Monche. Artemis Verlag, Miinchen<br />
e Stuttgart, 1953, 421 pp.<br />
OLPHE-GALLIARMichel: Cassien, in Dict. de Spiritualité, col. 214-276.<br />
- 190-
PAULOTMgr.: La virginité cbrétienne, in La Vie Spirituelle, aprile 1958,<br />
p.402.<br />
REscH P.: La doctrine ascétique des premiers Mattres égyptiens du IVe<br />
siècle. Paris, 1931.<br />
RIVIERE J.: Saint Basile} éuéque de Césarée iLes Moralistes cbrétiensi.<br />
Paris, Gabalda, 1925.<br />
SCHMITZDom Philibert: La première communauté de uierges à Rome,<br />
in Rev. Bénédictine, 1926 XXXVIII, 189-195.<br />
STEINMANNJean: Saint [ean-Baptiste et la spiritualité du désert. Edit.<br />
du Seuil. Paris, 1955, 192 pp., ilI.<br />
VAN GAUWENBERG:Etude sur les moines d'Egypte après le concile de<br />
Chalcédoine jusqu'à l'inuasion arabe. Louvain, 1914.<br />
VIZMANOSF. de B.: Las uirgenes cristianas de la Iglesia primitiva, Estudio<br />
bistorico-ideologico seguido de una antologia de tratados patristicos<br />
sobre la virginidad (in B.A.C. voI. 45), Madrid, 1949, in 8°<br />
XXIV-1308 pp.<br />
VOOSENE.: Les persécutions romaines. Etat de la question, in Reuue<br />
diocésaine de Namur, 1958, XII, pp. 132-154 et 471-487.<br />
Antonius Magnus Eremita 356-1956 (Studia ad antiquum monachismum<br />
spectantia, cura Basilii Steidle OSB), in Studia Anselmiana, fase.<br />
XXXVIII. Roma, Herder, 1956, in 8°, XIII - 306 pp.<br />
Il Monachesimo orientale (Atti del Convegno di Studi Orientali che sul<br />
predetto tema si tenne a Roma sotto la direzione del Pontificio Istituto<br />
Orientale nei Giorni 9, lO, Il e 12 aprile 1958). Pont. Inst. Orientalium<br />
Studiorum, Piazza Santa Maria Maggiore 7 (Coli. Orientalia<br />
Christiana Anacleta 153). Roma 1958, in 8° 364 pp.<br />
Ir Supplemento<br />
Bibliografia per « Il monaehesimo occidentale prima della fondazione<br />
di Citeaux », in riferimento alle puntate 4 - 7 della nostra rivista:<br />
AULINGERGislar: Das Humanum in der Benedikts von Nursia. Eine<br />
moralgeschichtliche Studie (Coll. Kircbengescbicbtlicbe Quellen und<br />
Studien 1). St. Ottilien, Eos Verlag, 1950,8°, XXIV - 249 pp.<br />
BARDYGustave: Les origines des écoles monastiques en Occident, in<br />
Sacris Erudiri 5, 1953, pp. 86-104.<br />
- 191
BAUERREIS Dom R.: Bibliographia Benedictina 1939-1958, in Studien<br />
und Mitteilungen z. Geschichte des Benediktiner-Ondens, 64, 1952,<br />
pp. 29-127.<br />
BERLIERE Dom U.: L'ordre monastique des origines au XII e siècle.<br />
Paris, Lethielleux, e Maredsous, 1921.<br />
BOUYER Louis: Le sens de la vie monastique. Ediz. Brépols. Turnhout.<br />
Paris, 1950.<br />
BUTLER Dom C.: Le Monachisme bénédictin, trad. Grollenu, Paris, De<br />
Gigord, 1924.<br />
CASSIEN: Collationes, trad. Pichery. ]uvizy, 1921-23. Nuova ediz.<br />
« Sources chrétiennes 12 », Paris, édit. du Cerf 1955, 8°, 1 voI. conf.<br />
l-VIII, 282 pp.<br />
CASSIEN: De Institutis Coenobiorum, trad. Pichery. Juvizy, 1925.<br />
CHAGNYAndré: Cluny et son empire, 4a édiz. Paris, Vitte, 1949 (Biblio)<br />
CHAMPLYI.H.: Histoire de l'abbaye de Cluny. Paris, Libr. des Sciences,<br />
3 ediz. 1930.<br />
COLLINET: La règle de saint Benoit et la législation de ]ustinien, in<br />
Rev. d'Rist. des religions, t. CIII-XIV, 1931, pp. 272 sq.<br />
COLOMBASGarda, SANSEGUNDOLeon y CUNILL Odilon: San Benito, su<br />
vida y su regia (B.A.C.) Madrid. La Editorial catolica, 1954, 8°, XX<br />
- 760 pp.<br />
COURTOIS Christian: L'éuolution du monacbisme en Gaule de s. Martin<br />
à s. Colomban, in Il Monachesimo nell' alto Medioevo... Spoleto,<br />
1957, pp. 47-72.<br />
CRISTIANI Chan: Lérins et ses [ondateurs. Ediz. de Fontanelle, 1946.<br />
CRISTIANI Chan: Casien, édiz. de Fontanelle, 2 voI. 1946.<br />
DUBAR Luc: Recherches sur les olfices du monastère de Corbie jusqu'à<br />
la fin du Xllle siècle. Paris, Piccard, 1948, 8°, 196 pp.<br />
DUBLER Elisabeth: Das Bild des beiligen Benedikt bis zum Ausgang des<br />
Mittelalters (Benediktinisches Geistesleben 4) St. Ottilien, Eos Verlag,<br />
1953, 8°, XIV - 188 pp. 150 ill.<br />
DucKETT Eleanor Shipley: Saint Dunstan 01 Canterbury, A Study 01<br />
Monastic Rejorm in the Tenth Century. New York, Norton, 1955,<br />
8°, XI - 249 pp.<br />
S. GREGOIRE le Gd.: Vie et miracles du bienheureux Père saint Benoit,<br />
Edit. de la Source, Paris, 1952.<br />
- 192
HALLINGER D. Kassius: Gorze-Kluny. ColI. Studia Anselmiana, fase.<br />
22-23, 2 vol., Roma, Herder ,1950-51.<br />
HERWEGEN D. Ildefons: Saint Benoit, trad. Alibertis et de Varey. Desclée,<br />
1925.<br />
HILPISCH Stephanus: Geschichte der Benediktinerinnen (ColI. Benediktinisches<br />
Geistesleben), St. Ottilien, Eos Verlag, 1951, 12°, VIII -<br />
136 pp.<br />
RODUM A.: La réforme monastique d'Arnoul le Grand) compte le Flandres<br />
(estr. del Bull. Soc. acad. des Antiquaires de la Morinie 18),1957,<br />
27 pp. Traduzione in francese di uno sudio pubblicato in olandese nel<br />
1945.<br />
]ACQUIN A. M.: Histoire de l'Eglise, Desclée, t. II 1936 e t. III, 1948.<br />
KLEINCLAUSZ A.: Alcuin. Paris, Les Belles Lettres, 1948, 317 pp.<br />
KLOTZ G.: Histoire du Moyen-Age, t. I: Les destinées de l'Empire en<br />
Occident. Paris, Presses Univo 1928.<br />
LAFONTAINEP. H.: L'Evéque d'ordinations des Religieux des débuts du<br />
monchisme à la mort de Louis le Pieux. Ottawa, Ediz. de l'Université,<br />
1951, 8°, 267 pp.<br />
LAUGHLINTérence P. Mc.: Le très ancien Droit monastique de l'Cccident<br />
Coll. Archives de la France Monastique t. XXXVIII, Ligugé,<br />
1953, 273 pp.<br />
LECCISOTTI Tomm.: Il sepolcro di San Benedetto (Miscellanea Cassinese,<br />
27), 1951, 8°, 247 pp. ill.<br />
LECLERCQ Henri: Eugyppius, in Dict. Archéol. chrét. et lit. t. V, col.<br />
702-704.<br />
LECLERCQ Henri: Monachisme, in idem, t. XI, col. 1774-1947.<br />
LEMARIGNIER]. F.: Etude sur les privilèges d'exemption et de juridiction<br />
ecclésiastique des abbayes normandes depuis les origines [usqu'en 1140.<br />
ColI. Archives de la France Monastique) t. XLIV, 1937.<br />
LESNE E.: Histoire de la proprieté ecclésiastique en France. Lille, t. II:<br />
La propriété ecclésiastique et les droits régaliens, 3e fase. 1928; t. V:<br />
Les Ecoles, 1940.<br />
LUBECK Konrad: Fuldaer Studien. Fulda, Parzeller, 2 voI. 1949-50, in<br />
8°, 206 et 257 pp.<br />
MONTALEMBERTcomte de: Précis d'Histoire monastique. Version inédite<br />
primitive des Moines d'Occident, revue et misé à jour par les Bénéditins<br />
d'Oosterbout. Paris, Vrin, 1934.<br />
- 193-
MONTALEMBERTE. compte de: Les moines d'Occident, 7a ediz. Paris, Lecoffre,<br />
1892 .<br />
•<br />
MOREAUE. de: Les abbayes de Belgique (VIIe-XIIe siècle). Bruxelles,<br />
La Renaissance du Livre. 1952, 12\ 164 pp.<br />
PEREZDEURBELDom Justo: Historia de la Orden Benedictina. Madrid,<br />
Editorial FAX, 1941, in 4°, 747 pp. Il capitolo sull'ordine cistercense<br />
è completo.<br />
RAMONI ARRUFATDom Antoni: L'ordre monastique des origines au<br />
Xlle siècle. Montserrat 1925 (Biblioteca Monastica voI. VI) in 8°, 328<br />
pp .<br />
•<br />
SCHMITZDom Philibert: Histoire de l'Ordre de saint Benoit, ediz. di<br />
Maredsous, t. I e II, 1942, e t. VII (moniales), 1956.<br />
SCHREIBERGeorg: Gemeinschaften des Mittelalters, Regensburg, Miìnster<br />
1948, 488 pp.<br />
SCHUSTERcardinal: Saint Benoit et son temps, trad. Gai, Ediz. Robert<br />
Laffont, Paris, 1950.<br />
SCHUSTERcardinal: La vie monastique dans la pensée de saint Benoit,<br />
trad. Robert Gantoy. Paris, Plon, 1953.<br />
SCHUSTERM.: Eugippius. Leben des beiligen Severino Testo latino, trad.<br />
e note. Wien, Sexl., 1946, 198 pp.<br />
STEIDLEBasilius: Vie Regel St. Benedikte, eingeleitet, iibersetzt und am<br />
dem alten Monchtum erklart: Beuron, Kunstverlag, 1952, in 12°,<br />
XIV - 343 pp.<br />
VALOUS G. de: Le Monachisme clunisien des origines au XV e siècle.<br />
Coll. Archives de la France Monastique, t. XXXIX et XL, 2 vol., 1935.<br />
VAN HOUTRYVEIdesbald: L'unique nécessaire d'après saint Benoit, la<br />
tradition monastique et les grands maitres de la vie spirituelle. Bruges,<br />
Beyaert, 1957 ,8° 340 pp.<br />
WARRENH. B. de: Le monachisme bénédictin à l'apparition de saint<br />
Bernard, in Bernard de Clairuaux. Abbaye d'Aiguebelle et Paris, Alsatia,<br />
1953, pp. 45-63.<br />
ZUMKELLERA.: Vas Monchtum des hl. Augustinus iCassiciacum, XI,<br />
prima serie, voI. 5) Wurtzbourg, Augustinus Verlag, 1950, 8°, 387 pp.<br />
Mélanges Colombaniens, Actes du Congrès International de Luxeuil.<br />
Paris, Alsatia, 1951, 8°,419 pp.<br />
[umièges, Congrès scientifique du Xllle centenaire. Rouen, Lecerf, 1955,<br />
8°, 2 voI. XIV - 1070 pp.<br />
Sankt Bonifatius. Gedenkgabe zum zioblibundersten Todestag, hrggb.<br />
- 194-
von der Stadt Fulda in Verbindung mit den Diozesen Fulda und Mainz.<br />
Fulda, Parzeller, 1954,4°, XII - 686 pp.<br />
Il Monachesimo nell'alto Medioevo. Spoleto, 1957.<br />
Commentationes in Regulam S. Benedicti, Cura Basilii Steidle O.S.B.,<br />
in Studia Anselmiana, fase. XLII. Roma, Herder, 1957, 358 pp.<br />
Studi Gregoriani per la storia di Gregorio VII et della riforma gregoriana,<br />
raccolti da G. B. Borino, t. IV, Roma, A. Signorelli, 1952, 8°, 468<br />
pp.; t. V. Roma, abbazia di S. Paolo, 1956, 8° 115 pp.<br />
Le Message des moines à notre temps. Mélanges offerts à Dom Alexis<br />
abbé de Boquen. MCMLVIII. Paris, Fayard, 387 pp.<br />
IIr Supplemento<br />
Bibliografia per « La fondazione dell'abbazia di Citeaux », in riferimento<br />
alle puntate 8 - lO della nostra rivista:<br />
ALBERICFr.: Compendium of the history of the Cistercian Order. 1944,<br />
in 8°, 375 pp.<br />
BERLIEREDom U.: L'Ordre monastique des origines au Xlle siècle. Cap.<br />
VI: L'Ordre de Citeaux. Paris, 1921, 3 ediz. 1924.<br />
BERLIEREDom U.: Les origines de l'Ordre de Citeaux et l'Ordre bénédictin<br />
au XIIe siècle, in Revue Hist, eccl. Louvain, t. I, 1900, pp. 448-<br />
471 e t. II, 1901, pp. 253-290.<br />
BEssE Dom. J. M.: Cisterciens, in Dict. Théol. cath. Letouzey, t. II,<br />
col. 2532-2550.<br />
(BEssE Dom): Recueil bistorique des Arcbeuécbes, Euécbés, Abbayes et<br />
Prieurés de France par Dom Beaunier. Edition reoue et complétée.<br />
lntroduction (Coll. Archives de la France Monastique, t. IV), Paris e<br />
Ligugé, 1906. Cisterciens, pp. 136 à 184, con Bibliografia.<br />
BONDUELLEJ.: Conuers, in Dict. Droit Canon. Letouzey, 1949, t. IV,<br />
col. 562-588.<br />
BOUYERLouis: La Spiritualité de Citeaux, Paris, 1955.<br />
BURCHARD:Apologia de Barbis, ediz. E. Ph. Goldschmidt. Cambridge.<br />
1935.<br />
CANIVEZJ.: Clteaux, in Dict. Hist, Géog. eccl., col. 852-997, con Bibliografia.<br />
CANIVEZJ.: Albéric, in Dict. de Spiritualité. Beauchesne, t. I, 276-277<br />
- 195-
CANIVEZJ.: Le rite cistercien, in Ephemerides Liturgicae, 1949, LXIII,<br />
276-311.<br />
CHASLESM.: Etude sur l'institut monastique des [rères convers et sur<br />
l'oblature au Moyen-Age, leur origine et leur réle (XIe-XIIIe s.) Scuola<br />
di Chartes. 1906, pp. 13-49.<br />
COOKEAlice: A Study in tuielith century religious revivay and rejorm,<br />
in Bull. 01 the fohn Ryland's Library, 1925, voI. IX, pp. 139-176.<br />
DELEHAYE Fernand: Un Moine: saint Robert, [ondateur de Citeaux,<br />
in Collectanea OCR. 1952, XIV, 83-106.<br />
DONNELLYJames S.: The Decline 01 the medie val Cistercian Laybrotberhood.<br />
Fordham University Studies. New York, 1949, 95 pp. con importante<br />
Bibliografia.<br />
DUCOURNEAUOthon: Les origines cisterciennes, in Revue Mobillon, t.<br />
XXII et XXIII, stampato a parte, Ligugé 1933.<br />
DUCOURNEAUOthon: De l'Institution et des Us des conoers, in Saint<br />
Bernard et son temps. Dijon, 1929, t. II, pp. 139-201 (il più importante<br />
studio sulla questione).<br />
DUCURNEAUOthon: Histoire de l'Ordre de Cùeaux. Etudes critiques,<br />
I. Les origines. II. Vie intime de l'Ordre. Ms. 403 pp. negli archivi<br />
dell'abbazia di Aiguibelle.<br />
DUVERNAYRoger: Citeaux, Vallombreuse et Etienne Harding, in Analecta<br />
SOCI VIII, 1952, pp. 379-495.<br />
FLICHE Aug.: Histoire de l'Eglise. Paris, Bloud e Gay, t. VIII.<br />
FOLZ Robert: Le problème des origines de Czteaux, in Mélanges Saint<br />
Bernard, Dijon, 1955, pp. 284-294.<br />
GRISSER P. Bruno: Consuetudines domus cisterciensis, in Analecta<br />
SOC, III, 138-146.<br />
GUIGNARDPhilippe: Les Monuments primitijs de la Règle cistercienne.<br />
Dijon, 1878.<br />
HALLINGERP. Cassius: W ober kommen die Laienbrùder? in Analecta<br />
SOC. XII; 1956, pp. 1-104 (origine dei conversi: Vallomhreuse,<br />
Chartreuse, Cluny, Citeaux etc.).<br />
HERMANS D. Vincent: Spiritualité monastique. Rome, 1954.<br />
HOFFMANNEh.: Das Konverseninstitut des Cistercienserordens. Fribourg<br />
1905, 101 pp.<br />
HUMPFNER R. Tiburtius: Die Bibel des hl. Stepban Harding, in Cistercienser<br />
Cbronik, 29,1917, pp. 73-81.<br />
- 196-
JAILLARD P. Bruno: Quelques notes sur la vie des convers de Citeaux au<br />
Xlle et au Xllle siècle. Ms. de Sept Fons, 1949.<br />
KING Archdale: Citeaux and ber Elder Daugbters. London, Burns and<br />
Oates, 1954.<br />
LAURENT Jacques: Cartulaires de l'abbaye de Molesme. 2 voI. Paris,<br />
1907-11.<br />
LAURENT Jacques: Le problème des commencements de Citeaux, in<br />
Annales de Bourgogne, 1934, VI, 213-229.<br />
LECLERCQ Dom Jean: Ecrits monastiques sur la Bible aux Xle - XIIle<br />
siècles, in Medieval Studies, 1953, XV, 95-106.<br />
LEFEVRE J. A.: Les traditions manuscrites des Usus conversorum de<br />
Citeaux au Xlle siècle, in Collectanea OCR. 1955, XVII, 11-39.<br />
LEFEVRE J. A.: Saint Robert de Molesme dans l'opinion monastique<br />
du Xlle et du XIIle siècle, in Analecta Bollandiana, LXXIV, 1956,<br />
pp. 50-83.<br />
LEKAI Louis: The White Monks. Okauchee Wis. USA. 1953. Trad.<br />
francese Les moines blancs. Ed. du Seuil, Paris, 1957, 384 pp. 9<br />
carte.<br />
LENSSEN P. Séraphin: Saint Robert, le fondateur de Citeaux, in Collectanea<br />
OCR. IV, ano 1937 stampato a parte Westmalle 1937. (analisi<br />
critica di J. Laurent in Annales de Bourgogne, XII, 1940, pp.<br />
31-36).<br />
(LE PREVOST) P. Aloys: Esquisse de l'Ordre cistercien. Ribérac, Réjou,<br />
1914, 34 pp.<br />
MAHN J. Berthold: L'Ordre cistercien et son gouuernement des origines<br />
au milieu du XIIle siècle 1098-1265. Paris, De Boccard, 1945, ristampa<br />
nel 1951.<br />
MALMESBURY Guillaume de: Gesta Regum Anglorum, lib. IV, $ 334<br />
in Migne PL. 179, col. 1286-1290, De Cisterciensibus.<br />
MANRIQUE Ange: Annales cisterciennes. Lyon, 1612-49, t. I.<br />
MARILIER Jean: Chartes et Documents de l'abbaye de Citeaux. 2 fase.,<br />
Hauteroche, 1950.<br />
MARILIER Jean: Les débuts de l'abbaye de Citeaux, in Les débuts des<br />
abbayes cisto dans les anc. Poys bourguignons, comtois et romands.<br />
Dijon, 1955, pp. 71-76.<br />
MARILIER Jean: La vocation, in Bernard de Clairuaux. Abbaye d'Aiguebelle<br />
e Paris, Alsatia, 1953, pp. 29-37.<br />
- 197-
MARTIN P.: Saint Etienne Harding et les premières recenstons de la<br />
Vulgate Latine. Amiens, 18~7.<br />
MULHERNPh. F.: Origines des [rères conuers, in La Vie Spirituelle.<br />
Suppl., n. 22, 15 setto 1952, pp. 302-318.<br />
MULLER P. Gregor: Die Grundung des Abtei Citeaux. Bregenz, 1898.<br />
MULLER P. Gregor: Clteaux unter dem Abte Albericb, Bregenz, 1909.<br />
NOBLETD. A.: Sur l'institution des [rères convers, in Revue Mabillon,<br />
t. II, 1906, pp. 83-93.<br />
ORDERIC Vital: Historia ecclesiastica, lib. VIII, in Migne PL. 188,<br />
col. 636.<br />
OURSEL C.: La miniature du Xl.Ie siècle à l'abbaye de Citeaux, Dijon,<br />
1926.<br />
OUSREL C.: Les principes et l'esprit des miniatures primitives de Citeaux,<br />
in Citeau» in de Nederlanden, VI, 1955, pp. 161-172.<br />
PARKEN Mason W. A.: The beginnings 01 the Cistercienser Order<br />
(Transactions 01 the Royal Historical Society). London, 1905, t. XIX,<br />
pp. 169-207.<br />
PRESSE Dom Alexis: Une école de sainteté cbez les Cisterciens, in<br />
La Vie Spirituelle, 1932, XXII suppl. pp. 96-106.<br />
ROCHEMONTEIXA. de: La maison de Graule de l'Ordre de Citeaux.<br />
Etude sur la vie des convers de Citeaux en Auvergne. Paris, 1888,<br />
in 8°, 294 pp.<br />
SALMONDom P.: L'ascèse monastique et les débuls de Citeaux, in<br />
Mélanges Saint Bernard, Dijon, 1954, pp. 268-283.<br />
SPAHRP. Colomban: Das Leben des hl. Robert von Molesme. Freiburg,<br />
1944. : .. ·'·1<br />
SPAHRP. Colomban: De Fontibus constitutiuis primigenii iuris constitutionalis<br />
sacri Ordinis cisterciensis. Roma, 1953.<br />
TURK Mgr Josip: Cisterciensium [ratrum I nstituta, in Cistercienser<br />
Chronik, LII, 1940~pp. 101-107, 118-123 e 132-141.<br />
TURK Mgr Josip: Cistercii Statuta antiquissima, in Analecta SOc. IV,<br />
1948, 158 pp.<br />
WATKINWilliam: The first Cistercian Era (Journal 01 Theological Studies,<br />
1930, t. XXXII, pp. 56-61).<br />
W ARRENH. B. de: vedere Bibliografia 2.<br />
- 198-
IV supplemento<br />
Bibliografia per «La formazione e l'organizzazione dell'Ordine<br />
di Citeaux » in riferimento alle puntate 11-14 della nostra rivista:<br />
BEAUFORT Gérard de: La cbarte de charité cistercienne et son évolution<br />
in Rev. ni« eccl. Louvain, 1954, XLIX, 391-437.<br />
BERLIERE Dom U.: vedere Bibliografia 3.<br />
BESSE Dom J. M.: vedere Bibliografia 3.<br />
Bocx P. Colomban: Les codificatione du Droit cistercien, in Collectanea<br />
OCR, anni 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954 passim.<br />
BOUTON P. Jean de la Croix: Saint Bernard et les moniales, in Mélanges<br />
Saint Bernard. Dijon, 1954, pp. 225-248.<br />
Botrrox P. Jean de la Croix: L) établissement des moniales cisterciennes,<br />
in Les débuts des abbayes cisto dans les anciens pays bourguignons)<br />
comtois et romands (XXIVe Congrès de l'ABSS, VIII centenario<br />
di S. Bernardo). Dijon, 1955, pp. 37-70.<br />
BRARD P. Bruno: Cisterciens et Cisterciennes, in Catbolicisme 7, col.<br />
1141-1151.<br />
CANIVEZ Jos.: Statura Capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis ab<br />
anno 1116 ad annum 1786. Louoain, 8 vol., 1933-1941.<br />
Chimay (Les moines de): La Bibliographie de saint Etienne Harding,<br />
in Collectanea OCR. 1934, I, 36 sq.<br />
DALGAIRNS J. D.: Saint Etienne Harding, vie édit. par le Reo. [, H.<br />
Newman. Paris, Lecoffre, e Lyon, Libr. Chrét., 1846, 320 pp.<br />
DUVERNAYRoger: vedere Bibliografia 3.<br />
Etienne Harding (Vie de St). N. D. de Lérins, 1875, 252 pp.<br />
FLICHE Aug.: vedere Bibliografia 3.<br />
FOLZ Robert: vedere Bibliografia 3.<br />
GOMEZ P. Alberto: Super Chartam Caritatis d'après Analecta 1945, in<br />
Cistercium, 1950, II, 47-51.<br />
GRIESSER P. Bruno: Beitrdge zur Beurteilung des Cod. 1711 von Trient,<br />
in Citeaux in de Nederlanden, 1955, VI, 117-130.<br />
HAID D. Kassian: Die Bedeutung des hl. Stephan, in Cistercienser<br />
Chronik, XLVI 1934, pp. 57-63.<br />
HAID D. Kassian: Vor 800 [abren Zum Abschluss des Stepbans [ubilaums,<br />
in idem, pp. 369-375.<br />
199 -
HERBLAYA. d': Le problème des origines cisterciennes, in Rev. Hist,<br />
eccl. Louvain, 1955, L. 158-164. Difende la tesi di ]. A. Lefèvre<br />
contro G. de Beaufort.<br />
HERMANSD. Vincent: vedere Bibliografia 3.<br />
HOURLIERD. ]acques: Le Cbapitre général jusqu'au moment du Grand<br />
Schisme. Tesi per il dottorato. Paris, Sisey, 1936, in 8°, XIII-284 pp.<br />
HUMPFNER P. Tiburtius: Der bisher vermisste teil des Exordium magnum<br />
S.O.C. Pars bucusque ignota Exordii Magni. Bregenz, Teutsch,<br />
1908, in 8°, 14, pp.<br />
HUMPFNER P. Tiburtius: Exordium Cistercii cum Summa Cartae Caritatis<br />
et fundatio primarum quattuor filiarum Cistercii. Kapisztran<br />
Nyomda. Vac, 1932, in 8°, 29 pp.<br />
HUYGHEGérard: La clàture des moniales des origines à la fin du Xllle<br />
siècle. Roubaix. 1944, 117 pp.<br />
]ANAUSCHEKP. Leopold: Originum Cisterciensium tomus 1. Wien,<br />
1877.<br />
]ASSMEIERJ.: Das Mitbestimmungsrecht der Untergebenen in den alteren<br />
Miinnerordensverbanden (Miìnchener theologische Studien, III:<br />
Kanonisliche Abteilung. 5. Miinchen, Karl Zink; 1954, in 8°, x-302<br />
KINGArchdale: vedere Bibliografia 3.<br />
KOCH P. Konrad: Vollstandiges Brevier aus der Schreibstude des hl.<br />
Stephan, in Analecta SOC. 1946. II, 146-147.<br />
KOVACSFrançois: Fragments du chant cistercien primiti], in Analecta<br />
SOC., 1950, VI, 140-150.<br />
KOVACSFrançois: Relation entre l'Officium defunctorum feriale et la<br />
liturgie cistercienne primitive, in Analecta SOc., 1951, VII, 78-84.<br />
KOVACSFrançois: A propos de la date de la rédaction des Instituta<br />
generalis Capitali apud Cistercium, in Analecta SOC., 1951, VII,<br />
85-90.<br />
LAGGERL. de: Le Règle mitigée de Citeaux au Xlle siècle. A propos<br />
d'Ardorel en Albigeois, in Bull. litt. eccl. Toulouse, 1922, pp. 187-<br />
211.<br />
LAURENTJacques: vedere Bibliografia 3.<br />
LE BAIL Dom Anselme: La célébration du VIlle centenaire de la mort<br />
de S. Etienne Harding de Clteaux, in Collectanea OCR., 1934, I,<br />
154 sq.<br />
- 200-
LECLERQ Dom Jean: Epitres d'Alexandre III sur les Cisterciens, in<br />
Rev. Bénédictine, 1954, LXIV, 68-82.<br />
LEFEvRE J. A.: La uéritable Carta Caritatis primitive et son éuolution<br />
1114-1119, in Colleetanea OCR, 1954, XVI, 5-29.<br />
LEFEvRE J. A.: La oéritable Constitution cistercienne de 1119, in idem,<br />
77-104.<br />
LEFEVRE J. A.: A propos de la composition des Instituta generalis Capituli<br />
apud Cistercium, in idem, 157-182.<br />
LEFEVRE J. A.: Pour une nouvelle datation des Instituta generalis Capituli<br />
apud Cistercium, in idem, 241-266.<br />
LEFEVRE J. A.: Les traditions manuscrites des Usus conversorum, in<br />
idem, 1955, XVII, 11-39.<br />
LEFEVRE J. A.: L'évolution des Usus conversorum de Cùeaux, in idem,<br />
65-97.<br />
LEFEVR.E J. A.: Un texte inconnu de l'Exordium Cistercii et de la Summa<br />
CC, nel ms. Melun 55, in idem, 265-271.<br />
LEFEVRE J. A.: A propos des sources de la législation primitive de Prémontré,<br />
in Anal. Praem., 1954, XXX, 12-19.<br />
LEFEVRE J. A.: Le urai récit primiti] des origines cisterciennes est-il<br />
l'Exordium Parvum? in Le Moyen Age, 1955, pp. 79-120 et 329-<br />
361. Lista dei mss. de l'Exordium Paroum.<br />
LEFEVRE J. A.: A propos d'un nouveaux texte de la CC prior dans le<br />
ms. Metz 1247, in Rev. Bénédictine, 1955, pp. 90-109.<br />
LEFEVRE J. A.: Une Bulle inconnue d'Alexandre III dans le ms. Dijon<br />
87, in Cistercienser Chronik, 62. 1955, pp. 1-7.<br />
LEFEVRE J. A.: S. Robert de Molesme dans l'opinion monastique du<br />
Xlle e du Xllle siècle, in Anal. Bollandiana, 1956, LXXIV, 50-83.<br />
LEFEVRE J. A.: Que savons-nous du Citeaux primitif? in Rev. Rist.<br />
eccl. Louvain, 1956, LI, 5-41.<br />
LEFEVR.E J. A.: Les traditions manuscrites de l'Exordium Parvum, in<br />
Scriptorium, 1956, X, 42-46.<br />
LEKAI Louis: vedere Bibliografia 3.<br />
LUYKX B.: Essai sur les sources de l'Ordo missae Praemonstratensis,<br />
in Anal. Praem., 19-46, XXII-XXIII, pp. 35-97.<br />
MAGYARASZ F.: Der hl. Stepban Harding und der hl. Bernbard, in<br />
Cistercienser Chronik, 36, 1934, p. 169 sq.<br />
MAGYARASZ F.: Ein hohes und beiliges Ordensjubileum, in idem, 8-11.<br />
- 201-
MAHNJ. B.: vedere Bibliografia 3.<br />
MALET Dom André: La liturgie cistercienne. Westmalle, 1921, in 8°,<br />
57 pp.<br />
MALMESBURYGuillaume: vedere Bibliografia 3.<br />
MARILIERJean: Quelques précisions sur les commencements de Citeaux.<br />
Les donations d'Elisabeth de Vergy, in Annales de Bourgogne, 1914,<br />
XVI, 28-36 . Vedere anche Bibliografia 3.<br />
MARILIERJean: Autour de la Carta caritatis, in Annales de Bourgogne,<br />
1954, XXVI, 218-220 - Les Cisterciens, in idem, 1957 XXIX, p. 132.<br />
MARILIERJean: L'évolution des institutions cisterciennes dans la 1ère<br />
moitié du Xlle siècle. (Académie des Arts, Sciences et Belles-Lettres<br />
de Dijon, communic. du 21.1.1948).<br />
MAROSSZEKIP. Solutor: Les origines du chant cistercien. Recherches sur<br />
les réjormes du plain-cbant cistercien au Xlle siècle, in Analecta SOCI<br />
1952, VIII, fase. I-II, et Paris, 1951, 196 pp.<br />
MARTINP.: vedere Bibliografia 3.<br />
MASAI F.: Les études cisterciennes de ]. A. Lejèure, in Scriptorium,<br />
1957, XI, 119-123.<br />
MULLER P. Gregor: Aus den letzten Lebensjahren des hl. Stephan Abts<br />
von Citeaux, in Cistercienser Chronik, 46 Jahrg. 1934, pp. 1-8.<br />
MULLER P. Gregor: Studiens iiber das Generalkapitel, in Cistercienser<br />
Cbronik, passim.<br />
MULLER P. Gregor: Generalkapitel der Cistercienserinnen, in Cistercienser<br />
Cbronik, 24.1912, pp. 65-72, 114-119,152-157.<br />
NOBLET Dom: L'hymnaire cistercien, in Revue Mabillon, 1906, II,<br />
93-96.<br />
NOSCHITZKAP. Canisius: Codex manuscriptus 31 Bibliotbecae Universitatis<br />
Labacensis, in Analecta SOC. 1950, VI, 1-124.<br />
PETIT Ernest: Histoire des ducs de Bourgogne. Dijon, t. I e II, 1885 e<br />
1888, e t. V, 1894 (Obituaire de Citeaux, pp. 396-407).<br />
PRESSE Dom Alexis: S. Etienne Harding, in Collectanea OCR. 1934,<br />
1, 21 sq.<br />
PRESSE Dom Alexis: Notes sur le culte liturgique rendu à S. Etienne<br />
Harding dans l'Ordre de Citeaux, in Cisto Cbronik, 46. 1934, pp.<br />
105-108.<br />
RENAUDP. Nivard: Les liores liturgiques cisterciens. Etude bistorique<br />
et canonique, in Collectanea OCR, anno 1936,1937,1938,1939,1940<br />
passim.<br />
- 202-
RODRIGUEZLoPEZ A.: El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y<br />
el Hospital del ReYJ T. I e II, Burgos, 1907.<br />
SCHNEIDERP. Fulgence: L'ancienne messe cistercienne. Tilburg, 1929,<br />
in 8°, 264 pp.<br />
SEJALONP. Hugues: Nomasticon Cisterciense. Solesmes, 1892.<br />
SPAHR P. Colomban:Eine seltsame Formung des Exordium Parvum.<br />
Revue d'Hist, ecci. Suisse, 1946, in 8°, pp. 101-108. Vedere anche la<br />
Bibliografia 3.<br />
TRILHE D. Robert: Liturgie de l'Ordre de Citeaux, in Dict. Hist. Géog.<br />
eccl., fase. XXIX, col. 1779-1811.<br />
TURK Mgr Josip: Charta caritatis prior, in Analecta SOC. 1946, I,<br />
pp. 11-61. Vedere anche Bibliografia 3.<br />
VANDAMME P. Jean Bapt.: Autour des origines cisterciennes, in Collectanea<br />
OCR. 1958, XX, 37-60, 153-168, 374-390.<br />
VANDI]K L.: Essai sur les sources du droit prémontré primiti] concernant<br />
les pouuoirs du «Dominus Praemonstratensis » in Analecta<br />
Praem., 1952, XXVIII, 73-136.<br />
WEINMANNC.: Hymnarium Parisiense. Das Hymnar der Cistercienser-<br />
Abtei Pairis im Elsass. Ratisbonne, Coppenrath, 1905, in 8° VIII,<br />
73 pp. et 1 pl.<br />
WILLEMS Dom Eugène: Esquisse historique de l'Ordre de Citeaux de<br />
après le Père Grégoire Muller. Edition illustrée, rejondue et mise à<br />
jour. Abbaye du Val-Dieu, Aubel. Dison-Verviers (Belgique), Prima<br />
parte 1097-1493, in 8°, 274 pp.<br />
WINANDYRme Jacques: Les origines de Cùeaux et les trauaux de M.<br />
Lejèure, in Rev. Bénédictine, 1957, LVII, 49-76.<br />
Segnala le « dangereuses faiblesses » del sistema elaborato da M. J. A.<br />
Lefèvre.<br />
CONTINUA<br />
- 203-
RECENSIONI<br />
AA. VV. Dizionario degli Istituti<br />
di perfezione - Ed. Paoline -<br />
Roma 1975 - voI. II pp. XXV<br />
colI. 1972, L. 36.000<br />
Il secondo volume del « Dizionario<br />
» non riesce ad esaurire la<br />
lettera « C », ma va tenuto presente<br />
che in questa lettera si presentano<br />
numerose voci assai impegnative,<br />
che esigono una trattazione<br />
abbastanza diffusa. Vengono<br />
innanzitutto grandi Ordini religiosi:<br />
Canonici Regolari, Chierici<br />
Regolari, Cappuccini, Carmelitani,<br />
Certosini, <strong>Cistercensi</strong>, Compagnia<br />
di Gesù, di cui alcuni (Carmelitani<br />
e <strong>Cistercensi</strong>) presentano due<br />
rami dell'osservanza: antica e riformata,<br />
e quasi tutti presentano<br />
anche il ramo o i rami femminili.<br />
Di questi grandi Ordini viene presentato<br />
un quadro abbastanza<br />
esauriente, per quanto può essere<br />
fatto in una sintesi, della storia,<br />
del diritto e soprattutto della spiritualità<br />
e del loro attuale posto<br />
in seno alla Chiesa. E tutto questo<br />
viene esposto non tanto da uno<br />
studioso, ma da un membro dello<br />
stesso ordine, che ne vive la dinamica<br />
all'interno dell'Ordine stesso,<br />
presentando una visione allo<br />
stesso tempo erudita e palpitante<br />
di vita e di spirito ecclesiale.<br />
Interessante, anche se non sempre<br />
del tutto convincente è la difesa<br />
della vita contemplativa pura<br />
- 204-<br />
fatta da un « monaco Certosino »:<br />
« Separati da tutti, il solitario è<br />
unito a tutti e sta, in nome di<br />
tutti, alla presenza del Dio vivente;<br />
il suo cuore si dilata nella<br />
unione con Dio sino ad abbracciare<br />
il mondo intero, cooperando<br />
con la preghiera e l'intera vita<br />
all'opera della salvezza di Cristo»<br />
(colI. 792-793).<br />
Ci sono poi moltissime voci di<br />
grande interesse generale. Di notevole<br />
importanza è lo studio su i<br />
CARISMI, specialmente nell'attuale<br />
risveglio, anche se qua e là<br />
discutibile nelle sue applicazioni,<br />
dei carismi nella istituzione ecclesiale,<br />
risveglio al quale i religiosi,<br />
gruppo eminentemente carismatico,<br />
non possono restare estranei.<br />
L'estensore della voce pone dei<br />
punti molto chiari, non nascondendosi<br />
le immancabili difficoltà<br />
e la conflittualità possibile tra<br />
carismi e istituzione. Di non minore<br />
importanza è la voce CON-<br />
SIGLI EVANGELICI, dove, in<br />
maniera succinta, la problematica<br />
vivissima oggi sul significato e<br />
l'esistenza dei cosiddetti consigli<br />
evangelici viene esposta e risolta<br />
alla luce della più recente esegesi.<br />
Non posso ricordare poi tutte le<br />
voci di estremo interesse che sono<br />
contenute in questo volume come<br />
Celibato, Clausura, Classi di religiosi,<br />
Convento, Commenda. Interessante<br />
pure i temi trattati che
allargano i confini della vita religiosa<br />
presentandoci i musulmani<br />
e i confuciani.<br />
Non vanno sottovalutati gli<br />
articoli che ci presentano grandi<br />
abbazie che sono state punti nevralgici<br />
di vita religiosa nel corso<br />
dei secoli. Al rigurado però non<br />
si riesce a spiegarsi la mancanza di<br />
una voce specifica per la CER-<br />
TOSA DI PAVIA la cui rinomanza<br />
non è certamente minore ad<br />
altre abbazie o monasteri che pure<br />
vengono ricordati anche nel presente<br />
volume.<br />
Per quanto riguarda più da<br />
vicino la vita cistercense si può<br />
notare che le voci che la riguardano<br />
direttamente riempiono 91<br />
colonne.<br />
Un rapido e preciso contributo<br />
del P. Vongrey sull'arte cistercense<br />
(21 colonne) ci illustra il<br />
vasto movimento dell' arte che i<br />
<strong>Cistercensi</strong> nel loro rapido diffondersi,<br />
hanno portato in tutta Europa<br />
medioevale e che continua<br />
anche nell' età più recente nel barocco<br />
francese e della Germania<br />
meridionale «Le caratteristiche<br />
estetiche durevoli si trovano nella<br />
intera opera architettonica: armonia<br />
delle proporzioni, chiarezza e<br />
logica dell'articolazione, perfetto<br />
lavoro degli scalpellini, plasticità<br />
al serVIZIO dell' architettura e<br />
orientata sulla funzione vivacizzata<br />
della luce» (col. 1057). Il<br />
padre Lekai in 50 colonne fa un<br />
compendio della storia dell'Ordine<br />
nelle sue varie manifesta-<br />
- 205<br />
zioni. L'esposizione è resa visibile<br />
nelle numerose cartine che dimostrano<br />
in modo plastico la vitalità<br />
dell'Ordine durante i secoli. Il<br />
paragrafo sulla spiritualità e cultura<br />
è visto in maniera storica con<br />
un elenco di scrittori e di opere<br />
che dimostrano quali maestri di<br />
spiritualità siano stati i cistercensi<br />
durante i secoli. Si sarebbe desiderato,<br />
però, una sintesi della<br />
spiritualità che facesse cogliere<br />
meglio gli elementi interiori che<br />
vivificano ancora oggi la famiglia<br />
cistercense.<br />
L'esposizione storica delle varie<br />
Congregazioni che formano l'Ordine<br />
Cistercense serve a mostrare<br />
tutta la varietà e la vitalità di<br />
questo ramo della famiglia benedettina.<br />
Da segnalare l'articolo sulla<br />
«Carta Caritatis », primo documento<br />
legislativo dell'Ordine che<br />
da alcuni decenni è al centro degli<br />
interessi degli storici. n P. Zakar<br />
espone sinteticamente l'evoluzione<br />
e lo stato attuale delle ricerche<br />
al riguardo. Sono poi interessanti<br />
le presentazioni di alcune abbazie<br />
cistercensi: Chaalis, La Cambre,<br />
Chiaravalle della Colomba, Casaman<br />
...<br />
n volume si chiude con una<br />
voce che tocca da vicino anche la<br />
vita monastica: « CONVENTUA-<br />
LISMO» che richiama quello<br />
delle «Osservanze» fenomeno<br />
vissuto specialmente dai <strong>Cistercensi</strong><br />
di Spagna.<br />
In complesso un volume di
estremo e vario interesse che non<br />
da soltanto delle notizie ma propone<br />
problemi, suscita discussioni<br />
in quel vasto mare pieno di vita<br />
che è la VITA RELIGIOSA.<br />
P. Malachia Falletti<br />
G. BARRA, Quando l'amore si fa<br />
pane. Profilo di S. Giuseppe B.<br />
Cottolengo, Gribaudi, Torino '74,<br />
pp. 224;<br />
A. PRONZATO, Nel segno della misericordia.<br />
Vita di don Carlo Steeb<br />
Gribaudi, Torino 1974, pp. 352;<br />
A. PRONZATO, Prete con mondo a<br />
carico. Profilo di don Giacinto<br />
Bianchi, Gribaudi, Torino 1975,<br />
pp. 272.<br />
L'editre Gribaudi di Torino<br />
ha pubblicato tre volumi dovuti<br />
alla penna di due sacerdoti: Giovanni<br />
Barra e Alessandro Pronzato.<br />
In essi si studia la vita o,<br />
meglio, il pensiero spirituale di<br />
tre sacerdoti: don Carlo Steeb,<br />
don Giacinto Bianchi e don Giuseppe<br />
Benedetto Cottolengo: tre<br />
sacerdoti di estrazione diversa. Lo<br />
Steeb proviene da una famiglia<br />
luterana e borghese e « potrà vantare<br />
tra i suoi antenati ascendenti<br />
comuni con lo scrittore Schiller,<br />
il poeta Holderlin, il teologo Davide<br />
Federico Strauss e nientemeno<br />
che il filosofo Hegel». Il<br />
Cottolengo proviene da una famiglia<br />
borghese contadina che aveva<br />
- 206-<br />
dato alla chiesa un teologo e un<br />
padre domenicano. Don Giacinto<br />
Bianchi discende da una famiglia<br />
contadina che lo farà studiare solo<br />
a causa della sua gracilità. Lo<br />
stesso Steeb è tedesco, il Cottolengo<br />
è piemontese e il Bianchi<br />
lombardo.Da tutto ciò deriva la<br />
varia cultura dei tre sacerdoti:<br />
uno teologo, il Cottolengo, un<br />
altro insegnante e cultore di lingue<br />
straniere, lo Steeb; il terzo,<br />
il Bianchi con una cultura scaturita<br />
dal suo grande camminare e<br />
dal contatto, per mezzo della predicazione,<br />
col popolo e i suoi<br />
costumi.<br />
Questo preambolo vuole introdurre<br />
le varie biografie, che non<br />
vogliono essere solo dei volumi<br />
di agiografia, ma anche la dimostrazione,<br />
come vedremo, della<br />
continuità e dell'importanza della<br />
Chiesa nel campo sociale. Tre<br />
sacerdoti che camminano, pur con<br />
andamento diverso, sulla stessa<br />
strada, e raggiungono lo stesso<br />
fine: l'amore. Non l'amore a parole<br />
ma quello espresso coi fatti<br />
che scaturiscono dalla.unica fonte:<br />
Cristo. Essi dimostrano che la<br />
Chiesa è sempre presente quando<br />
l'uomo ha. bisogno di essere sorretto<br />
e aiutato.<br />
Va notato che mentre il Cottolengo<br />
e lo Steeb appartengono al<br />
1700-1800, il Bianchi appartiene<br />
al 1800-1900. Si tratta di tre personaggi,<br />
come si vede, che devono<br />
essere visti da angolazioni diverse,
con diverse interpretazioni della<br />
loro vita e del loro lavoro. Questo<br />
fine è stato raggiunto egregiamente<br />
dai due scrittori, il Barra educatore<br />
e giornalista, il Pronzato<br />
scrittore di opere di formazione<br />
spirituale.<br />
I tre sacerdoti che ci vengono<br />
presentati li vediamo rifulgere dal<br />
risultato del loro lavoro più che<br />
dall'elenco delle loro qualità,<br />
quale l'agiografia tradizionale,<br />
sempre valida, presenta a coloro<br />
che vogliono app.rofondire e apprendere<br />
il cammino completo del<br />
personaggio. Il Barra e il Pronzato,<br />
a nostro parere, si preoccupano<br />
di dimostrare come il sacerdozio,<br />
donato a diversi uomini<br />
porta sempre, qualunque sia la<br />
strada ad essi assegnata, ad un<br />
solo fine: l'amore di Dio attraverso<br />
l'uomo da Cristo redento. E<br />
dai tre, che non intendono essere<br />
dei « fondatori », ma solo esecutori,<br />
fioriscono numerose opere:<br />
il Cottolengo dona a Torino e al<br />
mondo il grande miracolo della<br />
Piccola Casa della Divina Provvidenza,<br />
sotto la regola di San Vincenzo<br />
de' Paoli; lo Steeb, dopo<br />
lunga meditazione e esperienza al<br />
Lazzaretto, affronterà l'opera dell'ospedale<br />
e del ricovero dei vecchi,<br />
dando alle sue collaboratrici<br />
la Regola delle « Sorelle della Misericordia<br />
di Vienna» anch'esse<br />
in sostanza riproducenti la regola<br />
di S. Vincenzo.<br />
Don Giacinto Bianchi inizierà<br />
invece un'opera per ragazzi abban-<br />
- 207-<br />
donati, agganciandolo all' opera di<br />
un sacerdote genovese a Betlemme,<br />
il Canonico Bellotti.<br />
Tre istituzioni che portano nel<br />
mondo l'Amore; i titoli delle<br />
opere danno già l'indicazione di<br />
questo cammino: «Il segno della<br />
misericordia », «Prete con mondo<br />
a carico », « Quando l'amore<br />
si fa pane ». Agiografia moderna<br />
che non toglie nulla alla validità<br />
di quella tradizionale. P. Stanislao<br />
Bellando, agostiniano di S.<br />
Spirito in Firenze, a chi criticava<br />
la « Storia di Cristo» e « S. Agostino»<br />
del Papini perché scritti<br />
in forma nuova, diceva: «I volumi<br />
di Papini si possono dare a<br />
professionisti e a uomini della<br />
strada sicuri che li leggono, mentre<br />
i volumi scientifici non vengono<br />
letti che da poche persone colte<br />
», I tre volumi editi da Gribaudi<br />
rispondono alla stessa logica:<br />
son libri che si leggono d'un fiato:<br />
tutti e tre, ricchi di citazioni, non<br />
sono aggravati di note bibliografiche,<br />
che non hanno importanza<br />
per i lettori che vogliono conoscere<br />
lo spirito che anima i protagonisti.<br />
Barra chiude il suo volume con<br />
un titolo che esprime tutto il<br />
carattere della spiritualità del Cottolengo:<br />
«La vita non consiste<br />
nel capire, ma nell'amare ». Pronzato<br />
conclude scrivendo: «Carlo<br />
Steeb ci dice che, in fondo, la<br />
scoperta più esaltante del suo<br />
lunghissimo viaggio è stata preci-
samente questa: la verità è amore.<br />
Cottolengo, Steeb, Bianchi: tre<br />
sacerdoti tre fiori sulla stessa<br />
pianta, la Chiesa, con una missione<br />
propria ci ricordano i versi di<br />
Umberto Pestellini: «Candido,<br />
- 208-<br />
odoroso e posato / ancora sul<br />
ramo i suoi compagni / gli dicevano:<br />
resta, resta ancora / ma è<br />
stato chiamato ».<br />
Paolo Cherubelli
SOMMARIO<br />
MALACHIA FALLETTI, L'abate e la direzione spirituale o<br />
JEAN LECLERCQ, Bernardo di Chiaravalle (1090 - 20 agosto<br />
1153) o o • o<br />
JEAN LECLERCQ, Psicologia e vita spirituale in San Bernardo<br />
JEAN DE LA CROIX BUTON, Storia dell'Ordine Cistercense<br />
(XXI puntata) o o • o<br />
JEAN DE LA CROIX BOUTON, Note per una bibliografia della<br />
Storia dell'Ordine Cistercense o<br />
RECENSIONI o<br />
pago 105<br />
» 127<br />
» 132<br />
» 162<br />
» 188<br />
» 204