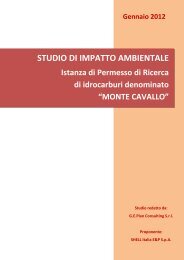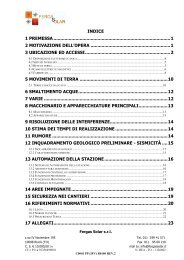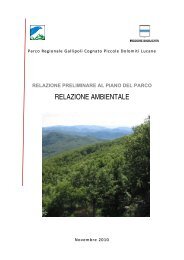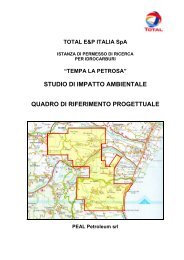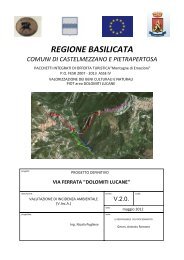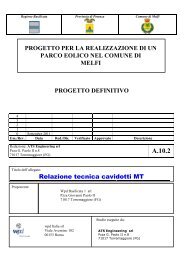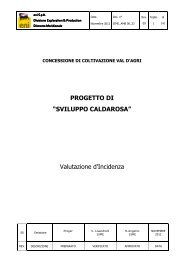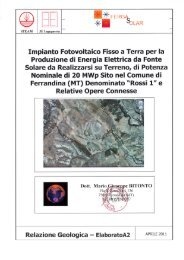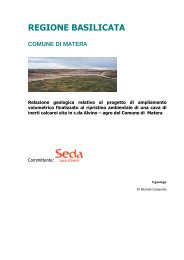relazione di screening - Valutazioneambientale.Regione.Basilicata…
relazione di screening - Valutazioneambientale.Regione.Basilicata…
relazione di screening - Valutazioneambientale.Regione.Basilicata…
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P a g i n a | 1<br />
GENNAIO 2013<br />
RELAZIONE DI SCREENING<br />
Istanza <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Ricerca <strong>di</strong> Idrocarburi<br />
denominato “LA CAPRIOLA”<br />
Proponente<br />
Delta Energy ltd.<br />
DELTA ENERGY
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
SOMMARIO<br />
1 INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 7<br />
2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ................................................................................................... 8<br />
2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ................................................................................................................. 8<br />
2.2 IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO ............................................................................................................................. 9<br />
2.3 DESCRIZIONE DEL COMMITTENTE ........................................................................................................................ 9<br />
2.4 VINCOLI PRESENTI NELL’AREA .............................................................................................................................10<br />
2.4.1 Aree naturali protette ............................................................................................................................10<br />
2.4.2 Vincoli archeologici ................................................................................................................................13<br />
2.4.3 Strumenti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione.......................................................................................14<br />
2.4.4 Coerenza con gli strumenti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione .............................................................20<br />
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .........................................................................................................22<br />
3.1 UBICAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO .................................................................................................................22<br />
3.2 ATTIVITÀ ESPLORATIVA PRECEDENTE .....................................................................................................................23<br />
3.2.1 Presenza <strong>di</strong> attività estrattive in zona .....................................................................................................25<br />
3.3 FINALITÀ DELL’INTERVENTO ...............................................................................................................................26<br />
3.4 PROGRAMMA LAVORI ......................................................................................................................................26<br />
3.4.1 Fasi operative del programma lavori ......................................................................................................26<br />
3.5 OBIETTIVI MINERARI........................................................................................................................................27<br />
3.6 ROCCE SERBATOIO CARBONATICHE ......................................................................................................................29<br />
3.6.1 Rocce serbatoio incarsite nella piattaforma carbonatica Apula ...............................................................35<br />
3.7 ROCCE SERBATOIO CLASTICHE ............................................................................................................................38<br />
3.8 ROCCIA DI COPERTURA ....................................................................................................................................39<br />
3.9 ROCCIA MADRE ..............................................................................................................................................40<br />
3.10 TRAPPOLE ....................................................................................................................................................42<br />
3.11 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ IN PROGETTO .............................................................................................................43<br />
3.11.1 Indagine geofisica: generalità ............................................................................................................43<br />
3.11.2 Propagazione dell’energia .................................................................................................................44<br />
3.11.3 Generazione dei segnali sismici ..........................................................................................................44<br />
3.11.4 Progettazione <strong>di</strong> una campagna <strong>di</strong> acquisizione geofisica ...................................................................49<br />
4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ...........................................................................................................54<br />
4.1 UBICAZIONE GEOGRAFICA .................................................................................................................................54<br />
4.2 ATMOSFERA ..................................................................................................................................................56<br />
4.2.1 Qualità dell’aria .....................................................................................................................................56<br />
4.2.2 Clima .....................................................................................................................................................57<br />
4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO .....................................................................................................................................60<br />
4.3.1 Inquadramento geologico ......................................................................................................................60<br />
4.3.2 Geologia <strong>di</strong> superficie dell’area in esame ................................................................................................75<br />
2
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
4.3.3 Caratterizzazione geomorfologica ..........................................................................................................76<br />
4.3.4 Caratterizzazione del suolo ....................................................................................................................78<br />
4.3.5 Uso del suolo .........................................................................................................................................85<br />
4.4 AMBIENTE IDRICO...........................................................................................................................................86<br />
4.4.1 Caratterizzazione idrica superficiale .......................................................................................................86<br />
4.4.2 Caratterizzazione idrica profonda ..........................................................................................................89<br />
4.4.3 Rischio idrogeologico .............................................................................................................................91<br />
4.5 RISCHIO SISMICO ............................................................................................................................................94<br />
4.6 FLORA E FAUNA ..............................................................................................................................................96<br />
4.6.1 Copertura forestale e vegetazione..........................................................................................................96<br />
4.6.2 Siti Rete Natura 2000 ed habitat ............................................................................................................98<br />
4.6.3 Fauna ....................................................................................................................................................99<br />
5 ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI ................................................................................................................ 101<br />
5.1 INTRODUZIONE ............................................................................................................................................ 101<br />
5.2 EMISSIONE SONORE ED IMPATTO ACUSTICO ......................................................................................................... 101<br />
5.2.1 Impatto acustico prodotto dai Vibroseis ............................................................................................... 101<br />
5.2.2 Limiti <strong>di</strong> legge ...................................................................................................................................... 104<br />
5.2.3 Conclusioni .......................................................................................................................................... 105<br />
5.3 VIBRAZIONI................................................................................................................................................. 105<br />
5.4 SUBSIDENZA................................................................................................................................................ 107<br />
5.5 OCCUPAZIONE DEL SUOLO............................................................................................................................... 107<br />
5.6 IMPATTI IN ATMOSFERA .................................................................................................................................. 107<br />
5.7 AMBIENTE IDRICO......................................................................................................................................... 108<br />
5.8 RIFIUTI ...................................................................................................................................................... 108<br />
5.9 IMPATTI SU ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA ............................................................................................................. 108<br />
5.9.1 Matrice <strong>di</strong> Leopold ............................................................................................................................... 108<br />
5.9.2 Descrizione ed esposizione delle matrici impiegate ............................................................................... 109<br />
5.9.3 Conclusioni .......................................................................................................................................... 113<br />
5.10 IMPATTI SU AREE PROTETTE SIC/ZPS ................................................................................................................. 113<br />
6 MITIGAZIONI ................................................................................................................................................... 114<br />
6.1 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ...................................................................................................... 114<br />
7 SINTESI NON TECNICA ..................................................................................................................................... 119<br />
8 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ........................................................................................................................... 121<br />
3
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
ELENCO DELLE FIGURE E DELLE TABELLE<br />
Figura 2.1 – Localizzazione dell’area in istanza, con riferimento delle aree SIC/ZPS presenti nelle zone limitrofe. ..........11<br />
Figura 2.2 - Localizzazione dell’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in riferimento alla presenza <strong>di</strong> aree naturali protette (fonte:<br />
tavola 4.2 del Piano <strong>di</strong> gestione delle acque, mo<strong>di</strong>ficato) .............................................................................................12<br />
Figura 3.1 - Delimitazione dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca “La Capriola” con in<strong>di</strong>cazione dei limiti comunali .22<br />
Figura 3.2 - Ubicazione dei campi estrattivi presenti nelle vicinanze dell’area <strong>di</strong> istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong><br />
idrocarburi “La Capriola” ............................................................................................................................................23<br />
Figura 3.3 – Localizzazione dei pozzi esplorativi perforati all’interno dell’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “La Capriola”, relativi a<br />
precedenti attività <strong>di</strong> esplorazione e produzione .........................................................................................................24<br />
Figura 3.4 - Relazioni stratigrafiche tra Catena e Avanfossa nel settore Appenninico meri<strong>di</strong>onale; in evidenza i livelli a<br />
gas e ad olio nei rispettivi intervalli cronostratigrafici ..................................................................................................28<br />
Figura 3.5 - Livello <strong>di</strong> calcareniti terziarie con alta porosità <strong>di</strong> matrice nei pressi <strong>di</strong> Matera ..........................................30<br />
Figura 3.6 - Porosità legata alla <strong>di</strong>ssoluzione delle Ru<strong>di</strong>ste nei calcari tardo-Cretacici della piattaforma Apula .............31<br />
Figura 3.7 - Relazione tra spessore degli strati e intensità <strong>di</strong> fratturazione (a) e tessitura e densità <strong>di</strong> fratturazione (b)<br />
(fonte: Di Cuia et al., 2009) .........................................................................................................................................32<br />
Figura 3.8 – Calcari fratturati della Piattaforma Apula (cava <strong>di</strong> Altamura) ...................................................................33<br />
Figura 3.9 – Calcari fratturati con fuoriuscita <strong>di</strong> bitume in una cava a Lettomanopello nei pressi della Maiella .............34<br />
Figura 3.10 – Esempio <strong>di</strong> foto da satellite nella zona <strong>di</strong> Altamura che evidenza la presenza <strong>di</strong> un sistema carsico<br />
controllato dai principali lineamenti strutturali ...........................................................................................................35<br />
Figura 3.11 - Modellizzazione delle zone limitrofe al Pulo <strong>di</strong> Altamura .........................................................................35<br />
Figura 3.12 – Modello carsico nei calcari della Piattaforma Apula ...............................................................................36<br />
Figura 3.13 - Distribuzione verticale della porosità legata al carsismo (fonte: André & Doulcet, 1991, mo<strong>di</strong>ficato)........37<br />
Figura 3.14 - Composite log dal pozzo Monica 1 ..........................................................................................................38<br />
Figura 3.15 - Alternanze <strong>di</strong> livelli sabbiosi <strong>di</strong> origine torbi<strong>di</strong>tica e argille nel pozzo Fiume Basento 2. La prima curva<br />
rappresenta SP, mentre le altre i valori <strong>di</strong> resistività ....................................................................................................39<br />
Figura 3.16 - Esempio <strong>di</strong> roccia <strong>di</strong> copertura Pleistocenica sopra i calcari della piattaforma Apula nel pozzo Fiume<br />
Basento 4 ...................................................................................................................................................................40<br />
Figura 3.17 - Tipi <strong>di</strong> idrocarburi nei depositi mesozoici e Plio-pleistocenici (fonte: Sella et al. 1988, mo<strong>di</strong>ficato) ............41<br />
Figura 3.18 - Schemi delle varie tipologie <strong>di</strong> trappole (e relativi campi) impostatesi nel substrato carbonatico prepliocenico<br />
e trappole in substrato plio-pleistocenico (fonte: Sella et al., 1988, mo<strong>di</strong>ficato) ...........................................42<br />
Figura 3.19 - Impatto ambientale delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> indagine sismica: da sinistra a destra, irrilevante, basso,<br />
me<strong>di</strong>o-alto e alto (fonte: convegno nazionale Assomineraria, 2003) ............................................................................43<br />
Figura 3.20 - Concetti <strong>di</strong> sismica a riflessione e percorso delle onde sismiche captate dai ricevitori (fonte:<br />
www.retegeofisica.it) .................................................................................................................................................44<br />
Figura 3.21 - Esempio <strong>di</strong> stesura e linea <strong>di</strong> acquisizione sismica ...................................................................................46<br />
Figura 3.22 - Dispositivo <strong>di</strong> acquisizione sismica e riflettore sismico nel sottosuolo (in alto). Tipica linea sismica (in<br />
basso). .......................................................................................................................................................................46<br />
Figura 3.23 - Carrello trainato da trattore con massa battente ....................................................................................47<br />
Figura 3.24 - Esempio <strong>di</strong> Vibroseis ...............................................................................................................................48<br />
Figura 3.25 - Particolare della piastra del Vibroseis .....................................................................................................48<br />
Figura 3.26 – Esempio <strong>di</strong> picchetti posizionati durante il rilievo topografico, quello <strong>di</strong> sinistra in<strong>di</strong>ca il posizionamento <strong>di</strong><br />
un geofono, quello <strong>di</strong> destra in<strong>di</strong>ca un punto <strong>di</strong> energizzazione. ...................................................................................50<br />
Figura 3.27 - Esempio <strong>di</strong> come vengono stesi manualmente i cavi e posizionati i geofoni, a destra in alto un<br />
ingran<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un geofono......................................................................................................................................51<br />
Figura 3.28 - Posizionamento dei cavi senza danneggiare la vegetazione ....................................................................51<br />
Figura 3.29 - Esempio <strong>di</strong> energizzazione lungo strada principale (Vibroseis) .................................................................52<br />
Figura 3.30 - Picchetti che in<strong>di</strong>cano i punti <strong>di</strong> energizzazione lungo una strada secondaria ...........................................52<br />
Figura 3.31 - Postazione ricezione ed elaborazione dati ...............................................................................................53<br />
Figura 4.1 – Localizzazione e confini della <strong>Regione</strong> Basilicata; le due province <strong>di</strong> cui la regione si compone ..................54<br />
Figura 4.2 - Delimitazione dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca “La Capriola” con in<strong>di</strong>cazione dei limiti comunali .55<br />
Figura 4.3 – Sud<strong>di</strong>visione del territorio lucano in base all’orografia della <strong>Regione</strong> ........................................................55<br />
Figura 4.4 – Carta delle classi fitoclimatiche delle <strong>Regione</strong> Basilicata; in rosso il perimetro del blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “La<br />
Capriola” (fonte: http://cart.ancitel.it) ........................................................................................................................59<br />
Figura 4.5 - Moto relativo attuale delle placche (fonte: Finetti 2005) ...........................................................................60<br />
Figura 4.6 - Schema geo<strong>di</strong>namico dell’area Me<strong>di</strong>terranea (fonte: Carminati & Doglioni, 2004).....................................61<br />
4
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.7 - Schema evolutivo della migrazione del fronte delle Maghrebi<strong>di</strong> dal Miocene ad oggi (fonte: Doglioni et al.,<br />
2004) .........................................................................................................................................................................61<br />
Figura 4.8 - Distribuzione dei principali domini tettonici nel Me<strong>di</strong>terraneo centrale......................................................62<br />
Figura 4.9 - Sistema <strong>di</strong> pieghe, faglie e sovrascorrimenti della catena Appennino meri<strong>di</strong>onale (fonte: Scrocca 2010) ....63<br />
Figura 4.10 - Carta geologica dell’Italia Meri<strong>di</strong>onale, con i limiti dei principali domini geologico-strutturali e ubicazione<br />
dell’area <strong>di</strong> interesse (fonte: Patacca et al, 2006, mo<strong>di</strong>ficato) ......................................................................................64<br />
Figura 4.11 - Carta tettonica dell’Italia centro meri<strong>di</strong>onale; in evidenza la Catena dell’Appennino Campano-Lucano (A) e<br />
quella dell’Arco Calabro-Peloritano (B); nel cerchio rosso, il blocco oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (fonte: C.N.R. - Progetto finalizzato<br />
Geo<strong>di</strong>namica – Pubblicazione n. 269, mo<strong>di</strong>ficata) .......................................................................................................65<br />
Figura 4.12 - Mappa delle principali unità geologico-strutturali dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale e ubicazione del blocco in<br />
stu<strong>di</strong>o; (fonte: Compagnoni et al 2004, mo<strong>di</strong>ficato) .....................................................................................................66<br />
Figura 4.13 - Ricostruzione paleogeografica dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale durante il Giurassico e Cretaceo (fonte:<br />
Zappaterra 1994) .......................................................................................................................................................67<br />
Figura 4.14 - Sezione NE-SO schematica con la <strong>di</strong>stribuzione spaziale dei principali corpi sabbiosi torbi<strong>di</strong>tici Plio-<br />
Pleistocenici (fonte: Casne<strong>di</strong>, 1998 mo<strong>di</strong>ficato) ............................................................................................................68<br />
Figura 4.15 – Calcari della Piattaforma Apula in una sezione delle cave <strong>di</strong> Apricena nel settore settentrionale della<br />
Puglia.........................................................................................................................................................................71<br />
Figura 4.16 – Assetto paleogeografico del settore centrale della piattaforma durante il Cretaceo; il settore nordorientale<br />
è caratterizzato da depositi <strong>di</strong> piattaforma tipici <strong>di</strong> mare poco profondo, mentre quello sud-orientale dalla<br />
deposizione <strong>di</strong> dolomie ...............................................................................................................................................72<br />
Figura 4.17 – Assetto durante l’Eocene del settore in stu<strong>di</strong>o; i calcari iniziano a subire le prime deformazioni con<br />
fagliazione a cinematica <strong>di</strong>retta e deposizione dei primi se<strong>di</strong>menti calcarenitici e brecce (ve<strong>di</strong> sezione interpretativa) ..73<br />
Figura 4.18 – Durante il Miocene, la fase deformativa è in uno sta<strong>di</strong>o avanzato e le con<strong>di</strong>zioni paleogeografiche sono<br />
favorevoli per la deposizione più massiccia <strong>di</strong> calcareniti, calcari marnosi e brecce che drappeggiano e uniformano la<br />
topografia del top dei calcari ......................................................................................................................................73<br />
Figura 4.19 – Nel Pliocene le zone più depresse appaiono quasi completamente riempite dal materiale depostosi tipico<br />
<strong>di</strong> margine <strong>di</strong> piattaforma, testimoniato anche dalla presenza <strong>di</strong> una superficie erosiva dovuta ad emersione della<br />
stessa .........................................................................................................................................................................74<br />
Figura 4.20 – Configurazione attuale del Top dei carbonati frutto delle complesse fasi evolutive precedenti .................74<br />
Figura 4.21 – Carta geologica del settore sud-orientale della Basilicata (Foglio 201 “Matera”).....................................75<br />
Figura 4.22 – Versanti calanchivi presenti all’interno dell’area in istanza “La Capriola” ................................................77<br />
Figura 4.23 – Formazioni <strong>di</strong> calanchi sui rilievi argillosi presenti nel settore orientale del blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o .....................77<br />
Figura 4.24 - Particolare della carta pedologica generale della <strong>Regione</strong> Basilicata relativa al blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o ..............78<br />
Figura 4.25 - Estratto dalla Corine Land Cover dell’uso del suolo; in nero l’area dell’istanza “La Capriola”.....................85<br />
Figura 4.26 - Principali bacini idrografici della Basilicata; in rosso il perimetro dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso ............87<br />
Figura 4.27 - Mappa della <strong>di</strong>stribuzione dei principali corpi idrici presenti nella regione Basilicata e relativa posizione<br />
dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (fonte: www.il<strong>di</strong>strettoidrograficodellappenninomeri<strong>di</strong>onale.it) ......................................................89<br />
Figura 4.28 – Particolare degli acquiferi limitrofi all’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o; si tratta sostanzialmente <strong>di</strong> acquiferi alluvionali<br />
relativi all’esistenza e all’azione dei relativi corsi d’acqua (fonte: www.il<strong>di</strong>strettoidrograficodellappenninomeri<strong>di</strong>onale.it)<br />
..................................................................................................................................................................................91<br />
Figura 4.29 – Mappa dei movimenti franosi e <strong>di</strong>ssesti idrogeologici nell’area in istanza; in evidenza le classi <strong>di</strong> rischio .93<br />
Figura 4.30 - Tempi <strong>di</strong> ritorno per le aree a rischio idraulico nel tratto del fiume Basento e del Cavone ricadenti<br />
all’interno dell’istanza <strong>di</strong> permesso .............................................................................................................................94<br />
Figura 4.31 - Mappa <strong>di</strong> pericolosità sismica del territorio nazionale a cura dell’istituto Nazionale <strong>di</strong> Geofisica e<br />
Vulcanologia (riferimento: Or<strong>di</strong>nanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) (fonte: www.protezionecivile.gov.it) .......95<br />
Figura 4.32 - Mappa <strong>di</strong> classificazione sismica con le isolinee <strong>di</strong> accelerazione al suolo riferita alla mappa <strong>di</strong> Figura 4.31<br />
..................................................................................................................................................................................95<br />
Figura 4.33 - Mappa della Classificazione Sismica aggiornata al 2012 (fonte: www.protezionecivile.gov.it) ..................96<br />
Figura 4.34 – Localizzazione dell’area oggetto <strong>di</strong> istanza sulla Carta Forestale della Basilicata (fonte:<br />
rs<strong>di</strong>.regione.basilicata.it, mo<strong>di</strong>ficato) ..........................................................................................................................97<br />
Figura 5.1 - Posizione ricettori per il test del rumore .................................................................................................. 102<br />
Figura 5.2 - Grafico con le curve <strong>di</strong> tendenza ricavate dai dati della Tabella 5.2 .......................................................... 103<br />
Figura 5.3 - Punti <strong>di</strong> misurazione per i Noise Test Vibration ........................................................................................ 103<br />
Figura 5.4 – Valori limite assoluti <strong>di</strong> immissione Leq in dB(A) (fonte: DPCM 14/11/97, tabella C, ai sensi dell’art. 3) ... 104<br />
Figura 5.5 - Punti <strong>di</strong> rilevamento delle vibrazioni ....................................................................................................... 106<br />
Figura 5.6 - Grafico ricavato dai dati sulle vibrazioni ................................................................................................. 107<br />
Figura 6.1 - Esempio <strong>di</strong> cartellonistica stradale utilizzata durante le fasi <strong>di</strong> energizzazione lungo strada ..................... 114<br />
5
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 6.2 - Vibroseis evidenziati con apposita segnaletica luminosa ......................................................................... 115<br />
Figura 6.3 - Copricavi segnalati ................................................................................................................................. 115<br />
Figura 6.4 - Supervisore all’attività <strong>di</strong> energizzazione................................................................................................. 116<br />
Figura 6.5 - Coor<strong>di</strong>namento traffico veicolare ........................................................................................................... 116<br />
Figura 6.6 - Personale addetto al coor<strong>di</strong>namento veicolare vestito con indumenti ad alta visibilità............................. 117<br />
Figura 6.8 – Cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione e/o le colture ............................................... 117<br />
INDICE DEGLI ALLEGATI<br />
Allegato 1: Carta topografica (cartografia in base IGM)<br />
Allegato 2: Carta Corine Land Cover<br />
Allegato 3: Carta delle aree protette<br />
Allegato 4: Report fotografico<br />
Stu<strong>di</strong>o preparato da G.E.Plan Consulting S.r.l.<br />
Redatto Approvato<br />
Dott.ssa Valentina Negri, Dott. Geol. Alessandro Criscenti Dott. Geol. Raffaele <strong>di</strong> Cuia<br />
6
1 INTRODUZIONE<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La zona nella quale ricade l'area in istanza, geologicamente assai complessa, è il risultato <strong>di</strong> lunghe e<br />
tormentate fasi geologico-deformative. I dati ricavati dalle campagne esplorative del passato da un lato<br />
confermano le potenzialità del sistema petrolifero e dall'altro la complessità esplorativa dell'area, in quanto<br />
gli accumuli <strong>di</strong> idrocarburi sono associati a trappole strutturali e/o stratigrafiche complesse. In passato tali<br />
scoperte sono state tralasciate perché non ritenute economicamente sfruttabili, specie perché coniugate ad<br />
obsolete tecnologie ed a meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> ricerca non efficaci.<br />
Tra i settori per l’esplorazione <strong>di</strong> idrocarburi in<strong>di</strong>viduati in Italia, l’Appennino Meri<strong>di</strong>onale e l’a<strong>di</strong>acente<br />
Avanfossa Bradanica rappresentano due dei maggiori siti su cui puntare l’attenzione sia dal punto <strong>di</strong> vista<br />
dei caratteri geologici, sia per quanto concerne le provate potenzialità esplorative e produttive.<br />
L’importanza <strong>di</strong> questi siti viene rilanciata soprattutto alla luce delle future potenzialità che potrebbero<br />
rivelare grazie all’utilizzo <strong>di</strong> più moderne tecnologie investigative ed alla quantità e qualità delle conoscenze<br />
geologiche acquisite.<br />
In questo assetto geologico-esplorativo Delta Energy Ltd (in seguito “Delta”) ha raccolto tutti i dati<br />
<strong>di</strong>sponibili sull’evoluzione geostrutturale dell’area e tutte le informazioni sulle precedenti campagne<br />
esplorative effettuate nella zona, ricreando un proprio modello geologico-strutturale che ha confermato la<br />
potenzialità dell’area in oggetto. La strategia esplorativa pianificata da Delta prevede, grazie alle moderne<br />
tecnologie, <strong>di</strong> evidenziare nuovi accumuli <strong>di</strong> idrocarburi e/o <strong>di</strong> rivalutare quelli tralasciati in precedenza.<br />
Considerando il punto <strong>di</strong> vista delle opportunità nel settore dell’oil&gas, l’Italia <strong>di</strong>spone delle risorse<br />
necessarie per aumentare in modo significativo la produzione nazionale <strong>di</strong> idrocarburi, riducendo la propria<br />
<strong>di</strong>pendenza dalle importazioni. Lo sviluppo <strong>di</strong> questo potenziale può giocare un ruolo strategico per l’Italia e<br />
Delta può offrire un importante contributo in termini <strong>di</strong> investimenti, esperienza, competenze tecnologiche<br />
all’avanguar<strong>di</strong>a, sostenibilità e conoscenza della realtà locale.<br />
La politica <strong>di</strong> Delta Energy è basata sulla trasparenza, sulla comunicazione e sulla cooperazione, per cui il<br />
contatto con il pubblico risulta <strong>di</strong> fondamentale importanza, sia per quanto riguarda i privati citta<strong>di</strong>ni che gli<br />
enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si prefigge <strong>di</strong> ascoltare i bisogni delle comunità locali ed<br />
interagire con esse, instaurando un rapporto <strong>di</strong> collaborazione con lo scopo <strong>di</strong> creare benefici per il<br />
territorio.<br />
I benefici legati all’attività <strong>di</strong> ricerca e produzione <strong>di</strong> idrocarburi sono rappresentati da un aumento<br />
dell’occupazione lavorativa, dalla riduzione dei costi dell’energia e da investimenti <strong>di</strong>retti sul territorio<br />
generati dalle royalties. In Italia, infatti, il sistema <strong>di</strong> prelievo fiscale sull’attività <strong>di</strong> esplorazione e produzione<br />
<strong>di</strong> idrocarburi combina royalties, canoni d’esplorazione e produzione, tassazione specifica e imposte sul<br />
red<strong>di</strong>to della società. Le somme raccolte dallo Stato vengono in seguito <strong>di</strong>stribuite tra le Regioni e i Comuni<br />
interessati dalle attività <strong>di</strong> estrazione degli idrocarburi, rappresentando una forma <strong>di</strong> entrata finanziaria<br />
<strong>di</strong>retta che si traduce in investimenti sul territorio. In generale sono le istituzioni regionali/locali che sono<br />
deputate a costruire politiche pubbliche per lo sviluppo delle comunità territoriali anche con l’utilizzo delle<br />
risorse provenienti dalle royalties.<br />
7
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO<br />
Il territorio interessato dall’istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca idrocarburi “La Capriola”, depositata il 02 aprile<br />
2012 al Ministero dello Sviluppo Economico, ricade interamente nella provincia <strong>di</strong> Matera in particolare nei<br />
comuni <strong>di</strong> Montescaglioso, Pomarico, Pisticci, Bernalda e, per una piccola parte, Montalbano Jonico.<br />
Provincia Matera<br />
Comuni<br />
Soggetto<br />
proponente<br />
Bernalda<br />
Montalbano Jonico<br />
Montescaglioso<br />
Pomarico<br />
Pisticci<br />
2.1 Quadro normativo <strong>di</strong> riferimento<br />
Delta Energy Ltd.<br />
D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,<br />
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”;<br />
D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2008/50/CE relativa alla qualità<br />
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”;<br />
L.R. del 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo<br />
sviluppo industriale.”;<br />
Direttiva del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”;<br />
D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori <strong>di</strong>sposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile<br />
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.”;<br />
L.R. del 22 ottobre 2007, n. 17 “Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 <strong>di</strong><br />
approvazione dei piani territoriali paesistici <strong>di</strong> area vasta.”;<br />
D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale.”;<br />
D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 “Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10<br />
della legge 6 luglio 2002, n. 137.”;<br />
D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni al D.P.R. 8<br />
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE relativa alla<br />
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”;<br />
Del.G.R. del 22 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 2454 della Basilicata “D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 –<br />
Regolamento recante attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat<br />
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica - In<strong>di</strong>rizzi applicativi in materia <strong>di</strong><br />
valutazione d’incidenza.”;<br />
L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio.”;<br />
L.R. del 14 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale e norme per la<br />
tutela dell’ambiente.”;<br />
8
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
D.P.C.M. del 29 settembre 1998 “Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento per l'in<strong>di</strong>viduazione dei criteri<br />
relativi agli adempimenti <strong>di</strong> cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180.”;<br />
D.L. del 11 giugno 1998, n. 180 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a<br />
favore delle zone colpite da <strong>di</strong>sastri franosi nella regione Campania.”;<br />
D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.”;<br />
D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE<br />
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna<br />
selvatiche.”;<br />
Direttiva del 3 marzo 1997, n. 97/11/CE “Direttiva del Consiglio che mo<strong>di</strong>fica la <strong>di</strong>rettiva 85/337/CEE<br />
concernente la valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> determinati progetti pubblici e privati.”;<br />
L. del 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”;<br />
L.R. del 28 giugno 1994, n. 28 “In<strong>di</strong>viduazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle<br />
aree naturali protette in Basilicata.”;<br />
L.R. del 2 settembre 1993, n. 50 “Mo<strong>di</strong>fica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987 n. 20 contenente<br />
norme in materia <strong>di</strong> tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure.”;<br />
Direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli<br />
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.”;<br />
L.R. del 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici <strong>di</strong> area vasta.”;<br />
L.R. del 4 agosto 1987, n. 20 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze<br />
naturali.”;<br />
Direttiva del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE “Direttiva del Consiglio concernente la valutazione<br />
dell’impatto ambientale <strong>di</strong> determinati progetti pubblici e privati.”.<br />
2.2 Impostazione dello stu<strong>di</strong>o<br />
Il presente stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>screening</strong>, relativo all’istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca “La Capriola”, è stato redatto ai<br />
sensi della L.R. del 14 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale e norme per<br />
la tutela dell’ambiente”, che <strong>di</strong>sciplina la normativa in merito alla valutazione dell’impatto ambientale nella<br />
<strong>Regione</strong> Basilicata. L’impostazione della presente <strong>relazione</strong> segue gli schemi in<strong>di</strong>viduati nella normativa<br />
vigente e fa particolare riferimento alle “Linee guida per la valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale” emanate in<br />
materia dalla <strong>Regione</strong> Basilicata.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o è corredato dalla seguente documentazione:<br />
<strong>relazione</strong> <strong>di</strong> <strong>screening</strong> (sud<strong>di</strong>visa in: quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale<br />
con descrizione degli impatti dell’opera in oggetto);<br />
documentazione fotografica;<br />
allegati cartografici.<br />
2.3 Descrizione del Committente<br />
La Società Delta Energy Ltd (Delta) è stata fondata nel 2010 da professionisti del settore della ricerca e<br />
produzione <strong>di</strong> idrocarburi con una consolidata esperienza lavorativa in Europa, sud-est Asiatico, Australia,<br />
Africa, America settentrionale e meri<strong>di</strong>onale. Le competenze dei soci coprono l’intero spettro necessario ad<br />
una corretta gestione del proce<strong>di</strong>mento, in quanto sia l’aspetto tecnico (geologia, geofisica, resevoir<br />
engineering, drilling engineering) che quello legale sono coor<strong>di</strong>nati interamente dalle risorse interne alla<br />
Società. Grazie all’esperienza del personale della Delta, acquisita in tutti i settori chiave dell’esplorazione<br />
9
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
energetica ed alla collaborazione con altri esperti del settore, è stato possibile sviluppare una strategia<br />
integrata ed innovativa, in grado <strong>di</strong> costruire un modello esplorativo all’avanguar<strong>di</strong>a per lo sviluppo <strong>di</strong><br />
progetti trascurati da altre compagnie, in quanto non considerati economicamente vantaggiosi.<br />
L’obiettivo <strong>di</strong> Delta è quello <strong>di</strong> rispondere alla crescente domanda <strong>di</strong> energia attraverso l’esplorazione e la<br />
produzione <strong>di</strong> idrocarburi secondo rigorosi criteri <strong>di</strong> efficienza e responsabilità sociale, ambientale ed<br />
economica.<br />
La politica <strong>di</strong> Delta Energy è basata sulla trasparenza, sulla comunicazione e sulla cooperazione, per cui il<br />
contatto con il pubblico risulta <strong>di</strong> fondamentale importanza, sia per quanto riguarda i privati citta<strong>di</strong>ni che gli<br />
enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si prefigge <strong>di</strong> ascoltare i bisogni delle comunità locali ed<br />
interagire con esse, instaurando un rapporto <strong>di</strong> collaborazione, e partecipare alla creazione <strong>di</strong> benefici per il<br />
territorio.<br />
2.4 Vincoli presenti nell’area<br />
2.4.1 Aree naturali protette<br />
Le aree naturali protette sono aree nelle quali è necessario garantire, promuovere, conservare e valorizzare<br />
il patrimonio naturale <strong>di</strong> specie animali e vegetali <strong>di</strong> associazioni forestali, <strong>di</strong> singolarità geologiche, <strong>di</strong> valori<br />
scenici e panoramici o <strong>di</strong> equlilibri ecologici. Tali aree permettono la tutela dell’integrità fisica, dell’identità<br />
culturale e della bio<strong>di</strong>versità del territorio e sono sud<strong>di</strong>vise in zone ed elementi strutturali della forma del<br />
territorio congiuntamente ad elementi <strong>di</strong> specifico interesse storico e naturalistico.<br />
La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle<br />
aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal<br />
Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente le aree naturali protette si classificano in:<br />
Parchi Nazionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più<br />
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche,<br />
geologiche, geomorfologiche, biologiche, <strong>di</strong> rilievo internazionale o nazionale per valori<br />
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello<br />
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.<br />
Parchi naturali regionali e interregionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed<br />
eventualmente da tratti <strong>di</strong> mare prospicienti la costa, <strong>di</strong> valore naturalistico e ambientale, che<br />
costituiscono, nell'ambito <strong>di</strong> una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, in<strong>di</strong>viduato dagli<br />
assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tra<strong>di</strong>zioni culturali delle<br />
popolazioni locali.<br />
Riserve naturali: costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più<br />
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi<br />
importanti per la <strong>di</strong>versità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve<br />
naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse<br />
rappresentati.<br />
Zone umide <strong>di</strong> interesse internazionale: costituite da aree acquitrinose, palu<strong>di</strong>, torbiere oppure<br />
zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone <strong>di</strong> acqua marina la cui<br />
profon<strong>di</strong>tà, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono<br />
essere considerate <strong>di</strong> importanza internazionale ai sensi della convenzione <strong>di</strong> Ramsar.<br />
Altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, etc.)<br />
che non rientrano nelle precedenti classi. Si <strong>di</strong>vidono in aree <strong>di</strong> gestione pubblica, istituite cioè con<br />
leggi regionali o provve<strong>di</strong>menti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provve<strong>di</strong>menti<br />
formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.<br />
10
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Aree <strong>di</strong> reperimento terrestri e marine: sono in<strong>di</strong>cate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono<br />
aree la cui conservazione attraverso l'istituzione <strong>di</strong> aree protette è considerata prioritaria.<br />
A livello comunitario, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della<br />
bio<strong>di</strong>versità è la rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per<br />
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie <strong>di</strong> flora e fauna minacciate o<br />
rare.<br />
La rete Natura 2000 comprende le Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva<br />
79/409/CEE "Uccelli", e le Zone Speciali <strong>di</strong> Conservazione istituite dagli Stati Membri secondo quanto<br />
stabilito dalla Direttiva Habitat, denominate Siti <strong>di</strong> importanza Comunitaria (SIC). Nelle aree che<br />
compongono la rete Natura 2000 le attività umane non sono escluse, in quanto non si tratta <strong>di</strong> riserve<br />
rigidamente protette, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche<br />
"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" dell’area<br />
in cui sussiste la zona <strong>di</strong> rilevanza naturalistica. In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 21%<br />
circa del territorio nazionale.<br />
All’interno del territorio interessato dall’area in istanza non è presente alcuna area naturale protetta, come<br />
parchi, riserve o siti Rete Natura 2000 (Figura 2.1). Quelle più vicine, nelle zone limitrofe dell’area oggetto<br />
<strong>di</strong> istanza, sono:<br />
la SIC/ZPS IT9220255 “Valle Basento - Ferran<strong>di</strong>na Scalo”, ubicata a circa 4,6 km dal confine nordoccidentale<br />
dell’area in istanza;<br />
la SIC IT9220085 “Costa Ionica Foce Basento, <strong>di</strong>stante circa 7,2 km dal limite sud-orientale dell’area;<br />
la Riserva regionale EUAP 0037 “Riserva Metaponto”, <strong>di</strong>stante circa 8,2 km dal limite sud-est<br />
dell’area.<br />
Figura 2.1 – Localizzazione dell’area in istanza, con riferimento delle aree SIC/ZPS presenti nelle zone limitrofe.<br />
11
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Dalla tavola 4.2 del Piano <strong>di</strong> Gestione delle Acque della regione Basilicata, in cui sono riportate tutte le Aree<br />
designate per la protezione degli habitat e delle specie (Figura 2.2) è possibile osservare come, nella parte<br />
occidentale dell’area, siano presenti due zone catalogate come IBA (Important Bird Area), facenti parte<br />
della stessa IBA, n. 196, denominata “Calanchi della Basilicata”.<br />
Una Important Bird Area (IBA) è un'area considerata come habitat importante per la conservazione <strong>di</strong><br />
popolazioni <strong>di</strong> uccelli. Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base <strong>di</strong> criteri<br />
omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte <strong>di</strong> BirdLife International (network internazionale per la<br />
<strong>di</strong>fesa dell’avifauna, in Italia rappresentato dalla LIPU). Molti paesi sono ormai dotati <strong>di</strong> un inventario dei<br />
siti prioritari per l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mon<strong>di</strong>ale. L’Italia<br />
contribuisce a questa rete globale con 172 aree che coprono una superficie pari a 5 milioni <strong>di</strong> ettari, circa il<br />
16% del territorio nazionale. La loro in<strong>di</strong>viduazione – il primo inventario risale al 1989, l’ultimo al 2002 – è<br />
servita molto spesso come base per la designazione delle Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale.<br />
Attualmente, il 71% della superficie delle IBA corrisponde ad aree tutelate ZPS (Zone <strong>di</strong> Protezione<br />
Speciale), anche se non è questo il caso, infatti questa IBA non coincide con nessuna area protetta in<br />
corrispondenza del territorio interessato dall’istanza.<br />
Figura 2.2 - Localizzazione dell’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in riferimento alla presenza <strong>di</strong> aree naturali protette<br />
(fonte: tavola 4.2 del Piano <strong>di</strong> gestione delle acque, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
Le IBA sono, quin<strong>di</strong>, aree in<strong>di</strong>viduate come prioritarie per la conservazione dell'avifauna. Per quanto<br />
riguarda la IBA ricadente nel territorio dell’istanza, <strong>di</strong> seguito vengono riportate le caratteristiche che ne<br />
hanno motivato l’istituzione.<br />
Nome e co<strong>di</strong>ce: IBA 196 - Calanchi della Basilicata;<br />
Superficie: 51.420 ha;<br />
Descrizione e motivazione del perimetro: vasta area, caratterizzata da formazioni calanchive, che<br />
include le zone collinari pre-costiere della Basilicata. Il perimetro segue per lo più strade, ma anche<br />
crinali, sentieri, etc. L’IBA è costituita da due porzioni <strong>di</strong>sgiunte: una inclusa tra i paesi <strong>di</strong> Ferran<strong>di</strong>na,<br />
Pomarico e Bernalda, l’altra è delimitata a nord dalla strada statale 407, a sud dall’IBA 195 ed a<br />
ovest dall’IBA 141;<br />
Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione: Lanario (Falco biarmicus), Gufo reale (Bubo<br />
bubo), Averla capirossa (Lanius collurio);<br />
Categoria e criteri IBA:<br />
12
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Specie Nome scientifico Status Criterio<br />
Nibbio reale Milvus milvus B C6<br />
Ghiandaia marina Coracias garrulus B C6<br />
Monachella Oenanthe hispanica B A3<br />
Zigolo capinero Emberiza melanocephala B A3<br />
2.4.2 Vincoli archeologici<br />
Tabella 2.1 – Criteri IBA relativi a singole specie (fonte: www.lipu.it)<br />
Le aree archeologiche sono perimetrate su cartografia in base IGM, ma ne esiste un quadro d’unione solo<br />
approssimativo, inoltre la maggioranza dei siti risultano non fruibili e <strong>di</strong> conseguenza non evidenziati in<br />
carta. Ciò nonostante, dalle informazioni ricavate si deduce che i territori comunali intersecati dal perimetro<br />
dell’istanza sono interessati da alcune piccole aree <strong>di</strong> interesse archeologico. In dettaglio:<br />
l'area archeologica della città <strong>di</strong> Metaponto (frazione <strong>di</strong> Bernalda), fondata dagli Achei durante la<br />
seconda metà del VII sec. a.C., comprende il santuario urbano, parte dell'agorà e l'asse viario nordsud<br />
su cui s'imposta l'intero impianto urbano. L'area sacra è caratterizzata da e<strong>di</strong>fici templari in stile<br />
dorico (Tempio <strong>di</strong> Hera e tempio <strong>di</strong> Apollo) e ionico (tempio <strong>di</strong> Artemis) e da un sacello<br />
probabilmente de<strong>di</strong>cato ad Atena, realizzati dal VI al V secolo a.C. Nell'agorà si <strong>di</strong>stingue<br />
l'imponenza architettonica del teatro che nel IV sec. sostituisce un e<strong>di</strong>ficio arcaico destinato alle<br />
assemblee citta<strong>di</strong>ne. Tra l'agorà e la linea delle mura orientali si sviluppa il Castro Romano,<br />
probabilmente sede <strong>di</strong> una guarnigione militare romana nel III sec. a.C.;<br />
i ritrovamenti archeologici che interessano il comune <strong>di</strong> Montescaglioso sono avvenuti in più parti<br />
del centro abitato e in quelle periferiche (Portico, Pagliarone, Difesa S. Biagio, Sterpina) risalenti tra<br />
il VII ed il III secolo a.C., ed inducono a pensare che la collina e l’agro <strong>di</strong> Montescaglioso furono sede<br />
<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> più abitati o <strong>di</strong> antichi villaggi, alcuni dell’età del ferro. Durante i lavori pubblici<br />
all’interno del centro abitato, nell’Abbazia <strong>di</strong> San Michele o dell’abitato <strong>di</strong> Difesa <strong>di</strong> San Biagio, si<br />
rinvennero corre<strong>di</strong> funerari, vasi, anfore e oggetti vari, ora custo<strong>di</strong>ti nei musei <strong>di</strong> Matera e <strong>di</strong> Reggio<br />
Calabria. A Difesa San Biagio troviamo la Cappella <strong>di</strong> San Biagio con annessa necropoli me<strong>di</strong>evale<br />
risalente ai sec. XI-XII e l'abitato in<strong>di</strong>geno <strong>di</strong> Lama dell'Inferno con resti <strong>di</strong> abitazioni, cinta fortificata<br />
e necropoli databili a partire dal sec. VII a.C.;<br />
nel comune <strong>di</strong> Pomarico insiste il sito archeologico denominato “Pomarico Vecchio”, si tratta <strong>di</strong> un<br />
piccolo inse<strong>di</strong>amento con le caratteristiche <strong>di</strong> un avamposto fortificato, collocabile nella seconda<br />
metà del VI sec. a.C. e sino al III sec. a.C.. Il sito era ubicato sul confine della zona metapontina della<br />
Magna Grecia, ma popolato in prevalenza da genti in<strong>di</strong>gene, l'estensione del sito si aggira intorno ai<br />
3 ettari e si trova a circa 11 km dall’abitato <strong>di</strong> Pomarico e a circa 3 km dal fiume Basento;<br />
l'Area Archeologica dell'Incoronata è un sito archeologico situato in territorio <strong>di</strong> Pisticci, in località<br />
San Teodoro. È un'area collinare sulla riva destra del Basento interessata da scavi archeologici che<br />
hanno portato alla luce i resti <strong>di</strong> un villaggio enotro risalente al IX secolo a.C. e <strong>di</strong> uno greco <strong>di</strong> fase<br />
successiva costruito sopra il precedente villaggio. L'Incoronata ebbe un ruolo <strong>di</strong> rilievo come<br />
emporio ed entrò nell'orbita <strong>di</strong> Siris. Sia il villaggio che l'emporio, furono <strong>di</strong>strutti tra il 640 a.C. e il<br />
630 a.C. a causa delle rivalità tra Metaponto e Siris. Dopo la <strong>di</strong>struzione del sito dell'Incoronata, gli<br />
achei fondarono una colonia a Metaponto come avamposto contro Taranto e successivamente<br />
13
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
creano una serie <strong>di</strong> fattorie nell'interno per controllare il territorio a<strong>di</strong>acente gli inse<strong>di</strong>amenti Enotri.<br />
Sono ora visitabili i resti della citta<strong>di</strong>na, mentre gli oggetti e i vari reperti rinvenuti nei <strong>di</strong>ntorni sono<br />
esposti al Museo Archeologico Nazionale <strong>di</strong> Metaponto, a cui compete l'organizzazione delle visite<br />
dell'area dell'Incoronata.<br />
Nonostante alcuni dei siti sopra descritti ricadano all’interno del perimetro dell’istanza <strong>di</strong> ricerca, è<br />
opportuno ricordare che i lavori non prevedono l’interessamento <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> interesse archeologico o beni <strong>di</strong><br />
interesse storico-architettonico e comunque non sono previste azioni che mutino lo stato superficiale e<br />
profondo del suolo, come ad esempio scavi o arature.<br />
2.4.3 Strumenti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione<br />
La pianificazione territoriale e urbanistica persegue obiettivi <strong>di</strong> sviluppo sostenibile nel governo unitario del<br />
territorio regionale coerentemente con principi <strong>di</strong> trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei vantaggi.<br />
La normativa <strong>di</strong> riferimento è rappresentata dalla Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed<br />
uso del territorio”. La pianificazione territoriale ed urbanistica persegue le procedure e le strutture operative<br />
nella presente legge ed in riferimento a principi <strong>di</strong> trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei vantaggi obiettivi <strong>di</strong> sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.<br />
Sono oggetti della pianificazione territoriale e urbanistica i sistemi naturalistico-ambientale, inse<strong>di</strong>ativo e<br />
relazionale della <strong>Regione</strong> Basilicata:<br />
il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall’intero territorio regionale non interessato<br />
agli inse<strong>di</strong>amenti o dalle reti dell’armatura urbana, ma con interessi interagenti nei processi <strong>di</strong><br />
trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;<br />
il Sistema Inse<strong>di</strong>ativo (SI) costituito dagli inse<strong>di</strong>amenti urbani, periurbani e <strong>di</strong>ffusi,<br />
industriali/artigianali, agricoli/produttivi;<br />
il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria, delle reti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti e aeroporti.<br />
Gli ambiti della pianificazione territoriale e urbanistica sono ambiti istituzionali <strong>di</strong> pianificazione, e ne fanno<br />
parte:<br />
il territorio regionale;<br />
i territori delle Province <strong>di</strong> Matera e Potenza;<br />
i territori dei Comuni ricadenti nel Territorio Regionale;<br />
il territorio dei Parchi Naturali nazionali e regionali;<br />
il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.<br />
2.4.3.1 Carta Regionale dei Suoli (CRS)<br />
La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce la perimetrazione dei Sistemi che costituiscono il territorio<br />
regionale, i livelli <strong>di</strong> trasformazione del territorio stesso, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla<br />
conservazione ed alla <strong>di</strong>fesa del suolo.<br />
La CRS, normata dall’art. 10, definisce:<br />
la perimetrazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, inse<strong>di</strong>ativo, relazionale) che costituiscono il<br />
territorio regionale, in<strong>di</strong>viduandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado <strong>di</strong><br />
vulnerabilità e <strong>di</strong> riproducibilità;<br />
i livelli <strong>di</strong> trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la in<strong>di</strong>viduazione e la<br />
perimetrazione dei Regimi d’intervento;<br />
le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione ed alla <strong>di</strong>fesa del suolo.<br />
14
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
2.4.3.2 Quadro Strutturale Regionale (QSR):<br />
Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l’atto <strong>di</strong> programmazione territoriale con il quale la <strong>Regione</strong><br />
definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali<br />
nazionali e con le politiche settoriali e <strong>di</strong> bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i<br />
principi <strong>di</strong> tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta<br />
Regionale dei Suoli. Il QSR contiene:<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione, nell’ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Inse<strong>di</strong>ativo e Relazionale, <strong>di</strong> una<br />
strategia territoriale che rafforzi gli effetti <strong>di</strong> complementarietà e <strong>di</strong> integrazione tra le varie parti<br />
degli stessi, al fine <strong>di</strong> migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle azioni fondamentali per la salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente, la <strong>di</strong>fesa del suolo in<br />
coerenza con quanto <strong>di</strong>sposto dai Piani <strong>di</strong> Bacino, la prevenzione e la <strong>di</strong>fesa dall’inquinamento, dalle<br />
calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;<br />
l’in<strong>di</strong>cazione delle azioni strategiche coor<strong>di</strong>nate con gli analoghi Quadri <strong>di</strong> assetto delle altre regioni<br />
e con le Linee fondamentali <strong>di</strong> assetto del territorio nazionale;<br />
l’in<strong>di</strong>cazione degli ambiti territoriali.<br />
2.4.3.3 Piano Strutturale Provinciale (PSP)<br />
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l’atto <strong>di</strong> pianificazione con il quale la Provincia esercita nel governo<br />
del territorio un ruolo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento programmatico e <strong>di</strong> raccordo tra le politiche territoriali della<br />
<strong>Regione</strong> e la pianificazione urbanistica comunale, determinando in<strong>di</strong>rizzi generali <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
provinciale intesi anche ad integrare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> mobilità dei citta<strong>di</strong>ni, e ad organizzare sul<br />
territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. Il PSP contiene:<br />
il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Inse<strong>di</strong>ativo e Relazionale, desunto dalla<br />
CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle linee strategiche <strong>di</strong> evoluzione <strong>di</strong> tali Sistemi;<br />
la Verifica <strong>di</strong> Coerenza <strong>di</strong> tali linee strategiche con gli in<strong>di</strong>rizzi del QSR ai sensi dell’art. 29 e la Verifica<br />
<strong>di</strong> Compatibilità con i Regimi d’Intervento della CRS;<br />
gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani <strong>di</strong> Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri<br />
atti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione settoriali;<br />
gli elementi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento della pianificazione comunale che interessano comuni <strong>di</strong>versi,<br />
promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;<br />
le Schede Strutturali <strong>di</strong> assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale;<br />
le opportune salvaguar<strong>di</strong>e relative a previsioni imme<strong>di</strong>atamente vincolanti ai fini paesistici;<br />
gli elementi <strong>di</strong> integrazione con i piani <strong>di</strong> protezione civile e <strong>di</strong> prevenzione dei Rischi.<br />
Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo, e quelli che possono<br />
determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico.<br />
Il PSP ha valore <strong>di</strong> Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della<br />
protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della <strong>di</strong>fesa del<br />
suolo.<br />
2.4.3.4 Il Piano Strutturale Comunale (PSC)<br />
Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le in<strong>di</strong>cazioni strategiche per il governo del territorio comunale,<br />
contenute dal PSP, integrate con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> sviluppo espressi dalla comunità locale. Il PSC contiene:<br />
il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Inse<strong>di</strong>ativo e Relazionale, desunto dalla<br />
CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro<br />
conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi <strong>di</strong> vita, degli orari e della<br />
mobilità;<br />
15
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento Preliminare;<br />
la in<strong>di</strong>viduazione e precisazione dei Sub-Sistemi Naturalistico-Ambientale, Inse<strong>di</strong>ativo e Relazionale,<br />
riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell’Armatura Urbana e dei Regimi d’Uso<br />
revisionali;<br />
la verifica <strong>di</strong> coerenza <strong>di</strong> tali previsioni con gli in<strong>di</strong>rizzi del PSP e la verifica <strong>di</strong> compatibilità con i<br />
Regimi d’Intervento della CRS;<br />
l’eventuale perimetrazione dei Piani Operativi <strong>di</strong> cui al successivo art. 15, <strong>di</strong> importanza strategica;<br />
i regimi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a;<br />
gli in<strong>di</strong>rizzi ed i parametri da rispettare nella pre<strong>di</strong>sposizione dei PO, e la definizione delle<br />
<strong>di</strong>mensioni massime ammissibili degli inse<strong>di</strong>amenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari<br />
per garantirne la realizzazione;<br />
i perimetri dei Distretti Urbani.<br />
Il PSC definisce le in<strong>di</strong>cazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenuto dal PSP, integrato<br />
con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> sviluppo espressi dalla comunità locale.<br />
2.4.3.5 Piano Operativo (PO)<br />
Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC,<br />
e/o del Regolamento Urbanistico, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative <strong>di</strong> riqualificazione e<br />
recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta <strong>di</strong>:<br />
bilanci urbanistici (verifica dello stato <strong>di</strong> attuazione della pianificazione vigente);<br />
bilanci ambientali (verifica <strong>di</strong> sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base <strong>di</strong><br />
standard prestazionali);<br />
previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali;<br />
proposte presentate da privati attraverso le modalità <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> Bando.<br />
Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti <strong>di</strong> Regime d’Uso, Regime<br />
d’Intervento e definizione dell’assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.<br />
Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani Attuativi.<br />
2.4.3.6 Regolamento Urbanistico (RU)<br />
Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e <strong>di</strong>sciplina gli inse<strong>di</strong>amenti esistenti<br />
sull’intero territorio comunale. Esso contiene:<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all’Armatura Urbana;<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree sulle quali è possibile effettuare interventi <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, <strong>di</strong><br />
completamento o <strong>di</strong> ampliamento degli e<strong>di</strong>fici esistenti;<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree destinate ad opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria;<br />
la in<strong>di</strong>viduazione delle aree sulle quali si può intervenire solo me<strong>di</strong>ante PA;<br />
la determinazione degli interventi consentiti all’esterno dei Suoli Urbanizzati;<br />
le infrastrutture da realizzare all’esterno dei Suoli Urbanizzati;<br />
i Regimi urbanistici vigenti all’interno dei perimetri <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione;<br />
la <strong>di</strong>sciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />
2.4.3.7 Piani Attuativi (PA)<br />
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici <strong>di</strong> dettaglio, approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU,<br />
ai fini del coor<strong>di</strong>namento degli interventi sul territorio, aventi contenuti e l’efficacia <strong>di</strong>:<br />
Piani Particolareggianti ( art. 13 della Legge n. 1150/42);<br />
Piani <strong>di</strong> Zona per l’e<strong>di</strong>lizia economica e popolare ( Legge n. 167/62);<br />
Piani per gli Inse<strong>di</strong>amenti Produttivi ( art. 27 della Legge n. 865/71);<br />
16
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Piani <strong>di</strong> Recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente ( art.28 della Legge n. 457/78);<br />
Piani <strong>di</strong> Lottizzazione ( art. 28 della Legge n. 1150/42).<br />
I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure <strong>di</strong> cui alle<br />
relative leggi nazionali <strong>di</strong> riferimento.<br />
2.4.3.8 Rapporto Urbanistico<br />
Il Rapporto Urbanistico contiene l'aggiornamento annuale dello stato <strong>di</strong> attuazione del PO, in riferimento al<br />
Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed ai suoi elenchi annuali, ed alle proposte <strong>di</strong> attuazione<br />
presentate dai privati; contiene altresì gli esiti delle politiche perequative, nonché le proposte <strong>di</strong> variazione<br />
del PS. E’costituito da Bilancio urbanistico e quello ambientale.<br />
Il Bilancio Urbanistico si compone <strong>di</strong> due parti:<br />
La prima descrive, separatamente per la parte attuata e per quella programmata dell'impianto urbano<br />
la dotazione, l'estensione e lo stato d'uso dei servizi, delle attrezzature e delle infrastrutture <strong>di</strong> base <strong>di</strong><br />
livello comunale esistenti; la dotazione espressa in mq e mq/ab degli spazi destinati dal Piano vigente<br />
alla parte pubblica della città, in<strong>di</strong>vidua gli immobili <strong>di</strong> proprietà pubblica <strong>di</strong>stinti per soggetti<br />
proprietari specificandone l'uso, il grado <strong>di</strong> utilizzazione e la destinazione <strong>di</strong> Piano, con particolare<br />
riferimento alle <strong>di</strong>smissioni ed agli usi impropri.<br />
La seconda analizza il deficit <strong>di</strong> dotazione dei servizi, lo stato d'uso ed i requisiti prestazionali, la<br />
<strong>di</strong>stribuzione territoriale, ed i costi <strong>di</strong> gestione per ogni singolo servizio, attrezzatura ed infrastruttura <strong>di</strong><br />
livello locale.<br />
Il Bilancio Ambientale, invece, ha lo scopo <strong>di</strong> valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi <strong>di</strong><br />
urbanizzazione, è atto tecnico amministrativo necessario per la formazione dei PO e per l'aggiornamento<br />
annuale dei Rapporti Urbanistici. Si articola in due parti:<br />
La prima si riferisce alla descrizione e quantificazione <strong>di</strong> alcuni in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato in Ambito Urbano<br />
(superfici dei SU e dei SNU, dei suoli non permeabili, dei suoli interessati dai processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione e<br />
<strong>di</strong> degrado, verde urbano fruibile (parchi e giar<strong>di</strong>ni) e su tutto il territorio comunale e/o provinciale<br />
(stato <strong>di</strong> connessione degli inse<strong>di</strong>amenti alle reti energetiche, con<strong>di</strong>zioni della Mobilità - Traffico -<br />
Accessibilità; superfici alberate, <strong>di</strong>stinte in gran<strong>di</strong> areali, macchie, siepi, filari).<br />
La seconda si riferisce alla descrizione e quantificazione dei principali in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pressione (Ciclo<br />
dell’Aria, Ciclo delle Acque, Continuità Ecologiche, Bio<strong>di</strong>versità, Rifiuti, Rumore, Campi<br />
elettromagnetici). La descrizione degli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato è obbligatoria per tutti i comuni e concorre<br />
all'aggiornamento del SIT; la descrizione degli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pressione è obbligatoria solo per i comuni<br />
specificatamente in<strong>di</strong>cati dai PSP in quanto se<strong>di</strong> <strong>di</strong> concentrazioni inse<strong>di</strong>ative e/o <strong>di</strong> attività<br />
produttive.<br />
Il Bilancio Ambientale si conclude con una <strong>relazione</strong> sintetica che valuta in termini <strong>di</strong> positività o <strong>di</strong><br />
negatività il bilancio, in<strong>di</strong>cando i punti <strong>di</strong> pressione del sistema inse<strong>di</strong>ativo sull’ambiente naturale e sulla<br />
salubrità dell’ambiente urbano. Nella <strong>relazione</strong> si adotteranno azioni atte a migliorare il grado <strong>di</strong> pressione<br />
rilevato (interventi <strong>di</strong> mitigazione degli impatti negativi, potenziamento delle dotazioni ecologiche).<br />
2.4.3.9 Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei Lavori pubblici<br />
Questa <strong>relazione</strong> costituisce il Documento <strong>di</strong> verifica ed approfon<strong>di</strong>mento urbanistico delle previsioni<br />
contenute in detto Programma. Compito della Relazione è quello <strong>di</strong> assicurare che gli obiettivi e i lavori<br />
previsti per il sod<strong>di</strong>sfacimento dei bisogni ivi espressi, trovino coerente riscontro nella vigente pianificazione<br />
urbanistica. Essa costituisce il supporto programmatico attraverso il quale l'Amministrazione Comunale<br />
delinea i contenuti urbanistici, a valenza e titolarità pubblica e privata, del re<strong>di</strong>gendo PO.<br />
17
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
2.4.3.10 Piano Regionale <strong>di</strong> Tutela delle Acque (PRTA)<br />
Il Piano <strong>di</strong> Tutela delle Acque adottato con Delib.G.R. del 21 novembre 2008, n. 1888 “D.Lgs. 152/06 art. 121<br />
- Piano Regionale <strong>di</strong> Tutela delle Acque – Adozione” abroga il previgente Piano Regionale <strong>di</strong> Risanamento<br />
delle Acque e costituisce uno specifico piano <strong>di</strong> settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006. Il Piano <strong>di</strong><br />
Tutela contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità ambientale <strong>di</strong> cui<br />
alla Parte III, del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del<br />
sistema idrico. Il Piano <strong>di</strong> tutela delle acque costituisce un adempimento della <strong>Regione</strong> Basilicata al dettato<br />
del D.Lgs. 152/2006, che ne definisce natura e contenuti, al fine <strong>di</strong> salvaguardare le risorse idriche<br />
superficiali, profonde e marino-costiere.<br />
Il suddetto Piano è un piano stralcio <strong>di</strong> settore del Piano <strong>di</strong> Bacino e deve contenere l’elenco dei corpi idrici<br />
che insistono sul territorio e le aree che richiedono specifiche misure <strong>di</strong> prevenzione dall’inquinamento,<br />
fornendo inoltre le in<strong>di</strong>cazioni temporali degli interventi <strong>di</strong> protezione e risanamento, nonché il relativo<br />
programma <strong>di</strong> verifica dell’efficacia.<br />
Gli obiettivi generali del Piano <strong>di</strong> Tutela delle Acque, sono:<br />
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;<br />
risanamento dei corpi idrici inquinati;<br />
miglioramento dello stato delle acque e protezione <strong>di</strong> quelle destinate ad usi particolari;<br />
uso sostenibile e durevole della risorsa con priorità per le acque potabili;<br />
mantenimento della naturale capacità <strong>di</strong> auto depurazione dei corpi idrici e della capacità <strong>di</strong><br />
sostenere comunità animali e vegetali.<br />
All’art. 31, comma 3, delle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione al Piano Regionale <strong>di</strong> Tutela delle Acque si precisa<br />
che “il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo<br />
Economico per i giacimenti a mare ed anche con le Regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo<br />
scarico <strong>di</strong> acque risultanti dall’estrazione <strong>di</strong> idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi<br />
idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano<br />
contenuto idrocarburi, in<strong>di</strong>cando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque <strong>di</strong><br />
scarico o altre sostanze pericolose <strong>di</strong>verse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli<br />
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche<br />
necessarie a garantire che le acque <strong>di</strong> scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri<br />
ecosistemi”.<br />
2.4.3.11 Piano Territoriale Regionale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento (PTRC)<br />
Il nuovo piano paesistico della Basilicata è in fase <strong>di</strong> redazione così come pianificato con la Del.G.R. del 23<br />
settembre 2002, n. 1715 recante “In<strong>di</strong>rizzi, modalità e tempi alla base della pianificazione paesistica”. La<br />
normativa in vigore è invece costituita da un insieme <strong>di</strong> leggi, tra cui si segnala:<br />
la L.R. del 22 ottobre 2007, n. 17, recante “Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1990, n. 3<br />
<strong>di</strong> approvazione dei piani territoriali paesistici <strong>di</strong> area vasta”;<br />
la L.R. del 11 agosto 1999, n. 23, recante “Tutela, governo ed uso del territorio”;<br />
la L.R. del 2 settembre 1993, n. 50, recante “Mo<strong>di</strong>fica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987 n. 20<br />
contenente norme in materia <strong>di</strong> tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle<br />
procedure”;<br />
la L.R. del 12 febbraio 1990, n. 3, recante “Piani regionali paesistici <strong>di</strong> area vasta”;<br />
la L.R. del 4 agosto 1987, n. 20, recante “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle<br />
bellezze naturali”.<br />
18
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
L’art. 1 della L.R. 3/90 ha per oggetto gli elementi del territorio <strong>di</strong> particolare interesse ambientale e<br />
pertanto <strong>di</strong> interesse pubblico, che identificano gli elementi che concorrono alla definizione dei caratteri<br />
costitutivi del territorio. I Piani Territoriali <strong>di</strong> area vasta approvati con la presente legge sono:<br />
1. Sirino;<br />
2. Sellata e Volturino;<br />
3. Gallipoli Cognato;<br />
4. Metaponto;<br />
5. Laghi <strong>di</strong> Monticchio;<br />
6. Maratea - Trecchina - Rivello.<br />
Nessuna delle zone sopra citate ricade nell’area in istanza.<br />
2.4.3.12 Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Provinciale (PTCP)<br />
Per quanto riguarda il Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Provinciale, la provincia <strong>di</strong> Matera ha avviato il<br />
processo <strong>di</strong> stesura nel 2005, arrivando alla sua definizione nel mese <strong>di</strong> agosto 2006 come Piano Territoriale<br />
Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia <strong>di</strong> Matera ed infine alla sua approvazione<br />
da parte della <strong>Regione</strong> Basilicata che le ha dato forma nella L.R. del 3 novembre 1998, n. 41, recante<br />
“Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale” oggi sostituita dalla L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure<br />
finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”. Il Piano è costituito da<br />
una serie <strong>di</strong> elaborati che tengono conto <strong>di</strong> prescrizioni, precisazioni e osservazioni pervenute all'Ufficio<br />
Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Il suddetto Piano produce gli stessi effetti giuri<strong>di</strong>ci dei Piani Territoriali <strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>namento istituiti con gli artt. 5 e 6 della L. del 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”. AI sensi<br />
dell’art. 7, comma 5, della L.R. 41/98 le previsioni strutturali del PTC avevano vali<strong>di</strong>tà ventennale e la<br />
predetta L.R. 41/98, all’art. 7, comma 10, stabiliva che “Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della<br />
deliberazione <strong>di</strong> approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i comuni hanno l’obbligo <strong>di</strong> adeguare i propri<br />
strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi territori”. L’art. 7, comma<br />
8, stabiliva infine che “I contenuti tecnici dei Piani Territoriali dei Consorzi e dei Piani <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento dei<br />
nuclei d’industrializzazione saranno definiti con provve<strong>di</strong>mento della Giunta Regionale”.<br />
2.4.3.13 Piano stralcio per la <strong>di</strong>fesa dal rischio idrogeologico (PAI)<br />
La prima stesura del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino della<br />
Basilicata è stato approvato il 5 <strong>di</strong>cembre 2001, ed è stato redatto sulla base degli elementi <strong>di</strong> conoscenza<br />
<strong>di</strong>sponibili consolidati alla data <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e preparazione dello stesso, secondo le in<strong>di</strong>cazioni contenute nel<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 recante “Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />
coor<strong>di</strong>namento per l'in<strong>di</strong>viduazione dei criteri relativi agli adempimenti <strong>di</strong> cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L.<br />
11 giugno 1998, n. 180” il quale a sua volta recita “Misure urgenti per la prevenzione del rischio<br />
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da <strong>di</strong>sastri franosi nella regione Campania”. Il piano è entrato in<br />
vigore il giorno 14 gennaio 2002, data <strong>di</strong> pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.<br />
11. Nel corso degli anni che ci separano dalla sua prima stesura le previsioni formulate nel PAI sono state<br />
verificate con perio<strong>di</strong>cità annuale secondo quanto previsto dall'articolo 25 “Aggiornamento del Piano<br />
Stralcio” delle “Norme <strong>di</strong> Attuazione del Piano Stralcio per la <strong>di</strong>fesa dal Rischio Idrogeologico –<br />
Aggiornamento 2010”, approvato dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino della Basilicata il 26 marzo 2010 (“Norme <strong>di</strong><br />
Attuazione”); il 27 aprile 2011 il Comitato Istituzionale dell’Autorità ha <strong>di</strong>sposto l’adozione del primo<br />
aggiornamento 2011 del PAI, avvenuto in data 10 ottobre 2011, all’interno del quale sono state valutate ed<br />
approvate dal Nucleo Tecnico Amministrativo 37 segnalazioni da parte <strong>di</strong> soggetti pubblici e privati, così<br />
come <strong>di</strong>sposto dall’art. 25 delle Norme <strong>di</strong> Attuazione, interessando le aree <strong>di</strong> 24 Comuni. Per<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree dell’istanza che ricadono nelle zone a rischio idrogeologico in<strong>di</strong>viduate dal PAI si<br />
rimanda all’apposito paragrafo 4.4.3.<br />
19
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
2.4.3.14 Piani regolatori generali (PRG)<br />
Dalla ricerca effettuata è emerso che il Comune <strong>di</strong> Pomarico risulta tuttora privo <strong>di</strong> un Piano Regolatore<br />
Generale che ne in<strong>di</strong>rizzi lo sviluppo urbanistico.<br />
Per quanto riguarda il Comune <strong>di</strong> Montescaglioso, è stata reperita la Del.G.M. del 9 ottobre 2002, n. 115 con<br />
la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito le linee guida riguardanti la redazione del Regolamento<br />
Urbanistico; da altre informazioni assunte risulta che nel mese <strong>di</strong> aprile 2011 il suddetto regolamento,<br />
denominato Nuovo Regolamento Urbanistico (NRU), risulta in fase <strong>di</strong> valutazione alla conferenza <strong>di</strong><br />
pianificazione.<br />
Per ciò che concerne il Comune <strong>di</strong> Bernalda, in attuazione alla delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale del 20 ottobre<br />
2000 n. 42, nella quale si ravvisava la improrogabile necessità <strong>di</strong> procedere alla revisione degli strumenti<br />
urbanistici generali, l’Amministrazione Comunale, con delibera <strong>di</strong> G.C. del 13 luglio 2001 n. 120, ha affidato<br />
l’incarico per la redazione della Variante al P.R.G. relativa ad urgenti problematiche riferibili alla<br />
riqualificazione urbana, necessitata anche da alcuni vuoti normativi, al recupero degli inse<strong>di</strong>amenti abusivi e<br />
alla revisione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> norme non più rispondenti alle nuove esigenze. Successivamente, con delibera<br />
<strong>di</strong> G.C. del 5 nevembre 2002 n. 150, l’oggetto dell’incarico è stato rimodulato per la formazione del<br />
Regolamento Urbanistico in attuazione alla L.R. n. 23 del 1999, in ragione della coincidenza dei contenuti<br />
delle analisi e degli stu<strong>di</strong> svolti per la Variante al P.R.G. con le attività per la formazione del R. U. e della più<br />
intensa attività regionale in materia che si era concretizzata con la pubblicazione della L.R. n. 3 del 2002, <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>fica e integrazione della n. 23, e si sarebbe ulteriormente e decisamente esplicitata nell’aprile 2003 con<br />
la pubblicazione del Regolamento d’attuazione della stessa L.R. n. 23/99 e con l’obbligo per tutti i Comuni<br />
della Basilicata <strong>di</strong> adozione dei R.U. entro e non oltre il 31 marzo 2004. Le attività <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />
avviatesi nel settembre del 2001, si sono svolte parallelamente alla pre<strong>di</strong>sposizione da parte dell’Amm.ne<br />
Comunale della nuova cartografia aerofotogrammetrica degli abitati <strong>di</strong> Bernalda e <strong>di</strong> Metaponto e<br />
Serramarina che costituiscono un mezzo in<strong>di</strong>spensabile per la pianificazione delle parti del territorio<br />
comunale urbanizzate, ma anche per l’avvio <strong>di</strong> nuove logiche <strong>di</strong> gestione del territorio, che sono, peraltro, in<br />
linea con le previsioni della L.R. n. 23/99.<br />
Il Piano Regolatore generale del Comune <strong>di</strong> Pisticci sud<strong>di</strong>vide il territorio comunale in zone destinate agli<br />
inse<strong>di</strong>amenti residenziali e produttivi, alle attrezzature pubbliche, al verde pubblico ed agricolo. Nelle nuove<br />
costruzioni, nelle ricostruzioni e nelle mo<strong>di</strong>fiche planovolumetriche o negli ampliamenti <strong>di</strong> qualsiasi entità e<br />
misura <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, devono essere osservate le norme e le prescrizioni che riguardano le singole zone<br />
nelle quali è articolato il P.R.G. (conformemente al RA della L.R. 23/99). Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23/99<br />
sono oggetto delle norme del Regolamento Urbanistico gli inse<strong>di</strong>amenti esistenti sull’intero territorio<br />
comunale e i loro eventuali completamenti e integrazioni ove previsti. In conformità alla LR 23/99 e del<br />
relativo Regolamento <strong>di</strong> Attuazione ai fini della determinazione dei Regimi Urbanistici, quali risultano<br />
dall’applicazione congiunta dei Regimi d’Uso e dei Regimi d’Intervento, il territorio comunale è stato<br />
sud<strong>di</strong>viso in: Ambiti Urbani, Ambiti Periurbani, Ambiti Extraurbani.<br />
Per quanto riguarda il Piano Regolatore del Comune <strong>di</strong> Montalbano Jonico, il Consiglio Comunale ha<br />
proceduto all’approvazione del Regolamento Urbanistico, del Piano Particolareggiato <strong>di</strong> Recupero e del<br />
Piano <strong>di</strong> Protezione Civile in data 22 giugno 2012.<br />
2.4.4 Coerenza con gli strumenti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione<br />
Il progetto risulta nel complesso compatibile con quanto previsto dai piani territoriali e dai vincoli normativi<br />
precedentemente elencati. Per rientrare nella totale compatibilità con i vincoli presenti, si evidenziano nella<br />
presente <strong>relazione</strong> gli impatti potenziali e le relative misure <strong>di</strong> mitigazione.<br />
Si specifica inoltre che l’attività <strong>di</strong> energizzazione, effettuata con i mezzi pre<strong>di</strong>sposti (Vibroseis), non<br />
interesserà le seguenti aree:<br />
alvei, invasi e corsi d'acqua tutelati;<br />
20
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
complessi archeologici (siti e monumenti) ufficialmente riconosciuti, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> pregio architettonico,<br />
centri storici;<br />
aree naturali protette.<br />
L’attività <strong>di</strong> stesura dei cavi per l’acquisizione sismica me<strong>di</strong>ante geofoni, potrà interessare parzialmente le<br />
aree sopra elencate, ma verrà effettuata esclusivamente a mano dagli operatori e nel pieno rispetto della<br />
flora e della fauna ivi presenti. Si precisa che nessun mezzo motorizzato accederà a tali aree.<br />
Sono fatte salve ulteriori aree o siti vincolati da strumenti urbanistici locali e dalla Soprintendenza per i Beni<br />
Culturali.<br />
21
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE<br />
3.1 Ubicazione dell’area d’intervento<br />
L’area in istanza denominata “La Capriola”, topograficamente presente all’interno del Foglio I.G.M. n. 201, si<br />
trova nella regione Basilicata e ha un’estensione <strong>di</strong> 188,10 km 2 . Essa ricade interamente nella provincia <strong>di</strong><br />
Matera in particolare nei comuni <strong>di</strong> Montescaglioso, Pomarico, Pisticci, Bernalda e, per una piccola parte,<br />
Montalbano Jonico (Figura 3.1).<br />
Figura 3.1 - Delimitazione dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca “La Capriola” con in<strong>di</strong>cazione dei limiti comunali<br />
Le coor<strong>di</strong>nate geografiche dei vertici del blocco in istanza sono elencate nella seguente Tabella 3.1:<br />
VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE<br />
a 4°5’ 40°28’ m 4°9’ 40°21’<br />
b 4°17’ 40°28’ n 4°6’ 40°21’<br />
c 4°17’ 40°27’ o 4°6’ 40°21’,404<br />
d 4°19’ 40°27’ p 4°6’,074 40°21’,347<br />
e 4°19’ 40°25’ q 4°7’,578 40°22’,485<br />
f 4°17’ 40°25’ r 4°5’,605 40°24’,001<br />
g 4°17’ 40°23’ s 4°6’,108 40°24’,381<br />
h 4°15’ 40°23’ t 4°5’,817 40°24’,617<br />
i 4°15’ 40°22’ u 4°6’,117 40°24’,858<br />
l 4°9’ 40°22’ v 4°5’ 40°25’,721<br />
Tabella 3.1 - Coor<strong>di</strong>nate geografiche dei vertici dell’area in istanza<br />
22
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
All’interno del perimetro dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o non sono presenti Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone<br />
<strong>di</strong> Protezione Speciale (Z.P.S.).<br />
3.2 Attività esplorativa precedente<br />
Di seguito verrà descritta brevemente l’attività esplorativa precedentemente svolta nell’area. Lo stu<strong>di</strong>o dei<br />
dati storici, infatti, permette <strong>di</strong> valutare se aree già interessate in passato da attività <strong>di</strong> esplorazione e<br />
produzione <strong>di</strong> idrocarburi possano ancora avere delle potenzialità estrattive o se, all’interno delle stesse,<br />
possano esserci nuovi obiettivi minerari tralasciati in precedenza (Figura 3.2).<br />
Figura 3.2 - Ubicazione dei campi estrattivi presenti nelle vicinanze dell’area <strong>di</strong> istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi “La<br />
Capriola”<br />
In <strong>relazione</strong> alle zone limitrofe all’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca, l’attività esplorativa precedente è<br />
stata abbondante, ottenendo risultati molto positivi negli scorsi decenni e, come vedremo, ha<br />
rappresentato e rappresenta tuttora una delle principali province minerarie italiane. Nel dettaglio, l’area <strong>di</strong><br />
interesse denominata “La Capriola” risulta essere stata in precedenza oggetto <strong>di</strong> attenzione dal punto <strong>di</strong><br />
vista esplorativo, con la presenza <strong>di</strong> alcuni pozzi esplorativi per idrocarburi liqui<strong>di</strong> all’interno del suo<br />
perimetro (Figura 3.3), quali:<br />
Pomarico 004;<br />
Fiume Basento 005 DIR;<br />
Fiume Basento 002;<br />
Castelluccio 002;<br />
Campanaro 001;<br />
Fiume Basento 007 DIR;<br />
Fiume Basento 008;<br />
Fiume Basento 003;<br />
23
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Fiume Basento 006;<br />
Montesottano 001;<br />
Fiume Basento 004.<br />
Figura 3.3 – Localizzazione dei pozzi esplorativi perforati all’interno dell’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “La Capriola”, relativi a precedenti<br />
attività <strong>di</strong> esplorazione e produzione<br />
I dati reperiti dai pozzi presenti nell’area <strong>di</strong> istanza hanno fornito le seguenti in<strong>di</strong>cazioni preliminari (Tabella<br />
3.2):<br />
POZZO ANNO<br />
PROFONDITÀ<br />
FINALE [m]<br />
24<br />
ESITO<br />
PROFONDITÀ DEL TETTO DEI<br />
CARBONATI [m]<br />
POMARICO 004 1959 1183,80 sterile 1173,50<br />
FIUME BASENTO 005 DIR 1986 1417 sterile Non raggiunto<br />
FIUME BASENTO 002 1984 1481 Gas (metano) Non raggiunto<br />
CASTELLUCCIO 002 1962 1551 sterile Non raggiunto<br />
CAMPANARO 001 1962 1601 sterile Non raggiunto<br />
FIUME BASENTO 007 DIR 1987 1797 sterile Non raggiunto<br />
FIUME BASENTO 008 1987 1807 sterile Non raggiunto<br />
FIUME BASENTO 003 1985 1603,50 Gas (metano) Non raggiunto
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
FIUME BASENTO 006 1986 13620 Gas (metano) Non raggiunto<br />
MONTESOTTANO 001 1963 1983,20 sterile Non raggiunto<br />
FIUME BASENTO 004 1985 2198 Gas (metano) 2188 (olio denso nei vacuoli e<br />
nelle fratture)<br />
Tabella 3.2 - Informazioni preliminari estrapolate dai dati dei pozzi presenti all’interno dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
3.2.1 Presenza <strong>di</strong> attività estrattive in zona<br />
L’attività estrattiva in Basilicata annovera uno tra i giacimenti <strong>di</strong> petrolio più importanti d’Italia, ubicato nella<br />
Val d’Agri, in provincia <strong>di</strong> Potenza.<br />
3.2.1.1 Campi petroliferi in Val d’Agri<br />
Le ricerche <strong>di</strong> idrocarburi in Val d’Agri iniziarono fin dai primi del ‘900 con uno stu<strong>di</strong>o sistematico,<br />
commissionato dall’Ispettorato del Corpo Reale minerario, delle manifestazioni superficiali <strong>di</strong> olio e gas <strong>di</strong><br />
Tramutola. Nel <strong>di</strong>cembre del 1912, la Società Petroli d’Italia (SPI) stipulò alcuni contratti <strong>di</strong> cessione con i<br />
proprietari terrieri per la ricerca e lo sfruttamento del bacino petrolifero, senza però avere gli esiti sperati.<br />
Le ricerche continuarono negli anni trenta portando alla scoperta dell’esistenza <strong>di</strong> una notevole quantità <strong>di</strong><br />
gas. Una prima fase <strong>di</strong> coltivazione si sviluppò nel ventennio 1939-1959, caratterizzato dall’embargo<br />
petrolifero e da scarsi rinvenimenti <strong>di</strong> risorse petrolifere in altre aree dell'Italia.<br />
Nel 1933 l’AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli, istituita dal Governo nel 1926), ottenne un permesso <strong>di</strong><br />
ricerca, eseguì degli stu<strong>di</strong> geologici e rinvenne nel 1937 il giacimento <strong>di</strong> Tramutola dove, tra il 1939 e il 1947<br />
si eseguirono attività <strong>di</strong> ricerca e coltivazione. Le ricerche si estesero da Tramutola alle aree <strong>di</strong> S. Angelo Le<br />
Fratte, Savoia Lucana e Brienza. Questa prima fase <strong>di</strong> attività estrattiva si chiuse nel 1959, con l’ultimo pozzo<br />
(risultato sterile) perforato da AGIP in territorio <strong>di</strong> Tramutola.<br />
Il periodo <strong>di</strong> “austerity” conseguente alla guerra in Kippur, l’emergenza petrolifera e l’innovazione<br />
tecnologica nella ricerca e sviluppo dei giacimenti <strong>di</strong> idrocarburi <strong>di</strong>edero l’avvio ad una nuova campagna<br />
esplorativa in Basilicata dove, a partire dal 1975, l’AGIP ottenne quattro nuovi permessi <strong>di</strong> ricerca che<br />
portarono alla scoperta in Val d’Agri <strong>di</strong> uno dei giacimenti più importanti d’Europa.<br />
Negli anni ’80, la ricerca, condotta dalla società Petrex, si spostò ai pie<strong>di</strong> della montagna <strong>di</strong> Viggiano e nel<br />
1981, con la perforazione del pozzo “Costa Molina 1”, fu scoperto il giacimento denominato “Trend 1”. Nel<br />
1984 il Ministero dell’Industria conferì all’AGIP la concessione <strong>di</strong> coltivazione Costa Molina. Nello stesso<br />
anno fu conferito il permesso <strong>di</strong> ricerca “Monte Sirino” alla Società Petrolifera Italiana e alla Società Fiat<br />
Rimi. Nel maggio 1988, la perforazione del pozzo “Monte Alpi 1” (a cui partecipò anche la società britannica<br />
Enterprise Oil Italiana S.p.A.) portò al rinvenimento dell’omonimo giacimento.<br />
Negli anni 90 iniziò quello che si definisce “lo sviluppo dell’attività petrolifera in Basilicata”. Il Ministero<br />
dell’Industria conferì ad AGIP le concessioni <strong>di</strong> coltivazione Grumento Nova (Decreto del 9/10/1990),<br />
Caldarosa (Decreto del 15/7/1991) e Volturino (Decreto del 27/12/1993). Nel 1996, per la prima lavorazione<br />
del petrolio si costruì a Viggiano il Centro Olio “Monte Alpi” con una capacità <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> 1.200<br />
m 3 /giorno <strong>di</strong> olio, equivalenti a 7.500 barili/giorno e 300.000 m 3 /giorno <strong>di</strong> gas. Nell’aprile del 1996 entrò in<br />
esercizio la prima linea <strong>di</strong> trattamento. Nel 1999 la concessione Costa Molina venne inglobata nella<br />
concessione Caldarosa. In quell’anno, nell'area della Val d'Agri, <strong>di</strong> pertinenza delle concessioni Grumento<br />
Nova, Volturino e Caldarosa, esistevano 24 pozzi, perforati a partire da 20 postazioni.<br />
Nel 2001 erano due le concessioni esistenti in Val d'Agri: la concessione denominata Grumento Nova, delle<br />
società ENI S.p.A. e Enterprise Oil Italiana S.p.A., <strong>di</strong> km 2 398,39 risultante dall’unificazione delle concessioni<br />
<strong>di</strong> Grumento Nova, Caldarosa e della porzione sud orientale della concessione Volturino, con scadenza<br />
fissata al 26 ottobre 2019, e la concessione Volturino, ridotta da km 2 348,37 a km 2 261,76. Nello stesso anno<br />
entrò in esercizio il Centro Olio Val d’Agri (COVA) quale ampliamento del preesistente Centro Olio Monte<br />
25
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Alpi, in produzione dal 96. Nel 2003 il 29% della titolarità della concessione Grumento Nova fu trasferita ed<br />
intestata dalla società Enterprise Oil Italiana S.p.A. alla Società Shell Italia E&P S.p.A. Nel 2005 le concessioni<br />
Grumento Nova e Volturino furono unificate in un'unica concessione denominata Val d'Agri. La nuova<br />
concessione Val d'Agri, con scadenza fissata al 26 ottobre 2019, è intestata alle società ENI S.p.A. e Shell<br />
Italia E&P S.p.A., con quote rispettivamente del 66% e del 34%.<br />
Nel 2011 è stato avviato l’ammodernamento del COVA ed approvato il nuovo programma <strong>di</strong> sviluppo della<br />
Concessione Val d’Agri.<br />
3.3 Finalità dell’intervento<br />
Delta Energy ha preparato una strategia innovativa per l’esplorazione nell’area e che si baserà<br />
sull’acquisizione <strong>di</strong> nuovi dati geofisici basati sulla sismica a riflessione e sulla loro interpretazione secondo<br />
le più innovative conoscenze per quanto riguarda l’identificazione e la caratterizzazione delle zone<br />
strutturalmente complesse e l’identificazione delle zone che sono sottoposte a stress critico per identificare<br />
le <strong>di</strong>rezioni e l‘ubicazione del reticolo <strong>di</strong> fratturazione e faglie aperte o parzialmente aperte. L’obiettivo del<br />
programma lavori proposto è la completa valutazione delle potenzialità geo-minerarie del sottosuolo<br />
nell'area in istanza, ed in particolare della possibile presenza <strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> idrocarburi economicamente<br />
sfruttabili.<br />
3.4 Programma lavori<br />
Di seguito viene riportato il programma tecnico dei lavori, sud<strong>di</strong>viso in fasi operative e tempi <strong>di</strong> esecuzione,<br />
che Delta si propone <strong>di</strong> eseguire qualora la titolarità del permesso <strong>di</strong> ricerca le venga assegnata con decreto<br />
ministeriale.<br />
I lavori qui <strong>di</strong> seguito elencati rappresentano il tipico approccio esplorativo utilizzato dall’industria<br />
petrolifera, il quale inizia con l’analisi <strong>di</strong> dati del sottosuolo già <strong>di</strong>sponibili per poi passare all’acquisizione <strong>di</strong><br />
nuove informazioni, sia tramite la rielaborazione <strong>di</strong> dati sismici precedentemente acquisiti, sia attraverso<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> nuovi. Tale ciclo prosegue con le valutazioni sul potenziale minerario dell’area in oggetto e<br />
con l’eventuale decisione <strong>di</strong> perforare uno o più pozzi esplorativi.<br />
È importante precisare che l’eventuale fase <strong>di</strong> perforazione dovrà essere oggetto <strong>di</strong> una nuova proposta<br />
progettuale da sottoporre alla necessaria valutazione ambientale e, successivamente, al parere della<br />
competente Commissione VIA.<br />
3.4.1 Fasi operative del programma lavori<br />
Il programma lavori proposto prevede due fasi operative principali: una fase <strong>di</strong> esplorazione e una fase <strong>di</strong><br />
perforazione. I risultati derivanti da ogni fase saranno integrati con tutte le altre informazioni esistenti e/o<br />
acquisite al fine <strong>di</strong> una migliore valutazione del potenziale minerario del sottosuolo nell'area in esame.<br />
1. Fase operativa <strong>di</strong> ricerca<br />
La prima fase operativa, oggetto del presente stu<strong>di</strong>o, è <strong>di</strong> tipo esplorativo e prevede una serie <strong>di</strong><br />
operazioni atte al miglioramento delle conoscenze della situazione geologica del sottosuolo e<br />
all'identificazione <strong>di</strong> possibili accumuli <strong>di</strong> idrocarburi economicamente sfruttabili. Questa fase è<br />
composta da:<br />
Stu<strong>di</strong>o geologico: gli stu<strong>di</strong> geologici e geofisici comprenderanno l'interpretazione <strong>di</strong> tutti i dati <strong>di</strong><br />
sottosuolo <strong>di</strong>sponibili (sondaggi, sismica) e l'integrazione con i dati bibliografici e <strong>di</strong> affioramento su<br />
analoghi <strong>di</strong> superficie e <strong>di</strong> sottosuolo che presentano le stesse caratteristiche geologiche dell'area in<br />
esame. Durante questa fase Delta si propone anche <strong>di</strong> svolgere stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> terreno al fine <strong>di</strong> meglio<br />
comprendere la <strong>di</strong>stribuzione spaziale e le relazioni geometriche delle unità bacinali presenti, la<br />
<strong>di</strong>stribuzione degli intervalli porosi all’interno dei calcari della piattaforma Apula e le caratteristiche<br />
del reticolo <strong>di</strong> fratture associato a calcari cretacei. I risultati <strong>di</strong> questi stu<strong>di</strong> e analisi verranno<br />
26
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
utilizzati per aggiornare e dettagliare il modello geologico e petrolifero già in possesso. Oltre a<br />
questi stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> terreno Delta Energy Ltd si impegna anche a condurre un’analisi delle foto da satellite<br />
che ricoprono l’area in istanza per meglio comprendere ed in<strong>di</strong>viduare i principali lineamenti<br />
strutturali che interessanto l’area, per meglio comprendere il pattern <strong>di</strong> fratturazione che si può<br />
riscontrare anche all’interno degli eventuali serbatoi.<br />
Acquisto, rielaborazione ed interpretazione <strong>di</strong> linee sismiche 2D pre-esistenti: Per migliorare le<br />
conoscenze del sottosuolo in particolare per quanto riguarda la situazione geologico-strutturale<br />
dell'area e per poter identificare più precisamente i criteri e le caratteristiche con cui acquisire il<br />
rilievo sismico 2D, che rappresenta l’eventuale fase successiva del programma lavori, Delta si<br />
impegna ad acquistare e rielaborare secondo le tecnologie più all'avanguar<strong>di</strong>a nel settore i dati<br />
sismici <strong>di</strong>sponibili dell'area interessata per un totale <strong>di</strong> 50 km <strong>di</strong> linee sismiche. Tale valore rimane<br />
soggetto alla qualità dei dati a <strong>di</strong>sposizione.<br />
Acquisizione, elaborazione ed interpretazione <strong>di</strong> nuovi dati sismici <strong>di</strong> tipo 2D: qualora, dopo le fasi<br />
precedenti, fosse necessario acquisire altri dati <strong>di</strong> sottosuolo <strong>di</strong> tipo sismico per meglio delineare<br />
accumuli <strong>di</strong> idrocarburi <strong>di</strong> tipo liquido o gassoso nei livelli potenziali descritti nella <strong>relazione</strong> tecnica,<br />
e per meglio definire la migliore ubicazione del pozzo esplorativo, Delta si impegna ad acquisire ed<br />
elaborare un totale <strong>di</strong> circa 80 km <strong>di</strong> linee sismiche 2D.<br />
2. Fase Operativa <strong>di</strong> Perforazione<br />
Qualora gli stu<strong>di</strong> svolti nella precedente fase operativa confermino le potenzialità minerarie dell'area<br />
in esame evidenziando la presenza <strong>di</strong> trappole che abbiano la capacità <strong>di</strong> contenere quantità<br />
economicamente sfruttabili <strong>di</strong> idrocarburi e la contemporanea presenza <strong>di</strong> rocce madre, rocce<br />
serbatoio e rocce <strong>di</strong> copertura, Delta si impegna a perforare almeno un pozzo esplorativo all'interno<br />
dell'area in oggetto la cui profon<strong>di</strong>tà finale sarà in<strong>di</strong>cativamente <strong>di</strong> circa 2300 metri e sarà comunque<br />
in funzione delle caratteristiche geologiche ritrovate. Questa eventuale fase operativa sarà sottoposta<br />
ad una nuova procedura <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale.<br />
3.5 Obiettivi minerari<br />
Considerate le caratteristiche geologico-strutturali del settore meri<strong>di</strong>onale appenninico ed in particolare<br />
dell’area <strong>di</strong> transizione tra la Catena s.s. e l’Avanfossa ove l’area in istanza ricade, il potenziale minerario<br />
dell’area può essere rappresentato da molteplici obiettivi (Figura 3.4):<br />
1. idrocarburi gassosi e liqui<strong>di</strong> nei livelli porosi dei carbonati della piattaforma Apula in trappole<br />
strutturali;<br />
2. livelli a gas e ad idrocarburi liqui<strong>di</strong> nella serie calcarenitica del Terziario (Miocene);<br />
3. idrocarburi gassosi nei livelli sabbiosi <strong>di</strong> origine torbi<strong>di</strong>tica del Pliocene-Pleistocene depositatisi<br />
nell’avanfossa bradanica in trappole strutturali, stratigrafiche e miste.<br />
L’importanza <strong>di</strong> questi obiettivi è stata confermata dalle scoperte nelle aree circostanti <strong>di</strong> numerosi campi <strong>di</strong><br />
idrocarburi o dalla presenza <strong>di</strong> manifestazioni in <strong>di</strong>versi pozzi perforati nelle zone limitrofe.<br />
L’assetto geologico-strutturale, la natura litologica e l’evoluzione tettonica <strong>di</strong> questo settore della catena<br />
Appenninica Meri<strong>di</strong>onale sono oggetto da tempo <strong>di</strong> un notevole interesse geominerario. L’obiettivo<br />
principale dell’esplorazione, in particolare, risulta essere costituito dalle anticlinali <strong>di</strong> rampa formatesi tra il<br />
Pliocene me<strong>di</strong>o e il Pleistocene inferiore, come conseguenza <strong>di</strong> modelli strutturali talvolta con geometria<br />
“duplex” nella piattaforma Apula al <strong>di</strong> sotto delle sequenze alloctone.<br />
La falda <strong>di</strong> copertura Appenninica abbraccia varie unità tettono-stratigrafiche impilatesi durante l’orogenesi<br />
alpina nel Miocene-Pleistocene. Tali unità sono caratterizzate da se<strong>di</strong>menti compresi tra il Mesozoico e il<br />
Terziario e dalle unità sin-orogeniche dei flysch. Il thrust belt Apulo rappresenta l’area <strong>di</strong> principale interesse<br />
per gli obiettivi minerari dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale suffragati dai dati provenienti dai vicini giacimenti della<br />
Val d’Agri e Tempa Rossa.<br />
27
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.4 - Relazioni stratigrafiche tra Catena e Avanfossa nel settore Appenninico meri<strong>di</strong>onale; in evidenza i livelli a gas e ad olio<br />
nei rispettivi intervalli cronostratigrafici<br />
La generazione e la migrazione degli idrocarburi oggetto <strong>di</strong> ricerca, tuttavia, sembrano essere intimamente<br />
correlate alla messa in posto delle trappole strutturali precedentemente citate. I dati provenienti dalle<br />
perforazioni eseguite nelle aree limitrofe a quella in istanza e le analisi geochimiche degli oli, in<strong>di</strong>cano che<br />
essi si sono generati da una roccia madre carbonatica tipica <strong>di</strong> ambiente prevalentemente marino come i<br />
carbonati euxinici <strong>di</strong> intrapiattaforma <strong>di</strong> età compresa tra il Cretaceo inferiore e me<strong>di</strong>o.<br />
I numerosi stu<strong>di</strong> svolti nell’area, che hanno avuto un notevole incremento negli ultimi anni, pongono<br />
ragionevoli certezze sulla presenza <strong>di</strong> roccia madre al <strong>di</strong> sotto dell’area in istanza, malgrado questo tipo <strong>di</strong><br />
roccia non sia caratterizzata da un’assoluta uniformità.<br />
I dati provenienti dai campi in produzione posti nelle vicinanze sono caratterizzati da valori eterogenei<br />
dell’olio: mentre il campo Val d’Agri è caratterizzato da un olio leggero (>30° API), il campo Tempa Rossa<br />
presenta un olio più pesante (
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Di seguito sono sud<strong>di</strong>vise e illustrate le principali caratteristiche delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> rocce che<br />
compongono il complesso sistema del reservoir Apulo e Bradanico: roccia madre, roccia serbatoio<br />
(fratturate e/o incarsite), rocce serbatoio clastiche (laddove presenti), rocce <strong>di</strong> copertura e le <strong>di</strong>verse<br />
tipologie <strong>di</strong> trappole presenti nell’area <strong>di</strong> ricerca.<br />
3.6 Rocce serbatoio carbonatiche<br />
Le rocce serbatoio all’interno della piattaforma Apula sono rappresentate dai livelli a calcari, calcari<br />
dolomitici e dolomie <strong>di</strong> età comprese tra il Cenomaniano ed il Miocene me<strong>di</strong>o a cui è associata una porosità<br />
sia <strong>di</strong> tipo primaria che secondaria. Si tratta essenzialmente <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti originatisi in ambiente marino<br />
poco profondo, grossomodo se<strong>di</strong>menti lagunari e tidali che presentano una porosità primaria generalmente<br />
molto bassa (1-5%) per i carbonati <strong>di</strong> facies <strong>di</strong> piattaforma del Cretaceo mentre più elevate per i carbonati <strong>di</strong><br />
rampa del Terziario. Nella sequenza Mesozoica, specie se associati alle dolomie, la porosità può avere valori<br />
leggermente superiori. Le con<strong>di</strong>zioni legate alla produzione sono essenzialmente determinate dalla<br />
presenza <strong>di</strong> una fitta e particolarmente intensa rete <strong>di</strong> fratturazione che a livello locale favorisce una<br />
permeabilità dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> qualche mDarcy.<br />
La presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> porosità all’interno dei calcari della Piattaforma Apula, lungo l’intera<br />
colonna stratigrafica, possono essere così sud<strong>di</strong>vise:<br />
vacuolare/mol<strong>di</strong>ca/shelter, associata sia alla <strong>di</strong>ssoluzione <strong>di</strong> gusci <strong>di</strong> organismi (prevalentemente<br />
bivalvi), sia alla <strong>di</strong>ssoluzione legata alla circolazione <strong>di</strong> flui<strong>di</strong> <strong>di</strong>agenetici in una matrice già porosa;<br />
intercristallina;<br />
intragranulare;<br />
dovuta a macro e microfratture aperte.<br />
Nel dettaglio, i vari tipi <strong>di</strong> reservoir della successione Apula possono essere sintetizzati come segue:<br />
calcari caratterizzati da porosità primaria e <strong>di</strong> fratturazione del Miocene me<strong>di</strong>o-inferiore associati ad<br />
ambienti <strong>di</strong> rampa carbonatica con energia deposizionale che può essere, talvolta, molto elevata. Il<br />
meccanismo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione è legato al bilancio tra apporto se<strong>di</strong>mentario e loro successiva<br />
<strong>di</strong>stribuzione; quest’ultima a sua volta è collegata alle correnti deposizionali, e all’orientazione della<br />
rampa e dai punti sorgente. Pertanto, la continuità dei livelli sabbiosi è molto variabile e<br />
conseguentemente la loro correlabilità è ben riconosciuta soltanto in alcuni casi;<br />
se<strong>di</strong>menti neritici tardo cretacici, depostisi in un ambiente compreso tra la zona sopratidale e <strong>di</strong><br />
laguna aperta, caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> livelli a Ru<strong>di</strong>ste con elevata porosità vacuolare e da<br />
quelli <strong>di</strong> brecce dolomitiche altrettanto porose;<br />
calcari <strong>di</strong> piattaforma del Cretacico inferiore e Giurassico possono presentare una <strong>di</strong>ffusa<br />
dolomitizzazione, con porosità inter ed intra-cristallina;<br />
depositi <strong>di</strong> piattaforma carbonatica interna, anch’essi fratturati e <strong>di</strong>scretamente porosi,<br />
rise<strong>di</strong>mentati in un ambiente <strong>di</strong> piattaforma esterna o <strong>di</strong> scarpata durante l’Eocene.<br />
Nella ricerca <strong>di</strong> idrocarburi in Italia meri<strong>di</strong>onale i giacimenti che producono da livelli carbonatici della<br />
Piattaforma Apula sono riconducibili essenzialmente a 3 tipi (Tabella 3):<br />
Calcari e calcareniti miocenici depostisi in ambiente <strong>di</strong> rampa con porosità <strong>di</strong> matrice che può<br />
raggiungere il 20% e notevoli valori <strong>di</strong> permeabilità. In questo caso la fratturazione gioca un ruolo<br />
secondario nella produzione e nella caratteristiche della roccia serbatoio (Figura 3.5);<br />
Calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore deposti in ambiente <strong>di</strong> piattaforma con porosità <strong>di</strong><br />
matrice solitamente inferiore al 10% e permeabilità bassa. In queste rocce serbatoio la fratturazione<br />
gioca un ruolo fondamentale sulla possibilità <strong>di</strong> produzione e potenzialità <strong>di</strong> queste rocce serbatoio;<br />
Calcari e dolomie del Cretaceo inferiore-Giurassico con porosità e permeabilità <strong>di</strong> matrice e<br />
caratteristiche <strong>di</strong> fratturazione simili ai precedenti.<br />
29
NOME<br />
FORMAZIONE<br />
-RESERVOIR<br />
Bolognano Miocene<br />
Altamura<br />
Bari<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
ETÀ LITOLOGIA<br />
Secondano<br />
(Cretaceo<br />
sup.)<br />
Cretaceo inf.-<br />
Giurassico<br />
Calcari e<br />
calcareniti<br />
Calcari e<br />
dolomie<br />
calcaree<br />
Calcari e<br />
dolomie<br />
AMBIENTE<br />
DEPOSIZIONALE<br />
30<br />
POROSITÀ<br />
MATRICE<br />
PERMEABILITÀ<br />
MATRICE<br />
(mD)<br />
OIL<br />
(°API)<br />
Rampa 5-20% 300-1000 20-40<br />
Piattaforma<br />
carbonatica<br />
Piattaforma<br />
carbonatica<br />
TIPO<br />
GIACIMENTO<br />
MATRICE<br />
(CARSISMO +<br />
FRATTURE)<br />
2-12% 0.1-100 11-30 DUAL K/PHI<br />
2-10% 300 20 DUAL K/PHI<br />
Tabella 3 - Quadro riassuntivo dei reservoir carbonatici della Piattaforma Apula<br />
Figura 3.5 - Livello <strong>di</strong> calcareniti terziarie con alta porosità <strong>di</strong> matrice nei pressi <strong>di</strong> Matera<br />
Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono uno degli obiettivi principali della ricerca<br />
esplorativa per idrocarburi nell’area in istanza, sono molto complesse oltre che da un punto <strong>di</strong> vista<br />
geologico, anche sotto l’aspetto <strong>di</strong>namico. L’eterogeneità che le caratterizza è dovuta alla complessità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione delle facies carbonatiche e la loro previsione in 3D è tutt’altro che semplice. La ragione<br />
principale <strong>di</strong> questa complessità è dovuta all’interazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi fattori legati alla loro <strong>di</strong>stribuzione e<br />
tipologia. I principali fattori che controllano e contrad<strong>di</strong>stinguono le facies carbonatiche ed i loro ambienti<br />
deposizionali sono:<br />
i fattori fisici legati all’ambiente (correnti, energia del moto ondoso...);<br />
la temperatura dell'acqua e la circolazione;<br />
la penetrazione della luce;<br />
l’ossigenazione dell’acqua;<br />
la salinità dell’acqua;<br />
l’apporto terrigeno;<br />
l’abbondanza e la <strong>di</strong>versità dei nutrienti;<br />
l’età (ogni periodo è caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi organismi);<br />
la biologia degli organismi;
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
la latitu<strong>di</strong>ne e quin<strong>di</strong> il clima;<br />
accumulo/deposizione/tasso <strong>di</strong> subsidenza;<br />
variazioni batimetriche.<br />
Una volta che i se<strong>di</strong>menti si sono depositati, subentrano altri fattori ad influenzare fortemente l'evoluzione<br />
delle rocce carbonatiche ed il loro futuro sviluppo come possibili rocce serbatoio:<br />
l’evoluzione <strong>di</strong>agenetica;<br />
la circolazione <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>;<br />
l’evoluzione delle sequenze;<br />
la tettonica (geometria della fratture).<br />
Per una buona descrizione e la modellizzazione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> serbatoio si devono prendere in<br />
considerazione tutti questi fattori perché hanno una forte influenza sul volume dei pori e sulla connettività<br />
che ne determina la permeabilità (Figura 3.6).<br />
Figura 3.6 - Porosità legata alla <strong>di</strong>ssoluzione delle Ru<strong>di</strong>ste nei calcari tardo-Cretacici della piattaforma Apula<br />
Per quanto riguarda i serbatoi carbonatici fratturati, l'identificazione e la <strong>di</strong>stribuzione delle fratture al loro<br />
interno è <strong>di</strong>fficile in quando esiste una mancanza <strong>di</strong> dati relativi al sottosuolo. Tuttavia utilizzando dati in<br />
affioramento e <strong>di</strong> sottosuolo molti autori hanno stu<strong>di</strong>ato la <strong>relazione</strong> tra la fratturazione e i <strong>di</strong>versi<br />
parametri che possono essere identificati in una sequenza carbonatica (litologia, consistenza, spessore degli<br />
strati, etc.). Queste relazioni sono fortemente influenzate da fattori locali e regionali, ma alcune regole<br />
generali possono essere identificate e generalizzate.<br />
L'intensità della fratturazione si pensa essere in parte controllata dallo spessore degli strati (Ladeira e Price,<br />
1981;. Shaocheng et al., 1998) e dalla litologia (Atkinson & Mere<strong>di</strong>th, 1987; Pollard & Ay<strong>di</strong>n 1988;<br />
Wennberg et al., 2006). Price 1966, riporta una <strong>relazione</strong> pressappoco lineare tra spaziatura me<strong>di</strong>a dei<br />
giunti e spessore stratale e suggerisce che l'aumento <strong>di</strong> intensità <strong>di</strong> fratturazione in strati sottili è dovuta al<br />
trasferimento <strong>di</strong> stress dagli strati incompetenti a<strong>di</strong>acenti a quello competente. Gross et al. 1995, riportano<br />
una riduzione della zona d’ombra dello stress attorno ai pre-esistenti joint che aumenta in estensione<br />
laterale in <strong>relazione</strong> alla loro altezza. L’altezza dei joint corrisponde solitamente allo spessore dello strato<br />
con conseguente cor<strong>relazione</strong> lineare tra spessore degli strati e spaziatura dei joint. La <strong>relazione</strong> tra<br />
l’intensità <strong>di</strong> fratturazione e litologia può essere spiegato da <strong>di</strong>fferenze nelle proprietà elastiche. Gross et al.,<br />
1995 riportano che l’estensione laterale della stress shadow aumenti con l’aumentare dei moduli <strong>di</strong> Young<br />
in<strong>di</strong>ca quin<strong>di</strong> che la spaziatura dei joint dovrebbe essere maggiore negli strati con più alti moduli <strong>di</strong> Young,<br />
vale a <strong>di</strong>re negli strati più rigi<strong>di</strong>, quin<strong>di</strong> mudstone. Questo tuttavia non è sempre il caso degli strati più<br />
31
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
competenti che spesso mostrano intensità <strong>di</strong> fratturazione superiore; questo può essere spiegato con la<br />
giunzione che si verifica a livelli <strong>di</strong> deformazione inferiori all'interno degli strati rigi<strong>di</strong>, a causa della loro<br />
natura fragile. L’intensità <strong>di</strong> fratturazione registrata in affioramento è probabile che sia una sovrastima <strong>di</strong><br />
quella trovata nel sottosuolo a causa della pressione <strong>di</strong> rilascio dei joint; può anche essere che sia la<br />
correzione <strong>di</strong> Terzaghi ad essere una sovrastima delle fratture quando viene utilizzata sulle scan-line<br />
(Rohrgbaugh Jr. et al., 2002).<br />
Alcuni stu<strong>di</strong> dettagliati effettuati in Maiella e nella zona delle Murge (Sharkeley et al., 2007, Di Cuia et al.,<br />
2009) hanno permesso <strong>di</strong> comprendere meglio il rapporto tra <strong>di</strong>stribuzione, intensità e caratteristiche della<br />
fratturazione e altri importanti fattori (litologia, tessitura delle rocce, posizione nella struttura, etc.).<br />
In generale, l'intensità <strong>di</strong> fratturazione è maggiore in strati sottili piuttosto che in quelli spessi. Esiste una<br />
<strong>relazione</strong> lineare tra lo spessore degli strati e l'intensità <strong>di</strong> fratturazione; questa <strong>relazione</strong> può essere<br />
osservata sui dati acquisiti sia su piattaforma che in scarpata. Entrambe mostrano gra<strong>di</strong>enti simili<br />
(piattaforma 0,35 e scarpata 0,26), evidenziando una generale <strong>relazione</strong> tra l'intensità della fratturazione e<br />
lo spessore degli strati (Figura 3.7).<br />
Figura 3.7 - Relazione tra spessore degli strati e intensità <strong>di</strong> fratturazione (a) e tessitura e densità <strong>di</strong> fratturazione (b) (fonte: Di<br />
Cuia et al., 2009)<br />
32
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate (Figura 3.8 e Figura 3.9) sono piuttosto <strong>di</strong>fficili da prevedere,<br />
comprendere, descrivere e modellizzare a causa della complessità <strong>di</strong> altri fattori che influenzano la corretta<br />
<strong>di</strong>stribuzione delle fratture. Peacock e Mann in un articolo del 2005 hanno cercato <strong>di</strong> riassumere i principali<br />
fattori che controllano le fratture nelle rocce serbatoio. Questi fattori possono essere raggruppati in tre<br />
categorie principali:<br />
fattori legati alle rocce e alle loro caratteristiche <strong>di</strong>agenetiche;<br />
fattori strutturali;<br />
situazione <strong>di</strong> stress attuale.<br />
Figura 3.8 – Calcari fratturati della Piattaforma Apula (cava <strong>di</strong> Altamura)<br />
Non è sempre facile in<strong>di</strong>viduare e interpretare faglie e fratture nel sottosuolo. La loro importanza relativa<br />
sul serbatoio, specie quando il segnale sismico è <strong>di</strong> scarsa qualità o quando i dati sono quantitativamente<br />
limitati. Nella parte a terra dell’ Appennino meri<strong>di</strong>onale si verificano entrambe queste situazioni, la qualità<br />
della sismica è in generale scarsa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile interpretazione e i dati <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> sottosuolo (carote, <strong>di</strong>agrafie<br />
<strong>di</strong> immagine, etc.) non sono abbondanti. Pertanto bisogna utilizzare un approccio in<strong>di</strong>retto per<br />
comprendere le caratteristiche strutturali delle rocce serbatoio. La metodologia utilizzata da Delta Energy<br />
per l’identificazione <strong>di</strong> zone fratturate utilizza in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> frattura in<strong>di</strong>retta quali:<br />
1) i log <strong>di</strong> produzione (PLT e log <strong>di</strong> temperatura in produzione e iniezione);<br />
2) descrizione delle carote e analisi - la scala <strong>di</strong> osservazione è limitata così come l'entità delle fratture e<br />
faglie che possono essere identificate;<br />
3) parametri <strong>di</strong> perforazione (per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> fango, tasso <strong>di</strong> penetrazione, % <strong>di</strong> recupero delle carote,<br />
manifestazioni, etc.):<br />
33
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Per<strong>di</strong>te fango – avviene dove la permeabilità della formazione è maggiore (in vecchi pozzi la per<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> fango sembra essere superiore, probabilmente dovuto a tecniche <strong>di</strong> perforazione meno avanzate<br />
e alla scarsa esperienza in questo tipo <strong>di</strong> serbatoio);<br />
Tasso <strong>di</strong> penetrazione - aumenta dove il grado <strong>di</strong> compattazione della formazione <strong>di</strong>minuisce;<br />
% <strong>di</strong> recupero delle carote - potrebbe essere influenzato dalla densità <strong>di</strong> fratturazione o dalla<br />
compattazione;<br />
manifestazioni - in<strong>di</strong>catore della presenza <strong>di</strong> HC.<br />
4) Log Elettrici (Sonico, GR, Caliper, LLD/LLS, CNL-LDT, SP), le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> un tipo o la combinazione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> log in<strong>di</strong>cano la presenza <strong>di</strong> fratture, visto che:<br />
Log Sonico - dove <strong>di</strong>minuisce la velocità <strong>di</strong> propagazione delle onde acustiche le fratture sono<br />
aperte o riempite con <strong>di</strong>fferente materiale;<br />
Caliper - se la <strong>di</strong>mensione del foro aumenta vi è una variazione nella litologia della formazione o<br />
durezza;<br />
Resistività - grande <strong>di</strong>fferenza tra la resistività superficiale e profonda in<strong>di</strong>ca fratture con un grande<br />
sviluppo;<br />
Density Log – la <strong>di</strong>minuzione dei valori <strong>di</strong> densità nella stessa litologia in<strong>di</strong>ca che la compattazione si<br />
riduce.<br />
5) Image Log (FMI, FMS e UBI) - per in<strong>di</strong>viduare l’orientazione delle fratture, la densità e il rapporto relativo<br />
e identificare la presenza <strong>di</strong> vacuoli (maggiori intervalli <strong>di</strong> porosità).<br />
Figura 3.9 – Calcari fratturati con fuoriuscita <strong>di</strong> bitume in una cava a Lettomanopello nei pressi della Maiella<br />
La presenza <strong>di</strong> più in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> fratture alla stessa profon<strong>di</strong>tà aumenta la probabilità <strong>di</strong> aver in<strong>di</strong>viduato una<br />
frattura o una faglia. Questo approccio è molto utile, ma può essere fuorviante se non adeguatamente<br />
calibrato e utilizzato con cura da persone esperte.<br />
La maggior parte dei serbatoi fratturati naturalmente sono caratterizzati da un basso valore <strong>di</strong> porosità della<br />
matrice (molto inferiore al 10%) e da una bassa permeabilità (inferiore a 1 mD).<br />
Il calcolo della porosità ha coinvolto nel tempo geologi, reservoir engineer e petrofisici. Qui <strong>di</strong> seguito è<br />
illustrato l'approccio adottato da Roberto Aguilera in uno dei suoi stu<strong>di</strong> (Aguilera, 1995):<br />
Nel tentativo <strong>di</strong> quantificare la porosità da frattura si può incorrere in valori anche del 100%. Questo perché<br />
la porosità da frattura, a <strong>di</strong>fferenza della porosità <strong>di</strong> matrice, è fortemente <strong>di</strong>pendente dalla scala. Per<br />
esempio, se in un pozzo abbiamo un 1-piede <strong>di</strong> rottura della perforazione, il valore <strong>di</strong> porosità da frattura in<br />
quella particolare posizione all'interno <strong>di</strong> tale rottura è del 100% (altri tipi <strong>di</strong> porosità secondaria potrebbero<br />
anche essere presenti ma non rilevabili). In generale, alla scala dell’intero serbatoio, il valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
34
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
porosità da frattura è in molti casi meno dell’1%. Di seguito sono riportati alcuni valori <strong>di</strong> porosità da<br />
frattura pubblicati in letteratura:<br />
Chalk <strong>di</strong> Austin, Texas: 0,2%;<br />
Formazione <strong>di</strong> Monterey, California: da 0,01 a 1,1%;<br />
Zona carsica del sud Africa: da 1 a 2%;<br />
Campo <strong>di</strong> Amal, Libia: 1,7%;<br />
Campo a gas del Fiume Beaver, Columbia Britannica: da 0,05 a 5%;<br />
Ellenburger, Texas: 0,23-1,04%;<br />
Calcari del Mississippi, Oklahoma: 0,5%;<br />
Lacq Supérieur, Francia: 0,5%.<br />
3.6.1 Rocce serbatoio incarsite nella piattaforma carbonatica Apula<br />
Le rocce carbonatiche dell’Appennino meri<strong>di</strong>onale presentano un grande sviluppo <strong>di</strong> fenomeni carsici sia<br />
superficiali (Figura 3.10 e Figura 3.11) che profon<strong>di</strong> (Figura 3.12). L'attuale topografia carsica dell’Avampaese<br />
apulo nella regione delle Murge assomiglia ad un’area con storia del carsismo polifasico caratterizzata da<br />
eventi che alternano seppellimenti ed emersioni. Il più comune livello paleocarsico della piattaforma Apula<br />
è rappresentato dai depositi <strong>di</strong> bauxite nel Cretaceo, associati a fenomeni <strong>di</strong> carsismo superficiale<br />
(Carannante et al., 1988).<br />
Delta Energy ha iniziato da tempo lo stu<strong>di</strong>o sui carbonati della Piattaforma Apula per comprendere le<br />
caratteristiche ed i principali fattori che controllano lo sviluppo <strong>di</strong> geometrie legate alla <strong>di</strong>ssoluzione ed al<br />
carsismo. Questi stu<strong>di</strong> utilizzano oltre che le informazioni raccolte sul terreno anche l’utilizzo delle foto da<br />
satellite per identificare i lineamenti strutturali e le geometrie carsiche.<br />
Figura 3.10 – Esempio <strong>di</strong> foto da satellite nella zona <strong>di</strong> Altamura che evidenza la presenza <strong>di</strong> un sistema carsico controllato dai<br />
principali lineamenti strutturali<br />
Figura 3.11 - Modellizzazione delle zone limitrofe al Pulo <strong>di</strong> Altamura<br />
35
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.12 – Modello carsico nei calcari della Piattaforma Apula<br />
Il più sorprendente esempio <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> paleocarsismo nei depositi carbonatici della piattaforma Apula si<br />
è sviluppato nel corso del Miocene. Questa fase, la cui durata è fortemente <strong>di</strong>battuta, ha permesso lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> un profilo carsico completo che può raggiungere una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 100 metri rispetto alla<br />
originaria superficie topografica. Nel sottosuolo il più rappresentativo e stu<strong>di</strong>ato esempio carsico è<br />
rappresentato dal campo a petrolio <strong>di</strong> Rospo Mare (Doulcet et al. 1990, André e Doulcet 1991). Si trova nel<br />
mare Adriatico, 20 km a est della costa italiana vicino al 42° parallelo, 40 km a nord della penisola del<br />
Gargano e 75 km a S-E della città <strong>di</strong> Pescara. Il campo è <strong>di</strong> circa 10 × 15 km <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni e il serbatoio, che<br />
si trova ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 1310 m, ha riserve recuperabili che sono state valutate in 15 × 10 6 m 3 <strong>di</strong><br />
petrolio viscoso (11°-12° API, André e Doulcet, 1991) (Figura 3.13).<br />
36
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.13 - Distribuzione verticale della porosità legata al carsismo (fonte: André & Doulcet, 1991, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
Il serbatoio è costituito da calcari incarsiti del Cretaceo inferiore (Formazione <strong>di</strong> Cupello), caratterizzata da<br />
mudstone/wackestone dal bianco al grigio chiaro, con intercalazione <strong>di</strong> packstone/grainstone; i wackestone<br />
sono dominanti ed i principali grani sono rappresentati da ooi<strong>di</strong>, peloi<strong>di</strong> e bioclasti. La roccia <strong>di</strong> copertura è<br />
rappresentata dalla Formazione Bolognano (Miocene) e dalle evaporiti messiniane (Figura 3.14).<br />
Il petrolio è ospitato nelle cavità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione associate al paleocarsismo sviluppatosi nei calcari cretacici<br />
prima della trasgressione miocenica. Stu<strong>di</strong> sul carsismo e sulla fratturazione hanno consentito dettagliate<br />
correlazioni fra le <strong>di</strong>verse zone carsiche.<br />
Gli stu<strong>di</strong> eseguiti su carote <strong>di</strong> fondo hanno <strong>di</strong>mostrato che la densità <strong>di</strong> frattura può raggiungere anche una<br />
concentrazione <strong>di</strong> 15 fratture al metro. L'origine <strong>di</strong> queste fratture è associata a meccanismi <strong>di</strong> collasso delle<br />
volte carsiche. Molti dei condotti carsici e delle fratture sono state parzialmente o completamente sigillati<br />
da se<strong>di</strong>menti marini del Miocene.<br />
I vacuoli sono molto sviluppati specialmente lungo il tetto dei condotti carsici; le loro <strong>di</strong>mensioni variano da<br />
millimetriche fino a 7-8 centimetri e la porosità associata a questi intervalli vacuolari va fino all’8%. Stu<strong>di</strong> su<br />
carote <strong>di</strong> fondo mettono in evidenza la presenza anche <strong>di</strong> porosità secondaria associata a fratture, pertanto,<br />
la porosità effettiva delle rocce serbatoio deve essere superiore alla porosità misurata su carota.<br />
37
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
3.7 Rocce serbatoio clastiche<br />
Figura 3.14 - Composite log dal pozzo Monica 1<br />
La successione a livelli torbi<strong>di</strong>tici del Pliocene me<strong>di</strong>o-Pleistocene rappresentano il principale target a gas<br />
biogenico presente soprattutto nel settore dell’Avanfossa bradanica. I livelli torbi<strong>di</strong>tici a sabbie argillose,<br />
dallo spessore variabile <strong>di</strong> 2-20 m, sono intercalati da marne pelagiche e argille che creano pacchi <strong>di</strong> strati<br />
multipli che possono raggiungere anche spessori <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> metri.<br />
Le sequenze torbi<strong>di</strong>tiche sono caratterizzate da un’estrema variabilità dei parametri petrofisici. In generale i<br />
valori <strong>di</strong> porosità nelle torbi<strong>di</strong>ti Plioceniche variano tra il 10% e il 30% con valori <strong>di</strong> permeabilità che posso<br />
andare da 2 mD e 2000 mD. Le successioni torbi<strong>di</strong>tiche <strong>di</strong> età Pleistocenica presentano sempre valori <strong>di</strong><br />
porosità che vanno dal 10% al 30% ma i valori <strong>di</strong> permeabilità registrati sono compresi tra i 50 mD e i 500<br />
mD. I bassi valori <strong>di</strong> porosità sono associati ai livelli a shale che rappresentano le facies più <strong>di</strong>stali delle<br />
correnti <strong>di</strong> torbida.<br />
La porosità me<strong>di</strong>a riportata per 60 degli 89 giacimenti produttivi a gas è del 25,4% con valori che vanno dal<br />
5% (Campo <strong>di</strong> Lucera) al 33% (campi <strong>di</strong> Bastia e Mezzanelle). Negli stessi campi la me<strong>di</strong>a del Recovery Factor<br />
è <strong>di</strong> circa il 56,6% con valori minimi del 20% (Campo <strong>di</strong> San Teodoro) e massimi del 78% (Campo <strong>di</strong> Termoli).<br />
38
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione dei livelli torbi<strong>di</strong>tici e il loro spessore è principalmente influenzato dai depocentri controllati<br />
dal sistema <strong>di</strong> faglie. Quest’ultimi, relativamente stretti e allungati in <strong>di</strong>rezione NO-SE, sono stati riempienti<br />
dai depositi legati alle correnti <strong>di</strong> torbida e sono allineati parallelamente alla <strong>di</strong>rezione del flusso. La<br />
risultante sequenza torbi<strong>di</strong>tica consiste in depositi <strong>di</strong> scarpata, bacinali e <strong>di</strong> ventagli. La maggior parte degli<br />
accumuli <strong>di</strong> gas si trova nella parte esterna dei depositi <strong>di</strong> ventaglio.<br />
Durante il Plio-Pleistocene, gli assi dei depocentri si sono allontanati dalla parte frontale del<br />
sovrascorrimento (dalla parte interna verso quella esterna dell’avampaese) muovendosi con <strong>di</strong>rezione SO-<br />
NE ma al tempo stesso anche con <strong>di</strong>rezione NO-SE.<br />
3.8 Roccia <strong>di</strong> Copertura<br />
La roccia <strong>di</strong> copertura per i se<strong>di</strong>menti pliocenici è rappresentata dai livelli argillosi. La continuità <strong>di</strong> questa<br />
copertura è assicurata dal fatto che la se<strong>di</strong>mentazione <strong>di</strong> tipo argilloso rappresenta il principale tipo <strong>di</strong><br />
depositi dell’area (Figura 3.15).<br />
Figura 3.15 - Alternanze <strong>di</strong> livelli sabbiosi <strong>di</strong> origine torbi<strong>di</strong>tica e argille nel pozzo Fiume Basento 2. La prima curva rappresenta SP,<br />
mentre le altre i valori <strong>di</strong> resistività<br />
39
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Per quanto riguarda la roccia <strong>di</strong> copertura dei depositi carbonatici della piattaforma Apula, essa è costituita<br />
dalle sequenze silicoclastiche <strong>di</strong> età Pliocenica-Pleistocenica tipici <strong>di</strong> un ambiente deposizionale marino<br />
collegato ad una zona <strong>di</strong> Avanfossa, e anche dai livelli gessiferi del Messiniano. Questi depositi <strong>di</strong> Avanfossa<br />
ricoprono in maniera uniforme e continua il tetto della piattaforma. I depositi Pliocenici e Pleistocenici sono<br />
costituiti essenzialmente da scisti, corpi torbi<strong>di</strong>tici e da corpi pelitici molto estesi e spessi (Figura 3.16).<br />
Proprio la continuità dei livelli argillosi e anche le variazioni laterali <strong>di</strong> facies fanno da sigillo assicurando una<br />
buona tenuta della roccia <strong>di</strong> copertura. In particolare, gli scisti pliocenici forniscono il sigillo essenzialmente<br />
agli accumuli della Val d’Agri.<br />
Figura 3.16 - Esempio <strong>di</strong> roccia <strong>di</strong> copertura Pleistocenica sopra i calcari della piattaforma Apula nel pozzo Fiume Basento 4<br />
3.9 Roccia madre<br />
Gli idrocarburi gassosi, uno degli obiettivi della ricerca mineraria nella zona in istanza <strong>di</strong> permesso, sono<br />
rappresentati principalmente dal gas <strong>di</strong> origine biogenica (79%). Nell’area sono presenti tutte le con<strong>di</strong>zioni<br />
per la formazione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> gas: adeguati contenuti <strong>di</strong> materia organica nei se<strong>di</strong>menti più argillosi<br />
(TOC da tracce a 1,0%; composizione terrigena del kerosene: >80%), elevata velocità <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione e<br />
subsidenza, regime termico <strong>di</strong> tipo freddo (
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
all’ambiente deposizione molto riducente della roccia madre. La roccia madre è rappresentata da livelli più<br />
ricchi in materia organica all’interno dei calcari della piattaforma apula, in particolare <strong>di</strong> età Cretacea (come<br />
nel caso degli oli del campo <strong>di</strong> Tempa Rossa).<br />
L’esplorazione petrolifera condotta nelle aree con contesti geologici analoghi a quello investigato, ha messo<br />
in evidenza la presenza <strong>di</strong> due tipologie ben <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> idrocarburi. In particolare, (i) idrocarburi liqui<strong>di</strong> e<br />
gassosi <strong>di</strong> origine termogenica nei carbonati mesozoici e (ii) gas biogenico nei depositi torbi<strong>di</strong>tici pliopleistocenici.<br />
La roccia madre e le caratteristiche <strong>di</strong> questi idrocarburi sono considerevolmente <strong>di</strong>versi<br />
(Figura 3.17).<br />
La roccia madre relativa agli idrocarburi liqui<strong>di</strong> nei carbonati della piattaforma Apula è rappresentata dai<br />
livelli argillosi dell’Albiano-Cenomaniano ricchi in materia organica, compresi nella successione del Bacino <strong>di</strong><br />
Lagonegro e dalle marne ed argille depositatesi in bacini intrapiattaforma della Piattaforma Apula, come<br />
testimoniato dalle caratteristiche degli oli dei campi della Val d’Agri e <strong>di</strong> Tempa Rossa.<br />
I principali tipi <strong>di</strong> idrocarburi liqui<strong>di</strong> possono esser <strong>di</strong>stinti sulla base delle analisi isotopiche, gascromatografiche,<br />
dai parametri fisici e dai biomarker: i) Oli maturi, caratterizzati da materia organica <strong>di</strong> tipo<br />
continentale, depostasi in ambiente ossigenato e ampio entro rocce <strong>di</strong> tipo argilloso; ii) Oli immaturi o<br />
parzialmente maturi, provenienti da una roccia madre marina depostasi in un ambiente deposizionale<br />
carbonatico con apporti continentali.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della materia organica risulta essere eterogenea, con valori <strong>di</strong> TOC (contenuto <strong>di</strong> carbonio<br />
organico) molto variabili tra 0,1 e 3,2% nelle dolomie, ma anche più del 45% in argille. Il kerogene è<br />
immaturo (Ro pari a 0,4%), <strong>di</strong> origine prevalentemente marina e con valori HI (in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> idrogeno) elevati<br />
(600-800 mg HC/g TOC). Il potenziale me<strong>di</strong>o è uguale a 2 kg HC/t, ma può arrivare anche a valori <strong>di</strong> 200 kg<br />
HC/t nelle litologie argillose; le densità mostrano oli con 30-45° API fino a 3° API, con la prevalenza <strong>di</strong> gra<strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong> (15-20° API).<br />
Figura 3.17 - Tipi <strong>di</strong> idrocarburi nei depositi mesozoici e Plio-pleistocenici (fonte: Sella et al. 1988, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
Il gas <strong>di</strong> origine termogenica (6% degli idrocarburi totali del bacino), può essere considerato come il<br />
prodotto <strong>di</strong> cracking della materia organica.<br />
Le densità relative agli idrocarburi liqui<strong>di</strong> nelle zone a terra mostrano valori molto variabili. Sono rinvenuti<br />
oli molto densi (3° API, nel pozzo Galgano), oli molto flui<strong>di</strong> (35°-40° API) e anche gasolina. Questa<br />
<strong>di</strong>stribuzione è certamente legata alla generazione recente degli oli ed al meccanismo <strong>di</strong> migrazione. In<br />
alcuni casi, come quello del campo <strong>di</strong> Pisticci, i particolari valori <strong>di</strong> densità (10°-15° API) sono causati da<br />
biodegradazione. La presenza <strong>di</strong> zolfo, rinvenuta in alcuni casi, viene associata ad un ambiente<br />
deposizionale riducente.<br />
41
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
In particolare, le correlazioni tra i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> olio e la sorgente suggeriscono che la roccia madre<br />
principale nei giacimenti in produzione on-shore è costituita da carbonati tardo-cretacici depostisi in<br />
ambienti ristretti. I risultati delle manifestazioni superficiali e <strong>di</strong> pozzo in<strong>di</strong>cano che questa roccia madre ha<br />
un’ampia <strong>di</strong>ffusione regionale. I flui<strong>di</strong> derivanti da queste rocce sono <strong>di</strong> origine e qualità molto variabili e<br />
vanno dal bitume agli oli leggeri.<br />
3.10 Trappole<br />
Il settore meri<strong>di</strong>onale appenninico, entro cui ricade l’interesse per le indagini in oggetto, è stato coinvolto<br />
da un’intensa evoluzione tettonica che ha generato lo sviluppo <strong>di</strong> sovrascorrimenti, la riattivazione <strong>di</strong> vecchi<br />
lineamenti strutturali e la deformazione dei vari depositi che hanno risposto alle deformazioni in maniera<br />
<strong>di</strong>fferente. Le <strong>di</strong>fferenti unità stratigrafiche hanno risposto alla deformazione a seconda della loro posizione,<br />
delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, dei flui<strong>di</strong> circolanti, dello stress e delle sue variazioni.<br />
L’attività e l’evoluzione tettonica ha prodotto tutta una serie <strong>di</strong> strutture che possono agire da trappole<br />
strutturali per l’accumulo <strong>di</strong> idrocarburi.<br />
Nella zona on-shore della Catena Appenninica Meri<strong>di</strong>onale i principali accumuli <strong>di</strong> idrocarburi sono generati<br />
da trappole <strong>di</strong> tipo strutturale associate a sovrascorrimenti legati alla deformazione appenninica, oppure<br />
alla riattivazione <strong>di</strong> precedenti faglie normali pre-appenniniche (in aree più esterne rispetto alla<br />
deformazione principale). A questo tipo <strong>di</strong> trappole sono legate le principali scoperte nei campi <strong>di</strong> Pisticci e<br />
a <strong>di</strong> Grottole-Ferran<strong>di</strong>na, rispettivamente caratterizzati da idrocarburi liqui<strong>di</strong> e gassosi.<br />
Dati gli scarsi valori <strong>di</strong> porosità e permeabilità delle litologie carbonatiche, <strong>di</strong> solito compatte e ben<br />
<strong>di</strong>agenizzate, gli idrocarburi si presentano accumulati in giacimenti fratturati con una produzione legata ai<br />
principali sistemi <strong>di</strong> frattura. In questo tipo <strong>di</strong> successione le trappole possono essere <strong>di</strong>stinte<br />
rispettivamente in (Figura 3.18):<br />
anticlinali legate a faglie inverse al <strong>di</strong> sotto delle falde alloctone;<br />
alti strutturali al <strong>di</strong> sotto del fronte <strong>di</strong> sovrascorrimento dei depositi <strong>di</strong> Avanfossa;<br />
alti strutturali non interessati dai fronti <strong>di</strong> sovrascorrimento;<br />
faglie a “domino” non interessate dai sovrascorrimenti.<br />
Figura 3.18 - Schemi delle varie tipologie <strong>di</strong> trappole (e relativi campi) impostatesi nel substrato carbonatico pre-pliocenico e<br />
trappole in substrato plio-pleistocenico (fonte: Sella et al., 1988, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
42
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
3.11 Descrizione dell’attività in progetto<br />
3.11.1 Indagine geofisica: generalità<br />
L’indagine geofisica è la metodologia scientifica che, attraverso l’interpretazione <strong>di</strong> dati registrati in<br />
superficie relativi alle <strong>di</strong>fferenti proprietà fisiche delle rocce che costituiscono il nostro pianeta, consente <strong>di</strong><br />
ottenere un’immagine del sottosuolo.<br />
La registrazione dei dati geofisici viene effettuata tramite strumenti ad alta sensibilità capaci <strong>di</strong> cogliere le<br />
minime perturbazioni prodotte nel sottosuolo o da sorgenti <strong>di</strong> energia naturale, quali terremoti, campi<br />
elettromagnetici, magneto-tellurici, gravitazionali, etc. (geofisica passiva), o da sorgenti <strong>di</strong> energia artificiale<br />
(geofisica attiva). La sismica a riflessione rientra tra i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> geofisica attiva. Le varie metodologie<br />
geofisiche si basano su <strong>di</strong>versi parametri, osservabili in <strong>relazione</strong> alle <strong>di</strong>fferenti proprietà fisiche delle rocce,<br />
come: la velocità <strong>di</strong> propagazione delle onde sismiche, le variazioni temporali dei campi elettrici e<br />
magnetici, nonché le variazioni spaziali del campo gravimetrico e <strong>di</strong> quello magnetico. I dati registrati sul<br />
terreno vengono elaborati con appositi programmi <strong>di</strong> calcolo che ricostruiscono immagini del sottosuolo in<br />
2D e 3D.<br />
Tra i <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong> geofisici, l’indagine sismica a riflessione è quella capace <strong>di</strong> fornire un’immagine del<br />
sottosuolo maggiormente dettagliata ed atten<strong>di</strong>bile. Per questo motivo, dal momento della sua prima<br />
applicazione, nei primi decenni del ‘900, è stata ed è comunemente utilizzata per la ricerca <strong>di</strong> idrocarburi,<br />
rappresentando la chiave <strong>di</strong> volta della ricerca stessa. Infatti, gli altri meto<strong>di</strong> geofisici vengono utilizzati<br />
come complemento ed integrazione della sismica a riflessione, generalmente per tararla laddove esistano<br />
pochi o nessun sondaggio, poiché forniscono ulteriori in<strong>di</strong>cazioni su determinate rocce o corpi rocciosi<br />
caratterizzati da marcate proprietà fisiche. Le metodologie complementari utilizzate più frequentemente<br />
sono la gravimetria, la magnetometria e, data la crescente atten<strong>di</strong>bilità legata a programmi <strong>di</strong> elaborazione<br />
sempre più sofisticati e precisi, la magnetotellurica. Questi meto<strong>di</strong>, tutti appartenenti alla geofisica passiva,<br />
registrano rispettivamente le variazioni del campo gravitazionale della Terra ed i campi magnetici naturali<br />
che si propagano all’interno della stessa.<br />
Le prospezioni geofisiche sono una metodologia <strong>di</strong> indagine essenziale per le ricerche geologiche, ecocompatibile<br />
e molto <strong>di</strong>ffusa in tutto il mondo ed in ogni tipo <strong>di</strong> ambiente naturale. Le perturbazioni<br />
ambientali, caratteristiche <strong>di</strong> questi tipi <strong>di</strong> rilievo, sono molto limitate nello spazio e nel tempo,<br />
principalmente legate alla sorgente <strong>di</strong> energizzazione, e le operazioni <strong>di</strong> ripristino sono semplici. È possibile<br />
stimare il potenziale grado <strong>di</strong> perturbazioni ambientali dei vari meto<strong>di</strong> geofisici (Figura 3.19).<br />
Figura 3.19 - Impatto ambientale delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> indagine sismica: da sinistra a destra, irrilevante, basso, me<strong>di</strong>o-alto e<br />
alto (fonte: convegno nazionale Assomineraria, 2003)<br />
43
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
3.11.2 Propagazione dell’energia<br />
Il segnale sismico prodotto da una sorgente <strong>di</strong> energia è un’onda elastica che penetra in un mezzo non<br />
omogeneo attraverso <strong>di</strong>scontinuità litologiche che ne mo<strong>di</strong>ficano notevolmente la struttura e la velocità <strong>di</strong><br />
propagazione. La registrazione ed il successivo esame dell’onda <strong>di</strong> ritorno in superficie permettono <strong>di</strong><br />
compiere un’indagine in<strong>di</strong>retta sulla natura, la geometria e la profon<strong>di</strong>tà anche a grande <strong>di</strong>stanza dalla<br />
superficie (in funzione della strumentazione e della conformazione del sottosuolo) degli orizzonti<br />
attraversati.<br />
Entro certi limiti, i fenomeni sismici sono paragonabili ai fenomeni ottici e ad essi sono quin<strong>di</strong> applicabili le<br />
leggi dell’ottica geometrica riguardanti la riflessione e la rifrazione, cioè due <strong>di</strong>fferenti mo<strong>di</strong> secondo i quali<br />
l’onda mo<strong>di</strong>fica la sua traiettoria. Il metodo sismico è basato sui principi della propagazione, rifrazione e<br />
riflessione <strong>di</strong> onde elastiche e perciò si ritiene utile fare un breve richiamo della teoria <strong>di</strong> propagazione delle<br />
onde.<br />
3.11.3 Generazione dei segnali sismici<br />
3.11.3.1 Sismica a riflessione<br />
La crosta terrestre è costituita da strati rocciosi contrad<strong>di</strong>stinti da valori <strong>di</strong>versi delle proprietà fisiche<br />
(elasticità, rigi<strong>di</strong>tà, porosità), in <strong>relazione</strong> alla struttura interna ed alla composizione mineralogica e dei<br />
flui<strong>di</strong> che li permeano. Le proprietà che <strong>di</strong>pendono maggiormente da queste variazioni sono quelle<br />
elastiche (compressibilità e rigi<strong>di</strong>tà) le quali sono in <strong>relazione</strong> alla velocità <strong>di</strong> propagazione delle onde<br />
sismiche. Perciò, quando un gruppo <strong>di</strong> onde elastiche viene prodotto in prossimità della superficie terrestre<br />
con varie tipologie <strong>di</strong> sorgente <strong>di</strong> sistema, esso si propaga nel sottosuolo fino ad incontrare una superficie<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità, quale un piano <strong>di</strong> stratificazione oppure una frattura degli strati rocciosi. Il gruppo <strong>di</strong> onde,<br />
seguendo le leggi fisiche, subisce una ripartizione dell’energia: parte dell’onda incidente viene riflessa da<br />
questa <strong>di</strong>scontinuità, parte continua il suo percorso in profon<strong>di</strong>tà, fino ad incontrare <strong>di</strong>scontinuità sempre<br />
più profonde e subire lo stesso processo.<br />
Il metodo sismico a riflessione consiste nel captare in superficie, tramite appositi sensori noti con il nome <strong>di</strong><br />
geofoni, i gruppi <strong>di</strong> onde riflessi dalle varie superfici <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità, registrando il tempo necessario<br />
all’onda elastica indotta artificialmente per tornare alla superficie del suolo (Figura 3.20). L’elaborazione <strong>di</strong><br />
questi tempi <strong>di</strong> percorso consente <strong>di</strong> ricostruire un’immagine delle principali strutture del sottosuolo fino a<br />
profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> alcuni chilometri in funzione del tempo <strong>di</strong> registrazione.<br />
Figura 3.20 - Concetti <strong>di</strong> sismica a riflessione e percorso delle onde sismiche captate dai ricevitori (fonte: www.retegeofisica.it)<br />
44
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Per esplicitare brevemente il concetto, si consideri ipoteticamente un profilo lungo L tra la sorgente <strong>di</strong><br />
energia e l’ultimo geofono dello stesura: se energizzato, l’impulso coprirà soltanto una lunghezza pari a L/2<br />
su ciascun orizzonte riflettente parallelo alla superficie del suolo. Ciò significa che per ogni profilo sarà<br />
necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> almeno due sorgenti <strong>di</strong> energia per avere una copertura completa (100%) degli<br />
orizzonti riflettenti. Ogni elemento delle superfici sarà perciò “illuminato” una volta, ma sarà energizzato<br />
l’intero profilo <strong>di</strong> lunghezza L.<br />
Questo è uno dei vantaggi della “copertura multipla”. Le tracce appartenenti al singolo sismogramma<br />
acquisito in campagna avranno la sorgente in comune e quin<strong>di</strong> il rispettivo “file” che le raccoglierà tutte, è<br />
definito common shot gather. Invece, il common receiver gather sarà l’insieme <strong>di</strong> tutte le tracce che hanno<br />
in comune la posizione del geofono, cioè tracce acquisite sullo stesso geofono al variare della sorgente <strong>di</strong><br />
energia. Per conoscenza, il common offset gather è l’insieme delle tracce <strong>di</strong> uguale <strong>di</strong>stanza sorgentegeofono<br />
e infine il common midpoint gather (CMP) è l’insieme <strong>di</strong> tutte le tracce che hanno sorgente e<br />
geofono simmetrici rispetto ad un punto tra loro. Quest’ultimo è il più significativo <strong>di</strong> tutti poiché per i<br />
riflettori piano-paralleli alla superficie topografica, l’insieme <strong>di</strong> tutte queste tracce porta con sé la stessa<br />
informazione, in quanto provengono dall’elemento riflettente sito sulla verticale del punto <strong>di</strong> mezzo: tale<br />
fatto è definito come common depth-point gather (CDP). La qualità dei dati ottenuti, <strong>di</strong>pende non solo<br />
dall’elaborazione successiva, ma anche da una serie <strong>di</strong> parametri <strong>di</strong> acquisizione scelti ad hoc. A tal<br />
proposito, non si <strong>di</strong>mentichi il walkaway, una procedura assai importante nella fase <strong>di</strong> acquisizione: essa<br />
viene affidata a tecnici esperti che hanno il compito <strong>di</strong> saggiare le caratteristiche dei terreni e scegliere le<br />
migliori geometrie ed i migliori parametri <strong>di</strong> acquisizione, effettuando una preliminare acquisizione sismica.<br />
I parametri da definire si possono riassumere come segue:<br />
lunghezza della registrazione = tempo <strong>di</strong> ascolto del sismografo, sufficiente ad esaurire la ricezione<br />
<strong>di</strong> ogni informazione <strong>di</strong> interesse;<br />
passo <strong>di</strong> campionamento = tempo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> un singolo valore la cui sequenza costituisce la<br />
forma d’onda; non deve essere superiore alla metà del periodo della più alta frequenza contenuta<br />
nel segnale;<br />
<strong>di</strong>stanza fra sorgente e geofono più lontano = determina la profon<strong>di</strong>tà esplorata per la quale è<br />
ancora possibile una buona analisi delle velocità;<br />
<strong>di</strong>stanza fra sorgente e geofono più vicino = non deve essere troppo grande in modo da consentire<br />
una buona valutazione degli spessori e delle velocità del primo strato aerato;<br />
<strong>di</strong>stanza tra i geofoni = <strong>di</strong>pende dai parametri precedenti e dal numero <strong>di</strong> canali <strong>di</strong>sponibili sul<br />
sismografo; quanto più breve è, tanto maggiore è la risoluzione superficiale; la simultaneità <strong>di</strong> una<br />
buona risoluzione superficiale e <strong>di</strong> una buona penetrazione in profon<strong>di</strong>tà è proporzionale al<br />
numero <strong>di</strong> canali <strong>di</strong>sponibile;<br />
filtri analogici = la miglior scelta dei filtri consente l’eliminazione dei rumori e il miglior<br />
sfruttamento della <strong>di</strong>namica del sismografo. In particolare questo vale per la scelta del filtro passa<br />
alto.<br />
La fase successiva <strong>di</strong> elaborazione dei dati acquisiti coinvolge aspetti come procedure matematiche, analisi<br />
delle velocità e varie correzioni, sviluppati con l’ausilio <strong>di</strong> software de<strong>di</strong>cati <strong>di</strong> alto livello. Non verranno<br />
invece specificate le singole operazioni <strong>di</strong> trattamento dei dati in tale sede.<br />
Al termine delle varie fasi, si otterrà un dato “pulito” da ogni rumore <strong>di</strong> fondo o eventuali caratteristiche del<br />
terreno che <strong>di</strong>sturbano il segnale in fase <strong>di</strong> acquisizione (Figura 3.22).<br />
45
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.21 - Esempio <strong>di</strong> stesura e linea <strong>di</strong> acquisizione sismica<br />
Figura 3.22 - Dispositivo <strong>di</strong> acquisizione sismica e riflettore sismico nel sottosuolo (in alto). Tipica linea sismica (in basso).<br />
3.11.3.2 Tipi <strong>di</strong> sorgente <strong>di</strong> onde elastiche<br />
La scelta della sorgente <strong>di</strong> energia è legata a <strong>di</strong>versi fattori tra i quali, profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> investigazione<br />
(profon<strong>di</strong>tà che si vuole raggiungere), caratteristiche geomorfologiche, risoluzione sismica che si vuole<br />
ottenere, modello geologico e litologie esistenti, compatibilità ambientali.<br />
46
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La sorgente <strong>di</strong> energia può essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi:<br />
Massa battente: è una sorgente <strong>di</strong> energia sismica non esplosiva che viene utilizzata<br />
nell’esplorazione <strong>di</strong> idrocarburi. Essa si basa sull’impulso inviato nel terreno dalla caduta libera <strong>di</strong><br />
una massa <strong>di</strong> acciaio pesante tra i 50 e 300 kg, da un’altezza <strong>di</strong> circa 1 m su una piastra isolata<br />
acusticamente. Tale massa è installata su un apposito veicolo, come carrelli trainati da mezzi<br />
agricoli o pick-up (Figura 3.23) e tramite un sistema <strong>di</strong> binari, viene sollevata dal terreno subito<br />
dopo l’impatto, così da poter essere nuovamente rilasciata entro poco tempo.<br />
Figura 3.23 - Carrello trainato da trattore con massa battente<br />
Vibroseis (Figura 3.24): l’energizzazione del rilievo sismico avviene facendo propagare nel terreno<br />
attraverso una piastra vibrante appoggiata al suolo, un impulso <strong>di</strong> breve durata <strong>di</strong> tipo ondulatorio<br />
avente un ampiezza <strong>di</strong> frequenze note (8-100 Hz). La piastra (Figura 3.25), posta al centro del<br />
Vibroseis, è messa in contatto con il terreno, l’impulso ondulatorio <strong>di</strong> frequenze è provocato da un<br />
sistema <strong>di</strong> valvole idrauliche che converte un impulso elettrico <strong>di</strong> riferimento in un flusso <strong>di</strong> olio<br />
idraulico che attiva il pistone. Per aumentare l’energia <strong>di</strong> immissione, possono essere utilizzati<br />
simultaneamente più Vibroseis. Questo strumento è stato usato per ambienti particolarmente<br />
sensibili. La <strong>di</strong>stanza tra due punti <strong>di</strong> energizzazione è scelta in funzione delle necessità <strong>di</strong><br />
acquisizione sia tecniche che logistiche. Questa tipologia <strong>di</strong> sorgente sarà quella utilizzata per<br />
l’attività proposta.<br />
47
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.24 - Esempio <strong>di</strong> Vibroseis<br />
Figura 3.25 - Particolare della piastra del Vibroseis<br />
Esplosivo: è una sorgente <strong>di</strong> energia convenzionale con il quale l’energizzazione del rilievo sismico<br />
avviene attraverso la detonazione <strong>di</strong> cariche esplosive poste all’interno <strong>di</strong> pozzetti detti “scoppio”<br />
(SP). Le singole cariche sono preconfezionate in tubi rigi<strong>di</strong> <strong>di</strong> plastica antistatica <strong>di</strong> vario peso, la<br />
quantità <strong>di</strong> carica per ogni singolo scoppio è scelta in funzione della risposta sismica della<br />
penetrazione desiderata, della profon<strong>di</strong>tà del pozzetto e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> superficie. La<br />
profon<strong>di</strong>tà dei pozzetti <strong>di</strong> scoppio varia tra 10 e 30 m. La <strong>di</strong>stanza tra i punti <strong>di</strong> energizzazione è<br />
variabile, a seconda delle caratteristiche ambientali e geologiche dell’area, nonché relativamente<br />
alla possibile vicinanza <strong>di</strong> abitazioni e/o centri abitati. Il posizionamento delle cariche nel sottosuolo<br />
viene inoltre determinato tenendo conto <strong>di</strong> possibili influenze sugli acquiferi, mitigando così ogni<br />
possibile influenza negativa sull’ambiente.<br />
48
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
3.11.4 Progettazione <strong>di</strong> una campagna <strong>di</strong> acquisizione geofisica<br />
Sono <strong>di</strong> seguito schematicamente riassunte le fasi necessarie per un’adeguata progettazione ed esecuzione<br />
<strong>di</strong> un rilievo sismico:<br />
creazione <strong>di</strong> un database dei potenziali proprietari;<br />
contatti con le autorità locali e richiesta autorizzazioni amministrative;<br />
primi contatti con i proprietari;<br />
prime valutazioni dei topografi;<br />
ulteriore contatto con i proprietari;<br />
rilievo topografico;<br />
stesura cavi e posizionamento geofoni;<br />
energizzazione;<br />
registrazione lungo il tracciato sismico;<br />
ispezione delle aree interessate dalla attività per il recupero del materiale;<br />
stima eventuali danni, rimozione materiale e ripristino del territorio.<br />
In funzione dell’obiettivo, con la definizione delle caratteristiche tecniche del rilievo ed in base a queste,<br />
viene pianificata l’ubicazione preliminare dei punti <strong>di</strong> energizzazione e <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> registrazione. Entrambi<br />
sono solitamente posti lungo profili rettilinei (linee sismiche) <strong>di</strong> lunghezza variabile da pochi km a <strong>di</strong>verse<br />
decine <strong>di</strong> km. L’ubicazione effettiva dei profili è poi realizzata successivamente a sopralluoghi in loco,<br />
tenendo presenti le varie caratteristiche ambientali (tipi e quantità <strong>di</strong> essenze vegetali, manufatti, siti<br />
archeologici etc.) e della morfologia territoriale. Le onde sismiche emesse vengono registrate da ricevitori<br />
ad alta frequenza (geofoni), <strong>di</strong>stribuiti anche questi in profili.<br />
3.11.4.1 Azioni <strong>di</strong> cantiere<br />
Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego<br />
organizzativo. In me<strong>di</strong>a una squadra sismica è composta da circa 30-50 persone con la presenza <strong>di</strong><br />
manodopera locale. La squadra può essere considerata come un piccolo cantiere itinerante, composto da<br />
<strong>di</strong>versi gruppi <strong>di</strong> lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati programmati ripetendo una sequenza<br />
<strong>di</strong> operazioni prefissata.<br />
Essi hanno il compito <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare, controllare e garantire il buon esito delle operazioni la cui sequenza è<br />
così schematizzata:<br />
creazione <strong>di</strong> un database dei potenziali proprietari: attraverso l’acquisizione delle mappe catastali<br />
sarà possibile creare un file nel quale saranno inseriti tutti i proprietari i cui terreni ricadono<br />
all’interno del permesso <strong>di</strong> ricerca. Successivamente questi dati verranno controllati <strong>di</strong>rettamente<br />
dai Permit Men che si recheranno <strong>di</strong>rettamente sul terreno; questa ulteriore verifica viene fatta per<br />
essere certi che siano contattate tutte le persone coinvolte dall’attività. Una volta raccolti tutti i<br />
dati verrà assegnato un co<strong>di</strong>ce ad ogni proprietario per una più facile e veloce gestione del<br />
database;<br />
contatti con le autorità: al fine <strong>di</strong> informare circa il progetto e le attività che verranno svolte, si<br />
organizzeranno degli incontri con i sindaci ed i tecnici dei comuni interessati dall’attività durante i<br />
quali verranno spiegate le fasi operative ed i meto<strong>di</strong> d’indagine. Verranno inoltre richiesti i nulla<br />
osta per il transito dei mezzi lungo le strade comunali e/o provinciali. Durante questa fase verranno<br />
contattati anche gli enti gestori dei sottoservizi presenti nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, per richiedere tutte le<br />
planimetrie ed organizzare incontri con i loro tecnici per meglio comprendere le esigenze del<br />
territorio;<br />
primi contatti con i proprietari: i tecnici (Permit Men) contatteranno i proprietari dei terreni che<br />
ricadono all’interno del permesso <strong>di</strong> ricerca, rilasciando loro degli opuscoli che illustrano il<br />
progetto. Verranno anche organizzati incontri <strong>di</strong> gruppo per eliminare tutte le perplessità dei<br />
citta<strong>di</strong>ni e per capire quali sono le esigenze del territorio;<br />
49
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
prime valutazioni dei topografi: le squadre <strong>di</strong> topografi insieme ai Permit Men iniziano le<br />
valutazioni preliminari sul terreno, con l’utilizzo <strong>di</strong> mappe, per in<strong>di</strong>viduare la posizione delle linee <strong>di</strong><br />
geofoni e i punti <strong>di</strong> energizzazione e re<strong>di</strong>gere in questo modo una prima mappa;<br />
ulteriore contatto con i proprietari: i proprietari vengono informati circa il posizionamento delle<br />
linee <strong>di</strong> geofoni e dei punti <strong>di</strong> energizzazione, in questa fase vengono anche raccolti ulteriori<br />
suggerimenti dei proprietari in modo da creare il minimo <strong>di</strong>sagio possibile;<br />
rilievo topografico: si effettuerà una campagna <strong>di</strong> rilievo con strumenti GPS per l’esatta<br />
determinazione dei punti <strong>di</strong> energizzazione e ricezione. L’accesso alla linea ed ai punti <strong>di</strong><br />
energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri) e non sono previsti<br />
lavori <strong>di</strong> movimento <strong>di</strong> terra per l’apertura <strong>di</strong> piste per l’accesso <strong>di</strong> personale e mezzi. Verranno<br />
posizionati sul terreno due <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> picchetti <strong>di</strong> legno che andranno ad identificare i punti in<br />
cui verranno posizionati i geofoni e i punti <strong>di</strong> energizzazione (Figura 3.26);<br />
Figura 3.26 – Esempio <strong>di</strong> picchetti posizionati durante il rilievo topografico, quello <strong>di</strong> sinistra in<strong>di</strong>ca il posizionamento <strong>di</strong> un<br />
geofono, quello <strong>di</strong> destra in<strong>di</strong>ca un punto <strong>di</strong> energizzazione.<br />
stesura cavi: la stesura dei cavi segue il tracciato in<strong>di</strong>cato dalla squadra sismica me<strong>di</strong>ante gli<br />
appositi picchetti sopra menzionati. Lo stesura dei cavi viene effettuato manualmente dai tecnici<br />
della squadra sismica, avendo cura <strong>di</strong> non danneggiare il manto erboso o eventuali colture (Figura<br />
3.27 e Figura 3.28);<br />
posizionamento geofoni: sul terreno vengono <strong>di</strong>sposti manualmente i geofoni per la ricezione del<br />
segnale sismico (Figura 3.27). I geofoni, posti ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa 30 metri l’uno dall’altro, sono<br />
collegati tra loro tramite cavi e all’unità centrale (rappresentata da un calcolatore installato dentro<br />
un ulteriore automezzo <strong>di</strong> registrazione) tramite segnali ra<strong>di</strong>o. Il cavo che collega i geofoni al<br />
trasmettitore ha un <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> circa 1 cm. Il posizionamento dei ricevitori viene eseguito<br />
manualmente dagli operatori;<br />
50
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.27 - Esempio <strong>di</strong> come vengono stesi manualmente i cavi e posizionati i geofoni, a destra in alto un ingran<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un<br />
geofono.<br />
Figura 3.28 - Posizionamento dei cavi senza danneggiare la vegetazione<br />
energizzazione: Le operazioni <strong>di</strong> acquisizione sismica avvengono con l’utilizzo <strong>di</strong> due o tre mezzi<br />
(“mezzi sorgente energia”) che si muovono alternativamente con un mezzo (“mezzo registrazione<br />
dati”) localizzato esternamente all’area d’indagine Viene appoggiata al terreno una piastra che<br />
trasmette un impulso <strong>di</strong> breve durata utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12 e 100 Hz.<br />
In <strong>relazione</strong> alla necessità <strong>di</strong> posizionare gli autoveicoli tra loro vicini e <strong>di</strong> pervenire ad un sicuro<br />
collegamento e sincronizzazione delle apparecchiature, per ogni singolo punto <strong>di</strong> stazionamento è<br />
previsto un tempo operativo nell’or<strong>di</strong>ne dei minuti (Figura 3.29). Si sottolinea che a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
quanto avviene per la stesura dei geofoni, le linee <strong>di</strong> energizzazione non necessitano <strong>di</strong> un<br />
posizionamento rigido ma può essere effettuato anche con un consistente spostamento laterale,<br />
destro o sinistro rispetto alla <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> avanzamento. Tale vantaggio consente <strong>di</strong> servirsi<br />
pienamente della viabilità esistente, consentendo <strong>di</strong> mantenere le adeguate <strong>di</strong>stanze dalle<br />
infrastrutture e dagli immobili presenti (Figura 3.30);<br />
51
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 3.29 - Esempio <strong>di</strong> energizzazione lungo strada principale (Vibroseis)<br />
Figura 3.30 - Picchetti che in<strong>di</strong>cano i punti <strong>di</strong> energizzazione lungo una strada secondaria<br />
registrazione: le onde elastiche prodotte dall’energizzazione del terreno sono captate dai geofoni,<br />
trasformate in impulso, registrate nella memoria del calcolatore installato su automezzo oltre ad<br />
52
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
essere imme<strong>di</strong>atamente visualizzate su carta ed in video (Figura 3.31). Le attività <strong>di</strong> registrazione,<br />
essendo la parte più delicata <strong>di</strong> tutto il processo, vengono gestite da tecnici specializzati che<br />
coor<strong>di</strong>nano l’attività e gli spostamenti <strong>di</strong> tutta la squadra sismica. Generalmente 2 o 3 tecnici sono<br />
a<strong>di</strong>biti a questa fase;<br />
Figura 3.31 - Postazione ricezione ed elaborazione dati<br />
rimozione materiale: alla fine <strong>di</strong> ciascuna fase <strong>di</strong> lavoro tutto il materiale (cavi, raccor<strong>di</strong>, sensori,<br />
segnali <strong>di</strong> riferimento, etc.) viene recuperato per essere utilizzato nelle tratte successive;<br />
stima degli eventuali danni: al temine delle singole fasi, tecnici specializzati provvederanno alla<br />
stima degli eventuali danni arrecati dall’attività e provvederanno ad un loro risarcimento,<br />
provvedendo al ripristino delle essenze arboree e arbustive eventualmente danneggiate durante i<br />
lavori come previsto dell’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo<br />
2011, recante “Disciplinare tipo per i permessi <strong>di</strong> prospezione e <strong>di</strong> ricerca e per le concessioni <strong>di</strong><br />
coltivazione <strong>di</strong> idrocarburi liqui<strong>di</strong> e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma<br />
continentale”, il quale stabilisce che: “I titolari <strong>di</strong> permessi o <strong>di</strong> concessioni debbono risarcire ogni<br />
danno derivante dall’esercizio delle loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti<br />
cauzionali a favore <strong>di</strong> proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei<br />
permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del R.D. n. 1443/1927”.<br />
3.11.4.2 Tempi <strong>di</strong> esecuzione<br />
I tempi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> un rilievo sismico <strong>di</strong>pendono sostanzialmente da tre fattori principali:<br />
tipo <strong>di</strong> sorgente d’energia utilizzata;<br />
numero e chilometraggio delle linee sismiche da registrare;<br />
morfologia del territorio ove sarà eseguito il rilievo sismico.<br />
Al momento, non sono ancora state definite con precisione le aree che verranno interessate dalle attività <strong>di</strong><br />
prospezione sismica in quanto la valutazione della localizzazione dei percorsi è subor<strong>di</strong>nata all’ottenimento,<br />
da parte della società Delta Energy Ltd, del decreto che accor<strong>di</strong> la titolarità del permesso <strong>di</strong> ricerca<br />
idrocarburi emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non è quin<strong>di</strong> possibile, a questo stato dei<br />
lavori, sapere con precisione la durata della campagna <strong>di</strong> acquisizione sismica.<br />
53
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE<br />
Il presente capitolo si prefigge lo scopo <strong>di</strong> fornire un quadro completo sulle componenti ambientali e le<br />
eventuali interferenze che potrebbero insorgere dallo svolgimento delle attività <strong>di</strong> esplorazione sopra<br />
descritte. A tal proposito si punterà l’attenzione sulle esigenze <strong>di</strong> tutela ambientale che vincolano l’area <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o, sull’in<strong>di</strong>viduazione delle potenzialità paesaggistiche ed ecologiche dell’intero territorio.<br />
4.1 Ubicazione geografica<br />
La Basilicata, comunemente denominata Lucania, è ubicata nel settore meri<strong>di</strong>onale dell’Italia. Essa confina<br />
con le regioni: Puglia a nord e ad est, Campania ad ovest, Calabria a sud, mentre è bagnata a sud-ovest dal<br />
Mar Tirreno e a sud-est dal Mar Ionio. Dal punto <strong>di</strong> vista amministrativo, la Basilicata comprende le province<br />
<strong>di</strong> Potenza e Matera. L’area in istanza ricade interamente nel territorio della <strong>Regione</strong> Basilicata, più<br />
precisamente, nel settore centro-orientale della provincia <strong>di</strong> Matera (Figura 4.1).<br />
Figura 4.1 – Localizzazione e confini della <strong>Regione</strong> Basilicata; le due province <strong>di</strong> cui la regione si compone<br />
L’area oggetto <strong>di</strong> istanza comprende al suo interno il territorio dei comuni <strong>di</strong> Montescaglioso, Pomarico,<br />
Pisticci, Bernalda e, per una piccola parte, Montalbano Jonico (Figura 4.2).<br />
54
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.2 - Delimitazione dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca “La Capriola” con in<strong>di</strong>cazione dei limiti comunali<br />
Per quanto riguarda l’assetto orografico del territorio lucano, esso risulta assai eterogeneo specie tra le due<br />
province che lo compongono: mentre la provincia <strong>di</strong> Potenza ha il 69% <strong>di</strong> territorio montuoso e il 31%<br />
collinare, la provincia <strong>di</strong> Matera presenta valori profondamente <strong>di</strong>fferenti con il 5% <strong>di</strong> territorio montuoso, il<br />
72% collinare e il 23% pianeggiante.<br />
In linea generale, comunque, l’intera regione che si estende per un totale <strong>di</strong> 999.461 ha è in leggera<br />
prevalenza montuosa con quasi il 47%; il 45% è a copertura collinare e solo l’8% del territorio risulta<br />
pianeggiante (Figura 4.3).<br />
Figura 4.3 – Sud<strong>di</strong>visione del territorio lucano in base all’orografia della <strong>Regione</strong><br />
In particolare, il territorio relativo all’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, appare solo parzialmente montuoso, vista la vicinanza<br />
dell’a<strong>di</strong>acente Catena Appenninica, con la presenza <strong>di</strong> modesti rilievi soprattutto nella parte nordoccidentale<br />
del blocco. In prevalenza, tuttavia, sull’area insistono rilievi <strong>di</strong> natura collinare in <strong>relazione</strong> alle<br />
propaggini più esterne della catena che sono caratterizzate da un paesaggio meno aspro dovuro ad una<br />
dolce <strong>di</strong>minuzione delle pendenze avvicinandosi verso la linea <strong>di</strong> costa ionica.<br />
55
4.2 Atmosfera<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Le sostanze emesse in atmosfera da attività antropiche e naturali sono le cause dei principali problemi<br />
ambientali. Tra essi i più <strong>di</strong>ffusi risultano essere:<br />
• l’aci<strong>di</strong>ficazione;<br />
• lo smog fotochimico;<br />
• la degradazione della qualità dell’aria nelle aree urbane e in quelle industriali;<br />
• il cambiamento climatico;<br />
• il riscaldamento del globo;<br />
• i danni al patrimonio storico ed artistico;<br />
• i danni agli e<strong>di</strong>fici;<br />
• la riduzione dell’ozono stratosferico.<br />
La valutazione della con<strong>di</strong>zione ambientale dell’atmosfera non può prescindere dall’analisi dello stato e<br />
delle pressioni esercitate su <strong>di</strong> essa dal sistema regionale <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni e servizi.<br />
A tal fine il Piano Regionale <strong>di</strong> Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA), redatto dalla <strong>Regione</strong><br />
Basilicata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 126 del 20.05.1991, si configurava come un primo importante<br />
strumento conoscitivo in materia ambientale in ambito regionale. Ad oggi il D.M. dell'Ambiente del 20<br />
maggio 1991 è stato sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2008/50/CE<br />
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”.<br />
4.2.1 Qualità dell’aria<br />
L’inquinamento atmosferico è definito come l’insieme <strong>di</strong> quelle mo<strong>di</strong>ficazioni della normale composizione<br />
dell’aria, dovuto alla presenza <strong>di</strong> sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali<br />
con<strong>di</strong>zioni ambientali. Esso risulta in gran parte essere il risultato delle attività antropiche tra cui sono<br />
annoverate le emissioni da traffico auto veicolare, da riscaldamento domestico, da sorgenti industriali, etc.<br />
La caratterizzazione <strong>di</strong> tali emissioni viene tra<strong>di</strong>zionalmente effettuata me<strong>di</strong>ante analisi fisicochimiche e,<br />
sempre più frequentemente, anche me<strong>di</strong>ante analisi biologiche (biomonitoraggio) e monitoraggio in<br />
automatico o con meto<strong>di</strong> manuali.<br />
La valutazione della qualità dell’aria nelle aree urbane, come in precedenza visto, era regolata dal D.M.<br />
dell’Ambiente del 20 maggio 1991, recante “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria” che<br />
prevedeva la realizzazione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> monitoraggio costituite dalle seguenti tipologie <strong>di</strong> stazioni:<br />
stazione <strong>di</strong> riferimento (classe A), da localizzare in zone non <strong>di</strong>rettamente interessate dalle sorgenti<br />
<strong>di</strong> emissione (parchi urbani o isole pedonali);<br />
stazione da ubicare in aree ad elevata densità abitativa (classe B);<br />
stazione da localizzare in zone ad elevata densità <strong>di</strong> traffico (classe C);<br />
stazione da localizzare in periferia o in aree suburbane finalizzate alla misura degli inquinanti<br />
fotochimici (classe D).<br />
In base alle <strong>di</strong>sposizioni del D.M. dell'Ambiente del 20 maggio 1991 la <strong>Regione</strong> Basilicata ha realizzato una<br />
rete <strong>di</strong> rilevamento della qualità dell’aria in grado <strong>di</strong> effettuare un monitoraggio completo sulla maggior<br />
parte del territorio regionale. La <strong>Regione</strong> ha assunto il compito <strong>di</strong> garantire il funzionamento del sistema <strong>di</strong><br />
rilevamento, l’atten<strong>di</strong>bilità delle misure, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento; per quanto<br />
concerne la <strong>di</strong>ffusione dei dati ha, inoltre, realizzato presso il Dipartimento Ambiente e Territorio un Centro<br />
<strong>di</strong> acquisizione ed elaborazione dati per l’espletamento delle funzioni stabilite dalla legge.<br />
56
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Oggi il D.M. dell'Ambiente del 20 maggio 1991 è stato sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155<br />
“Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in<br />
Europa”.<br />
Da una analisi dell’inventario regionale delle emissioni, risulta che la <strong>Regione</strong> Basilicata, data anche la<br />
struttura del suo sistema produttivo, non presenta eccessive criticità per ciò che riguarda le emissioni <strong>di</strong><br />
inquinanti in atmosfera. Si ricorda inoltre che il tipo <strong>di</strong> attività proposto ha carattere temporaneo e<br />
reversibile.<br />
In definitiva, nel tentativo <strong>di</strong> contestualizzare l’entità del potenziale pericolo <strong>di</strong> inquinamento atmosferico<br />
sul territorio regionale, sono stati in<strong>di</strong>viduati alcuni centri o aree le cui attività potrebbero contribuire a<br />
deteriorare la qualità dell’aria. Tra essi si collocano i due capoluoghi <strong>di</strong> Provincia, Potenza e Matera, a causa<br />
soprattutto delle emissioni dovute al traffico veicolare e agli usi energetici per riscaldamento domestico;<br />
mentre le altre aree che risultano sottoposte a controllo sono le zone industriali <strong>di</strong> Tito, Ferran<strong>di</strong>na, Pisticci<br />
e Melfi, nonché le zone della Val d’Agri soggette alle estrazioni <strong>di</strong> idrocarburi.<br />
4.2.2 Clima<br />
La particolare conformazione della Basilicata che la espone a due <strong>di</strong>fferenti mari, il Tirreno ad ovest e lo<br />
Ionio ad est, risulta <strong>di</strong> fondamentale importanza nel determinarne le generali con<strong>di</strong>zioni climatiche e<br />
nell’influenzare anche i <strong>di</strong>versi settori che dall’entroterra si spingono fino alle zone costiere. Il clima della<br />
Basilicata, infatti, varia <strong>di</strong> zona in zona: seppur nel settore orientale la regione possa risentire anche<br />
dell’influsso del Mar Adriatico, non offrendo protezione per la mancanza <strong>di</strong> rilievi come quelli appenninici<br />
presenti sul versante opposto, addentrandosi verso l’interno la mitezza viene subito meno dando spazio ad<br />
un clima decisamente più rigido tipicamente continentale dove l’inverno è più freddo e ricco <strong>di</strong><br />
precipitazioni.<br />
In generale, comunque, il clima della regione è <strong>di</strong> tipo me<strong>di</strong>terraneo caratterizzato da inverni piovosi e calde<br />
estati siccitose. Sull’intero territorio lucano si registrano eventi piovosi durante tutto l’anno, ma comunque<br />
maggiormente concentrate nel semestre autunno-inverno. La <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>stanza dal mare influenza, come<br />
detto, il grado <strong>di</strong> continentalità climatica <strong>di</strong> alcune zone, accentuando le escursioni termiche e le <strong>di</strong>fferenze<br />
tra le precipitazioni del periodo autunno-inverno e quelle del periodo primavera-estate.<br />
Le temperature seguono un andamento grossomodo simile su tutto il territorio regionale. In funzione dei<br />
caratteri orografici del territorio, il clima tipico dell’area indagata è temperato semiarido caratterizzato da<br />
estati secche ed escursioni stagionali <strong>di</strong> circa 16°C.<br />
La piovosità me<strong>di</strong>a si attesta sui 600 mm, con un bilancio idrico fortemente deficitario nei mesi estivi a<br />
fronte <strong>di</strong> una piovosità annua compresa tra 550 e 700 mm, concentrata in autunno (circa il 31%) ed in<br />
inverno (circa il 34%), con un’incidenza minima in estate (13%). Il più alto tasso <strong>di</strong> piovosità mensile si<br />
registra in novembre e <strong>di</strong>cembre, quello minore in agosto. L’intensità e la frequenza delle precipitazioni<br />
risultano decrescenti da nord a sud. Le temperature me<strong>di</strong>e mensili sono comprese fra 3° e 28°C, con punte<br />
massime in agosto (40-46°C) e minime in febbraio (anche inferiori a 10°C).<br />
I venti predominati sono lo Scirocco (<strong>di</strong>rezione SE), il Maestrale (NO) e la Tramontana (N); durante l’inverno<br />
lo Scirocco viene sostituito dal Ponente (O).<br />
Nel dettaglio, la regione, presenta quattro gran<strong>di</strong> aree climatiche che possono essere sud<strong>di</strong>vise in questo<br />
modo:<br />
Pianura jonica del Metapontino, dove a inverni miti e piovosi si alternano estati calde e secche, ma<br />
abbastanza ventilate;<br />
Costa tirrenica, in cui si riscontrano le stesse affinità climatiche dell'area jonica, con la sola<br />
eccezione che la temperatura è leggermente più elevata in inverno e più fresca in estate e l'umi<strong>di</strong>tà<br />
è molto accentuata;<br />
57
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Collina materana, dove i tipici caratteri me<strong>di</strong>terranei si attenuano notevolmente addentrandosi<br />
verso l'interno: già a partire dai 300-400 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne gli inverni <strong>di</strong>vengono fred<strong>di</strong> e nebbiosi,<br />
la neve può fare la sua comparsa <strong>di</strong>verse volte all'anno da novembre a marzo inoltrato. Anche qui le<br />
estati sono calde e secche, con escursioni termiche giornaliere abbastanza elevate;<br />
Montagna appenninica, caratterizzata da inverni molto fred<strong>di</strong>, soprattutto oltre i 1000 metri <strong>di</strong><br />
quota, dove la neve al suolo rimane fino a primavera inoltrata, e talvolta fino alla fine <strong>di</strong> maggio sui<br />
rilievi maggiori. Nel capoluogo della regione, Potenza, posto a 819 metri s.l.m., l'inverno può essere<br />
molto nevoso, le temperature possono scendere anche <strong>di</strong> molti gra<strong>di</strong> sotto lo zero (il record<br />
citta<strong>di</strong>no è <strong>di</strong> -15 °C), risultando tra le città più fredde d'Italia. Le estati sono moderatamente calde,<br />
anche se le temperature notturne possono essere molto fresche.<br />
Per quanto riguarda la classificazione fitoclimatica in merito alla <strong>Regione</strong> Basilicata è possibile riconoscere<br />
una varietà <strong>di</strong> classi <strong>di</strong>ssimili e <strong>di</strong>pendenti in linea <strong>di</strong> massima dalla variazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi fattori come:<br />
latitu<strong>di</strong>ne, longitu<strong>di</strong>ne, altitu<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong>stanza dalla linea <strong>di</strong> costa... Per quanto concerne in particolare il blocco<br />
oggetto del presente stu<strong>di</strong>o esso ricade in due classi fitoclimatiche principali (Figura 4.4):<br />
Clima mesome<strong>di</strong>terraneo-termotemperato umido-subumido – (giallo) – presente maggiormente nel<br />
settore centro orientale del blocco; esso è caratterizzato in prevalenza da clima me<strong>di</strong>terraneo<br />
oceanico-semicontinentale del me<strong>di</strong>o e Basso Adriatico, dello Ionio e delle isole maggiori al<br />
contatto delle zone montuose.<br />
Clima Mesotemperato-mesome<strong>di</strong>terraneo umido-subumido – (verde) – che caratterizza il settore<br />
centro occidentale del blocco; nella fattispecie si tratta <strong>di</strong> clima temperato oceanico-continentale <strong>di</strong><br />
transizione delle aree costiere del me<strong>di</strong>o Adriatico, delle pianure interne <strong>di</strong> tutto il pre-appennino e<br />
della Sicilia.<br />
58
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.4 – Carta delle classi fitoclimatiche delle <strong>Regione</strong> Basilicata; in rosso il perimetro del blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “La Capriola”<br />
(fonte: http://cart.ancitel.it)<br />
59
4.3 Suolo e sottosuolo<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
4.3.1 Inquadramento geologico<br />
L’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca ricade nell’avanfossa Bradanica, a ridosso della catena appenninica<br />
meri<strong>di</strong>onale. Questo bacino rappresenta il depocentro della se<strong>di</strong>mentazione proveniente dalla messa in<br />
posto della Catena Appenninica. L’intera zona ricade all’interno <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi domini geologici-strutturali quali la<br />
Catena Appenninica meri<strong>di</strong>onale, un complesso sistema deformativo costituito da faglie e sovrascorrimenti<br />
prodotto dall’interazione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti appartenenti sia a domini <strong>di</strong> placca continentale europea sia a quelli<br />
africani.<br />
Gli Appennini meri<strong>di</strong>onali fanno parte dell’orogenesi del Me<strong>di</strong>terraneo centrale e sono costituiti da una pila<br />
<strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti e unità tettoniche derivanti dalla deformazione dei <strong>di</strong>versi domini Mesozoici e Cenozoici. La<br />
catena montuosa rappresenta il risultato <strong>di</strong> una complessa collisione continentale durante il Neogene-<br />
Quaternario tra la Placca Africana (più precisamente il Promontorio Apulo o Placca Adria) e la Placca<br />
Europea (Blocco Sardo-Corso).<br />
L’area me<strong>di</strong>terranea durante il Mesozoico era sotto l’effetto <strong>di</strong> una fase <strong>di</strong>stensiva che aveva portato<br />
l’apertura <strong>di</strong> un oceano (Tetide) con la creazione <strong>di</strong> margini passivi e lo sviluppo <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> piattaforme<br />
carbonatiche. Il tardo Mesozoico invece, vede lo sviluppo <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> subduzione (da est verso ovest) con<br />
un’inversione nel regime estensionale. Questo cambio nella <strong>di</strong>namica delle placche portò alla progressiva<br />
chiusura dell’oceano appena formato.<br />
Il moto delle placche (Figura 4.5) viene per lo più governato dalla <strong>di</strong>stribuzione delle zone <strong>di</strong> subduzione<br />
dove la composizione della crosta gioca un ruolo importante. La composizione oceanica o continentale della<br />
litosfera, la densità, lo spessore dei se<strong>di</strong>menti ere<strong>di</strong>tati durante la fase estensionale mesozoica, la<br />
<strong>di</strong>stribuzione sono stati fattori determinanti per l’evoluzione delle successive zone <strong>di</strong> subduzione.<br />
Figura 4.5 - Moto relativo attuale delle placche (fonte: Finetti 2005)<br />
Lo spostamento relativo tra la Placca Africana e quella Europea non è ancora del tutto chiaro ma le<br />
ricostruzioni mostrano un movimento nord-ovest e nord-est. Recenti stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> geodesia confermano una<br />
convergenza <strong>di</strong>ffusa nella quale l’Africa e Europa si avvicinano <strong>di</strong> 5 mm l’anno mostrando anche uno<br />
spostamento comune verso nord-est.<br />
Le più importanti aree soggette a subduzione durante il Cenozoico nell’area me<strong>di</strong>terranea si trovano nella<br />
zona Alpina-Balearica nel settore nord occidentale, la fascia Appenninica-Magrebide nella zona centrale e la<br />
zona Dinarica nel me<strong>di</strong>terraneo nord orientale (Figura 4.6).<br />
60
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.6 - Schema geo<strong>di</strong>namico dell’area Me<strong>di</strong>terranea (fonte: Carminati & Doglioni, 2004)<br />
La catena Appenninica rappresenta il risultato della migrazione verso est del fronte Appenninico-<br />
Maghrebide ed è dovuta principalmente alla rotazione del fronte <strong>di</strong> subduzione a causa delle <strong>di</strong>fferenti<br />
competenze geologiche della placca subdotta (Figura 4.7).<br />
Figura 4.7 - Schema evolutivo della migrazione del fronte delle Maghrebi<strong>di</strong> dal Miocene ad oggi (fonte: Doglioni et al., 2004)<br />
61
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La catena Appenninica ha una forma ad “arco” e occupa l’intera penisola italiana, partendo dal Piemonte-<br />
Monferrato in Italia settentrionale fino alla parte settentrionale della catena africana delle Magrebi<strong>di</strong>. L’arco<br />
in origine aveva una <strong>di</strong>rezione NE-SO per poi ruotare <strong>di</strong> 90° nella situazione attuale durante gli ultimi 30 Ma.<br />
Si calcola che l’arco sia migrato in <strong>di</strong>rezione verso est <strong>di</strong> circa 775 km dal tardo Oligocene.<br />
Nel complesso quadro geologico-regionale generatosi nel Me<strong>di</strong>terraneo centrale è possibile riconoscere, in<br />
maniera semplificata, tre <strong>di</strong>fferenti macrodomini tettonici che, si sviluppano in <strong>di</strong>rezione perpen<strong>di</strong>colare al<br />
fronte Appenninico (Avraham et al., 1990; Lentini et al., 1996, 2002; Finetti et al., 1996) (Figura 4.8):<br />
• Avampaese (Foreland Domains - Verde);<br />
• Catena (Orogenic Domains - Rosa);<br />
• Retroarco (Hinterland Domains - Giallo).<br />
Figura 4.8 - Distribuzione dei principali domini tettonici nel Me<strong>di</strong>terraneo centrale<br />
Il Dominio <strong>di</strong> Avampaese (foreland Domains) rappresentato in verde, è costituito dalla parte continentale<br />
indeformata della placca africana, rappresentata dal blocco Ibleo-Pelagiano e dalla placca Adria. La placca<br />
Adria conosciuta anche come Promontorio Apulo, nella parte meri<strong>di</strong>onale a contatto con l’Avampaese<br />
Africano e il Bacino Ionico, perde le proprie caratteristiche continentali con lo sviluppo <strong>di</strong> creazione <strong>di</strong> nuova<br />
crosta oceanica.<br />
L’intero Dominio della Catena Appenninica può essere, invece, scomposto in tre principali settori:<br />
il sistema esterno, costituito dai sovrascorrimenti legati allo scollamento della copertura<br />
se<strong>di</strong>mentaria interna del settore inarcato dell’Avampaese continentale;<br />
62
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La Catena Appennino-Maghrebide, generata dall’embriciatura delle sequenze se<strong>di</strong>mentarie<br />
appartenenti sia ai settori <strong>di</strong> crosta oceanica (Bacino Tetideo e Ionico) sia ai settori <strong>di</strong> crosta<br />
continentale (parte interna delle piattaforme carbonatiche);<br />
La Catena Kabilo-Calabride legata alla delaminazione e successiva migrazione verso i quadranti sudorientali<br />
del margine Europeo.<br />
Figura 4.9 - Sistema <strong>di</strong> pieghe, faglie e sovrascorrimenti della catena Appennino meri<strong>di</strong>onale (fonte: Scrocca 2010)<br />
Il Dominio <strong>di</strong> Retroarco, infine, risulta rappresentato dal blocco Sardo-Corso e dal Bacino del Tirreno.<br />
Quest'ultimo, a sua volta, è caratterizzato da una crosta <strong>di</strong> tipo oceanico e la cui apertura è datata dal<br />
Miocene me<strong>di</strong>o.<br />
Nell’area meri<strong>di</strong>onale del Tirreno le proprietà dell’orogenesi Appennino-Maghrebide sono controllate dallo<br />
spessore <strong>di</strong> crosta del Dominio <strong>di</strong> Avampaese.<br />
L’area in istanza ricade nella fascia dei sovrascorrimenti appenninici, andando a collocarsi nel quadrante<br />
meri<strong>di</strong>onale della Catena Appenninica Meri<strong>di</strong>onale. In questo settore l’intero orogene è caratterizzato da tre<br />
gran<strong>di</strong> sistemi geologico-strutturali, legati tra <strong>di</strong> loro da un punto <strong>di</strong> vista geo<strong>di</strong>namico: l’Appennino<br />
Campano-Lucano, l’Avanfossa Bradanica e l’Avampaese Apulo.<br />
Nel dettaglio, l’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, ricade in corrispondenza delle propaggini più esterne dell’Avanfossa<br />
Bradanica, proprio a ridosso del supposto (benché non affiorante) fronte del thrust che delimiterebbe il<br />
settore <strong>di</strong> Catena s.s. dalla fossa (Figura 4.10).<br />
63
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.10 - Carta geologica dell’Italia Meri<strong>di</strong>onale, con i limiti dei principali domini geologico-strutturali e ubicazione dell’area <strong>di</strong><br />
interesse (fonte: Patacca et al, 2006, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
In particolare, l’Avanfossa Bradanica, rappresenta un’area che accoglie i se<strong>di</strong>menti provenienti dallo<br />
smantellamento della Catena Appenninica, la quale risulta separata dal settore più settentrionale dell’Arco<br />
Calabro-Peloritano da un lineamento tettonico non chiaramente definito chiamato “Linea <strong>di</strong> Sangineto”<br />
(Figura 4.11).<br />
La Catena Appenninica Meri<strong>di</strong>onale e l’Arco Calabro-Peloritano rappresentano due e<strong>di</strong>fici orogenetici<br />
costituiti da Unità litologico-strutturali profondamente <strong>di</strong>verse, originariamente posti in aree <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>mentazione molto <strong>di</strong>stanti ed appartenenti a domini paleogeografici <strong>di</strong>fferenti. L’Appennino<br />
Meri<strong>di</strong>onale è, infatti, costituito da unità depostesi all’interno della Placca Continentale Africana mentre<br />
l’Arco Calabro-Peloritano è caratterizzato da unità pertinenti alla Placca Continentale Europea. La presenza<br />
contemporanea <strong>di</strong> questi due <strong>di</strong>fferenti orogeni e la loro messa in posto durante il Cenozoico hanno causato<br />
una complessità strutturale che si sviluppa soprattutto lungo la zona in cui le catene sono poste a contatto.<br />
64
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.11 - Carta tettonica dell’Italia centro meri<strong>di</strong>onale; in evidenza la Catena dell’Appennino Campano-Lucano (A) e quella<br />
dell’Arco Calabro-Peloritano (B); nel cerchio rosso, il blocco oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (fonte: C.N.R. - Progetto finalizzato Geo<strong>di</strong>namica –<br />
Pubblicazione n. 269, mo<strong>di</strong>ficata)<br />
4.3.1.1 Appennini Meri<strong>di</strong>onali<br />
L’Appennino meri<strong>di</strong>onale può essere in prima approssimazione sud<strong>di</strong>viso in due gran<strong>di</strong> complessi<br />
stratigrafico-strutturali sovrapposti, rappresentati da unità alloctone sovrascorse su un avampaese<br />
mobilizzato durante le più recenti fasi tettoniche Appenniniche. Tali unità derivano dalla deformazione e<br />
accavallamento <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti Mesozoici e Cenozoici <strong>di</strong> paleoambienti che vanno da bacino-bacino profondo<br />
(Unità <strong>di</strong> Lagonegro) ad ambienti <strong>di</strong> piattaforma carbonatica (Piattaforma Appenninica). Nella parte più<br />
occidentale della catena, le facies <strong>di</strong> piattaforma risultano sovrascorse sul dominio Lagonegrese, le cui unità,<br />
nell’area <strong>di</strong> Val d’Agri, risultano accavallate sulla Piattaforma Apula.<br />
All’interno dei singoli domini tettonici è, inoltre, possibile identificare delle precise unità stratigraficostrutturali<br />
le cui peculiarità hanno permesso <strong>di</strong> delineare le principali fasi evolutive che hanno caratterizzato<br />
l’intera area appenninica meri<strong>di</strong>onale. Le principali unità in<strong>di</strong>viduate, procedendo da ovest ad est, sono<br />
(Figura 4.12):<br />
La Piattaforma Appenninica;<br />
Il Bacino lagonegrese s.l. e le unità esterne;<br />
L’Avanfossa Bradanica;<br />
La Piattaforma Apula.<br />
65
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.12 - Mappa delle principali unità geologico-strutturali dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale e ubicazione del blocco in stu<strong>di</strong>o;<br />
(fonte: Compagnoni et al 2004, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
4.3.1.2 Piattaforma Appenninica e Bacino <strong>di</strong> Lagonegro<br />
Procedendo da ovest verso est, i settori più occidentali dell’area appenninica sono interessati dalla presenza<br />
<strong>di</strong> unità <strong>di</strong> piattaforma e unità appartenenti ad ambienti <strong>di</strong> tipo bacinale.<br />
Alla Piattaforma Appenninica appartengono unità composte prevalentemente da dolomie e calcari <strong>di</strong> acqua<br />
bassa che, verso est, passano a facies <strong>di</strong> margine <strong>di</strong> piattaforma e scarpata. Lo sviluppo <strong>di</strong> questi depositi è<br />
ripetutamente interrotto da superfici <strong>di</strong> <strong>di</strong>scordanza stratigrafica, marcate da brusche variazioni verticali <strong>di</strong><br />
facies. La piattaforma mostra uno sviluppo verticale considerevole dovuto alla combinazione <strong>di</strong> alta<br />
produzione carbonatica e ai forti tassi <strong>di</strong> subsidenza.<br />
Le unità bacinali, ad ovest della Piattaforma Appenninica, fanno parte del bacino <strong>di</strong> Lagonegro i quale<br />
rappresentano il risultato <strong>di</strong> una fase estensionale generato da un rift Triassico. L’apporto se<strong>di</strong>mentario in<br />
bacino è governato dalla produzione carbonatica delle piattaforme circostanti quale la Piattaforma<br />
Appenninica a ovest e la Piattaforma Apula ad est (Figura 4.13), pertanto le successioni che vanno dal<br />
Triassico all'Eocene sono composte prevalentemente da torbi<strong>di</strong>ti carbonatiche, calcari con selce, ra<strong>di</strong>olariti e<br />
marne silicizzate.<br />
Sopra le unità lagonegresi, durante il Pliocene, si assiste alla messa in posto dei “flysch esterni”, che<br />
rappresentano il risultato delle fasi iniziali dell’innalzamento della catena Appenninica.<br />
Queste due unità, seppur non rientrino nell’area oggetto d’istanza, risultano interessanti al fine delle<br />
ricostruzioni del contesto geologico-strutturali dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale.<br />
66
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.13 - Ricostruzione paleogeografica dell’Appennino Meri<strong>di</strong>onale durante il Giurassico e Cretaceo (fonte: Zappaterra 1994)<br />
4.3.1.3 Avanfossa Bradanica<br />
L’Avanfossa Bradanica è il dominio strutturale compreso tra il fronte della Catena Appenninica e<br />
l’Avampaese Apulo, a prevalente sviluppo NO-SE. Essa comprende una parte affiorante data dal Tavoliere<br />
delle Puglie, dalla Fossa Bradanica e dalla fascia ionica della Lucania porzione in cui ricade l’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Questo elemento strutturale inizia a delinearsi a partire dal Pliocene me<strong>di</strong>o-superiore, quando<br />
un’importante subsidenza portò alla formazione <strong>di</strong> un bacino se<strong>di</strong>mentario allungato parallelamente alla<br />
Piattaforma Apula, il cui margine interno è stato successivamente ribassato in blocchi con geometrie a<br />
gra<strong>di</strong>nata.<br />
I se<strong>di</strong>menti dell’Avanfossa sono principalmente costituiti da depositi clastici (argille, sabbie e conglomerati)<br />
<strong>di</strong> facies marina e coprono un intervallo cronostratigrafico che va dal Pliocene me<strong>di</strong>o-superiore al<br />
Pleistocene (Ogniben et al, 1969).<br />
Nel suo complesso, la Catena, è stata caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> avanfossa poi coinvolte<br />
nella deformazione a falde dell’Appennino e che quin<strong>di</strong> si trovano adesso inglobate nella catena stessa. A<br />
<strong>di</strong>fferenza delle precedenti avanfosse, tuttavia, quella Bradanica risulta solo parzialmente deformata dalla<br />
tettonica appenninica e pertanto giace in posizione autoctona.<br />
Evoluzione strutturale<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista strutturale, essa è caratterizzata dalla debole deformazione che ha provocato la<br />
formazione <strong>di</strong> sovrascorrimenti superficiali interessando i se<strong>di</strong>menti più antichi depostisi al suo interno. Le<br />
strutture più caratteristiche sono rappresentate da anticlinali più o meno complesse legate a<br />
sovrascorrimenti a me<strong>di</strong>o-basso angolo e da faglie inverse (probabilmente invertite) al livello dei depositi<br />
della piattaforma apula (pre-Pliocene).<br />
67
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La progressiva subduzione della litosfera continentale Adriatica ha causato una migrazione dei depocentri<br />
assiali dell’Avanfossa. Negli Appennini centrali la depressione raggiunse la profon<strong>di</strong>tà massima nel Pliocene<br />
inferiore, mentre se ci si sposta lungo l’Avanfossa della catena Appenninica la massima profon<strong>di</strong>tà si<br />
raggiunge solo in tempi relativamente più recenti. Nella parte settentrionale della fossa Bradanica il<br />
maggiore spessore si raggiunge durante il Pliocene me<strong>di</strong>o.<br />
Durante il Pliocene-inizio Pleistocene, l’Avanfossa Bradanica è stata caratterizzata da un tasso <strong>di</strong> subsidenza<br />
(> 1 mm/a) tale da permettere la deposizione <strong>di</strong> spesse sequenze clastiche. Successivamente, si nota una<br />
<strong>di</strong>minuzione del tasso <strong>di</strong> subsidenza, in totale contrasto con l’Avanfossa Appenninica e il Mar Ionio.<br />
L’Avanfossa Bradanica è stata deformata durante il Plio-Pleistocene da parte dell’ultimo impulso<br />
dell’orogenesi e da ripetute spinte provenienti dalla parte meri<strong>di</strong>onale della Catena Appenninica. Gli effetti<br />
tettonici sono registrati da se<strong>di</strong>menti clastici che hanno riempito la depressione e dal substrato carbonatico.<br />
Nella piattaforma Apula è possibile <strong>di</strong>stinguere due set principali <strong>di</strong> faglie, in base al loro orientamento:<br />
NO-SE (N120°-N150°) faglie normali con immersione SO-NE;<br />
E-O (N90°-N100°).<br />
Il sistema principale è rappresentato dal set <strong>di</strong> faglie orientate NO-SE; la loro cinematica presenta una<br />
componente trascorrente ed una compressiva verso la catena Appenninica.<br />
Evoluzione deposizionale<br />
Al sollevamento della catena è seguito lo scivolamento gravitativo <strong>di</strong> materiale clastico depostosi<br />
nell’avanfossa; contemporaneamente si sono deposte anche le sabbie torbi<strong>di</strong>tiche nella parte esterna<br />
dell’area. La <strong>di</strong>rezione delle correnti <strong>di</strong> torbida risulta longitu<strong>di</strong>nale lungo i principali assi del bacino, ipotesi<br />
confermate anche dai dati <strong>di</strong> pozzo e dalle analisi sismiche. Talvolta le sequenze gravitative sono intercalate<br />
da torbi<strong>di</strong>ti che evidenziando la contemporaneità della loro deposizione. L’Avanfossa Bradanica è costituita<br />
nella parte centrale da debris-flow, mud-flows e elementi alloctoni della catena Appenninica. Mentre la<br />
parte centrale è costituita da depositi torbi<strong>di</strong>tici.<br />
In alcune parti del bacino è possibile <strong>di</strong>stinguere due cicli principali <strong>di</strong> deposizione in base alla presenza <strong>di</strong><br />
sequenze calcarenitiche, facilmente identificabili nei log a causa degli elevati valori <strong>di</strong> resistività. La presenza<br />
<strong>di</strong> foraminiferi bentonici testimonia, inoltre, che questi livelli sono associabili a facies deposizionali <strong>di</strong> mare<br />
poco profondo. Possiamo concludere che il bacino è stato interessato da una seconda fase deposizionale<br />
durante il Pliocene me<strong>di</strong>o-inferiore e che è continuata fino al Pleistocene. Questi se<strong>di</strong>menti pleistocenici<br />
sono preservati solo localmente perché la maggior parte è stata erosa in seguito al sollevamento tettonico<br />
della struttura nel tardo Pleistocene (Figura 4.14).<br />
Figura 4.14 - Sezione NE-SO schematica con la <strong>di</strong>stribuzione spaziale dei principali corpi sabbiosi torbi<strong>di</strong>tici Plio-Pleistocenici<br />
(fonte: Casne<strong>di</strong>, 1998 mo<strong>di</strong>ficato)<br />
68
Stratigrafia<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La stratigrafia dell’Avanfossa Bradanica varia sia in termini <strong>di</strong> età sia in litologia spostandoci da NO a SE lungo<br />
gli assi principali della fossa. La base dell’Avanfossa poggia con <strong>di</strong>scordanza stratigrafica che frequentemente<br />
assume i caratteri <strong>di</strong> angular unconformity, sui calcari della piattaforma Apula. Questa superficie <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scordanza registra l’intensa erosione dei se<strong>di</strong>menti d’età cenomaniana e probabilmente turoniana,<br />
avvenuta prima della fine del Turoniano. Le unità erose sono state rise<strong>di</strong>mentate sotto forma <strong>di</strong> brecce<br />
carbonatiche nelle aree depresse a<strong>di</strong>acenti.<br />
Dati stratigrafici iniziano a partire dal Pliocene inferiore con unità caratterizzate dalla presenza della<br />
Globorotalia punticulata. Le successioni poggiano sopra una <strong>di</strong>scordanza <strong>di</strong> tipo stratigrafico che interessa la<br />
Piattaforma Apula. Lo spessore <strong>di</strong> questi se<strong>di</strong>menti decresce spostandosi dalla parte nord-occidentale del<br />
bacino verso quella sud-orientale. Il Pliocene inferiore è caratterizzato da se<strong>di</strong>menti fini intercalati da<br />
torbi<strong>di</strong>ti arenacee, mentre nella zona centrale e sud-orientale sono presenti se<strong>di</strong>menti marnosi con<br />
intercalazioni <strong>di</strong> calcareniti <strong>di</strong> ambiente poco profondo.<br />
Questi se<strong>di</strong>menti sono stati rinvenuti in alcuni pozzi perforati nella zona Bradanica e rappresentano<br />
l’intervallo stratigrafico più giovane delle rocce appartenenti al settore più esterno del thrust degli<br />
Appennini Meri<strong>di</strong>onali. Il ritrovamento dei suddetti se<strong>di</strong>menti in taluni pozzi, è stato <strong>di</strong> fondamentale<br />
importanza per delineare i rapporti tra i <strong>di</strong>versi domini tettonici degli Appennini Meri<strong>di</strong>onali. I dati<br />
provenienti dalle perforazioni, infatti, hanno messo in evidenza che i se<strong>di</strong>menti del Pliocene inferiore si<br />
trovano impilati al tetto della piattaforma Apula e ambedue sono stati interpretati come sovrascorse al <strong>di</strong><br />
sopra delle sequenze alloctone del Miocene.<br />
Nell’area Tempa Rossa-Val d’Agri, a più <strong>di</strong> 40 km dall’attuale posizione centrale dell’Avanfossa, l’intervallo<br />
pliocenico inferiore è definito da uno spesso deposito <strong>di</strong> marne e argille che costituiscono la copertura<br />
principale delle rocce serbatoio.<br />
La sequenza del Pliocene inferiore si è deposta durante le prime fasi dell’orogenesi degli Appennini<br />
Meri<strong>di</strong>onali. Nell’Avampaese degli Appennini Centrali, il Pliocene inferiore è testimoniato dalla presenza <strong>di</strong><br />
spessi depositi torbi<strong>di</strong>tici alternati a depositi emipelagici fini. L’Avanfossa Bradanica, in particolare nell’area<br />
nord-occidentale, è costituita da marne e argille emipelagiche con poca presenza <strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>ti, probabilmente<br />
a causa della <strong>di</strong>stanza dalla fonte principale <strong>di</strong> apporto se<strong>di</strong>mentario torbi<strong>di</strong>tico.<br />
I se<strong>di</strong>menti del Pliocene me<strong>di</strong>o-superiore sono stati osservati in molti pozzi dell’area Bradanica in posizione<br />
autoctona. In alcuni pozzi nella parte occidentale, appaiono me<strong>di</strong>amente deformati dall’orogenesi<br />
Appenninica generando blande anticlinali il cui asse è orientato NO-SE. In generale, questi depositi sono<br />
rappresentati da marne e argilliti, deposte in ambiente emipelagico, con intervalli <strong>di</strong>scontinui <strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>ti.<br />
L’evoluzione <strong>di</strong> questo sistema <strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>ti può essere spiegato attraverso la variazione <strong>di</strong> apporto<br />
se<strong>di</strong>mentario in funzione del <strong>di</strong>verso tasso <strong>di</strong> subsidenza.<br />
AI <strong>di</strong> sopra delle unità plioceniche non si registrano variazioni nell’ambiente deposizionale e i depositi<br />
pleistocenici sono caratterizzati nuovamente da alternanze <strong>di</strong> emipelagiti e torbi<strong>di</strong>ti. Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> terreno<br />
suggeriscono una migrazione del depocentro dell’Avanfossa verso est e un massimo tasso <strong>di</strong> subsidenza in<br />
corrispondenza nella parte centrale e meri<strong>di</strong>onale della depressione. Nella parte nord-occidentale della<br />
fossa, la sequenza pleistocenica, può raggiungere i 600 m ed è costituita da marne e argilliti, mentre nella<br />
parte meri<strong>di</strong>onale si raggiungono spesso i 1000 m <strong>di</strong> spessore. In quest’area si osserva lo sviluppo <strong>di</strong> spesse<br />
sequenze <strong>di</strong> corpi torbi<strong>di</strong>tici; gli intervalli sabbiosi mostrano una limitata estensione e possono essere<br />
correlati solo su piccole <strong>di</strong>stanze.<br />
L’attuale situazione deposizionale è frutto del veloce tasso <strong>di</strong> risalita della catena in quest’area, la quale<br />
risulta essere anche la sorgente principale dell’apporto se<strong>di</strong>mentario nel bacino. Le deformazioni che hanno<br />
interessato la fossa non hanno permesso la <strong>di</strong>spersione delle correnti <strong>di</strong> torbida e l’elevato accumulo <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>menti conferma l’alto tasso <strong>di</strong> subsidenza dell’area e anche l’abbondante apporto se<strong>di</strong>mentario.<br />
Allontanandoci dall’area depocentrale la deposizione è caratterizzata da emipelagiti fini e da torbi<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>stali.<br />
Nel complesso la sequenza tipica mostra nella parte inferiore la presenza <strong>di</strong> sequenze torbi<strong>di</strong>tiche<br />
69
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
intervallate da livelli marnoso-argillosi. Questi depositi caratterizzano anche l’intervallo datato Pliocene<br />
me<strong>di</strong>o-superiore tanto che talvolta risulta <strong>di</strong>fficile demarcare il Pliocene dal Pleistocene.<br />
Il resto della sequenza Pleistocenica è caratterizzata da marne e argilliti con rari livelli <strong>di</strong> sabbie fini. Parte <strong>di</strong><br />
questa sequenza affiora nel settore meri<strong>di</strong>onale della Puglia. Le unità Plio-Pleistocenici deposte<br />
nell’Avanfossa Bradanica poggiano in <strong>di</strong>scordanza sui carbonati della Piattaforma Apula <strong>di</strong> spessore variabile<br />
dai 5000 m ai 7000 m. Si tratta <strong>di</strong> carbonati, stratigraficamente ricoperti dai depositi terrigeni messiniani e<br />
pliocenici.<br />
I carbonati della Piattaforma Apula poggiano sui depositi vulcanoclastici del Permiano, e talvolta ricoprono<br />
le unità del Carnico-La<strong>di</strong>nico. Questi carbonati affiorano verso est nella zona del Gargano e del Salento,<br />
mentre la piattaforma Apula può essere seguita verso ovest attraverso la cor<strong>relazione</strong> delle <strong>di</strong>agrafie <strong>di</strong><br />
pozzo, al <strong>di</strong> sotto dei depositi Plio-Pleistocenici.<br />
Il contatto tra Piattaforma Apula e depositi <strong>di</strong> Avanfossa varia localmente in base all’assetto geologico. I<br />
se<strong>di</strong>menti più giovani appartenenti alla piattaforma Apula sono rappresentati da carbonati <strong>di</strong> acqua bassa <strong>di</strong><br />
età miocenica inferiore-me<strong>di</strong>o con intercalazioni <strong>di</strong> depositi clastici. I depositi più vecchi che sono a contatto<br />
i se<strong>di</strong>menti dell’Avanfossa Bradanica sono carbonati <strong>di</strong> acqua bassa <strong>di</strong> età Cretacica. In alcuni pozzi al tetto<br />
della piattaforma Apula sono presenti dei livelli <strong>di</strong> brecce che testimoniano dei locali eventi <strong>di</strong> emersione<br />
della piattaforma o un sollevamento regionale e <strong>di</strong> emersione della piattaforma durante il tardo Eocene-<br />
Oligocene.<br />
4.3.1.4 La piattaforma Apula<br />
La Piattaforma Apula, affiorante ad est della zona d’interesse, rappresenta la zona d'avampaese della catena<br />
Appenninica e nel contempo la più orientale delle piattaforme delineatesi a partire dal Triassico. In un<br />
contesto regionale, può essere considerata, una zona <strong>di</strong> avampaese intra-orogenico al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> due zone<br />
<strong>di</strong> subduzione: una immergente verso ovest, sotto gli Appennini, l’altra verso est al <strong>di</strong>sotto delle Dinari<strong>di</strong>.<br />
La storia tettonica della piattaforma è stata caratterizzata da <strong>di</strong>fferenti episo<strong>di</strong> a partire dal Triassico fino al<br />
Pliocene. Lungo il suo margine occidentale si sono accavallati, durante il Cenozoico, i domini tettonici <strong>di</strong><br />
avanfossa e catena precedentemente descritti. Litologicamente l’Avampaese Apulo risulta, in prevalenza,<br />
composto da una sequenza <strong>di</strong> carbonati in facies <strong>di</strong> piattaforma <strong>di</strong> età Mesozoica.<br />
Parte delle unità appartenenti alla Piattaforma Apula (Formazione <strong>di</strong> Altamura–Cretaceo superiore)<br />
affiorano nelle Murge pugliesi (Figura 4.15) pressoché indeformate e rappresentano l’avampaese della<br />
catena Appenninica. In queste aree le unità calcaree della piattaforma Apula possono ritrovarsi anche nel<br />
sottosuolo a profon<strong>di</strong>tà perfino elevate, raggiungendo gli oltre 6000 m. L’evoluzione stratigraficodeposizionale<br />
del dominio Apulo, dal Mesozoico al Miocene, può altresì essere sinteticamente sud<strong>di</strong>visa<br />
secondo due fasi principali: fase Mesozoica e Cenozoica.<br />
La fase Mesozoica è testimoniata a partire dalla porzione basale della piattaforma mai affiorante, ma nota<br />
solo grazie a dati <strong>di</strong> pozzo. Essa è costituita da anidriti e dolomie triassiche, su cui poggia una spessa<br />
successione, prevalentemente dolomitica (Giurassico-Cretaceo), tipica <strong>di</strong> facies <strong>di</strong> piattaforma carbonatica<br />
poco profonda. La scarsa variabilità verticale degli ambienti va attribuita ad un tasso <strong>di</strong> subsidenza<br />
relativamente costante e compensato dal tasso <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione. Alla sommità della successione<br />
dolomitica si osserva la presenza <strong>di</strong> calcari <strong>di</strong> scogliera e <strong>di</strong> scarpata (limite Giurassico-Cretaceo), che<br />
registrano un generale approfon<strong>di</strong>mento della piattaforma.<br />
Si passa quin<strong>di</strong>, verso l’alto, a facies carbonatiche intertidali con livelli dolomitizzati e al cui interno sono<br />
presenti episo<strong>di</strong>che intercalazioni <strong>di</strong> calcari a Ru<strong>di</strong>ste, che si estendono fino alla parte alta del<br />
Cenomaniano. Queste facies, che possono essere osservate in affioramento nell’area delle Murge, in<strong>di</strong>cano<br />
una se<strong>di</strong>mentazione <strong>di</strong> piattaforma protetta, perio<strong>di</strong>camente invasa, con conseguente sviluppo <strong>di</strong> facies <strong>di</strong><br />
ambiente più aperto, costituite da biocostruzioni a Ru<strong>di</strong>ste.<br />
Al tetto della successione cenomaniana si rinviene un'estesa superficie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scordanza stratigrafica che<br />
assume frequentemente caratteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>scordanza angolare. La stessa superficie, oltre ad essere localmente<br />
70
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> bauxiti, registra l’intensa erosione dei se<strong>di</strong>menti d'età cenomaniana e<br />
probabilmente turoniana, avvenuta prima della fine del Turoniano. Le unità erose sono state rise<strong>di</strong>mentate<br />
sotto forma <strong>di</strong> brecce carbonatiche nelle aree depresse a<strong>di</strong>acenti. La <strong>di</strong>scordanza cenomaniana-turoniana è<br />
il frutto <strong>di</strong> una repentina inclinazione della piattaforma verso SO; testimonianze <strong>di</strong> tale evento sono state<br />
rinvenute anche in affioramento nel Gargano. Al <strong>di</strong> sopra della <strong>di</strong>scordanza e sulla corrispondente superficie<br />
concordante poggiano brecce costituite da frammenti pre-cenomaniani, cenomaniani e probabilmente<br />
anche turoniani, associati con la superficie d'erosione. A questi depositi fa seguito una successione<br />
composta da laminiti algali caratteristiche <strong>di</strong> un ambiente intertidale o sopratidale, wackestone a<br />
foraminiferi e bioclasti e livelli a ru<strong>di</strong>ste originatisi in ambienti ossigenati.<br />
La frequenza dei livelli a Ru<strong>di</strong>ste, interpretati come corpi biocostruiti che aumenta verso l’alto a scapito degli<br />
intervalli a laminiti algali, in<strong>di</strong>ca un generale aumento del livello marino al <strong>di</strong>sopra della piattaforma. Il tetto<br />
<strong>di</strong> questi depositi, d'età campaniana superiore, è rappresentato da un’altra <strong>di</strong>scordanza stratigrafica da<br />
imputare ad una ulteriore inclinazione e sprofondamento <strong>di</strong> parte della piattaforma. Sui se<strong>di</strong>menti della<br />
piattaforma aperta con scogliera a Ru<strong>di</strong>ste poggiano, con contatto brusco, facies <strong>di</strong> scarpata carbonatica che<br />
passano, verso le aree bacinali ad ovest, a depositi pelagici. Questi se<strong>di</strong>menti sono <strong>di</strong> età compresa tra il<br />
Campaniano superiore ed il Maastrichtiano.<br />
Figura 4.15 – Calcari della Piattaforma Apula in una sezione delle cave <strong>di</strong> Apricena nel settore settentrionale della Puglia<br />
La fase Cenozoica inizia con la presenza <strong>di</strong> rocce ignee ultrabasiche sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>cchi e rocce<br />
subvulcaniche <strong>di</strong> probabile età eocenica che giacciono localmente a contatto al tetto delle precedenti unità<br />
del Maastrichtiano. Il contatto con i soprastanti depositi eocenici avviene per <strong>di</strong>scordanza stratigrafica, alla<br />
quale si associa, come riconosciuto nell’area garganica, la presenza <strong>di</strong> superfici erosive. La successione<br />
eocenica è composta da torbi<strong>di</strong>ti carbonatiche su cui progradano se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> piattaforma interna,<br />
localmente trasgre<strong>di</strong>ti da facies <strong>di</strong> piattaforma esterna/margine. Su questa superficie è sviluppata, in<br />
particolar modo nel sottosuolo, una successione miocenica <strong>di</strong> calcari pelagici, ricchi <strong>di</strong> fosfati, che<br />
rappresenta la sequenza d'annegamento della piattaforma Apula. L’annegamento della piattaforma Apula è<br />
legato al carico prodotto dall’impilamento lungo il suo margine occidentale delle falde appenniniche.<br />
71
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Nelle immagini che seguono sono illustrate le fasi evolutive, dal Cretaceo, della Piattaforma Apula partendo<br />
dalla <strong>di</strong>stribuzione delle facies ottenuta analizzando i dati <strong>di</strong> pozzo e le linee sismiche a <strong>di</strong>sposizione. Tale<br />
stu<strong>di</strong>o è stato fatto non solo nella zona in esame ma in un’area molto più ampia al fine <strong>di</strong> comprendere<br />
l’evoluzione alla scala <strong>di</strong> bacino. In questo modo, oltre a definire la <strong>di</strong>stribuzione delle facies è stato<br />
possibile ricostruire nel tempo l’evoluzione degli ambienti deposizionali. Dal Cretaceo è possibile osservare<br />
come nella porzione nord-orientale, presenti sequenze caratterizzate da se<strong>di</strong>mentazione carbonatica <strong>di</strong><br />
mare basso mentre ad occidente prevalgono rocce calcaree con tessitura più fine (Figura 4.16). Localmente<br />
sono presenti dolomie e calcari dolomitici frutto delle con<strong>di</strong>zioni favorevoli allo sviluppo della piattaforma.<br />
Durante il Cretaceo infatti la piattaforma aggrada, crescendo in altezza, bilanciando la risalita del livello del<br />
mare. L’Eocene mostra la deposizione <strong>di</strong> calcari a nummuliti e brecce calcaree. Queste sono una<br />
testimonianza <strong>di</strong> una fase <strong>di</strong> emersione che induceva uno smantellamento della piattaforma carbonatica e<br />
quin<strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> brecce (Figura 4.17). Durante il Miocene, così come nel Pliocene, la <strong>di</strong>stribuzione delle<br />
facies cambia considerevolmente con una drastica riduzione delle aree occupate dalla piattaforma<br />
carbonatica per dare spazio alla deposizione <strong>di</strong> brecce tettoniche <strong>di</strong> rampa e <strong>di</strong> slope generatesi a seguito<br />
dell’uplift dell’avampaese, siamo infatti nel pieno dell’attività tettonica (Figura 4.18, Figura 4.19).<br />
Figura 4.16 – Assetto paleogeografico del settore centrale della piattaforma durante il Cretaceo; il settore nord-orientale è<br />
caratterizzato da depositi <strong>di</strong> piattaforma tipici <strong>di</strong> mare poco profondo, mentre quello sud-orientale dalla deposizione <strong>di</strong> dolomie<br />
72
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.17 – Assetto durante l’Eocene del settore in stu<strong>di</strong>o; i calcari iniziano a subire le prime deformazioni con fagliazione a<br />
cinematica <strong>di</strong>retta e deposizione dei primi se<strong>di</strong>menti calcarenitici e brecce (ve<strong>di</strong> sezione interpretativa)<br />
Figura 4.18 – Durante il Miocene, la fase deformativa è in uno sta<strong>di</strong>o avanzato e le con<strong>di</strong>zioni paleogeografiche sono favorevoli<br />
per la deposizione più massiccia <strong>di</strong> calcareniti, calcari marnosi e brecce che drappeggiano e uniformano la topografia del top dei<br />
calcari<br />
73
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.19 – Nel Pliocene le zone più depresse appaiono quasi completamente riempite dal materiale depostosi tipico <strong>di</strong><br />
margine <strong>di</strong> piattaforma, testimoniato anche dalla presenza <strong>di</strong> una superficie erosiva dovuta ad emersione della stessa<br />
La Figura 4.20 mostra, infine, la complessità della <strong>di</strong>stribuzione delle facies e delle <strong>di</strong>fferenti unità apule al <strong>di</strong><br />
sotto dell’unconformity che marca i passaggio tra i depositi terziari <strong>di</strong> avampaese e quelli della piattaforma<br />
Apula. La variabilità delle caratteristiche tessiturali, <strong>di</strong> facies e <strong>di</strong> età ha un forte impatto nella variabilità<br />
delle proprietà petrofisiche dei carbonati apuli e <strong>di</strong> conseguenza delle proprietà <strong>di</strong> tali unità come rocce<br />
serbatoio.<br />
Figura 4.20 – Configurazione attuale del Top dei carbonati frutto delle complesse fasi evolutive precedenti<br />
74
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
4.3.2 Geologia <strong>di</strong> superficie dell’area in esame<br />
La geologia <strong>di</strong> superficie dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o non appare particolarmente articolata, come emerge anche dalla<br />
carta geologica d’Italia (Foglio n. 201 “Matera” - Figura 4.21). Si tratta in prevalenza <strong>di</strong> formazioni geologiche<br />
costituite da depositi marini plio-pleistocenici e in piccola parte da se<strong>di</strong>menti continentali olocenici associati<br />
all’attività dei corsi d’acqua e rielaborati dal <strong>di</strong>lavamento superficiale. Partendo stratigraficamente dal basso,<br />
sono visibili:<br />
Le Calcareniti <strong>di</strong> Gravina: presenti principalmente nel settore occidentale del blocco a partire dal<br />
centro abitato <strong>di</strong> Pisticci, presenti orograficamente sia a destra che a sinistra del Fiume Basento;<br />
Depositi marini: organizzati in terrazzi in varie quote <strong>di</strong>sposti grossomodo parallelamente alla linea<br />
<strong>di</strong> costa, i quali ricoprono il settore orientale del blocco;<br />
Depositi alluvionali attuali/olocenici: frutto dell’incessante attività dei principali corsi d’acqua che<br />
attraversano il blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (il Basento e il Cavone);<br />
Coperture detritiche: parzialmente rielaborate per <strong>di</strong>lavamento presenti a sprazzi nella parte<br />
settentrionale del blocco.<br />
Figura 4.21 – Carta geologica del settore sud-orientale della Basilicata (Foglio 201 “Matera”)<br />
Le Calcareniti <strong>di</strong> Gravina rappresentano la base della successione del ciclo se<strong>di</strong>mentario della Fossa<br />
bradanica. Questa formazione, affiorante lungo le sponde del Fiume Bradano, è costituita da calcareniti<br />
fossilifere con vario grado <strong>di</strong> cementazione e porosità. Sulle Calcareniti <strong>di</strong> Gravina, che hanno uno spessore<br />
massimo <strong>di</strong> circa 60 m, poggiano limi e limi sabbiosi fossiliferi, caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> un elevato<br />
contenuto in carbonati; le argille affiorano ampiamente nella zona in corrispondenza della parte inferiore e<br />
me<strong>di</strong>a dei versanti.<br />
75
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Nella zona sono inoltre presenti in corrispondenza della parte bassa dei versanti, lembi <strong>di</strong> antichi depositi<br />
terrazzati mentre lungo gli alvei dei corsi d'acqua si rinvengono depositi alluvionali <strong>di</strong> età recente. Infine<br />
nella parte me<strong>di</strong>o-superiore dei versanti si trovano accumuli <strong>di</strong> vecchie frane attualmente stabilizzate. Tali<br />
accumuli, anche se rielaborati dall'erosione, possono superare lo spessore <strong>di</strong> 7-8 m e sono particolarmente<br />
ampi sui fianchi del rilievo su cui sorge l'abitato <strong>di</strong> Miglionico, il quale sorge alla quota massima <strong>di</strong> m 465 m,<br />
in corrispondenza <strong>di</strong> un costone sabbioso-conglomeratico che degrada bruscamente. Il costone è<br />
caratterizzato da pareti subverticali incise da canaloni profon<strong>di</strong>; più a valle, dove affiorano le argille, il<br />
pen<strong>di</strong>o <strong>di</strong>venta più dolce e l’idrografia superficiale sviluppa tipiche forme calanchive (Figura 4.22 e Figura<br />
4.23).<br />
4.3.3 Caratterizzazione geomorfologica<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista geomorfologico il territorio interessato dall’area in istanza presenta una morfologia<br />
mista tra montuosa e collinare dal profilo moderatamente aspro, influenzata dalle caratteristiche del<br />
substrato e dall’attività erosiva delle acque superficiali. In concomitanza <strong>di</strong> eventi piovosi <strong>di</strong> una certa<br />
intensità, laddove affiorano rocce con una permeabilità limitata e le acque hanno un tempo <strong>di</strong> infiltrazione<br />
nel suolo molto elevato, i fenomeni erosivi risultano molto intensi incidendo profondamente i versanti.<br />
L’analisi <strong>di</strong> immagini da satellite ha permesso <strong>di</strong> identificare una serie <strong>di</strong> lineamenti con <strong>di</strong>rezione SO-NE ed<br />
altri con <strong>di</strong>rezione NO-SE, parallela all’andamento del fronte delle coltri appenniniche nell’Avanfossa.<br />
Ambedue le serie <strong>di</strong> lineamenti si riflettono sull’andamento del reticolo idrografico il cui pattern è marcato<br />
da un forte controllo strutturale. In particolare l'interpretazione aerofotogeologica e la ricostruzione<br />
geometrica delle formazioni geologiche affioranti nell’area <strong>di</strong> Montescaglioso (settore nord-orientale del<br />
blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o), hanno reso ipotizzabile la presenza <strong>di</strong> una lineazione tettonica con andamento<br />
appenninico che correndo alla base del Colle Vetere, in prossimità della frana <strong>di</strong> Madonna della Nuova,<br />
prosegue verso sud-est inserendosi nella valle <strong>di</strong> località Pozzo Caselle. A tutte le varie fasi se<strong>di</strong>mentarie<br />
me<strong>di</strong>o pleistoceniche corrispondono fasi evolutive geomorfologiche che hanno prodotto nel tempo la<br />
parziale demolizione del terrazzo <strong>di</strong> Montescaglioso con la formazione delle scarpate che delimitano<br />
l’attuale valle del fiume Bradano. L’osservazione <strong>di</strong> immagini da foto aeree e da satellite consente <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare, nell’ambito della collina <strong>di</strong> Montescaglioso, <strong>di</strong>verse scarpate morfologiche, originatesi a seguito<br />
<strong>di</strong> processi gravitativi, alcune delle quali oramai ridotte a semplici relitti appena accennati. L’assetto<br />
morfologico della collina <strong>di</strong> Montescaglioso, caratterizzata da un terrazzo morfologico i cui bor<strong>di</strong><br />
corrispondono a lineamenti morfologici riconducibili a gran<strong>di</strong> frane relitte, innescatesi in sistemi<br />
morfoclimatici <strong>di</strong>versi da quello attuale, è caratteristico <strong>di</strong> gran parte delle colline tabulari presenti nell’area<br />
bradanica. Tutto il bordo del terrazzo è con<strong>di</strong>zionato da forme concave, riferibili ad aree evolutesi a seguito<br />
<strong>di</strong> antichi fenomeni franosi, all’interno delle quali si è impostato e sviluppato un reticolo idrografico<br />
caratterizzato da una elevata capacità erosiva che ha dato luogo a profon<strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> erosione lineare.<br />
4.3.3.1 I calanchi<br />
L'azione degli agenti idrometeorici su terreni ad elevata componente argillosa produce caratteristiche<br />
manifestazioni geomorfologiche conosciute con il nome <strong>di</strong> calanchi. I calanchi occupano circa un terzo del<br />
territorio regionale e sono definiti come forme <strong>di</strong> erosione superficiale lineare veloce. Le forme a calanchi in<br />
genere interessano i versanti argillosi esposti a sud essendo il frutto dell'azione combinata del sole e<br />
dell'acqua piovana. Il sole essicca lo strato argilloso superficiale e determina la formazione <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong><br />
fessure all'interno delle quali la circolazione dell'acqua piovana provoca erosione. Questo processo porta<br />
alla formazione <strong>di</strong> piccoli rivoli che <strong>di</strong>ventano vallecole per poi evolvere a fossi calanchivi più o meno ampi<br />
separati da stretti <strong>di</strong>spluvi. I versanti esposti a nord sono meno soggetti all'erosione in calanchi ed in genere<br />
ospitano prati -pascoli, boschi, oliveti, seminativi, etc.<br />
In Basilicata il fenomeno calanchivo è ben evidente nei depositi plio-pleistocenici dell'Avanfossa Bradanica,<br />
del Bacino <strong>di</strong> Sant'Arcangelo e degli altri bacini intrappenninici presenti in regione. Reticoli calanchivi<br />
interessano depositi lacustri del Pleistocene, facies argillose del Flysch <strong>di</strong> Gorgoglione e <strong>di</strong> Albidona, le<br />
Argille Varicolori e le Crete Nere. Le aree calanchive della Basilicata ospitano una notevole varietà <strong>di</strong><br />
76
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
fitocenosi tra loro <strong>di</strong>fferenziate da fattori fisici quali substrato geologico, esposizione del versante,<br />
con<strong>di</strong>zioni climatiche ed altitu<strong>di</strong>ne. Su queste forme d'erosione si rinvengono sia tipologie a carattere<br />
endemico, sia aspetti <strong>di</strong> vegetazione comuni ad analoghi contesti geomorfologici dell'Italia centromeri<strong>di</strong>onale.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni fisiche <strong>di</strong> questi ambienti sono sempre particolarmente selettive e le specie<br />
vegetali sono adatte a sopravvivere a stress termici e idrici, a svilupparsi su substrati in quasi totale assenza<br />
<strong>di</strong> pedogenesi, accelerata erosione e presenza <strong>di</strong> sali so<strong>di</strong>ci.<br />
Figura 4.22 – Versanti calanchivi presenti all’interno dell’area in istanza “La Capriola”<br />
Figura 4.23 – Formazioni <strong>di</strong> calanchi sui rilievi argillosi presenti nel settore orientale del blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
77
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Il recupero ambientale <strong>di</strong> queste aree con interventi <strong>di</strong> riforestazione è sicuramente vincolato alla<br />
conoscenza, oltre che delle caratteristiche geo-pedologiche, anche <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori biologici, quali le<br />
associazioni vegetali caratteristiche <strong>di</strong> questi contesti ambientali alle quali partecipano specie con<br />
adattamenti morfofisiologici selezionati proprio dalle <strong>di</strong>fficili con<strong>di</strong>zioni fisiche.<br />
La presenza e l'impianto <strong>di</strong> tali specie consente <strong>di</strong> limitare il fenomeno erosivo ed in molti casi <strong>di</strong> invertire la<br />
tendenza accelerando il recupero da un punto <strong>di</strong> vista pedologico e <strong>di</strong> copertura della vegetazione che si<br />
afferma gradualmente verso sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> maggiore evoluzione apportando <strong>di</strong> conseguenza un notevole<br />
miglioramento anche nella stabilità dei versanti.<br />
4.3.4 Caratterizzazione del suolo<br />
La Carta Pedologica generale della <strong>Regione</strong> Basilicata in scala 1:250.000, realizzata nell’ambito del<br />
Programma Interregionale “agricoltura e qualità”, costituisce il primo inventario dei suoli della <strong>Regione</strong><br />
Basilicata ed una prima sintesi a livello regionale delle informazioni pedologiche ad oggi <strong>di</strong>sponibili. Si tratta<br />
<strong>di</strong> un documento che descrive i suoli come corpi naturali, nell’insieme degli strati o orizzonti che li<br />
compongono (Figura 4.24).<br />
Figura 4.24 - Particolare della carta pedologica generale della <strong>Regione</strong> Basilicata relativa al blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
Dalla consultazione della suddetta carta, si osserva che nell’area interessata dalla prospezione sono presenti<br />
le seguenti province pedologiche:<br />
11.4, 12.3, 12.4, 14.9, 14.12, 15.1; 15.2, 15.3.<br />
Tali province pedologiche vengono dettagliatamente descritte nella seguente tabella:<br />
78
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Provincia pedologica 11 - Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche della fossa bradanica<br />
Suoli dei versanti interessati da antichi movimenti <strong>di</strong> massa, con scarpate ripide e<br />
frastagliate verso monte, nelle quali affiora il substrato. Nelle aree <strong>di</strong> accumulo i<br />
versanti si presentano lineari, poco ondulati. Le pendenze sono molto variabili, da<br />
deboli a forti; mentre la classe più frequente è probabilmente la moderata. Le<br />
quote vanno da 100 a 580 m s.l.m. L'unità, costituita da 7 delineazioni, ha una<br />
Paesaggio<br />
superficie totale <strong>di</strong> 9.090 ha. L'utilizzazione del suolo prevalente è agricola<br />
(seminativi, oliveti); in via subor<strong>di</strong>nata, nei versanti più ripi<strong>di</strong>, vi sono aree a<br />
vegetazione naturale, essenzialmente arbustiva ed erbacea. Sono presenti suoli <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verso grado evolutivo: suoli a profilo <strong>di</strong>fferenziato per rimozione dei carbonati,<br />
lisciviazione, melanizzazione (suoli Pomarico), suoli moderatamente evoluti per<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati e melanizzazione (suoli Concone), e suoli con<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati iniziale e brunificazione (suoli Timmari).<br />
Suoli Pomarico<br />
Questi suoli hanno un epipedon mollico con un contenuto in sostanza organica da<br />
moderato a buono, al <strong>di</strong> sotto del quale sono presenti orizzonti argillici <strong>di</strong><br />
spessore e grado <strong>di</strong> espressione variabili. Sono suoli molto scarsamente calcarei, e<br />
non vi sono in genere orizzonti calcici entro i primi 2 metri <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà. Sono<br />
molto profon<strong>di</strong>, a tessitura argilloso sabbiosa e scheletro da scarso ad assente. La<br />
reazione è neutra in superficie e subacida in profon<strong>di</strong>tà, ed il tasso <strong>di</strong> saturazione<br />
in basi è alto. Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio me<strong>di</strong>ocre.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Argixerolls fine, mixed, semiactive, thermic.<br />
11.4<br />
Classificazione WRB: Chromi-Luvic Phaeozems.<br />
Suoli Concone<br />
Suoli profon<strong>di</strong>, hanno un epipedon mollico con un contenuto moderato in<br />
sostanza organica, e presentano uno o più orizzonti calcici entro il metro e mezzo<br />
<strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà. Sono suoli moderatamente calcarei in superficie, molto calcarei in<br />
Suoli<br />
Principali<br />
profon<strong>di</strong>tà. La tessitura è franco sabbioso argillosa in superficie e franco argillosa<br />
in profon<strong>di</strong>tà, e lo scheletro è scarso o assente. Hanno reazione alcalina, alto<br />
tasso <strong>di</strong> saturazione in basi, permeabilità moderatamente bassa ed drenaggio<br />
me<strong>di</strong>ocre.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixerolls fine loamy, mixed, active,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcaric Phaeozems.<br />
Suoli Timmari<br />
Sono profon<strong>di</strong>, moderatamente evoluti, con un orizzonte cambico <strong>di</strong> spessore<br />
moderato (30-50 cm) sovrastante substrati sabbiosi. Franco sabbiosi in superficie<br />
e sabbiosi in profon<strong>di</strong>tà, hanno scheletro scarso o assente. Sono molto calcarei in<br />
tutto il profilo, talora moderatamente calcarei negli orizzonti superficiali, hanno<br />
reazione alcalina in superficie e molto alcalina in profon<strong>di</strong>tà e alta saturazione in<br />
basi. La permeabilità è alta e il drenaggio buono.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed,<br />
superactive, thermic.<br />
Classificazione WRB: Eutric Cambisols.<br />
Provincia pedologica 12 - Suoli delle colline argillose<br />
Suoli delle aree a morfologia complessa, caratterizzate dall'alternanza, spesso<br />
secondo una successione a cuestas, <strong>di</strong> versanti da sub-pianeggianti a<br />
moderatamente acclivi, e <strong>di</strong> versanti da acclivi a scoscesi, caratterizzati dalla<br />
12.3 Paesaggio notevole <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> calanchi. I materiali <strong>di</strong> partenza sono depositi marini<br />
argillosi e argilloso-limosi, prevalentemente pliocenici (Argille marnose<br />
grigioazzurre); su superfici limitate possono essere presenti depositi alluvionali<br />
sabbioso-limosi. Le quote sono comprese tra 20 e 750 m s.l.m. L'unità è costituita<br />
79
Suoli<br />
Principali<br />
12.4 Paesaggio<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
da 9 delineazioni, e ha una superficie complessiva <strong>di</strong> 51.590 ha. L'uso del suolo è<br />
caratterizzato dall'alternanza <strong>di</strong> aree agricole, in prevalenza seminativi, e <strong>di</strong><br />
vegetazione naturale per lo più arbustiva ed erbacea. Nelle aree a calanchi, in<br />
gran parte denudate, affiora <strong>di</strong>rettamente il substrato. Sui versanti subpianeggianti<br />
o moderatamente acclivi, o comunque meno erosi, si sono formati<br />
suoli con pronunciati caratteri vertici. Di questi, i più <strong>di</strong>ffusi sono i suoli<br />
Elemosina, che hanno profilo moderatamente <strong>di</strong>fferenziato per iniziale<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati e brunificazione; sulle superfici più stabili si sono<br />
formati i suoli Scelzi, che presentano una più marcata ri<strong>di</strong>stribuzione dei<br />
carbonati, con formazione <strong>di</strong> un orizzonte calcico poco profondo. Suoli con<br />
orizzonte calcico, ma privi <strong>di</strong> caratteri vertici, sono i suoli La Piana, che<br />
caratterizzano aree pianeggianti, in posizione sommitale e <strong>di</strong> estensione limitata,<br />
con depositi <strong>di</strong> origine alluvionale. Altri suoli moderatamente evoluti e privi <strong>di</strong><br />
caratteri vertici sono i suoli Panzaniella, presenti su versanti caratterizzati da<br />
materiali <strong>di</strong> partenza più sabbiosi, per variazioni all'interno del substrato o per<br />
apporti colluviali. Anche questi suoli sono poco <strong>di</strong>ffusi. Nelle aree più erose, in<br />
genere in corrispondenza dei versanti più ripi<strong>di</strong> e a calanchi, sono presenti suoli<br />
poco evoluti, con profilo scarsamente <strong>di</strong>fferenziato (suoli Murgine). Questi suoli<br />
sono molto <strong>di</strong>ffusi, e sono in genere associati ad aree denudate, dove affiora<br />
<strong>di</strong>rettamente il substrato.<br />
Suoli Murgine<br />
Suoli poco evoluti, sottili o moderatamente profon<strong>di</strong> per la presenza del substrato<br />
compatto. Sono molto calcarei, hanno tessitura argillosa e sono privi <strong>di</strong> scheletro.<br />
Hanno reazione alcalina o molto alcalina. Il loro drenaggio è buono, per effetto <strong>di</strong><br />
un favorevole drenaggio esterno, la permeabilità bassa.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerorthents fine, mixed, calcareous, active,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcaric Regosols.<br />
Suoli Scelzi<br />
Suoli con marcati caratteri vertici, con fessure che nella maggior parte degli anni<br />
sono aperte per più <strong>di</strong> 6 mesi, molto profon<strong>di</strong>, con orizzonte calcico superficiale.<br />
Argillosi e privi <strong>di</strong> scheletro, sono molto calcarei e a reazione alcalina in superficie,<br />
molto alcalina in profon<strong>di</strong>tà. Hanno permeabilità molto bassa; il loro drenaggio è<br />
me<strong>di</strong>ocre, talora lento nei perio<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>, buono nei perio<strong>di</strong> secchi.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Ari<strong>di</strong>c Calcixererts fine, mixed, active, thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcic Vertisols.<br />
Suoli degli ampi versanti a pendenze elevate (in prevalenza acclivi o molto acclivi),<br />
modellati da un'intensa erosione superficiale con formazione <strong>di</strong> estese superfici<br />
<strong>di</strong>ssestate a calanchi. Il substrato è costituito da limi e argille con caratteristiche<br />
concrezioni <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio biancastre (Argille calcigne), e argille limose<br />
(Argille grigioazzurre). La fascia altimetrica è molto ampia, da 20 a 770 m s.l.m.<br />
L'unità ha 7 delineazioni e una superficie totale <strong>di</strong> 30.608 ha. L'uso del suolo<br />
prevalente è dato da aree a vegetazione naturale, per lo più erbacea e arbustiva,<br />
spesso pascolate. Le aree agricole sono costituite da seminativi avvicendati. Nei<br />
versanti meno acclivi, più stabili, coltivati o a pascolo, sono <strong>di</strong>ffusi suoli a profilo<br />
moderatamente <strong>di</strong>fferenziato per iniziale ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati e<br />
brunificazione, con moderati caratteri vertici (suoli Barletta). Nei versanti più<br />
acclivi o più erosi i suoli sono a profilo scarsamente <strong>di</strong>fferenziato (suoli Murgine).<br />
Molto <strong>di</strong>ffuse sono le aree denudate, nelle quali affiora <strong>di</strong>rettamente il substrato<br />
argilloso poco alterato. Nel fondo delle incisioni del fitto reticolo idrografico sono<br />
presenti, anche se occupano superfici molto limitate, depositi alluvio-colluviali sui<br />
quali si sono sviluppati suoli poco evoluti (suoli Pecoriello).<br />
80
14.9<br />
Suoli<br />
principali<br />
Paesaggio<br />
Suoli<br />
Principali<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Suoli Barletta<br />
Suoli con moderati caratteri vertici, sono moderatamente profon<strong>di</strong> o profon<strong>di</strong>,<br />
limitati dal substrato compatto. Hanno tessitura argilloso limosa e sono privi <strong>di</strong><br />
scheletro, molto calcarei e molto alcalini. Il loro drenaggio è buono, talora<br />
me<strong>di</strong>ocre, ed è favorito dal buon drenaggio esterno; la permeabilità è bassa.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Vertic Haploxerepts fine, mixed, active, thermic.<br />
Classificazione WRB: Eutri-Vertic Cambisols.<br />
Suoli Murgine<br />
Suoli poco evoluti, sottili o moderatamente profon<strong>di</strong> per la presenza del substrato<br />
compatto. Sono molto calcarei, hanno tessitura argillosa e sono privi <strong>di</strong> scheletro.<br />
Hanno reazione alcalina o molto alcalina. Il loro drenaggio è buono, per effetto <strong>di</strong><br />
un favorevole drenaggio esterno, la permeabilità bassa.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerorthents fine, mixed, calcareous, active,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcaric Regosols.<br />
Provincia pedologica 14 - Suoli delle pianure alluvionali<br />
Suoli dei fondovalle alluvionali, compresi tra i terrazzi più antichi o i versanti e le<br />
aree più inondabili limitrofe ai corsi d'acqua. Riguardano le incisioni vallive e i<br />
fon<strong>di</strong> valle dei principali fiumi tributari dello Ionio (Sarmento, Sinni, Agri, Cavone,<br />
Basento, Bradano), con aree a morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante<br />
caratterizzate da depositi alluvionali a granulometria variabile, comprendenti<br />
superfici alluvionali recenti, spesso lievemente terrazzate, coni alluvionali, fasce<br />
<strong>di</strong> colluvi alla base dei versanti, terrazzi più bassi. I se<strong>di</strong>menti che le hanno<br />
originate sono <strong>di</strong> varia natura e composizione, in quanto sono provenienti sia<br />
dalle alluvioni del fiume principale, che da apporti più locali, <strong>di</strong> torrenti e fossi che<br />
affluiscono nella valle dai versanti soprastanti, sia <strong>di</strong> materiale colluviale, eroso<br />
dalle pen<strong>di</strong>ci. Le quote variano dal livello del mare fino a 490 m s.l.m. L'unità ha<br />
65 delineazioni, per una superficie totale <strong>di</strong> 38.720 ha. Queste aree sono in gran<br />
parte agricole: le aree più rilevate ospitano vigneti e oliveti, mentre le superfici<br />
servite da canali <strong>di</strong> irrigazione sono intensamente coltivate (in genere a ortaggi). I<br />
suoli più <strong>di</strong>ffusi hanno profilo poco <strong>di</strong>fferenziato, per brunificazione e iniziale<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati (suoli Servino e Rivolta). Gli altri suoli elencati<br />
coprono superfici relativamente ridotte, se si considera l'unità cartografica nel<br />
suo complesso, anche se localmente possono interessare superfici significative. I<br />
suoli Manicone, che hanno profilo moderatamente <strong>di</strong>fferenziato per<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati con formazione <strong>di</strong> orizzonti calcici profon<strong>di</strong>, si sono<br />
sviluppati sulle superfici relativamente, più antiche. In aree caratterizzate dalla<br />
presenza <strong>di</strong> una falda che interessa il suolo, sono presenti suoli con gra<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> gleificazione: i suoli Tre Confini si rinvengono in aree con falda<br />
temporanea, i suoli Serrapotamo in aree con falda permanente. Nei tratti<br />
terminali delle valli, presso lo sbocco nella piana costiera, sono <strong>di</strong>ffusi suoli a<br />
evoluzione iniziale (suoli L'Arbusto). A proposito dei sopra citati suoli<br />
Serrapotamo, è da segnalare che è su questi suoli che tra<strong>di</strong>zionalmente viene<br />
coltivato il peperone <strong>di</strong> Senise.<br />
Suoli Servino<br />
Sono suoli molto profon<strong>di</strong>, a tessitura variabile, al confine tra le classi<br />
granulometriche fine loamy e coarse loamy: franchi o franco sabbiosi in<br />
superficie, hanno spesso tessitura più fine in profon<strong>di</strong>tà, e sono privi <strong>di</strong> scheletro.<br />
Da molto a scarsamente calcarei, hanno reazione da alcalina ad estremamente<br />
alcalina, sono ben drenati e a permeabilità moderatamente alta. Sulle superfici<br />
più recenti, l'orizzonte cambico non è sufficientemente espresso, e questi suoli<br />
sono da attribuire al grande gruppo degli Xerofluvents. In altri casi, hanno<br />
81
14.12<br />
Paesaggio<br />
Suoli<br />
principali<br />
15.1 Paesaggio<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
granulometria più sabbiosa o ciottolosa (varianti degli Xeropsamments e della<br />
famiglia loamy skeletal).<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Fluventic Haploxerepts fine loamy, mixed,<br />
superactive, thermic.<br />
Classificazione WRB: Eutri-Fluvic Cambisols.<br />
Suoli Rivolta<br />
Suoli molto profon<strong>di</strong>, sono <strong>di</strong>ffusi principalmente nei tratti me<strong>di</strong>o e terminale dei<br />
fiumi ionici. Privi <strong>di</strong> scheletro, hanno tessitura franco limosa, drenaggio da buono<br />
a me<strong>di</strong>ocre e permeabilità moderatamente alta. Sono molto calcarei e molto<br />
alcalini in tutti gli orizzonti.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine silty, mixed, active,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcaric Cambisols.<br />
Suoli delle superfici a<strong>di</strong>acenti ai corsi d'acqua, facilmente inondabili nel corso<br />
degli eventi <strong>di</strong> piena, a meno che non siano protetti da argini. Comprendono gli<br />
ampi greti dei fiumi principali e delle fiumare minori, privi <strong>di</strong> vegetazione o con<br />
vegetazione naturale <strong>di</strong> ripa e <strong>di</strong> greto, e limitate aree a<strong>di</strong>acenti, in genere<br />
protette da argini, coltivate (colture arboree specializzate, colture orticole,<br />
seminativi). I materiali <strong>di</strong> partenza sono costituiti da depositi alluvionali ciottolosi<br />
e sabbiosi, con scarsa presenza delle frazioni limose e argillose. La morfologia è<br />
pianeggiante e le quote vanno da 0 a 775 m s.l.m. L'unità è costituita da 7<br />
delineazioni, e interessa una superficie complessiva <strong>di</strong> 20.616 ha. Sono suoli a<br />
profilo poco <strong>di</strong>fferenziato. I suoli Agri sono ampiamente <strong>di</strong>ffusi, i suoli Macristasi<br />
caratterizzano le aree in posizione <strong>di</strong>stale rispetto ai greti attuali, e sono talora<br />
coltivati.<br />
Suoli Agri<br />
Suoli poco evoluti, molto profon<strong>di</strong>, franco sabbiosi in superficie, sabbiosi in<br />
profon<strong>di</strong>tà, con scheletro abbondante, talora frequente in superficie. Sono molto<br />
calcarei e alcalini, e presentano un drenaggio rapido e una permeabilità alta.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerorthents sandy skeletal, mixed, thermic.<br />
Classificazione WRB: Endoskeleti-Calcaric Regosols.<br />
Suoli Macristasi<br />
Suoli poco evoluti caratterizzati da un minore contenuto in scheletro rispetto ai<br />
suoli Agri, da assente a comune. Molto profon<strong>di</strong>, hanno tessitura da franca a<br />
franco sabbiosa, drenaggio rapido e permeabilità moderatamente alta. Sono<br />
moderatamente calcarei e alcalini in superficie, molto calcarei e molto alcalini nel<br />
substrato.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerofluvents coarse loamy, mixed,<br />
calcareous, superactive, thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcaric Fluvisols.<br />
Provincia pedologica 15 - Suoli dei rilievi interni occidentali<br />
I suoli <strong>di</strong> questa unità si sono formati su superfici, in parte conservate e in parte<br />
erose e smantellate, appartenenti ai terrazzi marini posti alle quote più elevate.<br />
Hanno morfologia variabile, caratterizzata da aree da pianeggianti a debolmente<br />
acclivi, alternate a profonde e ampie incisioni (da moderatamente acclivi a molto<br />
acclivi, con scarpate talora scoscese), molto frequenti, corrispondenti al reticolo<br />
idrografico minore. Il substrato è costituito da sabbie con lenti <strong>di</strong> ghiaie e ciottoli<br />
calcarei, e depositi colluviali e alluvionali. Le quote sono comprese tra 40 e 330 m<br />
s.l.m. E' composta da 6 delineazioni, che coprono una superficie totale <strong>di</strong> 12.275<br />
ha. L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi, oliveti e vigneti; nelle scarpate<br />
più ripide delle incisioni è presente vegetazione naturale, prevalentemente<br />
arbustiva. Accanto a suoli molto evoluti, con forte <strong>di</strong>fferenziazione del profilo per<br />
82
Suoli<br />
Principali<br />
15.2 Paesaggio<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
effetto <strong>di</strong> cicli pedogenetici <strong>di</strong> intensità <strong>di</strong>versa (attraverso processi <strong>di</strong><br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati, lisciviazione e rubefazione), talora conservati e<br />
spesso troncati dall'erosione, sono presenti suoli moderatamente evoluti, con<br />
minore <strong>di</strong>fferenziazione del profilo (per moderata ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati, e<br />
brunificazione). Molti suoli conservano un orizzonte superficiale <strong>di</strong> colore scuro<br />
(epipedon mollico), formatosi attraverso il processo della melanizzazione. I suoli<br />
Tempa Rossa e Gaudella sono presenti sulle superfici più conservate dei terrazzi, i<br />
suoli Scarciullo caratterizzano le ampie e profonde incisioni.<br />
Suoli Tempa Rossa con orizzonte calcico profondo<br />
Suoli molto evoluti e molto profon<strong>di</strong>, hanno un epipedon mollico con moderato<br />
contenuto in sostanza organica, tessitura franco sabbiosa in superficie e argillosa<br />
in profon<strong>di</strong>tà, scheletro comune o frequente. Sono il risultato <strong>di</strong> una evoluzione<br />
policiclica, che ha portato allo sviluppo <strong>di</strong> orizzonti <strong>di</strong> accumulo secondario <strong>di</strong><br />
carbonato <strong>di</strong> calcio a profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>verse. Sono decarbonatati in superficie e molto<br />
calcarei in profon<strong>di</strong>tà, e hanno reazione da neutra a molto alcalina. Alcuni<br />
orizzonti possono essere talora moderatamente so<strong>di</strong>ci. Hanno permeabilità<br />
moderatamente bassa e sono ben drenati.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Argixerolls fine, mixed, active, thermic.<br />
Classificazione WRB: Chromi-Luvic Phaeozems.<br />
Suoli Tempa Rossa con orizzonte calcico moderatamente profondo<br />
Simili ai suoli precedenti, questi suoli hanno un orizzonte calcico a moderata<br />
profon<strong>di</strong>tà, probabilmente a causa <strong>di</strong> erosioni pregresse. Hanno tessitura franco<br />
sabbioso argillosa in superficie, argillosa nell'orizzonte argillico, e<br />
progressivamente più sabbiosa in profon<strong>di</strong>tà, scheletro assente o comune. La loro<br />
reazione è alcalina in superficie, molto alcalina in profon<strong>di</strong>tà.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Calcic Argixerolls fine, mixed, active, thermic.<br />
Classificazione WRB: Chromi-Luvic Kastanozems.<br />
Suoli Gaudella<br />
Suoli molto profon<strong>di</strong>, a tessitura franco sabbiosa in superficie e franco sabbioso<br />
argillosa in profon<strong>di</strong>tà, con scheletro assente in superficie, da scarso a frequente<br />
in profon<strong>di</strong>tà. Sono privi <strong>di</strong> carbonati in superficie e scarsamente o<br />
moderatamente calcarei in profon<strong>di</strong>tà. Subaci<strong>di</strong> o neutri in superficie, hanno<br />
reazione crescente in profon<strong>di</strong>tà, fino ad alcalina. La saturazione in basi è sempre<br />
alta. Hanno permeabilità moderatamente bassa e sono ben drenati.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, semiactive,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Chromic Luvisols.<br />
Suoli Scarciullo<br />
Diffusi all'interno delle incisioni dei terrazzi, caratterizzano superfici a pendenze<br />
deboli o moderate (10-20%). Sono molto profon<strong>di</strong>, a tessitura franco sabbioso<br />
argillosa in superficie e franco sabbiosa in profon<strong>di</strong>tà, con scheletro scarso. Da<br />
scarsamente a moderatamente calcarei, hanno reazione molto alcalina,<br />
permeabilità moderatamente alta e sono ben drenati.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Eutric Cambisols.<br />
Suoli su superfici pianeggianti o sub-pianeggianti, che <strong>di</strong>ventano da debolmente<br />
acclivi ad acclivi in corrispondenza <strong>di</strong> alcune incisioni del reticolo idrografico<br />
minore. I materiali <strong>di</strong> partenza sono costituiti da sabbie con lenti <strong>di</strong> ghiaie e<br />
ciottoli calcarei, e talora depositi colluviali e alluvionali. Le quote sono comprese<br />
tra i 20 e i 220 m s.l.m. L'unità è costituita da 5 delineazioni, per una superficie<br />
totale <strong>di</strong> 12.635 ha. L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi, oliveti e vigneti.<br />
83
15.3<br />
Suoli<br />
Principali<br />
Paesaggio<br />
Suoli<br />
Principali<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Solo sui versanti più ripi<strong>di</strong> delle incisioni è presente vegetazione naturale, per lo<br />
più arbustiva. Sono suoli a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione del profilo. Accanto a<br />
suoli evoluti (per ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati, lisciviazione dell'argilla e<br />
rubefazione), sono presenti suoli a profilo meno <strong>di</strong>fferenziato (per ri<strong>di</strong>stribuzione<br />
dei carbonati, con una parziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali, e<br />
brunificazione). In molti casi si è conservato un orizzonte superficiale <strong>di</strong> colore<br />
scuro (epipedon mollico). I suoli Campagnola e Pezzica sono presenti su ampie<br />
superfici. I primi in<strong>di</strong>viduano le aree più conservate, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
morfologico, mentre i secon<strong>di</strong> caratterizzano le aree che hanno subito fenomeni<br />
<strong>di</strong> erosione superficiale con asportazione dei suoli originari.<br />
Suoli Pezzica<br />
Suoli profon<strong>di</strong>, a tessitura franco sabbioso argillosa in superficie e argillosa in<br />
profon<strong>di</strong>tà, con scheletro scarso o comune. Sono moderatamente calcarei in<br />
superficie e fortemente calcarei in profon<strong>di</strong>tà, e hanno reazione alcalina. Possono<br />
presentare, in profon<strong>di</strong>tà, eccesso <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o nel complesso <strong>di</strong> scambio. La loro<br />
permeabilità è moderatamente bassa, il drenaggio me<strong>di</strong>ocre.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixerepts fine loamy, mixed, active,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Hyposo<strong>di</strong>c Calcisols.<br />
Questi suoli frequentemente presentano un epipedon mollico, e rientrano nel<br />
sottogruppo dei Typic Calcixerolls.<br />
I suoli <strong>di</strong> questa unità si sono sviluppati su superfici pianeggianti e ben<br />
conservate, talora debolmente o moderatamente acclivi, dei terrazzi marini,<br />
localmente interessate da depositi alluvionali e colluviali <strong>di</strong> modesto spessore, e<br />
con alcune profonde incisioni dovute al reticolo idrografico secondario. I materiali<br />
<strong>di</strong> partenza sono sabbie con lenti <strong>di</strong> ghiaie e ciottoli calcarei. Le quote sono<br />
comprese tra i 10 e i 140 m s.l.m. E' costituita da 8 delineazioni, per una<br />
superficie complessiva <strong>di</strong> 9.110 ha. L'uso del suolo è agricolo: predominano i<br />
seminativi, con presenza <strong>di</strong> frutteti, oliveti e vigneti. Sono suoli a <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong><br />
evoluzione. Sono presenti suoli a profilo molto evoluto, con <strong>di</strong>fferenziazione<br />
marcata degli orizzonti per effetto della ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati, della<br />
lisciviazione dell'argilla e della rubefazione. Questi suoli hanno orizzonti profon<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> accumulo secondario dei carbonati (orizzonti calcici) e dell'argilla illuviale<br />
(orizzonti argillici). In altri suoli, l'evoluzione è meno pronunciata e si limita alla<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei carbonati (con una parziale decarbonatazione degli orizzonti<br />
superficiali) e alla brunificazione. In alcuni casi si è conservato un orizzonte<br />
superficiale <strong>di</strong> colore scuro (epipedon mollico). Nei suoli irrigati dei terrazzi più<br />
bassi, talora, gli orizzonti superficiali sono leggermente salini. I suoli Tarantone si<br />
sono sviluppati soprattutto nelle aree più pianeggianti e conservate, mentre nelle<br />
aree a maggiore pendenza sono più <strong>di</strong>ffusi i suoli Pezzica e La Petrulla. Sono<br />
presenti, anche se interessano superfici ridotte, i suoli Scanzano, Olivastreto e San<br />
Basilio.<br />
Suoli Tarantone con orizzonte calcico moderatamente profondo<br />
Suoli profon<strong>di</strong>, a substrato sabbioso-scheletrico, con un orizzonte argillico che<br />
sovrasta un orizzonte calcico entro 1 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà. La tessitura è franca in<br />
superficie e franco argillosa o franco limoso argillosa nell'orizzonte argillico, lo<br />
scheletro scarso o assente. Il drenaggio è buono, la permeabilità me<strong>di</strong>a. Possono<br />
presentare, al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> 150 cm <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, un orizzonte petrocalcico che<br />
cementa gli strati <strong>di</strong> ciottoli del substrato. Hanno reazione alcalina in superficie,<br />
molto alcalina in profon<strong>di</strong>tà. Completamente decarbonatati nei primi orizzonti,<br />
sono molto calcarei in profon<strong>di</strong>tà.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Calcic Haploxeralfs fine silty, mixed, semiactive,<br />
84
4.3.5 Uso del suolo<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Calcic Luvisols.<br />
Suoli Tarantone con orizzonte calcico profondo o molto profondo<br />
Simili ai precedenti, ne costituiscono un termine probabilmente più conservato;<br />
l'orizzonte calcico si rinviene a profon<strong>di</strong>tà superiore al metro dalla superficie.<br />
Hanno tessitura franco argillosa nell'orizzonte argillico.<br />
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxeralfs fine loamy, mixed, semiactive,<br />
thermic.<br />
Classificazione WRB: Haplic Luvisols.<br />
Suoli Pezzica<br />
Per la loro descrizione si veda l’unità 15.2<br />
Il territorio interessato dall’area in istanza presenta modeste caratteristiche <strong>di</strong> sviluppo e in cui si<br />
evidenzia la presenza <strong>di</strong> un unico settore trainante in<strong>di</strong>viduato nel settore agricolo. Le principali<br />
produzioni e le relative specializzazioni riguardano le coltivazioni cerealicole e l’olivicoltura. Il restante<br />
territorio montano e collinare presenta un tipo <strong>di</strong> agricoltura tra<strong>di</strong>zionale ed estensiva, basata sulla<br />
pastorizia (Figura 4.25).<br />
Notevole, la presenza <strong>di</strong> aziende convertite al biologico che sono presenti per il 44% nella Provincia <strong>di</strong><br />
Potenza e per il 56% in quella <strong>di</strong> Matera. La maggiore frequenza <strong>di</strong> tali aziende si riscontra nei Comuni <strong>di</strong><br />
Matera, Pisticci, Ferran<strong>di</strong>na, Montescaglioso, Bernalda, nella montagna interna da Corleto Perticara a<br />
Bella e lungo il bordo settentrionale lucano.<br />
Figura 4.25 - Estratto dalla Corine Land Cover dell’uso del suolo; in nero l’area dell’istanza “La Capriola”<br />
85
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Nel dettaglio, dall’analisi dell’uso del suolo riportato in Figura 4.25, estratto dalla Corine Land Cover, emerge<br />
che:<br />
l’areale maggiormente riportato è riferito a settori <strong>di</strong> territorio destinati a “seminativi in aree non<br />
irrigue” (colore viola); la sua <strong>di</strong>stribuzione è pressocchè totale all’interno del blocco da est a ovest;<br />
buona parte dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso è de<strong>di</strong>cata alla presenza <strong>di</strong> “uliveti” (colore blu);<br />
queste aree riguardano principalmente il settore meri<strong>di</strong>onale del blocco laddove la morfologia del<br />
suolo inizia ad addolcirsi;<br />
un’altra porzione significativa del blocco è rappresentata da superfici a “boschi <strong>di</strong> latifoglie” (colore<br />
rosa); queste aree boscate sono principalmente presenti nel settore settentrionale del blocco e<br />
concentrate sui rilievi più significativi presenti all’interno dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;<br />
le “colture annuali associate a colture permanenti” (colore arancione) fanno parte della categoria<br />
delle zone agricole eterogenee che caratterizzano principalmente le zone meri<strong>di</strong>onali del blocco in<br />
vicinaza con le aree ad uliveti visti in precedenza.<br />
Le variazioni più significative in merito all’uso del suolo si osservano nei territori limitrofi ai centri abitati <strong>di</strong><br />
Pisticci e Bernalda:<br />
sono infatti presenti zone a<strong>di</strong>bite ad “attività industriali o commerciali” (colore verde) associate a<br />
“zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea”; ambedue le tipologie sono integrate sul<br />
territorio al “tessuto urbano <strong>di</strong>scontinuo” relativo ai rispettivi centri citta<strong>di</strong>ni.<br />
4.4 Ambiente idrico<br />
4.4.1 Caratterizzazione idrica superficiale<br />
La particolare conformazione della regione coniugata al singolare schema orografico e alla posizione<br />
geografica, conferiscono alla Basilicata un singolare assetto idrografico superficiale.<br />
I maggiori corsi d’acqua della regione, infatti, sfociano nel Mar Ionio e si susseguono procedendo da NE a SO<br />
nell’or<strong>di</strong>ne seguente: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni (Figura 4.26).<br />
Oltre a questi fiumi in Basilicata ricade anche una parte del fiume Ofanto, che sfocia nel Mar Adriatico, i<br />
fiumi Melandro e Platano (affluenti del Sele) e il Noce, che sfociano nel Mar Tirreno. I fiumi Basento, Agri e<br />
Cavone scorrono interamente nel territorio regionale, mentre i fiumi Bradano, Sinni, Noce, Lao, Ofanto e<br />
Sele ricadono in parte nelle regioni limitrofe Puglia, Calabria e Campania.<br />
La rete idrografica pertanto viene sud<strong>di</strong>visa in un totale <strong>di</strong> 8 bacini 3 dei quali a valenza regionale (Basento,<br />
Agri e Cavone), mentre gli altri hanno rilevanza interregionale così come sono stati definiti dall’art. 15 della<br />
Legge 183/89 e dall’art. 1 della Legge Regionale 29/94:<br />
1) Il bacino del fiume Bradano;<br />
2) Il bacino del Sinni-Noce;<br />
3) Il bacino del fiume Sele;<br />
4) Il bacino del fiume Lao;<br />
5) Il bacino del fiume Ofanto.<br />
Quasi tutti i corsi d’acqua sono pressoché paralleli fra loro e hanno inizialmente andamento O-E per poi<br />
piegare verso S-E fino a <strong>di</strong>sporsi perpen<strong>di</strong>colarmente alla linea litoranea del Metapontino. Tutti i corsi<br />
d’acqua della Basilicata hanno carattere prevalentemente torrentizio; anche l’Agri e il Sinni, pur godendo<br />
degli apporti <strong>di</strong> numerose sorgenti e pur essendo caratterizzati da una nevosità maggiore rispetto al<br />
Bradano e al Basento, mostrano un notevole <strong>di</strong>vario tra portate <strong>di</strong> magra e portate <strong>di</strong> piena.<br />
86
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Spostandoci verso valle, l’alveo dei fiumi lucani (soprattutto per il Bradano e per il Basento) tende a formare<br />
ripetuti meandri, con greti larghi, che sono soggetti ad esondazione in occasione dei maggiori eventi <strong>di</strong><br />
piena e ad impaludamenti nella stagione secca.<br />
Figura 4.26 - Principali bacini idrografici della Basilicata; in rosso il perimetro dell’area in istanza <strong>di</strong> permesso<br />
Come evidenziato in Figura 4.26 l’area si stu<strong>di</strong>o ricade a cavallo tra i bacini idrografici del Fiume Bradano a<br />
nord-est, Fiume Basento nel settore centrale e Fiume Cavone nella porzione sud-occidentale.<br />
Di seguito una breve descrizione dei bacini idrografici <strong>di</strong> questi fiumi:<br />
Bacino del fiume Bradano<br />
Il bacino del Fiume Bradano è uno dei maggiori della Basilicata (ha una superficie <strong>di</strong> 2735 km 2 ) ed è il più a<br />
nord <strong>di</strong> tutti quelli lucani. È separato da quello del Basento dai Monti Li Foj, dal Monte Cupolicchio e<br />
percorre una serie <strong>di</strong> vette man mano degradanti verso la pianura fino a sfociare nel Mar Ionio. Presenta<br />
una pendenza me<strong>di</strong>a del 7% e nella zona del Me<strong>di</strong>o Bradano si trovano i sottobacini del Bilioso, del<br />
Basentello, del Gravina e del Fiumicello. In questa zona la pendenza si riduce e, all‘altezza <strong>di</strong> Irsina, la<br />
portata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>viene più consistente. In corrispondenza della <strong>di</strong>ga <strong>di</strong> San Giuliano (Basso Bradano) l‘alveo<br />
si immette in una profonda fossa calcarea detta “gravina“, per poi riacquistare nuovamente la sua fisionomia<br />
fino alla foce. Le formazioni geologiche prevalenti nella parte alta del bacino sono scisti argillosi, argille<br />
scagliose, arenarie eoceniche poco permeabili. Nel me<strong>di</strong>o e basso bacino prevalgono le argille plioceniche<br />
87
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
impermeabili, mentre verso il litorale ionico sono presenti formazioni alluvionali, <strong>di</strong> epoca recente e <strong>di</strong>screta<br />
permeabilità.<br />
Bacino del fiume Basento<br />
Il fiume Basento si sviluppa per 149 km <strong>di</strong> lunghezza ed è il corso d‘acqua più lungo a sud del Volturno. E’ un<br />
tipico corso d‘acqua me<strong>di</strong>terraneo a carattere torrentizio. Presenta una morfologia caratterizzata da zone<br />
montuose e collinari e nella parte terminale è pianeggiante. Il Basento presenta caratteristiche<br />
morfologiche <strong>di</strong>verse lungo il suo percorso. Infatti nella parte iniziale (Alto Basento) scorre tra le rocce<br />
modellate dall‘erosione, attraversa la città <strong>di</strong> Potenza per giungere fino alla confluenza con il Torrente<br />
Camastra (Me<strong>di</strong>o Basento), che rappresenta il maggiore affluente, e in corrispondenza dello Scalo <strong>di</strong><br />
Grassano l‘alveo si espande acquisendo caratteri morfologici alluvionali. Più a valle si giunge nella valle del<br />
Basento (Basso Basento) attraversando la zona industriale <strong>di</strong> Ferran<strong>di</strong>na e Pisticci, per poi giungere in<br />
corrispondenza della foce situata nel comune <strong>di</strong> Bernalda dove, grazie alla realizzazione <strong>di</strong> impianti idrovori<br />
e tramite canali <strong>di</strong> bonifica realizzati negli anni ‘40, si ha il convogliamento delle acque verso il mare. Dal<br />
punto <strong>di</strong> vista geologico le formazioni affioranti sono modeste: si ritrovano rocce permeabilissime come i<br />
calcari madreporici a noduli <strong>di</strong> selce, del trias, calcari compatti cretacei e qualche lembo <strong>di</strong> dolomia.<br />
Bacino del fiume Cavone<br />
Il bacino del fiume Cavone ha un’estensione <strong>di</strong> 648,55 km 2 ed è posizionato tra quello del Basento e quello<br />
dell’Agri. Lo spartiacque meri<strong>di</strong>onale parte dal punto <strong>di</strong> incontro <strong>di</strong> questi tre bacini (Monte dell’Impiso la<br />
cui vetta è a 1310 m s.l.m.) e corre parallelamente al corso d’acqua fino al litorale ionico. Quello<br />
settentrionale, in comune con quello del Basento, ha una forma ad arco nella parte iniziale per poi<br />
proseguire anch’esso parallelamente al fiume fino alla foce. Il fiume Cavone nella parte iniziale prende il<br />
nome <strong>di</strong> Torrente Salandrella ed ha come unico affluente il Torrente Misegna. Essendo caratterizzato da<br />
apporti sorgentizi molto scarsi, il Cavone ha portate <strong>di</strong> magra quasi nulle. La parte alta del bacino è<br />
caratterizzata da formazioni permeabili quali calcari marnosi e arenarie giallastre, mentre la rimanente<br />
parte è costituita da argille plioceniche, argille scagliose e scisti argillosi.<br />
I <strong>di</strong>versi corsi d'acqua sono alimentati oltre che dalle precipitazioni atmosferiche, nella maggior parte<br />
perio<strong>di</strong>che e stagionali, anche da acque <strong>di</strong> falda che in alcuni punti, per la presenza <strong>di</strong> profonde incisioni del<br />
reticolo vallivo, vengono a giorno costituendo sorgenti.<br />
La grande quantità <strong>di</strong> risorsa idrica prodotta in Basilicata, stimabile in me<strong>di</strong>a in un miliardo <strong>di</strong> metri cubi<br />
all’anno, è utilizzata me<strong>di</strong>ante gran<strong>di</strong> opere idrauliche: invasi, traverse, opere <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> sorgenti e<br />
falde, reti <strong>di</strong> adduzione e <strong>di</strong>stribuzione, impianti <strong>di</strong> sollevamento e potabilizzazione. Il sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ghe e<br />
traverse realizzate sulle aste dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni e sui principali tributari, è costituito da<br />
16 invasi <strong>di</strong> grande e me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>mensione tra i quali:<br />
1) gli invasi <strong>di</strong> San Giuliano, Acerenza, Genzano e Basentello sul fiume Bradano;<br />
2) gli invasi del Pertusillo e Marsico Nuovo sull’Agri;<br />
3) l’invaso <strong>di</strong> Monte Cotugno sul Sinni;<br />
4) l’invaso del Ren<strong>di</strong>na sull’Ofanto;<br />
5) l’invaso del Camastra sul Basento.<br />
Per schema idrico si intende l’insieme <strong>di</strong> opere idrauliche me<strong>di</strong>ante le quali avviene il trasferimento della<br />
risorsa idrica dalle fonti <strong>di</strong> approvvigionamento agli utilizzatori finali per i <strong>di</strong>versi usi (potabile, irriguo,<br />
industriale). Lo schema Basento-Bradano risulta abbastanza articolato e complesso. Si sviluppa nell’area<br />
interna della Basilicata e si estende fino ai confini con la limitrofa Puglia, nei territori <strong>di</strong> Minervino Murge e<br />
Spinazzola. Tale schema comprende l’invaso del Camastra sul torrente omonimo tributario del Basento, la<br />
traversa <strong>di</strong> Trivigno sul fiume Basento, l’invaso del Basentello, l’invaso del Pantano nel territorio <strong>di</strong> Pignola,<br />
gli invasi <strong>di</strong> Acerenza e Genzano (attualmente in fase <strong>di</strong> collaudo) sul fiume Bradano.<br />
88
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
4.4.2 Caratterizzazione idrica profonda<br />
Le peculiarità dell’attuale assetto idrogeologico che caratterizza la regione Basilicata non possono<br />
prescindere dalle relative conoscenze geologiche e geomeccaniche dei complessi litologici presenti. La<br />
geologia della Basilicata deriva da una serie <strong>di</strong> unità strutturali, più o meno traslate dalla loro posizione<br />
originaria, sovrapposte le une alle altre. Sono state <strong>di</strong>stinte numerose formazioni dai vari autori che hanno<br />
stu<strong>di</strong>ato il territorio lucano, così come vari sono i modelli e gli schemi geologici sull’evoluzione<br />
paleogeografica dell’area.<br />
Tuttavia è possibile riconoscere e sud<strong>di</strong>videre la regione Basilicata in tre principali corpi idrici sotterranei<br />
(Figura 4.27):<br />
a) un complesso prevalentemente calcareo-dolomitico <strong>di</strong> età mesozoica, formato dai rilievi più<br />
occidentali dell’Appennino Lucano e che in Basilicata comprende i rilievi dei Monti della Maddalena<br />
a ovest <strong>di</strong> Paterno, il Monte Paratiello a ovest <strong>di</strong> Muro Lucano, i monti <strong>di</strong> Maratea e i versanti più<br />
settentrionali del Pollino (in verde in Figura 4.27);<br />
b) un complesso calcareo-silico-marnoso, anch’esso <strong>di</strong> età mesozoica, costituito sia da rocce tenere<br />
(argille, marne ed arenarie) e, subor<strong>di</strong>natamente, calcari, calcari con selce e <strong>di</strong>aspri, comprendente i<br />
maggiori rilievi dell’Appennino Lucano e culminanti con le cime del Volturino e del Sirino-Papa;<br />
c) un terzo complesso, formato da rocce tenere, nelle quali predomina la frazione argillosa<br />
generalmente <strong>di</strong> natura flyschoide. Si <strong>di</strong>stingue un flysch <strong>di</strong> età mesozoica, o flysch del Cilento, e vari<br />
flysch terziari (argilloso calcareo e marnoso-arenaceo); essi costituiscono l’impalcatura della me<strong>di</strong>a<br />
montagna e della collina lucana, oltre a riempire la fossa Bradanica (in azzurro in Figura 4.27).<br />
Figura 4.27 - Mappa della <strong>di</strong>stribuzione dei principali corpi idrici presenti nella regione Basilicata e relativa posizione dell’area <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o (fonte: www.il<strong>di</strong>strettoidrograficodellappenninomeri<strong>di</strong>onale.it)<br />
89
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
I rapporti stratigrafico-tettonici dell’Appennino Lucano vedono da una serie <strong>di</strong> coltri <strong>di</strong> ricoprimento messe<br />
in posto essenzialmente durante il miocene, sormontate dai depositi clastici mio-pliocenici coinvolti nelle<br />
ultime fasi tettogenetiche (bacini <strong>di</strong> avanfossa e <strong>di</strong> piggy-back).<br />
Con riferimento ai principali corpi idrici precedentemente descritti si può dedurre che l’impalcatura della<br />
regione Lucana è costituita dal complesso silico-calcareo-marnoso (formazione <strong>di</strong> Monte Facito, calcari con<br />
selce, scisti silicei e Flysch Galestrino) a cui si sovrappone tettonicamente il complesso calcareo-dolomitico<br />
dei Monti della Maddalena, Maratea, etc. Entrambi, a loro volta, sono sormontati dal complesso terrigeno,<br />
anche se l’affioramento maggiore <strong>di</strong> queste formazioni è presente verso est e in prevalente sovrapposizione<br />
al complesso calcareo-silico-marnoso. Seguono in sovrapposizione, con coperture più o meno ampie, le<br />
formazioni più recenti composte da se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> mare basso plio-pleistocenico, i se<strong>di</strong>menti coevi <strong>di</strong> origine<br />
continentale dei bacini intrappenninici (bacino lacustre del Mercure, Agri e Noce) e i prodotti vulcanici del<br />
Vulture.<br />
I complessi mesozoici largamente affioranti nella porzione occidentale della catena presentano, per quanto<br />
riguarda l’interazione con gli agenti meteorici, una resistenza all’erosione assai simile. Diversa è invece la<br />
permeabilità dei due complessi. Alta, anche se secondaria, nel complesso calcareo e scarsa nel complesso<br />
calcareo-silico-marnoso con conseguente agevolazione, in questo ultimo, dello sviluppo della<br />
gerarchizzazione dei corsi d’acqua. Ad oriente della Valle dell’Agri comincia la larga fascia dell’Appennino<br />
lucano dominato da paesaggi collinari, con larghe valli dal fondo alluvionato.<br />
Il particolare stato <strong>di</strong> tettonizzazione dei terreni flyscho<strong>di</strong>, laddove affiorano le formazione delle Argille<br />
Varicolori, conferiscono ai fenomeni franosi un importante ruolo morfogenetico. Molto frequente, negli alti<br />
bacini del Bradano e del Basentello, è il paesaggio costituito dai calanchi che <strong>di</strong>vengono la norma nelle<br />
basse valli dove affiorano le argille plio-quaternarie.<br />
In generale, a causa della complessità geologica e delle <strong>di</strong>fferenti proprietà petrofisiche delle rocce presenti<br />
nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profon<strong>di</strong> non è sempre <strong>di</strong> facile<br />
interpretazione. I fattori che giocano un ruolo fondamentale nei movimenti idrici profon<strong>di</strong> sono la porosità<br />
primaria della roccia incassante, la permeabilità e il suo grado <strong>di</strong> fatturazione. In particolare le fratture e le<br />
faglie consentono anche movimenti verticali <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>.<br />
Le Sabbie <strong>di</strong> Monte Marano sono piuttosto permeabili e la sovrapposizione stratigrafica <strong>di</strong> questa unità sulle<br />
argille impermeabili, determina la possibile esistenza <strong>di</strong> acquiferi. La presenza nell'ambito delle sabbie <strong>di</strong><br />
orizzonti <strong>di</strong> materiale più fine conferisce un minor grado <strong>di</strong> permeabilità che determina delle irregolarità<br />
nella morfologia della superficie piezometrica della falda e nella modalità <strong>di</strong> deflusso delle acque.<br />
Il Conglomerato <strong>di</strong> Irsina rappresenta il termine <strong>di</strong> chiusura del ciclo se<strong>di</strong>mentario della Fossa bradanica ed<br />
affiora in corrispondenza delle parti sommitali dei rilievi. La formazione è composta da ciottoli poligenici <strong>di</strong><br />
piccole <strong>di</strong>mensioni compresi in una matrice sabbiosa prevalentemente quarzoso-micacea. Il grado <strong>di</strong><br />
cementazione è generalmente piuttosto basso. Gli affioramenti <strong>di</strong> tali terreni, permeabili per porosità ed a<br />
forte capacità <strong>di</strong> assorbimento, corrispondono alle principali aree <strong>di</strong> alimentazione delle locali falde idriche.<br />
Le sorgenti rilevate possono essere considerate tutte <strong>di</strong> "strato con giacitura suborizzontale" secondo la<br />
classifica proposta da GORTANI. Questo tipo <strong>di</strong> sorgente trova spiegazione nei caratteri geologici della zona,<br />
in cui si rinvengono termini permeabili (Sabbie <strong>di</strong> Monte Marano e Conglomerato d'Irsina) su se<strong>di</strong>menti<br />
pelitici (Argille subappennine) in sostanza impermeabili. La giacitura suborizzontale degli strati fa si che i<br />
punti <strong>di</strong> emergenza si trovino quasi tutti approssimativamente alla stessa quota in corrispondenza del<br />
contatto sabbie-argille. Non sempre, tuttavia, sono stati in<strong>di</strong>viduati punti <strong>di</strong> emergenza ben definiti; il tipo <strong>di</strong><br />
sorgente è infatti quasi sempre molto <strong>di</strong>ffuso a causa della presenza <strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> frana, che <strong>di</strong>sperdono<br />
l’emergenza iniziale in molti rivoli.<br />
Nel dettaglio, in merito all’area in esame, i corpi idrici sotterranei che caratterizzano il blocco “La Capriola”<br />
sono da ricondursi ad acquiferi <strong>di</strong> tipo alluvionale dovuti allo sviluppo delle principali aste fluviali che<br />
caratterizzano l’assetto idrografico visto in precedenza. Nonostante il blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sia interessato dai tre<br />
principali bacini idrografici (Bradano, Basento e Cavone), il principale corpo idrico che attraversa l’area da<br />
NO a SE è l’acquifero alluvionale del Fiume Basento (Figura 4.28).<br />
90
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 4.28 – Particolare degli acquiferi limitrofi all’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o; si tratta sostanzialmente <strong>di</strong> acquiferi alluvionali relativi<br />
all’esistenza e all’azione dei relativi corsi d’acqua (fonte: www.il<strong>di</strong>strettoidrograficodellappenninomeri<strong>di</strong>onale.it)<br />
4.4.3 Rischio idrogeologico<br />
Il territorio della regione Basilicata è particolarmente soggetto a fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto idrogeologico. Il<br />
rischio è definito in base alla possibilità che un evento calamitoso si verifichi in <strong>relazione</strong> all’elemento<br />
vulnerabile presente sul territorio e scaturisce quin<strong>di</strong> dalla combinazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi elementi, ovvero:<br />
• la probabilità che l’evento si verifichi in un determinato intervallo <strong>di</strong> tempo;<br />
• la vulnerabilità del luogo in cui l’evento può verificarsi (danno potenziale);<br />
• il valore del danno che l‘evento provocherebbe ossia per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> vite umane, danni alle<br />
infrastrutture, etc.<br />
Appare perciò evidente che lo stesso fenomeno fisico sarà considerato più o meno rischioso a seconda del<br />
periodo <strong>di</strong> ritorno dell‘evento, del luogo in cui si potrebbe verificare, del numero <strong>di</strong> persone e delle<br />
infrastrutture che potrebbe coinvolgere.<br />
Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico ha valore <strong>di</strong> Piano Territoriale <strong>di</strong> Settore ed è lo<br />
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo me<strong>di</strong>ante il quale sono pianificate e programmate le<br />
azioni e le norme d’uso riguardanti la <strong>di</strong>fesa dal rischio idraulico e idrogeologico nel territorio <strong>di</strong> competenza<br />
dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino della Basilicata (in breve ADB). Il Piano ha la funzione <strong>di</strong> eliminare, mitigare o<br />
prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni dannosi <strong>di</strong> natura geomorfologica (<strong>di</strong>ssesti gravitativi dei<br />
versanti – fenomeni franosi) o <strong>di</strong> natura idraulica (esondazioni dei corsi d’acqua, alluvioni, etc.),<br />
circoscrivendone le aree.<br />
91
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Come visto in precedenza, il territorio della regione Basilicata è esteso complessivamente quasi 1.000.000<br />
ha; esso comprendente 131 comuni e non ricade interamente nell’ambito dell’ADB della Basilicata. Ai fiumi<br />
principali si aggiunge una fitta ed estesa rete <strong>di</strong> corsi d’acqua minori, nonché numerose sorgenti, che<br />
contribuiscono alla fragilità idrogeologica dell’intero territorio.<br />
A tal proposito è stato redatto da parte del Ministero dell‘Ambiente uno stu<strong>di</strong>o me<strong>di</strong>ante il quale si è<br />
attribuito a ciascun comune italiano un valore del livello <strong>di</strong> attenzione del rischio idrogeologico. Tale stu<strong>di</strong>o<br />
è stato condotto sulla base della banca dati AVI (Aree Vulnerate Italiane) realizzata dal GNDCI (Gruppo<br />
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche). I dati riportati riguardavano <strong>di</strong>verse voci tra cui: le<br />
vittime causate dai <strong>di</strong>ssesti idrogeologici del Dipartimento della Protezione Civile; la classificazione da parte<br />
del Servizio Geologico Nazionale sulla propensione al <strong>di</strong>ssesto dei territori comunali; la valutazione della<br />
propensione al rischio idraulico a cura del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Lo stu<strong>di</strong>o ha<br />
permesso, in ultima istanza, la redazione <strong>di</strong> una classificazione del rischio in:<br />
molto elevato (R4): area in cui è possibile il verificarsi <strong>di</strong> fenomeni tali da provocare la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> vite<br />
umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli e<strong>di</strong>fici ed alle infrastrutture, danni al<br />
patrimonio ambientale e culturale, <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> attività socio-economiche;<br />
elevato (R3): area in cui è possibile il verificarsi <strong>di</strong> eventi che implichino rischi per l’incolumità delle<br />
persone, danni funzionali agli e<strong>di</strong>fici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,<br />
interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale;<br />
me<strong>di</strong>o (R2): area in cui è possibile l’instaurarsi <strong>di</strong> fenomeni che implichino danni minori agli e<strong>di</strong>fici,<br />
alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, tali da non pregiu<strong>di</strong>care le attività economiche e<br />
l’agibilità degli e<strong>di</strong>fici;<br />
basso (R1): area in cui è possibile l’instaurarsi <strong>di</strong> fenomeni comportanti danni sociali ed economici<br />
marginali al patrimonio ambientale e culturale;<br />
non classificabile (P): aree che, pur presentando pre<strong>di</strong>sposizione all’instabilità, non sono<br />
antropizzate e/o prive <strong>di</strong> beni sensibili e, pertanto, mancano dell’elemento vulnerabile;<br />
aree soggette a verifica idrogeologica (ASV): aree nelle quali sono presenti fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto e<br />
instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica.<br />
I comuni della Basilicata a rischio idrogeologico, in<strong>di</strong>viduati dal Ministero dell‘Ambiente e dall‘Unione delle<br />
Province Italiane nel 2003 sono 123, ben il 94% del totale (<strong>di</strong> cui 56 a rischio frana, 2 a rischio alluvione e 65<br />
a rischio <strong>di</strong> entrambe). Un dato che palesa la fragilità <strong>di</strong> un territorio in cui un intenso temporale potrebbe<br />
essere sufficiente a provocare smottamenti, allagamenti e <strong>di</strong>sagi per la popolazione. Questa fragilità è<br />
attribuibile ad un uso del territorio e delle acque che troppo spesso non considera le limitazioni imposte da<br />
un rigoroso piano <strong>di</strong> assetto idrogeologico (PAI). Il primato negativo del rischio idrogeologico nel territorio<br />
lucano è detenuto dalla provincia <strong>di</strong> Matera, in cui tutti i comuni risultano a rischio.<br />
In merito all’area in istanza <strong>di</strong> permesso, il rischio legato ai movimenti franosi e ai <strong>di</strong>ssesti è maggiormente<br />
concentrato nei pressi dei piccoli centri abitati <strong>di</strong> Pisticci, nel settore occidentale del blocco, e <strong>di</strong> Bernalda in<br />
quello centro-orientale (Figura 4.29). Si noti in particolare come ai <strong>di</strong>versi eventi franosi vengano associati<br />
<strong>di</strong>fferenti classi <strong>di</strong> rischio (da basso a molto elevato). Questi <strong>di</strong>ssesti sono legati all’elevata plasticità delle<br />
unità geologiche presenti nell’area che caratterizzano i maggiori terreni <strong>di</strong> copertura sia del bacino del<br />
Basento, sia del Cavone.<br />
Per quanto riguarda le successioni stratigrafiche presenti nelle varie zone possono essere raggruppate in<br />
complessi idrogeologici caratterizzati da <strong>di</strong>fferente tipo e grado <strong>di</strong> permeabilità. In particolare si<br />
analizzeranno i terreni <strong>di</strong> copertura relativi al solo bacino del Basento visto che caratterizza la parte<br />
predominante del blocco <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Nel settore centro-orientale del bacino del Basento il complesso idrogeologico <strong>di</strong> maggiore estensione<br />
areale è il Complesso argilloso-sabbioso, che include le successioni argillose pleistoceniche dell’Avanfossa<br />
bradanica, caratterizzato da un grado <strong>di</strong> permeabilità da basso a nullo. I depositi sabbiosi e conglomeratici<br />
92
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
<strong>di</strong> chiusura dell’Avanfossa bradanica sono inclusi nel Complesso sabbioso-conglomeratico, che si rinviene in<br />
corrispondenza dei rilievi <strong>di</strong> Serra del Cedro (Tricarico), <strong>di</strong> Grassano, <strong>di</strong> Grottole, <strong>di</strong> Coste dell’Abbate-<br />
Ferran<strong>di</strong>na, <strong>di</strong> Miglionico-Pomarico. Il grado <strong>di</strong> permeabilità <strong>di</strong> tale complesso è variabile, da me<strong>di</strong>o a basso,<br />
in <strong>relazione</strong> alle caratteristiche granulometriche, allo stato <strong>di</strong> addensamento e/o cementazione dei depositi,<br />
ed allo stato <strong>di</strong> fratturazione. Tale complesso costituisce acquiferi <strong>di</strong> limitata estensione e potenzialità che<br />
alimentano sorgenti <strong>di</strong> portata ridotta.<br />
L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del Basento con<strong>di</strong>ziona le caratteristiche <strong>di</strong> franosità dello<br />
stesso. Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI risulta che nelle parti del<br />
bacino caratterizzate dalla presenza delle successioni sabbiose e conglomeratiche plio-pleistoceniche dei<br />
bacini intrappenninici e dell’Avanfossa bradanica, i fenomeni franosi più <strong>di</strong>ffusi sono del tipo scivolamento<br />
rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento. Nelle aree <strong>di</strong> affioramento delle<br />
successioni argillose plio-pleistoceniche molto <strong>di</strong>ffuse sono le forme calanchive, i movimenti franosi del tipo<br />
colamento lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo creep. Dal medesimo censimento e da quelli<br />
effettuati per l’aggiornamento del PAI, nel bacino del Basento risultano 5877 movimenti franosi, rilevati in<br />
misura prevalente nei centri abitati presenti al suo interno.<br />
Figura 4.29 – Mappa dei movimenti franosi e <strong>di</strong>ssesti idrogeologici nell’area in istanza; in evidenza le classi <strong>di</strong> rischio<br />
La metodologia utilizzata per l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree a rischio idraulico è basata sull’utilizzo del metodo<br />
della valutazione delle piene (VAPI), me<strong>di</strong>ante il quale vengono determinate le portate al colmo <strong>di</strong> piena con<br />
assegnata probabilità <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento (tempo <strong>di</strong> ritorno – Tr).<br />
Per quanto concerne le aree inondabili all’interno della zona oggetto dell’istanza (Figura 4.30), il settore<br />
maggiormente interessato è quello centrale del blocco con andamento NO-SE e coincide con le aree<br />
limitrofe al letto del Fiume Basento. In esso è chiaramente visibile la <strong>di</strong>screpanza tra le aree inondabili a<br />
seconda dei tempi <strong>di</strong> ritorno considerati (maggiori per Tr=500 anni). L’altro settore del blocco interessato da<br />
rischio esondazione, anche se con entità chiaramente minori poiché legate al minore corso d’acqua del<br />
93
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Cavone, è quello sud-occidentale. Qui non si evidenziano significative <strong>di</strong>fferenze tra i tempi <strong>di</strong> ritorno<br />
considerati.<br />
Figura 4.30 - Tempi <strong>di</strong> ritorno per le aree a rischio idraulico nel tratto del fiume Basento e del Cavone ricadenti all’interno<br />
dell’istanza <strong>di</strong> permesso<br />
4.5 Rischio sismico<br />
La classificazione sismica <strong>di</strong> un territorio è lo strumento con cui viene quantificata la probabilità che si<br />
verifichi un evento sismico in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato. Sulla scorta della<br />
classificazione emersa viene stilato il tessuto normativo per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.<br />
Nel corso degli anni sono stati condotti <strong>di</strong>versi stu<strong>di</strong> che hanno portato alla realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse carte<br />
tematiche ognuna delle quali prendeva in considerazione parametri fisici <strong>di</strong>fferenti. I più recenti criteri per<br />
la classificazione sismica dell’intero territorio italiano prendono in considerazione i valori <strong>di</strong> accelerazione<br />
massima del suolo “a × g” con probabilità <strong>di</strong> superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigi<strong>di</strong><br />
caratterizzati da Vs30 > 800 m/s.<br />
Seguendo il criterio dell’accelerazione al suolo, sono state in<strong>di</strong>viduate quattro <strong>di</strong>fferenti zone sismiche su<br />
tutto il territorio nazionale, secondo lo schema seguente:<br />
ZONA<br />
Accelerazione con probabilità <strong>di</strong> superamento<br />
pari al 10% in 50 anni (ag)<br />
Accelerazione orizzontale massima convenzionale <strong>di</strong><br />
ancoraggio dello spettro <strong>di</strong> risposta elastico (ag)<br />
1 0,25 < a g ≤ 0,35 g 0,35 g<br />
2 0,15 < a g ≤ 0,25 g 0,25 g<br />
3 0,05< a g ≤ 0,15 g 0,15 g<br />
4 ≤ 0,05g 0,05 g<br />
Tabella 4.1 - Elenco delle quattro zone sismiche in cui è sud<strong>di</strong>viso il territorio nazionale e i relativi valori <strong>di</strong> accelerazione al suolo<br />
(fonte: www.protezionecivile.gov.it)<br />
94
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Le zone 1, 2 e 3 possono essere sud<strong>di</strong>vise a loro volta in sottozone caratterizzate da valori <strong>di</strong> ag interme<strong>di</strong><br />
rispetto a quelli riportati in Tabella 4 a intervalli <strong>di</strong> 0,025 g.<br />
Nel dettaglio, l’area in istanza <strong>di</strong> permesso ricade in un settore con un grado <strong>di</strong> sismicità me<strong>di</strong>o-basso con<br />
valori <strong>di</strong> accelerazione al suolo compresi tra 0.075 - 0.15 g (Figura 4.31 e Figura 4.32).<br />
Figura 4.31 - Mappa <strong>di</strong> pericolosità sismica del territorio nazionale a cura dell’istituto Nazionale <strong>di</strong> Geofisica e Vulcanologia<br />
(riferimento: Or<strong>di</strong>nanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) (fonte: www.protezionecivile.gov.it)<br />
Figura 4.32 - Mappa <strong>di</strong> classificazione sismica con le isolinee <strong>di</strong> accelerazione al suolo riferita alla mappa <strong>di</strong> Figura 4.31<br />
95
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La mappa riportata in Figura 4.33 rappresenta graficamente l'elaborato della mappa ricavata dal calcolo<br />
dell’accelerazione al suolo, riferita alla <strong>Regione</strong> Basilicata. Nell’ambito della stessa regione rientrano ben tre<br />
delle quattro zone sismiche annoverate nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> pericolosità; in particolare l’area in istanza risulta<br />
ricadere a cavallo tra le zone 2 e 3 in sottozone ed esse riconducibili a causa della loro specificità.<br />
Figura 4.33 - Mappa della Classificazione Sismica aggiornata al 2012 (fonte: www.protezionecivile.gov.it)<br />
Si sottolinea che, nonostante l’area presa in esame dal presente stu<strong>di</strong>o ricada nelle zone sismiche 2 e 3 ad<br />
un livello <strong>di</strong> pericolosità sismica me<strong>di</strong>o-bassa, l’attività oggetto del presente stu<strong>di</strong>o non prevede la<br />
realizzazione alcuna <strong>di</strong> opere soggette a tale rischio. Si precisa inoltre che le attività proposte dal presente<br />
stu<strong>di</strong>o non interferiranno in alcun modo con il già presente rischio né potranno essere causa <strong>di</strong> insorgenza<br />
<strong>di</strong> eventi sismici: non sono pertanto previsti rischi a carico della componente antropica o ambientale.<br />
4.6 Flora e fauna<br />
4.6.1 Copertura forestale e vegetazione<br />
Lo strumento <strong>di</strong> conoscenza e monitoraggio delle <strong>di</strong>verse formazioni boschive regionali è rappresentato<br />
dalla Carta Forestale, la quale analizza e sud<strong>di</strong>vide i popolamenti forestali in funzione ad una serie <strong>di</strong><br />
parametri, quali l’estensione, la composizione specifica, la tipologia e il grado <strong>di</strong> accessibilità.<br />
La Carta Forestale della <strong>Regione</strong> Basilicata è stata realizzata dall’istituto Nazionale <strong>di</strong> Economia Agraria<br />
(INEA, sede regionale per la Basilicata) in stretto collegamento con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio<br />
del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della <strong>Regione</strong> Basilicata, con la<br />
supervisione scientifica <strong>di</strong> docenti dell’Università della Basilicata.<br />
La superficie forestale della <strong>Regione</strong> è <strong>di</strong> 355.409 ettari, per un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> boscosità (dato dal rapporto<br />
percentuale fra superficie forestale e superficie territoriale) del 35.6% . Il valore dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> boscosità della<br />
provincia <strong>di</strong> Matera è pari al 25%, con una superficie boschiva <strong>di</strong> 86.057 ettari.<br />
Confrontando le due province che costituiscono la regione Basilicata, si osserva che in provincia <strong>di</strong> Matera<br />
<strong>di</strong>minuisce l’incidenza del querceto e degli altri boschi mesofili e meso-termofili, mentre aumenta<br />
96
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
considerevolmente il peso delle pinete me<strong>di</strong>terranee, a causa degli estesi rimboschimenti effettuati nel<br />
passato nelle sub-litoranee dell’arco ionico, e della macchia. I boschi <strong>di</strong> faggio sono pressoché assenti nella<br />
provincia <strong>di</strong> Matera, mentre al contrario mancano le formazioni a gariga nella provincia <strong>di</strong> Potenza, ben<br />
rappresentate invece in provincia <strong>di</strong> Matera. Nel complesso, emerge una più marcata impronta<br />
me<strong>di</strong>terranea del territorio materano.<br />
Dalla consultazione <strong>di</strong> tale carta, si osserva che per l’area interessata dal permesso <strong>di</strong> ricerca (Figura 4.34)<br />
sono presenti <strong>di</strong>verse categorie fisionomiche, descritte nella Tabella 4.2.<br />
Fisionomia<br />
principale<br />
Macchia<br />
Gariga<br />
Boschi <strong>di</strong> pini<br />
Me<strong>di</strong>terranei<br />
Formazioni<br />
igrofile<br />
Figura 4.34 – Localizzazione dell’area oggetto <strong>di</strong> istanza sulla Carta Forestale della Basilicata<br />
(fonte: rs<strong>di</strong>.regione.basilicata.it, mo<strong>di</strong>ficato)<br />
Composizione specifica In<strong>di</strong>viduazione nell’area <strong>di</strong> permesso<br />
Macchia a leccio con altre sclerofille<br />
Macchia termofille con filiera e/o<br />
lentisco prevalenti<br />
Macchia mista <strong>di</strong> altre sclerofille<br />
Gariga a lentisco<br />
Gariga a rosmarino e cisto<br />
Formazioni <strong>di</strong> pino d’Aleppo<br />
Rimboschimenti con pino marittimo<br />
e/o pino domestico prevalenti<br />
Rimboschimenti misti <strong>di</strong> conifere<br />
me<strong>di</strong>terranee<br />
Formazioni riparali a salice<br />
Alneti riparali<br />
Pioppeti artificiali a pioppo ibrido<br />
97<br />
In<strong>di</strong>cata dal colore verde, rappresenta la<br />
fisionomia prevalente nell’area. Si rinviene<br />
nella porzione settentrionale, orientale e<br />
meri<strong>di</strong>onale dell’area in istanza<br />
In<strong>di</strong>cata dal colore azzurro, è localizzata nella<br />
zona centrale dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
In<strong>di</strong>cata dal colore rosso, è presente nel<br />
vertice nord-occidentale, nord-orientale e<br />
nella porzione occidentale dell’area<br />
In<strong>di</strong>cata dal colore blu, ricopre l’area del<br />
fiume Basento, ricca <strong>di</strong> elementi idrofili in<br />
alveo e <strong>di</strong> elementi tipici delle argille sui<br />
versanti, con presenza <strong>di</strong> specie erbacee
Piantagioni da<br />
legno<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Formazioni planiziali o retrodunali<br />
(con farnia, pioppo bianco, frassino<br />
angustifolio, etc.)<br />
Altre formazioni igrofile<br />
Piantagioni <strong>di</strong> latifoglie per<br />
arboricoltura da legno<br />
Piantagioni <strong>di</strong> conifere per<br />
arboricoltura da legno<br />
Rimboschimenti con conifere<br />
esotiche o naturalizzate<br />
Robinieti<br />
Eucalitteti<br />
98<br />
substeppiche.<br />
Tabella 4.2 – Categorie fisionomiche presenti nel territorio della Bailicata<br />
In<strong>di</strong>cata dal colore fuxia, è presente in due<br />
piccole superfici, una localizzata nella parte<br />
centro-orientale dell’area in istanza e l’altra<br />
lungo il limite occidentale<br />
Per quanto riguarda le aree calanchive, la vegetazione presenta una rilevante complessità strutturale dovuta<br />
al <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> evoluzione raggiunta in funzione <strong>di</strong> due cause principali: il <strong>di</strong>namismo erosivo e<br />
l'antropizzazione. Queste determinano <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità dei versanti sui quali i tipi <strong>di</strong><br />
vegetazione si <strong>di</strong>spongono a mosaico con locale prevalenza <strong>di</strong> specie effimere a ciclo biologico annuale<br />
(terofite) oppure <strong>di</strong> specie perenni sia erbacee (emicriptofite e geofite) che suffrutticose (camefite). Alcune<br />
<strong>di</strong> queste specie, soprattutto le perenni Lygeum spartum, Camphorosma monspeliaca e Atriplex halimus<br />
possiedono un esteso e poderoso apparato ra<strong>di</strong>cale, che svolge un ruolo determinante nei processi <strong>di</strong><br />
stabilizzazione delle superfici argillose ostacolandone l'erosione.<br />
4.6.2 Siti Rete Natura 2000 ed habitat<br />
L’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, come precedentemente riportato, non comprende al suo interno nessun sito della<br />
Rete Natura 2000. Le aree SIC-ZPS più vicine all’area oggetto <strong>di</strong> istanza, sono:<br />
la SIC/ZPS IT9220255 “Valle Basento - Ferran<strong>di</strong>na Scalo”, ubicata a circa 4,6 km dal confine nordoccidentale<br />
dell’area in istanza;<br />
la SIC IT9220085 “Costa Ionica Foce Basento”, <strong>di</strong>stante circa 7,2 km dal limite sud-orientale<br />
dell’area.<br />
La SIC/ZPS IT9220255 denominata “Valle Basento - Ferran<strong>di</strong>na Scalo”, insiste sul confine fra i Comuni <strong>di</strong><br />
Ferran<strong>di</strong>na e Pomarico ed è una delle ZPS coincidenti con una SIC. L’habitat <strong>di</strong> riferimento sono le<br />
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (62), nella fattispecie rappresentate dal<br />
riferimento sin tassonomico dei Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue delle classi Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea, Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea (6220). L’habitat risponde alla descrizione delle Praterie<br />
xerofile e <strong>di</strong>scontinue <strong>di</strong> piccola taglia a dominanza <strong>di</strong> graminacee, su substrati <strong>di</strong> varia natura, spesso<br />
calcarei e ricchi <strong>di</strong> basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni che ospitano al loro interno aspetti<br />
annuali (Helianthemetea guttati); praterie dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-<br />
Me<strong>di</strong>terraneo, con <strong>di</strong>stribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle<br />
isole. La vegetazione delle praterie xerofile me<strong>di</strong>terranee occupa frequentemente aree <strong>di</strong> erosione o<br />
comunque dove la continuità dei suoli risulti interrotta, tipicamente all’interno delle radure a vegetazione<br />
perenne, sia essa quella delle garighe appenniniche subme<strong>di</strong>terranee delle classi Rosmarinetea officinalis e<br />
Cisto-Micromerietea; quella delle Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su<br />
substrato calcareo della classe Festuco-Brometea (6210); o infine quella delle Formazioni erbose rupicole<br />
calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albi (6110). Le praterie xerofile tipiche <strong>di</strong> questo habitat possono<br />
rappresentare sta<strong>di</strong> pionieri <strong>di</strong> colonizzazione <strong>di</strong> superfici costituite da affioramenti rocciosi <strong>di</strong> varia natura<br />
litologica <strong>di</strong> nuova formazione, così come aspetti <strong>di</strong> degradazione più o meno avanzata al termine <strong>di</strong><br />
processi regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o. Quando le con<strong>di</strong>zioni<br />
ambientali e l’assenza <strong>di</strong> perturbazioni antropiche favoriscono lo sviluppo del suolo e della vegetazione, le<br />
comunità riferibili all’Habitat 6220 possono subire l’invasione <strong>di</strong> specie perenni arbustive legnose, dando
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
luogo ad associazioni vegetazionali più evolute. Queste associazioni si collocano generalmente all’interno <strong>di</strong><br />
serie il cui climax è rappresentato da pinete me<strong>di</strong>terranee (2270) <strong>di</strong> Pinus pinea e Pinus pinaster; oppure da<br />
foresta sempreverde (9340) <strong>di</strong> Quercus ilex e Q. rotun<strong>di</strong>folia o dal bosco misto a dominanza <strong>di</strong> caducifoglie<br />
collinari termofile (91AA), quali Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. dalechampi.<br />
Per quanto riguarda la SIC IT9220085, denominata “Costa Ionica Foce Basento”, il sito comprende l'area <strong>di</strong><br />
foce del fiume Basento e il tratto <strong>di</strong> costa sabbiosa che si estende a nord e in gran parte a sud del fiume. La<br />
costa si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), caratterizzati da rilevanti attività<br />
<strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> origine idrica ed eolica e fenomeni <strong>di</strong> erosione (predominanti) e se<strong>di</strong>mentazione che<br />
determinano l'alternanza <strong>di</strong> tratti costieri più o meno estesi. La vegetazione potenziale dell'area è<br />
rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali sabbiosi e dalla vegetazione <strong>di</strong> cinta e<br />
boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua me<strong>di</strong>terranei. L'assetto attuale della vegetazione è il<br />
risultato <strong>di</strong> massicci interventi <strong>di</strong> bonifica e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree<br />
agricole interne, per cui si ha un complesso mosaico <strong>di</strong> vegetazione a <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> naturalità e maturità<br />
che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree e<strong>di</strong>ficate. Particolarmente estese sono le<br />
formazioni alofile retrodunali che consistono in un complesso mosaico <strong>di</strong> fitocenosi: salicornieti (habitat<br />
1420), giuncheti e prati perio<strong>di</strong>camente inondati (1410), boscaglie a Tamarix (92D0) e canneti. All'interno si<br />
estende una pineta <strong>di</strong> origine artificiale a pino domestico (Pinuspinea), e pino d'Aleppo (Pinus halepensis), e<br />
spora<strong>di</strong>camente pino marittimo (Pinus pinaster) che occupa aree potenzialmente colonizzate dall'habitat<br />
della macchia retrodunale (2260), ben evidente nei tratti in cui la pineta è <strong>di</strong>radata. In alcuni tratti la pineta<br />
si spinge anche in contesti potenzialmente occupati dai pascoli inondati me<strong>di</strong>terranei (1410) e dai<br />
salicornieti (1420). Dal punto <strong>di</strong> vista strettamente forestale è interessante notare come due elementi<br />
essenziali della macchia me<strong>di</strong>terranea, quali il lentisco e la fillirea, siano abbondantemente rappresentati in<br />
molti tratti della pineta. Pertanto, si può ritenere che il rimboschimento in esame assuma la fisionomia<br />
dell'alleanza Oleo-Ceratonion molto simile alle limitrofe pinete joniche del tarantino e probabilmente<br />
all'associazione Pistacio-Pinetum halepensis De Marco et al. (1984).<br />
4.6.3 Fauna<br />
La Basilicata presenta ambienti ricchi <strong>di</strong> animali, infatti la natura stessa del territorio e la bassa densità <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amenti umani ne favorisce l'abbondanza. Tra le specie animali la lontra (Lutra Lutra) è la rarità più<br />
importante, presente in Italia proprio nel territorio compreso tra Cilento, le montagne del Pollino e fino alla<br />
Puglia settentrionale. Nei boschi lucani è la Volpe (Vulpes Vulpes) a farla da padrone insieme a faine (Martes<br />
faina), martore (Martes martes) e donnole (Mustela nivalis). Ma il più grande predatore della regione è il<br />
lupo (Canis lupus italicus) con una presenza concentrata nel massiccio del Pollino. Riguardo alla fauna<br />
terrestre, è possibile incontrare tra i sentieri o nascosti nella macchia me<strong>di</strong>terranea esemplari <strong>di</strong> istrice,<br />
faine, tassi e ricci. I rettili che è possibile incontrare sono il biacco, il cervone, la natrice dal collare e la vipera<br />
comune.<br />
Nella provincia <strong>di</strong> Matera la fauna è ricca <strong>di</strong> specie d’interesse conservazionistico. Le specie più importanti,<br />
segnalate nell’area ZPS “Valle Basento - Ferran<strong>di</strong>na Scalo”, ubicata a circa 4,6 km dal confine nordoccidentale<br />
dell’area in istanza, sono:<br />
Cicogna nera (Ciconia nigra), la cui popolazione italiana riveste particolare interesse biogeografico,<br />
in quanto posta a metà tra popolazioni <strong>di</strong>sgiunte (quella iberica e quella europea centro-orientale);<br />
due specie <strong>di</strong> Lanidae (Lanius minor, Lanius collurio) ni<strong>di</strong>ficanti nel sito, le quali frequentano<br />
ambienti aperti, con alberi o cespugli sparsi, spesso anche ai margini <strong>di</strong> aree coltivate dove non<br />
siano state eliminate le siepi <strong>di</strong> confine;<br />
Lontra (Lutra lutra);<br />
Testuggine d'acqua (Emys orbicularis);<br />
e il Cervone (Elaphe quatuorlineata).<br />
Per quanto riguarda l’avifauna presente nell’area oggetto dell’istanza, le specie che hanno contribuito alla<br />
costituzione dell’IBA sono:<br />
99
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Nibbio reale (Milvus milvus);<br />
Ghiandaia marina (Coracias garrulus);<br />
Monachella (Oenanthe hispanica);<br />
Zigolo capinero (Emberiza melanocephala);<br />
Lanario (Falco biarmicus);<br />
Gufo reale (Bubo bubo);<br />
Averla capirossa (Lanius collurio).<br />
100
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
5 ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI<br />
5.1 Introduzione<br />
Lo scopo del presente capitolo è quello <strong>di</strong> analizzare e valutare i potenziali impatti che potrebbero derivare<br />
dalle interazioni tra le attività <strong>di</strong> svolgimento della campagna <strong>di</strong> acquisizione geofisica e le componenti<br />
ambientali presenti nell’area.<br />
L’area oggetto <strong>di</strong> istanza, come descritto nei paragrafi precedenti, è costituita da un territorio misto, che va<br />
da zone più pianeggianti a montano-collinari e caratterizzato da bassa antropizzazione e da un uso<br />
predominante del suolo a scopi agricoli e pastorali. Le operazioni <strong>di</strong> rilievo sismico, così come descritte nel<br />
“quadro <strong>di</strong> riferimento progettuale”, hanno carattere <strong>di</strong> cantiere mobile temporaneo, infatti al termine<br />
dell’acquisizione dei dati tutte le attrezzature verranno rimosse. Gli impatti esaminati in questo capitolo<br />
verranno quin<strong>di</strong> considerati limitatamente al periodo <strong>di</strong> tempo in cui le attività previste possono avere<br />
interazioni con la matrice ambientale circostante.<br />
Durante la fase gestionale dell’indagine geofisica (condotta utilizzando come fonte <strong>di</strong> energizzazione i<br />
Vibroseis), le possibili interazioni con l’ambiente circostante sono da considerarsi piuttosto limitate, visto il<br />
tipo <strong>di</strong> attività, ed il carattere temporaneo, localizzato e reversibile <strong>di</strong> tutte le azioni previste, e sono<br />
rappresentate essenzialmente da rumore, vibrazioni e occupazione del suolo.<br />
Si ricorda che l’attività <strong>di</strong> energizzazione, effettuata attraverso i Vibroseis, non andrà ad interessare le<br />
seguenti aree:<br />
alvei, invasi e corsi d'acqua tutelati;<br />
complessi archeologici (siti e monumenti) ufficialmente riconosciuti, e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> pregio architettonico<br />
e centri storici;<br />
aree protette.<br />
5.2 Emissione sonore ed impatto acustico<br />
Ogni suono è caratterizzato dalla propagazione <strong>di</strong> onde <strong>di</strong> pressione in un mezzo elastico dovute alla rapida<br />
successione <strong>di</strong> compressioni ed espansioni del mezzo stesso. Affinché il fenomeno nasca e si propaghi è<br />
necessaria la presenza <strong>di</strong> una sorgente sonora e <strong>di</strong> un mezzo elastico che ne consenta la propagazione e<br />
proprio per quest’ultimo motivo il suono non può <strong>di</strong>ffondersi nel vuoto. Per rumore, invece, si intende<br />
qualsiasi fenomeno acustico che, a <strong>di</strong>fferenza del suono, viene percepito dall’ascoltatore come sgradevole,<br />
fasti<strong>di</strong>oso e non desiderato.<br />
In base all’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995 e s.m.i.),<br />
l’inquinamento acustico è definito come l'introduzione <strong>di</strong> rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente<br />
esterno tale da provocare fasti<strong>di</strong>o o <strong>di</strong>sturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,<br />
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o<br />
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.<br />
Per meglio valutare l’estensione areale degli impatti che le emissioni sonore potrebbero avere<br />
sull’ambiente circostante, sono stati utilizzati i risultati dei Noise Test Vibration che la <strong>di</strong>tta Spectrum<br />
Acoustic Consultant (certificata ISO 9001) ha effettuato per le attività <strong>di</strong> acquisizione sismica <strong>di</strong> altro<br />
permesso <strong>di</strong> ricerca, del tutto simile a quella prevista per questa indagine.<br />
5.2.1 Impatto acustico prodotto dai Vibroseis<br />
L'unico rumore <strong>di</strong> rilievo che si percepisce, nel caso <strong>di</strong> un rilievo geosismico condotto me<strong>di</strong>ante l’utilizzo dei<br />
Vibroseis, è quello generato dal motore del mezzo motorizzato. La Tabella 5.1, ottenuta dalla me<strong>di</strong>a fra<br />
<strong>di</strong>verse misurazioni sperimentali eseguite su macchine durante la lavorazione e i dati riportati dal<br />
"Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente <strong>di</strong> Lavoro <strong>di</strong> Torino e Provincia<br />
(1994)", riporta le misure <strong>di</strong> rumore a tre metri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza per <strong>di</strong>versi automezzi pesanti, utilizzati<br />
frequentemente in fase <strong>di</strong> cantiere.<br />
101
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Tipo <strong>di</strong> macchina Leq me<strong>di</strong>o in dB(A)<br />
Autocarro 82<br />
Escavatore CAT 85<br />
Escavatore con<br />
puntale<br />
102<br />
93<br />
Ruspa o pala 86<br />
AutoGru 86<br />
Gru 80<br />
Rullo Compressore 86<br />
Autobetoniera 83<br />
Betoniera 76<br />
Grader 90<br />
Battipalo 88<br />
Vibroseis 79<br />
Sega circolare 92<br />
Tabella 5.1 - Valori me<strong>di</strong> a 3 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza per singole macchine operatrici<br />
Il test del rumore viene effettuato presso punti prestabiliti, al fine <strong>di</strong> evidenziare come, a <strong>di</strong>stanza<br />
crescente, si abbia un <strong>di</strong>minuzione lineare del rumore (Tabella 5.2). I valori riportati in tabella vengono<br />
raccolti posizionando i 6 <strong>di</strong>fferenti ricettori (Figura 5.1) ad una <strong>di</strong>stanza crescente.<br />
Figura 5.1 - Posizione ricettori per il test del rumore
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Posizione Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A)<br />
1 1 83 10 78 20 74<br />
2 1 93 10 84 20 80<br />
3 1 93 10 84 20 78<br />
4 1 90 10 83 20 77<br />
5 1 93 10 83 20 79<br />
6 1 93 10 83 20 79<br />
Me<strong>di</strong>a 1 92 10 83 20 78<br />
Tabella 5.2 - Dati ricavati in campagna <strong>di</strong> acquisizione sismica 3D (le posizioni si riferiscono alla Figura 5.1)<br />
Dai dati che si ottengono è possibile creare una curva <strong>di</strong> tendenza dalla quale si osserva che ad una <strong>di</strong>stanza<br />
<strong>di</strong> 100 m dalla sorgente del rumore si raggiungono valori inferiori ai 40 dB(A), rispettando i limiti <strong>di</strong> legge<br />
(Figura 5.2).<br />
dB(A)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1 2 3<br />
4 5 6<br />
Lineare (1) Lineare (2) Lineare (4)<br />
Lineare (5) Lineare (6)<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Distanza (m)<br />
Figura 5.2 - Grafico con le curve <strong>di</strong> tendenza ricavate dai dati della Tabella 5.2<br />
I risultati dei Noise Test Vibration effettuati dalla <strong>di</strong>tta Spectrum Acoustic Consultant sono stati effettuati<br />
misurando l’impatto acustico in <strong>di</strong>eci punti prestabiliti posizionati a 10 metri <strong>di</strong>stanza intorno agli<br />
automezzi, come mostrato nella Figura 5.3.<br />
Figura 5.3 - Punti <strong>di</strong> misurazione per i Noise Test Vibration<br />
103
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Durante i test sono stati misurati gli impatti acustici prodotti in quattro <strong>di</strong>verse configurazioni, <strong>di</strong> seguito<br />
descritte:<br />
Nessun tipo <strong>di</strong> schermatura (Unsilenced Vib);<br />
Pannello laterale intorno alla macchina (+ Side Panels);<br />
Schermatura superiore e pannello laterale (+ Side + Top Panels);<br />
Pannelli laterali, schermatura acustica superiore e posteriore (+ side + roof + rear panels).<br />
I risultati ottenuti sono mostrati nella Tabella 5.3.<br />
Tabella 5.3 - Risultati del Noise Test Vibration per le quattro configurazioni descritte<br />
Si può notare come le misurazioni riferite alla quarta configurazione mostrino una riduzione del rumore<br />
fino a 8 dB(A) in corrispondenza del punto <strong>di</strong> misurazione posteriore, e un valore <strong>di</strong> -6dB(A) me<strong>di</strong>ato su tutti<br />
i punti rispetto alla prima configurazione, senza alcuna schermatura, valori entrambi che rappresentano un<br />
ottimo risultato per la <strong>di</strong>minuzione dell’impatto acustico sui ricettori sensibili.<br />
5.2.2 Limiti <strong>di</strong> legge<br />
La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26/10/95 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in<br />
materia <strong>di</strong> tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.<br />
La suddetta Legge, che si compone <strong>di</strong> 17 articoli, delinea le competenze degli enti pubblici (Stato, Regioni,<br />
Province e Comuni), che esplicano le azioni <strong>di</strong> regolamentazione, pianificazione e controllo, e definisce le<br />
<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> impatto acustico a cui devono attenersi i soggetti pubblici e/o privati, che possono<br />
essere causa <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> inquinamento acustico. Alla Legge 447/1995, che costituisce il “quadro <strong>di</strong><br />
riferimento” in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico, sono collegati una serie <strong>di</strong> Decreti attuativi, tra cui il<br />
principale risulta essere il D.P.C.M. 14/11/97 che è andato a mo<strong>di</strong>ficare il precedente D.P.C.M. 01/03/91.<br />
Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite <strong>di</strong><br />
emissione, i valori limite <strong>di</strong> immissione (Figura 5.4), i valori <strong>di</strong> attenzione ed i valori <strong>di</strong> qualità in funzione<br />
delle classi <strong>di</strong> destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge.<br />
Figura 5.4 – Valori limite assoluti <strong>di</strong> immissione Leq in dB(A)<br />
(fonte: DPCM 14/11/97, tabella C, ai sensi dell’art. 3)<br />
104
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
È opportuno precisare che la strumentazione utilizzata durante l’attività <strong>di</strong> rilievo geofisico dovrà rispettare<br />
i limiti <strong>di</strong> immissione acustica, ai fini <strong>di</strong> tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio.<br />
5.2.3 Conclusioni<br />
L’area in questione, essendo prevalentemente agricola, si ipotizza, durante il periodo <strong>di</strong> riferimento<br />
notturno, un rumore <strong>di</strong> fondo inferiore a 35 dB(A). Presso i recettori sensibili presenti nell’area (borghi <strong>di</strong><br />
case) deve quin<strong>di</strong> essere rispettato il livello sonoro immesso durante il periodo <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong>urno pari a<br />
55 dB(A) e 45 dB(A) nel periodo <strong>di</strong> riferimento notturno (Tabella 5.4). Per quanto concerne i ricettori<br />
sensibili classificati come “aree particolarmente protette” i limiti assoluti <strong>di</strong> immissione per il periodo <strong>di</strong><br />
riferimento <strong>di</strong>urno e notturno sono rispettivamente <strong>di</strong> 50 dB(A) e 40 dB(A). Nel contesto in esame, si<br />
considera il rumore <strong>di</strong> fondo praticamente ininfluente, pertanto il rumore immesso presso potenziali<br />
ricettori sarà dovuto alla sola sorgente sopra citata.<br />
Si ricorda che l’attività non verrà eseguita all’interno <strong>di</strong> aree a qualsiasi titolo protette o vincolate e,<br />
considerando il fatto che all’interno dell’area in istanza non sono presenti siti Rete Natura 2000, si può<br />
escludere qualsiasi impatto acustico con questo tipo <strong>di</strong> ricettori.<br />
Fascia <strong>di</strong> pertinenza<br />
Limiti immissione dB(A)<br />
Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00-6:00)<br />
Zona I: “Aree particolarmente protette” 50 40<br />
Zona II: “Aree prevalentemente residenziali” 55 45<br />
Zona III: “Aree <strong>di</strong> tipo misto” 60 50<br />
Tabella 5.4 - Tabella riassuntiva delle aree nelle quali sono collocati i ricettori sensibili dei rispettivi limiti <strong>di</strong> immissione acustica e<br />
della <strong>di</strong>stanza alla quale la strumentazione dovrà essere posizionata<br />
Dai dati riportati ai punti precedenti si evince che i limiti <strong>di</strong> immissione in aree particolarmente protette e<br />
aree prevalentemente residenziali, rispetto ad una sorgente sonora quale il Vibroseis, vengono rispettati<br />
già ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 100 m.<br />
Se le opere <strong>di</strong> indagine richiederanno l’intervento operativo a <strong>di</strong>stanze inferiori <strong>di</strong> quelle sopra citate, per<br />
far fronte al superamento dei limiti assoluti <strong>di</strong> immissione e dei limiti <strong>di</strong>fferenziali presso i ricettori sensibili,<br />
il proponente provvederà preventivamente a richiedere un’autorizzazione in deroga alle competenti<br />
amministrazioni comunali coinvolte, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera h) della L. del 26 ottobre 1995, n.<br />
447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.<br />
5.3 Vibrazioni<br />
Le vibrazioni sono onde elastiche che vengono prodotte appoggiando al terreno una piastra che trasmette<br />
impulsi <strong>di</strong> breve durata utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12-100 Hz e la cui propagazione in<br />
superficie risulta estremamente limitata. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> effetti rapidamente reversibili al cessare delle<br />
attività <strong>di</strong> prospezione.<br />
Di seguito vengono riportati i valori <strong>di</strong> velocità delle particelle (PPV) in funzione dell’incremento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza<br />
dal mezzo e della potenza della vibrazione, è infatti possibile variare la potenza <strong>di</strong> vibrazione in funzione<br />
della vicinanza a ricettori sensibili (Tabella 5.5 e Figura 5.5).<br />
105
Distanza (m)<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Potenza della vibrazione %<br />
15% 20% 30% 50% 75%<br />
10 5.3 6.3 1.0 12.0 13.5<br />
20 3.0 4.0 5.2 6.4 7.8<br />
30 2.4 2.8 3.1 3.5 4.5<br />
50 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8<br />
75 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2<br />
100 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9<br />
Tabella 5.5 – Valori <strong>di</strong> velocità delle particelle (PPV) in funzione della <strong>di</strong>stanza e della potenza della vibrazione<br />
Figura 5.5 - Punti <strong>di</strong> rilevamento delle vibrazioni<br />
Secondo la DIN 4150-3 “Vibrazioni nell’e<strong>di</strong>lizia – Parte 3: effetti sugli e<strong>di</strong>fici”, ritenuta maggiormente<br />
rappresentativa in quanto più restrittiva tra le norme internazionali vigenti:<br />
per valori <strong>di</strong> frequenza minimi nell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 12 Hz ai fini della tutela assoluta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici anche con<br />
caratteristiche <strong>di</strong> particolare sensibilità o valenza artistica o storica, sono ammissibili valori massimi<br />
<strong>di</strong> velocità <strong>di</strong> oscillazione nell’or<strong>di</strong>ne dei 3-4 mm/sec;<br />
il decremento della velocità <strong>di</strong> oscillazione è caratterizzato da variazione esponenziale correlabile<br />
con la <strong>di</strong>stanza, secondo regole tali da garantire, nell’arco <strong>di</strong> uno scostamento <strong>di</strong> 50 metri dal punto<br />
sorgente, un decremento dell’or<strong>di</strong>ne dell’80% per le onde nel terreno e del 60% delle onde lungo la<br />
superficie.<br />
I dati riportati in Figura 5.6 sono riferiti ad una campagna <strong>di</strong> acquisizione sismica 2D simile a quella<br />
presentata in questo progetto. Osservando il grafico si può notare come, già ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 50 metri dal<br />
punto sorgente, i valori <strong>di</strong> ampiezza registrabili raggiungano valori massimi dell’or<strong>di</strong>ne dei 3-5 mm/sec e<br />
siano pertanto compatibili con i valori <strong>di</strong> tutela assoluti approvati dalle citate norme DIN 4150-3.<br />
106
5.4 Subsidenza<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 5.6 - Grafico ricavato dai dati sulle vibrazioni<br />
L’attività <strong>di</strong> prospezione geofisica, condotta utilizzando come fonte <strong>di</strong> energizzazione i Vibrosises, non<br />
prevede movimenti <strong>di</strong> terra, né interazione con l’assetto geologico strutturale del sottosuolo. Inoltre, non è<br />
prevista l’estrazione <strong>di</strong> nessun tipo <strong>di</strong> materiale, sia esso liquido, solido o gassoso, il ché determina<br />
l’assenza <strong>di</strong> interazioni in grado <strong>di</strong> generare fenomeni <strong>di</strong> subsidenza nell’area oggetto <strong>di</strong> istanza o delle zone<br />
limitrofe.<br />
Pertanto, in base alla natura dell’attività proposta, non è previsto alcun impatto con le componenti suolo<br />
e/o sottosuolo, in grado <strong>di</strong> generare il fenomeno della subsidenza.<br />
Nel caso in cui gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> acquisizione dovessero rilevare l'interesse a realizzare un’eventuale perforazione,<br />
verrà successivamente sviluppato uno Stu<strong>di</strong>o d’Impatto Ambientale finalizzato ad effettuare verifiche e<br />
simulazioni sugli eventuali effetti dell’estrazione per quanto riguarda la subsidenza nell’area.<br />
5.5 Occupazione del suolo<br />
L’occupazione del suolo è un fattore d’impatto e durata limitata nel tempo dal momento che al termine<br />
delle operazioni si provvede al recupero dell’area indagata ed alla restituzione dell’originaria destinazione<br />
d’uso. Inoltre, l’impatto potenziale durante la fase <strong>di</strong> cantiere è estremamente ridotto, dato che le<br />
attrezzature presentano modeste <strong>di</strong>mensioni e, <strong>di</strong> fatto, l’attività è assimilabile al passaggio ed alla<br />
temporanea sosta <strong>di</strong> macchine agricole.<br />
Al momento, non sono ancora state definite con precisione le aree che verranno interessate dalle attività <strong>di</strong><br />
prospezione geofisica, in quanto la valutazione della localizzazione dei percorsi è subor<strong>di</strong>nata<br />
all’ottenimento, da parte della società Delta Energy Ltd, del decreto che accor<strong>di</strong> la titolarità del permesso <strong>di</strong><br />
ricerca idrocarburi, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non è quin<strong>di</strong> possibile, a questo stato<br />
dei lavori, produrre una cartografia adeguata che illustri le linee che <strong>di</strong>verranno oggetto <strong>di</strong> prospezione<br />
sismica.<br />
5.6 Impatti in atmosfera<br />
Si ritiene che l’attività oggetto del presente stu<strong>di</strong>o, possa provocare impatti del tutto trascurabili sulla<br />
qualità dell’aria, considerato che non vi sono punti emissivi fissi (in questa fase non sono previste<br />
perforazioni) e che l’unico impatto in atmosfera possa derivare dagli automezzi, del tutto assimilabili alle<br />
emissioni prodotte dai mezzi agricoli utilizzati abitualmente nella zona.<br />
107
5.7 Ambiente idrico<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede<br />
l’approvvigionamento idrico superficiale e sotterraneo e non sono previsti scarichi né <strong>di</strong> acqua, né <strong>di</strong> reflui<br />
legati all’attività <strong>di</strong> acquisizione sismica.<br />
5.8 Rifiuti<br />
L’attività in oggetto non prevede alcuna produzione <strong>di</strong> rifiuti.<br />
5.9 Impatti su ecosistemi, flora e fauna<br />
Per analizzare e stimare gli eventuali impatti che l’attività in progetto potrebbe provocare su ecosistemi,<br />
flora e fauna, si è deciso <strong>di</strong> utilizzare una metodologia in grado <strong>di</strong> fornire una valutazione il più oggettiva<br />
possibile delle implicazioni del progetto, rappresentata dalla matrice ambientale <strong>di</strong> Leopold. Si evidenzia<br />
che, oltre alla quantificazione degli impatti potenziali, sono stati tenuti in considerazione vari fattori, quali:<br />
la reversibilità, per valutare se l’impatto causerà alterazioni più o meno permanenti allo stato<br />
ambientale;<br />
la durata dell’impatto sulla matrice ambientale, ossia quanto l’alterazione prodotta sullo stato<br />
ambientale permanga anche dopo la conclusione dei lavori;<br />
la scala spaziale, cioè l’area massima <strong>di</strong> estensione in cui l’azione che crea l’impatto ha influenza<br />
sull’ambiente;<br />
l’evitabilità <strong>di</strong> un’azione specifica;<br />
la mitigabilità dell’impatto, ossia la possibilità <strong>di</strong> ammortizzare gli impatti anche in maniera parziale<br />
attraverso interventi <strong>di</strong> mitigazione o col tempo.<br />
5.9.1 Matrice <strong>di</strong> Leopold<br />
Lo scopo della matrice <strong>di</strong> Leopold è l’analisi e la stima, qualitativa e quantitativa, delle alterazioni e/o<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> una singola componente ambientale o all’ambiente nel suo complesso che gli interventi<br />
sopra descritti potrebbero provocare.<br />
Di seguito viene fornito un elenco schematico delle caratteristiche del metodo della matrice <strong>di</strong> Leopold.<br />
Descrizione<br />
Vantaggi<br />
Procedura <strong>di</strong><br />
compilazione<br />
MATRICE DI LEOPOLD<br />
Il metodo della matrice <strong>di</strong> Leopold consiste nella creazione <strong>di</strong> una tabella <strong>di</strong><br />
corrispondenza (equivalente a una checklist bi<strong>di</strong>mensionale) che permette <strong>di</strong> confrontare<br />
le azioni previste nel progetto e che possono avere ripercussioni sull’ambiente con le<br />
caratteristiche dell’ambiente stesso.<br />
La possibilità <strong>di</strong> ottenere una visualizzazione imme<strong>di</strong>ata, attraverso una rappresentazione<br />
grafica, degli impatti potenziali rispetto a ciascuna componente ambientale.<br />
La matrice utilizzata per valutare l’impatto ambientale delle attività previste è stata<br />
compilata secondo le in<strong>di</strong>cazioni fornite nell’articolo “A procedure for evaluating<br />
Environmental Impact” (Leopold et al., 1971).<br />
Secondo quanto in<strong>di</strong>cato dagli autori, la matrice viene sviluppata riportando in colonne le<br />
azioni previste nel progetto, e in riga le componenti ambientali (riunite in tre categorie<br />
principali) che possono essere interessate, in modo tale da riuscire a valutare gli<br />
eventuali impatti me<strong>di</strong>ante le intersezioni che si creano tra lo stato ambientale e le azioni<br />
proposte.<br />
108
Valutazione<br />
quantitativa<br />
degli impatti<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
La procedura illustrata da Leopold et al. (1971), consiste nell’in<strong>di</strong>viduare all’interno della<br />
matrice tutte le possibili intersezioni tra righe e colonne che in<strong>di</strong>cano interazioni tra le<br />
attività progettuali e le componenti ambientali. Ad ogni intersezione viene quin<strong>di</strong><br />
assegnato un valore <strong>di</strong> una scala scelta per poter ottenere una valutazione quantitativa<br />
del probabile impatto.<br />
Ad ogni casella corrisponde una probabile interazione ed è caratterizzata da due numeri:<br />
Il primo numero corrisponde alla magnitu<strong>di</strong>ne dell’impatto, cioè a quello che nell’articolo<br />
precedentemente citato viene definito “magnitude”;<br />
Il secondo numero in<strong>di</strong>ca la rilevanza dell’impatto (“importance” secondo Leopold et al.).<br />
Attraverso la sommatoria dei valori assegnati è possibile ottenere una stima globale dei<br />
probabili effetti <strong>di</strong> interazione tra le azioni previste nel progetto e le componenti<br />
ambientali.<br />
5.9.2 Descrizione ed esposizione delle matrici impiegate<br />
Al fine <strong>di</strong> ottenere una più completa visualizzazione degli impatti che si possono produrre sulle componenti<br />
ambientali durante le attività <strong>di</strong> acquisizione sismica è stata creata una matrice che comprende gli effetti<br />
delle operazioni descritte in questo stu<strong>di</strong>o e che verranno realizzate nell’intera area oggetto <strong>di</strong> istanza<br />
(Tabella 5.6). Nelle colonne delle azioni sono state riportate le azioni previste durante le varie fasi <strong>di</strong><br />
progettazione della campagna <strong>di</strong> acquisizione geofisica.<br />
La scelta <strong>di</strong> operare le valutazioni dei possibili impatti ambientali con questa metodologia permette non<br />
solo <strong>di</strong> avere un quadro più chiaro delle interazioni attività/ambiente, ma consente anche <strong>di</strong> evidenziare se,<br />
eventualmente, una delle fasi presenti più criticità rispetto alle altre. Sono state quin<strong>di</strong> prese in<br />
considerazione le possibili interazioni tra le attività previste nel progetto e i cosiddetti “ricettori <strong>di</strong> impatto”.<br />
Essi corrispondono a tutti gli elementi in cui è stato scomposto il sistema ambientale circostante che<br />
possono subire mo<strong>di</strong>ficazioni causate dalle attività sopra citate che si trovano nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze<br />
dell’area che <strong>di</strong>verrà oggetto <strong>di</strong> rilievo sismico.<br />
I ricettori <strong>di</strong> impatto sono stati sud<strong>di</strong>visi in tre categorie (fisico-chimiche, biologiche e socio-culturali), che a<br />
loro volta sono state sud<strong>di</strong>vise in altre sottocategorie. Lo scopo principale della scomposizione<br />
dell’ambiente in sottoelementi è la possibilità <strong>di</strong> poter evidenziare il livello al quale agiscono le <strong>di</strong>verse<br />
attività del progetto.<br />
Nel caso in cui non siano previste probabilità <strong>di</strong> interazione tra una data azione e una componente<br />
ambientale, la casella non viene compilata. Dopo la compilazione della matrice si è proceduto alla somma<br />
dei valori presenti nelle righe e nelle colonne, in modo tale da riuscire a ottenere una visione d’insieme<br />
degli effetti che ogni fase in cui è stato scomposto il programma potrebbe produrre sull’ambiente e, a<br />
seguire, è stato fornito un breve commento delle interazioni previste.<br />
Durante la compilazione delle matrici, sono state considerate le seguenti considerazioni generali:<br />
tutte le attività previste hanno carattere limitato nel tempo e risultano completamente reversibili al<br />
cessare delle attività in oggetto, per questo motivo il valore assegnato alla rilevanza dell’impatto si<br />
mantiene in tutti i casi su numeri molto bassi (1 o 2);<br />
non sono previste interazioni con zone fluviali o lacustri presenti all’interno dell’area. Per questo<br />
motivo le caselle corrispondenti alle interazioni dell’acqua e dei pesci con le attività <strong>di</strong> progetto non<br />
sono state compilate;<br />
verrà mantenuta un’adeguata <strong>di</strong>stanza (da commisurare e giustificare in <strong>relazione</strong> all’energia degli<br />
impulsi e alla natura dei terreni) da immobili/costruzioni e reliquati storici nonché dalle<br />
infrastrutture e dai sottoservizi. Particolare attenzione verrà posta alla presenza <strong>di</strong> metanodotti e<br />
infrastrutture militari;<br />
109
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
si avrà cura <strong>di</strong> ripristinare eventuali essenze arboree ed arbustive danneggiate durante i lavori.<br />
Per quanto riguarda i possibili impatti con specie <strong>di</strong> flora e fauna protette non sono previste interazioni,<br />
dovuto al fatto che all’interno dell’area in istanza non sono presenti aree naturali protette.<br />
Nella tabella seguente viene applicata la Matrice <strong>di</strong> Leopold all’intera area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca<br />
idrocarburi denominato “La Capriola”.<br />
110
COMPONENTI AMBIENTALI E SOCIALI<br />
Fisico-chimiche<br />
Biologiche<br />
Sociali-culturali<br />
Suolo<br />
Acqua<br />
P a g i n a | 111<br />
MATRICE DI LEOPOLD APPLICATA A TUTTA LA ZONA OGGETTO DI STUDIO<br />
AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO<br />
Rilievo<br />
topografico<br />
(max 10-10)<br />
Sten<strong>di</strong>mento e<br />
rimozione cavi<br />
(max 10-10)<br />
Posizionamento e<br />
rimozione geofoni<br />
(max 10-10)<br />
Energizzazione<br />
(max 10-10)<br />
Movimento e<br />
uso automezzi<br />
(max 10-10)<br />
TOTALE<br />
(max 50/50-50/50)<br />
Qualità del suolo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5/50-5/50<br />
Coltivazioni 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 8/50-5/50<br />
Amb. idrico superficiale - - - - - -<br />
Ambiente idrico profondo - - - - - -<br />
Atmosfera Qualità dell’aria - - - - 2-1 2/50-1/50<br />
Flora<br />
Fauna<br />
Vegetaz. planiziale e arbusti 1-1 1-1 1-1 - 1-1 4/50-4/50<br />
Copertura erbosa 2-1 2-1 2-1 - 2-1 8/50-4/50<br />
Vegetazione idrofita 1-1 1-1 1-1 - - 3/50-3/30<br />
Specie tutelate - - - - - -<br />
Mammiferi 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50<br />
Uccelli 1-1 1-1 1-1 - 2-1 5/50-4/50<br />
Pesci - - - - - -<br />
Altri animali vertebrati 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50<br />
Insetti 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50<br />
Specie tutelate - - - - - -<br />
Ecosistemi Qualità degli ecosistemi 1-1 1-1 1-1 - - 3/50-3/50<br />
Percezione<br />
del<br />
paesaggio<br />
Aspetto del paesaggio - 2-1 2-1 - 2-1 6/50-3/50<br />
TOTALE<br />
(max 170/170-170/170)<br />
12/170-<br />
10/170<br />
14/170-<br />
11/170<br />
14/170-11/170 8/170-5/170 17/170-10/170<br />
Tabella 5.6 – Matrice <strong>di</strong> Leopold applicata all’area in istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi “La Capriola”
P a g i n a | 112<br />
Come si può osservare dai risultati della matrice esposta le probabilità <strong>di</strong> interazione tra le attività <strong>di</strong><br />
prospezione sismica e le componenti ambientali sono estremamente basse (meno del 10% del valore<br />
massimo raggiungibile nella maggioranza dei casi). Inoltre, si può evincere che:<br />
Il rilievo topografico avrà influenze estremamente basse su tutte le componenti ambientali. Infatti è<br />
previsto l’utilizzo della viabilità esistente (strade, piste, sentieri), senza la necessità <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong><br />
movimento <strong>di</strong> terra per l’accesso <strong>di</strong> personale e mezzi. Come già stabilito, durante tale attività<br />
verranno posizionati sul terreno due <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> picchetti <strong>di</strong> legno che andranno ad identificare i<br />
punti in cui verranno posizionati i geofoni ed i punti <strong>di</strong> energizzazione. Eventuali interazioni con<br />
l’ambiente, quin<strong>di</strong>, potrebbero essere date da interazioni con arbusti, copertura erbosa o col suolo.<br />
Sia i valori corrispondenti alla grandezza che la rilevanza dell’impatto assegnati alle caselle sono<br />
comunque bassi, viste le scarse probabilità <strong>di</strong> interazione e gli effetti che sarebbero comunque<br />
estremamente ridotti nell’entità e nel tempo.<br />
Lo sten<strong>di</strong>mento/rimozione dei cavi ed il posizionamento/rimozione dei geofoni prevede l’utilizzo <strong>di</strong><br />
viabilità esistente, inoltre, l’attività viene effettuata manualmente. Valgono in generale quin<strong>di</strong> le<br />
stesse considerazione fatte per il rilievo topografico, vale a <strong>di</strong>re impatti estremamente bassi su<br />
tutte le componenti ambientali.<br />
L’attività <strong>di</strong> energizzazione presenta interazioni <strong>di</strong> importanza limitata con l’ambiente. Infatti, come<br />
già stabilito in precedenza, le frequenze usate sono basse (comprese tra 12 -100 Hz) e <strong>di</strong> breve<br />
durata (pochi secon<strong>di</strong>), quin<strong>di</strong> non risultano in alcun modo dannose. Inoltre le linee <strong>di</strong><br />
energizzazione non necessitano <strong>di</strong> un posizionamento rigido. Il posizionamento può quin<strong>di</strong> essere<br />
effettuato anche con un consistente spostamento laterale, destro o sinistro rispetto alla <strong>di</strong>rezione<br />
<strong>di</strong> avanzamento. Tale vantaggio consente <strong>di</strong> servirsi pienamente della viabilità esistente. I valori<br />
assegnati a questa attività sono corrispondenti a 2-1, solo per quello che riguarda la fauna<br />
(eccettuati gli uccelli). Inoltre, non sono state compilate le caselle <strong>di</strong> intersezione con le specie <strong>di</strong><br />
flora e fauna protette in quanto, come precedentemente affermato, non sono presenti aree<br />
naturali protette all’interno della zona <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Per ciò che concerne il movimento degli automezzi, è già stato stabilito che verranno seguite solo<br />
strade già esistenti. Si ricorda ancora che il movimento degli automezzi, così come l’attività <strong>di</strong><br />
energizzazione, andrà ad interessare esclusivamente aree non protette, non tutelate e non <strong>di</strong><br />
pregio. Non sarà necessario la creazione <strong>di</strong> nuove strade <strong>di</strong> accesso, quin<strong>di</strong> l’impatto che essi<br />
avranno sul suolo è da considerarsi molto basso. L’impatto più alto è dato dal rumore e dalle<br />
vibrazioni prodotti dai mezzi durante il movimento. Il rumore comunque, come già stabilito, è<br />
previsto rientrare nei limiti <strong>di</strong> emissione acustica presso i potenziali ricettori presenti sul territorio.<br />
Anche le vibrazioni prodotte dal transito degli automezzi sono previste rimanere entro i limiti <strong>di</strong><br />
legge. Per quello che riguarda le emissioni gassose invece, non essendo previsti punti emissivi fissi,<br />
l’impatto sull’atmosfera è considerato del tutto trascurabile. È stata comunque assegnato un valore<br />
2-1 all’intersezione con la componente “qualità dell’aria”, mentre alle caselle corrispondenti alle<br />
componenti faunistiche e floristiche sono stati assegnati valori <strong>di</strong> grandezza 2 e valori <strong>di</strong> importanza<br />
pari a 1, data appunto il continuo spostamento dei mezzi e la durata limitata nel tempo dell’attività.<br />
È stato inoltre assegnato un valore 2/1 alla casella corrispondenti all’aspetto del paesaggio. Si noti<br />
che non sono state compilate le caselle <strong>di</strong> intersezione con le specie <strong>di</strong> flora e fauna protette in<br />
quanto non sono presenti aree naturali protette all’interno dell’area.<br />
Dall’esame dei risultati ottenuti si può dedurre che le componenti ambientali che più potrebbero risentire<br />
delle attività previste sono:<br />
Coltivazioni e copertura erbosa: alle caselle corrispondenti è stato assegnato un valore <strong>di</strong> 2-1<br />
all’intersezione con le attività <strong>di</strong> rilievo topografico e sten<strong>di</strong>mento/rimozione <strong>di</strong> cavi e geofoni (a<br />
causa dell’interazione che potrebbe avere il passaggio dei tecnici) e <strong>di</strong> movimento automezzi.<br />
Fauna: sono stati assegnati valori corrispondenti a 1-1 o 2-1 a causa della percezione che<br />
potrebbero avere animali ed insetti delle attività previste, in particolare del movimento <strong>di</strong><br />
automezzi e del passaggio dei tecnici. Per quanto riguarda gli uccelli presenti nell’area IBA<br />
(Important Bird Area) il potenziale impatto provocato dall’attività in progetto è legato alla
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
componente acustica dovuta al movimento degli automezzi. Tale impatto risulta comunque del<br />
tutto reversibile ed assimilabile a quello normalmente prodotto dalle macchine agricole in zona.<br />
Aspetto del paesaggio: è stato assegnato un valore <strong>di</strong> 2-1 alle caselle <strong>di</strong> intersezione con lo<br />
sten<strong>di</strong>mento/rimozione cavi e geofoni e il movimento automezzi, mentre all’intersezione con<br />
l’attività <strong>di</strong> energizzazione è stato assegnato un valore corrispondente a 1-1, consistendo<br />
quest’ultima in un’azione puntuale e limitata nel tempo.<br />
Gli ecosistemi, intesi come zone in cui sono presenti specie protette, non verranno influenzati dalle attività<br />
previste.<br />
5.9.3 Conclusioni<br />
Il progetto andrà ad insistere su un paesaggio <strong>di</strong> tipo misto, a<strong>di</strong>bito quasi totalmente all’uso agricolopastorale<br />
e costituito per la maggior parte da campi coltivati, da seminativi e colture <strong>di</strong> vario tipo. Essendo il<br />
progetto costituito da attività <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> superficie, non presenta impatti significativi a carico degli<br />
ecosistemi naturali e della fauna e flora ivi presenti, tranne che per la componente “inquinamento<br />
acustico”. Il problema è ovviato con l’osservanza <strong>di</strong> alcune prassi lavorative, ovvero mantenendo un<br />
adeguato raggio d’azione dei mezzi meccanici rispetto ai siti <strong>di</strong> maggior pregio naturalistico ed ambientale<br />
(si veda il Capitolo “Mitigazioni”). Con tali in<strong>di</strong>cazioni, si manterrà il livello acustico naturale delle aree sopra<br />
elencate e pertanto non si prevedono impatti significativi sugli ecosistemi.<br />
5.10 Impatti su aree protette SIC/ZPS<br />
Il territorio in cui ricade l’area dell’istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca idrocarburi denominata “La Capriola” non<br />
comprende al suo interno Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (Z.P.S.),<br />
rientranti nel progetto Rete Natura 2000. Quelle più vicine, localizzate esternamente all’area oggetto <strong>di</strong><br />
istanza, sono:<br />
la SIC/ZPS IT9220255 “Valle Basento - Ferran<strong>di</strong>na Scalo”, a nord-ovest dell’area in istanza;<br />
la SIC IT9220085 “Costa Ionica Foce Basento, a sud-est dell’area.<br />
Tali siti sono localizzati al <strong>di</strong> fuori del perimetro dell’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, ad una <strong>di</strong>stanza minima<br />
rispettivamente <strong>di</strong> 4.6 e 7.2 chilometri.<br />
Considerando la notevole <strong>di</strong>stanza, non è previsto alcun tipo <strong>di</strong> impatto, né <strong>di</strong> tipo acustico, né provocato<br />
dalle vibrazioni emesse dai vibrosises, la cui propagazione in superficie risulta estremamente limitata.<br />
Pertanto è da escludersi qualsiasi interferenza tra l’attività proposta ed i siti Rete Natura 2000 a<strong>di</strong>acenti<br />
all’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
113
6 MITIGAZIONI<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Nel caso <strong>di</strong> questa <strong>relazione</strong> il termine, “mitigazione” viene utilizzato col significato <strong>di</strong> “azione attuata al fine<br />
<strong>di</strong> non danneggiare l’ambiente”. Esso quin<strong>di</strong> non implica necessariamente effetti negativi sull’habitat <strong>di</strong><br />
specie che insistono all’interno dell’area in istanza.<br />
Considerando gli impatti analizzati nel precedente capitolo, si può dedurre che il progetto in esame non<br />
arrechi potenziali interazioni negative con la fauna, la flora o con la popolazione presenti nell’ambiente <strong>di</strong><br />
indagine. Tuttavia, è doveroso tenere in considerazione la componente progettuale riconducibile alla<br />
fattispecie dell’inquinamento acustico, la quale potrebbe arrecare <strong>di</strong>sturbo alla popolazione ed alla fauna<br />
presente nelle aree rurali.<br />
Attualmente, non sono ancora stati prodotti stu<strong>di</strong> sull’entità e sulla soglia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo acustico significativi<br />
verso la fauna presente in aree agricole. E’ probabile che l’interazione sia molto bassa, poiché tale fauna è<br />
abituata alla presenza antropica e delle macchine operatrici. Sono stati considerati i criteri espressi per la<br />
prevenzione della indebita esposizione al rumore <strong>di</strong> persone, con i limiti <strong>di</strong> legge stabiliti dal DPCM del<br />
14/11/1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” aventi la massima severità,<br />
ossia riferiti alle aree territoriali protette (Classe I). I limiti <strong>di</strong> legge sono <strong>di</strong> massimo rigore, pertanto il<br />
problema dell’inquinamento acustico in aree sensibili è risolto con la prescrizione a mantenersi a <strong>di</strong>stanze<br />
entro i limiti legislativi <strong>di</strong> sicurezza dalle aree urbane ed essendo comunque a debita <strong>di</strong>stanza dalle aree<br />
protette e dalle aree ad elevata valenza naturalistica, in quanto nessuna <strong>di</strong> esse risulta inclusa nell’area in<br />
istanza.<br />
6.1 Interventi <strong>di</strong> compensazione ambientale<br />
L’attività che verrà svolta si configura come attività <strong>di</strong> cantiere temporaneo mobile. Al fine <strong>di</strong> creare il minor<br />
<strong>di</strong>sagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo della rete stradale presente nonché<br />
l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli operatori e della popolazione. Inoltre, una volta<br />
ottenuta la titolarità del permesso <strong>di</strong> ricerca, sarà cura <strong>di</strong> Delta richiedere ai comuni interessati e/o alle<br />
province interessate i nulla osta per il passaggio dei mezzi sulle strade comunali e/o provinciali.<br />
Di seguito si riportano alcuni esempi degli interventi <strong>di</strong> compensazione che verranno adottati:<br />
Cartellonistica stradale in conformità con la legislazione locale: il cantiere temporaneo verrà<br />
evidenziato con apposita cartellonistica (Figura 6.1), inoltre agli automezzi verrà applicata sul retro<br />
adeguata segnaletica (Figura 6.2);<br />
Figura 6.1 - Esempio <strong>di</strong> cartellonistica stradale utilizzata durante le fasi <strong>di</strong> energizzazione lungo strada<br />
114
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 6.2 - Vibroseis evidenziati con apposita segnaletica luminosa<br />
Copricavi: qualora i cavi che collegano i geofoni dovessero attraversare la viabilità, verranno<br />
debitamente segnalati (Figura 6.3).<br />
Figura 6.3 - Copricavi segnalati<br />
Supervisore dell’attività: oltre al personale specializzato alla guida dei mezzi ed al coor<strong>di</strong>namento del<br />
traffico veicolare, tutte le attività vengono costantemente supervisionate da personale specializzato<br />
(Figura 6.4);<br />
115
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 6.4 - Supervisore all’attività <strong>di</strong> energizzazione<br />
Coor<strong>di</strong>namento del traffico veicolare: ad inizio e fine convoglio sarà presente del personale tecnico,<br />
vestito con indumenti ad alta visibilità, che si occuperà del coor<strong>di</strong>namento della viabilità (Figura 6.5 e<br />
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).<br />
Figura 6.5 - Coor<strong>di</strong>namento traffico veicolare<br />
116
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Figura 6.6 - Personale addetto al coor<strong>di</strong>namento veicolare vestito con indumenti ad alta visibilità<br />
Posizionamento <strong>di</strong> cavi e geofoni senza danneggiare la vegetazione: la stesura dei cavi ed il<br />
posizionamento dei geofoni verrà effettuato manualmente dai tecnici della squadra sismica utilizzando<br />
dei pali il cui scopo è quello <strong>di</strong> mantenere i cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione.<br />
Figura 6.7 – Cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione e/o le colture<br />
Di seguito vengono riassunte schematicamente le misure <strong>di</strong> mitigazione proposte durante lo svolgimento<br />
dell’attività <strong>di</strong> rilievo geofisico:<br />
117
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Tipo <strong>di</strong> attività Eventuali impatti Mitigazioni proposte<br />
Sten<strong>di</strong>mento cavi e<br />
posizionamento geofoni<br />
Energizzazione (Vibroseis)<br />
Occupazione <strong>di</strong> suolo,<br />
impatto su manto<br />
erboso<br />
Occupazione <strong>di</strong> suolo,<br />
interferenze su flora e<br />
fauna locali, emissioni<br />
acustiche, vibrazioni<br />
Sono previsti: il ripristino del manto vegetale<br />
superficiale se danneggiato, l’esecuzione dell’attività<br />
tenendo sollevati i cavi per non danneggiare la<br />
vegetazione e/o le colture.<br />
Sono previsti: il ripristino del manto vegetale<br />
superficiale se danneggiato, l’esecuzione dell’attività a<br />
<strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> sicurezza da ricettori sensibili, la riduzione<br />
al minimo delle emissioni acustiche e delle vibrazioni,<br />
l’uso della viabilità esistente, l’esclusione del taglio<br />
della vegetazione arborea, l’in<strong>di</strong>viduazione dei<br />
percorsi d’accesso all’area meno interferenti con gli<br />
habitat naturali. L’intera attività verrà eseguita in<br />
sicurezza, me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> opportuna<br />
cartellonistica e personale addetto specializzato.<br />
Si ricorda che l’attività non prevede movimentazione o scavi <strong>di</strong> terreno e verrà svolta utilizzando la rete<br />
stradale e le strade rurali presenti all’interno del permesso <strong>di</strong> ricerca.<br />
118
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
7 SINTESI NON TECNICA<br />
L’istanza <strong>di</strong> permesso per la ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” ricopre un’area <strong>di</strong> 188,1 km 2 ed<br />
è ubicata nella parte sud-occidentale della regione Basilicata, ricadendo interamente provincia <strong>di</strong> Matera. I<br />
Comuni interessati dall’area dell’istanza sono: Montescaglioso, Pomarico, Pisticci, Bernalda e, per una<br />
piccolissima parte, Montalbano Jonico.<br />
L’area <strong>di</strong> ricerca presenta tutte le caratteristiche geologiche per poter essere considerata <strong>di</strong> notevole<br />
interesse minerario, pertanto viene proposta un’indagine geofisica che, attraverso l’acquisizione e<br />
l‘interpretazione <strong>di</strong> dati registrati in superficie, consenta <strong>di</strong> ottenere un‘immagine del sottosuolo e <strong>di</strong><br />
verificare l’eventuale presenza <strong>di</strong> idrocarburi.<br />
Il territorio interessato dall’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è <strong>di</strong> tipo misto, da pianeggiante a collinare-montuoso,<br />
caratterizzato da bassa antropizzazione e da un uso predominante del suolo per scopi agricoli e pastorali.<br />
Le attività oggetto del presente stu<strong>di</strong>o si configurano come attività <strong>di</strong> cantiere temporaneo, non si<br />
prevedono quin<strong>di</strong> opere permanenti.<br />
La Società Delta Energy Ltd è stata fondata da professionisti nel settore della ricerca e produzione <strong>di</strong><br />
idrocarburi con una consolidata esperienza lavorativa in Europa, sud-est Asiatico, Australia, Africa, America<br />
settentrionale e meri<strong>di</strong>onale; la loro strategia innovativa permetterà <strong>di</strong> costruire un modello esplorativo<br />
all’avanguar<strong>di</strong>a per lo sviluppo <strong>di</strong> progetti trascurati da altre compagnie in quanto non considerati<br />
economicamente vantaggiosi. La politica <strong>di</strong> Delta Energy è basata sulla trasparenza, sulla comunicazione e<br />
sulla cooperazione, per cui il contatto con il pubblico risulta <strong>di</strong> fondamentale importanza, sia per quanto<br />
riguarda i privati citta<strong>di</strong>ni che gli enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si prefigge <strong>di</strong> ascoltare<br />
i bisogni delle comunità locali ed interagire con esse, instaurando un rapporto <strong>di</strong> collaborazione, e<br />
partecipare alla creazione <strong>di</strong> benefici per il territorio.<br />
Gli obiettivi minerari principali dell’area in istanza sono rappresentati da idrocarburi gassosi e liqui<strong>di</strong> nei<br />
carbonati della piattaforma Apula, nella serie calcarenitica del Terziario e nei livelli sabbiosi <strong>di</strong> origine<br />
torbi<strong>di</strong>tica del Pliocene-Pleistocene. L’obiettivo del programma lavori proposto è la completa valutazione<br />
delle potenzialità geo-minerarie del sottosuolo nell'area in istanza, ed in particolare sulla possibile presenza<br />
<strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> idrocarburi economicamente sfruttabili.<br />
Il programma lavori <strong>di</strong> Delta Enegry Ltd. prevede due fasi operative principali: una fase <strong>di</strong> esplorazione,<br />
proprosta nel presente stu<strong>di</strong>o, ed un’eventuale successiva fase <strong>di</strong> perforazione. Infatti, qualora gli stu<strong>di</strong><br />
svolti in questa fase confermino le potenzialità minerarie dell'area, Delta Energy Ltd si impegna a perforare<br />
almeno un pozzo esplorativo. È importante precisare che l’eventuale fase <strong>di</strong> perforazione dovrà essere<br />
oggetto <strong>di</strong> una nuova proposta progettuale da sottoporre alla necessaria valutazione ambientale.<br />
L’indagine geofisica proposta consiste nella generazione <strong>di</strong> un’onda elastica prodotta da una sorgente <strong>di</strong><br />
energia chiamata Vibroseis. Quest’onda elastica penetra nel sottosuolo, che è un mezzo non omogeneo (le<br />
<strong>di</strong>scontinuità litologiche mo<strong>di</strong>ficano la struttura e la velocità <strong>di</strong> propagazione dell’onda), si riflette e ritorna<br />
in superficie. La registrazione ed il successivo esame dell’onda che ritorna in superficie permettono <strong>di</strong><br />
creare un’immagine delle strutture presenti nel sottosuolo.<br />
Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego<br />
organizzativo: in me<strong>di</strong>a una squadra sismica è composta da circa 30-50 persone con la presenza <strong>di</strong> mano<br />
d’opera locale. I tecnici contatteranno i proprietari dei terreni che ricadono all’interno del permesso <strong>di</strong><br />
ricerca, consegnando loro degli opuscoli illustranti il progetto; verranno anche organizzati incontri <strong>di</strong><br />
gruppo per <strong>di</strong>scutere tutte le eventuali perplessità dei citta<strong>di</strong>ni.<br />
L‘attività in oggetto determina la produzione <strong>di</strong> vibrazioni o impulsi (onde elastiche) la cui propagazione in<br />
superficie risulta estremamente limitata, si tratta in ogni caso <strong>di</strong> effetti che non arrecano potenziali impatti<br />
negativi con la fauna, la flora e con la popolazione presenti nell’ambiente <strong>di</strong> indagine.<br />
L’occupazione <strong>di</strong> suolo è un fattore d‘impatto e durata limitata nel tempo in quanto al termine delle<br />
operazioni, si provvede al recupero delle attrezzature ed alla restituzione dell’area alla originaria<br />
119
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
destinazione d‘uso. Inoltre, l’impatto potenziale durante la fase <strong>di</strong> cantiere è estremamente ridotto, dato<br />
che le attrezzature presentano modeste <strong>di</strong>mensioni e, <strong>di</strong> fatto, l’attività è assimilabile al passaggio ed alla<br />
temporanea sosta <strong>di</strong> macchine agricole.<br />
Per quanto riguarda la qualità dell‘aria si ritiene che le attività oggetto del presente stu<strong>di</strong>o possano<br />
provocare impatti del tutto trascurabili e determinati dalle sole emissioni deigli automezzi in azione.<br />
Non si prevede la produzione <strong>di</strong> rifiuti.<br />
Al fine <strong>di</strong> evitare alla popolazione presente nelle abitazioni residenziali un’eventuale esposizione al rumore,<br />
tutte le attività in oggetto si terranno a <strong>di</strong>stanze tali da rispettare i limiti <strong>di</strong> legge.<br />
L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede<br />
l’approvvigionamento idrico superficiale e sotterraneo e non sono previsti scarichi né <strong>di</strong> acqua, né <strong>di</strong> reflui<br />
legati all’attività <strong>di</strong> acquisizione sismica.<br />
Per quanto riguarda i possibili impatti sulla salute pubblica, è opportuno precisare che durante lo<br />
svolgimento della campagna <strong>di</strong> acquisizione geofisica non si produrranno emissioni <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni ionizzanti<br />
e/o non ionizzanti, pertanto non si prevede alcun rischio per la popolazione, la quale non sarà esposta ad<br />
alcun tipo <strong>di</strong> interferenza in grado <strong>di</strong> determinare effetti sulla salute umana.<br />
Essendo il progetto costituito da attività <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> superficie, non presenta impatti significativi a carico<br />
degli ecosistemi naturali e della fauna e flora ivi presenti, tranne che per la componente acustica,<br />
comunque contenuta. I limiti <strong>di</strong> immissione in aree particolarmente protette e aree prevalentemente<br />
residenziali, rispetto ad una sorgente sonora quale il Vibroseis, vengono rispettati già ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 100<br />
m. Nel caso in cui le opere <strong>di</strong> indagine richiedano l’intervento operativo a <strong>di</strong>stanze inferiori, per far fronte al<br />
superamento dei limiti assoluti <strong>di</strong> immissione e dei limiti <strong>di</strong>fferenziali presso i ricettori sensibili, il<br />
committente provvederà preventivamente a richiedere un’autorizzazione in deroga alle competenti<br />
amministrazioni comunali coinvolte.<br />
Il territorio in cui ricade l’area dell’istanza non comprende al suo interno Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria<br />
(S.I.C.) o Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (Z.P.S.), rientranti nel progetto Rete Natura 2000, pertanto è da<br />
escludersi qualsiasi interferenza tra l’attività proposta ed aree naturali protette.<br />
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico dell’area, il settore maggiormente interessato è quello centrale<br />
del blocco con andamento NO-SE e coincide con le aree limitrofe al letto del Fiume Basento. L’altro settore<br />
del blocco interessato da rischio esondazione, anche se con entità chiaramente minori poiché legate al<br />
minore corso d’acqua del Cavone, è quello sud-occidentale.<br />
L’area presa in esame dal presente stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>screening</strong> ricada nelle zone sismiche 2 e 3 ad un livello <strong>di</strong><br />
pericolosità sismica me<strong>di</strong>o-bassa. Si precisa che l’attività oggetto del presente stu<strong>di</strong>o non prevede la<br />
realizzazione alcuna <strong>di</strong> opere soggette a tale rischio e non interferirà in alcun modo con il già presente<br />
rischio né potrà essere causa <strong>di</strong> insorgenza <strong>di</strong> eventi sismici. Non sono pertanto previsti rischi a carico della<br />
componente antropica o ambientale.<br />
Al fine <strong>di</strong> creare il minor <strong>di</strong>sagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo della rete<br />
stradale presente nonché l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli operatori e della<br />
popolazione.<br />
Per tutte le sopra citate osservazioni, lo stu<strong>di</strong>o preliminare ambientale non evidenzia potenziali impatti<br />
negativi a carico della fauna, della flora e della popolazione presente nell’ambiente <strong>di</strong> indagine. Pertanto,<br />
il programma lavori proposto per l‘area del permesso <strong>di</strong> ricerca “La capriola” risulta, nel complesso,<br />
compatibile con quanto previsto dai piani territoriali e dai vincoli normativi esposti.<br />
120
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
8 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA<br />
Aguilera R (1995). Naturally Fractured Reservoirs, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma.<br />
André P., Doulcet A. (1991). Rospo Mare Field–Italy, Apulian Platform, Adriatic Sea, in Treatise of Petroleum<br />
Geology, Atlas of Oil and Gas Fields, Stratigraphic Traps II (eds. E.A Beaumont and N.H. Foster),<br />
American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, pp. 29–54.<br />
Atkinson, Mere<strong>di</strong>th (1987). Experimental fracture mechanics data for rocks and minerals. pp 477 – 525.<br />
Avraham Z.B., Boccaletti M., Cello G., Grasso M., Letini F., Torelli L., Tortorici L. (1990). Principali domini<br />
strutturali originatisi dalla collizione neogenico – quaternaria nel Me<strong>di</strong>terraneo Centrale. Mem. Soc.<br />
Geol. It., 45, 453-462.<br />
Boccaletti M., Ciaranfi N., Cosentino D., Deiana G., Gelati R., Lentini F., Massari F., Moratti G., Pescatore T.,<br />
Ricci Lucchi F., Tortorici L. (1999). Palinspastic restoration and paleogeographic reconstruction of the<br />
peri – Tyrrhenian area during the neogene. Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 77, 41-<br />
50.<br />
Carannante G., Pugliese A., Ruberti D., Simone L., Vigliotti M., Vigorito M. (2009). Evoluzione cretacica <strong>di</strong> un<br />
settore della piattaforma apula da dati <strong>di</strong> sottosuolo e <strong>di</strong> affioramento (Appennino campano –<br />
molisano). Ital. J. Geosci. (Boll. Soc. Geol. It), 128, 3-31.<br />
Carannante G., D’argenio B., Dello Iacovo B., Ferreri V., Mindszenty A., & Simone L. (1988). Stu<strong>di</strong> sul<br />
carsismo cretacico dell'appennino campano. Memorie della Società Geologica Italiana, 41, 733-759.<br />
Carminati E. and C Doglioni (2004). Me<strong>di</strong>terranean Tectonics. Elsevier Ltd.<br />
Casne<strong>di</strong> R. (1998). Subsurface basin analysis of fault-controlled turbi<strong>di</strong>te system in Bradano Trough,<br />
Southern Adriatic Foredeep, Italy. The American Associationof Petyroleum Geologists Bulletin, 72,<br />
1370-1380.<br />
Compagnoni B., Galluzzo F., (2004). Geological Map of Italy.<br />
De Marco G. , e Caneva G. (1984). Analisi sintassonomica e fitogeografica comparata <strong>di</strong> alcune significative<br />
cenosi a Pinus halepensis Mill. in Italia.<br />
Di Cuia R., Shakerley A., Masini M., Casabianca D. (2009). Integrating outcrop data at <strong>di</strong>fferent scales to<br />
describe fractured carbonate reservoirs: Example of the Maiella carbonates, Italy: First Break, vol.<br />
27(3), p. 45-55.<br />
Doglioni C., Fernandez M., Gueguen E., Sàbat F. (1999). On the interference between the early Apennines-<br />
Maghrebides back arch extention and Alps-Betics orogen in the Neogene Geodynamics of the Western<br />
Me<strong>di</strong>terranea. Boll. Soc. Geol. It., 118, 75-89, 11 ff.<br />
Doulcet A., Cazzola C., Marinelli S., (1990), Il campo <strong>di</strong> Rospo Mare: un esempio <strong>di</strong> paleokarst petrolifero,<br />
Memorie della Società Geologica Italiana, vol. 45, n.2, pp. 783-789.<br />
Finetti I., Lentini F., Carbone S., Catalano S., Del Ben A. (1996). Il sistema Appennino Meri<strong>di</strong>onale – Arco<br />
Calabro – Sicilia nel me<strong>di</strong>terraneo centrale: stu<strong>di</strong>o geologico–geofisico. Boll. Soc. Geol. It., 115, 529 –<br />
559.<br />
Finetti I. (2005), CROP Project: Deep Seismic Exploration of the Central Me<strong>di</strong>terranean and Italy, Atlases<br />
Geosci., vol. 1, Elsevier, New York.<br />
Gross et al (1995). Effect of <strong>di</strong>fferent supplementary cementitious materials on mechanical properties of<br />
high performance concrete Cement and Concrete Research Volume 25, Issue 1, Pages 209-220.<br />
Holton, (1999). Southern Apennines success bodes well for potential off southern Italy. Oil and Gas Journal,<br />
29/11/1999.<br />
Ladeira F.L., & Price N.J. (1981). Relationship between fracture spacing and bed thickness. Journal of<br />
Structural Geology, Volume 3, Issue 2, Pages 179-183.<br />
121
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Lentini F., Carbone S., Di Stefano A., Guarnieri P., (2002). Stratigraphical and structural constrains in the<br />
Lucanian Apennines (southern Italy): tools for reconstructing the geological evolution. In Journal of<br />
Geodynamics 34, 141-158.<br />
Lentini F., Catalano S., Carbone s., (1996). The external thrust system in the southern Italy: a target for<br />
petroleum exploration. Petroleum Geoscience , 2, 333-342.<br />
Leopold L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. (1971). A procedure for evaluating environmental<br />
impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C.<br />
Masini M (2007). Strain pre<strong>di</strong>ction using cross-section restoration. M.Sc. Thesis, Royal Holloway, Univ. of<br />
London.<br />
Mateu-Vicens G., Pomar L.,Tropeano M., (2008), Architectural complexity of a carbonate trangessive<br />
systems tract induced by basement physiography . Se<strong>di</strong>mentology, 55, 1815-1848.<br />
Mattavelli L., Novalli L., (1990), Geochemistry and Habitat of the Oils in Italy. The American Association of<br />
Petroleum Geologist Bulletin, 74, 1623-1639.<br />
Mazzoli S., Barkham S., Cello G., Gambini R., Mattinoni L., Shiner P., Ton<strong>di</strong> E., (2001), Reconstruction of<br />
continental margin architecture deformed by the contraction of the Lagonagro Basin, southern<br />
Apennines, Italy. Journal of the Geological Society, 158, 309-319.<br />
Morelli A., Bonar<strong>di</strong> G., Colonna V., Dietrich D., Giunta G., Ippolito F., Liguori V., Lorenzoni S., Paglionico A.,<br />
Perrone V., Piccarretta G., Russo M., Scandone P., Zanettini – Lorenzioni E., Zuppetta A., (1976), L’arco<br />
Calabro - Peloritano nell’Orogene Appenninico Magrebide. Mem. Soc. Geol. It, 17, 1-60.<br />
Mosca F., Sciamanna S., Sassi W., Rudkiewicz J.L., Gambibi R., (2004), Pre<strong>di</strong>cting hydrocarbon generation<br />
and expulsion in the Southern Apennines Thrust belt by 2-D integrated structural and geochemical<br />
modeling: part II – geochemical modeling.<br />
Ogniben L., (1969) - Schema introduttivo all. geologia del Confine calabro-Iucano, Mem. Soc. Geol. ltal.,<br />
8,453-763,1969.<br />
Parotto M., Praturlon A., (2004), The southern Apennine arc. Special Volume of the Italian Geological Society<br />
for the IGC 32, 33-58.<br />
Patacca E., Scandone P. (2001). Late thrust propagation and se<strong>di</strong>mentary response in the thrust beltforedeeep<br />
system of the Southern Apennines (Pliocene – Pleistocene). In: VAI G.B., Martini I.P. (Eds.): “<br />
Anatomy of a mountain: The Apennines and adjacent Me<strong>di</strong>terranean basins”. Kluwer Academic<br />
Publishers, 401-440.<br />
Patacca E., Scandone P., (2007). Geology of the Southern Apennines, Boll. Soc. Geol. It., Spec. Issue, 7, 75-<br />
119.<br />
Peacock, D. C. P., & Mann, A. (2005). Evaluation of the Controls on Fracturing in Reservoir Rocks. Journal of<br />
Petroleum Geology, 28(4), 385-396.<br />
Pollard D.D. and A. Ay<strong>di</strong>n, (1988). Progress in understan<strong>di</strong>ng jointing over the past one hundred<br />
years.Geological Society of America Bulletin, v. 100, p. 1181-1204.<br />
Price N. J. (1966). Fault and joint development in brittle and semi-brittle rock. Pergamon Press, New York,<br />
176 p.<br />
Rohrbaugh Jr et Al, (2002). Estimating Fracture Trace Intensity, Density, and Mean Length Using Circular<br />
Scan Lines and Windows, AAPG Bulletin; v. 86; no. 12; p. 2089-2104.<br />
Sella M., Turci C., Riva A., (1988). Sintesi geominerarion della fossa bradanica (avanfossa della catena<br />
appenninica meri<strong>di</strong>onale). Mem. Soc. Geol. It., 41, 87-107.<br />
Shaocheng et al., (1998). A revised model for the relationship between joint spacing and layer thickness.<br />
Journal of Structural Geology, Volume 20, Issue 11, Pages 1495-1508.<br />
122
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
Sharkeley A (2007). Fracture network characteristics and impact on reservoir connectivity: the example of<br />
the cretaceous to tertiary carbonates of Maiella mountain (Italy). Master of Science Thesis Iin<br />
Petroleum Geology, Imperial College, Univ. of London.<br />
Shiner P., Beccaccini A., Mazzoli B., (2004). Thin-skinned versus thick-skinned structural models for Apulian<br />
carbonate reservoirs: constraints from the Val d’Agri Fields, S Appennines, Italy. Marine and<br />
Petroleum Geology, 21, 805-827.<br />
Steckler S. M., Agostinetti P. N., Wilson C.K., Roselli P., Seeber L., Amato A., Lerner – Lam A., Crustal<br />
structure in the Southern Apennines from teleseismic receiver functions. The Geology Society of<br />
America., 36, 155-158.<br />
Stossel I., (1999). Ru<strong>di</strong>sts and Carbonates Platform Evolution: the Late Cretaceous Maiella Carbonate<br />
Platform Margin, Abruzzi, Italy. Mem. Sc. Geol., v.51/2, 333-413.<br />
Tavarnelli E., (1996). The effects of pre-existing normal faults and on thrust ramp development: an example<br />
from the northern Apennines, Italy. Geologische Rundschau, 85, 363-371.<br />
Tavarnelli E., Prosser G., (2003). The complete Apennine orogenic cycle preserved in a transient single<br />
outcrop near San Fele, Lucania, southern Italy. Journal of the Geological Society, London, 160, 429-<br />
434.<br />
Turrini C., Renninson P., (2004). Structural style from the southern Apennines’ hydrocarbon province – an<br />
integrated view. In MClay K.R., Thrust tectonics and hydrocarbon system, AAPG Memoir 82, 558-578.<br />
Van Dijk J.P., Bello M., Toscano C., Bersani A., Nardon S., (2000). Tectonic model and three-<strong>di</strong>mensional<br />
fracture network analysis of Monte Alpi (southern Apennines). Tectonophysics, 324, 203 -237.<br />
Wennberg O. P., Svana T., Azizzadeh M., Aqrawi A. M. M., Brockbank P., Lyslo K. B. and Ogilvie S. (2006).<br />
Fracture intensity vs. mechanical stratigraphy in platform top carbonates: the Aquitanian of the<br />
Asmari Formation, Khaviz Anticline, Zagros, SW Iran, Petroleum Geoscience; v. 12; no. 3; p. 235-246.<br />
Zappaterra E., (1994). Source rock <strong>di</strong>stribution model of the Periadriatic Region. AAPG Bulletin, 1994, 78,<br />
333-354.<br />
basilicata.po<strong>di</strong>s.it<br />
cart.ancitel.it<br />
cartadellanatura.isprambiente.it<br />
leggiurbanistiche.wordpress.com<br />
rs<strong>di</strong>.regione.basilicata.it<br />
unmig.sviluppoeconomico.gov.it<br />
vnr.unipg.it/habitat<br />
www.aptbasilicata.it<br />
www.basilicata.beniculturali.it<br />
www.basilicatanet.it/suoli<br />
www.birdlife.org<br />
www.comune.bernalda.matera.it<br />
www.comune.montalbano.mt.it<br />
www.comune.montescaglioso.mt.it<br />
Sitografia<br />
123
www.comune.pisticci.mt.it<br />
Istanza <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> idrocarburi denominata “La Capriola” Delta Energy ltd.<br />
www.comune.pomarico.mt.it<br />
www.<strong>di</strong>strettosolofra.com<br />
www.il<strong>di</strong>strettoidrograficodellappenninomeri<strong>di</strong>onale.it<br />
www.isprambiente.gov.it<br />
www.lipu.it<br />
www.old.consiglio.basilicata.it<br />
www.osservatoriovaldagri.it<br />
www.protezionecivile.gov.it<br />
www.retegeofisica.it<br />
www.uccellidaproteggere.it<br />
www.vulcani.ingv.it<br />
124