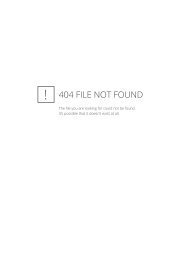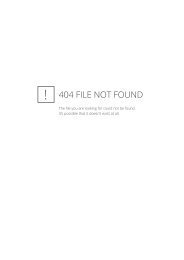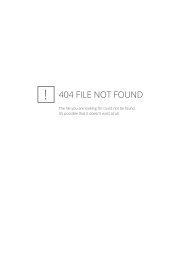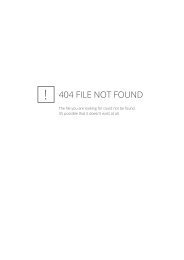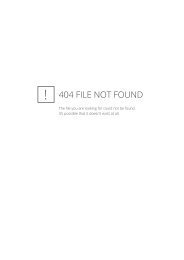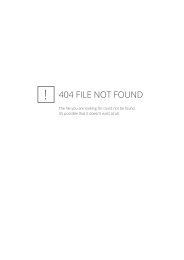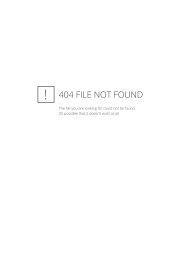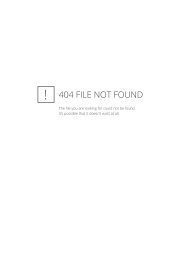Dispensa 7 - Corsoarcheologia.org
Dispensa 7 - Corsoarcheologia.org
Dispensa 7 - Corsoarcheologia.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Costantinopoli e il mondo bizantino<br />
Capitolo 7<br />
Appunti a cura di Sandro Caranzano , riservati<br />
ai fruitori del corso di archeologia presso<br />
l'Università Popolare di Torino 2008-2009.<br />
Lezioni tenute il 20 e 27/01/2009<br />
7.1. – Breve storia delle genesi dell’impero bizantino<br />
La data di nascita di un mondo pienamente bizantino è dibattuta. Il grande storico bizantino<br />
Ostrogovsky, per esempio, ha proposto che solo con Eraclio si possa parlare di un oriente<br />
romano del tutto autonomo e indipendente. In ogni caso la fondazione di Costantinopoli alla<br />
foce del Bosforo sui resti dell’antica Bisanzio da parte di Costantino fu un passo<br />
indispensabile ma non sufficiente, dal momento che non era probabilmente nelle intenzioni<br />
dell’imperatore creare una città antagonista a Roma. L’investimento di capitali e risorse nella<br />
nuova Costantinopoli fu probabilmente uno strascico della tendenza già presente ai tempi<br />
della tetrarchia di abbellire o fondare città in posizioni strategiche da utilizzare per il<br />
controllo amministrativo e militare di un impero molto vasto (ricordiamo a questo titolo le<br />
dimensioni raggiunte da Arles, Treviri, Milano, Tessalonica, Milano etc.)<br />
Dal punto di vista politico molti ravvisano nella criterio scelto da Teodosio I per la<br />
successione un momento strategico che avrebbe segnato l’inizio di una separazione sempre<br />
più netta, anche sul piano culturale, tra occidente o oriente. Teodosio morendo nel 395,<br />
spartì il regno tra i due giovani figlioletti Arcadio (in oriente) e Onorio (in occidente) che<br />
posti sotto la tutela di consiglieri: in particolare Arcadio – di soli 7 anni - era influenzato dai<br />
consiglieri di corte eunuchi (in particolare Rufino e Eutropio) mentre Onorio si appoggiava al<br />
generale barbarico Silicone. I due giovani imperatori molto presto incominciarono a<br />
sospettare vicendevolmente mentre la rivendicazione del governo delle province di Tracia e<br />
dell’Illirico erano motivo di disputa tra le due parti dell’Impero. Nel 402-3 il settore<br />
occidentale fu messo in pericolo dalle scorrerie perpetuate dai Goti di Radegaiso e poi nel<br />
407 dai Goti di Alarico che ebbero l’ardire di passare le Alpi e saccheggiare la Pianura<br />
Padana. Silicone riuscì a respingere i nemici nelle famose battaglie di Pollenzo (non lontano<br />
da Bra) e di Mantova; in seguito, però, divenne oggetto di invidia e fu screditato a corte (che<br />
vedeva in lui un capo germanico sempre pronto a scendere a patti con i nemici per il proprio<br />
personale interesse). Così Stilicone, il figlio Eucherio e la moglie Serena furono richiamati<br />
alla corte di Ravenna e decapitati dall’Imperatore. In un’Italia priva di un esercito addestrato<br />
e ben coordinato la situazione declinò molto rapidamente.<br />
Fig. 44 – Busto di Teodosio II da Costantinopoli / Fig 45. L’impero romano ai tempi di Teodosio II<br />
Le orde di Alarico giunsero per due volte sin sotto le mura di Roma e non contente di aver<br />
innalzato alla porpora uno sbiadito senatore di nome Attalo, nel 410 saccheggiarono la città.<br />
In Oriente, alla morte di Arcadio, andò al potere Teodosio II che si mantenne sempre in<br />
ottimi rapporti con Galla Placidia che invece non mancava di litigare con il fratello, Onorio.<br />
L’esperienza vissuta dall’occidente consigliò ad Arcadio e al suo reggente, il prefetto al<br />
Pretorio Flavio Antemio, di dare una nuova potente cinta di mura a Costantinopoli. Nel 413<br />
41
venne così costruita in fretta e furia la cinta che vediamo ancora oggi estendersi dal Corno<br />
d’Oro fino al Mar di Marmara (Propontide).<br />
Nel 423, in occidente, moriva Onorio e saliva al potere – alla modesta età di 6 anni e sotto la<br />
tutela della madre - l’imperatore Valentiniano III, figlio di Galla Placidia (la sorella di<br />
Onorio) e di un nobile romano (Costanzo III): gli Unni guidati da Attila dopo aver messo a<br />
ferro e a fuoco le Gallie, scesero in Italia e vennero fermati sul Mincio dalla missione di papa<br />
Leone I. L’ultima grande battaglia dell’esercito romano contro una coalizione di barbari fu<br />
guidata ai famosi Campi Catalaunici dal generale romano barbarico Ezio (Etzel in<br />
germanico) che si era imposto come protettore dell’impero. Valentiniano III si sposava ora<br />
con Licinia Eudossia, la figlia dell’imperatore d’Oriente Teodosio II (indotto dalla sorella<br />
Pulcheria - una fervente cristiana grande fautrice della verginità - a impalmare Elia<br />
Eudossia). Teodosio II fu, in questi anni, un po’ il segreto coordinatore delle vicende<br />
politiche dell’occidente.<br />
Il periodo non era dei più propizi perché negli stessi anni (439), i Vandali, insediati in<br />
Spagna, spinti ad oriente dall’arrivo dei Visigoti, avevano passato lo stretto di Gibilterra<br />
conquistando l’Africa romana proconsolare e Cartagine. Come noto, durante l’assedio della<br />
città africana di Ippona perse anche la vita Agostino che nel frattempo aveva provveduto a<br />
scrivere il famoso libro “la città di Dio”. Nel 454 Valentiniano III, forse mal consigliato a<br />
corte, dopo aver convocato a palazzo Ezio lo uccise con un colpo di spada; Ezio fu vendicato<br />
qualche tempo dopo da alcuni guerrieri sciri aizzati dal senatore Massimo. Valentiniano II<br />
morì determinando la fine della dinastia e lasciando l’impero privo di un valido comandante<br />
militare. Intanto i Vandali, messe le mani sulla flotta romana, bloccarono il rifornimento di<br />
grano africano da cui dipendeva l’impero (annona). Trasformatisi ora anche in marinai<br />
sbarcarono in centro Italia perpetuando nel 455 un nuovo e traumatizzante sacco di Roma.<br />
Fig. 46 Dittico di Onorio dal tesoro di Aosta / Fig 47- estensione dell’impero d’occidente alla morte di Teodosio I / Fig. 48 Busto di Onorio<br />
Nel 450, in Oriente, Teodosio moriva spezzandosi la schiena per una caduta da cavallo.<br />
Aveva garantito allo spezzone orientale dell’impero la sopravvivenza alla prima dura serie di<br />
invasioni barbariche e promulgato l’importantissimo codice teodosiano, una raccolta di leggi<br />
che avrebbe fatto la felicità dei giuristi medievali e del futuro imperatore Giustiniano.<br />
Nel 451 andava al potere in Oriente l’imperatore Marciano che per garantirsi una<br />
legittimazione politica sposava la virtuosa sorella di Teodosio II, Pulcheria. In questo periodo<br />
l’oriente era scosso da importanti dibattiti teologici sulla natura di Cristo. I patriarcati di<br />
Roma, Gerusalemme, Antiochia, Alessandria e Costantinopli si contendevano il favore a<br />
corte e il peso sullo scacchiere mediterraneo sostenendo specifiche tesi che trovavano<br />
l’appoggio di particolari settori della società romana. In particolare nell’area antiochena<br />
aveva ricevuto un certo favore la tesi di Nestorio secondo cui in Cristo erano presenti due<br />
nature distinte , quella umana e quella divina. Tale teoria metteva in crisi il Credo già<br />
enunciato nel 325 alla presenza di Costantino nel famoso concilio di Nicea e rischiava di<br />
evidenziare la natura umana di Cristo nel momento della sua incarnazione. Dall’altra parte, il<br />
patriarca di Alessandria, influenzato dalle teorie del monaco Eutiche, aveva teorizzato il<br />
monofisismo secondo cui la parte carnale di Cristo si era parzialmente dissolta in quella<br />
divina. L’imperatore Marciano è noto per aver convocato nel 451 a Calcedonia un famoso<br />
concilio con cui le teorie eretiche furono condannate. Nestorio, in particolare, fuggì<br />
dall’Impero presso i nemici storici dei bizantini, i Sasanidi, dove diede origine ad una<br />
comunità cristiana eretica.<br />
Nel 457, morto Zenone andò al potere in Oriente Leone I che dovette far fronte alla influenza<br />
sempre più marcata dei barbari e in particolare del capo goto Aspar. Leone I scelse così di<br />
appoggiarsi per la prima volta ad un comandante isaurico (l’Isauria era una regione<br />
42
dell’Anatolia che aveva come centro l’attuale Antalia), Zenone I, che fu associato al potere in<br />
una posizione secondaria ma che poi, per una serie di fortunate vicende, ereditò l’impero alla<br />
morte di Leone I , nel 474.<br />
Intanto l’Africa occupata dai Vandali continuava ad essere un problema irrisolto. A nulla<br />
servirono le azioni coordinate dall’imperatore d’occidente Antemio (nel 568) per un colpo di<br />
mano in Africa e neanche quelle condotte, in parallelo, dal cognato dell’imperatore bizantino<br />
Leone I, Basilisco, che dopo alcune azioni a Capo Bon fu costretto a scendere a patti con il re<br />
vandalo Genserico e a rientrare a Bisanzio con la flotta gravemente dnneggiata.<br />
Nel 476 il mal ridotto impero d’occidente subiva la deposizione del famoso Romolo<br />
Augustulo e il potere preso da Odoacre, figlio del comandante della guardia scira a Ravenna.<br />
Odoacre riconobbe la sovranità di Bisanzio sull’occidente ma essendo barbaro non ottenne<br />
mai le insegne imperiali e fu nominato semplicemente magister militum per Italiam.<br />
Sotto Zenone nacquero nuovi problemi con i Goti insediati nella Mesia (guidati da Teodorico<br />
della dinastia degli Amali) e in Tracia (guidati da Teodorico Strabone); la morte di Teodorico<br />
Strabone non impedì a Teodorico di riversarsi nelle terre al di qua del Danubio a causa del<br />
mancato rispetto dei patti da parte dell’imperatore bizantino. Questo riuscì a sbarazzarsi<br />
delle orde barbariche innalzando Teodorico come comandante delle truppe dell’Illirico e<br />
spedendolo in Italia nella speranza che si logorasse nella lotta contro Odoacre. Nel 493,<br />
tuttavia, inaspettatamente Teodorico riuscì ad avere ragione di Odoacre e si insediò a<br />
Ravenna inaugurando un tentativo di coesistenza tra romani e germani del tutto nuovo.<br />
Anche lui non ricevette le insegne da Costantinopoli in quanto barbaro ma il titolo onorifico<br />
di patricius. L’esperimento non sarebbe andato a buon fine anche per l’ostilità delle elité<br />
romane e così Teodorico, dopo aver promosso la costruzione di alcune chiese e battisteri di<br />
un certo pregio per i cattolici e gli ariani nella stessa Ravenna (si pensi al battistero degli<br />
ariani o a sant’Agata), si irrigidì eliminando personaggi eminenti come il senatore Cassiodoro<br />
o lo stesso filosofo Severino Boezio che avrebbe scritto in prigione, prima di essere<br />
giustiziato, il famoso De consolatione filosofia. Alla morte di Zenone, nel 491, il popolo di<br />
Costantinopoli chiese un imperatore romano a causa della diffidenza verso gli Isaurici che<br />
venivano considerati comunque cittadini di secondo livello. La vedova Ariadne, andò dunque<br />
in sposa ad Anastasio (491-518) che portò avanti una politica energica contro gli Isaurici che<br />
furono deportati parzialmente in Tracia. Anastasio si trovò in difficoltà a causa del suo<br />
appoggio alla corrente religiosa monofisita che era sempre attiva a Costantinopoli. Alla morte<br />
di Anastasio andò al potere Giustino I (518-526) , un rozzo contadino semi-analfabeta (si<br />
dice che firmasse con il normografo dal momento che non era in grado di scrivere<br />
fluidamente) che era riuscito a scalare la carriera militare fino alla porpora. Giustinano gli<br />
stette a fianco mentre era ancora in vita e riuscì ad ereditarne il regno alla sua morte. Il regno<br />
di Giustiniano (526-565) rappresenta il grande periodo della restaurazione bizantina.<br />
Giustiniano cercò infatti di garantirsi la neutralità di Cosroe II di Persia a cui versò dei tributi<br />
annuali per poter inviare i suoi generali più fidati, Belisario (sposato con Antonina) e poi<br />
Narsete alla riconquista dell’Africa, della Spagna e dell’Italia. Tutte le operazioni furono<br />
condotte brillantemente e con successo mentre lungo il limes orientale e quello africano<br />
veniva costruita una nuova rete di potenti fortezze le cui rovine si possono visitare ancora<br />
oggi (basta pensare a Zenobia Halabya in Siria o a Haidra in Africa) La guerra per la<br />
riconquista dell’Italia fu molto lunga e sanguinosa e si svolse dal 535 al 553. La penisola ne<br />
uscì fuori dissanguata e tormentata da pestilenze. E’ possibile affermare con le guerre gotiche<br />
l’Italia sia entrata di fatto nell’alto-medioevo. Spunto per l’aggressione ai Goti era stato<br />
l’omicidio della figlia di Teodorico (morto nel 526 proprio l’anno della salita al potere di<br />
Giustiniano) Amalasunta – strozzata sul Lago di Bolsena – che aveva sotto tutela il giovane<br />
figlio Atalarico. Dietro questo vicenda si pone la figura del cugino Teodato, proprietario di<br />
vasti latifondi in Toscana, che aveva indotto con la forza la donna sposarlo. La guerra fu<br />
lunga e sanguinosa e si protrasse nel 553 con la cattura del nuovo re goto Vitige (che aveva<br />
sposato per legittimarsi l’unica figlia di Amalasunta, Matasunta) che fu condotto in trionfo a<br />
Costantinopoli. Il comando delle truppe Gote passò allora a Totila 1 e quindi a Teia che<br />
1 Dopo quattro assedi Roma sembrava un unico campo di battaglia. Se nella prima conquista della città da parte di<br />
Totila, tutto ciò che era rimasto della città pagana era stato risparmiato, nei successivi assedi l'Urbe perse il suo<br />
grandissimo patrimonio architettonico. Gli assediati bizantini per far fronte alla carenza di armi dovettero eliminare<br />
tutto il bronzo che rimaneva nei templi. Il Foro Romano era mutilato di ogni statua o rostrum che da secoli lo aveva<br />
caratterizzato, il tempio di Giove Ottimo Massimo in cima al Campidoglio era ridotto ad un cumulo di macerie e<br />
colonne a causa delle spoliazioni. Si stima che circa trentamila statue bronzee siano state fuse soltanto durante<br />
questi assedi e che circa 250 mila colonne di marmo siano cadute per esser riusate come rinforzo alle porte cittadine<br />
o addirittura come arma contro i nemici oltre le mura (venendo fatte rotolare lungo le mura al momento<br />
dell'assedio) oppure per venire riutilizzate nella costruzione di chiese. A questo periodo si fa risalire la distruzione<br />
completa delle grandi Basiliche romane: la Basilica Emilia, la Basilica Giulia e la più grande, la Basilica Ulpia, tutte<br />
crollarono a causa di ripetuti incendi. Le macerie della Basilica Ulpia erano tanto grandi che ostruirono in parte il<br />
Foro di Augusto ed il Foro di Cesare. I Goti, nell'ultima presa della città, ed in segno di disprezzo, abbatterono tutti i<br />
più grandi edifici pagani rimasti: si persero così il tempio di Venere e Roma e la sua colossale statua; le Terme di<br />
Caracalla e quelle di Traiano vennero spogliate di ogni cosa, dal bronzo rimasto al marmo perfino i mosaici furono<br />
43
sarebbe stato l’ultimo re dei Goti. I bizantini non avevano però forze sufficienti per governare<br />
un impero così grande. In un primo momento Narsete rimase ancora in Italia con poteri<br />
straordinari e ri<strong>org</strong>anizzò anche l'apparato difensivo, amministrativo e fiscale. A difesa della<br />
penisola furono stanziati quattro comandi militari, uno a Forum Iulii (Cividale del Friuli),<br />
uno a Trento, uno sull'isola Cumana ed infine uno presso le Alpi Cozie. L'Italia fu <strong>org</strong>anizzata<br />
in Prefettura e suddivisa in province. Tuttavia molto presto si comprese che solo Ravenna,<br />
controllata per via marittima dalla capitale, avrebbe potuto resistere a lungo. Il successore di<br />
Giustiniano, Giustino II costituì allora la nuova figura del governatore di Ravenna, chiamato<br />
esarca. Questo magistrato era di nomina imperiale e quasi sempre un orientale, a volte un<br />
eunuco di corte, deteneva sia il potere civile che quello militare ed esercitava la propria<br />
autorità tramite tribuni e magistri militum. Le autorità civili non scomparvero, ma furono in<br />
posizione subordinata rispetto all'esarca. Anche Africa, Sardegna e Corsica vennero costituite<br />
in Esarcato. Il potere di Giustiniano vacillò pochi anni dopo la presa del potere, nel 532, le<br />
fazioni dei verdi e degli azzurri si sollevarono contro l’imperatore nel grande ippodromo di<br />
Costantinopoli. Giustiniano aveva infatti sostenuto gli azzurri (corrispondenti alle fasce più<br />
aristocratiche della cittadinanza e vicine all’ortodossia) mentre la giovane moglie Teodora,<br />
secondo alcuni in diabolico accordo con il marito, la fazione dei verdi (più vicina alla<br />
b<strong>org</strong>hesia mercantile e alla setta monofisita). Il doppio gioco unito al forte fiscalismo aveva<br />
finito per scontentare tutti. Giustiniano riuscì ad avere ragione della sommossa ordinando<br />
alle guardie di massacrare circa 30.000 persone radunate nell’ippodromo. Aiutato dal<br />
prefetto al pretorio Giovanni il Cappàdoce (che però presto cadde a seguito delle trame<br />
dell’imperatrice) e dal giurista Triboniano, Giustiniano governò senza grandi traumi fino alla<br />
morte. Sotto di lui venne anche redatta l’importante raccolta giuridica del Digesto che si<br />
componeva di una raccolta di leggi di età romana (Codex +Digesto), di un manuale per lo<br />
studio del diritto (institutiones) e di una raccolta di leggi moderne (novellae). Nel 568,<br />
quando era al potere Giustino II, l'Italia venne invasa dai Longobardi di re Alboino, i quali,<br />
entrati attraverso le Alpi Giulie, conquistarono, dapprima Forum Iulii, costringendo il<br />
presidio militare bizantino, in numero esiguo rispetto agli invasori, a ripiegare prima su<br />
Grado, poi in successione, passando per la Via Postumia, su Treviso, Vicenza e Verona. Nel<br />
settembre 569 i Longobardi arrivano a Milano. Bisanzio, già impegnata su altri fronti, non<br />
ebbe la forza di reagire all'invasione. Così negli anni settanta del secolo i Longobardi posero<br />
la loro capitale a Pavia e dilagarono anche nel centro e nel sud, così che due terzi della<br />
penisola erano in mano longobarda e solo la restante frazione era in mano imperiale.<br />
Bisanzio tuttavia non rinunciò passivamente all'invasione e ad una controffensiva. SC<br />
Imperatori bizantini fino ad Eraclio<br />
395-408 Arcadio<br />
408-450 Teodosio II<br />
450-457 Marciano<br />
457-474 Leone I il Grande<br />
474 Leone II<br />
474-491 Zenone<br />
475-476 Basilisco<br />
491-518 Anastasio I<br />
518-527 Giustino I<br />
527-565 Giustiniano I<br />
565-578 Giustino II<br />
578-582 Tiberio II<br />
582-602 Maurizio<br />
602-610 Foca<br />
610-641 Eraclio I<br />
641 Costantino III<br />
641 Eraclio II<br />
641-668 Costante II<br />
44<br />
Gli esarchi di Ravenna<br />
568-573 Flavio Longino<br />
573-576 Baduario<br />
576-585 Decio<br />
585-589 Smaragdo (1° mandato)<br />
589-598 Romano<br />
598-603 Callinico<br />
603-611 Smaragdo (2° mandato)<br />
611-615 Giovanni I Lemigio<br />
616-625 Eleuterio<br />
625-644 Isacco<br />
646-648 Platone<br />
648-649 Teodoro I Calliope (1° mandato)<br />
649-652 Olimpio<br />
652-666 Teodoro I Calliope (2° mandato)<br />
666-678 Gregorio<br />
678-687 Teodoro II<br />
687-702 Giovanni II Platino<br />
702-710 Teofilatto<br />
710-711 Giovanni III Rizocopo<br />
711-713 Entichio<br />
713-726 Scolastico<br />
726-728 Paolo<br />
728-751 Eutichio<br />
strappati. Totila si insediò poi all'interno dei Palazzi Imperiali già precedentemente usati da Teodorico. Erano questi<br />
immensi saloni che in breve dopo numerosi saccheggi erano stati spogliati dei marmi e dati alle fiamme più volte in<br />
segno di odio nei confronti di Roma, saccheggi questi che avevano un forte significato simbolico dato che sul<br />
Palatino era nata la città. Degna di nota è la sorte dei teatri di Roma, le cui orchestre vennero abbattute a martellate<br />
sulle colonne. Al termine di quattro assedi disastrosi, Roma era l'ombra di se stessa; all'interno dell'enorme città,<br />
che aveva avuto 1 milione e mezzo di abitanti, 15 mila persone vagavano smarrite, perlopiù nobili pagani scampati<br />
alla morte, il popolo sopravvissuto e la corte del Papa. La peste iniziò a serpeggiare nell'immensa città, molte zone<br />
vennero chiuse con muri, abbandonate e disabitate, dove si annidavano malattie; e in breve la natura nascose quelle<br />
zone abbandonate. Franò nell'inverno del 550 dal Campidoglio una grande quantità di terra che coprì le rovine<br />
rimaste dei templi di Saturno, Vespasiano, il Tabularium e molti altri edifici adiacenti, persino l'arco di Settimio<br />
Severo venne in gran parte sotterrato. Il cuore di Roma divenne un campo di macerie che affioravano dal terreno.<br />
Alla fine della guerra, Roma aveva aumentato il suo livello urbano di 4 metri.
7.2. Caratteri dell’architettura bizantina<br />
L’architettura bizantina è naturalmente l’erede di quella romana. Per il carattere in un certo<br />
senso spontaneo e meno <strong>org</strong>anizzato della cantieristica tardo antica, l’architettura bizantina<br />
appare più influenzata dalla locale disponibilità di materia prima. Capita così che in Oriente<br />
(Palestina, Siria, Giordania) data la carenza cronica di legno e di argille adatta ella<br />
produzione di mattoni si faccia spesso uso della pietra locale (tra cui molti basalti di origine<br />
vulcanica, ad es a Umm Al Jimal, Bosra, Rasafa e più in generale nell’Heuran) che viene<br />
tagliata in grandi blocchi isodomi spesso montati senza uso di calce. In Anatolia e in<br />
occidente si continua ad utilizzare l’antica tradizione della malta frammista a ciottoli<br />
alternata a filari di mattoni. I mattoni hanno naturalmente la funzione di strati elastici,<br />
capaci di assorbire piccoli ed eventuali assestamenti delle strutture (dovute a sismi,<br />
smottamenti del terreno etc.). La tendenza generalizzata (già attestata nella tarda romanità)<br />
è però quella verso un assottigliamento dei mattoni (forse per risparmiare sui costi) così che<br />
molto spesso la calce che separa i filari viene ad avere la stessa altezza dei mattoni. Di per sé<br />
la cosa non sarebbe particolarmente grave se non fosse che la calce bizantina, in assenza di<br />
quelle ottime sabbie pozzolane che troviamo ad es. nel Lazio, non ha la qualità di quella<br />
romana. I mattoni sono in ogni caso prodotti in dimensioni standard e con una<br />
<strong>org</strong>anizzazione protoindustriale come ai bei tempi dell’impero. Hanno il lato 36 cm e posti in<br />
doppio filare permettono di realizzare muri spessi circa 80 cm senza problemi. Dal punto di<br />
vista della copertura degli spazi, i bizantini fanno uso ripetuto della volta a botte, della volta a<br />
vela e della cupola. Come noto, la differenza tra la volta a vela e la cupola è il punto di<br />
imposta della sfera di pietre e mattoni. Nel caso della vela, i muri dell’ambiente<br />
quadrangolare si raccordano direttamente con la copertura tramite pennacchi ma il diametro<br />
della vela è uguale al lato del quadrato di base. La cupola invece appoggia su pennacchi<br />
aggettanti e ha un diametro minore del quadrato di base. La cosa più curiosa è che per la<br />
cronica assenza di legno, molti architetti bizantini furono in grado di costruire queste volte<br />
senza l’aiuto della tradizionale impalcatura di sostegno (centina). Temerariamente iniziavano<br />
a costruire le volte partendo dal basso confidando sulla tenuta della calce fino ad arrivare al<br />
centro ove, infine, ponevano la chiave garantendo stabilità alla struttura. Per questo i<br />
muratori bizantini misero a punto determinate tecniche di posa dei mattoni che garantivano<br />
stabilità a queste volte sospese nel vuoto durante le fasi di cantiere.<br />
Uso tipico del mondo bizantino è quello di inserire delle anfore nella muratura per<br />
alleggerirle. La cosa si vede con chiarezza a Ravenna, a Sant’Apollinare Nuovo, dove cocci di<br />
anfora frammisti a malta sono interposti tra l’arco di scarico dei muri portanti e l’architrave<br />
delle porte di accesso della basilica. Come noto gli edifici bizantini sono completamente<br />
proiettati verso l’interno. La definizione dello spazio interno è affidata ai marmi e ai mosaici<br />
policromi in pasta vitrea (si pensi a Ravenna in generale) e la luce proveniente dai finestroni<br />
in alto ha un gioco importante (anche simbolico) nella definizione dei volumi e nella<br />
percezione delle membrature architettoniche. L’esterno è invece normalmente spoglio,<br />
semplicemente intonacato o lasciato con il mattone a vista. Le cupole, all’interno, presentano<br />
delle costolature che però non hanno la funzione di rafforzare i punti di scarico dei pesi ma<br />
sono solamente decorative; tutto l’opposto di quanto vedremo nell’architettura gotica del<br />
medioevo quando gli architetti elaborarono alcune intelligenti soluzioni per lanciare le<br />
proprie ardite cattedrali verso altezze sempre più spinte.<br />
Fig. 49 - Volta bizantina realizzata con mattoni messi di coltello / Fig. 50 - Costruzione di volta a botte<br />
45
Nel mondo bizantino si osserva inoltre come la figura dell’architetto professionista stia<br />
sbiadendosi sempre di più. I documenti antichi ci riportano i nomi mechanichòs e di<br />
architekton. Differentemente da quanto potremmo aspettarci, i primi hanno uno status<br />
superiori ai secondi. Si tratta, in generale, ingeneri ed esperti in matematica che vengono<br />
prestati alla cantieristica spesso su incarico imperiale. Fanno parte di questa categoria<br />
Giovanni di Costantinopoli e Isodoro che saranno incaricati da Giustiniano di realizzare la<br />
fortezza sull’Eufrate di Halabyia (Zenobia) e gli stessi dell’Hagia Sofia. Gli “architetti” veri e<br />
propri sono invece figure più sbiadite; sembra che possano corrispondere ai nostri geometri<br />
ed il loro stipendio non è superiore a quello di un maestro di matematica e di stenografia ma<br />
ad es. guadagnano la metà di un maestro di grammatica.<br />
In questa fase, molte delle professioni si sono fatte ereditarie per volere dello Stato cosa che,<br />
lungi dal creare un favorevole regime protezionistico, aveva spinto molti a fuggire<br />
dall’impero o a far perdere le proprie tracce. Le tariffe previste per ogni categoria di<br />
lavoratori erano state rigidamente definitive già al tempo di Diocleziano dal famoso calmiere<br />
dei prezzi; da esso deduciamo che la paga giornaliera di un pittore era stimata in 150 denari,<br />
quella di un muratore a 75, quella di un mosaicista meramente esecutore a 60 e quella di un<br />
carpentiere a 50.Molti di questi professionisti erano inoltre obbligati dallo stato a prestazioni<br />
di corvéé e a servizi obbligatori tutt’altro che graditi (per es. la pulizia periodica delle fogne<br />
cittadine).<br />
Disponiamo di alcuni documenti che fanno luce sui caratteri di “improvvisazione” di alcuni<br />
cantieri. Già al tempo di Costantino il vescovo di Gerusalemme Macario (nel 326) aveva<br />
scritto una lettera all’imperatore in merito alla costruzione della chiesa del Santo Sepolcro.<br />
Nella corrispondenza tra i due Costantino sembra all’oscuro della forma definitiva che<br />
avrebbe dovuto assumere l’edificio e si raccomanda di ordinare per tempo i marmi<br />
provenienti dalle cave imperiali e sottolinea che se l’edificio dovrà avere un soffitto a<br />
cassettoni sarà necessario farlo presente perché in quel caso dovrà essere rivestito d’oro e<br />
l’imperatore provvederà al rifornimento.<br />
Conosciamo anche una lettera del vescovo Gregorio di Nissa al collega Iconio in cui il prelato<br />
si lamenta dell’esosità dei muratori della sua regione e chiede al collega se gli può mandare<br />
un po’ di maestranze più a buon mercato. In questo modo sappiamo che il prezzo normale di<br />
un lavoratore salariato era di 6 o 7 solidi d’oro all’anno mentre i concittadini di Gregorio<br />
avevano fatto un preventivo di 1/30 di solido al giorno.<br />
Fig. 51- Muro bizantino a filari alternati di pietra + calce e mattoni / Fig. 52 - pianta della basilica bizantina di S. Irene e Costantinopoli<br />
Molto interessante, infine il caso della chiesa di Gaza, che si situa ai tempi dell’imperatrice<br />
Eudocia. In questo caso la comunità locale era prevalentemente pagana; si trovavano a Gaza<br />
solamente 250 cristiani Dopo l’editto di Teodosio II che aveva irrigidito quello più famoso del<br />
padre decretando la distruzione di tutti gli edifici pagani d’Oriente, il vescovo di Gaza fu<br />
perplesso sulla forma da dare alla nuova chiesa cristiana che stava costruendo sulle rovine<br />
del tempio di Zeus Marnas. Si era infatti nel dubbio se utilizzare una pianta centrale perché<br />
anche il tempio appena distrutto aveva una planimetria di questo tipo. Dopo molti<br />
tentennamenti si scelse una pianta a croce ma ciò che è interessante e che il vescovo e i suoi<br />
fedeli tracciarono il perimetro sul terreno con un gesso e poi diedero via ad una costruzione<br />
che per la scarsità di mezzi durò 5 anni.Partecipavano al cantiere semplici cittadini che si<br />
industriavano a tagliare la pietra e a innalzare muri. In queste condizioni è naturale che molti<br />
edifici bizantini presentino errori di progettazione e lati di misura irregolare.Ciò che colpisce,<br />
soprattutto in Oriente, è poi il moltiplicarsi di chiese ed abbazie in tutte le città dell’impero.<br />
46
Piccoli centri vengono ad avere anche 15/20 chiese. Una delle ragioni di questa<br />
moltiplicazione è legata all’indotto economico che le chiese, soprattutto quelle martiriali,<br />
portavano ai loro fondatori. Molti laici avevano infatti iniziato a investire in chiese la cui<br />
rendita, in parte, veniva versata al fondatore. Con il tempo si giunse ad una vera inflazione al<br />
punto che le chiese erano superiori al numero potenziale di pellegrini che le potevano visitare<br />
e finanziare. Si cercò di ovviare al problema dei costi di gestione affidando ad un solo presule<br />
più chiese ma ad un certo punto il sistema parve collassate e Giustiniano dovette provvedere<br />
con un decreto che vietava le nuove fondazioni. In generale, al contrario di quanto si crede, le<br />
nuove chiese non furono costruite sulle rovine di quelle pagane perché i luoghi pagani erano<br />
spesso considerati popolati da demoni ed evitati. Un ultimo capitolo piuttosto stimolante è<br />
quello relativo alla dislocazione degli ambienti nelle prime chiese e sulla loro funzione. La<br />
situazione è abbastanza confusa è sembra che la ripetitività non fosse la regola. Di solito gli<br />
elementi fondamentali di una chiesa bizantina sono il nartece e il quadriportico anteriori;<br />
quindi, all’interno di trovano uno spazio rialzato per l’altare (bema), un synthronos (ovvero<br />
un bancale circolare situato al fondo dell’abside centrale su cui sedevano i celebranti con al<br />
centro la cattedra del vescovo o dell’archimandrita), un passaggio che conduceva all’altare<br />
(spesso definito da transenne utile alla sfilata iniziale effettuata dai chierici che entravano in<br />
chiesa), un ciborio (sorta di edicola in muratura sostenuta da colonne che dava rilievo<br />
all’altare) e un pulpito (a metà navata per la lettura dei Salmi). Sino all’VIII sec. anche in<br />
Oriente mancava ogni sorta di iconostasi e la chiesa era attrezzata di alcuni ambienti laterali<br />
di servizio: il diaconicon (ove si raccoglievano le offerte dei fedeli ed erano posti gli arredi<br />
liturgici), la prothesis (spesso l’abside di sinistra, dove si effettuava la preparazione dei pani<br />
per l’eucarestia) , talora anche accorpati in un unico locale definito pastophoria. Quanto<br />
all’utilizzo delle varie parti della chiesa sussistono delle incertezze. Sembra quasi che gli<br />
architetti si attenessero ad un modello generico e che poi i fedeli e i celebranti ne<br />
interpretassero liberamente l’uso. Come ha fatto notare Cyrill Mango, in effetti, è curioso che<br />
i monasteri e le chiese parrocchiali abbiano più o meno la stessa pianta pur essendo destinati<br />
a funzioni liturgiche differenti.<br />
Sappiamo per esempio che i catecumeni potevano assistere solamente alla prima parte della<br />
messa relativa alla lettura dei testi sacri ma che poi dovevano uscire dalla chiesa nel<br />
momento della celebrazione eucaristica; molto spesso osservavano la funzione dal cortile<br />
antistante (quadriportico e nartece) e le porte della chiesa venivano chiuse escludendoli nel<br />
momento topico. Sappiamo però che in alcune chiese essi prendevano posto nelle navate<br />
laterali interne, da cui potevano defluire velocemente quando necessario. Il fatto che in<br />
alcune chiese il matroneo (portico superiore delle navate laterali) sia chiamato<br />
catecumenion sembra prospettare anche altre soluzioni. C’è poi il problema della divisione<br />
tra uomini e donne. In alcune chiese le donne vengono sistemate nella navata sinistra e gli<br />
uomini in quelle di destra.Di certo le funzioni erano più impegnative di quelle odierne perché<br />
duravano almeno due ore e si rimaneva rigorosamente in piedi, proprio come accade nelle<br />
attuali chiese ortodosse d’oriente. Per dare un’idea delle scarsa conoscenza che abbiamo di<br />
queste prime chiese si consideri che rimane tutt’oggi un mistero il criterio che ha indotto alla<br />
genesi dello stesso transetto.<br />
SC<br />
47
7.3. Le chiese di Bisanzio fino all’Hagia Sofia<br />
Uno degli edifici più significativi dell’architettura sacra costantinopolitana è la chiesa di<br />
San Giovanni di Studios, costruita tra 454 e il 463 a.C. da un influente senatore cristiano<br />
ai tempi di Marciano e Leone I. L’edificio non è particolarmente noto ai turisti a causa del<br />
fatto non si presenta in forme monumentali e ha caratteri architettonici non molto esotici per<br />
un visitatore occidentale. E’ pero interessante per la sua antichità e perché ci dimostra che<br />
non tutte le chiese dell’Oriente furono a pianta centrale ma elaborarono la tradizione<br />
basilicale occidentale anche in modo significativo. Si tratta infatti di una chiesa a tre navate<br />
con abside circolare all’interno e poligonale all’esterno così da facilitare il cantiere<br />
costruttivo. Tre finestre si aprono sull’abside illuminando l’interno e alludendo<br />
indirettamente al dogma trinitario. La navata ha forma pressoché quadrata, anticipata,<br />
all’esterno, da un quadriportico abbastanza sviluppato. Le colonne interne sono realizzate in<br />
una bella breccia verde di Tessaglia.Oltre al tradizionale ciborio e al synthronos notiamo la<br />
presenza dei cosiddetti matronei sopra le navate laterali.<br />
Fig. 53 – Ricostruzione al computer dell’ingresso presso il quadriportico di San Giovanni Stoudios / Fig. 54 – abside di San Giovanni Stoudios<br />
Altrettanto interessante sarebbe è lo studio della chiesa di San Polieucto fondata da una<br />
potente aristocratica romana, Anicia Giuliana, già figlia di Galla Placidia e di Anicio Oliario<br />
(imperatore d’occidente nel 474). Dopo aver rifiutato le nozze con Teodorico degli Amali si<br />
trasferì a Costantinopoli andando in sposa a Flavio Aerobindo nella speranza di poter portare<br />
al trono il figlio Flavio Anicio. Anche per questa ragione cercò di mettersi in mostra presso i<br />
concittadini finanziando la costruzione di importanti edifici religiosi. L'edificazione di una<br />
così splendente basilica era una dimostrazione del suo potere economico e del suo prestigio<br />
sociale, come discendente degli antichi imperatori romani, eclissando il tempio dei Santi<br />
Sergio e Bacco, edificato vicino al palazzo imperiale da Teodora e Giustiniano I, nipote e<br />
successore di Giustino I. San Polieucto si trovava nel centro della città di Costantinopoli, a<br />
mezzo cammino tra il palazzo imperiale e la basilica dei Santi Apostoli, il mausoleo degli<br />
imperatori d'Oriente costruito dall'augusto Costantino I, fondatore della città. Il fregio<br />
commemorativo della fondazione specifica che i mosaici dell'atrio erano dedicati alla figura<br />
di Costantino e spiega che il proposito di Giuliana nel costruire questo tempio era onorare la<br />
fede di questo imperatore e quella del suo avo Teodosio I, i primi imperatori cristiani.<br />
La chiesa di San Polieucto è andata distrutta ma sono giunte a noi diverse partiture<br />
architettoniche in marmo che ne sottolineano la ricchezza. I marmi sono intagliati in modo<br />
esuberante e ricercato, con inclusioni paste vitree pietre preziose. Frammenti di questa<br />
chiesa si trovano a Venezia, proprio all’uscita di palazzo ducale. Si tratta dei cosiddetti<br />
pilastri acritani (cioè recuperati dai Crociati a S. Giovanni d’Acri). Riccamente intagliati,<br />
erano sfiorati dalla processione che accompagnava il doge nella basilica di San Marco per<br />
l’incoronazione (passando volutamente davanti alle statue dei tetrarchi per segnare<br />
visivamente l’eredità culturale e imperiale romana).<br />
48
Fig. 55-56 – Frammenti architettonici in marmo del proconneso provenienti da San Polieucto (oggi a Costantinopoli)<br />
Quanto alla chiesa di SS Sergio e Bacco fu iniziata nel 527, primo anno di regno di<br />
Giustiniano I e trasformata in moschea nel ‘600. È nota come Küçük Aya Sofya Camii<br />
(moschea della piccola Santa Sofia) per affinità architettoniche con la famosa basilica di<br />
Hagia Sophia.L’edificio presenta un a pianta centrale con un alternarsi di absidi quadrate e<br />
circolari ed è sormontata da una cupola con costolature. Anche se i dipinti e gli stucchi della<br />
moderna moschea hanno rovinato l’effetto originale, ciò che resta dei capitelli traforati e<br />
degli architravi marmorei ci dà un idea degli interni sfolgoranti di un tempo. Interessante la<br />
volta a cupola fatta “a zucca” nel tentativo di fondere i pennacchi di raccordo con il tamburo<br />
con la cupola stessa. All'esterno il muro meridionale presenta archi murati che collegavano<br />
l'edificio ad una chiesa precedente. La qualità delle membrature contrasta però con le<br />
irregolarità costruttive, tali che spesso molte misure sono sbilanciate e irregolari. Si è<br />
supposto pertanto che l’esecuzione pratica della struttura sia stata affidata a maestranze non<br />
molto perite.<br />
Fig. 57 – Tamburo di SS. Sergio e Bacco con i marmi bizantini / Fig. 58 Ricostruzione di SS Sergio e Bacco<br />
Non ci rimane ora che accennare al grande capolavoro dell’architettura bizantina, la chiesa<br />
dedicata da Giustiniano e Teodora alla divina sapienza, la Haghia Sofia. Come noto la chiesa<br />
sorse dove già all’età di Costantino si trovava un edificio religioso edificato nel 360. Durante<br />
la rivolta di Nika del 532 un incendio si era propagato per la città distruggendo molti edifici<br />
importanti come le terme di Zeuxippo. Lo spazio che si era generato nel centro storico diede<br />
modo alla coppia imperiale di progettare un edificio in grande stile. La dedica avvenne<br />
solennemente nel Natale del 537. Erano stati incaricati della costruzione di questo edificio<br />
due matematici, Antemio di Tralles e Isidoro di Mileto che progettarono un chiesa del tutto<br />
innovativa: tre navate (di cui la centrale molto dilatata) avrebbero sostenuto una cupola dal<br />
diametro spaventoso di 31 m. Per questo fu progettata con molta cura la base di 69,70 x<br />
76,60 che doveva sostenere l’immane peso. All’epoca il triangolo delle forze non era<br />
conosciuto e non esistevano dei calcoli di precisione per valutare le spinte. Per questo già<br />
durante il cantiere nacquero dei problemi molto seri. In un primo momento i piloni che<br />
avrebbero dovuto sostenere la cupola iniziarono ad inclinarsi verso l’esterno di 60 cm. Gli<br />
architetti preoccupati, si rivolsero all’imperatore che li confortò esortandosi ad arrivare sino<br />
49
Fig. 59 – Pianta d Santa Sofia / Fig. 60 – Ricostruzione 3D di Santa Sofia nella sua forma originale<br />
alla chiave di volta degli archi che avrebbe garantito solidità al complesso. Ciò in effetti<br />
avvenne ma la base ne risultò deformata in modo definitivo.<br />
Più avanti le colonne di porfido che componevano le trifore interne iniziarono a polverizzarsi<br />
sotto il peso della muratura superiore. Questa volta furono smontate in attesa che la<br />
muratura di calce (che era piena d’acqua perché doveva ancora asciugarsi) si alleggerisse.<br />
Destino volle che poco tempo dopo un terremoto facesse crollare l’immane cupola. Fu<br />
chiamato un matematico di nome Isodoro che fu capace di intuire il problema dovuto al<br />
profilo troppo depresso della cupola; la nuova cupola fu costruita più alta e con minore<br />
pendenza garantendo spinte verso il basso più verticalizzate. In questo modo, nonostante<br />
alcuni restauri, l’Haghia Sofia è giunta sino a noi anche se trasformata in moschea, stretta tra<br />
4 minareti e intonacata orribilmente di giallo.<br />
Dal punto di vista planimetrico rappresenta una vera innovazione e anche una bizzarria dal<br />
momento che è persino difficile chiarire si tratti di un edificio a pianta centrale o di una<br />
chiesa a tre navate sormontata da una cupola. E’ certo che però la sua grandezza manifestò in<br />
modo sul paesaggio cittadino la potenza e la forza di Giustiniano, venendo a costituire un<br />
deterrente anche psicologico per le tumultuose fazioni di Costantinopoli e le fronde di<br />
opposizione politica ad un potere che si era fatto sempre più centralizzato, con un imperatore<br />
che stringeva a sé in una morsa molto stretta anche la gerarchia ecclesiastica. SC<br />
A titolo orientativo pubblico qui un piccolo glossario religioso in uso in età bizantina:<br />
AKATHISTOS: lett. "non seduto". Inno di ringraziamento dell'ufficio bizantino che si canta in piedi il sabato della 5a<br />
settimana di Quaresima. Composto da Romano il Melode nel IV secolo è un acrostico di 24 strofe (ikos)<br />
corrispondente alle 24 lettere dell'alfabeto greco. Nell'anno 626 fu aggiunta una 25esima strofa di ringraziamento<br />
alla Madre di Dio per aver salvato Costantinopoli dagli Arabi e dai Persiani<br />
ACHEIROPOIETA: immagine "non fatta da mano umana", la cui origine è da attribuire a un evento prodigioso<br />
AMNÒS: letteralmente "agnello" indica la particella a forma quadrata che il sacerdote ricava dal pane eucaristico e<br />
50
che ha inciso il monogramma di Cristo<br />
AMPOLLE: piccoli contenitori in metallo o terracotta che i pellegrini utilizzavano per conservare l'olio preso dalle<br />
lampade che ardono presso le tombe dei santi o l'acqua delle s<strong>org</strong>enti miracolose; portano l'immagine del santo e<br />
così divennero i prototipi di successive icone<br />
ANACORETA: dal greco "anachorein" (ritirarsi) ha come suo sinonimo il termine "eremita" da "eremos" (deserto o<br />
luogo solitario)<br />
ANAGOGICO: dal greco "anagoghé" (ciò che innalza, che eleva) si dice di un'immagine che innalza lo spirito verso le<br />
cose invisibili<br />
ANALOGION: pulpito o leggio sul quale viene esposta l'icona<br />
ANASTASIS: lett. "resurrezione": l'icona della discesa di Cristo agli Inferi<br />
APOFASI: teologia negativa che si avvicina a Dio per la via della negazione<br />
APOFTEGMI: raccolte anonime di parole e opere dei primi "abba" del deserto dell'Egitto raccolti dalla tradizione<br />
orale copta e poi trascritti in greco in ordine alfabetico<br />
ARCHIMANDRITA: il superiore di un monastero greco-ortodosso<br />
ARTOFORION: dal greco "portatore del pane", (in slavo viene tradotto "conservatore dei doni") è un piccolo<br />
tabernacolo in cui si conserva il pane eucaristico<br />
ARTOS: pane eucaristico<br />
ASKITIS: asceta<br />
ASSIST: sottili colpi di luce, striature d'oro o di colore molto luminoso, che irradiano dal volto, dalle vesti (persino a<br />
volte dagli edifici); esprimono santità e illuminazione, deificazione della carne, una vera e propria teologia della luce<br />
BENEDIZIONE GRECA: il pollice e l'anulare della mano destra si uniscono lasciando l'indice diritto, e formando<br />
così l'anagramma di Cristo: IC XC (manuale monte Athos). Le due dita che si uniscono indicano anche l'unione della<br />
natura umana e divina di Gesù<br />
BEMA: il santuario, la parte più sacra del tempio dietro all'iconostasi dove si trova l'altare<br />
CENOBITI: i monaci di un cenobio dove si fa vita comune<br />
CHERUBINO: creatura angelica dalle molte ali<br />
CHITONE: sottoveste o veste da casa dei Greci, ornata da una fascia colorata (stichos o clavus)<br />
CLAMIDE: mantello leggero dei cavalieri e dignitari bizantini<br />
CLAVIO: (in greco stichos, in latino clavus) larga fascia ornamentale laterale sulla manica della tunica (chitone) di<br />
Cristo e degli apostoli<br />
CRISOGRAFIA: fondo oro che caratterizza le icone, anche se in alcune è sostituito da fondi rosso o blu. Gli abiti e i<br />
volti ricoperti di striature oro sottolineano la luce della divinità di Cristo. Sui santi dicono la loro trasfigurazione e<br />
divinizzazione<br />
CULLA: parte centrale della tavola dell'icona, ribassata di qualche millimetro così che intorno si formi una cornice<br />
DEESIS: "intercessione" della madre di Dio, Giovanni Battista, apostoli e santi chini ai lati del trono di Cristo,<br />
intercedono a favore dei fedeli<br />
DEIPARA: "Colei che ha partorito Dio" è il titolo concesso alla Madre di Dio dal concilio ecumenico di Nicea del 325<br />
DIAKONIKON: lo spazio dietro l'iconostasi, a destra del bema, dove si conservano i paramenti, gli oggetti, i libri<br />
sacri e tutto ciò che serve per la liturgia<br />
DIACONO: al servizio del sacerdote durante la liturgia, vestito con stikarion e l'orarion. Nelle icone se il diacono è<br />
santo viene raffigurato con l'incensiere e lo scrigno dei santi doni<br />
DISCOS: la patena dove si dispone il pane eucaristico (artos) frazionato in pezzetti (melismos)<br />
DODEKAORTON: dodici grandi feste dell'anno liturgico bizantino (in russo prazoniki). Le feste despotike, cioè di<br />
prima classe, sono precedute da un giorno di vigilia (preortia), sette di dopo-festa (meteortia) e un ottavo giorno di<br />
congedo (apòdosis)<br />
EISODOS: dal greco " ingresso": le icone della Presentazione al Tempio (di Maria e di Gesù) e dell'ingresso a<br />
Gerusalemme<br />
EMMANUELE: Cristo bambino o giovane imberbere<br />
EPIGONATION: stoffa ricamata e inamidata, a forma di rombo, pende dal fianco destro del celebrante, appeso a un<br />
nastro che gli passa sopra la spalla; si usa nelle solennità<br />
EPITAPHION: velo con il compianto funebre di Cristo morto che viene solennemente portato in processione in<br />
chiesa il venerdì (parasceve) e il sabato santo<br />
EPITRACHELION: stola sacerdotale di rito orientale con scene evangeliche<br />
ESCATOLOGIA: tutto ciò che concerne gli avvenimenti ultimi<br />
ESICASMO: dal greco "esychia" (lett. "refrigerio"), termine monastico che indica la quiete, il silenzio e la pace<br />
dell'uomo che, libero da passioni e turbamenti, si raccoglie e riposa in Dio. Antica corrente spirituale ripresa nel sec<br />
XV da Gregorio Palmas, l'esicasmo si caratterizzata per la ricerca della luce (energia divina increata) e per la<br />
ripetizione della preghiera di Gesù<br />
ESTASI: uscire da sè nella preghiera<br />
ETIMASIA: lett."preparazione del trono" per il giudizio finale: su un cuscino è posto il mantello del Giudice, un<br />
Libro chiuso, la Croce e gli strumenti della passione<br />
FELON: da "phelonion", manto liturgico sacerdotale e vescovile di origine antica in uso in Grecia e poi diffuso in<br />
Russia, senza apertura, corto davanti lungo dietro; nelle icone i vescovi dei primi secoli come san Nicola sono<br />
rappresentati con il felon, che poi viene sostituito dal sakkos<br />
FILOCALIA: raccolta di detti e fatti dei Padri del deserto (vedi apoftegmi)<br />
FILOXENIA: ospitalità di Abramo ai tre angeli-pellegrini, rivelazione trinitaria<br />
HIMATION: dal greco "mantello" la (toga dei romani) che Cristo portava sopra la tunica<br />
HYPAPANTE: dal greco "incontro": Gesù tra le braccia del vecchio Simeone<br />
HOROLOGION: libro liturgico bizantino simile al Libro delle Ore latino<br />
ICONA: dal greco "eikon", cioè immagine, più specificatamente attribuito alle immagini sacre, destinate ad un uso<br />
liturgico (ma anche domestiche, da viaggio, da processione)<br />
ICONOCLASMO: o iconoclastia, cioè "distruzione delle immagini", è quel movimento che avversò l'uso delle<br />
immagini tra il 626 e l'842, provocando molti martiri e la scomparsa di molte immagini sacre, spezzate e date alle<br />
fiamme<br />
ICONODULI: servitori delle immagini<br />
ICONOFILI: amanti delle immagini<br />
ICONOSTASI: lett. "luogo delle icone" è il tramezzo di legno ricoperto di immagini sacre (ffisse o mobili) che divide<br />
il "naos" dal "bema", cioè la navata dal presbiterio<br />
IEROMONACO: monaco che ha ricevuto l'ordine sacerdotale<br />
IERONDA: l'anziano, il saggio del monastero orotodosso (corrisponde allo starestz russo)<br />
IGUMENO: superiore di un monastero cenobitico<br />
IPOSTASI: unità in Cristo della natura umana e divina<br />
51
JHWH: tetragramma di Javhè, che significa "Io sono colui che sono": è il nome di Dio, impronunciabile presso gli<br />
Ebrei anche durante la lettura dei testi sacri<br />
KATOLIKON: la chiesa principale di un monastero greco, separata dagli altri edifici e situata nel mezzo del recinto<br />
del monastero<br />
KENOSIS: spoliazione, abbassamento, annullamento, rinuncia, morte: icona Battesimo di Gesù, Crocifissione,<br />
Discesa agli Inferi<br />
KONTAKION: inni liturgici simili ai tropari ma che si concludono con acclamazioni<br />
KLOBUC: copricapo semisferico con due fasce laterali ornato con piccole croci e cherubini usato dai mnetropoliti<br />
KOUKOULION: cappuccio che copre testa e spalle del monaco che indossa il "grande skema" durante il pranzo e la<br />
preghiera comune<br />
LAVRA: dal greco "via", strada intorno a cui si raccoglievano le piccole capanne ("kellia") degli eremiti greci<br />
LEVKAS: dal greco "bianco" è la preparazione del fondo dell'icona fatta di colla, gesso, polvere di alabastro<br />
LIK: sguardo, volto inteso in senso non fisico ma che assume una dignità espressiva spirituale<br />
LOROS: omophorion solenne che avvolge il corpo due volte e viene portato sopra le vesti dall'imperatore o dagli<br />
arcangeli Michele e Gabriele<br />
MANDYLION: dall'arabo "asciugamano", è il lino o sudario sul quale Cristo lasciò impresso il suo Volto Santo per<br />
mandarlo a Emessa da re Abgar, dove rimase fino al 944; poi fu trasferito a Costantinopoli, in Santa Sofia, e rubato<br />
nel 1204<br />
MANUALI DI PITTURA: Dionigi di Furna, Ermeneutica della pittura (secolo XVII); Foti Kontoglou, Ekphrasis<br />
(Trattato di iconografia ortodossa)<br />
MAPHORION: manto rosso porpora che avvolge la Madre di Dio ricoprendo la sua umanità (la veste azzurra) di<br />
dignità regale<br />
MELISMOS: frazione del pane eucaristico<br />
METAMORFOSI: dal greco "trasfigurazione", rappresenta il momento in cui Gesù si trasfigura davanti ai suoi<br />
apostoli sul monte Tabor<br />
METANOIA: rovesciamento dell'intelligenza e del cuore, di tutto il nostro modo di cogliere il reale<br />
METANIA: inchino profondo (piccola metania) oppure prostrati con la faccia a terra (grande metania)<br />
MENOLOGIO: raccolta vite santi secondo il calendario liturgico<br />
MIROFORE: donne portatrici di unguento e profumo (myron) per la sepoltura di Criito<br />
MITRA: copricapo alto e diviso nella sommità in due punte<br />
NAOS: navata della chiesa<br />
NIMBO: aureola d'oro intorno capo di Cristo (con la croce, detto "nimbo crocifero"), di Maria e dei santi<br />
OMOPHORION: lunga stola generalmente bianca e ornata di croci, sviluppo del loros, di derivazione imperiale,<br />
indica la dignità vescovile: viene incrociata sul petto e ricade sul braccio sinistro; termina con tre linee che indicano<br />
l'ordine diaconale, sacerdotale e vescovile<br />
ORARION: lunga fascia che il diacono porta sulla spalla sinistra sopra lo stikarion e, durante la preghiera, tiene<br />
alzata con la mano destra; oggi l'orarion è bianco come lo stikarion ma nelle icone antiche può essere rosso o nero<br />
anche se lo stikarion è bianco<br />
PATIBULUM: parte orizzontale della croce sulla quale venivano legate o inchiodate le mani del condannato prima di<br />
essere innalzato sul palo verticale (stipes) della croce<br />
PHELONION: veste liturgica<br />
PODLINIKI: manuali usati dagli iconografi per la corretta raffigurazione dei soggetti; il più famoso esempio è il<br />
"Manuale della pittura" del monaco e pittore Dionigi di Furna<br />
POLOS: sfera trasparente con la croce e il monogramma di Cristo, indica il cielo, è simbolo di forza e potere e viene<br />
tenuta in mano da Cristo, dagli arcangeli o dall'imperatore<br />
PORTE REGALI: porte centrali dell'iconostasi da cui il sacerdote accede durante la liturgia<br />
PORTE DIACONALI: a destra e a sinistra delle porte regali introducono rispettivamente nel diakonicon e nel<br />
proskomidion<br />
PREPODOBNYE: titolo dato a tutti i santi monaci della Chiesa russa, che significa "molto simile", sottinteso a<br />
"Cristo" o ai martiri<br />
PREGHIERA DI GESÙ: consiste nella ripetizione continua, ritmata sul respiro e sui batti del cuore, delle parole<br />
"Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio , abbi pietà di me peccatore"<br />
PROSKYNETARIA: leggi, sostegni o piccole edicole in cui le icone vengono poste per facilitarne la devozione:<br />
incensamento, genuflessione, bacio<br />
PROSKINESIS: (gr. proskinesis=onorare prostrandosi fino a terra) inchino profondo davanti a un'icona che si<br />
accompagna al segno della croce, al bacio dell'immagine e all'accensione di un cero<br />
PROSKINETARION: leggio o edicola dove vengono esposte le icone del santo o della festa per facilitarne la<br />
devozione che consiste in aspersioni con l'acqua benedetta, incensamento, genuflessioni, segno della croce e bacio<br />
delle icone. Il leggio su cui poggia l'icona è ricoperto di un drappo che pende fino a terra generalmente ricamato con<br />
croci (etimasia)<br />
PROSKOMIDIA: il sacerdote prepara il pane benedetto sul discos (o patena) e prega per le anime dei fedeli vivi e<br />
morti<br />
PARUSIA: la seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi<br />
PATERIK (paterikon): raccolte russe di vite di santi, monaci e padri della Chiesa<br />
PLURISTAURICA: (polystaurion), la parola significa "con molte croci" e si riferisce alle vesti liturgiche (felon,<br />
saccos) tessute o ricamate appunto con molte croci<br />
PODLINNIKI: "testi autentici", manuali salvi di pittura guida con i modelli per gli iconografi<br />
PROSKOMIDIA: rito della preparazione dei doni<br />
PROTHESIS: l'abside di sinistra dove si celebra il rito della preparazione dei pani<br />
PROSFORA: i pani che si usano per la consacrazione<br />
RASKOLNIKI: setta russa dei "vecchi credenti", tradizionalisti che non volendo accettare la riforma liturgica del<br />
patriarca Nikon si separò dalla Chiesa dopo il concilio di Mosca del 1666 e il cui principale esponente fu l'arciprete<br />
Avvakum, bruciato sul rogo nel 1682<br />
RIPIDION: ventaglio liturgico rotondo di metallo, con inciso un cherubino o un serafino, usati dai diaconi<br />
RIZA: lamina di copertura parziale in oro o argento, cesellata finemente e con inserimento di pietre preziose e smalti<br />
che lascia scoperto i volti, le mani e i piedi; impreziosisce le icone, soprattutto quelle ritenute miracolose<br />
ROSARIO PREGHIERA DI GESÙ: fatto di lana intrecciata o cuoio veniva portato in mano o intorno al polso del<br />
monaco per recitare la giaculatoria "Gesù Cristo, Figlio di Dio , abbi pietà di me peccatore" quando si trovava<br />
lontano dal monastero al posto dei salme delle ore canoniche secondo tabelle prestabilite. Ad esempio: Mattutino<br />
700 o 400 o 200; Ora prima 150 o 100 o 50; Vespri 100 o 200. Il rosario terminava con due pendagli triangolari di<br />
cuoio con incise preghiere o immagini sacre<br />
SAKKOS: tunica di derivazione imperiale usata dal vescovo, aperta sui due lati e chiuso da bottoni, in sostituzione<br />
52
del più antico felon<br />
SCABELLUM PEDUM: traversa poggiapiedi della croce che sosteneva il corpo dei condannati<br />
SKEMA: in greco "veste", è in realtà una stola monastica (analabos) che copre il corpo davanti e dietro, la ci parte<br />
anteriore è coperta di croci e iscrizioni; il monaco ordinario indossa il "micron skema" (piccolo abito) mentre il<br />
monaco di stretta osservanza il "megalon skema" (grande abito)<br />
SEMANTRON: asse di legno, generalmente appeso nei chiostri dei monasteri, che viene battuto come una campana<br />
per chiamare i monaci alla preghiera<br />
SERAFINI: il loro nome deriva dal termine ebraico serafim legato al verbo saraf, che significa bruciare; sono<br />
creature angeliche con sei ali, di cui con due si coprono la faccia, con due il corpo<br />
SINASSI: assemblea liturgica: la sinassi eucaristica è la messa<br />
SKITI: deriva da askiti (asceta) ed è un insieme di piccoli eremi di singoli o piccole fraternità chiamate kalìvi<br />
(capanna). E' invece chiamato kellion la cella eremitica o la comunità di asceti più grande della kalivi ma inferiore a<br />
una skiti<br />
SPAS: in russo "Salvatore"<br />
STARETZ: (geronda in greco): "vecchio pieno di bellezza" (kalogeros), uomo spirituale, illuminato dalla grazia,<br />
dotato del dono del discernimento delle menti, intorno a cui si raduna una piccola comunità di discepoli<br />
STAUROTECA: reliquiario contenente una particella della vera croce; icona in cui è inserita una croce di metallo a<br />
otto punte<br />
STICHOS: nome greco che corrisponde al latino clavio (vedi clavus), fascia che circonda il braccio destro della tunica<br />
di Cristo, generalmente dorata, e ne indica la divinità<br />
STIKARION: è la veste più semplice che può essere indossata da tutti coloro che durante la liturgia svolgono un<br />
compito di servizio come i cantori, i lettori, chi prepara l'incenso o porta il cero<br />
STIPES: il palo verticale della croce che normalmente si trovava già conficcato nel terreno e al quale veniva aggiunto<br />
il patibulum che il condannato portava sulle spalle fino al luogo della crocefissione<br />
STILITA: anacoreta che fa il voto di vivere su una colonna da cui predica, guarisce, dà consigli e dove fa vita di<br />
penitenza e, se sacerdote, celebra l'eucarestia<br />
STOLA: (epitrakelion) intera o in due pezzi, a volte chiusa davanti da bottoni, è l'ornamento del vescovo e del<br />
sacerdote che si porta diritto, appeso al collo, sopra il sakkos; un suo sviluppo più ricco e sontuoso è l'omoforion<br />
vescovile<br />
SUPPEDANEUM: (sotto i piedi) veniva inchiodato allo stipes perché il condannato a morte potesse stare in piedi<br />
SYNTHRONON: (trono condiviso) indica appunto un trono collettivo, per esempio unico per le tre persone della<br />
Trinità o per i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe ma anche per i dodici apostoli nell'icona della Pentecoste<br />
TEOFANIA: manifestazione della divinità di Cristo, si divide in grande (Battesimo) e piccola (..)<br />
TRICHINAS: del cilicio<br />
TROPARIO: inno variabile breve della liturgia ortodossa che descrive in forma poetica il significato delle feste e<br />
quindi aiuta il pittore di icone nella composizione<br />
TSHIN: fila, ordine, registro dell'iconòstasi<br />
UBRUS: velo e fazzoletto<br />
UMILENIE: tenerezza<br />
VELUM: cuffia pieghettata<br />
53