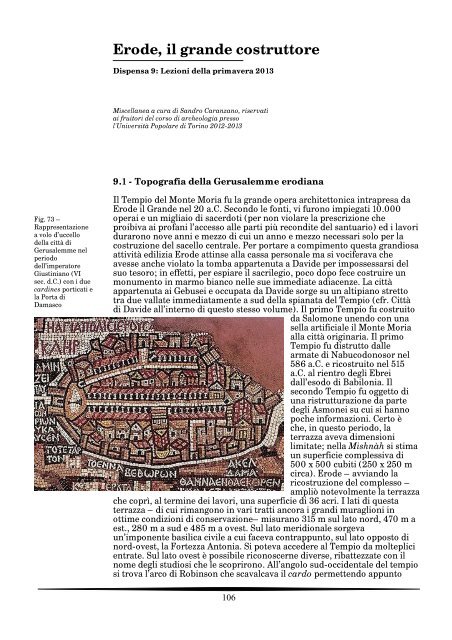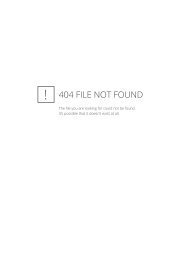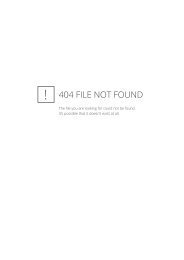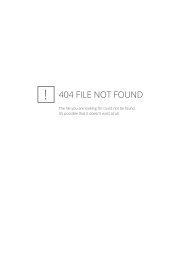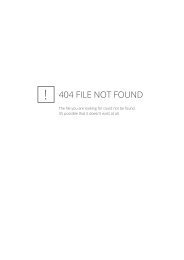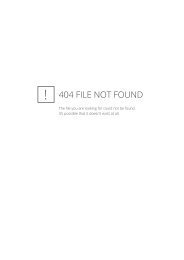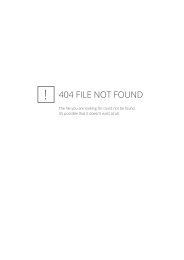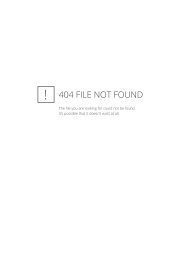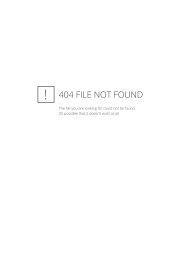Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org
Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org
Dispensa 9 - Corsoarcheologia.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fig. 73 –<br />
Rappresentazione<br />
a volo d’uccello<br />
della città di<br />
Gerusalemme nel<br />
periodo<br />
dell’imperatore<br />
Giustiniano (VI<br />
sec. d.C.) con i due<br />
cardines porticati e<br />
la Porta di<br />
Damasco<br />
Erode, il grande costruttore<br />
<strong>Dispensa</strong> 9: Lezioni della primavera 2013<br />
Miscellanea a cura di Sandro Caranzano, riservati<br />
ai fruitori del corso di archeologia presso<br />
l'Università Popolare di Torino 2012-2013<br />
9.1 - Topografia della Gerusalemme erodiana<br />
Il Tempio del Monte Moria fu la grande opera architettonica intrapresa da<br />
Erode il Grande nel 20 a.C. Secondo le fonti, vi furono impiegati 10.000<br />
operai e un migliaio di sacerdoti (per non violare la prescrizione che<br />
proibiva ai profani l’accesso alle parti più recondite del santuario) ed i lavori<br />
durarono nove anni e mezzo di cui un anno e mezzo necessari solo per la<br />
costruzione del sacello centrale. Per portare a compimento questa grandiosa<br />
attività edilizia Erode attinse alla cassa personale ma si vociferava che<br />
avesse anche violato la tomba appartenuta a Davide per impossessarsi del<br />
suo tesoro; in effetti, per espiare il sacrilegio, poco dopo fece costruire un<br />
monumento in marmo bianco nelle sue immediate adiacenze. La città<br />
appartenuta ai Gebusei e occupata da Davide s<strong>org</strong>e su un altipiano stretto<br />
tra due vallate immediatamente a sud della spianata del Tempio (cfr. Città<br />
di Davide all’interno di questo stesso volume). Il primo Tempio fu costruito<br />
da Salomone unendo con una<br />
sella artificiale il Monte Moria<br />
alla città originaria. Il primo<br />
Tempio fu distrutto dalle<br />
armate di Nabucodonosor nel<br />
586 a.C. e ricostruito nel 515<br />
a.C. al rientro degli Ebrei<br />
dall’esodo di Babilonia. Il<br />
secondo Tempio fu oggetto di<br />
una ristrutturazione da parte<br />
degli Asmonei su cui si hanno<br />
poche informazioni. Certo è<br />
che, in questo periodo, la<br />
terrazza aveva dimensioni<br />
limitate; nella Mishnàh si stima<br />
un superficie complessiva di<br />
500 x 500 cubiti (250 x 250 m<br />
circa). Erode – avviando la<br />
ricostruzione del complesso –<br />
ampliò notevolmente la terrazza<br />
che coprì, al termine dei lavori, una superficie di 36 acri. I lati di questa<br />
terrazza – di cui rimangono in vari tratti ancora i grandi muraglioni in<br />
ottime condizioni di conservazione– misurano 315 m sul lato nord, 470 m a<br />
est., 280 m a sud e 485 m a ovest. Sul lato meridionale s<strong>org</strong>eva<br />
un’imponente basilica civile a cui faceva contrappunto, sul lato opposto di<br />
nord-ovest, la Fortezza Antonia. Si poteva accedere al Tempio da molteplici<br />
entrate. Sul lato ovest è possibile riconoscerne diverse, ribattezzate con il<br />
nome degli studiosi che le scoprirono. All’angolo sud-occidentale del tempio<br />
si trova l’arco di Robinson che scavalcava il cardo permettendo appunto<br />
106
l’accesso alla basilica superiore. Poco oltre, dove oggi si trova il recinto<br />
riservato alle donne, si vede un architrave appartenuta alla porta di Berclay;<br />
nel corridoio riservato solo agli uomini, si osservano le tracce dell’arco di<br />
Wilson (forse la porta di Kiponos di cui si parla nella Mishnah) a cui segue<br />
l’arco di Warren che, pur bloccato, è visibile in corrispondenza del tunnel<br />
ovest. Il muraglione erodiano del lato occidentale è quello in cui si trova<br />
anche il cosiddetto Muro del Pianto; se ne conserva a vista solo un tratto di<br />
60 m che corrisponde a non più del 12% del suo sviluppo originale. Il muro<br />
– popolarmente scambiato nel passato per un rimasuglio del Tempio vero e<br />
proprio – divenne oggetto di attenzione da parte degli Ebrei solo nel XVI<br />
sec. quando, questi ultimi lasciato il quartiere sul Monte Sion, iniziarono a<br />
insediarsi in città.<br />
Sul lato meridionale si riconoscono le due porte dette di Huldah, molto<br />
importanti perché da qui accedevano al tempio i pellegrini provenienti da<br />
ogni dove, soprattutto in occasione delle tre festività principali dell’anno.<br />
Sul lato nord, stretta tra la fortezza Antonia e la zona delle piscine, si<br />
trovava una sola porta chiamata di Tadi. Secondo la Mishnàh essa era<br />
agibile esclusivamente agli infermi.<br />
Sul lato orientale, affacciata sulla vallata del Cedron si trovava la porta di<br />
Shushan, chiamata in questo modo in ricordo della città babilonese di Susa<br />
da cui gli Ebrei fecero ritorno terminato il loro esilio (era probabilmente<br />
decorata con la raffigurazione del palazzo stesso). La porta non poteva<br />
essere osservata da chi si trovava nel recinto sacro perché i pellegrini che<br />
uscivano dal Tempio procedevano a ritroso senza staccare la vista dal Santo<br />
dei Santi (dunque dando le spalle alla porta). All’esterno della cinta, a fianco<br />
della porta, erano incise nella parete come riferimento le misure del cubito.<br />
La porta di Shushan non è conservata e la Porta d’Oro – murata – che si<br />
vede oggi sempre sul lato est della cinta erodiana appartiene all’epoca<br />
bizantina.<br />
La spianata del Tempio era divisa in settori da una serie di recinzioni.<br />
Esisteva un cortile detto “dei gentili” separato da quello al quale potevano<br />
avere accesso solo i fedeli. Lungo la balaustrata iscrizioni bilingue in greco e<br />
latino minacciavano di morte chiunque avesse trasgredito le regola. Alcuni<br />
lacerti marmorei di queste iscrizioni sono stati messi in luce e sono esposti<br />
nel Museo di Israele. Alcuni scalini davano accesso a un ulteriore recinto<br />
dotato di una porta detta “bella” che permetteva di entrare nel “cortile delle<br />
donne”, uno spazio cultuale aperto ad entrambi i sessi. Agli angoli di questo<br />
cortile si trovavano quattro ambienti accessori: “la camera del legno” in cui<br />
veniva esaminato il legno destinato alla costruzione degli altari di culto, la<br />
“camera dell’olio” in cui venivano conservati l’olio e il vino utilizzati per il<br />
culto, la “camera dei naziriti” (consacrati) dove venivano cotti gli animali<br />
sacrificati e la “camera dei lebbrosi”, dotata di bagni e destinata all’ispezione<br />
dei malati.<br />
Da qui i fedeli potevano salire una scala di quindici gradini (tanti quanti<br />
sono i canti dell’Ascensione nel libro dei Salmi). In occasione della festività<br />
del Sukkot, i Leviti erano soliti stazionare su questi gradini intonando i<br />
Salmi. Al vertice di questa scala si trovava la “Porta di Nicànore” (così<br />
denominata dal nome di Nicànore di Alessandria che aveva donato il rame<br />
per la fusione delle grandi porte in bronzo). I pellegrini entravano quindi<br />
nella corte degli Israeliti (la sala di riunione del Sinedrio) in cui si<br />
presentavano le offerte ai sacerdoti del Tempio che stazionavano in uno<br />
spazio separato da una balaustra (l’accesso era consentito, ovviamente solo<br />
agli ebrei maschi). Al centro del cortile si trovava un altare di 16 x 7 m<br />
presso il quale i sacerdoti cuocevano gli animali sacrificati. Il punto finale<br />
del percorso era costituito dal Tempio vero e proprio, il cui portale era<br />
inquadrato da due grandi colonne, le famosissime Yachin e Boaz. Il Tempio<br />
era sormontato da una serie di merli a scaletta che avevano la funzione di<br />
tenere lontani gli uccelli, attratti dall’odore delle carni cotte sulla brace.<br />
Planimetricamente, il Tempio era costituito da un vestibolo esterno (ulam)<br />
che dava accesso al “Santo”; la porta, a quattro battenti, era protetta da<br />
107
Fig. 74 – Ricostruzione<br />
archeologica del Secondo<br />
Tempio dell’età di Erode:<br />
in primo piano il cortile<br />
dei Gentili seguito dalla<br />
porta di Nicanore e dal<br />
cortile dei Nazariti; al<br />
centro si nota la grande<br />
costruzione costituita dal<br />
sncta sanctorum con le<br />
colonne Iachim e Boaz.<br />
grandi tende in lino e lana intessute con diversi colori simboleggianti gli<br />
elementi del cielo e della terra. Il Santo (hekhal) ospitava la menoràh in oro,<br />
il tavolo per le offerte (sui cui erano i dodici pani, simbolo dello Zodiaco e<br />
dei mesi dell’anno) e un altare d’oro su cui erano bruciate tredici qualità di<br />
incenso che simboleggiavano l’appartenenza di ogni cosa a Dio. Ogni giorno<br />
dei sacerdoti estratti a sorte vi entravano per rifornire di olio combustibile la<br />
menoràh e per bruciare incenso. Oltre si trovava il “Santo dei santi”, una<br />
grande camera a cui poteva accedere solo l’alto sacerdote in occasione della<br />
festività dello Yom Kippur quando “pervaso di orrore” vi bruciava<br />
dell’incenso. Originariamente quest’aula conteneva l’Arca dell’alleanza con<br />
le tavole della Legge consegnate da Dio stesso a Mosè; dopo il saccheggio del<br />
Tempio perpetuato dai Babilonesi, questa stanza era rimasta vuota; in<br />
questa condizione ebbe modo di vederla Pompeo quando, presa<br />
Gerusalemme, profanò il Tempio.<br />
Sul lato meridionale della grande spianata s<strong>org</strong>eva, come si è detto,<br />
l’imponente basilica romana. L’interno era diviso in tre navate da 162<br />
colonne che dovevano<br />
essere imponenti tanto<br />
che Flavio Giuseppe<br />
ricorda che erano<br />
necessarie tre persone per<br />
poterle abbracciare<br />
completamente. Si poteva<br />
accedere alla basilica<br />
anche tramite una via<br />
riservata che passava<br />
sopra l’arco di Robinson;<br />
essa era prevalentemente<br />
utilizzata dal re e dai<br />
maggiorenti.<br />
Nell’angolo nord-ovest<br />
della piazza del tempio<br />
s<strong>org</strong>eva la Fortezza<br />
Antonia, battezzata con<br />
questo nome in onore del<br />
protettore di Erode,<br />
Marco Antonio. È<br />
probabile che l’edificio sia stato impostato sui resti della Birah (baris in<br />
greco), la grande fortezza costruita a protezione del Tempio nel VI sec. a.C.,<br />
quando gli Ebrei fecero ritorno dall’esilio a Babilonia. Anche i re asmonei<br />
avevano costruito una fortezza per il controllo di Gerusalemme ricordata<br />
dalle fonti con il nome di Akra; è possibile che si tratti del medesimo<br />
edificio, ma molti studiosi sono convinti che vada ubicata presso la Porta di<br />
Hulda.<br />
La fortezza Antonia – scrive Flavio Giuseppe – era stata costruita al vertice<br />
di una scarpata naturale di 25 m; i muraglioni della cinta raggiungevano i 25<br />
m di altezza con una torre a ognuno dei quattro angoli. La torre di sud-est<br />
era alta 35 m e permetteva una perfetta visuale su tutta l’area del Tempio.<br />
Molto dibattuta è anche la dimensione dell’edificio, stimata in soli 45 x 120<br />
m dai minimalisti e di 150 x 90 m dai massimalisti. La fortezza fu utilizzata<br />
da Erode e dai suoi famigliari nei primi dieci anni di regno, in attesa che<br />
venisse completato il nuovo castello presso l’attuale porta di Jaffa. La<br />
fortezza Antonia, diventata un punto di arroccamento degli Ebrei rivoltosi<br />
nel 66 a.C., fu rasa al suolo dai Romani dopo la conquista di Gerusalemme.<br />
Non lontano dall’Akra si trova la piscina di Bethsedà (cfr. capitolo<br />
riservato), composta da due vasche rettangolari; quella settentrionale si<br />
data al periodo del Primo Tempio, la seconda fu aggiunta in età ellenistica.<br />
Originariamente qui veniva effettuata la lavanda degli agnelli destinati al<br />
sacrificio nel Tempio; la piscina è situata non lontano dalla Porta dei Leoni<br />
che permetteva di raggiungere un grande mercato in cui venivano acquistati<br />
108
Fig. 75 –<br />
Ricostruzione<br />
dell’accesso al sancta<br />
sanctorum del<br />
Tempio di<br />
Gerusalemme<br />
dell’epoca di Erode il<br />
Grande.<br />
gli animali destinati al rito. Il Nuovo Testamento ricorda che la piscina era<br />
circondata da quattro portici, più un ulteriore portico edificato lungo la<br />
linea di separazione tra le due vasche. Sotto questi portici si raccoglievano i<br />
malati, i ciechi e i paralitici, e il luogo fece da fondale ad uno dei miracoli<br />
evangelici diventando, per questo, un luogo di pellegrinaggio cristiano.<br />
Nel periodo del secondo Tempio e in quello di Cristo, l’originaria città di<br />
Davide (cioè la parte meridionale di Gerusalemme) aveva perso di<br />
importanza e venne occupata da quartieri in cui alloggiavano i pellegrini<br />
diretti al Tempio. Qui si trovavano importanti ris<strong>org</strong>ive d’acqua tra cui la<br />
fonte di Ghion (dove s<strong>org</strong>eva la piscina di Siloe) e il torrente che scorreva<br />
nella valle del Cedron. Queste s<strong>org</strong>enti non erano sufficienti a risolvere tutte<br />
le esigenze logistiche di una città così importante e altra acqua veniva<br />
portata a Gerusalemme tramite acquedotti come quello proveniente da<br />
Betlemme (dove sono ancora visibili le grandi vasche di raccolta dell’acqua).<br />
Quando Giuseppe Flavio descrive la presa della città da parte di Tito<br />
enumera alcuni degli edifici più significativi situati nei quartieri<br />
meridionali: l’archivio, la camera di consiglio dei saggi, l’Ophel, il palazzo<br />
della regina Elena e l’Akra (che dunque non dovrebbe coincidere con la<br />
Fortezza Antonia). Tradizionalmente si ritiene che la città bassa (a sud del<br />
Tempio) fosse occupata da gente di più modesta condizione, mentre<br />
l’aristocrazia sacerdotale avrebbe avuto tutto l’interesse a concentrarsi nella<br />
zona alta situata nelle vicinanze del Tempio; tuttavia, gli scavi fatti nel<br />
settore meridionale, hanno offerto per ora un’immagine di abitazioni di<br />
tutto rispetto.<br />
Sempre nei quartieri meridionali, non lontano dalla Piscina di Siloe, si<br />
trovava la sinagoga di Teodotos. La sinagoga è nota grazie al ritrovamento<br />
nel 1913-14 di una iscrizione in greco all’interno di una cisterna per l’acqua<br />
da parte dell’archeologo Raimond Weill in cui si accenna a un certo<br />
Teodotos figlio di Vettenos. L’iscrizione, oggi conservata nel Museo di<br />
Israele, recita: «Theodotos, figlio di Vettenos, sacerdote e capo della<br />
sinagoga, figlio del capo della sinagoga, che fu figlio a sua volta del vecchio<br />
capo della sinagoga, ricostruì la sinagoga per la lettura della Legge e per lo<br />
studio dei precetti sacri; costruì anche gli ambienti necessari, i bagni rituali,<br />
e le stanze in cui alloggiare i bisognosi che vi vengono da lontano. La<br />
sinagoga fu fondata dai suoi antenati, dai vecchi e dai Simonidi».<br />
Durante gli sterri furono trovate tracce di scalini e di vasche per le abluzioni<br />
del tipo usato nel mondo<br />
ebraico (mikva’ot), forse gli<br />
stessi citati nell’iscrizione. È<br />
noto che le sinagoghe divennero<br />
luoghi di preghiera per gli ebrei<br />
dopo la distruzione del Tempio;<br />
l’iscrizione descrive con<br />
chiarezza le funzioni associate a<br />
questa tipologia di edificio.<br />
Non lontano da qui, doveva<br />
trovarsi il palazzo della regina<br />
Elena di Adiabene (una regione<br />
del regno partico-sasanide<br />
situata nel nord dell’Irak). Le<br />
fonti antiche ricordano che essa,<br />
venuta a conoscenza della<br />
religione giudaica da alcuni<br />
mercanti giunti nel suo paese, si<br />
convertì trasferendosi a<br />
Gerusalemme dove fece<br />
costruire un suntuoso palazzo,<br />
rendendosi benemerita per la<br />
liberalità e le azioni<br />
caritatevoli.La tradizione<br />
109
abbinica ricorda, sempre presso il settore sud-orientale della città, una<br />
tomba abbastanza monumentale appartenente alla profetessa Hulda,<br />
vissuta nel VII sec a.C. Di questo edificio si parla nel corso di una disputa<br />
rabbinica sul trattamento da riservare alle tombe nel caso di un<br />
ampliamento della città.<br />
Lungo il muro meridionale del tempio (cfr. Davidson center) esisteva una<br />
scalinata che permetteva ai pellegrini di accedere alla spianata del Tempio; i<br />
sacerdoti e la famiglia reale entravano, invece, dall’arco di Wilson o,<br />
comunque, tramite gli accessi del lato ovest. Lo spazio davanti al muro sud<br />
era occupato da un grande spiazzo dove si raccoglievano i pellegrini prima<br />
di salire al Tempio. In questo punto sono stati trovati diversi miqvaot<br />
utilizzati per i bagni rituali preliminari. Le scale erano due: quella più<br />
stretta, a ovest, era destinata a coloro che entravano nel Tempio; quella<br />
occidentale, larga 64 m, era riservata ai pellegrini che uscivano.<br />
Probabilmente davanti alla porte di accesso si riuniva uno dei quattro<br />
tribunali del Sinedrio che giudicava delle contese civili e religiose tra gli<br />
ebrei.<br />
Flavio Giuseppe riferisce che Erode costruì in città un teatro e un grande<br />
anfiteatro. Sempre Giuseppe Flavio riferisce che quando morì Erode,<br />
scoppiò a Gerusalemme una rivolta popolare proprio nella zona dei<br />
quartieri meridionali ove si concentravano i pellegrini in occasione della<br />
festa dello Shauvot (la Pentecoste). Giuseppe dice che i Romani<br />
concentrarono i rivoltosi presso l’anfiteatro, che dunque avrebbe dovuto<br />
trovarsi nelle vicinanze. È anche possibile che Flavio confonda l’anfiteatro<br />
con il circo per le bighe e le quadrighe, come sappiamo aveva fatto in<br />
un’altra parte della sua opera parlando di Cesarea marittima; il problema è<br />
aperto.<br />
Presso la porta di Jaffa s<strong>org</strong>eva il palazzo fatto costruire da Erode ed<br />
inaugurato nel 23 a.C. Giuseppe Flavio ne ricorda l’imponenza e l’eclettismo<br />
delle sistemazioni, con sale arricchite da loggiati, fonti d’acqua e trovate<br />
stravaganti. L’edificio fu chiamato Caesareum o Agrippeum in onore di<br />
Cesare Augusto e del genero Agrippa, protettori di Erode. Dalle descrizioni<br />
antiche sappiamo che il palazzo aveva muri alti 15 m e una superficie di base<br />
di 330 x 130 m. L’Agrippeum fu danneggiato durante l’assedio di Tito. Dopo<br />
la morte di Erode ospitò i governatori romani della Giudea tra i quali quel<br />
Gennio Floro che era il procuratore in carica all’atto della rivolta del 66 a.C.<br />
Dal palazzo doveva essere possibile abbracciare con uno sguardo l’agorà<br />
della città, perché è scritto che Gennio Floro diede ordine ai soldati di<br />
attaccare i maggiorenti giudei che si rifiutavano di punire i responsabili<br />
delle insurrezioni dei giorni precedenti. Adiacente al palazzo era la<br />
Cittadella di Erode, costruita volutamente nel punto più alto della città a 777<br />
m slm. Tre torri permettavano di controllare visivamente gran parte di<br />
Gerusalemme e l’accesso alla città. La torre più alta era l’occidentale,<br />
battezzata con il nome del fratello defunto di Erode, Fasaele. Secondo Flavio<br />
Giuseppe aveva una base in grandi blocchi quadrati misuranti 20 m di lato;<br />
potrebbe trattarsi del poderoso basamento che ancora oggi sostiene la torre<br />
medievale detta “di Davide” presso l’attuale cittadella. La torre – che<br />
s’innalzava per 45 m – era sormontata da passaggi di ronda e torrette, con<br />
un profilo a scala che forse era ispirato al faro di Alessandria. Seguiva la<br />
torre di Ippico (così denominata dal nome di un caro amico di Erode, un<br />
comandante della cavalleria caduto in battaglia); era alta 40 m e s<strong>org</strong>eva<br />
sopra una cisterna per l’acqua profonda 10 m.<br />
La terza torre era dedicata a Mariamne, la moglie asmonea di Erode che il re<br />
aveva fatto uccidere per gelosia. Era la più piccola, con una base di 10 m e<br />
un’altezza di 27 m. Secondo Flavio Giuseppe era anche la più aggraziata e<br />
per questa ragione era stata dedicata a una donna. Distrutta la città, Tito<br />
lasciò in piedi queste tre torri a testimonianza del passato glorioso di<br />
Gerusalemme, ma anche a imperitura memoria dell’assedio portato<br />
vittoriosamente a termine.<br />
110
Non lontano dal palazzo di Erode doveva poi trovarsi la casa di Caifa, il gran<br />
sacerdote del Tempio al tempo di Gesù.<br />
Le fonti antiche ricordano che presso la città di Davide s<strong>org</strong>eva la tomba di<br />
re Davide. Un passaggio del rabbino Akiva riferisce che esistevano dei canali<br />
che raccoglievano le impurità presenti presso la tomba di Hulda e quella di<br />
Davide che venivano così convogliate nella Valle del Cedron; la tomba<br />
doveva dunque trovarsi nelle vicinanze della valle. Per molto tempo si è<br />
creduto che la tomba di Davide si trovasse sul Monte Sion, probabilmente<br />
per un’ incomprensione di età medievale; all’epoca di Giuseppe Flavio si<br />
usava il termine di “città di Davide” per riferirsi alla città alta ma<br />
originariamente, invece, la città di Davide era solo quella bassa. È quindi<br />
probabile che l’attuale ubicazione della tomba di Davide sul Monte Sion sia<br />
nata da una tradizione cristiana poi abbracciata dai Mussulmani e, solo a<br />
partire dal XII sec. anche dagli Ebrei. Poiché tra il 1948 e il 1967 la città<br />
vecchia era in mano alla Giordania, il Monte Sion rimase l’unico luogo<br />
accessibile agli Ebrei che vi si recavano a pregare sfruttando l’edificio<br />
costruito sul posto dai crociati (vedi capitolo riservato).<br />
Le fonti antiche ricordano anche un Palazzo degli Asmonei ubicato nel<br />
settore a occidente del Tempio. Di questo edificio non sono noti resti.<br />
Sappiamo però che esso fu ricostruito da Agrippa II e che, data l’altezza<br />
degli ultimi piani, permetteva di osservare quanto avveniva nel cortile del<br />
Tempio. I sacerdoti reagirono a questa intromissione costruendo un alto<br />
muro che impediva la veduta del Tempio; Agrippa II fece ricorso<br />
all’imperatore Nerone ma, inaspettatamente, gli fu dato torto.<br />
9.2 - Scavi presso il Davidson Center.<br />
Sul lato meridionale del Davidson Center, in prossimità della strada<br />
moderna, gli scavi hanno portato alla luce due torri quadrate (14 x 10 m)<br />
con profonde fondazioni, divise internamente in quattro stanze. La forma e<br />
le dimensioni di queste torri fanno pensare che esse inquadrassero l’antica<br />
Porta delle acque. Si trattava di una porta di accesso all’acropoli la cui<br />
tipologia rimanda a quella della “porta del palazzo reale” scoperta nella<br />
cittadella di Megiddo, anch’essa datata in età israelitica.<br />
Nel periodo del primo Tempio, le porte assolvevano una serie di funzioni<br />
abbastanza complesse: vi si tenevano mercati frequentati dai banditori e il<br />
consiglio degli anziani (il Sinedrio) vi teneva giudizio. La porta delle acque<br />
dava accesso all’acropoli e al palazzo reale a chi proveniva dalla fonte di<br />
Ghion o dalla Valle del Cedron.<br />
Della porta rimangono solo più i basamenti conservati per l’altezza di 5 m.<br />
Quando fu completato lo scavo archeologico, fu possibile scoprire quaranta<br />
giare collassate sul pavimento della torre; si crede fossero originariamente<br />
stoccate al secondo piano e che siano cadute in basso a seguito di un<br />
terremoto.<br />
La planimetria permette di riconoscere anche le rovine di una torre<br />
aggettante aggiunta in un secondo tempo, a cui sembra fare cenno il profeta<br />
Nemia. La torre misura 16 x 8 m e si conserva sino all’altezza di 9 m; è<br />
probabile che si tratti di un’aggiunta del tempo di Uzziah (786-758 a.C.).<br />
111
Fig. 76 – Il muro<br />
delle sostruzioni<br />
erodiane visto dal<br />
lato meridionale con<br />
la porta di Hulda,<br />
oggi definitivamente<br />
murata.<br />
L’elemento più monumentale è<br />
però costituito dal settore<br />
meridionale delle mura del<br />
Tempio: dopo la distruzione del<br />
primo Tempio ad opera di<br />
Nabucodonosor, nel 586 a.C., fu<br />
infatti necessario attendere<br />
qualche decennio prima che i<br />
dignitari ebraici deportati a<br />
Babilonia potessero rientrare in<br />
città e avviarne la ricostruzione<br />
del cosiddetto secondo Tempio.<br />
Questo avvenne al tempo di<br />
Zorobabele, un governatore di<br />
origini ebraiche e la ricostruzione<br />
durò cinque anni concludensosi<br />
nel 515 a.C. Le fonti riferiscono<br />
che furono riedificati i muri che<br />
circondavano il Monte Moria e<br />
che fu realizzata una piazza più<br />
grande della precedente,<br />
misurante 500 x 500 cubiti. Le mura della città vera e propria furono invece<br />
ricostruite solo cinquant’anni più tardi, al tempo di Nemia.<br />
Di queste mura rimane poco o nulla ma sappiamo che gli Asmonei<br />
avviarono le attività costruttive seguendo il percorso delle mura di Nemia.<br />
L’indagine archeologica permette di comprendere che la nuova cinta correva<br />
più a ovest, lasciando fuori una parte della città costruita da Davide e<br />
Salomone.<br />
Dopo la conquista di Alessandro Magno, la regione fu sottoposta ai Tolomei<br />
venendo a far parte della provincia di Siria e Fenicia. Nel 200 a.C. Antioco<br />
III Megas conquistò Gerusalemme facendola rientrare nelle pertinenze dei<br />
Seleucidi. Antioco IV Epìfane – famoso per avere avviato un processo di<br />
ellenizzazione della città – fece invece costruire una fortezza chiamata Akra<br />
la cui posizione non è mai stata identificata con precisione; la fortezza era<br />
adiacente al tempio e ospitava le truppe e i nobili seleucidi. L’archeologo<br />
Yadin è convinto di poterne riconoscere le vestigia presso la scalinata<br />
meridionale del tempio di Erode.<br />
Giuseppe Flavio riferisce che la cittadella era stata costruita nel punto più<br />
alto per sovrastare il Tempio e che i Maccabei, preso possesso di<br />
Gerusalemme, lavorarono tre anni ininterrottamente, giorno e notte, per<br />
spianarla alla perfezione.<br />
Gli Asmonei, inoltre, ingrandirono la piattaforma del Tempio<br />
permettendole di avanzare ulteriormente sul fronte meridionale senza però<br />
farle raggiungere l’ampiezza di quella erodiana. Tracce dei successivi<br />
ingrandimenti sono percepibili lungo la cinta sul lato est: a destra si può<br />
riconoscere il muro di Nemia agganciato all’ampliamento asmoneo, a<br />
sinistra (cioè più a sud) la giunzione tra questo ed il muro erodiano. Il muro<br />
asmoneo appare bellissimo, a grandi blocchi squadrati con le tipiche bugne.<br />
Più avanti, Erode volle ampliare la superficie del Monte Moria con<br />
un’imponente sostruzione di tradizione romana, creando una serie di fornici<br />
ed un nuovo muro di cinta. L’area così cintata veniva ad avere un forma<br />
trapezoidale di 485 x 315 x 460 x 280 m, con il lato più lungo volto ad ovest<br />
e il più corto a sud. La piattaforma si ergeva a 737 m s.l.m.<br />
Siamo in grado di ricostruire con precisione l’aspetto del muraglione<br />
perimetrale: realizzato in grandi blocchi di pietra bugnata di 1,1/1 x 22 m del<br />
peso di cinque/sei tonnellate cadauno, presentava riseghe di 2/3 cm ad<br />
intervalli regolari. Alcuni blocchi erano posti di traverso per creare come un<br />
chiave di ancoraggio alla piattaforma rocciosa naturale; alcuni di essi<br />
misurano anche 11 m di lunghezza.<br />
112
Fig. 77 – Il cardo<br />
romano che<br />
conduceva alla valle<br />
del Tyrupheion con i<br />
blocchi del muro di<br />
Erode crollati sotto i<br />
colpi delle catapulta<br />
che romane.<br />
Fig. 78 – Il cosiddetto<br />
Arco di Robinson -<br />
dal nome<br />
dell’archeologo<br />
scopritore - che<br />
metteva in contatto<br />
l’ambiente degli<br />
archivi di palazzo con<br />
la basilica del Tempio<br />
di Erode.<br />
Oggi, del muro originario, si contano<br />
ancora trentaquattro filari erodiani: il<br />
punto meglio conservato si trova<br />
nell’angolo sud-ovest, dove il muro<br />
raggiunge i 20 m di altezza; presso la<br />
porta di Huldah si riconoscono ancora<br />
alcuni blocchi lunghi 10 m e alti 2 m<br />
dal peso di cinquanta tonnellate.<br />
La Basilica reale s<strong>org</strong>eva al vertice del<br />
lato sud del recinto del tempio di<br />
Erode. L’edificio era a cinque navate<br />
divise da filari di quaranta colonne<br />
distanziate 4,75 m. Secondo Giuseppe<br />
Flavio, per abbracciare ognuna delle<br />
colonne erano necessarie tre persone;<br />
il lato lungo raggiungeva i 180 m; la<br />
navata centrale era ampia 13,5 m e le<br />
laterali 9 m.<br />
L’altezza della navata centrale era doppia rispetto a quella delle laterali,<br />
lasciando così spazio per un cleristorio. È presumibile che ad est (cioè sul<br />
lato corto che guarda alla valle del Cedron) si trovasse un’abside. Le colonne<br />
avevano una circonferenza di 2 m ed erano alte 10 m.<br />
La basilica serviva per gli scambi e le contrattazioni e, dato che i magistrati<br />
romani non avevano diritto di giudizio sulla comunità giudaica, vi si riuniva<br />
anche il Sinedrio; della Basilica non è rimasta più alcuna vestigia.<br />
All’angolo sud-occidentale del muro del Tempio si trovano i resti del<br />
cosiddetto arco di Robinson. Edward Robinson è lo studioso che nel 1838<br />
condusse gli scavi in questa zona e scoprì i resti di un grande arco situato 12<br />
m a nord dell’angolo sud-occidentale del Tempio. Gli studi hanno<br />
dimostrato che l’arco sormontava il cardo romano e che una scalinata,<br />
piegando di novanta gradi, sfruttava questo arco per scavalcare la via, dando<br />
accesso ad una delle quattro porte occidentali del Tempio. È possibile che<br />
alcuni piloni ad est della scala appartengano all’antico archivio di<br />
Gerusalemme. Giuseppe Flavio riferisce che da qui partivano varie scale che<br />
permettevano di raggiungere la Valle di Tyropéion (“dei Formaggiai”).<br />
Il cardo vero e proprio è una strada larga 8 m pavimentata in belle lastre di<br />
pietra che però non presentano le tipiche tracce del passaggio dei carri, forse<br />
perché era stata ripavimentata poco prima dell’assedio di Tito,<br />
su ordine del governatore Albino (62-64 d.C.).<br />
La strada è affiancata da botteghe dotate,<br />
originariamente, di più piani; conservata per 75 m,<br />
passava tangente al muro ovest del Tempio e, al<br />
fondo, deviava verso sinistra per raggiungere la<br />
porta di Damasco.<br />
Sotto la strada corre, ad 1,5 m di profondità, la<br />
cloaca che conduceva a valle le acque nere; un<br />
secondo condotto, a tre metri di profondità,<br />
raccoglieva invece l’acqua piovana convogliandola<br />
verso la cisterna di Birkhet al-Amra (la cisterna<br />
rossa) situata a sud della città.<br />
Il cardo è stata gravemente danneggiato dal crollo<br />
dei muri del Tempio verificatosi durante l’assedio di<br />
Tito e condotto con l’aiuto di catapulte.<br />
Tra i blocchi di crollo è stata trovata una pietra<br />
incisa in ebraico antico in cui è scritto «al luogo dove<br />
il trombettiere annuncia» o, secondo un’altra<br />
lettura, « il trombettiere separa». In effetti, dagli<br />
spalti delle mura, un trombettiere – prima dell’alba<br />
113
Fig. 79 –<br />
Ricostruzione della<br />
balconata destinata al<br />
trombettiere che<br />
segnava con lo shofar<br />
l’inizio e la fine del<br />
sabbath; sulla base<br />
dei resti recuperati<br />
alla base del muro<br />
durante gli scavi<br />
archeologici.<br />
e dopo il tramonto del Sabato – dava uno squillo per segnalare l’inizio del<br />
giorno di riposo. L’originale è conservato nel Museo d’Israele.<br />
Il fregio del muro era ricoperto di stucchi colorati di blu (simbolo dell’aria),<br />
giallo (la terra), rosso (il fuoco) e viola (mare).<br />
Un’altra strada romana corre parallela al muro sud del Tempio; anch’essa è<br />
rialzata e livellata con l’aiuto di fornici di sostruzione di tipo romano e<br />
raggiunge un’ampiezza di 6,5 m. Il lato meridionale delle mura del Tempio<br />
era riservato all’accesso dei pellegrini.<br />
Le porte di Huldah prendono il nome da una profetessa che fu sepolta<br />
vicino alle porte sud della città nel periodo del primo Tempio. Si tratta, di<br />
due accessi: quello più a sinistra ha due fornici, quello a destra ne conta tre.<br />
Le due porte distano tra loro 70 m; dalla loro soglia al cortile del tempio era<br />
necessario percorrere delle scale che colmavano un dislivello di 14 m (si<br />
tratta delle scale incluse nelle cosiddette “stalle di Salomone”, situate nel<br />
corpo della sostruzione del Tempio – non visitabili per ragioni di sicurezza<br />
– ).<br />
Davanti alle porte si trova una grande scala, in parte costruita scavando la<br />
roccia naturale, in parte edificata con blocchi di pietra. Larga 64 m, presenta<br />
gradini di ampiezza alternata (di 90 e 30 cm) così da regolare e rallentare il<br />
passo dei pellegrini che salivano al tempio.<br />
La porta a tre fornici di sinistra non è più quella erodiana ma un rifacimento<br />
successivo. Alla sua base si trova un’iscrizione<br />
funeraria ebraica realizzata in età islamica, quando gli<br />
Ebrei non avevano più accesso alla spianata dove era<br />
stata costruita la moschea di Al-Aqsa.<br />
La porta di destra (a due fornici) in età omayyade era<br />
ancora agibile visto che i califfi islamici la fecero<br />
addobbare aggiungendo un’architrave nuova di zecca.<br />
In questa occasione venne anche reimpiegata<br />
un’epigrafe di Antonino Pio, inserita nel muro<br />
rovesciata.<br />
Dopo il terremoto del 1033 d.C., i Fatimidi<br />
bloccarono la porta edificando un torrione che la<br />
nasconde alla vista per oltre tre quarti. Più a sud,<br />
nella zona dell’Ophel, una vasca con gradini su<br />
quattro lati era usata dai pellegrini per i bagni<br />
collettivi; poteva contenere molta acqua derivata<br />
dalla cisterna del Tempio, la cui capienza è stimata in<br />
40.000 m 3 di acqua.<br />
Dopo la distruzione della città da parte di Tito, i<br />
Romani ristrutturarono il centro riqualificando<br />
l’originaria griglia di cardini e decumani. Dalla porta<br />
di Damasco partiva il cardo massimo, rettilineo e<br />
porticato se due lati. Sempre dalla porta di Damasco<br />
partiva anche il cardo vallensis, che passava in una depressione naturale<br />
raggiungendo, con andamento curvo, il muro ovest del Tempio.<br />
Dalla porta di Giaffa fu tracciato un decumano privo di portici. Adriano,<br />
fondata Aelia Capitolina, vietò agli Ebrei di insediarsi in città, fondando, sul<br />
luogo del secondo Tempio un tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva e<br />
presso la città fu fatta stazionare la X legione.<br />
In età bizantina, l’imperatrice Eudocia fece ricostruire le mura sud della<br />
città: il nuovo perimetro includeva ora l’Ophel, il Monte Sion, la città di<br />
David ed il Monte del Tempio, gravemente distrutto dalle catapulte di Tito.<br />
In quel periodo la spianata era per lo più abbandonata e distrutta; gli Ebrei<br />
erano impossibilitati ad avviare una nuova ricostruzione del Tempio,<br />
mentre i Cristiani non avevano particolare interesse a farlo visto che Gesù<br />
ne aveva profetizzato la fine.<br />
Nell’area dell’Ophel, in particolare, si sviluppò un quartiere molto affollato,<br />
vivacizzato da piccole strade, magazzini spesso sprovvisti di finestre,<br />
monasteri e botteghe artigiane. Questo quartiere rimase semiabbandonato<br />
114
Fig. 80 – Il muro<br />
meridionale del<br />
Tempio colonna, in<br />
alto, il lato posteriore<br />
della moschea di al-<br />
Aqsa; in primo piano<br />
a sinistra la torre<br />
mamelucca che<br />
bloccò l’accesso<br />
all’antica porta<br />
omayyade.<br />
dopo il saccheggio di Gerusalemme attuato nel 614 d.C. dei Persiani. I resti<br />
di molti edifici sono ancora riconoscibili perché le loro fondamenta erano<br />
state scavate nella roccia di base.<br />
A cavallo della porta che dal cortile omayyade porta verso gli scavi orientali,<br />
si trovano alcuni ambienti che potrebbero appartenere ad un ospizio.<br />
Alcune stanze sono decorate a mosaico, uno dei quali recita «buona fortuna<br />
a chi vive qui». Le pareti sono stuccate con tre strati sovrapposti: il primo è<br />
composto di calce e ghiaia, il secondo di malta più fine e impressioni<br />
triangolari che servivano da arriccio per l’ultimo strato di intonaco. A<br />
sinistra della porta omayyade c’è una scala che scende ad una cava<br />
abbandonata.<br />
Alla base della porta di Huldah si riconoscono, invece, le fondazioni del<br />
Monastero delle Vergini. Si tratta di un edificio quadrangolare di circa 18 x<br />
18 m di base, costruito sul finire del IV sec a.C. La planimetria presenta<br />
diverse stanze raccolte attorno ad un cortile.<br />
Gli scavi hanno restituito una tavola d’altare, una croce in bronzo di 64 cm e<br />
un reliquiario con dentro un teschio. Probabilmente la cappella che ospitava<br />
queste reliquie si trovava al secondo piano; l’edificio fu devastato da Cosroe<br />
II e poi abbandonato.<br />
Adiacente al muro sud del tempio, a circa 10 m di distanza dalla tripla porta,<br />
s<strong>org</strong>e un fornice bizantino con volta a botte, parte di un impianto per la<br />
spremitura dell’uva. Una parte della produzione avveniva al piano<br />
superiore, per risolvere il problema dello spazio disponibile, molto angusto.<br />
Come noto, i monasteri bizantini avevano spesso degli impianti artigianali<br />
annessi che garantivano una rendita aggiuntiva. Proprio di fronte, dall’altra<br />
parte della strada, c’era un porticina che permetteva di salire alla cappella<br />
del convento, al secondo piano.<br />
Ad est, allineato al Monastero delle Vergini, c’è un edificio dedalico con ben<br />
tre aperture a nord-est. All’ingresso si vede ancora una croce entro un<br />
cerchio rosso. Dato l’alto numero di scale e le stanze piccoline, sembra<br />
essere stato un ospizio per pellegrini.<br />
Dall’angolo sud-est della cortina del Tempio, parte un muro in blocchi<br />
squadrati senza calce alternato a torri quadrate fatto realizzare da Eudocia<br />
su un tracciato più antico. Il muro è spesso 3 m, era alto 16 m e la parte<br />
interna era riempita ad emplecton.<br />
La conquista da parte dei Musulmani di Gerusalemme avvenne nel 638 d.C.<br />
per opera di Omar Ibn’al Kattabh (634-644 d.C.). Costui, giunto a<br />
Gerusalemme, ordinò la<br />
ripulitura della spianata del<br />
Tempio che, negli ultimi<br />
secoli, si era trasformata in<br />
una discarica. Fu quindi<br />
avviata la costruzione della<br />
moschea di Al-Aqsa<br />
(l’estrema), luogo<br />
identificato come quello in<br />
cui Buraq trasportò<br />
Maometto a Gerusalemme<br />
dalla Medina nel mistico<br />
viaggio notturno. Gli<br />
Omayyadi costruirono<br />
dunque una prima moschea<br />
quadrata in legno, capace di<br />
contenere tremila persone.<br />
Da questo momento, fu<br />
finalmente concesso agli<br />
Ebrei di accedere alla<br />
spianata. Sotto il califfo al<br />
Malik (685-705 d.C.) venne<br />
costruita la cupola della<br />
115
occia (era il 691 d.C.) mentre al-Walid (705- 715) costruì la nuova moschea<br />
di Al-Aqsa. Gli Omayyadi costruirono anche un grande palazzo califfale alla<br />
base del muro sud.<br />
Nel cortile del visitor center si possono osservare i resti di una casa<br />
bizantina con cortile dotata di una scala che permetteva di raggiungere il<br />
piano superiore. Quando Omar venne a Gerusalemme, la casa fu affidata ad<br />
una comunità di ebrei che, aggiunta una nicchia nel muro, la trasformò in<br />
una sinagoga. A fianco della nicchia è dipinta in rosso una menoràh; una<br />
seconda è stata trovata nel crollo (evidentemente inquadrava la nicchia<br />
dall’altro lato). L’architrave della porta che dà accesso alla stanza presenta<br />
una croce cristiana entro un cerchio che, ad un certo punto, fu stuccata per<br />
lasciar spazio a due menoràh. Evidentemente si tratta di un edificio<br />
bizantino trasformato in funzione del culto ebraico.<br />
Poco dopo, il califfo al-Walid avviò, nello stesso luogo, la costruzione di un<br />
palazzo. La prima necessità fu quella di riparare l’enorme breccia nel muro<br />
sud del Tempio creata dalle catapulte di Tito. Completata l’opera con<br />
materiale di recupero si procedette, nella spianata alla base del muro<br />
meridionale, a costruire il grande palazzo.<br />
Dato che la zona era molto irregolare fu necessario livellarla con sostruzioni<br />
a botte derivate dalla tradizione romana. Per evitare che crollassero, le<br />
puntellarono all’interno con pali di legno formanti un’impalcatura di cui si<br />
vedono, ancora oggi, le impronte nella calce.<br />
L’edificio del califfo aveva mosaici e stucchi. Il palazzo fu distrutto dal<br />
terremoto del 749 d.C. Aveva un cortile, due piani, un’entrata al centro del<br />
lato est e una al centro del lato ovest. Un ponte ad arco dava accesso diretto<br />
alla spianata del Tempio dall’ultimo piano. L’imposta dell’arco è ancora<br />
visibile sul lato sud del Tempio.<br />
9.3 – La fortezza di Herodion.<br />
L’Herodion è un palazzo-fortezza edificato da Erode a 5 km di distanza da<br />
Betlemme e a 15 km da Gerusalemme, in una posizione strategica, al confine<br />
tra le colline di Giuda e il deserto della Giudea.<br />
Già nel Medioevo, un frate domenicano, Felix Fabri, giunto sul posto, aveva<br />
scambiato le rovine erodiane per quelle di una fortezza crociata.<br />
Il vero<br />
Fig. 81 – Planimetria<br />
della fortezza palazzo<br />
circolare costruita da<br />
Erode nel sito di<br />
Herodion.<br />
116
Fig. 82 – Un’ottima<br />
ricostruzione grafica<br />
dell’Herodion<br />
realizzato da Erode il<br />
grande, in cui fu<br />
ospitato anche il<br />
generale di Augusto,<br />
Agrippa durante una<br />
sua visita nel Vicino<br />
Oriente.<br />
scopritore dell’Herodion fu lo studioso americano Edward Robinson che nel<br />
1838 lasciò una descrizione del sito. Felician de Saulcy (un esploratore<br />
francese) visitò l’Herodion il decennio successivo (1850- 1863). Costui scavò<br />
la piscina bassa di Erode e avendo trovato una struttura a tholos, pensò di<br />
aver scoperto la tomba del re ideumeo, realizzando per l’occasione disegni<br />
accurati.<br />
Gli scavi partirono nel 1879 con Conrad Schick, un architetto-archeologo<br />
svizzero di stanza a Gerusalemme. Nel 1962 padre Virgilio Corbo scavò il<br />
palazzo con la scuola francescana di Gerusalemme. L’Herodion basso è<br />
stato, infine, scavato dal 1972 da Ehud Netzer che ha recentemente<br />
annunciato anche la scoperta della tomba di Erode<br />
Nel 40 a.C., dopo che Crasso era stato sconfitto a Carre, un personaggio<br />
della famiglia degli Asmonei, Matatia Antigono, si appoggiò ai Parti per<br />
estromettere i Romani dalla regione. Ircano, il vecchio fratello asmoneo<br />
fuggito dalla prigione in cui era detenuto dai Romani, si era precipitato in<br />
Giudea, venendo a rappresentare un grave pericolo. Erode, che era idumeo e<br />
legittimo successore politico di Antipatro – il grande amico dei romani –,<br />
fuggì da Gerusalemme in direzione dell’Herodion nel cuore della notte ma,<br />
il mattino seguente, fu raggiunto dai nemici. Ne seguì una grande battaglia<br />
che lo vide vincitore. Da qui egli raggiunse subito Gerusalemme ma sua<br />
madre perì schiacciata dalle ruote del carro che si era rovesciato. Pare che<br />
Erode fosse molto colpito da questo evento al punto di tentare il suicidio. Ne<br />
fu distolto dai suoi compagni e raggiunse Roma dove fu poi elevato, da<br />
Augusto, al prestigioso ruolo di tetrarca di Giudea; sembra che la decisione<br />
di edificare l’Herodion sia anche nata dal desiderio di celebrare questa<br />
vittoria.<br />
L’Herodion fu probabilmente costruito tra il 23 e il 20 a.C.; quello che è<br />
certo è che nel 15 a.C. vi fu ospitato Marco Vipsanio Agrippa.<br />
E<br />
r<br />
o<br />
d<br />
e<br />
f<br />
r<br />
e<br />
q<br />
u<br />
e<br />
n<br />
t<br />
a<br />
v<br />
a<br />
s<br />
p<br />
e<br />
s<br />
s<br />
o<br />
l<br />
’<br />
H<br />
e<br />
r<br />
o<br />
d<br />
117
Fig. 83 – Disegno<br />
esemplificativo del<br />
sarcofago a rosette<br />
trovato in frammenti<br />
presso la tomba di<br />
Erode.<br />
Fig. 84 – Veduta aerea<br />
del complesso dell’<br />
Herodion con chiara<br />
indicazione della<br />
fortezza superiore e del<br />
palazzo inferiore,<br />
nonché delle vie<br />
d’accesso del luogo del<br />
rinvenimento della<br />
tomba del re di Giuda.<br />
ion soprattutto d’estate<br />
perché in una posizione ben<br />
ventilata; d’inverno<br />
preferiva il palazzo di<br />
Gerico. Dopo la morte<br />
Erode, tra il 4 e il 6 a.C. il<br />
regno fu governato da<br />
Archelao.<br />
Tra il 42 e il 46 d.C. l’edificio<br />
fu affidato ad Agrippa I<br />
(nipote di Erode) che era<br />
stato accolto a Roma<br />
diventando amico di Druso<br />
Maggiore e che avendo<br />
sostenuto Claudio nella sua<br />
ascesa al trono era stato ricompensato con il regno della Giudea.<br />
L’Herodion fu occupato dagli Zeloti durante la rivolta del 70 d.C. e, dopo gli<br />
attacchi militari romani, venne abbandonato.<br />
Architettura: La struttura è costituita da un cilindro dal diametro di 63 m<br />
realizzato con due muri concentrici che distano circa 3,5 m, creando una<br />
galleria interna. Questa era divisa in due piani da un passaggio ligneo la cui<br />
funzione era di coibentare l’interno del palazzo, rafforzare le fondazioni e<br />
permettere l’accesso alle torri percorrendo uno spazio protetto e da una<br />
posizione non facilmente visibile dall’esterno; alcuni di questi corridoi<br />
avrebbero anche potuto utilizzati per stoccare le derrate.<br />
La grande torre est aveva ha un diametro di 18,3 m e si eleva per 20 m sulla<br />
roccia di base. Quello che resta è solamente più il basamento di<br />
un’impressionante torre di vedetta che le fonti ricordano alta 45 m, e che un<br />
tempo doveva presentarsi non molto differente nell’aspetto dalla torre detta<br />
di Fasaele che lo stesso Erode aveva costruito a Gerusalemme.<br />
La torre dell’Herodion ospitava bagni e ambienti residenziali; fonte di<br />
ispirazione per questa architettura eclettica potrebbe essere stato il<br />
celeberrimo Faro di Alessandria, mentre pare poco convincente il paragone<br />
fatto da alcuni studiosi con il Mausoleo di Augusto, le cui fonti di ispirazione<br />
sono legate ai grandi mausolei ellenistici. Nelle ricostruzioni si ipotizza che<br />
n<br />
e<br />
l<br />
c<br />
e<br />
n<br />
t<br />
r<br />
o<br />
g<br />
e<br />
o<br />
m<br />
e<br />
t<br />
r<br />
i<br />
c<br />
o<br />
,<br />
l<br />
118
a torre ospitasse una scala che metteva in collegamento ben sette piani; al<br />
vertice si trovavano due o tre piani abitabili coperti da un tetto a cono. Tre<br />
sono, infine, le torri semicircolari disposte lungo la cinta del castello in<br />
corrispondenza degli altri punti cardinali;divise internamente in piani<br />
ospitavano i soldati e le sentinelle di Erode. In una seconda fase, le torri<br />
furono quadripartite.<br />
Si suppone che le torri non fossero molto più alte della cinta circolare.<br />
Per quanto riguarda l’accesso alla fortezza, Giuseppe Flavio, riferisce<br />
dell’esistenza di una rampa con scalini lunga 120 m. Gli scalini sono spariti<br />
ma è rimasto il varco di accesso largo 6,5 m (l’ampiezza è quella di un tipica<br />
strada romana che permetteva la circolazione di due carri in senso<br />
alternato).<br />
Gran parte della struttura fu realizzata con blocchi di calcare locale bugnato,<br />
capace di facilitare le operazioni di sollevamento dei blocchi con gru e corde.<br />
Il cortile rettangolare è orientato N-S ed è dominato a est da un’imponente<br />
torre cilindrica. Il cortile è circondato da un peristilio di colonne corinzie<br />
con capitelli simili a quelli scoperti a Gerico e a Masada. Le colonne erano<br />
rivestite di stucco così da apparire come monoliti di marmo e sembra che<br />
l’ampio spiazzo interno ospitasse un giardino.<br />
La prima stanza affacciata sul cortile a sud è il triclinio; misura 15 x 10,5 m e<br />
oggi è invaso dai bancali aggiunti dagli Zeloti che vi installarono una<br />
sinagoga.<br />
L’aula si apre sul cortile con una porta inquadrata da due finestre e, nel<br />
progetto originale, la sala era decorata con un pavimento musivo policromo.<br />
A fianco si trova quella che è stata identificata come una chiesa bizantina<br />
ricavata da un ambiente a pianta cruciforme di rappresentanza ai cui angoli<br />
sembra fossero situati, originariamente, dei cubicula. Seguono le piccole<br />
terme di Erode; qui l’ambiente più grande è stranamente il caldarium a cui<br />
segue un laconicum (un tempo coperto da una volta a botte) con una<br />
interessante cupola dotata di oculo fatta con blocchi lapidei, quindi un<br />
piccolo frigidarium e lo spogliatoio.<br />
Il cortile aveva un pozzo che scendeva a una cisterna situata a 10 m sotto il<br />
livello del pavimento. Altre tre cisterne – scavate nella montagna<br />
venticinque metri più in basso – erano capaci di contenere 2500 m 3 d’acqua.<br />
L’edificio, in una seconda fase, fu circondato da un terrapieno che conferisce<br />
ancora oggi alla montagna un impressionante aspetto conico e che ebbe<br />
come effetto quello di bloccare l’accesso esterno alle cisterne; è possibile che<br />
questa operazione sia stata condotta a termine dopo la morte di Erode,<br />
quando l’intera collina fu trasformata in un cenotafio del re idumeo.<br />
Più o meno alla base della torre circolare del cortile dell’Herodion si stacca<br />
un canale sotterraneo scavato dai rivoltosi dell’epoca di Bar Khokbà. Questo<br />
cunicolo scende sino alla cisterna intermedia da cui gli Zeloti intendevano<br />
ricavare una via di fuga. Il detrito derivato dallo scavo di questo condotto fu<br />
gettato al fondo delle cisterne romane che divennero inservibili. In questa<br />
occasione furono anche realizzati dei puntelli in legno simili a quelli in uso<br />
presso le miniere antiche per consolidare staticamente i condotti realizzati<br />
con poca perizia.<br />
119
Fig. 85 – Immagine<br />
del sarcofago a<br />
rosette<br />
probabilmente<br />
appartenuto a Erode<br />
il Grande.<br />
9.4 - Tomba di Erode<br />
La lunga ricerca della tomba di Erode il Grande<br />
ha avuto termine con la venuta alla luce dei resti<br />
del suo sarcofago e di un mausoleo sulle pendici<br />
nord-orientali del Monte Herodion. La scoperta<br />
è stata annunciata nel 2009 da Ehud Netzer<br />
dell’Istituto di Archeologia dell’Università di<br />
Gerusalemme. Il mausoleo era stato quasi<br />
completamente smantellato nell’antichità e al<br />
suo posto è stato possibile ritrovare una parte<br />
del podio costituito da una base in pietra bianca.<br />
Tra i molti elementi architettonici di alta qualità<br />
sparsi tra le rovine, spicca un gruppo di urne.<br />
Altre simili si trovano sui monumenti funebri del<br />
mondo nabateo. Le urne avevano un coperchio a due spioventi ed erano<br />
decorate sui lati.<br />
La scoperta più importante è però costituito da dai pezzi di un grande<br />
sarcofago appartenuto a Erode, lungo quasi 2,5 m, di calcare rossiccio di<br />
Gerusalemme, decorato a rosette. Il sarcofago fu rotto in centinaia di pezzi,<br />
senza dubbio deliberatamente forse tra il 66 e il 72 d.C., durante la Prima<br />
rivolta giudaica, quando i ribelli si impadronirono della rocca. I ribelli erano<br />
noti per il loro odio per Erode e tutto quello che rappresentava, in quanto<br />
governatore “cliente” dei romani.<br />
La ricerca della tomba di Erode si era concentrata per molto tempo<br />
sull’Herodion inferiore, in una zona che era stata costruita espressamente<br />
per il funerale e la sepoltura del re.<br />
Quando non fu trovato alcun segno del sepolcro stesso all’interno dell’area,<br />
la spedizione cominciò a cercarlo sul pendio della collina. Per rivelare i resti<br />
dell’epoca di Erode, la spedizione è stata“costretta” dapprima a scavare un<br />
grosso complesso di strutture bizantine (tra cui una chiesa), uno sforzo che<br />
ha richiesto molti anni di scavi.<br />
Lo storico Giuseppe Flavio ha descritto il funerale nell’anno 4 a.C. ma non la<br />
tomba vera e propria: «Il funerale del re occupò in seguito la sua attenzione.<br />
Archelaus, non omettendo nulla che potesse contribuire alla sua<br />
magnificenza, tirò fuori gli ornamenti regali che dovevano accompagnare la<br />
processione in onore del defunto. La bara era di oro massiccio, con pietre<br />
preziose e aveva una copertura di porpora, ricamata in vari colori; su questa<br />
giaceva il corpo avvolto in una veste viola, con un diadema sul capo e una<br />
corona d’oro, lo scettro vicino alla mano destra. Intorno alla bara c’erano i<br />
figli di Erode e un numeroso gruppo di parenti; questi erano seguiti dalle<br />
guardie, dal contingente di traci, germani e galli, tutti in assetto da guerra. Il<br />
resto delle truppe marciava davanti, armate e ordinate, comandate dai<br />
comandanti e dagli ufficiali subordinati; dietro venivano 500 dei servi e dei<br />
liberti di Erode, portando spezie. Il corpo fu poi portato all’Herodion, dove<br />
fu sepolto, secondo le direttive del defunto. Cosi finì il regno di Erode».<br />
(Guerra Giudaica 1,23,9)<br />
9.5 - L’Herodion basso<br />
Si tratta di un complesso pianificato alla base della collina dell’Herodion.<br />
Data l’irregolarità della morfologia originale, gli architetti di Erode<br />
dovettero livellare l’area con un terrapieno artificiale. Il palazzo, (che è<br />
dotato di molte infrastrutture acquatiche come piscine e ninfei) era servito<br />
dall’acquedotto di Erode che arrivava da Betlemme.<br />
L’elemento centrale è rappresentato da un peristilio che racchiude un<br />
giardino ed una vasca dell’acqua. Il peristilio misura 122 x 105 m e la piscina<br />
in esso contenuta è profonda 4 m, una profondità notevole che la rendeva<br />
più adatta per una navigazione con piccole barche (secondo un raffinato uso<br />
già noto presso i Tolomei) piuttosto che per il nuoto (la capienza è stata<br />
120
Fig. 86 – Planimetria<br />
ricostruttiva<br />
dell’Herodion basso<br />
con la via di accesso<br />
processionale che<br />
permetteva di<br />
raggiungere la<br />
fortezza superiore.<br />
calcolata in 10.000 m 3 d’acqua). Al centro, si trovano i resti del podio di un<br />
edificio circolare che avrebbe potuto essere una tholos.<br />
I peristili che girano attorno alla vasca sono colonnati con ordine ionico e<br />
sopraelevati di 1,5 m tramite cinque gradini, probabilmente per facilitare la<br />
visione dello specchio d’acqua a chi passeggiava nel palazzo.<br />
Il complesso è chiuso ad est e ad ovest da due lunghi ambienti (quello di<br />
ovest è stato costruito addirittura incidendo la roccia basale) la cui funzione<br />
non è molto chiara.<br />
Nella parte ovest del complesso si trovano le terme. Passato un piccolo<br />
cortile colonnato si accedeva ad uno spogliatoio seguito da un caldarium, da<br />
due tepidaria e da un piccolo frigidarium.<br />
Sulle pendici della collina si trovano le sostruzioni voltate a botte di un<br />
palazzo esteso sul lato maggiore per 130 m, smantellato dai bizantini per<br />
ricavare materiale da costruzione.<br />
Alla sua base si trovano le tracce di un’area lunga 350 m e larga 35 m. È<br />
possibile che si tratti della via processionale di cui parla Giuseppe Flavio ed<br />
in cui si svolse il corteo funebre di Erode.<br />
Ad ovest, proprio dove inizia la via processionale (in molte guide viene<br />
ancora chiamato “circo”), si trova un edificio quadrangolare con diverse<br />
nicchie ed una grande apertura che guarda ad est. L’aspetto non è poi così<br />
diverso da quello mostrato da alcune tombe di Petra (ad esempio il triclinio<br />
della Tomba del soldato romano). In età romana fu trasformato in ninfeo,<br />
ma all’età di Erode era qualcosa di diverso: un mausoleo? una biblioteca? un<br />
triclinio? L’edificio si specchiava ad est, su una vasca dell’acqua; alle sue<br />
spalle una scaletta porta al grande peristilio di palazzo.<br />
121
Fig. 87 – Veduta aerea<br />
della fortezza di Masada<br />
con all’ampio plateaux<br />
superiore perfettamente<br />
fortificato e, chiaramente<br />
indicata, la rampa di<br />
assedio romana.<br />
9.6 – Fortezza di Masada<br />
Diverse interessanti informazioni sulla fortezza di Masada sono contenute<br />
nella Guerra giudaica e nelle Antichità giudaiche compilate dallo storico<br />
romano di origini ebraiche Giuseppe Flavio. Giuseppe – il cui nome<br />
originario era quello di Matatìa – ebbe modo di raccogliere molte<br />
informazioni di prima mano, dal momento che fu coinvolto a livello<br />
personale nella grande rivolta iniziata nel 66 a.C.<br />
Giuseppe Flavio era nato a Gerusalemme nel 37 d.C. da una famiglia<br />
sacerdotale e sua madre era imparentata con la dinastia asmonea. All’età di<br />
diciassette anni si ritirò con un amico di nome Banus nel deserto della<br />
Giudea dove rimase per tre anni; è possibile che in questa occasione abbia<br />
avuto la possibilità di vedere o raccogliere le prime informazioni sulla<br />
fortezza di Masada. All’età di 26 anni Giuseppe fu inviato a Roma per<br />
intercedere presso Nerone per alcuni sacerdoti giudei che si erano appellati<br />
in giudizio all’imperatore, ottenendo ottimi risultati grazie all’intercessione<br />
di Poppea e di Aliturus, un attore di origini giudee molto attivo a corte.<br />
Tornato in Giudea, Giuseppe si trovò di fronte alla grande rivolta giudaica,<br />
nei confronti della quale, almeno inizialmente, mantenne un atteggiamento<br />
ambiguo. Il “governo” instaurato a Gerusalemme, infatti, lo pose al<br />
comando delle truppe dei rivoltosi in Galilea e quando l’esercito romano<br />
raggiunse la cittadina di Iotapata, Giuseppe resistette per sei settimane;<br />
quando i Romani conquistarono la città, Giuseppe si rifugiò in una grotta<br />
con quaranta rivoltosi, riuscendo a sopravvivere con uno stratagemma, per<br />
poi collaborare con i Romani in qualità di interprete. Dopo aver rifiutato un<br />
appezzamento di terra alla periferia di Gerusalemme, Giuseppe scelse di<br />
s<br />
e<br />
g<br />
u<br />
i<br />
r<br />
e<br />
T<br />
i<br />
t<br />
o<br />
a<br />
R<br />
o<br />
m<br />
a<br />
p<br />
e<br />
r<br />
i<br />
l<br />
trionfo della Guerra Giudaica; entrato in amicizia con la famiglia imperale<br />
fu ospitato da Vespasiamo in un settore del Palatino, ebbe una rendita dallo<br />
stato romano e venne incaricato di scrivere un resoconto della Guerra<br />
Giudaica. Il volume, pubblicato dopo dieci anni, si conclude con il racconto<br />
del grande sacrificio dei giudei asserragliati nella fortezza di Masada; è<br />
chiaro che uno degli obbiettivi di questo trattato è di scoraggiare i<br />
provinciali da ulteriori rivolte, descrivendo in dettaglio l’<strong>org</strong>anizzazione e<br />
l’efficienza della machina da guerra romana. Nel 94 d.C. vennero infine<br />
122
Fig. 88 – Il palazzo<br />
estivo di Erode sul<br />
versante<br />
settentrionale della<br />
fortezza di Masada<br />
con i padiglioni e le<br />
rotonde panoramiche.<br />
pubblicate le “Antichità giudaiche”, un resocondo della storia del popolo<br />
ebraico dalle origini al tempo della rivolta. In questo libro, Giuseppe ci<br />
informa del fatto che il primo a costruire una fortezza sulla spianata di<br />
Masada fu il prete Gionata in cui gli storici riconoscono il gran sacerdote e<br />
re degli asmonei Alessandro Ianneo. In effetti, appartiene agli Asmonei l’uso<br />
di costruire palazzi fortificati fuori Gerusalemme su veri e propri nidi<br />
d’aquila. La loro funzione era quella di costituire un valido rifugio in caso di<br />
rivolta; da qui, sarebbe stato possibile ri<strong>org</strong>anizzare le forze e le truppe e<br />
piombare su Gerusalemme riconquistando il trono. Tutte le fortezze<br />
asmonee conosciute (l’Alexandreion, Ircania, Aristobulia, Macheronte) si<br />
caratterizzano per essere poste su vertiginose rocche strapiombanti, per<br />
essere circondate da muraglioni difensivi ed essere dotate di impianti<br />
idraulici (acquedotti spesso basati sul principio del sifone) e di grandi<br />
cisterne per lo stoccaggio dell’acqua piovana. Gli Asmonei, in tempo di pace,<br />
utilizzavano queste fortezze per nascondervi le proprie ricchezze, per<br />
imprigionarvi i rivali politici, per eseguirvi sentenze di morte e per curare<br />
affari governativi “un po’ speciali” lontano da occhi indiscreti.<br />
Nel caso specifico di Masada, la<br />
fortezza fu coinvolta nelle convulse<br />
fasi della resa di potere di Erode. Nel<br />
43 a.C., Malico – che era comandante<br />
in capo delle truppe asmonee –<br />
avvelenò ad un banchetto il padre di<br />
Erode, Antipatro. Fallito il tentativo<br />
di Malico di diventare governatore<br />
della Giudea, la rivolta venne presa in<br />
mano da suo fratello che si<br />
asserragliò a Masada venendo però<br />
battuto da Erode.<br />
Si tornerà a parlare di Masada due<br />
anni più tardi. L’ultimo discendente<br />
degli Asmonei Mattia Antigono<br />
voleva infatti approfittare della<br />
penetrazione dei Parti nel nord della<br />
Siria per prendere il potere.<br />
Promettendo loro laute ricchezze<br />
chiese che intervenissero in Giudea. Erode di fronte a questo grave pericolo<br />
si ritirò con la famiglia nella fortezza di Masada. Dopo aver lasciato<br />
ottocento militari di guardia, raggiunse rapidamente il regno nabateo con<br />
cui aveva ottimi rapporti diplomatici (una della sue mogli, Cyprus, era<br />
infatti imparentata con la famiglia reale nabatea). Non avendo ottenuto<br />
grandi risultati egli partì alla volta di Roma dove incontrò Marco Antonio<br />
che aveva rinnovato un patto triumvirale con Augusto. Avuta l’investitura di<br />
tetrarca di Giudea con la ratifica dal Senato di Roma, Erode sbarcò ad Acri<br />
muovendo con le truppe verso Masada che liberò dalla stretta di Antigono.<br />
Poi, nel corso di tre anni, riprese possesso del suo regno. Da questo<br />
momento Erode tenne in massima considerazione questa fortezza,<br />
soprattutto considerando i pericoli che venivano dall’Egitto dove Cleopatra<br />
– entrata in grande confidenza con Antonio – mirava ad esercitare un<br />
influenza politica anche sulla Giudea; non a caso Antonio aveva stabilito<br />
proprio in quegli anni che la zona di Gerico fosse sottratta ad Erode e data<br />
in sfruttamento a Cleopatra; la regione era economicamente molto<br />
strategica perché qui si estraeva e preparava il preziosismo balsamo.<br />
Durante i trentasei anni di regno di Erode il pianoro di Masada fu soggetto<br />
ad ingenti trasformazioni. In una prima fase, al centro del plateaux si avviò<br />
la costruzione di un palazzo reale; in un secondo tempo si provvide a<br />
costruire un palazzo climatizzato situato sullo strapiombo della falesia nord,<br />
dotato di terme, uffici amministrativi, magazzini; in questa stessa fase<br />
vennero realizzati importanti condotti dell’acqua e cisterne sotterranee.<br />
Nell’ultima fase, tutto il pianoro venne circondato da un grande muro di<br />
123
cinta dotato di torri di avvistamento e casermette. Ampi spazi erano liberi,<br />
probabilmente per lasciare spazio ad orti e coltivazioni. Quando Augusto<br />
vinse la resistenza di Marco Antonio e Cleopatra nella famosa battaglia di<br />
Azio del 31 a.C., Erode – che era stato un supporter di Marco Antonio –<br />
temette per il suo futuro e quello dei famigliari; così fece rifugiare i suoi<br />
familiari a Masada e la moglie prediletta Mariamne nell’Alexandreion per<br />
recarsi a Rodi ad incontrare Augusto. Facendo leva sulle sue doti di fedeltà,<br />
Erode riuscì ad impressionare positivamente l’imperatore vedendo<br />
riconfermati i suoi poteri.<br />
Alla morte di Erode nel 4 a.C., la fortezza passò in mano al figlio Archèlao,<br />
presto deposto da Roma a causa delle continue lamentele che il suo<br />
comportamento provocava nei Giudei. Deposto Archelao, i Romani vi<br />
posero di stanza per oltre sessant’anni una guarnigione militare. Come noto,<br />
il crescere della pressione fiscale, la corruzione di alcuni governatori romani<br />
e il tentativo da parte dell’impero romano di introdurre statue ed insegne<br />
all’interno del recinto del Tempio di Gerusalemme accrebbero<br />
gradatamente l’astio dei Giudei che ricordavano ancora l’atteggiamento<br />
ellenizzante messo in pratica da Antioco III Epifane. La situazione favoriva<br />
tutti quei profeti ed interpreti di orientamento messianico che vedevano<br />
avvicinarsi la fine dei tempi e la resa dei conti e che interpretavano molti<br />
fenomeni naturali come le eclissi solari o le scosse telluriche come un segno<br />
divino.<br />
Nel 66 d.C. si assistette ad una insurrezione generale da parte di gruppi che<br />
chiedevano l’emancipazione da Roma; tra i capi popolo, Giuseppe ricorda<br />
Giuda di Gamla (attivo in Golan) e Zadok il fariseo (attivo a Gerusalemme).<br />
Questi gruppi – che vengono comunemente definiti con il nome di Zeloti –<br />
erano fondamentalmente composti da farisei che interpretavano la legge in<br />
modo abbastanza rigido e che non accettavano di riconoscere qualunque<br />
autorità eccetto quella di Dio. Giuseppe attribuisce loro il nome di “sicari”<br />
per l’ abitudine di confondersi nei luoghi pubblici e pugnalare con la daga gli<br />
oppositori politici. Il leader dei rivoltosi della Galilea fu identificato in<br />
Manahem ben Giuda a cui vennero attribuite qualità messianiche; il leader<br />
dei gruppi gerosolimitani fu Eleazaro figlio di Hanania, l’alto sacerdote.<br />
Il primo a muoversi fu Manahem che attaccò la fortezza di Masada, si<br />
impossessò delle riserve di cibo e delle armi che vi erano raccolte e da qui<br />
piombò su Gerusalemme occupandola e incoronandosi re. Il giorno<br />
successivo la fazione dei galilei mise le mani sul vecchio gran sacerdote e i<br />
suoi familiari che, portati in un condotto della città furono giustiziati. I<br />
giorni seguenti, Manahem indossò gli abiti sacerdotali per fare ingresso nel<br />
tempio. Subito gli Zeloti di Gerusalemme guidati da Eleazaro ben Yair (il<br />
nipote di Manahem) gli piombarono addosso e lo uccisero. Eleazaro si<br />
rifugiò quindi a Masada: da qui i rivoltosi iniziarono a effettuare sortite e<br />
razzie nella zona di Hebron e della costa del Mar Morto, ad esempio a en<br />
Gedi. Altri protagonisti della rivolta si appoggiarono alla fortezza; è il caso<br />
di Simone bar Giora entrato in rotta di collisione con Hanan ben Hanan,<br />
l’alto sacerdote di Gerusalemme. Riconquistata Gerusalemme, Simone fu<br />
parte attiva della resistenza ai Romani e dopo la vittoria di Tito e<br />
Vespasiano fu condotto a Roma come prigioniero per essere poi decapitato<br />
vicino al tempio di Giove in qualità di leader della rivolta. Dopo la caduta<br />
Gerusalemme rimanevano ancora sacche di irriducibili arroccati nelle<br />
vecchie fortezze erodiane. Giunio Basso fu incaricato di condurre le truppe<br />
romane all’assedio. La prima fortezza ad essere espugnata fu l’Herodion,<br />
quindi Macheronte in Transgiordania e per ultima Masada. Giunio Basso<br />
morì prima che iniziasse l’assedio di Masada e il comando passò a Flavio<br />
Silva. La fortezza era occupata da gruppi di irriducibili sicari guidati da<br />
Eleazaro, discendente di Giuda. I Romani circondarono la rocca con un<br />
muraglione ed edificarono una serie di fortini che sarebbero stati utili per<br />
condurre a termine l’assedio. L’elemento più impressionante è certamente<br />
la grande rampa alta 100 m, appoggiata al lato ovest della collina che<br />
permise di portare sin sotto le mura una torre di assedio alta 35 m dotata di<br />
124
Fig. 89 – Planimetrie di<br />
dettaglio della fortezza<br />
di Masada con<br />
indicazione dei<br />
principali edifici<br />
residenziali, delle<br />
cisterne e degli<br />
ambienti di servizio.<br />
catapulte che “battevano”le vecchie mura della fortezza di Erode. Gli<br />
assediati vedendo crollare le difese avevano raccolto detriti, terra e tronchi<br />
di legno con cui rimpiazzare il vecchio muro. Secondo Flavio Giuseppe gli<br />
Zeloti, vista l’impossibilità di una via di fuga, presero la decisione di<br />
suicidarsi collettivamente piuttosto che vedere le proprie mogli disonorate<br />
dai soldati romani e i figli tratti in schiavitù a Roma. Secondo Giuseppe<br />
novecentosessanta persone si diedero quindi la morte; ad essi sopravvissero<br />
solo due donne con i cinque figli che si erano nascosti in una cisterna. I<br />
Romani penetrati il mattino seguente nella fortezza, la trovarono deserta e<br />
raccolte informazioni dai pochi sopravvissuti ammirarono la nobiltà e la<br />
determinazione degli Zeloti.<br />
Alcuni tratti del racconto hanno incuriosito gli storici: perché i Romani<br />
attesero il mattino per portare a termine l’assedio (visto che il sole a<br />
quell’ora sarebbe stato loro sfavorevole?); perché portarono a termine un<br />
assedio così imponente se la fortezza era occupata semplicemente da<br />
manipoli di banditi fuggiaschi? Soprattutto, come mai più volte nelle Guerre<br />
Giudaiche si racconta di suicidi di massa (ad esempio quello di Gamala in<br />
cui Flavio Giuseppe era riuscito a salvarsi escogitando un trucco)? Il dubbio<br />
è che il racconto sia un artificio letterario o una amplificazione. Alcuni<br />
storici si chiedono come sia stato possibile che ancora tre anni dopo la<br />
caduta di Gerusalemme, fortezze così strategiche come l’Herodion e Masada<br />
potessero ancora essere in mano ai rivoltosi.<br />
L’altipiano di Masada fu scelto già dagli Asmonei per la sua inaccessibilità.<br />
Il lato più semplice da approcciare è quello occidentale, dove il dislivello tra<br />
la sommità e la base si riduce a cento metri. Qui anticamente passava la<br />
principale via d’eccesso alla fortezza, oggi visibile nella risistemazione che<br />
ne fecero i monaci che in età bizantina si sistemarono sulla spianata<br />
costruendo un piccolo monastero. Quando Erode costruì le cisterne nel<br />
cuore della rocca, fu realizzato sul lato nord un secondo sentiero che saliva a<br />
zig zag alla cosiddetta “porta della acque”, ancora riconoscibile. Sul lato est<br />
che guarda al Mar Morto, il dislivello sale a 350 m; qui si trovava il “sentiero<br />
del serpente” che sale zigzagando dal fondovalle alla sommità dove<br />
intercetta la terza porta ricavata nella cinta. Il collegamento tra la porta “del<br />
serpente” e quella “dell’acqua” fu assicurata da un sentiero di<br />
circonvallazione che corre ancora poco sotto le mura. Le tre porte di accesso<br />
125
Fig. 90 – Ricostruzione<br />
tridimensionale del<br />
palazzo settentrionale<br />
di Masada; un chiaro<br />
esempio di eclettismo<br />
di architettura<br />
ellenistica.<br />
a cui abbiamo accennato erano<br />
dominate da una torre di avvistamento,<br />
avevano portali con doppio battente e<br />
atrio con bancali. Il perimetro totale<br />
del muro di cinta misura un chilometro<br />
e duecentonovata metri; Giuseppe<br />
ricorda che lungo di esso erano<br />
dislocate trentasette torri con scale<br />
interne mobili (lignee); di queste torri<br />
ne rimangono ancora ventisette. Al<br />
muro di cinta erano appoggiati<br />
ambienti dall’ampiezza di 6,5 m che<br />
furono reimpiegati dagli Zeloti<br />
(costruendo nuove partizioni interne,<br />
forni e dispense) come abitazioni per le<br />
diverse famiglie che si erano rifugiate a<br />
Masada. Come sempre, i tetti dovevano<br />
essere realizzati incannicciato rivestito<br />
di argilla sospeso su travature lignee; è<br />
probabile che gran parte delle<br />
coperture del tetto siano state smantellate dagli assediati per costruire il<br />
famoso muro difensivo a cui accenna Giuseppe Flavio. All’interno di uno<br />
degli ambienti della cinta è stato trovato un rogo in cui erano stati gettati<br />
abiti, ornamenti personali, scarpe e utensili; potrebbe trattarsi del rogo<br />
precedente la notte del suicidio di massa a cui accenna Giuseppe Flavio. Sul<br />
lato di nord-ovest del complesso è stato individuato un’ambiente con<br />
bancali diviso in tre navate da un piccolo colonnato. Si tratta di una vecchia<br />
stalla di età erodiana composta di atrio e aula per i cavalli, trasformata dai<br />
rivoltosi in una sinagoga. In un ambiente adiacente è stato trovato un<br />
ripostiglio in cui erano stati sacralmente sepolti alcuni scritti religiosi (in<br />
ottemperanza alla legge ebraica) – si tratta tecnicamente di una genizah –<br />
in cui si riconoscono i capitoli finali del Deuteronomio e alcune parti della<br />
profezia di Ezechia sulla Resurrezione delle ossa. Due ostraca recuperati in<br />
questo ambiente riportano, tra l’altro, il nome di Ezechia e un titolo<br />
sacerdotale.<br />
In corrispondenza della scarpata settentrionale fu costruito, da Erode, il<br />
secondo palazzo reale. Si tratta di un edificio appollaiato su un vero e<br />
proprio nido d’aquila, diviso in tre settori separati da un dislivello<br />
rispettivamente di 20 e 30 m. Alle spalle di un grande complesso di<br />
magazzini si riconosce il piano più alto, <strong>org</strong>anizzato attorno ad un atrio<br />
affiancato da quattro ambienti abitativi. Una scala permetteva di<br />
raggiungere il terrazzo intermedio costituito da un salone circolare –<br />
probabilmente porticato – adiacente ad una piccola stanza. Una scala a<br />
chiocciola ricavata nel ventre della montagna permetteva di scendere fino<br />
all’edificio inferiore, raccolto attorno ad un cortile porticato in<br />
comunicazione con delle piccole terme. Le colonne erano costituite di più<br />
rocchi sovrapposti poi stuccati e dipinti ad imitazione del marmo. Le pareti<br />
dell’ambiente sono decorate con affreschi di primo stile pompeiano. In<br />
corrispondenza della scaletta che scende alle piccole terme, Tigel Yadin ebbe<br />
modo di scoprire il corpo di un uomo, di una donna e di un bambino nonché<br />
i resti di una corazza romana, punte di freccia e uno scialle. La prima<br />
interpretazione fu quella che si trattasse dei resti degli ultimi sopravvissuti<br />
alla tragica notte dell’assedio, una interpretazione oggi messa fortemente in<br />
discussione.<br />
Sulla parete della falesia situata nelle immediate vicinanze del palazzo nord<br />
si trovano alcune cisterne per la raccolta dell’acqua piovana fatte costruire<br />
da Erode e capaci di contenere, complessivamente, quarantamile metri cubi<br />
d’acqua. Già nel periodo asmoneo, per dare risposta al problema di una<br />
piovosità ridotta a quindici centimetri d’acqua annui, si erano costruite al<br />
vertice della montagna alcune cisterne che raccoglievano l’acqua piovana.<br />
126
Fig. 91 – Uno dei sette<br />
campi militari<br />
impostati dei romani<br />
durante l’assedio della<br />
fortezza di Masada nel<br />
periodo della prima<br />
rivolta giudaica.<br />
Erode realizzò un sistema più elaborato creando dei canali che<br />
raccoglievano l’acqua che stagionalmente ingrossava i due vicini wadi<br />
facendola risalire, con un sistema di sifoni, fino alle cisterne di palazzo. Le<br />
quattro cisterne inferiori si trovano a 130 m dalla sommità e potevano<br />
essere raggiunte dal sentiero “del serpente”; quella superiore - a 80 m dalla<br />
sommità - era collegata da un altro sentiero alla “porta delle acque”. Non<br />
esistevano canali o pozzi che mettessero in comunicazione le cisterne con il<br />
palazzo: dunque ci si doveva affidare a gerle caricate a dorso di mulo per<br />
fare percorrere all’acqua i pochi metri che le separavano dal palazzo del re.<br />
Immediatamente ad est del Palazzo Reale si trovano ventitre fornici che<br />
servivano come deposito di derrate. All’interno dei fornici sono stati trovati<br />
diversi recipienti colmi di cibo ancora abbastanza ben conservati in quanto<br />
protetti dalle travi cadute trasversalmente durante il collasso della struttura.<br />
In effetti, parte dei fornici sembra stata messa deliberatamente a fuoco, in<br />
armonia con quanto raccontato da Giuseppe secondo cui i rivoltosi diedero<br />
fuoco solo ad un settore dei magazzini, così da poter dimostrare ai Romani<br />
che il loro sacrificio non derivava dal venire meno dello scorte ma da una<br />
scelta deliberata. I diversi recipienti erano separati a seconda del contenuto<br />
(vino, olio, spezie). Delle scritte sull’argilla indicavano il nome dei<br />
possessori; tra i nomi riconoscibili quelli di Samuele ben Ezra e di Simeone<br />
ben Yoezer. Altri recipienti erano marchiati con la lettera ebraica taf<br />
(abbreviazione per truma = “offerta”) . Altri recipienti dimostrano che le<br />
riserve erano state accatastate dagli Zeloti perché riportano iscrizioni di<br />
purezza come Ksher(in) leteharat haodesh (Kosher santificato per la<br />
libagione). Tra il palazzo e i magazzini si trova un impianto termale che<br />
presenta una planimetria chiaramente ispirata a quella delle terme romane.<br />
Il complesso è composto dalla tipica palestra porticata seguita da uno<br />
spogliatoio, un frigidarium, un tepidarium e un caldarium; gli Zeloti però<br />
modificarono lo spogliatoio ricavandone una vasca per le abluzioni rituali<br />
Al centro del pianoro si trova il primo palazzo di Erode. Vi si entra da un<br />
portale affiancato da ambienti per le guardie con un anticamera dotata di<br />
sedile-bancale di attesa. L’impianto dell’edificio è raccolto attorno ad un<br />
cortile. Un anticamera situata sul lato meridionale dà accesso ad una sala<br />
angolare sul cui pavimento si riconoscono ancora le tracce di quattro basi e<br />
diversi frammenti di legno carbonizzati; si dovrebbe trattare della stanza del<br />
trono del re. Una porticina dà accesso ad un’altra anticamera che conduce ai<br />
bagni privati: una scala permetteva di raggiungere i piani superiori; altre<br />
stanze satelliti erano usate dai famigliari, per l’amministrazione e i servizi di<br />
palazzo. E’ probabile che dopo la costruzione del palazzo nord questo<br />
edificio sia stato degradato a stanza per l’entourage di Erode.<br />
Altre infrastrutture sono<br />
disperse nell’ampio<br />
spazio della spianata di<br />
Masada. Nell’angolo<br />
sud-ovest del palazzo si<br />
trova una piscina<br />
quadrangolare di 14 x<br />
7,5 m interpretata da<br />
Yadin come una piscina<br />
di età erodiana; oggi si è<br />
propensi a credere sia<br />
stata sistemata dagli<br />
Zeloti per effettuare i<br />
previsti bagni rituali.<br />
127
Fig. 92 – Veduta aerea<br />
complessiva dal lato<br />
settentrionale del<br />
complesso del palazzo<br />
di Erode a Masada.<br />
Sembra invece<br />
attribuibile ad<br />
una iniziativa di<br />
Erode la piscina<br />
di 18 x 12 m,<br />
costruita in<br />
prossimità della<br />
scarpata di sudovest.<br />
In vari<br />
tratti del pianoro<br />
si trovano poi<br />
vasche ad<br />
immersione<br />
destinate alla<br />
purificazione<br />
precedente il<br />
rituale<br />
(mikvaot). E’<br />
interessante<br />
ricordare che<br />
secondo le<br />
prescrizioni<br />
sacre era<br />
necessario utilizzare solo acqua molto pura, piovana o proveniente da<br />
s<strong>org</strong>enti. Quando però, come nel caso di Masada il clima inclemente non<br />
permetteva di adempiere alle prescrizioni era consentito mescolare acqua<br />
proveniente dalla s<strong>org</strong>ente (pura) con acqua proveniente da cisterne<br />
(impura). Questo spiega l’esistenza di doppie vasche comunicanti con<br />
tubazioni che servivano a mescolare le acque.<br />
Al centro del pianoro è possibile anche riconoscere i resti di una chiesa<br />
bizantina appartenente ad un monastero impostato nel corso del VII sec.<br />
d.C. dai monaci che ricolonizzarono l’altura. Altri eremiti si erano<br />
certamente sistemati nelle grotticelle disperse tutt’attorno.<br />
La riscoperta di Masada si deve all’americano Edward Robinson che<br />
identificò il sito con un cannocchiale mentre si trovava a Ein-Gadi.<br />
9.6.2 – Manoscritti<br />
Nelle ricerche a Masada è stato possibile raccogliere circa cinquemila<br />
monete, settecento ostraca e moltissimi frammenti di rotoli iscritti. Tra gli<br />
altri, sono stati riconosciuti frammenti del Libro dei Salmi, del Levitico,<br />
prescrizioni per i sacrifici del Sabbath; tutti libri che presentano affinità con<br />
quelli scoperti nelle caverne di Qumran. Dato che molti di questi libri<br />
furono deliberatamente stracciati, si reputa che si sia trattato di<br />
un’operazione deliberata portata a termine dai Romani dopo aver<br />
conquistato la fortezza. Tra i testi più interessanti si annoverano diverse<br />
pagine del giudizio di Ben Sira, un testo biblico non canonico conosciuto<br />
solo tramite un’edizione greca scritta da suo nipote alla fine del II sec d.C. e<br />
poi inclusa nel Canone Cristiano sotto il nome di Ecclesiastico. E’ stato poi<br />
possibile ritrovare alcune pagine originali in lingua ebraica del Libro del<br />
Giubileo.<br />
Per quanto riguarda gli ostraca essi riportano generalmente poche lettere e<br />
si presume servissero per <strong>org</strong>anizzare la distribuzione del cibo tra gli<br />
assediati. Alcuni riportano dei nomi come «figlia di Katra, figlio di Karzela,<br />
moglie di Giacomo». Presso il palazzo è stato trovato un deposito di ostraca<br />
ove sembra di poter riconoscere il nome di sacerdoti. Presso i magazzini si<br />
sono trovati cocci di terracotta riportanti le sigle di «figlio del fornaio», «il<br />
cacciatore» e persino il nome di Ben Yair che Giuseppe Flavio ci ricorda<br />
essere stato il nome del comandante della guarnigione.<br />
128
Fig. 93 – Veduta dal<br />
basso della fortezza<br />
erodiana di<br />
Macheronte in<br />
Giordania, la più<br />
orientale di quelle mai<br />
costruite da Erode<br />
Zigael Yadin fu il primo a teorizzare che questi ostraca fossero stati<br />
utilizzati nella ultima famosa notte del suicidio di massa per estrarre a sorte<br />
i condannati, una ipotesi che negli ultimi anni è stata messa in dubbio. Tra<br />
le iscrizioni degne di nota una riportante il nome di «Akavia, figlio di<br />
Hananiah il Gran Sacerdote», forse lo stesso citato da Giuseppe. Altri cocci<br />
riportano il contenuto delle diverse anfore: fichi, carne, balsamo.<br />
Tra le monete ritrovate, vale la pena ricordare quelle coniate dai rivoltosi<br />
che portavano la dicitura «Shekel Israel» e «Gerusalemme la Santa»,<br />
seguita da lettere che indicano l’anno della rivolta (1,2,3,4 / shana aleph,<br />
shana beth etc. etc.).<br />
9.7 – La fortezza erodiana di Macheronte<br />
Le rovine dell’antica cittadella di Macheronte (l’odierna Mukawir), si<br />
trovano al vertice di una scenografica montagna conica modellata<br />
dall’erosione millenaria a circa 700 metri sul livello del mare, ai bordi della<br />
faglia che strapiomba vertiginosamente sul Mar Morto, 30 km a sud di<br />
Madaba.<br />
Dell’edificio originario non rimane molto a causa delle ingiurie del tempo<br />
ma il luogo emana un fascino straordinario per l’imponenza del paesaggio<br />
ed in considerazione delle vicende storiche succedutesi su questo vero e<br />
proprio “nido d’aquila”. Qui, secondo la tradizione soggiornò Erode il<br />
Grande e fu decapitato Giovanni Battista; anche alcuni gruppi di ebrei vi<br />
cercarono inutilmente rifugio nel loro ultimo disperato tentativo di rivolta<br />
contro i Romani.<br />
Un primo edificio fu costruito, attorno al 100 a.C., dal principe Alessandro<br />
Ianneo della dinastia giudea degli Asmonei, in una posizione strategica,<br />
sulla strada che da Amman conduce verso il Mar Morto, per controllare il<br />
confine strategico con il regno Nabateo. Della fortezza originaria non<br />
rimangono resti sensibili poiché venne distrutta dal governatore romano<br />
della Siria Gabinio nel 57 a.C. nel quadro delle guerre di conquista dell’area<br />
siro-palestinese coordinate dal generale Pompeo.<br />
Fu tuttavia Erode il Grande, designato da Augusto governatore della Giudea<br />
nel 30 a.C., a mettere mano alla costruzione di un nuovo possente palazzo<br />
s<br />
i<br />
t<br />
u<br />
a<br />
t<br />
o<br />
a<br />
l<br />
l<br />
a<br />
s<br />
o<br />
m<br />
m<br />
i<br />
t<br />
à<br />
d<br />
e<br />
l<br />
l<br />
129
Fig. 94 – Il cortile<br />
della fortezza di<br />
Macheronte presso il<br />
quale, secondo alcuni<br />
archeologici, sarebbe<br />
avvenuta la famosa<br />
danza di Salome.<br />
a montagna, non lontano delle terme di Callirhoe (Zara) ove si recava spesso<br />
nel tentativo di curare la salute malferma.<br />
Nell’ultimo decennio, le rovine sono state oggetto di ricerche e restauri con<br />
la collaborazione dell’Università di Firenze. L’edificio, completamente<br />
autosufficiente e capace di offrire tutte le comodità gradite ad un principe,<br />
era parte di una rete di cittadelle di cui la Masada – in Israele – è,<br />
certamente, l’esempio più noto.<br />
. Sul crinale della breve sella che congiunge il moderno parcheggio con la<br />
montagna vera e propria è possibile riconoscere i resti di un muro (crollato)<br />
che sorreggeva un acquedotto. Il terminale del condotto (ancora rivestito di<br />
calce) si conclude sul versante opposto, dopo aver risalito per un tratto le<br />
ripide pendici della montagna. Il breve canale gira qui bruscamente per<br />
gettarsi in una gigantesca cisterna scavata proprio nel ventre della<br />
montagna.<br />
Il palazzo di Erode era circondato da un muro di cinta intervallato da torri<br />
che raggiungevano l’altezza di 17 metri. Il corpo centrale presenta un<br />
peristilio centrale con capitelli ionici (risollevati) attorno a cui si dispongono<br />
ordinatamente stanze di rappresentanza e triclini un tempo mosaicati e<br />
stuccati. Al centro, una grande cisterna, costituiva raccoglieva ulteriore<br />
acqua piovana. Un corridoio nord–sud separa l’area residenziale da una<br />
serie di stanze di servizio, mentre sul lato meridionale, alcune camere<br />
adiacenti dotate di pavimenti rialzati e di vasche per il bagno erano parte di<br />
un complesso termale autonomo.<br />
Durante il regno di Erode<br />
Antipa, figlio di Erode il<br />
Grande, Giovanni Battista<br />
fu arrestato e imprigionato<br />
nel palazzo di Macheronte<br />
per avere condannato il<br />
matrimonio di Erode con<br />
Erodiade che era stata<br />
moglie del fratello del<br />
principe, Filippo (Marco<br />
6,18). Durante lo<br />
svolgimento di un<br />
banchetto a cui erano stati<br />
invitati i nobili della<br />
Galilea, gli ufficiali<br />
dell’esercito e i funzionari<br />
di corte, la figlia di<br />
Erodiade, Salòme, ballò in<br />
modo incantevole<br />
ottenendo la promessa che qualunque suo desiderio sarebbe stato<br />
assecondato. Avendo delegato la scelta alla madre, quest’ultima chiese la<br />
testa di Giovanni Battista che le fu portata su un vassoio.<br />
Secondo la tradizione la testa, gettata dalle guardie giù per le ripide falde di<br />
Macheronte, fu raccolta dai fedeli e conservata gelosamente fino a quando,<br />
nel VII sec d.C. trovo la sua definitiva sede nella moschea di Damasco, ove si<br />
trova tutt’ora.<br />
Più tardi, durante le rivolta giudaica, la cittadella divenne rifugio dei<br />
rivoltosi e fu assediata dal generale Lucilio Basso – 72 d.C. – e dalla Legio X<br />
Fratensis. I ribelli furono isolati con la costruzione di un muro di<br />
sbarramento e facendo uso di catapulte. La resa loro è narrata con l’aggiunta<br />
di alcuni divertenti particolari dallo storico romano di origine ebrea<br />
Giuseppe Flavio ed ebbe come protagonista un ardimentoso soldato<br />
egiziano. Questo evento sancì il definitivo collasso delle strutture che furono<br />
abbandonate.<br />
Ancora oggi, posizionandosi sul bordo delle mura e guardando in basso<br />
verso ovest, è possibile sc<strong>org</strong>ere un piccolo colle la cui sommità è cosparsa<br />
da pietrisco portato dal fondo valle: si tratta di una base per le catapulte<br />
130
omane. A cavallo del crinale, sul fondo si distinguono anche le rovine di un<br />
piccolo forte romano. Tramite la fotografia aerea si sono, infine,<br />
riconosciute le tracce di un muro costruito dai Romani allo scopo di isolare<br />
gli assediati e ottenerne la capitolazione. Il muro girava tutt’attorno al<br />
Palazzo di Erode su un’area di circa mezzo km 2 .<br />
L’edificio di Erode delude, talora, per la scarsa conservazione delle vestigia,<br />
ma la fatica della salita viene ampiamente ricompensata dal panorama<br />
spettacolare e dalla suggestione che evocano le vicende di cui è stato teatro.<br />
Nei giorni sereni, puntando lo sguardo in direzione occidentale, non è<br />
difficile sc<strong>org</strong>ere, oltre la valle del Giordano, la città di Gerusalemme e<br />
cogliere il riflesso dorato della cupola della moschea di Omar, sulla spianata<br />
del tempio. Verso sud invece, oltre i valloni scoscesi modellati dall’erosione<br />
fluviale, si riconosce con più facilità l’ampia depressione del Mar Morto.<br />
La presa di Macheronte:<br />
Tra gli assediati v'era un giovane di grande coraggio e assai valoroso, di<br />
nome Eleazar; questi si era distinto nelle sortite, incitando i più dei<br />
compagni a uscire dalle mura e a ostacolare il lavoro dei terrapieni, infliggendo<br />
ai romani negli scontri molte e pesanti perdite. (…)<br />
Una volta, dopo che lo scontro s'era concluso e le due parti s'erano<br />
separate, nella sprezzante sicurezza che nessun nemico avrebbe allora<br />
ripreso la lotta, egli rimase fuori delle porte e si mise a chiacchierare con i<br />
compagni che stavano sulle mura senza badare a nient'altro.<br />
Approfittando dell'occasione, un soldato dell'esercito romano, un tale Rufo<br />
oriundo dall'Egitto, mentre nessuno se l'aspettava, gli piombò addosso<br />
all'improvviso, lo afferrò con tutte le armi, e mentre lo sbigottimento<br />
paralizzava quelli che stavano a guardare mura, si affrettò a trasportarlo<br />
nel campo dei romani. Avendo il comandante dato ordine di denudarlo e,<br />
portatolo nel luogo meglio visibile da quelli che stavano nella città (cioè<br />
l’insediamento civile che anticamente s<strong>org</strong>eva alla base della collina del<br />
Macheronte n.d.r.), di infliggergli la flagellazione, i giudei furono<br />
profondamente turbati dalla triste sorte del giovane e tutta la città<br />
proruppe in lamenti e in gemiti sproporzionati alla disgrazia di una<br />
persona sola. Al veder ciò, Basso ideò uno stratagemma contro i nemici,<br />
pensando di esasperare il loro dolore sì da costringerli a consegnare la<br />
fortezza in cambio della grazia al giovane.<br />
Comandò infatti di piantare una croce come se volesse immediatamente<br />
appendervi Eleazar, e a tale spettacolo quelli della fortezza furono presi da<br />
un'angoscia ancora più grande, gridando fra alti gemiti che quella era una<br />
disgrazia intollerabile. Nello stesso tempo Eleazar prese a supplicarli di<br />
non lasciare che egli subisse la morte più dolorosa e, insieme, di pensare<br />
alla loro salvezza cedendo alla forza e alla fortuna dei romani, dal<br />
momento che tutti quanti erano stati sottomessi. Quelli allora, impietositi<br />
dalle süe parole e cedendo alle preghiere che nella città molti facevano in<br />
suo favore, poiché apparteneva a una famiglia cospicua e assai numerosa,<br />
si lasciarono vincere dalla pietà - cosa contraria alla loro natura - e<br />
inviarono senza indugi alcuni a trattare la resa della fortezza.<br />
Flavio Giuseppe. La Guerra Giudaica. Libro VII,6.<br />
131
1. Tempio / 2. Muro sud e stoà reale / 11. Monte degli Ulivi / 13. Valle del Cedron / 15. Città di Davide / 17.<br />
Piscina di Sile / 18. Valle del Tyropeion / 20. Città bassa / 23. Città alta / 24. Tomba di Davide? / 27. Teatro<br />
/ 28. Agora /29. Palazzo di Erode / 36. Fortezza Antonia.<br />
132