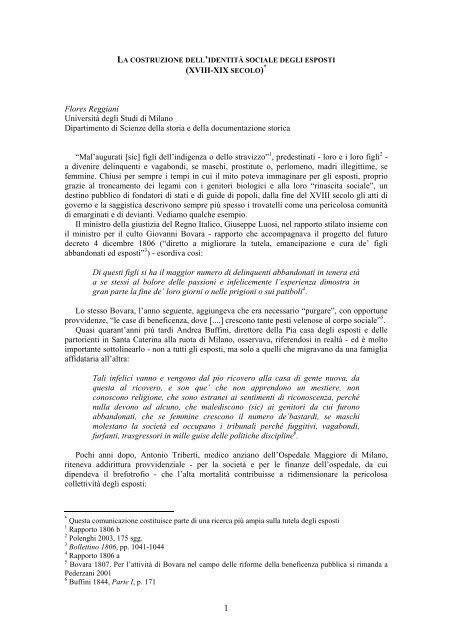You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ SOCIALE DEGLI ESPOSTI<br />
(<strong>XVIII</strong>-<strong>XIX</strong> SECOLO) *<br />
Flores Reggiani<br />
Università degli Studi di <strong>Milano</strong><br />
Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica<br />
“Mal’augurati [sic] figli dell’indigenza o dello stravizzo” 1 , predestinati - loro e i loro figli 2 -<br />
a divenire delinquenti e vagabondi, se maschi, prostitute o, perlomeno, madri illegittime, se<br />
femmine. Chiusi per sempre i tempi in cui il mito poteva immaginare per gli esposti, proprio<br />
grazie al troncamento dei legami con i genitori biologici e alla loro “rinascita sociale”, un<br />
destino pubblico di fondatori di stati e di guide di popoli, dalla fine del <strong>XVIII</strong> <strong>secolo</strong> gli atti di<br />
governo e la saggistica descrivono sempre più spesso i trovatelli come una pericolosa comunità<br />
di emarginati e di devianti. Vediamo qualche esempio.<br />
Il ministro della giustizia del Regno Italico, Giuseppe Luosi, nel rapporto stilato insieme con<br />
il ministro per il culto Giovanni Bovara - rapporto che accompagnava il progetto del futuro<br />
decreto 4 dicembre 1806 (“diretto a migliorare la tutela, emancipazione e cura de’ figli<br />
abbandonati ed esposti” 3 ) - esordiva così:<br />
Di questi figli si ha il maggior numero di delinquenti abbandonati in tenera età<br />
a se stessi al bolore delle passioni e infelicemente l’esperienza dimostra in<br />
gran parte la fine de’ loro giorni o nelle prigioni o sui patiboli 4 .<br />
Lo stesso Bovara, l’anno seguente, aggiungeva che era necessario “purgare”, con opportune<br />
provvidenze, “le case di beneficenza, dove [....] crescono tante pesti velenose al corpo sociale” 5 .<br />
Quasi quarant’anni più tardi Andrea Buffini, direttore della Pia casa degli esposti e delle<br />
partorienti in Santa Caterina alla ruota di <strong>Milano</strong>, osservava, riferendosi in realtà - ed è molto<br />
importante sottolinearlo - non a tutti gli esposti, ma solo a quelli che migravano da una famiglia<br />
affidataria all’altra:<br />
Tali infelici vanno e vengono dal pio ricovero alla casa di gente nuova, da<br />
questa al ricovero, e son que’ che non apprendono un mestiere, non<br />
conoscono religione, che sono estranei ai sentimenti di riconoscenza, perché<br />
nulla devono ad alcuno, che malediscono (sic) ai genitori da cui furono<br />
abbandonati, che se femmine crescono il numero de’bastardi, se maschi<br />
molestano la società ed occupano i tribunali perché fuggitivi, vagabondi,<br />
furfanti, trasgressori in mille guise delle politiche discipline 6 .<br />
Pochi anni dopo, Antonio Triberti, medico anziano dell’Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong>,<br />
riteneva addirittura provvidenziale - per la società e per le finanze dell’ospedale, da cui<br />
dipendeva il brefotrofio - che l’alta mortalità contribuisse a ridimensionare la pericolosa<br />
collettività degli esposti:<br />
*<br />
Questa comunicazione costituisce parte di una ricerca più ampia sulla tutela degli esposti<br />
1<br />
Rapporto 1806 b<br />
2<br />
Polenghi 2003, 175 sgg.<br />
3<br />
Bollettino 1806, pp. 1041-1044<br />
4<br />
Rapporto 1806 a<br />
5<br />
Bovara 1807. Per l’attività di Bovara nel campo delle riforme della beneficenza pubblica si rimanda a<br />
Pederzani 2001<br />
6 Buffini 1844, Parte I, p. 171<br />
1
Se poi la mortalità della prima infanzia non scemasse d’assai il numero di<br />
queste misere creature, in venti anni noi avressimo una vera colonia di<br />
trentamila proletari tutti allevati dalla pubblica carità coll’ingente dispendio<br />
di più milioni di lire austriache all’anno da popolare la maggior parte di<br />
questi le prigioni, gli ergastoli e la classe dei mendicanti e delle prostitute 7 .<br />
Trentaquattro anni più tardi, uno dei successori di Buffini, Francesco Gallarini, riflettendo<br />
sulla proposta - emersa in Francia - di contrastare il calo della natalità riaprendo le ruote,<br />
prospettava inquietanti scenari di rivolta sociale:<br />
Non arrivo a comprendere di quale vantaggio possa essere ad una nazione<br />
l’aumento della popolazione, ottenuto con l’accrescimento di una turba di<br />
spostati, d’individui senza nome abbandonati a loro stessi, i quali potrebbero<br />
ad ogni momento insorgere contro questa società, che superbamente si chiama<br />
civile, e rinfacciarle l’ignominia della propria nascita e la vita umiliante<br />
dovuta alla carità legale 8 .<br />
Anche lo scrittore Ludovico Corio - e siamo ormai nel 1885 - chiosava, nel resoconto della<br />
sua inchiesta sociale <strong>Milano</strong> in ombra:<br />
Il lôcch (“malavitoso”, in dialetto milanese), di solito, nasce in un brefotrofio,<br />
passa l'adolescenza nel riformatorio, si sviluppa e vive nel carcere e muore<br />
all'ospitale. Tra l'uno e l'altro stadio di vita passa i giorni nel postribolo, nella<br />
taverna o sulla piazza.<br />
E aggiungeva, riportandole parole di un non meglio precisato “statista”:<br />
“Purtroppo, anche in questo anno, dei condannati per delitti comuni il<br />
maggiore contingente è fornito dai trovatelli. È questa una piaga alla quale<br />
conviene che la società ponga un rimedio provvidenziale ed efficace” 9 .<br />
I dati statistici – ma nessun numero accompagnava le parole – sembrano essere stati<br />
all’origine di queste osservazioni. Se, secondo la nota e spesso citata affermazione di Vincenzo<br />
Cuoco (1809), nel Regno di Napoli bastava “aprire i registri delle [...] corti criminali per<br />
avvedersi che il massimo numero dei condannati è[ra] composto dagli esposti” 10 , il decreto 12<br />
agosto 1807 del Regno Italico (“relativo alla pubblica tutela da estendersi agli esposti ed<br />
abbandonati” 11 ) trovò la propria genesi proprio nel rilievo fatto dal viceré Eugenio de<br />
Beauharnais, secondo il quale “fra gli individui convinti di vari delitti e condannati a delle pene<br />
afflittive, il maggior numero trovasi essere stato di quelli chiamati Colombo ossia degli<br />
Esposti” 12 . Il dato, in realtà, non dava indicazioni su una presunta maggior “propensione alla<br />
criminalità” - rispetto alla popolazione con diverso cognome e di pari condizioni sociali - da<br />
parte degli esposti milanesi. Poiché da tre secoli e mezzo i figli dell’Ospedale Maggiore<br />
traevano la loro parentela dall’insegna del padre istituzionale, i Colombo - come, peraltro,<br />
osservavano gli amministratori del nosocomio e lo stesso ministro Bovara - erano frequentissimi<br />
nel “basso popolo” e poteva quindi accadere “bene spesso” che fossero “colti in delitto” anche<br />
7<br />
Triberti 1850, p. 4<br />
8<br />
Gallarini 1884, p. 5<br />
9<br />
Corio 1885, pp. 10, 16<br />
10<br />
Rapporto al Re Gioacchino Murat per l’organizzazione della pubblica istruzione, in Polenghi 2003, p.<br />
179<br />
11<br />
Bollettino 1807, pp. 418-420<br />
12<br />
Beauharnais 1807. Per una puntuale ricostruzione della legislazione napoleonica nel contesto più<br />
generale della militarizzazione dell’infanzia assistita, si rimanda a Polenghi 2003<br />
2
coloro che erano solo discendenti, magari lontanissimi, di esposti 13 . Nelle liste di coscrizione,<br />
del resto, si osservava un fenomeno analogo, come lamentava Joseph Fauchet, prefetto del<br />
dipartimento d’Arno, a proposito della presenza del cognome Degl’Innocenti, attribuito da<br />
secoli agli esposti fiorentini 14 . L’alta frequenza dei Colombo nella società lombarda, e quindi<br />
anche fra i delinquenti comuni, confermava solo che l’Ospedale aveva assistito migliaia di<br />
individui 15 e, inoltre, che molti maschi avevano avuto la possibilità di sposarsi e di trasmettere<br />
per generazioni il loro cognome ai figli. Bovara aggiungeva, fra l’altro, che i “facinorosi” forse<br />
dichiaravano di chiamarsi Colombo proprio per restare “incogniti” 16 in una folla di omonimi.<br />
Queste notazioni non impedirono che l’immagine sociale profondamente negativa degli<br />
esposti si definisse e desse avvio ad un’attività normativa intesa a tutelare e, insieme, a<br />
disciplinare, l’intera collettività dei figli e delle figlie degli ospedali. Forse più ancora delle<br />
nuove disposizioni, che sarebbero poi state riprese dai vari Stati durante gli anni della<br />
Restaurazione, sembra interessante il dibattito interno che precedette la loro emanazione. Le<br />
argomentazioni che in quell’occasione furono avanzate nell’ambito del Consiglio di Stato e del<br />
Consiglio legislativo gettano, infatti, una certa luce non solo sulla percezione che, “dall’alto”, si<br />
aveva degli esposti, ma soprattutto, sulle “coordinate concettuali” che la sorreggevano.<br />
Nella prima fase della discussione ebbe un ruolo importante anche l’Ospedale Maggiore di<br />
<strong>Milano</strong>, sia perché, nonostante lo si negasse, era indirettamente accusato di essere una vera<br />
fucina di delinquenti, sia perché i suoi amministratori furono interpellati dal ministro Bovara per<br />
avere un parere “tecnico”. Inoltre, fra i membri del Consiglio di Stato che parteciparono con più<br />
vivacità alla discussione legislativa si distinse il direttore generale dell’istruzione pubblica, il<br />
celebre Pietro Moscati. Moscati conosceva molto bene, per averne fatta esperienza diretta, la<br />
realtà del brefotrofio milanese. Il futuro “medico di Napoleone”, infatti, aveva avuto un ruolo<br />
decisivo nella densa attività di progettazione che era stata alla base della fondazione, promossa<br />
dal governo austriaco nel 1780, della nuova Pia Casa degli esposti e delle partorienti in Santa<br />
Caterina alla ruota. Ma non solo: era stato il primo direttore sanitario (1785) dell’Ospedale<br />
Maggiore, di cui la Casa costituiva “emanazione e parte”, e, come professore d’ostetricia, aveva<br />
lavorato, insegnato e abitato per anni all’interno dell’ospizio 17 .<br />
La situazione milanese, tuttavia, non era generalizzabile al Regno italico, non tanto per l’alto<br />
numero di assistiti e per l’elevata presenza di figli legittimi fra gli esposti 18 , ma soprattutto<br />
perché (e i due fatti erano strettamente connessi) l’elargitore di quella generosa e indiscriminata<br />
assistenza non era un “semplice” brefotrofio dalle finanze incerte, ma un ricco ospedale<br />
generale che coordinava una vasta rete di ricoveri, accogliendo, fra gli altri poveri, anche i<br />
trovatelli: non dimentichiamo che la Ca’ Granda era il proprietario del più cospicuo patrimonio<br />
fondiario della Lombardia 19 . I vari ospizi per gli esposti - e questo dato emerse con chiarezza nel<br />
momento in cui si vagliò la possibilità di formulare un progetto disciplinare unico - costituivano<br />
realtà profondamente disomogenee: le loro “circostanze” erano “differentissime” “e per<br />
istituzione e per località e per rendite, e per costume, condizione e stato delle popolazioni a cui<br />
inservono”. Era quindi “cosa dificilissima che ciò che conv[eniva] ad alcuni po[tesse]<br />
13 Amministratori 1807; Bovara 1807. Per inciso, osserviamo che tutt’oggi Colombo è uno dei cognomi<br />
più diffusi in Lombardia e in Italia, benché dal 1825 non fosse più stato assegnato dal brefotrofio<br />
milanese, in applicazione della Circolare governativa 29 novembre 1825 per i territori del Regno<br />
Lombardo-Veneto (testo in Buffini 1844, Parte II, pp. 65-66)<br />
14 Corsini 2007, pp. 278-279; Rollet, Escuriol 2007, pp. 30-31<br />
15 Solo dal 1659 al 1800 erano stati assistiti dall’Ospedale Maggiore più di 91.000 fra bambini e bambine.<br />
Nel 20-25% dei casi, tuttavia, si trattava di neonati accolti per il baliatico gratuito, che, quindi,<br />
conservavano il proprio cognome. Reggiani, Paradisi 1991, p. 955<br />
16 Bovara 1807<br />
17 Su Pietro Moscati: Decio 1906, pp. 144-150, 160-182; Pecchiai 1927, pp. 347-385; Castelli 1940, pp.<br />
129-169; Ferrari 1982; Remotti 1998. Sul ruolo di Moscati che, fra l’altro, designò la Pia Casa di Santa<br />
Caterina come sua erede universale, nella fase di discussione, organizzazione e progettazione, anche<br />
architettonica, del nuovo brefotrofio, si rimanda a Reggiani 2008 a, p. 61; Reggiani 2008 b, p. 107<br />
18 Hunecke 1989; Reggiani, Paradisi 1991<br />
19 Sulle differenze fra “grandi” e “piccoli” brefotrofi, Hunecke 1991, p. 63<br />
3
indifferentemente convenire anche agli altri” 20 . Si può, tuttavia, tentare di cogliere, nell’estrema<br />
varietà delle situazioni locali, un’evoluzione di lungo periodo, sulla quale è opportuno<br />
soffermarsi brevemente, perché costituiva lo sfondo sul quale si posava lo “sguardo” dei<br />
legislatori.<br />
Modelli educativi e integrazione sociale<br />
Benché si ritenga talvolta che le norme dei brefotrofi siano rimaste immutate per secoli, è<br />
possibile individuare alcune importanti cesure, che, nonostante le sfasature cronologiche,<br />
appaiono comuni alla storia di molte istituzioni destinate agli esposti. La prima cesura<br />
determinò, in tempi assai diversi secondo le realtà locali, il passaggio da un modello<br />
assistenziale strettamente basato sulle differenze di genere - prevalentemente “chiuso” per le<br />
femmine e “semichiuso” per i maschi - e orientato sull’inserimento sociale urbano, a un modello<br />
“aperto”, teoricamente non differenziato per genere, se non per la presenza della dote assegnata<br />
alle ragazze, e orientato sull’inserimento degli assistiti nel mondo contadino. La seconda cesura,<br />
anche questa disomogenea nella cronologia e sulla quale tornerò più avanti, vide la<br />
trasformazione degli ospizi per gli esposti in enti assistenziali amministrati non più da “capitoli”<br />
di notabili o prelati, ma da funzionari statali. L’Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong> rappresenta un<br />
riferimento significativo per esemplificare questa evoluzione 21 , sia per la sua fondazione remota<br />
– che raccoglieva un’ancora più remota eredità assistenziale alto-medievale - sia perché sembra<br />
aver anticipato, insieme con l’Ospedale degli Innocenti di Firenze 22 , soluzioni che in seguito<br />
furono adottate anche dagli altri ospizi.<br />
La beneficenza offerta ai bambini dal nosocomio milanese si era andata articolando, dal<br />
1456, in un complesso sistema che prevedeva ricoveri a lungo termine, accettazioni temporanee<br />
ed "elemosine" per il baliatico. Per inciso, si noti che l’idea di un’assistenza riservata ai soli figli<br />
illegittimi non compare mai né nell’atto di fondazione né nelle delibere del consiglio<br />
d’amministrazione dell’Ospedale Maggiore. Rivendicazioni in tal senso, soprattutto da parte dei<br />
direttori, cominciarono solo negli anni Trenta-Quaranta dell’Ottocento e si concretizzarono - in<br />
verità solo molto parzialmente - nella pratica quotidiana unicamente dal 1867, dopo il passaggio<br />
di gestione del brefotrofio all’ente territoriale provinciale. Al contrario, in epoca moderna,<br />
spesso veniva ricordato che le varie forme di beneficenza che implicavano un ingresso palese<br />
dei bambini (baliatico gratuito ed elemosine di baliatico) erano offerte ai genitori legittimi<br />
proprio per evitare che questi ricorressero all’esposizione in luogo pubblico o attraverso il torno.<br />
Vediamo quali erano i caratteri del modello educativo rimasto in vigore a <strong>Milano</strong> fino alla<br />
metà del Seicento. Come è noto, dopo l'ingresso, i bambini, se erano ancora lattanti, venivano<br />
affidati ad una balia interna e poi, non appena possibile, ad una balia esterna ("forese"), per<br />
essere infine consegnati, con lo svezzamento, ad una nutrice. Nella prima età moderna tali<br />
affidamenti erano però considerati solo temporanei. L'età della restituzione all'Ospedale,<br />
indicata intorno ai quattro anni nel 1508, fu successivamente innalzata a sei anni nel 1558,<br />
quando si cominciò a prevedere anche la possibilità, per le famiglie affidatarie, di trattenere i<br />
bambini come figli propri oppure come servi, in seguito alla stipula di un regolare contratto.<br />
Infine (1594) il rientro fu fissato a sette anni. Dopo la riconsegna, analogamente a quanto<br />
accadeva negli orfanotrofi, per gli assistiti e le assistite aveva inizio un periodo riservato prima<br />
all'istruzione di base, scolastica e religiosa, impartita da sacerdoti, e poi all'addestramento<br />
professionale, impartito da maestre interne per le femmine, da maestri a contratto (tessitori,<br />
calzolai, calzettai) per i maschi. Al termine, i ragazzi erano assegnati alle botteghe cittadine,<br />
mentre le ragazze, in attesa del matrimonio o della monacazione, restavano recluse, impegnate<br />
nelle attività produttive (filatura e tessitura pregiate, fabbricazione di nastri, ricamo e cucito), di<br />
cui godevano i proventi, e nei servizi ospedalieri (cucina, lavanderia, assistenza agli infermi e ai<br />
20 Rapporto 1807 a<br />
21 Per un quadro più dettagliato, nonché per la vasta bibliografia, sulla storia e sulle consuetudini<br />
dell’Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong> nel campo dell’assistenza materno-infantile, si rimanda a Reggiani<br />
2008 a<br />
22 Sandri 1997; Sandri 2001 a; Sandri, 2002 b<br />
4
più piccoli) oppure venivano mandate, ma non senza esitazioni, ripensamenti e resistenze, anche<br />
da parte delle stesse assistite - che preferivano la vita protetta e poco faticosa dell’Ospedale - a<br />
servizio in case private "honeste et da bene" di nobili e di artigiani, sposati e residenti in città 23 .<br />
Il modello di riferimento per le esposte sembra quindi essere stato, più che quello degli<br />
orfanotrofi femminili (spesso totalmente chiuso), quello dei conservatori. Si noti che le ragazze<br />
erano richieste in città non tanto - o perlomeno non solo - per lo svolgimento dei lavori<br />
domestici generici, ma soprattutto perché molto esperte nella tessitura e nei lavori di cucito. Gli<br />
affidatari, con strumento notarile, si impegnavano a dotarle al termine del servizio o, nel caso<br />
dei maschi, a lasciare loro un piccolo capitale qualora fossero morti prima della scadenza del<br />
contratto.<br />
Dalla metà del XVII <strong>secolo</strong>, in concomitanza con la decadenza delle manifatture pregiate<br />
urbane e con gravi difficoltà gestionali, l'Ospedale Maggiore cambiò radicalmente politica<br />
assistenziale, passando ad un modello, che potremmo definire “aperto”, molto meno<br />
differenziato per genere. Si deliberò, infatti, di lasciare gli esposti e le esposte sani - che non<br />
fossero stati reclamati dai loro genitori - presso le famiglie contadine non solo per i primi anni<br />
di vita, ma per tutta la durata della tutela ospedaliera. Gli affidatari avrebbero ricevuto in<br />
cambio un salario decrescente fino al settimo anno d'età e il corredo fino all'abdicazione.<br />
Questa, per coloro che non si fossero rivelati inabili, sarebbe cessata con il compimento dei<br />
quindici anni. Tuttavia le femmine nubili avrebbero mantenuto fino al 1784 - all’epoca dei più<br />
drastici interventi statalistici dell’imperatore Giuseppe II, che comportarono anche la<br />
temporanea chiusura del torno - il diritto di tornare “in qualunque età” nell'Ospedale Maggiore,<br />
ovvero, dopo il 1780, nella nuova sede della Pia casa di Santa Caterina alla ruota. La dote era<br />
pagata dall’Ospedale, non più dagli affidatari, tranne che per le Colombe che rientravano<br />
all’Ospizio e che venivano collocate a servizio.<br />
La delega dell’educazione ai contadini, con la conseguente dequalificazione professionale<br />
degli assistiti e delle assistite, da quel momento in poi destinati in maggioranza al lavoro<br />
agricolo e al servizio domestico generico, diminuì significativamente la capacità dell’Ospedale<br />
di proteggere direttamente i propri figli e figlie, anche perché il loro numero diveniva sempre<br />
più elevato, secondo un trend ascendente che, iniziato negli anni Trenta del Settecento, non<br />
avrebbe più conosciuto decisive battute d’arresto fino al 1868. Se la lontananza dall’ospizio<br />
significava minori possibilità di controlli diretti - che furono, infatti, progressivamente trasferiti<br />
dagli ispettori ospedalieri ai parroci e alle autorità locali -, gli amministratori, d’altra parte,<br />
erano convinti che la campagna, rispetto alla città, offrisse maggiori possibilità di radicamento<br />
sociale e minori rischi di traviamento, soprattutto per le ragazze. In generale, questa strategia<br />
non sembra aver dato esiti negativi, se, come si è detto, a fine Settecento i Colombo erano ormai<br />
diffusi ovunque nella società lombarda. Per quanto riguarda le femmine, osserviamo che,<br />
nell’Ottocento, cioè nel periodo in cui la svolta assistenziale adottata a <strong>Milano</strong> era divenuta<br />
quella più comunemente adottata dai brefotrofi italiani, le possibilità di sposarsi, per le esposte,<br />
sembrano essere state addirittura migliori rispetto a quelle delle altre fanciulle povere, come<br />
dimostrerebbe il fatto che la loro età al primo matrimonio, calcolata in alcune aree emiliane,<br />
fosse inferiore a quella delle altre donne 24 . I matrimoni avvenivano spesso poco dopo la<br />
cessazione della tutela dell’ospizio: costituivano fattori favorevoli sia il contatto diretto con i<br />
potenziali coniugi, anche nella famiglia stessa dell’affidatario, sia l’assenza di vincoli che<br />
potevano essere imposti dai genitori alle figlie per soddisfare le esigenze produttive della<br />
famiglia, sia la risorsa economica rappresentata dalla dote. Per <strong>Milano</strong> le elaborazioni sono<br />
ancora in corso, ma sappiamo che gli amministratori dell’Ospedale Maggiore non sembrano<br />
essere stati più ossessivamente assillati dalla necessità di “sgombrare” le centinaia di esposte<br />
nubili ricoverate fra le loro mura, benché continuasse a sussistere il grave problema, che non<br />
affronterò qui, dell’assistenza agli assistiti e alle assistite non autosufficienti.<br />
23 Lombardi, Reggiani 1990<br />
24 Angeli 1991, p. 141-142; Kertzer, Sigle 1998, pp. 208-217; Mazzoni, Manfredini 2007<br />
5
La costruzione di un’identità negativa<br />
Il cognome unico degli esposti era stato per secoli, in una società di “corpi” e di privilegi,<br />
sinonimo di un’appartenenza 25 - non raramente “a vita” - spesso molto più solida di quella che<br />
avrebbero potuto offrire le famiglie d’origine, naturalmente per coloro che sopravvivevano.<br />
Dalla fine del <strong>XVIII</strong> <strong>secolo</strong>, la filiazione istituzionale sembra essersi trasformata, come si è<br />
accennato, in un marchio di infamia, perlomeno nella percezione dei governanti. E’ tuttavia<br />
opportuno osservare che la percezione del “basso popolo”, sembra essere stata a lungo diversa,<br />
perlomeno nel Milanese, come testimoniano i tentativi di coloro che, ormai adulti, fingevano di<br />
chiamarsi Colombo per ottenere l’ammissione nell’Ospedale Maggiore o le proteste di chi,<br />
viceversa, si vedeva assegnato un cognome diverso. E’ il caso di un vedovo sessantenne, di cui,<br />
nei rapporti, si segnalavano l’estrema povertà e la buona condotta morale, che fu ricoverato<br />
nella Pia Casa d’industria in San Vincenzo, nel 1847. Nella “fede” di battesimo, il parroco, forse<br />
per semplificare le pratiche di ammissione, che avrebbero richiesto una laboriosa ricerca<br />
nell’archivio del brefotrofio, lo aveva indicato come Antonio Maria Ignoto, nato da “genitori<br />
incogniti”. L’uomo aveva mostrato “qualche dispiacere” nell’apprendere che era stato così<br />
registrato e, dopo aver osservato che era sempre stato denominato Colombo, aveva pregato la<br />
direzione - che aveva acconsentito alla sua richiesta, tranne che per gli atti d’ufficio - di poter<br />
essere ancora designato con la sua “parentela” 26 .<br />
Cognome a parte, non sembra che il passaggio per il brefotrofio sia stato considerato<br />
infamante dai Milanesi nemmeno quando, all’indomani dell’unità d’Italia, l’Ospizio degli<br />
esposti, ormai divenuto “provinciale”, tentò - come altri in Italia - di limitare l’accettazione ai<br />
soli illegittimi chiudendo la ruota (1868) ed eliminando progressivamente la pratica del baliatico<br />
gratuito. Non pochi genitori regolarmente sposati, infatti, arrivarono a denunciare falsamente i<br />
neonati allo stato civile come figli di ignoti, per poterli ricoverare. A <strong>Milano</strong> i casi furono circa<br />
tremila in trent’anni, secondo la testimonianza del direttore del Brefotrofio, Ernesto Grassi 27 ,<br />
che promosse un’inchiesta proprio allo scopo di individuare questo genere di abusi, e un<br />
fenomeno analogo è documentato anche per Firenze 28 .<br />
Ma ritorniamo alla percezione “dall’alto”. Prima di tutto osserviamo alcuni elementi di<br />
sfondo. Dall’età delle Riforme, in Lombardia, e, in generale, dall’epoca napoleonica, la gestione<br />
della beneficenza, tradizionalmente affidata alla nobiltà cittadina, venne sottoposta a radicali<br />
interventi di pubblicizzazione e razionalizzazione da parte dei nascenti Stati amministrativi 29 .<br />
Ed è la seconda cesura storica cui prima si accennava. La criminalizzazione degli esposti<br />
cominciò proprio quando i nuovi funzionari statali cominciano a denunciare la disastrosa<br />
situazione finanziaria degli “stabilimenti oppressi dal peso ormai strabocchevole di cotesti rifiuti<br />
della paterna e materna dissolutezza od inclemenza” 30 . Nel progressivo e non lineare passaggio<br />
dalla beneficenza “a pioggia” e sostanzialmente poco curante delle passività di bilancio, tipica<br />
dell’antico regime, all’assistenza controllata dallo Stato, diveniva infatti essenziale individuare<br />
chi avesse “veramente diritto” all’aiuto pubblico e definire i modi e i tempi del “dovere” che nei<br />
suoi confronti dovevano assolvere la società e gli enti caritativi 31 .<br />
Sempre in quegli anni, il nuovo codice napoleonico ridefinì le basi giuridiche dei rapporti di<br />
filiazione artificiale. Le disposizioni più generali riguardanti la tutela dei minori orfani e<br />
illegittimi trovarono una peculiare applicazione nel caso degli esposti e delle esposte con il<br />
decreto 4 dicembre 1806 che, estendendo ai figli minorenni degli ospedali l’istituto del tutore e<br />
dei consigli di famiglia, identificava questi ultimi nei consigli d’amministrazione degli ospizi e<br />
25 Da Molin 1991, p. 458-460; Bardet, Brunet 2007, p. 11<br />
26 Antonio Maria Ignoto 1847. Sulle Pie Case d’industria milanesi, Zocchi 2001<br />
27 Grassi 1898, p. 116<br />
28 Rampinelli 2000, pp. 73-98<br />
29 Woolf 1988<br />
30 Bovara 1807<br />
31 Bressan 1998, p. 59<br />
6
il primo in uno dei loro membri. Ma queste norme - che nascevano, sull’orma di quanto era<br />
accaduto in Francia, più che altro per colmare un vuoto legislativo, poiché non era possibile<br />
formare per gli esposti un consiglio di famiglia costituito da parenti - finirono per intrecciarsi<br />
con il complesso delle nuove forme di controllo che i poteri pubblici stavano estendendo sulle<br />
classi “pericolose”. Questo intreccio è ben esemplificato dal caso del decreto 12 agosto 1807<br />
(“relativo alla pubblica tutela da estendersi agli esposti ed abbandonati”), il cui iter è stato<br />
attentamente ricostruito da Simonetta Polenghi 32 , e che qui esaminerò da un diverso punto di<br />
vista. Il codice napoleonico, infatti, prolungava la minorità e sostituiva un uniforme limite di<br />
legge alla variabilità di soglie - alcune delle quali sensibilmente basse - con cui, nello ius<br />
commune e nel diritto statutario precedente, si raggiungevano gradualmente le singole capacità<br />
giuridiche 33 . Il limite fu posto a ventuno anni, eccezion fatta per il consenso alle nozze dei<br />
maschi, per il quale il termine si innalzava ai venticinque anni, salvo il successivo dovere degli<br />
“atti rispettosi” 34 . Si apriva così, fra il momento dell’abdicazione dall’ospizio e la maggiore età,<br />
una pericolosa “zona grigia”, in cui gli esposti si sarebbero trovati soli, in preda all’esuberanza<br />
dei loro istinti. Si presumeva, infatti, che i deboli legami - ritenuti esclusivamente mercenari -<br />
fra tenutari e assistiti si sarebbero inevitabilmente spezzati con la cessazione dei vantaggi<br />
economici offerti dal brefotrofio 35 .<br />
Se tutti i membri del Consiglio legislativo e del Consiglio di Stato, nelle lunghe sedute in cui<br />
venne discusso e riformulato il decreto, concordavano sulla necessità sia di un controllo sia di<br />
un sostegno preventivo per evitare i temuti e, loro giudizio, inevitabili, traviamenti di questi<br />
giovani, l’individuazione delle forme in cui controlli e sostegni si sarebbero realizzati, nonché<br />
l’identificazione delle autorità che avrebbero dovuto esercitarli, non furono questioni di facile<br />
soluzione. La tendenza centralistica, infatti, che da lì a pochi mesi avrebbe avuto il sopravvento<br />
con la riorganizzazione di tutto il sistema assistenziale nelle Congregazioni di Carità 36 , si<br />
scontrava - per il momento - con un orientamento più rispettoso non solo nei confronti delle<br />
diverse tradizioni e consuetudini assistenziali, che prevedevano, fra l’altro, età di abdicazione<br />
molto diverse, ma anche nei confronti degli amministratori degli ospizi. Bisognava evitare, per<br />
non privarsi della loro benefica collaborazione, di “urtare” queste persone che, il più delle volte,<br />
erano “distintissime per dignità e per credito e carattere” 37 . Per fare un esempio, se si fosse<br />
introdotto, come avrebbe voluto Bovara, l’obbligo di aprire all’interno dei brefotrofi “scuole di<br />
leggere, scrivere ed elementi di aritmetica” e laboratori “di sarto, calzolaio, falegname e<br />
ferraio”, stabilendo per legge anche regole uniformi per i contratti, ciò avrebbe significato,<br />
secondo alcuni consiglieri, accusare indirettamente molti ospizi di aver tenuto fino a quel<br />
momento i loro figli in “un’oziosa e scioperata nullità” 38 . Quindi, anche in considerazione<br />
dell’impossibilità di imporre una norma unica sull’obbligo di allestire (o allestire di nuovo,<br />
come nel caso di <strong>Milano</strong>) manifatture nelle Pie Case e in considerazione degli effetti “ruinosi”<br />
(Moscati) che sarebbero sortiti dall’uniformare l’età alla dimissione degli assistiti, ci si limitò a<br />
una formula generica (”saranno stabiliti dei lavori”) e se ne demandò l’applicazione a<br />
“concertazioni” caso per caso fra il ministro per il culto e i singoli ospizi 39 . Allo stesso modo si<br />
ritenne che non fosse opportuno sovrapporre esplicitamente la vigilanza della polizia alla tutela<br />
paterna che gli amministratori esercitavano direttamente sugli esposti rimasti all’interno dei<br />
brefotrofi 40 .<br />
Più in generale, si avvertiva il pericolo che gli interventi normativi incrinassero quel rapporto<br />
di fiducia reciproca fra opere pie, benefattori e maggioranza delle famiglie affidatarie che,<br />
nonostante le frodi perpetrate da alcune balie e i casi - inevitabili - di incuria e maltrattamento,<br />
costituiva ormai il fondamento dell’attività e dell’identità caritativa dei brefotrofi. Venne quindi<br />
32 Polenghi 2003<br />
33 Niccoli 1995, pp. 3-19<br />
34 Sarti 2006, p. 213-215<br />
35 Bovara 1807<br />
36 Bressan 1998, pp. 54-59<br />
37 Rapporto 1807 b<br />
38 Osservazioni 1807<br />
39 Estratto 1807 b<br />
40 Ibidem<br />
7
contestata e rinviata ad altra disposizione - che si sarebbe però rivelata ben più drastica - la<br />
proposta ministeriale che prevedeva, per il governo, la possibilità di devolvere, stabilmente e<br />
con atto pubblico, le rendite di alcuni istituti verso i brefotrofi più bisognosi dello stesso<br />
dipartimento o distretto. Un intervento simile, con ogni probabilità, avrebbe fatto diminuire i<br />
legati, che costituivano ancora una risorsa economica fondamentale per le opere pie, poiché<br />
prospettava agli occhi dei possibili testatori - desiderosi di assegnare le loro sostanze a un<br />
“particolare stabilimento” per “speciale affezione” - il “non rimoto pericolo” di una deroga alle<br />
loro volontà 41 .<br />
Anche sul versante degli “allevatori” non mancavano i timori per interventi legislativi che -<br />
pensati per proteggere gli esposti da eventuali soprusi - avrebbero potuto avere effetti addirittura<br />
controproducenti. Molto pragmaticamente e sinteticamente, Pietro Moscati esprimeva questi<br />
timori, sostenendo che quanti più vincoli e incomodi si fossero messi agli “uomini di<br />
campagna”, tanto meno questi sarebbero venuti a ritirare i figli degli ospedali 42 . Faceva così eco<br />
alla voce degli amministratori dell’Ospedale Maggiore che avevano sottolineato “l’assoluta<br />
necessità” che non venisse “alterata o tolta la tendenza dei contadini o di altre opportune<br />
persone ad assumere ed allevare esposti”: “mancato o scemato” tale “sfogo”, ne sarebbero<br />
risultati “gravissimi inconvenienti e danni” al Luogo pio e agli stessi assistiti 43 . Proprio per<br />
questo, l’anno precedente, Moscati aveva contestato, ma senza successo, la norma che affidava<br />
la tutela giuridica degli esposti collocati in campagna alla “commissione amministrativa del<br />
luogo più vicino a quello della residenza attuale del fanciullo”: in tal modo - aveva sostenuto - si<br />
obbligavano i tenutari dei Colombini, ma anche gli stessi assistiti, a compiere viaggi lunghissimi<br />
solo per un atto di stato civile 44 .<br />
Problemi ancora più delicati poneva l’attività di polizia, attività, che, alla fine, restò l’unico<br />
terreno sul quale si potevano introdurre norme uniformi e che, peraltro, finì per costituire il vero<br />
obiettivo dell’intervento legislativo, nonostante le intenzioni “preventive” e umanitarie del<br />
ministro Bovara. La polizia, dunque, avrebbe esercitato la sua “speciale vigilanza” sugli esposti<br />
dal momento in cui fossero usciti dagli ospizi fino al raggiungimento della maggiore età. Si<br />
stabilì, tuttavia, che sarebbe stata norma poco efficace “far vegliare” direttamente gli assistiti<br />
minorenni dai prefetti e dai vice-prefetti, che, “assorbiti dal gran vortice degli affari”, non<br />
avevano “né tempo né comodo di occuparsi di un oggetto di polizia meramente elementare” e,<br />
tanto meno, dalle municipalità, che, “dovendo collegialmente deliberare nelle non frequenti<br />
convocazioni, erano trattenute dalla spedizione d’altri più urgenti affari” 45 . Si assegnò, quindi,<br />
tale compito ai podestà e ai sindaci dei comuni, come avevano chiesto gli amministratori<br />
dell’Ospedale Maggiore. Ma, anche in questo caso, poiché si voleva evitare di “urtare” i<br />
contadini, si preferì non esplicitare nel testo del decreto il fatto che i podestà e sindaci avrebbero<br />
“vegliato” anche su di loro 46 .<br />
Nel complesso, con il decreto del 1807 si mise in atto un sistema articolato di controlli<br />
incrociati sui figli e sulle figlie degli ospedali, complessivamente considerati tutti come<br />
potenziali criminali. Ogni anno, sulla base delle notifiche inviate dagli amministratori degli<br />
ospizi, i sindaci e i podestà avrebbero inviato al vice-prefetto “il quadro” degli esposti che si<br />
41 Rapporto 1807; Estratto 1807 a<br />
42 Estratto 1807 b<br />
43 Amministratori 1807. In quell’anno l’Ospedale Maggiore aveva a carico 2.500 bambini e bambine sotto<br />
i quindici anni, dei quali circa 132 dai 14 ai 15 anni e 700 dagli 11 ai 13 (Ibidem)<br />
44 In occasione della discussione sul decreto 1806, Moscati, sostenuto da Giovanni Battista Costabili<br />
Containi, aveva proposto di far svolgere alle municipalità le funzioni tutorie sugli esposti almeno per gli<br />
atti di stato civile, anche se non per le questioni patrimoniali, ma il suo emendamento non era stato<br />
accolto dal Consiglio di Stato perché, a giudizio degli altri ministri, la situazione del brefotrofio di<br />
<strong>Milano</strong>, che aveva “diecimila” figli e figlie sparsi per tutta la campagna lombarda, non era generalizzabile<br />
al Regno. Il Viceré aveva inoltre fatto un’osservazione piuttosto sconcertante: “se codesti figli avessero a<br />
certa distanza i loro genitori, certamente nissuno domanderebbe che venissero dispensati dall’andare a<br />
trovarli” (Estratto 1806). Una posizione analoga a quella di Moscati è nella lettera indirizzata dagli<br />
amministratori dell’Ospedale Maggiore a Bovara (Amministratori 1806)<br />
45 Rapporto 1807<br />
46 Estratto 1807 b<br />
8
allevavano nei loro comuni “colla fedele indicazione del contegno di ciascuno dei medesimi”. I<br />
“quadri” sarebbero arrivati per via gerarchica al Ministro per il culto, ma, in caso di<br />
“rimarchevoli mancanze”, a seconda della loro gravità, era previsto l’intervento dei vice-prefetti<br />
e del direttore generale di polizia. Dall’età di quindici anni tutti gli esposti dimessi dagli ospizi o<br />
dagli allevatori avrebbero dovuto possedere un certificato di buona condotta, rilasciato,<br />
rispettivamente, dagli amministratori dei brefotrofi o dalle autorità locali: queste ultime<br />
avrebbero dovuto poi provvedere a vidimarlo ogni sei mesi, fino alla maggiore età del giovane.<br />
Coloro che fossero stati trovati sprovvisti del certificato sarebbero stati puniti con l’arresto sino<br />
a dieci giorni e, in caso di “fondato sospetto” sulla loro condotta, sarebbero stati segnalati dal<br />
giudice di pace, per mezzo del prefetto, al direttore generale di polizia. Furono tuttavia respinte,<br />
perché ritenute non eque né ammissibili, le proposte estreme, che avrebbero privato “individui<br />
già sfortunati” anche del “civile diritto d’individuale libertà” 47 . Il progetto iniziale del decreto,<br />
infatti, prevedeva il ricovero nelle Case di lavoro forzato o volontario per gli esposti che, a<br />
diciotto anni, non avessero trovato il modo di applicarsi stabilmente ad un’arte per procurarsi<br />
“onesta sussistenza”. Tuttavia - si era osservato – non solo sarebbe stato diseducativo<br />
rinchiudere fra gli oziosi questi giovani, che, magari si trovavano disoccupati non per propria<br />
colpa, quando sarebbe stato meglio avviarli ad un’attività o al servizio militare, ma, soprattutto,<br />
nessuna legge del Regno prevedeva una simile pena per gli altri diciottenni senza lavoro 48 .<br />
La ricerca d’archivio sulla reale applicazione - e sugli esiti - di queste norme e di altre simili<br />
adottate durante la Restaurazione, è ancora in corso. Ciò che preme ora sottolineare è che tali<br />
norme nascevano da alcuni presupposti condivisi, che cercherò ora di individuare.<br />
“Uccisi moralmente e civilmente”<br />
Per comprendere meglio il profilarsi dello scontro fra “famiglie assistenziali” e controllo<br />
statale va innanzi tutto ricordato che, già a partire dal secondo Settecento, gli Stati assoluti<br />
avevano cominciato a considerare gli esposti e gli orfani, che erano allevati a spese pubbliche,<br />
non più come i “figli degli Ospedali” - cioè delle comunità cittadine che se ne facevano carico<br />
attraverso la beneficenza privata - ma dello Stato 49 . Lo Stato-padre riconosceva a se stesso il<br />
dovere e il diritto di salvaguardare (e di utilizzare) un patrimonio demografico che costituiva<br />
una delle proprie ricchezze, come testimoniano i progetti di militarizzazione dell’infanzia<br />
assistita che, in quegli anni, presero corpo un po’ovunque in Europa. Esemplarmente,<br />
sintetizzava Bovara: “Resi costoro subordinati fino ad un’età più ferma potranno essere<br />
utilissimi allo Stato nelle arti ed anco nella vita militare” 50 . Il decreto del 17 gennaio 1812, che<br />
imponeva l’obbligo del reclutamento per i “figli esposti, abbandonati ed orfani poveri” maggiori<br />
di undici anni in “istato di servire”, cioè sani, e, in alternativa, il loro apprendistato gratuito fino<br />
ai venticinque anni, costituì l’epilogo, sebbene effimero, di tale processo. In realtà, in questo<br />
caso i legislatori del Regno riuscirono a rendere l’adeguamento alla normativa francese solo<br />
parzialmente operante, poiché l’applicabilità del decreto fu limitata a coloro che fossero “a<br />
carico del luogo pio”, escludendo così i giovani che, quell’età, si trovassero materialmente<br />
presso gli ospizi: come sappiamo si trattava di una minoranza, perlopiù costituita da inabili non<br />
reclutabili 51 . Diversamente le cose andarono nel Dipartimento dell’Arno, che faceva parte<br />
dell’Impero 52 .<br />
Ma c’è di più. La costruzione dell’identità sociale negativa degli esposti sembra aver preso<br />
corpo dalla fine del Settecento non solo in concomitanza con le grandi riforme degli enti<br />
assistenziali e con i progetti più radicali di disciplinamento dei poveri, ma, come hanno<br />
sottolineato Jean-Pierre Bardet e Guy Brunet, anche in coincidenza con importanti mutamenti<br />
47<br />
Osservazioni 1807<br />
48<br />
Rapporto 1807; Osservazioni 1807<br />
49<br />
Polenghi 2003. Evidenziano questo aspetto per i domini austriaci Trisciuzzi, De Rosa 1986 e<br />
Pawlowski 2002<br />
50<br />
Rapporto 1806 a<br />
51<br />
Polenghi 2003, pp. 196-199<br />
52<br />
Corsini 1991, pp. 108-114; Corsini 2007<br />
9
nella storia delle mentalità. Se, dagli anni venti dell’Ottocento, i trovatelli avrebbero suscitato<br />
l’avversione dei malthusiani, che li avrebbero considerati come l’incarnazione dei danni<br />
provocati da una prolificità popolare eccessiva, la loro condizione apparve da subito conflittuale<br />
con l’enfasi sempre più forte assegnata ai legami familiari anche nell’ambito “politico” 53 . Il<br />
processo di valorizzazione della famiglia biologica - e, in generale, dei vincoli di sangue come<br />
fondamento di ogni comunità, anche nazionale 54 - si sviluppò parallelamente a quello che vide il<br />
rapporto fra Stato e cittadino divenire sempre più diretto. Poiché l’identità individuale e<br />
familiare (garantita dal cognome paterno) costituiva un momento essenziale di tale relazione -<br />
relazione, che, a sua volta, rappresentava uno dei presupposti necessari per la creazione di uno<br />
Stato “forte” - gli esposti non potevano che essere guardati con sospetto, così come i domestici,<br />
che, infatti, erano stati espulsi dalla famiglia giuridica. Esemplarmente, il direttore generale<br />
della divisione polizia, Diego Guicciardi, durante la seduta del Consiglio di Stato, aveva<br />
auspicato che il “corpo” degli esposti - dentro e fuori degli ospizi - fosse tutto assoggettato alla<br />
vigilanza della polizia, perché se ne potesse fare un “mirato elenco, con tutti i connotati<br />
particolari”, “per far cessare l’assurdo ogni giorno rinascente di scambiare uno per un altro e<br />
non essere mai certi, né negli arresti né in ogni altra occorrente misura”, dell’identità degli<br />
innumerevoli Luigi Colombo o Bianchi 55 . Non più figli di quegli ospedali che sembravano non<br />
offrire più una tutela sufficiente, gli esposti, ormai “figli della fortuna” 56 , dopo essere diventati<br />
temporaneamente “figli dello Stato”, si apprestavano a essere considerati, nel giro di qualche<br />
decennio, “figli di nessuno”.<br />
Ma non si trattava solo di relazioni politico-amministrative. Sappiamo che negli stessi anni, i<br />
medici, e non solo loro, cominciarono a demonizzare un’altra pratica, anche questa strettamente<br />
connessa alla condizione degli esposti: quella del baliatico 57 . L’osservazione di Ottavia<br />
Niccoli 58 , cioè che studiare il mondo dell’infanzia in età moderna partendo dalle relazioni<br />
familiari è anacronistico, perché significa applicare moduli affettivi e relazionali che sono in<br />
gran parte ottocenteschi e postrousseauiani, può trovare quindi un corollario. A coloro che, fra<br />
Settecento e Ottocento, cominciavano a leggere il mondo dell’infanzia secondo quei nuovi<br />
moduli “affettivi” gli individui che ne apparivano esclusi fin dalla nascita non potevano che<br />
rappresentare un anacronismo. Inutilmente Moscati, basandosi sull’esperienza che “sola poteva<br />
somministrare una norma”, poteva sostenere che, in mezzo a migliaia di esposti consegnati fuori<br />
degli ospizi, “pochissimi” erano stati i casi di abusi 59 . La convinzione generale era che, poiché i<br />
contadini allevavano i figli degli ospedali solo per interesse, dovessero trattarli con durezza. Noi<br />
stessi siamo forse inclini a sottoscrivere il giudizio di Bovara secondo il quale i trovatelli erano<br />
destinati al traviamento, proprio perché non conoscevano l’amore di una “vera” famiglia 60 , e,<br />
viceversa, a condividere l’opinione del consigliere Giovanni Maestri, secondo il quale “un padre<br />
ha sempre sentimenti d’affezione coi quali rattempera la severità della correzione” 61 . Riducendo<br />
al puro interesse materiale - che pure, ovviamente, esisteva e che poteva anche essere<br />
inizialmente prioritario - la motivazione degli “allevatori”, si dimenticava, fra l’altro, che la cura<br />
di un figlio dell’Ospedale - Ospedale non casualmente chiamato dai Milanesi Ca’ Granda - si<br />
inseriva in una complessa rete, anche simbolica, di scambi assistenziali. Fra i Milanesi, infatti,<br />
era radicata la convinzione popolare che la beneficenza fatta agli esposti da parte dei poveri<br />
“compensasse” quella delle persone facoltose che, sostenendo economicamente il nosocomio,<br />
offrivano un ricovero ai loro infermi: l’omaggio funebre reso a un parente defunto<br />
nell’Ospedale spesso coincideva, per i contadini che venivano a <strong>Milano</strong>, con il ritiro di un<br />
trovatello 62 . Eppure - si asseriva - senza legami di sangue, fra adulti e bambini non vi potevano<br />
53<br />
Bardet, Brunet 2007, pp. 13-14, 9-10<br />
54<br />
Banti 2006, pp. 61-72<br />
55<br />
Estratto 1807<br />
56<br />
Rapporto 1807<br />
57<br />
Pasi 1987, pp. 119-120<br />
58<br />
Niccoli 1995, p. X<br />
59<br />
Estratto 1807 b<br />
60<br />
Bovara 1807<br />
61<br />
Estratto 1807 b<br />
62<br />
Giulini 1885<br />
10
essere né affetto, né cura, né sottomissione filiale, ma solo “malcontentezza ed avvilimento”,<br />
solitudine, indipendenza e, quindi, delinquenza e disordine sociale 63 .<br />
Sappiamo, tuttavia, che, fino a tempi non lontanissimi, il lavoro fin dalle età più tenere e<br />
l’estraniamento precoce dalla famiglia erano realtà consuete per tutti i bambini indigenti e, fino<br />
a tempi meno recenti, anche per i figli degli artigiani, dei mercanti e dei nobili 64 . Sappiamo,<br />
soprattutto, che, in ogni tempo, il legame biologico non è condizione né necessaria né<br />
sufficiente perché si stabilisca un legame affettivo fra un adulto e un bambino. Ancora alle<br />
soglie del XX <strong>secolo</strong>, i fanciulli e le fanciulle di alcune regioni italiane venivano venduti dai<br />
genitori biologici a suonatori e a venditori ambulanti oppure, dopo la stipula di un contratto di<br />
apprendistato, erano ceduti ad intermediari che li collocavano presso le manifatture estere, in<br />
particolare nelle vetrerie francesi e belghe 65 . Nei primi vent’anni del Novecento, nel 70% dei<br />
casi, le piccole prostitute accolte nel milanese Asilo Mariuccia erano state vittime di stupro o<br />
incesto oppure provenivano da famiglie in cui c’erano stati episodi di incesto 66 . Le statistiche<br />
odierne, d’altra parte, ci dicono che violenze fisiche e abusi sessuali verso i minori avvengono<br />
prevalentemente per opera di parenti. Infine non dimentichiamo che i veri abbandonati (che il<br />
già citato decreto 17 gennaio 1812 avrebbe con precisione distinto dagli esposti) erano i<br />
“derelitti”: i figli legittimi di quei genitori che - invece di affidare consapevolmente i loro nati<br />
ad un’istituzione – si dileguavano più o meno volontariamente. Lasciati a mendicare per le<br />
strade, questi bambini venivano raccolti dalle forze dell’ordine e poi ricoverati fra i vagabondi.<br />
D’altra parte, mentre prestiamo - giustamente - fede alle denunce sui maltrattamenti subiti<br />
dai trovatelli da parte dei loro “allevatori”, siamo forse inclini a dubitare della buona fede di<br />
quegli stessi parroci e di quegli stessi amministratori quando, nella maggioranza dei casi,<br />
dichiaravano “soddisfacenti” - ovviamente nei limiti di contesti spesso di assoluta miseria - o<br />
addirittura buone, soprattutto dal punto di vista affettivo, le loro condizioni di vita 67 . In realtà,<br />
fino alla metà del <strong>XIX</strong> <strong>secolo</strong> - quando cominciarono le indagini sistematiche, prima per opera<br />
dei direttori dei brefotrofi e poi degli “ispettori viaggianti” - abbiamo solo poche testimonianze<br />
controverse sulla vita degli esposti presso le famiglie dei tenutari. Se non mancavano le<br />
prevaricazioni e l’incuria 68 , non mancavano nemmeno le affiliazioni, che comportavano la<br />
rinuncia al salario e il diritto all’eredità su una parte di beni dell’affidatario, come avveniva ad<br />
Agnosine, in provincia di Brescia 69 . Non mancavano neppure, infine, i casi di profonda e<br />
duratura affezione reciproca, come documentava lo stesso Buffini 70 . Il giurista Carlo Bellani,<br />
con molto realismo e con l’esperienza che gli proveniva sia dalla frequentazione dei tribunali<br />
penali sia dalla pluriennale attività direttiva dell’Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong>, riassumeva così<br />
la situazione, commentando nel 1825 la vicenda di un’assistita sedotta dal suo tenutario: “Nel<br />
grande numero di figlie che sono alla campagna qualch’una [sic] riesce male, come avviene<br />
anche di varie legitime” 71 .<br />
Per concludere sembra di poter affermare che lo status dei figli e delle figlie dell’Ospedale,<br />
qualunque fosse la realtà delle loro esistenze - in genere non molto diversa da quella, sempre<br />
molto dura, degli altri poveri - o la percezione dei loro pari, fosse inevitabilmente destinato, con<br />
la fine dell’Ancien Régime, ad entrare “di per sé” in collisione con la mentalità dei nuovi ceti<br />
dirigenti e, come tale, a essere rifiutato. La sempre più numerosa “non-famiglia” degli esposti,<br />
63 Bovara 1807<br />
64 Niccoli 1995. Interessanti elementi sullo scambio dei bambini fra le famiglie in epoca moderna sono<br />
emersi nel convegno Il posto dei bambini. Infanzia e mondo degli adulti tra Medioevo ed età<br />
contemporanea, Roma 5-6 ottobre 2009, in particolare negli interventi di S. Bellavitis, Lavoro,<br />
apprendistato e circolazione dei bambini in età moderna, e S. Feci, Crescere orfani. Famiglie e tutele<br />
dei minori a Roma in età moderna<br />
65 Zucchi 1999; Di Bello, Nuti 2001<br />
66 Buttafuoco 1988, pp. 108-110. Si vedano anche le testimonianze raccolte nelle Langhe da Revelli 1977,<br />
in particolare, vol. II, p. 203 e Cambi, Ulivieri 1988, p. 46<br />
67 Polenghi 2003, pp. 182-185<br />
68 Di Bello 1989, pp. 56-105; Sandri 2001 a; Sandri 2001 b; Sandri 2002<br />
69 Onger 1985, p. 59<br />
70 Buffini 1844, Parte II, pp. 160-162<br />
71 Bellani 1825<br />
11
costituita promiscuamente da figli legittimi e da “figli della colpa”, appariva come un’anomalia<br />
nel corpo sociale. Qualunque fosse la loro filiazione e prima ancora che i brefotrofi venissero<br />
“doverosamente” riservati, almeno ufficialmente, ai bambini nati fuori del matrimonio, i figli<br />
degli ospedali cominciarono ad essere percepiti, tutti quanti, come “illegittimi”. “Uccisi<br />
moralmente e civilmente” 72 , “marchiati da una specie d’ignominia per l’ignota presunta [loro]<br />
origine” 73 , apparivano pericolosamente estranei sia alla nuova legalità sia al nuovo ideale di<br />
famiglia.<br />
Fonti d’archivio<br />
Abbreviazioni<br />
AIPMi = Archivi istituti provinciali assistenza infanzia <strong>Milano</strong>.<br />
Provincia di <strong>Milano</strong>. Direzione centrale cultura e affari sociali<br />
ALPE = Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri (Azienda di Servizi<br />
alla persona “Golgi-Redaelli”), <strong>Milano</strong><br />
AOM = Archivio Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong><br />
ASMi = Archivio di Stato di <strong>Milano</strong><br />
b. = busta<br />
p.m. = parte moderna<br />
Amministratori 1807<br />
Amministratori dell’Ospedale civico e uniti di <strong>Milano</strong> al Ministro per il culto, 12 marzo 1807, in ASMi,<br />
Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Antonio Maria Ignoto 1847<br />
Fascicolo personale di Antonio Maria Ignoto, in ALPE, Archivio della Direzione. Case d’industria e di<br />
ricovero. Ospitalità. Ricoverati a carico di corpi, b. 20<br />
Bellani 1825<br />
C. Bellani a E. De Micheli, parroco di Ozzero, 14 ottobre 1825, in AIPMi, Brefotrofio. Bambini. Carte<br />
sciolte, b. 1, 727/1810<br />
Bovara 1807<br />
G. Bovara al ministro dell’interno, 21 marzo 1807, in ASMi, Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Beauharnais 1807<br />
Eugenio de Beauharnais ai ministri dell’interno e del culto, 2 marzo 1807, in ASMi, Luoghi pii, p.m., b.<br />
98<br />
Estratto 1806<br />
“Estratto del processo verbale del Consiglio di Stato della seduta del giorno 20 novembre 1806”, in<br />
ASMi, Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Estratto 1807 a<br />
“Estratto del processo verbale del Consiglio di Stato della seduta del giorno 3 luglio 1807”, in ASMi,<br />
Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Estratto 1807 b<br />
“Estratto del processo verbale del Consiglio di Stato della seduta del giorno 7 agosto 1807”, in ASMi,<br />
Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
72 Portigliotti 1913, p. 867<br />
73 Bovara 1807<br />
12
Giulini 1885<br />
G. Giulini, “Relazione e proposta sul riordinamento del Brefotrofio provinciale e istituti provinciali<br />
annessi”, in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Santa Caterina alla ruota e Senavra, b. 28, a<br />
stampa<br />
Osservazioni 1807<br />
“Osservazioni sul progetto di decreto relativo agli esposti” da parte del Consiglio legislativo, 4 agosto<br />
1807, in ASMi, Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Rapporto 1806 a<br />
“Rapporto del ministro della giustizia e del ministro per il culto”, 17 giugno 1806, in ASMi, Luoghi pii,<br />
p.m., b. 98<br />
Rapporto 1806 b<br />
“Rapporto del Consiglio legislativo”, 5 luglio 1806, in ASMi, Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Rapporto 1807<br />
“Rapporto del Consiglio legislativo”, 1 luglio 1807, in ASMi, Luoghi pii, p.m., b. 98<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Angeli 1991<br />
Caratteristiche, mortalità e destino degli esposti dell’Ospedale di Imola nei sec. <strong>XVIII</strong>-<strong>XIX</strong>, in Enfance<br />
abandonnée et société en Europe, XIVe–XXe siècle, Rome, Ecole Française de Rome, 1991, pp. 123-149<br />
Banti 2006<br />
A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino,<br />
Einaudi, 2006 (1ª ediz. 2000)<br />
Bardet, Brunet 2007<br />
J.P. Bardet, G. Brunet, Nom, identité, destin des enfats trouvés dans les pays latins. Une enquête à<br />
poursuivre, in Noms et destins des Sans Famille, a cura di J.P. Bardet, G.Brunet, Paris, PUP, 2007, pp. 9-<br />
22<br />
Bollettino 1806<br />
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte III. Dal 1° settembre al 31 dicembre 1806, <strong>Milano</strong>, Reale<br />
stamperia, [1806]<br />
Bollettino 1807<br />
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte seconda..Dal 1° luglio al 30 settembre 1807, <strong>Milano</strong>,<br />
Reale stamperia, [1807]<br />
Bressan 1998<br />
E. Bressan, Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e contemporanea. Storia e problemi,<br />
<strong>Milano</strong>, NED, 1998<br />
Buffini 1844<br />
A. Buffini, Ragionamenti storico economico-statistici e morali intorno all’Ospizio dei trovatelli in<br />
<strong>Milano</strong>, <strong>Milano</strong>, Pietro Agnelli, 1844<br />
Buttafuoco 1988<br />
A. Buttafuoco, Le Mariuccine. Storia di un’istituzione laica, l’Asilo Mariuccia, <strong>Milano</strong>, Franco Angeli,<br />
1988<br />
Cambi, Ulivieri 1988<br />
F. Cambi, S. Ulivieri, Storia dell’infanzia nell’Italia liberale, Firenze, La Nuova Italia, 1988<br />
13
Castelli 1940<br />
G. Castelli, Figure dell’ottocento alla Ca’ Granda. Amministratori, medici, farmacisti, <strong>Milano</strong>, Famiglia<br />
Meneghina, 1940<br />
Corio 1885<br />
L. Corio, <strong>Milano</strong> in ombra. Abissi plebei, <strong>Milano</strong>, Stabilimento G. Civelli, 1885, riedizione a cura di E.<br />
Cantarella, Per una lettura degli “Abissi plebei” di Lodovico Corio, in “Rivista Milanese di Economia -<br />
Serie quaderni”, n. 3, <strong>Milano</strong>, CARIPLO, 1982<br />
Corsini 1991<br />
C. Corsini, “Era piovuto dal cielo e la terra l’aveva raccolto”: il destino del trovatello, in Enfance<br />
abandonnée et société en Europe, XIVe–XXe siècle, Rome, Ecole Française de Rome, 1991, pp. 81-119<br />
Corsini 2007<br />
C.A. Corsini, Sunt nomina consequentia rerum? in Noms et destins des Sans Famille, a cura di J.P.<br />
Bardet, G. Brunet, Paris, PUP, 2007, pp. 273-284<br />
Da Molin 1991<br />
G. Da Molin, Modalità dell’abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel Seicento, in Enfance<br />
abandonnée et societé en Europe, XIVe–XXe siècle, Rome, Ecole Française de Rome, 1991, pp. 457-502<br />
Decio 1906<br />
C. Decio, Notizie storiche sulla ospitalità e didattica ostetrica milanese, Pavia, Fusi, 1906<br />
Di Bello 1989<br />
G. Di Bello, Senza nome né famiglia. I bambini abbandonati nell’ottocento, Pian di San Bartolo, Luciano<br />
Manzuoli Editore, 1989<br />
Di Bello, Nuti 2001<br />
G. Di Bello, V. Nuti, Soli per il mondo. Bambini e bambine emigranti tra Otto e Novecento, <strong>Milano</strong>,<br />
Edizioni Unicopli, 2001<br />
Ferrari 1982<br />
G.A. Ferrari, Moscati e i potenti, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa,<br />
a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, vol. II, pp. 925-955<br />
Gallarini 1884<br />
F. Gallarini, Relazione generale per l’anno 1884, <strong>Milano</strong>, G. Civelli, 1885<br />
Kertzer, Sigle 1998<br />
D.I. Kertzer, W. Sigle, The marriage of female foundligs in nineteenth-century Italy, in “Continuity and<br />
Change”, n. 13 (2), 1998, pp. 201-220<br />
Hunecke 1989<br />
V. Hunecke, I trovatelli di <strong>Milano</strong>. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al <strong>XIX</strong> <strong>secolo</strong>,<br />
Bologna, Il Mulino, 1989<br />
Hunecke 1991<br />
V. Hunecke, Intensità e fluttuazioni degli abbandoi dal XV al <strong>XIX</strong> <strong>secolo</strong>, in Enfance abandonée et<br />
societé en Europe, XIVe–Xxe siècle, Rome, Ecole Française de Rome, 1991, pp. 27-72<br />
Lombardi, Reggiani 1990<br />
D. Lombardi, F. Reggiani, Da assistita a serva. Circuiti di reclutamento delle serve attraverso le<br />
istituzioni assistenziali (Firenze-<strong>Milano</strong>, XVII-<strong>XVIII</strong> secc.), in Istituto internazionale di storia economica<br />
“F. Datini”, La donna nell’economia. Secc. XIII-<strong>XVIII</strong>, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier,<br />
1990, pp. 301-319<br />
Mazzoni, Manfredini 2007<br />
S. Mazzoni, M. Manfredini, Les enfants abandonnés à l’Hôpital de Parme (Italie) dans la commune de<br />
Pellegrino Parmense, in “Annales de démographie historique”, n. 2, 2007, pp. 83-97<br />
14
Niccoli 1995<br />
O. Niccoli, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma-<br />
Bari, Laterza , 1995<br />
Onger 1985<br />
S. Onger, L’infanzia negata. Storia dell’assistenza agli abbandonati e indigenti a Brescia nell’Ottocento,<br />
Brescia, AIED, 1985<br />
Pasi 1997<br />
A. Pasi, Infanzia e medicina: dalle “rozze femmine” al “medico dei bambini”, in Avvocati, medici,<br />
ingegneri: Alle origini delle professioni moderne (secoli XVI-<strong>XIX</strong>), a cura di M.L. Betri e A. Pastore,<br />
Bologna, CLUEB, 1997, 117-127<br />
Pawlowsky 2001<br />
V. Pawlowsky, Mutter ledig -Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784-1910, Innsbruck,<br />
StudienVerlag, 2001<br />
Pecchiai 1927<br />
P. Pecchiai, Della vita del dottor Pietro Moscati (1739-1824), in Id., L’Ospedale Maggiore di <strong>Milano</strong><br />
nella storia e nell’arte, <strong>Milano</strong>, Pizzi e Pizio, 1927, pp. 347-385<br />
Pederzani 2001<br />
Giovanni Bovara tra età asburgica ed età napoleonica: riforma e “pubblica tutela” degli istituti di<br />
assistenza e beneficenza, in Cultura, religione e trasformazione sociale. <strong>Milano</strong> e la Lombardia dalle<br />
riforme all’unità, a cura di M. Bona Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara, <strong>Milano</strong>, Franvo<br />
Angeli, 2001, pp. 217-231<br />
Polenghi 2003<br />
S. Polenghi, Fanciulli soldati. La militarizzazione dell’infanzia abbandonata nell’Europa moderna,<br />
Roma, Carocci, 2003<br />
Portigliotti 1913<br />
G. Portigliotti, Un’istituzione che scompare: la ruota degli esposti, in “La Lettura”, sett. 1913, pp. 866-<br />
868<br />
Rampinelli 2000<br />
F. Rampinelli, Storie di abbandoni. I processi per esposizione d’infante a Firenze dal 1870 al 1900,<br />
Firenze, Le Lettere, 2000<br />
Reggiani 2008 a<br />
F. Reggiani, La famiglia dell’Ospedale nei secoli, in “Si consegna questo figlio”. L’assistenza<br />
all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di <strong>Milano</strong>, a cura di M. Canella, L. Dodi, F.<br />
Reggiani , <strong>Milano</strong>, Skira, 2008, pp. 35-103<br />
Reggiani 2008 b<br />
F. Reggiani, Il vecchio e il nuovo brefotrofio. Un monastero sul Naviglio, in “Si consegna questo figlio”.<br />
L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di <strong>Milano</strong>, a cura di M.<br />
Canella, L. Dodi, F. Reggiani , <strong>Milano</strong>, Skira, 2008, pp. 105-114<br />
Reggiani, Paradisi 1991<br />
F. Reggiani, E. Paradisi, L’esposizione infantile a <strong>Milano</strong> fra Seicento e Settecento: il ruolo<br />
dell’istituzione, in Enfance abandonnée et société en Europe, XIV-XX siècle, Roma, École Française de<br />
Rome, 1991, pp. 937-979<br />
Remotti 1998<br />
G. Remotti, L’assistenza materno-infantile, a <strong>Milano</strong> attraverso i secoli. Pietro Moscati, Parte VI, in<br />
“Annali di ostetricia ginecologia medicina perinatale”, n. 1, 1998, pp. 13-98<br />
15
Revelli 1977<br />
N. Revelli, Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina, Torino, Einaudi, 1977<br />
Rollet, Escuriol 2007<br />
C. Rollet, C. Escuriol, Le nom des enfants abandonnés aux <strong>XIX</strong> et XX siècles: une appellation<br />
d’origine contrôlée, in in Noms et destins des Sans Famille, a cura di J.P. Bardet, G.Brunet, Paris, PUP,<br />
2007, pp. 25-48<br />
Sandri 1997<br />
L. Sandri, Dinamiche politico-istituzionali e sorte degli esposti nell’Ospedale degli Innocenti di Firenze,<br />
in Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda. L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-<strong>XIX</strong>),<br />
a cura di C. Grandi, Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi e ricerche / Canova, 1997, pp. 64-73<br />
Sandri 2001 a<br />
L. Sandri , Tra violenza e “buona creanza”: trovatelli a Firenze e in Toscana (sec. XVI-<strong>XVIII</strong>) in Archivi<br />
d’infanzia. Per una storiografia della prima età, a cura di E. Becchi, A. Semeraro, Firenze, La Nuova<br />
Italia, 2001, pp. 163-183<br />
Sandri 2001 b<br />
L. Sandri, Percorsi di vita ed educazione dei trovatelli a Firenze e in Toscana dal XVI al <strong>XVIII</strong> <strong>secolo</strong>, in<br />
Itinerari nella storia dell’infanzia. Bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi, a cura di C.<br />
Covato e S. Ulivieri, <strong>Milano</strong>, Unicopli, 2001, pp. 79-123<br />
Sandri 2002<br />
L. Sandri 2002, Da assistite a traviate. Le “Nocentine” tra XVI e <strong>XVIII</strong> <strong>secolo</strong>, in Forme di assistenza in<br />
Italia dal XV al XX <strong>secolo</strong>, a cura di G. Da Molin, Udine, Forum – Soc. Ed. Univ. Udinese, 23-39.<br />
Sarti 2006<br />
R. Sarti, Nubili e celibi tra scelta e costrizione. I percorsi di Clio (Europa occidentale, secoli VI-XX), in<br />
Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli VI-XX), a cura di M. Lanzinger, R. Sarti, Udine, Forum,<br />
2006, pp. 145-318<br />
Triberti 1850<br />
Della necessità di limitare ai soli figli illegittimi l’esposizione all’Ospizio di S. Caterina e di chiudere il<br />
demoralizzante torno, memoria del dottore Antonio Triberti, <strong>Milano</strong>, Angelo Bonfanti, 1850<br />
Trisciuzzi De Rosa 1986<br />
L. Trisciuzzi, D. De Rosa, I bambini di sua Maestà. Esposti e orfani nella Trieste del ‘700, <strong>Milano</strong>,<br />
Franco Angeli, 1986<br />
Woolf 1988<br />
S.J. Woolf, Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988<br />
Zocchi 2001<br />
P. Zocchi, Le Pie case d’industria e di ricovero (1784-1902), in Il tesoro dei poveri. Il patrimonio<br />
artistico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ECA) di <strong>Milano</strong>, a cura di M. G.<br />
Bascapè, P. M. Galimberti, S. Rebora, <strong>Milano</strong>, Silvana Editoriale, 2001, pp. 334-337<br />
Zucchi 1999<br />
J.E. Zucchi, I piccoli schiavi dell’arpa. Storie di bambini italiani a Parigi, Londra e New York<br />
nell'Ottocento, Genova, Marietti, 1999 (ediz. orig: 1992, Montreal and Kingston, Mc Gill - Queen's<br />
University Press)<br />
16