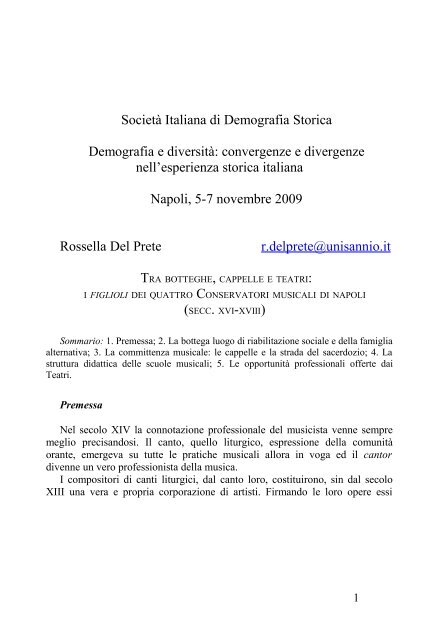i “figlioli” dei quattro Conservatori musicali di Napoli - Sides
i “figlioli” dei quattro Conservatori musicali di Napoli - Sides
i “figlioli” dei quattro Conservatori musicali di Napoli - Sides
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Società Italiana <strong>di</strong> Demografia Storica<br />
Demografia e <strong>di</strong>versità: convergenze e <strong>di</strong>vergenze<br />
nell’esperienza storica italiana<br />
<strong>Napoli</strong>, 5-7 novembre 2009<br />
Rossella Del Prete r.delprete@unisannio.it<br />
TRA BOTTEGHE, CAPPELLE E TEATRI:<br />
I FIGLIOLI DEI QUATTRO CONSERVATORI MUSICALI DI NAPOLI<br />
(SECC. XVI-XVIII)<br />
Sommario: 1. Premessa; 2. La bottega luogo <strong>di</strong> riabilitazione sociale e della famiglia<br />
alternativa; 3. La committenza musicale: le cappelle e la strada del sacerdozio; 4. La<br />
struttura <strong>di</strong>dattica delle scuole <strong>musicali</strong>; 5. Le opportunità professionali offerte dai<br />
Teatri.<br />
Premessa<br />
Nel secolo XIV la connotazione professionale del musicista venne sempre<br />
meglio precisandosi. Il canto, quello liturgico, espressione della comunità<br />
orante, emergeva su tutte le pratiche <strong>musicali</strong> allora in voga ed il cantor<br />
<strong>di</strong>venne un vero professionista della musica.<br />
I compositori <strong>di</strong> canti liturgici, dal canto loro, costituirono, sin dal secolo<br />
XIII una vera e propria corporazione <strong>di</strong> artisti. Firmando le loro opere essi<br />
1
iba<strong>di</strong>vano il valore della propria in<strong>di</strong>vidualità, prodotto <strong>di</strong> scienza e creatività,<br />
ed il senso del loro lavoro. Divenne necessario però tutelare la professionalità e<br />
la trasmissione <strong>di</strong> quell’«arte» e così, a partire dal secolo XVI, si <strong>di</strong>ffusero i<br />
centri <strong>di</strong> formazione musicale e <strong>di</strong> aggregazione per i cori destinati al servizio<br />
religioso. Essi furono favoriti dalle nuove confessioni riformate, in particolare<br />
quella luterana, che sollecitarono l’apertura <strong>di</strong> scuole dove agli stu<strong>di</strong> generali si<br />
accompagnassero lo stu<strong>di</strong>o della musica e la pratica del canto 1 .<br />
Crebbe l’interesse per la musica sacra, ma cominciò a prendere forma anche<br />
quello per la musica profana. Nel secolo XV, <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una cappella musicale<br />
<strong>di</strong>ventò un segno <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione, uno status symbol, e fu oggetto <strong>di</strong> ambizione <strong>di</strong><br />
corti e cattedrali in cui regnanti e vescovi si contendevano al loro servizio<br />
cantori esperti delle nuove tecniche compositive. Presso le corti nobiliari, in<br />
particolare, esplose una vera e propria moda delle cappelle <strong>musicali</strong>, che,<br />
<strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> imponenti organici, giovavano allo splendore del principe e alla<br />
concentrazione e assolutezza del suo potere 2 .<br />
Stu<strong>di</strong>are, conoscere, praticare la musica per <strong>di</strong>letto e per ragioni <strong>di</strong> alta<br />
ricreazione, piuttosto che con interessi professionali, tornò ad essere<br />
considerato un aspetto non secondario del processo formativo dell’uomo. Si<br />
sviluppò così l’educazione musicale destinata ai rampolli <strong>dei</strong> ceti emergenti, ma<br />
anche l’istruzione musicale che, nelle cappelle <strong>musicali</strong>, alimentava la<br />
formazione <strong>dei</strong> professionisti, compositori ed esecutori.<br />
Alla fine del secolo XVI, una nuova generazione <strong>di</strong> compositori <strong>di</strong> musiche<br />
madrigalistiche (Dentice, Gesualdo, Montella, Macque, Nenna e tanti altri<br />
nobili) 3 determinò un originale processo <strong>di</strong> <strong>musicali</strong>zzazione della nobiltà<br />
napoletana. Il madrigale definì una pratica musicale riservata ed elitaria che<br />
1 Il canto <strong>di</strong>dattico evangelico-umanista si sforzò <strong>di</strong> educare musicalmente fin da piccoli i ragazzi<br />
attraverso una letteratura pratica appositamente creata.<br />
2 S. Di Giacomo, I Maestri e i Musici del Tesoro <strong>di</strong> S. Gennaro, «<strong>Napoli</strong> Nobilissima», n.s. 1 (920);<br />
U. Prota-Giurleo, G.M. Trabaci e gli organisti della Real Cappella <strong>di</strong> Palazzo <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>,<br />
«L’Organo», I (1960), pp. 185-196; G. Ceci, Maestri organari a <strong>Napoli</strong> dal XV al XVIII secolo,<br />
Ricciar<strong>di</strong> e<strong>di</strong>tore, <strong>Napoli</strong>, 1931.<br />
2
dapprima sembrò essere esclusiva prerogativa della nobiltà partenopea <strong>di</strong> alto<br />
rango e <strong>di</strong> poche altre famiglie particolarmente interessate alla musica e,<br />
soltanto all’inizio del secolo successivo, irruppe con decisione nella vita<br />
musicale della città, <strong>di</strong>ffondendosi a più livelli. L’uso propagan<strong>di</strong>stico e<br />
rappresentativo della musica, contribuì, attraverso il mecenatismo <strong>di</strong> alcune<br />
famiglie nobiliari, al consolidamento professionale del compositore la cui<br />
attività, da otium intellettuale <strong>di</strong> letterati e religiosi d’alto rango, <strong>di</strong>venne lavoro<br />
retribuito presso le maggiori istituzioni ecclesiastiche e le cappelle delle corti 4 .<br />
Rango sociale e nucleo familiare <strong>di</strong> appartenenza furono fattori <strong>di</strong> notevole<br />
importanza nella determinazione <strong>di</strong> molti aspetti della vita musicale, così come<br />
la scelta <strong>di</strong> un patrocinatore al quale il compositore de<strong>di</strong>cava le proprie opere 5 .<br />
Sempre a <strong>Napoli</strong>, i musicisti non nobili si <strong>di</strong>stinguevano in sonatori e<br />
musici, due categorie che inquadravano musicisti <strong>di</strong> professione assai <strong>di</strong>versi tra<br />
<strong>di</strong> loro per cultura e stili <strong>di</strong> vita. I primi erano semplici esecutori, spesso<br />
strumentisti; i secon<strong>di</strong> potevano essere tanto compositori quanto esecutori. La<br />
vera <strong>di</strong>fferenza era nel rango sociale: i musici erano per lo più compositori non<br />
nobili appartenenti al popolo, i sonatori appartenevano alla plebe e si<br />
3 Le vicende del madrigale a <strong>Napoli</strong> tra ‘500 e ‘600 si <strong>di</strong>panano attraverso le due componenti<br />
costitutive <strong>dei</strong> questo particolare genere musicale: poesia e musica. <strong>Napoli</strong>, <strong>di</strong>venne un centro <strong>di</strong><br />
produzione madrigalistica geograficamente e culturalmente in<strong>di</strong>viduato, caratterizzato da una vita<br />
musicale particolarmente vivace (A. Pompilio e A. Vassalli, Il madrigale a <strong>Napoli</strong> nel Cinque-<br />
Seicento, in D.A. D’Alessandro e A. Ziino, La musica a <strong>Napoli</strong> durante il Seicento, Roma,<br />
E<strong>di</strong>zioni Torre d’Orfeo, 1987, pp. 9 – 16),<br />
4 Sulla caratterizzazione della professione del musicista in età moderna, cfr. R. Del Prete, Il<br />
musicista a <strong>Napoli</strong> nei secoli XVI-XVIII: storia <strong>di</strong> una professione, in S. Zaninelli e M. Taccolini,<br />
Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana, Roma, Vita &<br />
Pensiero, 2000, pp.325-335.<br />
5 Nelle raccolte madrigalistiche i testi poetici, insieme alla de<strong>di</strong>ca, erano infatti il mezzo principale<br />
con cui il compositore rendeva omaggio al proprio protettore, musicando uno o più brani su testi<br />
encomiastici o laudatori e, soprattutto, tenendo conto <strong>dei</strong> gusti letterari del proprio mecenate e della<br />
cerchia nobiliare entro la quale le sue composizioni sarebbero circolate.<br />
3
<strong>di</strong>stinguevano in galeotti, suonatori ambulanti o salariati <strong>di</strong> tromba, piffero e<br />
tamburo 6 .<br />
La connotazione sociale <strong>dei</strong> musicisti subì una profonda e sorprendente<br />
trasformazione nel corso del secolo XVII, quando, nonostante la nobiltà fosse<br />
ancora una classe sociale particolarmente numerosa, non si rilevano presenze<br />
significative <strong>di</strong> compositori nobili attivi nel regno. Una delle spiegazioni, quella<br />
più utile alla nostra trattazione, va ricercata, nel processo <strong>di</strong> consolidamento <strong>di</strong><br />
particolari strutture <strong>di</strong>dattiche, i <strong>quattro</strong> conservatori <strong>musicali</strong>, che, autonomi<br />
nei confronti delle cappelle <strong>musicali</strong> e delle istituzioni <strong>musicali</strong> fiorite nei secoli<br />
precedenti, furono presto in grado <strong>di</strong> produrre “manodopera specializzata”. La<br />
richiesta <strong>di</strong> musica, a partire dal secolo XVII, si andò orientando sempre più<br />
verso usi profani (teatro musicale e concerti) e il fenomeno influenzò anche le<br />
cappelle <strong>musicali</strong>, che cominciarono ad accogliere esecutori (cantori e<br />
strumentisti) non più formati nel loro ambito, ma usciti dalle nuove “scuole <strong>di</strong><br />
musica”.<br />
L’esperienza dell’unico caso italiano <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong> <strong>quattro</strong><br />
conservatori napoletani, da istituti maschili <strong>di</strong> beneficenza per l’infanzia povera<br />
e abbandonata in centri <strong>di</strong> formazione professionale per musicisti, si rivela,<br />
pertanto, su vari livelli <strong>di</strong> analisi, <strong>di</strong> enorme interesse 7 . Essa si realizzò sulla<br />
base <strong>di</strong> un processo governato da principi economici e fu determinante per<br />
l’avvento <strong>di</strong> un mercato musicale così come per la nascita della Scuola<br />
Musicale Napoletana 8 .<br />
6 K.A. Larson, Con<strong>di</strong>zione sociale <strong>dei</strong> musicisti del Cinque e del Seicento, in L. Bianconi – R.<br />
Bossa (a cura <strong>di</strong>), Musica e Cultura a <strong>Napoli</strong> dal XV al XIX sec., Leo Olschki E<strong>di</strong>tore, Firenze<br />
1983, pp. 61-77.<br />
7 Un caso simile a quello napoletano fu quello <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong> veneziani destinati però<br />
esclusivamente alle putte, cioè alle fanciulle venete, orfane o non. Sull’argomento cfr. J.L.<br />
Baldauf-Berdes, Women Musicians of Venice Musical Foundations, 1525-1855, Oxford Press<br />
1993 (“Oxford Monographes on Music”).<br />
8 Sulla Scuola Musicale Napoletana vi è una sconfinata bibliografia. Ci limitiamo, in questa sede a<br />
citare due pietre miliari della storiografia musicale: G. Pannain, Le origini della scuola musicale <strong>di</strong><br />
<strong>Napoli</strong>, <strong>Napoli</strong> 1914 e F. Florimo, La scuola musicale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> e i suoi <strong>Conservatori</strong>, Morano,<br />
4
La musica aveva <strong>di</strong> nuovo mo<strong>di</strong>ficato la sua accezione: il mondo<br />
cristiano aveva recuperato il concetto <strong>di</strong> educazione musicale, ma su basi<br />
<strong>di</strong>verse: la musica non era più fonte <strong>di</strong> corruzione e <strong>di</strong> lascivia per i giovani, ma<br />
<strong>di</strong>ventando parte integrante della nuova liturgia, <strong>di</strong>ventava ad<strong>di</strong>rittura strumento<br />
<strong>di</strong> salvezza e <strong>di</strong> elevazione. Il mondo aristocratico, dal canto suo, forse sulla<br />
scorta dell’appren<strong>di</strong>stato musicale, offerto ai figli del popolo e della plebe, e<br />
della crescente produzione d’opere e drammi sacri, riprese a considerare la<br />
musica un’attività servile da gustarsi solo passivamente.<br />
Furono queste le componenti <strong>di</strong> una moda culturale assai <strong>di</strong>ffusa nel<br />
corso del secolo XVIII, che contribuirono alla trasformazione sociale della<br />
famiglia in termini <strong>di</strong> consumi, ma anche in termini <strong>di</strong> gestione delle relazioni<br />
parentali. E’ noto che il “mestiere” <strong>di</strong> musicista veniva spesso tramandato <strong>di</strong><br />
padre in figlio, laddove il primo maestro <strong>di</strong> musica era quasi sempre il padre.<br />
Casi europei <strong>di</strong> grande fama ce lo ricordano: le famiglie Bach, Mozart, Strauss,<br />
ma anche Scarlatti, Cimarosa, Corelli e tante altre. Le prime nozioni tecniche<br />
venivano impartite al musicista per lo più in ambito familiare, se qualcuno in<br />
famiglia esercitava già la professione musicale, oppure ad opera del maestro <strong>di</strong><br />
cappella della cattedrale locale, secondo il principio della trasmissione<br />
artigianale del mestiere tra maestro e allievo. Nei conservatori tale principio<br />
sarà rafforzato dalla massificazione dell’istruzione musicale, ma soprattutto dai<br />
frequenti incroci che il ceto artigiano ebbe con quello <strong>dei</strong> “musicisti”.<br />
La musica, dunque, come legame familiare, come autocelebrazione o<br />
encomio, come svago, ma anche come strumento <strong>di</strong> salvezza e redenzione, <strong>di</strong><br />
recupero alla legalità ed alla socialità e come opportunità professionale per i<br />
figli della plebe o della borghesia del Mezzogiorno d’Italia.<br />
Sarà interessante ragionare su come la capitale del Mezzogiorno d’Italia, pur<br />
senza adottare particolari istanze <strong>di</strong> sviluppo economico, riuscì a produrre in<br />
quegli anni un piano <strong>di</strong> qualificazione professionale <strong>di</strong> una parte non<br />
trascurabile delle sue risorse umane.<br />
<strong>Napoli</strong>, 1881-83, 4 voll. [rist. anastatica Forni, Bologna 1969].<br />
5
2. La bottega luogo <strong>di</strong> riabilitazione sociale e della famiglia alternativa<br />
I <strong>quattro</strong> istituti napoletani sorsero nell’arco <strong>di</strong> mezzo secolo 9 ; <strong>di</strong> nessuno <strong>di</strong><br />
essi si ha una storia compiuta, se si escludono gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Salvatore Di<br />
Giacomo, che per primo ne effettuò lo spoglio <strong>di</strong> incunaboli e libri mastri 10 .<br />
Tutti nacquero come istituti assistenziali per l’infanzia povera e abbandonata,<br />
ma ben presto si orientarono verso più articolate funzioni sociali, assistenziali<br />
ed educative che gradualmente si strutturarono e consolidarono nel corso del<br />
secolo XVII.<br />
Il problema del pauperismo e dell’assistenza ai poveri rappresenta, è noto,<br />
uno <strong>dei</strong> gran<strong>di</strong> no<strong>di</strong> storici dell’Europa preindustriale. Nel 1504 <strong>Napoli</strong> era<br />
9 Il S. Maria <strong>di</strong> Loreto, fondato nel 1537 nel Borgo <strong>di</strong> Loreto, il Sant’Onofrio a Capuana, sorto nel<br />
1578 a Porta Capuana; la Pietà <strong>dei</strong> Turchini, aperto nel 1583 nell’attuale Via Me<strong>di</strong>na;i Poveri <strong>di</strong><br />
Gesù Cristo, istituito nel 1589 a Piazzetta Girolamini, nei pressi dell’attuale Via Duomo;<br />
confluirono poi, nella seconda metà del ‘700, attraverso varie vicende, in uno solo, quello <strong>di</strong> S.<br />
Maria della Pietà <strong>dei</strong> Turchini.<br />
10 Con questo contributo, speriamo <strong>di</strong> concludere il ciclo <strong>dei</strong> nostri interventi parziali<br />
sull’argomento per intraprendere invece il progetto organico <strong>di</strong> una monografia sulle influenze che<br />
l’attività <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> istituti ebbero sulla costituzione <strong>di</strong> un mercato del lavoro musicale e <strong>di</strong> una<br />
produzione artistica che pose <strong>Napoli</strong> al centro dell’attenzione europea per la cultura musicale.<br />
Segnaliamo dunque i <strong>di</strong>versi contributi con cui abbiamo ricostruito gli aspetti assistenziali,<br />
educativi, gestionali, professionali e più strettamente <strong>musicali</strong> <strong>di</strong> due <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong><br />
napoletani: R. Del Prete, La trasformazione <strong>di</strong> un istituto benefico-assistenziale in scuola <strong>di</strong><br />
musica: una lettura <strong>dei</strong> libri contabili del <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto in <strong>Napoli</strong> (1586-<br />
1703), in M. Marino e R. Cafiero (a cura <strong>di</strong>), Francesco Florimo e l’Ottocento musicale, Jason<br />
E<strong>di</strong>trice, Reggio Calabria 1999, pp. 671-715; Id., Un’azienda musicale a <strong>Napoli</strong> tra Cinquecento e<br />
Settecento: il <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini, in ‹‹Storia Economica››, 1999, n. 3, pp. 413<br />
– 464; Id. Legati pii, patronati e monti <strong>di</strong> maritaggi del <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria della Pietà <strong>dei</strong><br />
Turchini in <strong>Napoli</strong>, in “Rivista <strong>di</strong> Storia Finanziaria”, luglio-<strong>di</strong>cembre 2001, n. 7, pp. 7 – 32; Id., Il<br />
musicista a <strong>Napoli</strong> nei secoli XVI-XVII: storia <strong>di</strong> una professione, in S. Zaninelli e M. Taccolini (a<br />
cura <strong>di</strong>), Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana, Milano,<br />
Vita e Pensiero, 2002, pp. 325 – 335; Id., R. Del Prete, I figlioli del <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong><br />
Turchini <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> nella seconda metà del Settecento: percorsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e opportunità<br />
professionali, in “Nuova Rivista Storica”, I fascicolo 2009, pp. 205 – 222..<br />
6
appena uscita da un lungo periodo <strong>di</strong> instabilità politica ed entrò ufficialmente<br />
in un altrettanto lungo periodo <strong>di</strong> dominazione spagnola, cui molto spesso si<br />
attribuisce lo stato <strong>di</strong> abbandono e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sfacimento economico dell’intero<br />
Mezzogiorno italiano. In realtà, tale <strong>di</strong>sfacimento era cominciato parecchio<br />
tempo prima e i viceré garantirono la pubblica sicurezza che contribuì, nel corso<br />
<strong>di</strong> mezzo secolo, a quintuplicare la popolazione: verso il 1550 la città <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong><br />
aveva superato <strong>di</strong> gran lunga i duecentomila abitanti e <strong>di</strong>venne la più grande<br />
metropoli in Italia, superata in Europa soltanto da Parigi e forse da<br />
Costantinopoli 11 . Un tale incremento <strong>di</strong> popolazione causò sproporzioni sociali<br />
e gravi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> miseria cui si oppose un sistema <strong>di</strong> assistenza e carità<br />
privata, prima ancora che pubblica che, attraverso la fondazione <strong>di</strong> istituti <strong>di</strong><br />
beneficenza provò ad organizzare forme <strong>di</strong> soccorso ai poveri, generalmente<br />
fondate sull’elemosina <strong>dei</strong> privati 12 . La legislazione in materia <strong>di</strong> povertà e la<br />
politica assistenziale ‘pubblica’ accusava pesanti ritar<strong>di</strong> e notevoli carenze<br />
rispetto a contemporanei orientamenti europei. Tuttavia, la prammatica del<br />
1586 ribadì il principio del lavoro stabile inteso come strumento <strong>di</strong> controllo<br />
sociale. Si <strong>di</strong>ffondeva una nuova considerazione della povertà che esaltava il<br />
“povero onesto” emarginando il vagabondo ozioso 13 . Il povero veniva<br />
“<strong>di</strong>scriminato” in congiunturale e strutturale. Il primo, ricevendo soccorso,<br />
favoriva la redenzione <strong>dei</strong> benefattori e dunque acquisiva una rilevante funzione<br />
sociale; il secondo, perdeva tale funzione, perché considerato responsabile della<br />
sua povertà.<br />
Fu necessaria, pertanto, una nuova forma <strong>di</strong> assistenza che si concretizzò<br />
nell’apertura <strong>di</strong> conservatori, convitti, orfanotrofi, ospedali ed altri istituti,<br />
11 G. Galasso, Breve premessa alla storia civile e sociale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, in L. Bianconi e R. Bossa (a<br />
cura <strong>di</strong>), Musica e cultura a <strong>Napoli</strong> dal XV al XIX secolo, Firenze, Olschki, 1983, pp.13 – 27.<br />
12 La bibliografia sulle istituzioni <strong>di</strong> beneficenza è estremamente vasta, riman<strong>di</strong>amo per brevità ad<br />
uno <strong>dei</strong> lavori più recenti sulla povertà in Italia in cui <strong>di</strong>versi casi regionali offrono riferimenti<br />
bibliografici <strong>di</strong>versi: V. Zamagni (a cura <strong>di</strong>), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal<br />
Me<strong>di</strong>oevo ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2000.<br />
13 Prammatica I, De Vagabun<strong>di</strong>s seu erronibus, 31 maggio 1685, in L. Giustiniani, Nuova<br />
collezione delle prammatiche del Regno <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, t. XV, <strong>Napoli</strong>, 1808, p. 16.<br />
7
generalmente affidati a congregazioni laiche o religiose e sorti, molto più<br />
spesso, per iniziativa <strong>di</strong> singoli benefattori (terziari francescani o mercanti, nel<br />
caso <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong> “<strong>musicali</strong>”). Si trattò <strong>di</strong> istituzioni ampiamente<br />
coinvolte nelle attività sociali, politiche e culturali delle comunità, che<br />
potremmo definire, alla luce della situazione attuale, antesignane <strong>di</strong> molti<br />
servizi e professioni sociali, oggi incentivati dall’erogazione <strong>di</strong> finanziamenti<br />
pubblici. Organismi e iniziative non profit le definiremmo oggi, che si sono<br />
susseguiti per oltre otto secoli nel nostro Paese e che hanno espresso ed<br />
esprimono, in forme storicamente <strong>di</strong>verse, l’esigenza <strong>di</strong> costruire rapporti<br />
sociali e solidali, spesso complementari o alternativi rispetto a quelli su cui si<br />
fondano le economie <strong>di</strong> mercato. Da un lato, il peculiare coniugarsi <strong>di</strong> istanze<br />
civiche e religiose ha sollecitato uomini e donne provvisti <strong>di</strong> mezzi a lasciare<br />
qualcosa ai poveri, alimentando un plurisecolare flusso <strong>di</strong> beni; dall’altro<br />
promotori e amministratori degli istituti caritativi hanno svolto una<br />
fondamentale opera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione: sollecitando donazioni, raccogliendo fon<strong>di</strong>,<br />
amministrando risorse ed erogando servizi a favore <strong>dei</strong> meno fortunati 14 .<br />
Su tutti quegli istituti regnò quasi incontrastato quel principio europeo del<br />
renfermement, che suggeriva più o meno vaghi propositi <strong>di</strong> rieducazione <strong>dei</strong><br />
giovanetti, recuperati attraverso la pratica del lavoro. D'altronde, i principi<br />
mercantilistici allora in voga – fuga dall’ozio, creazione <strong>di</strong> nuove fabbriche,<br />
formazione <strong>di</strong> nuova forza-lavoro – uniti alle motivazioni <strong>di</strong> carattere eticoreligioso<br />
resero i binomi lavoro-preghiera e assistenza-produzione due<br />
presupposti imprescin<strong>di</strong>bili per qualunque azione caritatevole che si rivolgesse<br />
ad un “capitale umano” trascurato, abbandonato, apparentemente inabile al<br />
lavoro. Il lavoro richiamava soprattutto la possibilità <strong>di</strong> auto-sostentamento e fu<br />
14 Il crescente interesse per la raccolta fon<strong>di</strong> o fund raising con finalità sociali ha recentemente<br />
indotto stu<strong>di</strong>osi ed operatori ad interrogarsi sulle ra<strong>di</strong>ci antiche del fenomeno a partire dalla<br />
specificità della tra<strong>di</strong>zione delle città italiane, contrad<strong>di</strong>stinte fin dal tardo Me<strong>di</strong>oevo da una intensa<br />
attività caritativa e assistenziale sostenuta finanziariamente da lasciti e donazioni da parte <strong>di</strong> laici<br />
(B. Farolfi e V. Melandri, a cura <strong>di</strong>, Il fund raising in Italia. Storia e prospettive, Bologna, Il<br />
Mulino, 2008; sull’uso <strong>di</strong> lasciare in ere<strong>di</strong>tà legati ai <strong>Conservatori</strong> cfr. il nostro stu<strong>di</strong>o sul<br />
<strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini: R. Del Prete, Legati, patronati e maritaggi., cit.).<br />
8
utilizzato non solo per recuperare alla socialità i poveri, soprattutto se giovani,<br />
ma anche per reperire le risorse necessarie per accoglierli e riabilitarli ad una<br />
citta<strong>di</strong>nanza produttiva.<br />
In quest’ottica sistemare “a bottega” i piccoli ospiti del <strong>Conservatori</strong>o ebbe<br />
sicuramente un duplice significato: da un lato, avviandoli ad un mestiere gli si<br />
conferiva uno status sociale da spendere in età adulta, dall’altro si provvedeva a<br />
sostituire una famiglia totalmente assente, per con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> orfanità o <strong>di</strong><br />
generale abbandono. Il maestro artigiano e la sua famiglia, <strong>di</strong>ventavano la<br />
famiglia <strong>di</strong> adozione <strong>dei</strong> piccoli appren<strong>di</strong>sti accolti nella bottega che, molto<br />
spesso, coincideva con la casa della famiglia artigiana 15 . Il valore educativo e<br />
simbolico evocato da questa prassi <strong>di</strong> affido familiare, che risolveva una serie <strong>di</strong><br />
problemi (risorse per il mantenimento del figliolo, accoglienza in un ambiente<br />
familiare, educazione alla legalità e a comportamenti <strong>di</strong> sana convivenza,<br />
addestramento e avvio ad un’arte da riutilizzare in fase adulta, fund raising per<br />
lo stesso <strong>Conservatori</strong>o che faceva “cassa” per garantire assistenza ad un<br />
numero maggiore <strong>di</strong> reietti), era indubbiamente altissimo.<br />
Le attività artigianali o manifatturiere cui venivano avviati dai Governatori<br />
<strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong> i fanciulli raccolti per le strade <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, erano<br />
<strong>di</strong>verse. Un gran numero <strong>di</strong> figlioli era de<strong>di</strong>to all’arte della seta e imparava<br />
quella <strong>di</strong> trenettaro, <strong>di</strong> filatoraro o <strong>di</strong> berrettaio. Nel primo periodo <strong>di</strong> vita <strong>dei</strong><br />
<strong>quattro</strong> istituti, i fanciulli, la cui età variava tra i sette e i 13 anni, venivano<br />
quasi esclusivamente preparati ai mestieri. I vari governatori degli istituti<br />
stipulavano veri e propri contratti con i maestri artigiani presso i quali venivano<br />
sistemati gli orfanelli. L’istromento 16 prevedeva da parte del maestro artigiano,<br />
anzitutto <strong>di</strong> insegnare al figliolo il mestiere, poi <strong>di</strong> offrirgli “vitto, vestito e <strong>di</strong><br />
15 Sui modelli della famiglia artigiana, sulla sua ampiezza, sulla trasmissione del mestiere <strong>di</strong> padre<br />
in figlio nonché sulle politiche matrimoniali e sulle strategie familiari si veda G. Da Molin-A.<br />
Carbone, Gli artigiani nel Mezzogiorno d’Italia nel XVIII secolo:modelli <strong>di</strong>fferenti delle famiglie,<br />
del matrimonio e del controllo degli assetti produttivi, in S. Cavaciocchi (a cura <strong>di</strong>), La famiglia<br />
nell’economia europea <strong>dei</strong> secoli XIII-XVIII. The economic role of the family in the European<br />
Economic from the 13th to the 18 th Centuries, Prato, Fondazione Internazionale <strong>di</strong> Storia<br />
Economica “F. Datini”, 2009, pp. 305-324.<br />
9
en trattarlo per almeno sei anni continui”, alla fine <strong>dei</strong> quali avrebbe dovuto dargli ancora “un vestito<br />
nuovo <strong>di</strong> panno <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>” e poi consegnarlo ai governatori, pagando al <strong>Conservatori</strong>o 10 ducati per il<br />
servizio che l’orfanello in tutti quegli anni gli aveva offerto. Nel caso in cui i termini della consegna e<br />
del pagamento non fossero stati rispettati, era prevista una sanzione che obbligava l’artigiano a pagare<br />
altri 6 ducati al mese per tutto il tempo del ritardo. In questo modo il <strong>Conservatori</strong>o non soltanto si<br />
assicurava il maestro, ma anche tutte le spese relative al periodo stabilito, mentre una forza lavoro già<br />
produttiva entrava a far parte dell’Istituto, contribuendo così ad accrescerne le entrate 17 .<br />
La connessione tra l’attività <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong> e la congiuntura economica sembra emergere<br />
anche dal numero <strong>dei</strong> ragazzi poveri e abbandonati ospitati negli istituti. Purtroppo, le notizie <strong>di</strong> natura<br />
demografica sono piuttosto frammentarie e si riferiscono soltanto ad alcuni anni, ma rendono in<br />
maniera efficace la caratterizzazione sociale, professionale e geografica <strong>dei</strong> figlioli che entravano nei<br />
<strong>Conservatori</strong> in<strong>di</strong>viduando i percorsi attraverso i quali essi entravano in contatto con la realtà<br />
assistenziale <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> istituti. Alcuni <strong>di</strong> essi venivano “raccolti” dagli stessi Governatori che,<br />
perio<strong>di</strong>camente, “visitavano” le strade della città alla ricerca <strong>di</strong> fanciulli orfani o “mal guidati” dalle<br />
famiglie <strong>di</strong> appartenenza. Altri invece venivano segnalati e “raccomandati” ai <strong>di</strong>versi istituti da persone<br />
16 Così veniva chiamato il “contratto” che suggellava l’ingresso in conservatorio del fanciullo e regolava il rapporto con il<br />
mastro artigiano che lo accettava presso la sua bottega. Gli istrumenti venivano redatti con l’ausilio <strong>di</strong> un notaio <strong>di</strong> fiducia<br />
dell’ente.<br />
17 Tale prassi era attuata in tutti e <strong>quattro</strong> gli istituti, ma fu molto più frequente e sistematica nel <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria<br />
<strong>di</strong> Loreto, il più antico ed il più vicino ad una zona brulicante <strong>di</strong> attività artigianali: il borgo <strong>di</strong> Loreto, infatti, era nei pressi<br />
del Porto e si <strong>di</strong>stingueva per essere uno <strong>dei</strong> più fiorenti borghi artigiani e commerciali della città (filatori, berrettai, guantai,<br />
orefici, costruttori <strong>di</strong> riggiòle, ceramiche ed altro ecc.). Cfr, R. Del Prete, La trasformazione <strong>di</strong> un istituto beneficoassistenziale<br />
in scuola <strong>di</strong> musica, cit.<br />
10
che se ne assumevano la responsabilità garantendo per loro il pagamento <strong>di</strong> una retta. Dai Rolli <strong>dei</strong><br />
figlioli, desumiamo un lungo elenco <strong>di</strong> ingressi che offre alla nostra indagine un insieme <strong>di</strong> notizie<br />
interessanti: nome, provenienza geografica, età, periodo <strong>di</strong> permanenza, “plegio” o raccomandatario,<br />
modalità <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> uscita e, per gli anni successivi al 1650 circa, anche il tipo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> <strong>musicali</strong> che<br />
si accingevano a seguire. Tutte informazioni che aprono spiragli sulle <strong>di</strong>namiche della povertà<br />
napoletana, suggeriscono la tipologia degli artigiani del tempo, l’estrazione sociale <strong>di</strong> coloro che<br />
<strong>di</strong>venteranno gli allievi <strong>dei</strong> <strong>Conservatori</strong> <strong>musicali</strong>, definendo i protagonisti <strong>di</strong> quel particolare e florido<br />
sistema della domanda e dell’offerta musicale in atto a <strong>Napoli</strong> nei secoli XVII e XVIII.<br />
Oltre alla famiglia artigiana ed a quella <strong>di</strong> accoglienza del <strong>Conservatori</strong>o, <strong>di</strong> cui i fanciulli<br />
<strong>di</strong>ventavano figlioli nel rispetto <strong>di</strong> una gerarchia familiare produttiva, e dunque patriarcale 18 , vi ’era<br />
un’altra famiglia pronta ad accogliere i figlioli <strong>dei</strong> nostri <strong>Conservatori</strong>, quella dell’equipaggio nautico a<br />
cui potevano unirsi alcuni <strong>dei</strong> ragazzi avviati alle Scienze Nautiche. Presso il <strong>Conservatori</strong>o più antico<br />
tra i <strong>quattro</strong> istituti <strong>musicali</strong>, quello <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Loreto, fu infatti istituita una Scuola <strong>di</strong> arte<br />
nautica 19 . L’età <strong>di</strong> ammissione degli allievi era fissata a 13 anni e quasi tutti venivano “raccomandati”<br />
dal Re 20 , che interveniva anche nella scelta <strong>dei</strong> maestri 21 .<br />
18 La vita interna del <strong>Conservatori</strong>o era animata da numerosi altri “officiali” nel rispetto <strong>di</strong> una gerarchica <strong>di</strong>visione <strong>dei</strong> compiti,<br />
che affidava al padre rettore la “sovrintendenza tanto della Casa quanto della Chiesa”. Da lui <strong>di</strong>pendevano il vicerettore, il<br />
sacrestano, i prefetti, i maestri <strong>di</strong> grammatica, <strong>di</strong> musica, <strong>di</strong> strumenti, i figlioli, i sacerdoti e il maestro “scarparo”.<br />
19 Sul’istruzione nautica nel regno <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> cfr. R. Salvemini, Formazione e avviamento al lavoro nei reclusori e nei convitti<br />
del Regno <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> alla fine del Settecento, in in S. Zaninelli e M. Taccolini (a cura <strong>di</strong>), Il lavoro come fattore produttivo e<br />
come risorsa nella storia economica italiana, cit., pp. 187 – 198 e Id., Catechismo nautico. Marcello Eusebio Scotti, Procida,<br />
Monte Pio <strong>dei</strong> Marinai, 2001.<br />
11
Il movimento complessivo <strong>dei</strong> maschi entrati nei singoli <strong>Conservatori</strong> fu sempre molto irregolare<br />
variando in relazione alle uscite <strong>di</strong> quanti completavano il loro “istrumento”, al numero <strong>dei</strong> posti a<br />
piazza franca, ma ancor <strong>di</strong> più in relazione agli eventi che <strong>di</strong> volta in volta complicavano le con<strong>di</strong>zioni<br />
socio-economiche della città (nel 1657, ad esempio, il numero delle ammissioni risulta più basso del<br />
solito, probabilmente perché molte località subivano ancora il flagello della peste 22 , così come<br />
l’epidemia del 1764 e gli anni <strong>di</strong> crisi che seguirono posero una pesante ipoteca sulle antiche istituzioni<br />
ospedaliere citta<strong>di</strong>ne e sullo sviluppo della beneficenza pubblica e privata). Il numero <strong>dei</strong> giovanetti<br />
ospitati nei singoli istituti oscillò, in me<strong>di</strong>a, intorno alle 100 unità, ma nel <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> Santa Maria<br />
<strong>di</strong> Loreto, più avvezzo a <strong>di</strong>versificare la formazione e la destinazione <strong>dei</strong> suoi assistiti, il numero<br />
complessivo <strong>dei</strong> figlioli “recuperati” poteva essere <strong>di</strong> gran lunga superiore, dal momento che non tutti<br />
risiedevano all’interno dell’Istituto.<br />
Il contatto con il mondo artigiano continuò, con qualche <strong>di</strong>fferenza, anche quando gli istituti<br />
cominciarono a praticare l’istruzione musicale e l’avvio alle “professioni <strong>musicali</strong>” <strong>dei</strong> figlioli.<br />
20 Numerosi sono i <strong>di</strong>spacci reali ritrovati che consentono l’ammissione <strong>di</strong> figlioli alla Scuola Nautica negli anni 1751-1788. Nel<br />
1751, la Scuola prevedeva soltanto do<strong>di</strong>ci “piazze” per i figlioli del <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto ed il Re decise <strong>di</strong> farle<br />
occupare dai figli degli ufficiali <strong>di</strong> mare <strong>dei</strong> reali armamenti [Archivio del <strong>Conservatori</strong>o S. Pietro a Majella <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>,<br />
<strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini (da ora A.P.T.), Sezione Alunni e Convittori, Scuola <strong>di</strong> Nautica].<br />
21 Sempre nel 1751, pur <strong>di</strong> avere tra gli insegnanti della Scuola Michele De Leonar<strong>di</strong>s, Maestro dell’Accademia <strong>di</strong> Nautica, il<br />
re intervenne personalmente, integrandogli lo stipen<strong>di</strong>o con 9 ducati al mese (APT, Sezione Alunni e Convittori, Scuola <strong>di</strong><br />
Nautica).<br />
22 Sugli effetti sociali e fiscali della peste nel Regno <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> cfr. I.M. Fusco, Peste, demografia e fiscalità nel regno <strong>di</strong><br />
<strong>Napoli</strong> del XVII secolo, Milano, Franco Angeli, 2007.<br />
12
L’attività musicale nei conservatori fu svolta sin dal ‘500 a supporto <strong>di</strong> pratiche devozionali e <strong>di</strong><br />
pompose manifestazioni liturgiche. Ma è dal secolo successivo che, con maestri esterni, con la<br />
selezione degli allievi e con un repertorio scelto, s’impose la scuola musicale nel suo triplice ruolo <strong>di</strong><br />
agenzia educativa, <strong>di</strong> centro <strong>di</strong> formazione professionale per musicisti e <strong>di</strong> “fabbrica <strong>di</strong> musica” 23 . Agli<br />
inizi del secolo XVIII, infatti, gli orientamenti educativi e formativi <strong>dei</strong> <strong>Conservatori</strong> subirono un<br />
cambiamento <strong>di</strong> rotta: la musica <strong>di</strong>venne l’elemento fondamentale della struttura <strong>di</strong>dattica-assistenziale<br />
<strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> istituti imponendosi come l’arte più richiesta dal mercato socio-religioso <strong>di</strong> quel tempo. Gli<br />
istituti, che avevano avviato la loro missione rieducativa affidando alle botteghe i fanciulli abbandonati<br />
o trascurati raccolti dalla strada, compresero che quella stessa musica, utilizzata in un primo momento<br />
come strumento <strong>di</strong> rieducazione e <strong>di</strong> salvezza dell’anima, poteva <strong>di</strong>ventare l’arte da praticare in luoghi<br />
altri rispetto alle botteghe artigiane; cominciarono così a rifornire <strong>di</strong> musici e cantori le istituzioni<br />
ecclesiastiche e spesso anche i teatrini privati. Due furono i principali fattori che concorsero alla<br />
trasformazione <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> brefotrofi in Scuole <strong>di</strong> Musica: la necessità degli istituti <strong>di</strong> trovare fonti<br />
alternative <strong>di</strong> entrate per coprire le spese <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> assistenza e la necessità <strong>di</strong> far fronte alla<br />
domanda, sempre crescente, <strong>di</strong> “servizi <strong>musicali</strong>” <strong>di</strong> tipo religioso e più ancora <strong>di</strong> tipo laico.<br />
Si definirono così nuovi settori produttivi e nuovi sbocchi professionali in un più ampio sistema<br />
musicale e teatrale che, prima a livello urbano, poi nazionale, allargherà il suo raggio d’azione ai paesi<br />
stranieri, stimolando, nel circuito europeo, la domanda <strong>dei</strong> servizi della Scuola Musicale Napoletana 24 .<br />
Con il loro affermarsi, spuntarono figure professionali nuove, come maestri <strong>di</strong> musica, <strong>di</strong> lettere, <strong>di</strong><br />
23 Ogni maestro assunto dai singoli <strong>Conservatori</strong> aveva l’obbligo <strong>di</strong> produrre un certo numero <strong>di</strong> composizioni ogni anno e così<br />
gli allievi che eseguivano spesso le loro composizioni in una sorta <strong>di</strong> saggi scolastici <strong>di</strong> fine anno. La produzione <strong>di</strong> queste<br />
originali fabbriche <strong>di</strong> musica fu consistente e trovò il suo mercato non soltanto nel circuito urbano e nazionale, ma anche<br />
europeo.<br />
13
scienze o <strong>di</strong> nautica, copisti, cantanti e strumentisti, nonché scenografi, liutai, accordatori, personale <strong>di</strong><br />
scena.<br />
3. La committenza musicale: le cappelle e la strada del sacerdozio<br />
I primi impieghi, per così <strong>di</strong>re, professionali, <strong>dei</strong> figlioli educan<strong>di</strong> erano nei servizi <strong>musicali</strong> forniti a<br />
privati, congregazioni religiose e feste popolari. Per le feste popolari la domanda poteva rivolgersi ad<br />
uno o a più solisti o a un gruppo <strong>di</strong> strumentisti; i privati potevano richiedere “cori <strong>di</strong> angeli” in varie<br />
occasioni, ma in gran parte per cerimonie funebri: conventi, congregazioni o parrocchie si avvalevano<br />
della partecipazione <strong>dei</strong> figlioli a messe, processioni o solenni cerimonie liturgiche.<br />
Nell’analisi delle attività <strong>musicali</strong> in cui venivano impegnati i figlioli, gli appalti stipulati per<br />
“musica ed assistenza” descrivono una committenza rappresentata essenzialmente da chiese, monasteri<br />
e congregazioni della <strong>di</strong>ocesi napoletana. Particolarmente frequenti furono i contatti tra il <strong>Conservatori</strong>o<br />
<strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto e la Casa Santa dell’Annunziata, una delle congregazioni che si fece più<br />
assiduamente committente delle musiche <strong>dei</strong> figlioli. Ma l’assiduità <strong>dei</strong> contatti tra i due enti furono<br />
probabilmente dovuti principalmente a ragioni economiche: il Banco dell’Annunziata era uno <strong>dei</strong> sette<br />
banchi pubblici della città, che fungevano spesso da me<strong>di</strong>atori nei lasciti e nelle donazioni da parte <strong>di</strong><br />
privati e <strong>di</strong> congregazioni al <strong>Conservatori</strong>o, o si facevano garanti del pagamento delle rette<br />
d’educazione per un figliolo, oppure, nel migliore <strong>dei</strong> casi, assumevano il ruolo <strong>di</strong> sostenitore<br />
“economico” <strong>di</strong> quell’istituzione <strong>di</strong> beneficenza. Dai libri contabili <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> istituti sono emersi<br />
24 Citiamo tra i tanti riferimenti due classici: G. Pannain, Le origini della scuola musicale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, <strong>Napoli</strong>, 1914; F. Florimo,<br />
Le origini della scuola musicale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, <strong>Napoli</strong> 1881-83, 4 voll., [rist. anastatica Forni, Bologna, 1969]; M.F. Robinson,<br />
Naples and Neapolitan Opera, Oxford, 1972.<br />
14
<strong>di</strong>versi riferimenti alle doti <strong>di</strong> maritaggio depositate dai donatori presso uno <strong>dei</strong> banchi citta<strong>di</strong>ni e<br />
gestite dai governatori <strong>dei</strong> conservatori. Un sistema, questo, che garantiva l’accre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> polizze <strong>di</strong><br />
introito anche per gli assegni vitalizi degli orfanelli e <strong>dei</strong> successivi educan<strong>di</strong> che spesso usufruirono <strong>di</strong><br />
“piazze” aperte in favore della loro educazione 25 . A tal proposito, ribadendo il valore del legame<br />
familiare ricostruito nelle <strong>di</strong>verse azioni <strong>di</strong> recupero <strong>dei</strong> giovanetti abbandonati, ricor<strong>di</strong>amo la prassi,<br />
abbastanza <strong>di</strong>ffusa, <strong>di</strong> attribuire il cognome del donatore al figliolo beneficiato.<br />
Un’altra ragione potrebbe però spiegare l’assiduità <strong>dei</strong> contatti tra il S. Maria <strong>di</strong> Loreto e<br />
l’Annunziata: la presenza, tuttora da confermare, <strong>di</strong> una scuola femminile <strong>di</strong> canto all’interno del<br />
<strong>Conservatori</strong>o. La notizia, che non abbiamo potuto verificare nella documentazione consultata sinora, è<br />
riportata da Francesco Florimo che attribuisce al <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto una particolare<br />
pre<strong>di</strong>sposizione dell’istituto all’insegnamento del canto e soprattutto la presenza, per almeno il primo<br />
ventennio <strong>di</strong> attività del conservatorio, <strong>di</strong> fanciulle educate al canto 26 .<br />
Se il canto fu certamente alla base del progetto educativo <strong>dei</strong> <strong>Conservatori</strong> che privilegiò lo<br />
strumento della catechesi e della partecipazione alle celebrazioni liturgiche (i pueri cantores vantavano<br />
una tra<strong>di</strong>zione millenaria), non possiamo confermare la posizione del Florimo rispetto ad una rinomata<br />
e strutturata scuola <strong>di</strong> canto femminile del S. Maria <strong>di</strong> Loreto. Possiamo però ipotizzare la presenza<br />
delle fanciulle in <strong>Conservatori</strong>o nel primissimo periodo <strong>di</strong> attività non soltanto sulla base <strong>di</strong> due<br />
importanti ere<strong>di</strong>tà lasciate al <strong>Conservatori</strong>o (quella del mercante Antonio Battimelli e quella <strong>di</strong><br />
25 Le “piazze” erano una sorta <strong>di</strong> borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o che consentivano <strong>di</strong> finanziare stu<strong>di</strong>, carriere professionali, vocazioni religiose,<br />
attività impren<strong>di</strong>toriali. Esse consistevano in una ren<strong>di</strong>ta costituita su beni fon<strong>di</strong>ari e immobiliari che serviva ad accumulare le<br />
doti delle ragazze o le ren<strong>di</strong>te <strong>dei</strong> convittori. Per quelle aperte presso i <strong>Conservatori</strong> <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto e della Pietà <strong>dei</strong><br />
Turchini cfr. R. Del Prete, Un’azienda musicale a <strong>Napoli</strong> tra Cinque e Settecento, cit.<br />
26 F. Florimo, La scuola musicale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, cit. II, p. 54.<br />
15
Giovanni Mor<strong>di</strong>ni) destinate in parte a doti <strong>di</strong> maritaggio, ma anche per il riferimento <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse<br />
(quella del Mor<strong>di</strong>ni), alle orfanelle povere <strong>di</strong> S. Eligio. Sempre il Florimo, infatti, ripreso dal Di<br />
Giacomo che si rifà a sua volta agli storici dell’epoca, sostiene che nel 1565 il Collegio <strong>di</strong> Sant’Eligio<br />
accolse le fanciulle ospitate insieme agli altri orfanelli maschi nel <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong><br />
Loreto. Pare che la decisione fosse stata presa dal Car<strong>di</strong>nale Pietro Alfonso Carafa che, proprio in quel<br />
1565, anno del grande sinodo, prese una serie <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti nei confronti delle “monache” 27 .<br />
Il fatto che tra le congregazioni che instaurarono rapporti più frequenti con il <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S.<br />
Maria <strong>di</strong> Loreto, ve ne fossero due tra le più attive nel prestare assistenza alle fanciulle, sembrerebbe,<br />
dunque, convalidare la presenza, anche se <strong>di</strong> breve durata, <strong>di</strong> convittrici nel <strong>Conservatori</strong>o.<br />
Va ricordato però un luogo comune della cultura musicale religiosa del Seicento che non ammetteva<br />
in chiesa l’intervento delle donne in qualità <strong>di</strong> cantanti perché considerato, per tra<strong>di</strong>zione, privo <strong>di</strong><br />
culto 28 . Dunque, se è vero che il <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Loreto ospitava anche le fanciulle e che<br />
queste vi stu<strong>di</strong>assero canto, ciò accadde per tutta una serie <strong>di</strong> situazioni decisamente estranee all’idea<br />
‘clericale’ <strong>dei</strong> cantori! Probabilmente le fanciulle furono inizialmente accolte nell’istituto, nello spirito<br />
nobilissimo <strong>di</strong> prestar loro soccorso ed educazione. Esse vi restarono fino a quel 1565, che oltre ad<br />
essere l’anno del sinodo, fu anche l’anno in cui presso il <strong>Conservatori</strong>o arrivarono i Padri Somaschi che<br />
misero in atto un sistema “<strong>di</strong>dattico” più organico per i figlioli, ma soltanto per quelli maschi, accolti<br />
presso l’istituto 29 .<br />
27<br />
R. De Majo, Alfonso Carafa car<strong>di</strong>nale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, Città del Vaticano, 1962.<br />
28<br />
Sulla considerazione delle donne in musica e, più in generale, sulla religiosità musicale nel Seicento, cfr. G. Stefani, Musica<br />
Barocca. Poetica e Ideologia, Milano, Bompiani, 1974.<br />
29<br />
Altre presenze femminili si ebbero nei <strong>Conservatori</strong> nell’anno 1809, quando i <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong> si erano ormai ridotti ad<br />
uno, il Real Collegio <strong>di</strong> San Sebastiano, che aveva ‘assorbito’ quello della Pietà <strong>dei</strong> Turchini. L’attenzione <strong>dei</strong> Napoleoni<strong>di</strong> in<br />
16
Per ritornare alla committenza religiosa, sembra che la maggior parte delle attività <strong>musicali</strong> svolte<br />
dai figlioli <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong>, spetti, in particolare per tutto il Seicento, alle funzioni religiose.<br />
Gran parte <strong>dei</strong> servizi era assorbita dalle chiese o dalle congregazioni del tessuto urbano, un’altra parte<br />
dai monasteri o conventi della città e del suo circondario. Frequenti erano anche i servizi per le<br />
“esequie” richiesti <strong>di</strong>rettamente da privati che per riscattare i propri peccati “legavano” al<br />
<strong>Conservatori</strong>o parte delle loro ere<strong>di</strong>tà e per suggellare il passaggio a miglior vita nelle con<strong>di</strong>zioni del<br />
perdono, preferivano essere “accompagnati” dagli angioli della musica <strong>di</strong> questo o quel<br />
<strong>Conservatori</strong>o 30 .<br />
Le prestazioni <strong>musicali</strong> in genere erano costituite in “musiche, paranze, appalti, esequie ed angeli”.<br />
In ogni contratto veniva dettagliata la descrizione <strong>dei</strong> vari momenti dell’anno liturgico in cui era<br />
generale per le riforme ed il rior<strong>di</strong>namento strutturale del Regno, in particolare per la pubblica istruzione fece prevedere una<br />
nuova scuola pubblica che apriva l’istruzione musicale anche alle donne [R. Cafiero, Istruzione musicale a <strong>Napoli</strong> fra decennio<br />
francese e restaurazione borbonica: il «collegio <strong>di</strong> musica delle donzelle» (1806-1832), in M. Marino e R. Cafiero (a cura <strong>di</strong>),<br />
Francesco Florimo e l’Ottocento musicale, cit., pp.753 – 826].<br />
30 All’epoca era fortemente <strong>di</strong>ffusa la convinzione <strong>di</strong> investimento spirituale pro reme<strong>di</strong>o animae. L’opera svolta dalla Chiesa<br />
attraverso la pre<strong>di</strong>cazione non poteva non influenzare le coscienze <strong>dei</strong> singoli. Tra gli argomenti ricorrenti nell’oratoria<br />
controriformista troviamo, infatti, gli ammonimenti sul pericolo <strong>di</strong> dannazione eterna per coloro che, al momento del trapasso,<br />
non si preoccupavano del prossimo bisognoso. Tra gli elementi che con<strong>di</strong>zionarono fortemente la scelta delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
testamentarie, favorendo la confluenza <strong>di</strong> gran parte delle sostanze <strong>dei</strong> singoli nelle casse degli enti assistenziali, bisogna<br />
includere una certa <strong>di</strong>ffusione che ebbero i trattati sul “ben morire” ed il moltiplicarsi delle confraternite, che avevano come<br />
scopo la preparazione <strong>dei</strong> loro associati ad una “buona morte” (A. Tenenti, Il senso della morte e l’amore della vita nel<br />
Rinascimento), Torino, 1977, pp. 62-111; R. Del Prete, Legati, patronati e maritaggi del <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini,<br />
cit., pp. 7-17).<br />
17
ichiesto il servizio musicale. Esso poteva consistere in “paranze” semplici o piene 31 , in “cori”,<br />
“assistenze al Maestro <strong>di</strong> Cappella”, trattenimenti (mottetti, sinfonie ed altro). Una delle clausole<br />
ricorrenti riguardava il rispetto degli obblighi <strong>dei</strong> figlioli dettati dalle Regole del singolo <strong>Conservatori</strong>o:<br />
qualora uno <strong>dei</strong> servizi <strong>musicali</strong> fosse coinciso, per esempio, con il sabato de<strong>di</strong>cato alla confessione e<br />
alla comunione generale, o con la settimana degli esercizi spirituali, esso doveva essere spostato in<br />
epoche in cui i “figlioli educan<strong>di</strong>” fossero risultati liberi da ogni altro impegno canonico.<br />
Ai figlioli <strong>dei</strong> <strong>Conservatori</strong> veniva chiesto sempre il rispetto <strong>di</strong> un buon comportamento religioso e<br />
civile, soprattutto quando, quelli più adulti e più richiesti dal mondo dello spettacolo profano,<br />
cominciarono ad essere allettati da offerte personali che li avrebbero lanciati in carriere <strong>musicali</strong> e<br />
teatrali <strong>di</strong> ben altre <strong>di</strong>mensioni.<br />
Tra i committenti <strong>di</strong> musica appartenenti al popolo figurano mercanti, banchieri e ufficiali<br />
governativi. I nobili e i borghesi assumevano musicisti in qualità <strong>di</strong> musici <strong>di</strong> casa, <strong>di</strong> insegnanti <strong>di</strong><br />
canto e <strong>di</strong> strumenti <strong>musicali</strong>, o come esecutori <strong>di</strong> musica in occasioni particolari, come gli “spassi” <strong>di</strong><br />
Posillipo che, nelle sere d’estate, favorivano l’ostentazione sfarzosa tra i nobili, che gareggiavano per<br />
esibire sull’acqua le flotte <strong>di</strong> barche più numerose e sontuose e, a bordo, le livree più ricche per i loro<br />
marinai e musicisti. Tutte le occasioni, sia a carattere religioso sia civile, erano buone per organizzare<br />
festeggiamenti con i propri rispettivi ingre<strong>di</strong>enti (apparati civili e religiosi, carri, cuccagne, giostre,<br />
maschere, mascherate ecc.) 32 . In mano ai viceré più accorti le feste <strong>di</strong>vennero più raffinate e gran<strong>di</strong>ose<br />
per far presa efficace sull’istinto e sull’orgoglio popolare; assicurandosi così, il potere politico, cre<strong>di</strong>to<br />
31 Una paranza semplice impegnava me<strong>di</strong>amente do<strong>di</strong>ci figlioli, quella “piena” era formata da 25 figlioli.<br />
32 F. Mancini, Feste ed apparati civili e religiosi in <strong>Napoli</strong> dal Viceregno alla Capitale, E.S.I., <strong>Napoli</strong>, 1968.<br />
18
ed equilibrio. La musica in queste occasioni aveva un peso determinante: sottolineava la solennità e<br />
l’allegrezza, e trovava così il modo <strong>di</strong> imporsi come spettacolo.<br />
La statistica degli ingressi e delle uscite <strong>dei</strong> <strong>“figlioli”</strong> nei <strong>Conservatori</strong> pur fornendo un panorama<br />
frammentato, per le ragioni già in<strong>di</strong>cate, spiega, tuttavia, le motivazioni che spingevano un giovanetto<br />
ad entrare nell’istituto. Per un musicista che non appartenesse al cenacolo <strong>dei</strong> madrigalisti o a quello <strong>dei</strong><br />
teatri <strong>di</strong> corte, entrare in <strong>Conservatori</strong>o voleva <strong>di</strong>re non solo formazione, ma lavoro e subito. Ciò<br />
nonostante, si avverte spesso la provvisorietà con cui i <strong>“figlioli”</strong> intendevano la loro permanenza nel<br />
<strong>Conservatori</strong>o. La fuga rimaneva un’aspirazione <strong>di</strong>ffusa, soprattutto fra i più giovani e per ragioni<br />
<strong>di</strong>verse, che andavano dal desiderio <strong>di</strong> partecipare a momenti <strong>di</strong> protesta sociale, per affermare l’ideale<br />
politico-rivoluzionario del momento, al desiderio <strong>di</strong> poter lavorare accettando liberamente le offerte<br />
artistiche e <strong>musicali</strong> che potevano provenire dalla domanda esterna al <strong>Conservatori</strong>o 33 .<br />
L’anelito alla libertà, tuttavia, era spesso frustrato da con<strong>di</strong>zioni fisiche precarie che imponevano <strong>di</strong><br />
restare nell’ospizio o <strong>di</strong> far ritorno a casa. E’ significativa la percentuale <strong>dei</strong> casi <strong>di</strong> interruzione della<br />
permanenza in <strong>Conservatori</strong>o che <strong>di</strong>pese dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute del figliolo. Spesso si trattava <strong>di</strong><br />
eunuchi, il cui stato <strong>di</strong> salute, com’è noto, era particolarmente precario 34 . La prassi della castrazione in<br />
età prepuberale era <strong>di</strong>ffusissima in quel tempo e molte famiglie vi ricorrevano, nonostante i severi<br />
<strong>di</strong>vieti, per favorire l’inserimento <strong>dei</strong> propri figli nei cori <strong>di</strong> voci bianche delle chiese, sperando così in<br />
una futura aggregazione ai ranghi del clero 35 . Molte famiglie, allo scopo <strong>di</strong> garantire ai propri figli una<br />
33 Ricor<strong>di</strong>amo che, per contratto, gli allievi potevano essere impiegati per “servizi <strong>di</strong> musica” ma soltanto con l’assenso e la<br />
me<strong>di</strong>azione dell’istituto cui appartenevano e che gran parte degli introiti andava, per contratto, a rimpinguare la cassa comune<br />
del <strong>Conservatori</strong>o.<br />
34 Lo si deduce da una serie <strong>di</strong> attenzioni che i Padri Rettori riservano loro: dall’alimentazione, al dormitorio, all’infermeria.<br />
35 P. Barbier, Gli evirati cantori, Milano, Rizzoli, 1991.<br />
19
migliore e più agevole sistemazione, ma anche per conquistare un’elevazione sociale, li in<strong>di</strong>rizzavano<br />
alla carriera ecclesiastica o ad attività connesse alla vita della Chiesa, dunque alla musica 36 .<br />
Molti erano i figlioli che uscivano dai <strong>Conservatori</strong> per “farsi sacerdote”. Nel decennio 1652-1662,<br />
su 85 figlioli della Pietà <strong>dei</strong> Turchini, 18 uscirono per farsi “monaci”, 4 per prendere servizio come<br />
maestro <strong>di</strong> Cappella, tra questi, uno mantenne l’impegno <strong>di</strong> servire l’istituto in occasione del Corpus<br />
Domini , suonando il trombone ed un altro uscì come eunuco, cioè come cantante 37 .<br />
Un’altra considerazione riguarda il carattere corporativo assunto dalla realtà musicale napoletana nel<br />
periodo considerato 38 . L’elenco <strong>dei</strong> figlioli evidenzia, infatti, la presenza <strong>di</strong> numerosi gruppi familiari<br />
de<strong>di</strong>ti alla professione musicale: Caroselli, de las Infantas, Guido, Lippolis, Natale, Palumbo, Quintana,<br />
Rota, Sances e molti altri. La stessa scelta <strong>dei</strong> maestri veniva effettuata dai Governatori preferibilmente<br />
fra gli ex allievi formatisi nel conservatorio: Francesco Provenzale, maestro <strong>di</strong> Cappella alla Pietà fino<br />
al 1701, venne infatti sostituito da D. Gennaro Ursino e quin<strong>di</strong> da Nicola Fago, entrato come tenore nel<br />
1695.<br />
Più complessa si presenta la determinazione delle aree geografiche <strong>di</strong> provenienza che fanno<br />
emergere un altro dato <strong>di</strong> enorme rilevanza, quello relativo alla presenza <strong>di</strong> immigrati stranieri in tutti e<br />
<strong>quattro</strong> gli istituti.<br />
4. La struttura <strong>di</strong>dattica delle scuole <strong>musicali</strong><br />
36<br />
G.Galasso- C. Russo, Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d’Italia, Guida e<strong>di</strong>tore, <strong>Napoli</strong>, 1982, pp. 258-260.<br />
37<br />
R. Del Prete, Un’azienda musicale a <strong>Napoli</strong>, cit., p. 438.<br />
38<br />
R. Cafiero, “Se i Maestri <strong>di</strong> Cappella son compresi fra gli artigiani”: Saverio Mattei e una Querelle sulla con<strong>di</strong>zione<br />
sociale del musicista alla fine del XVIII sec., in G. Ferraro-F.Pollice (a cura <strong>di</strong>), Civiltà musicale calabrese nel Settecento,<br />
Lamezia Terme, 1994. pp.29-69.<br />
20
Una prassi <strong>di</strong> “ricovero”, suggerita da una politica <strong>di</strong> gestione ancora <strong>di</strong> tipo assistenziale, per tutto il<br />
‘600, prevedeva che i Governatori verificassero quali e quanti fossero i figlioli bisognosi <strong>di</strong> aiuto da<br />
accogliere nel <strong>Conservatori</strong>o. Tale prassi verrà pian piano abbandonata e sostituita, nel corso del ’700,<br />
da un sistema <strong>di</strong> ammissioni stabilito da regole <strong>di</strong> natura “<strong>di</strong>dattica”, più selettive e suggerite da una<br />
domanda “musicale” formulata non più soltanto da committenti religiosi, ma da privati, nobili e dallo<br />
stesso Viceré. Una volta in<strong>di</strong>viduati e ammessi in <strong>Conservatori</strong>o, i ragazzi venivano selezionati in base<br />
alle loro attitu<strong>di</strong>ni, separando quelli che mostravano attitu<strong>di</strong>ni allo stu<strong>di</strong>o della musica (figlioli<br />
educan<strong>di</strong>) da quelli che, invece, si mostravano più idonei ad imparare un’arte o un mestiere.<br />
Non si fa mai riferimento ad un numero massimo <strong>dei</strong> figlioli da ospitare e le modalità <strong>di</strong><br />
ammissione variarono col tempo in relazione alle richieste che provenivano dall’esterno e al fabbisogno<br />
interno dello stesso istituto (ad esempio si registra spora<strong>di</strong>camente l’esigenza <strong>di</strong> “musici” con voce da<br />
basso o <strong>di</strong> suonatori <strong>di</strong> corno da caccia, ecc.) 39 .<br />
Tra i garanti 40 degli alunni troviamo comunque, oltre ai numerosi artigiani della città qualche<br />
“artigiano della musica” come Gaetano Albano, maestro trombonaro, che garantì per l’alunno Gaetano<br />
Costa ammesso allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> “fiati, corde o canto”; o come Nicola Mancini, maestro organaro, che<br />
39 Alcuni elementi per ricostruire la caratterizzazione sociale, professionale, geografica <strong>dei</strong> primi figlioli e per in<strong>di</strong>viduare i<br />
percorsi attraverso i quali essi entrano in contatto con la nuova realtà assistenziale ce li fornisce l’Appen<strong>di</strong>ce allegata a questo<br />
lavoro.<br />
40 La “pleggeria” consisteva in una garanzia offerta per lo più da artigiani o negozianti agli alunni e talvolta ai convittori che<br />
ammontava, generalmente a 50 ducati. La somma veniva versata a scopo cautelativo e il garante si assumeva la responsabilità<br />
<strong>di</strong> rispondere in prima persona nel caso in cui l’alunno fuggisse dal <strong>Conservatori</strong>o senza completare il suo ‹‹istrumento›› (con<br />
il quale si era impegnato a “produrre” per l’ente per un certo numero <strong>di</strong> anni) o arrecasse danni alla Casa o alle persone.<br />
21
garantì per Fer<strong>di</strong>nando Murganza e per Giuseppe Domenicucci. Vi è poi il caso <strong>di</strong> Filippo Corelli, figlio<br />
del maestro <strong>di</strong> tromba del <strong>Conservatori</strong>o, Onofrio Corelli, esaminato ed ammesso nel 1781 41 . Da<br />
sottolineare tra gli ingressi degli educan<strong>di</strong>, quello combinato <strong>di</strong> fratelli o, più frequentemente, <strong>di</strong> figli <strong>di</strong><br />
musicisti 42 . In generale, i registri <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> conservatori partenopei s’infoltiscono sempre più <strong>dei</strong> figli<br />
delle classi me<strong>di</strong>e e basse: ad iscriversi sono sempre più gli immigrati con ambizioni <strong>musicali</strong>, molti <strong>dei</strong><br />
quali arrivano a posti <strong>di</strong> prestigio 43 .<br />
Definita la propria mission, sin dalla metà del Seicento, i conservatori ospitarono alunni e convittori.<br />
Il convittore entrava all’età <strong>di</strong> sette od otto anni e pagava un’entratura (una tassa d’iscrizione) ed una<br />
retta annuale <strong>di</strong>stinta tra “forestieri”, “regnicoli” e napoletani. Le cifre erano suscettibili <strong>di</strong> ulteriori<br />
variazioni in ribasso a seconda delle possibilità economiche, del “talento” del figliolo e delle<br />
presentazioni o “raccomandazioni” che lo accompagnavano. L’alunno, invece, aveva quasi sempre<br />
un’età più avanzata, intorno ai 18-20 anni; era già in grado <strong>di</strong> suonare o <strong>di</strong> cantare e pagava soltanto la<br />
sua entratura. Era però sempre accompagnato dal plegio <strong>di</strong> artigiani o negozianti e s’impegnava a<br />
servire il <strong>Conservatori</strong>o per un certo numero <strong>di</strong> anni concordato con i governatori (5-12 anni). Tale<br />
impegno obbligava l’alunno a “produrre” per l’ente per l’intero arco <strong>di</strong> tempo stabilito nell’atto<br />
d’ammissione, anche se questi decideva <strong>di</strong> non far più parte della comunità del <strong>Conservatori</strong>o. La<br />
41 Cfr. Appen<strong>di</strong>ce, tav. n. 3.<br />
42 Cfr. tavv nn 3-5.<br />
43 Purtroppo i dati dell’appen<strong>di</strong>ce non possono ancora essere esaustivi dell’intera “platea scolastica” <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong> <strong>Conservatori</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>. In attesa <strong>di</strong> completare il nostro lavoro riman<strong>di</strong>amo agli altri dati parziali raccolti da Guido Oliviero, Aggiunte a<br />
“La scuola musicale <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> <strong>di</strong> F. Florimo”: i contratti <strong>dei</strong> figlioli della Pietà <strong>dei</strong> Turchini nei protocolli notarili (1667-<br />
1713), in ‹‹Francesco Florimo e l’Ottocento musicale››, cit., pp. 717-752, e a quelli più antichi <strong>di</strong> S. Di Giacomo, Il<br />
<strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> Sant’Onofrio a Capuana e quello <strong>di</strong> S. Maria della Pietà <strong>dei</strong> Turchini, Remo Sandron,Palermo 1924.<br />
22
permanenza <strong>di</strong>pendeva molto dall’età del figliolo al momento dell’ammissione, dal tipo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
<strong>musicali</strong> che avrebbe intrapreso (violino, canto, <strong>di</strong>rezione corale o altro), dalle possibilità economiche e<br />
dalle modalità <strong>di</strong> pagamento 44 . Difficilmente il soggiorno nel <strong>Conservatori</strong>o aveva una durata<br />
ininterrotta e non sempre si rispettava l’obbligo <strong>di</strong> permanenza stabilito nell’atto <strong>di</strong> ammissione. La<br />
fuga restava un’aspirazione <strong>di</strong>ffusa, soprattutto fra i più giovani: l’insofferenza alle regole era forte<br />
anche perché la “chiusura” in <strong>Conservatori</strong>o non era stata una libera scelta per gran parte <strong>dei</strong><br />
convittori 45 .<br />
Pertanto, al <strong>di</strong> là del conclamato scopo <strong>di</strong> ospitare tutti i fanciulli mal guidati della città, i<br />
conservatori attirarono, nel Settecento, quando ormai si era affermato come eccellente Scuola <strong>di</strong><br />
Musica, quasi esclusivamente giovani musicisti dell’hinterland napoletano, salvo una piccola<br />
percentuale <strong>di</strong> regnicoli in senso lato e gruppi <strong>di</strong> forestieri che provenivano da Roma, Pisa, Firenze,<br />
Milano, Genova, o anche dall’estero: Lione, Parigi, Malta, Mosca, Bavarìa e Portogallo 46 . I figlioli più<br />
44 La permanenza <strong>dei</strong> figlioli nei singoli <strong>Conservatori</strong> variò, nel Settecento, tra i cinque e i <strong>di</strong>eci anni. Come accade ancora<br />
oggi, gli anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o previsti per la classe <strong>di</strong> violino erano almeno <strong>di</strong>eci, così come per il violoncello e per altri strumenti.<br />
45 Colpisce la severità con cui avveniva la punizione <strong>dei</strong> fuggiaschi o <strong>di</strong> quanti si ribellavano all’or<strong>di</strong>ne ed al rispetto rigido ed<br />
inelu<strong>di</strong>bile delle regole. Va ricordato che, nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, la provenienza sociale <strong>di</strong> quei ragazzi non era delle più<br />
elevate e la loro “educazione” obbe<strong>di</strong>va più alle leggi della strada che a quelle etico-religiose della famiglia e della Chiesa.<br />
Inoltre il conservatorio, in quanto struttura “pubblica” sorretta dalla beneficenza <strong>dei</strong> privati, pretendeva dai suoi ospiti “buone<br />
maniere” da esibire in società, una sorta <strong>di</strong> presentabilità esterna che sod<strong>di</strong>sfacesse i pregiu<strong>di</strong>zi e le aspettative <strong>dei</strong> benefattori,<br />
prima ancora che le esigenze <strong>dei</strong> “beneficiati”.<br />
46 Luigi De Rosa riporta la notizia dell’arrivo <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> giovani Portoghesi a <strong>Napoli</strong> nel 1760 venuti allo scopo <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>are musica (L. De Rosa, Navi, merci, nazionalità, itinerari in un porto dell’età industriale. Il porto <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> nel 1760, in<br />
Saggi e Ricerche sul Settecento, Istituto Italiano per gli Stu<strong>di</strong> Filosofici, <strong>Napoli</strong>, 1968). Sui rapporti <strong>musicali</strong> col Portogallo si<br />
veda anche U. Prota-Giurleo, Musicisti napoletani alla corte <strong>di</strong> Portogallo nel ‘700, <strong>Napoli</strong> 1925.<br />
23
meritevoli ottenevano in genere la piazza <strong>di</strong> primo o secondo tenore, soprano, violinista, trombettiere,<br />
oboista o maestro <strong>di</strong> cappella, cioè passavano alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> “alunni a piazza franca”, ossia senza<br />
pagamento <strong>di</strong> alcuna retta e in più assumendo il ruolo <strong>di</strong> mastricelli, cioè maestri assistenti.<br />
Regolarmente svolte e controllate, le loro lezioni erano considerate <strong>di</strong> gran valore per l’istruzione <strong>dei</strong><br />
loro compagni 47 . Tra le attività affidate ai figlioli, una certa importanza aveva anche la copia delle carte<br />
da musica, che avviava e sosteneva il mercato <strong>di</strong> un’e<strong>di</strong>toria musicale ancora molto artigianale 48 .<br />
5. Le opportunità professionali offerte dai Teatri<br />
Nel corso della seconda metà del Settecento il deca<strong>di</strong>mento del valore della musica,<br />
con<strong>di</strong>zionato dai gusti del pubblico, costrinse i compositori a mo<strong>di</strong>ficare il proprio stile per assecondare<br />
gli artifici canori <strong>dei</strong> “castrati” e i teatri attinsero più intensamente ai conservatori per formare i loro<br />
cori. La voce <strong>di</strong> soprano era la preferita e le parti da affidare a soprani erano perciò in genere più<br />
numerose che quelle <strong>di</strong> contralto o <strong>di</strong> tenore o <strong>di</strong> basso. Ciò favorì l’abitu<strong>di</strong>ne a far interpretare anche le<br />
parti maschili da soprani o contralti e soprattutto dai castrati, che <strong>di</strong>vennero i pre<strong>di</strong>letti del pubblico.<br />
L’esistenza <strong>di</strong> bambini evirati prima della pubertà per sfruttare le loro particolari doti vocali e<br />
per conservarne il timbro dolce e acuto risaliva al Cinquecento, quando venivano usati in particolare<br />
nella Cappella papale come pueri cantores. Tuttavia, fu solo nel Settecento che il fenomeno <strong>dei</strong> castrati<br />
assunse un’importanza determinante nell’opera in musica: essi <strong>di</strong>vennero spesso gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>vi molto<br />
ricercati dal pubblico, nonostante le numerosi critiche mosse, in particolare nella seconda metà del<br />
47 APT, Regole a stampa del 1769, p. IX.<br />
48 I copisti erano, in genere, coloro che non potevano pagare l’intera retta e offrivano un servizio alla Casa .<br />
24
secolo, contro la barbara usanza dell’evirazione. Alcuni <strong>di</strong> essi assursero a fama internazionale come<br />
Carlo Broschi detto Farinello, il più celebre; ma l’elenco anche solo <strong>dei</strong> più rinomati sarebbe assai<br />
lungo: Bernacchi, Carestini, Caffarelli, Gizziello, Guadagni e molti altri. Tutti si <strong>di</strong>sputarono la<br />
celebrità puntando chi al più spericolato virtuosismo, chi al sentimentalismo e comunque contribuendo<br />
alla creazione <strong>di</strong> quel particolare fenomeno detto del belcantismo 49 .<br />
Se da una parte, le prestazioni canore <strong>dei</strong> figlioli erano pur retribuite dagli impresari teatrali,<br />
dall’altra, la frequenza con cui gli allievi del <strong>Conservatori</strong>o prendevano parte a quelle rappresentazioni<br />
contribuì a seminare <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni e mancato rispetto delle regole <strong>di</strong>sciplinari al punto che, nel 1759, i<br />
governatori del <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini (rimasto allora l’unico conservatorio in vita)<br />
furono costretti a rivolgersi al re. Essi lamentarono il lassismo della <strong>di</strong>sciplina e del buon costume che i<br />
figlioli trovavano nei teatri, a scapito del buon nome e degli interessi del luogo pio. Partecipare alle<br />
opere messe in scena al Teatro <strong>di</strong> San Carlo, impe<strong>di</strong>va, per esempio, <strong>di</strong> rispettare una delle più ferme<br />
regole d’istituto, quella <strong>di</strong> non uscire <strong>di</strong> notte. Inoltre, la preparazione ai cori organizzati dall’impresario<br />
teatrale, pregiu<strong>di</strong>cava la <strong>di</strong>sponibilità all’esercizio quoti<strong>di</strong>ano scan<strong>di</strong>to dalle ore <strong>di</strong> lezione e <strong>di</strong> orazione.<br />
In particolare, i figlioli venivano meno alle lezioni serali tenute dai “mastricelli”, “le più profittevoli”.<br />
Senza contare poi le cattive amicizie contratte negli ambienti teatrali: canterine e ballerine, giocatori <strong>di</strong><br />
carte e <strong>di</strong> da<strong>di</strong>, che conducevano i giovani conservatoristi alla “rilasciatezza <strong>dei</strong> costumi” 50 .<br />
Il <strong>Conservatori</strong>o fu persino costretto a licenziare <strong>quattro</strong> figlioli “provetti”, che pure<br />
contribuivano alle sue entrate, a causa del loro tenore <strong>di</strong> vita, ormai troppo indecoroso per essere<br />
49 J. Rosselli, Il cantante d’opera: storia <strong>di</strong> una professione (1600-1990), Bologna, Il Mulino 1993.<br />
50 Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong>, da ora ASN, Fasci Teatrali 1759-60. La supplica è riportata anche da S. Di Giacomo, Il<br />
<strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> Sant’Onofrio,cit., p. 241.<br />
25
accettato dalla morale dell’istituto. Particolarmente preoccupati apparvero poi i governatori, quando<br />
richiamarono gli appalti <strong>di</strong> musiche e paranze 51 che l’istituto aveva con <strong>di</strong>verse chiese della città, presso<br />
le quali, generalmente, le prestazioni <strong>dei</strong> figlioli erano richieste nelle primissime ore del mattino.<br />
Diventava impossibile mandarvi i figlioli che si erano ritirati alle prime ore dell’alba dopo aver cantato<br />
nei teatri, e l’ente, per mantenere gli impegni presi con quelle Chiese avrebbe dovuto assumere per<br />
l’occasione musicisti esterni. Insomma, a queste con<strong>di</strong>zioni, gli interessi del <strong>Conservatori</strong>o rischiavano<br />
molto dalla partecipazione <strong>dei</strong> suoi alunni alle opere teatrali ed il tornaconto <strong>di</strong> quelle non era poi così<br />
consistente, almeno per l’Ente 52 .<br />
Per queste ragioni i governatori della Pietà supplicarono il re <strong>di</strong> vietare all’impresario del<br />
Teatro <strong>di</strong> San Carlo <strong>di</strong> contattare i figlioli del <strong>Conservatori</strong>o. Nonostante l’intervento del sovrano, però,<br />
il provve<strong>di</strong>mento fu ancora <strong>di</strong>satteso 53 . Intanto la musica napoletana perdeva i suoi toni e qualche anno<br />
dopo veniva presentato al re il piano <strong>di</strong> un’Accademia Teatrale per Profitto de’ Giovani<br />
<strong>Conservatori</strong>sti, che avanzava proposte <strong>di</strong> riforma tendenti a riportare l’attenzione degli studenti verso<br />
la bella musica, antica e tra<strong>di</strong>zionale, nonché a riqualificare gusto e tecnica degli allievi. L’offerta <strong>di</strong><br />
musicisti maturati nei conservatori eccedeva, ormai sin dai primi anni del ’700, la domanda locale.<br />
Sempre più numerosi dovettero cercare lavoro fuori <strong>Napoli</strong>. Riuniti in piccoli gruppi <strong>di</strong> emigranti, o<br />
residenti in città europee, o circolanti fra l’una e l’altra capitale, essi si adoperarono per imporre l’idea<br />
<strong>di</strong> una <strong>Napoli</strong> “musicale” all’attenzione del pubblico internazionale 54 .<br />
51<br />
R. Del Prete, Un’azienda musicale a <strong>Napoli</strong> tra Cinque e Seicento, cit., pp. 446-449.<br />
52<br />
ASN, Fasci Teatrali 1759-60.<br />
53<br />
APT, Corrispondenze, Suppliche e Memoriali, 14 gennaio 1763.<br />
54<br />
K. Preston, Opera on the Road. Traveling Opera troupes in the United States, 1825-60, Urbana & Chicago, University of<br />
Illinois Press, 1993.<br />
26
Non vi sono evidenti spiegazioni possibili per l’innegabile declino. I suoi sintomi furono però<br />
chiari: il numero degli allievi <strong>di</strong>venuti celebri calò considerevolmente e crebbero le critiche ai<br />
<strong>Conservatori</strong>. A queste <strong>di</strong>fficoltà interne se ne aggiunsero altre più gravi nel corso degli anni ’80 e nei<br />
primi decenni del secolo successivo. Si trattò essenzialmente <strong>di</strong> problemi economici. Il <strong>Conservatori</strong>o,<br />
aveva un <strong>di</strong>sperato bisogno <strong>di</strong> denaro contante e cercava <strong>di</strong> sopperire a tale necessità concedendo<br />
l’appalto <strong>di</strong> esazione <strong>di</strong> alcune sue ren<strong>di</strong>te mobiliari ed immobiliari 55 .<br />
Ciò nonostante, nel corso degli anni ’80 i pagamenti per i servizi <strong>musicali</strong> <strong>dei</strong> figlioli si<br />
intensificarono, ma soprattutto aumentarono i pagamenti per la partecipazione alle rappresentazioni nei<br />
teatri della città 56 . Villeneuve, in pieno ’700, descrisse bene i vantaggi, d’or<strong>di</strong>ne sociale ed economico,<br />
per i conservatori, delle frequenti esibizioni degli allievi, nelle varie parti della città e altrove 57 . Queste<br />
pratiche erano particolarmente gra<strong>di</strong>te agli allievi musicisti, perché movimentavano la loro monotona<br />
vita da conservatoristi e mettevano in luce tutto il loro talento e la tecnica acquisita negli stu<strong>di</strong>.<br />
Servivano anche agli studenti più avanzati per acquistare in<strong>di</strong>pendenza e autorità. In effetti, sia i<br />
musicisti sia l’amministrazione, nonostante le sue proteste, traevano beneficio da un sistema che offrì<br />
gran<strong>di</strong> vantaggi fino a quando le entrate dovute all’attività musicale furono sufficienti a garantire, ai<br />
55 APT, I, 2,12.<br />
56 APT, Giornali d’introito ed esito del Rettore, nn. 28,31,32, anni 1781,1784,1785; R. Del Prete, I figlioli del <strong>Conservatori</strong>o<br />
della Pietà <strong>dei</strong> Turchini <strong>di</strong> <strong>Napoli</strong> nella seconda metà del Settecento: percorsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e opportunità professionali, cit., p.<br />
217, n.39.<br />
57 “Ogniqualvolta una chiesa o una consorteria vuol mettere su una esecuzione musicale (il che accade spesso in Italia) viene<br />
inviata una lettera al rettore con la quale si chiede il servizio <strong>di</strong> 20, trenta o più ragazzi per un prezzo modesto ma stabilito.<br />
Questo porta beneficio all’istituzione, contribuisce al suo mantenimento e moltiplica il numero delle esecuzioni artistiche in<br />
città”, Josse de Villeneuve, Lettre sur le méchanisme de l’opéra italien, 1756, p. 108.<br />
27
conservatori, la propria autonomia dalle autorità superiori (per esempio la Corte), le cui richieste<br />
cominciavano a sollecitare oltre i limiti le risorse artistiche degli istituti.<br />
Nel 1791, il regio delegato Saverio Mattei ricevette l’incarico <strong>di</strong> intervenire nella gestione del<br />
<strong>Conservatori</strong>o per risollevarne le con<strong>di</strong>zioni sia sul piano <strong>di</strong>dattico che sul piano economico. Da questa<br />
fase <strong>di</strong> “commissariamento” dell’ente, nacque un “ordo stu<strong>di</strong>orum” che impose agli allievi <strong>di</strong><br />
cimentarsi col canto fermo, con le cantate <strong>di</strong> Leo, Durante e Scarlatti, nonché con i migliori trattati <strong>di</strong><br />
teoria. Si riprendeva così lo stu<strong>di</strong>o del cosiddetto stile antico.<br />
Le “uscite <strong>musicali</strong>” <strong>dei</strong> conservatoristi continuarono: le loro prestazioni, nonostante la musica<br />
napoletana cominciasse ad avvertire la crisi, erano ancora molto richieste 58 . Molti <strong>di</strong> loro <strong>di</strong>vennero<br />
musicisti e cantanti famosi, ma la loro vita e le loro opere attendono tuttora una puntuale ricognizione<br />
storico-musicologica. Sappiamo pochissimo <strong>di</strong> quanti, soprattutto tra Seicento e Settecento, passando<br />
per i <strong>Conservatori</strong> napoletani, costruirono le proprie carriere con impegno e sacrificio e la conoscenza<br />
delle loro con<strong>di</strong>zioni socio-professionali sarebbe determinante per comprendere e definire la loro<br />
produzione artistica.<br />
Per averne un’idea ci rifacciamo ai dati relativi all’estrazione sociale <strong>di</strong> un centinaio <strong>di</strong><br />
musicisti, raccolti anni fa da Elvi<strong>di</strong>o Surian: essi costituiscono un valido aiuto nel ricostruire il tipo <strong>di</strong><br />
formazione scolastica e professionale da essi ricevuto, il loro appren<strong>di</strong>stato tecnico, le loro modalità<br />
d’inserimento nel sistema produttivo, della carriera e della produzione operistica, <strong>dei</strong> mo<strong>di</strong> e <strong>dei</strong> tempi<br />
<strong>di</strong> lavoro. 59 La consapevolezza <strong>di</strong> operare in funzione del pubblico come prestatori <strong>di</strong> servizi ci porta a<br />
58 APT, Sezione Alunni e Convittori.<br />
59 E. Surian, L’operista, in L. Bianconi-G. Pestelli (a cura <strong>di</strong>), Il sistema produttivo e le sue competenze, in Storia<br />
dell’Opera, vol. IV, Torino, EdT/Musica, 1987, pp. 294 - 345.<br />
28
iconsiderare, alla luce anche <strong>di</strong> quanto sta accadendo oggi al mondo della cultura e dello spettacolo, il<br />
teatro, la musica, l’arte, come ‘servizi pubblici’. I musicisti che si formarono nei <strong>quattro</strong> conservatori<br />
napoletani crebbero con questa consapevolezza che aumentava ogni qualvolta il mondo <strong>dei</strong> teatri li<br />
cercava, in<strong>di</strong>vidualmente, per capacità e talento personale, in funzione del sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>dei</strong> gusti <strong>di</strong><br />
un pubblico “pagante” che affollava, mo<strong>di</strong>ficandone l’assetto gerarchico, le sale <strong>dei</strong> teatri pubblici 60 . Da<br />
ciò <strong>di</strong>scende l’attenzione e la preoccupazione <strong>dei</strong> compositori e degli operisti <strong>di</strong> offrire prodotti artistici<br />
che riscuotessero il consenso del committente (sia esso stato principe, impresario, e<strong>di</strong>tore) nonché il<br />
favore del pubblico pagante o <strong>di</strong> corte.<br />
Anno dopo anno, secolo dopo secolo, i musicisti che completavano il loro percorso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
(completo <strong>di</strong> tirocini formativi espletati nelle <strong>di</strong>verse prestazioni <strong>musicali</strong>) presso i <strong>Conservatori</strong>, si<br />
trovarono a fare i conti da un lato con una struttura <strong>di</strong>dattica dell’Istituto sempre più rigidamente<br />
articolata e dall’altro con l’organizzazione particolare del mondo dello spettacolo, per il quale lavorava.<br />
Da quando (dalla fine del Seicento in poi) le leggi del mercato, della domanda e dell’offerta,<br />
cominciarono a governare la vita e la produzione teatrale italiana, le energie professionali del musicista<br />
e dell’operista sono convogliate prevalentemente verso l’ottenimento del successo, quello economico in<br />
particolare.<br />
Quando i conservatoristi compresero <strong>di</strong> poter ricavare lauti proventi in cambio delle<br />
proprie prestazioni <strong>musicali</strong>, purché fossero <strong>di</strong>sposti a sostenere ritmi <strong>di</strong> lavoro stressanti, dai quali,<br />
invece, il <strong>Conservatori</strong>o cercava <strong>di</strong> preservarli, allora si lasciarono attrarre dal mondo dello spettacolo,<br />
che, è noto ed è così ancora oggi, esercitava sui giovani artisti napoletani un fascino particolare,<br />
60 La musica “ha per fine il gra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chi ascolta”, aveva scritto Alessandro Scarlatti al gran principe <strong>di</strong> Toscana nel 1706<br />
(M. Fabbri, Alessandro Scarlatti e il principe Fer<strong>di</strong>nando de’ Me<strong>di</strong>ci, Firenze, Olschki, 1961, p. 70).<br />
29
costringendoli, in una situazione <strong>di</strong> mancate garanzie (il compenso per una parte in teatro era comunque<br />
un compenso aleatorio e destinato generalmente a perdurare per brevi perio<strong>di</strong>, data la mutevolezza del<br />
gusto operistico e la spietata concorrenza, dal ‘700 in poi, tra gli operisti) ad acquisire una sorta <strong>di</strong><br />
abilità manageriale e un savoir-faire impren<strong>di</strong>toriale per salvaguardare i propri interessi.<br />
Superato il fervore giovanile, i musicisti più maturi avvertivano presto tutta la precarietà del loro<br />
lavoro e cominciavano a puntare al cosiddetto posto fisso: un impiego stabile in qualità <strong>di</strong> maestro <strong>di</strong><br />
cappella, preferibilmente in un’istituzione ecclesiastica, un posto <strong>di</strong> insegnante in uno <strong>dei</strong> <strong>quattro</strong><br />
<strong>Conservatori</strong> <strong>musicali</strong> napoletani o veneziani (nel ‘700) o in un <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> Stato o in scuole <strong>di</strong><br />
musica locali (nell’800). Tali impieghi avrebbero garantito sicuramente la continuità del lavoro, la sua<br />
residenzialità (contro i continui spostamenti degli operisti), un certo rispetto ed eventuali ulteriori<br />
benefici e premi supplementari in virtù <strong>di</strong> una possibile anzianità <strong>di</strong> servizio, ma si trattava quasi<br />
sempre <strong>di</strong> impieghi con salari relativamente bassi rispetto ai proventi che il musicista poteva realizzare<br />
in teatro 61 .<br />
Analizzando l’estrazione sociale <strong>dei</strong> musicisti del Sei-Settecento, predominano coloro che<br />
provenivano da famiglie <strong>di</strong> musicisti professionisti o che praticavano la musica per tra<strong>di</strong>zione familiare.<br />
Numerosi sono i casi <strong>di</strong> intere generazioni <strong>di</strong> musicisti che hanno praticato la musica teatrale per<br />
con<strong>di</strong>zionamento <strong>di</strong>retto da parte dell’ambiente familiare e come veicolo verso una celere affermazione<br />
in campo musicale.<br />
Nell’Otto-Novecento, al contrario, si assistette ad un’inversione <strong>di</strong> tendenza: il numero degli<br />
operisti provenienti da famiglie <strong>di</strong> musicisti calò progressivamente, mentre si registrò l’aumento <strong>di</strong><br />
61 Nel 1689, Alessandro Scarlatti guadagnò 120 ducati all’anno per l’insegnamento presso il <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong><br />
Loreto. Tre anni prima, per gli impegni operistici aveva guadagnato più del doppio, 300 ducati (F. Degrada, L’opera<br />
napoletana, in G. Barblan – A. Basso (a cura <strong>di</strong>), Storia dell’opera, I, Torino, Utet, 1977, pp. 237-332: 275.<br />
30
quelli nati nei ranghi delle classi me<strong>di</strong>o-alte. Ciò sta ad in<strong>di</strong>care che la professione dell’operista,<br />
perduta una gran parte della sua connotazione artigianale, esplosa nella massificazione dell’istruzione<br />
musicale seicentesca, conquistò, grazie ai nuovi spazi offerti dall’e<strong>di</strong>toria musicale, una collocazione<br />
sociale ben più rispettabile che nel passato.<br />
Gli operisti <strong>di</strong> umili origini non mancarono e si <strong>di</strong>stinsero per l’enorme produttività che<br />
caratterizzò le loro faticose carriere. Al contrario il compositore aristocratico e alto-borghese,<br />
usufruendo della ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> famiglia, non aveva l’esigenza <strong>di</strong> avanzare socialmente e <strong>di</strong> affermarsi come<br />
professionista. L’entità della produzione operistica, dunque, era inversamente proporzionale<br />
all’elevazione della fascia sociale <strong>di</strong> appartenenza del compositore.<br />
Per riba<strong>di</strong>re le <strong>di</strong>scendenze <strong>musicali</strong> <strong>di</strong> alcuni musicisti, ci rifacciamo oltre ai dati da noi raccolti<br />
per il <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini, cui limitiamo l’esempio in questa sede, anche ai dati<br />
raccolti su una classificazione <strong>di</strong> 81 operisti italiani per i quali si hanno dati certi circa la famiglia <strong>di</strong><br />
origine e che Elvi<strong>di</strong>o Surian ha or<strong>di</strong>nato per estrazione sociale 62 . Li riportiamo anche se, in parte,<br />
esulano dall’ambito della nostra trattazione. Essi confermano i decisivi legami familiari <strong>di</strong> molti<br />
compositori, che per <strong>di</strong>verse ragioni passarono per <strong>Napoli</strong> e per i suoi <strong>Conservatori</strong> <strong>musicali</strong>, chi come<br />
mestro, chi come allievo. Non è un caso che tra gli allievi in<strong>di</strong>viduati, vi siano quelli appartenenti, per<br />
famiglia, al ceto basso o me<strong>di</strong>o (Nicola Logroscino, Niccolò Jommelli, Giacomo Tritto, Gaspare<br />
Spontini, Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello, Francesco Feo, Antonio Cesti tra gli allievi).Così<br />
come Piccinni, Alessandro Scarlatti, Zingarelli, Bellini, Broschi e tanti altri.<br />
Appen<strong>di</strong>ce<br />
62 E. Surian, L’operista,cit., pp. 305-306.<br />
31
Tav. 1 - Famiglie <strong>di</strong> musicisti italiani(secc. XVI-XX)<br />
Musicista Grado <strong>di</strong> parentela con altri musicisti<br />
Antonio Maria Abbatini Zio maestro <strong>di</strong> cappella a Città <strong>di</strong> Castello<br />
Francesco Cavalli Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Crema<br />
Jacopo e Atto Melani Padre campanaio, sette fratelli musicisti<br />
Giovanni Legrenzi Padre violinista<br />
Alessandro Melani Padre campanaio, sette fratelli musicisti<br />
Marc’Antonio Ziani Zio Pietro Andrea compositore<br />
Carlo Francesco Padre organista<br />
Pollarolo<br />
Alessandro Scarlatti Probabilmente famiglia <strong>di</strong> musicisti per<br />
parte <strong>di</strong> madre<br />
Antonio Lotto Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Hannover<br />
Giovanni Bononcini Padre Giovanni Maria compositore<br />
Antonio Caldara Padre violinista<br />
Antonio Maria Padre Giovanni Maria compositore<br />
Bononcini<br />
Antonio Vival<strong>di</strong> Padre violinista<br />
Domenico Scarlatti Padre Alessandro compositore<br />
Riccardo Broschi Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Andria e<br />
Barletta<br />
32
Egi<strong>di</strong>o Romualdo Duni Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Matera<br />
Gennaro Manna Padre musicista, madre sorella <strong>di</strong> Francesco<br />
Feo<br />
Niccolò Piccinni Padre musicista, madre sorella <strong>di</strong> Gaetano<br />
Latilla<br />
Pietro Alessandro Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Massa<br />
Guglielmi<br />
Gian Francesco De Padre compositore<br />
Majo<br />
Nicola Zingarelli Padre insegnante <strong>di</strong> canto<br />
Luigi Caruso Padre maestro <strong>di</strong> cappella a <strong>Napoli</strong>, fratello<br />
tenore<br />
Gaetano Andreozzi Nipote <strong>di</strong> Niccolò Jommelli<br />
Luigi Cherubini Padre maestro al cembalo nei teatri <strong>di</strong><br />
Firenze<br />
Giuseppe NIcolini Padre maestro <strong>di</strong> cappella a Piacenza<br />
Giovanni Simone Mayr Padre organista<br />
Carlo Coccia Padre violinista<br />
Gioacchino Rossini Padre cornista ( e trombetta della città),<br />
madre cantante<br />
Gioacchino Pacini Padre tenore<br />
Giuseppe Persiani Padre violinista<br />
Vincenzo Bellini Padre maestro <strong>di</strong> Cappella a Catania<br />
Luigi e Federico Ricci Padre pianista<br />
33
Amilcare Ponchielli Padre organista<br />
Alfredo Catalani Nonno e padre musicisti<br />
Giacomo Puccini Antenati e padre musicisti<br />
Ildebrando Pizzetti Padre insegnante <strong>di</strong> pianoforte<br />
Gian Francesco Famiglia <strong>di</strong> musicisti<br />
Malipiero<br />
Nino Rota Nonno compositore, madre pianista<br />
Fonte: E. Surian, L’operista, in L. Bianconi-G. Pestelli (a cura <strong>di</strong>), Il sistema produttivo e le sue competenze,<br />
in Storia dell’Opera, vol. IV, Torino, EdT/Musica, 1987, pp. 294 - 345<br />
Tav. 2 – Estrazione sociale <strong>di</strong> musicisti italiani(secc. XVI-XX)<br />
CETO MEDIO<br />
Jacopo Peri Padre funzionario pubblico<br />
Clau<strong>di</strong>o Montever<strong>di</strong> Padre me<strong>di</strong>co farmacista<br />
Alessandro Stradella Padre governatore militare<br />
Tomaso Albinoni Padre governatore militare<br />
Nicola Logroscino Padre probabilmente proprietario terriero<br />
Giovanni Battista Pergolesi Padre perito agrario<br />
Niccolò Jommelli Padre agiato mercante<br />
Giacomo Tritto Padre commerciante<br />
Antonio Salieri Padre commerciante<br />
Gaspare Spontini Padre piccolo coltivatore<br />
Nicola Vaccai Padre me<strong>di</strong>co<br />
Giuseppe Ver<strong>di</strong> Famiglia <strong>di</strong> piccoli proprietari terrieri e commercianti<br />
34
Errico Petrella Padre ufficiale della marina borbonica<br />
Antonio Cagnoni Padre me<strong>di</strong>co<br />
Ruggero Leoncavallo Padre magistrato<br />
Francesco Cilea Padre eminente avvocato<br />
Umberto Giordano Padre farmacista<br />
Ermanno Wolf-Ferrari Padre pittore<br />
Lugi Dallapiccola Padre insegnante<br />
Gian Carlo Menotti Padre facoltoso commerciante<br />
Luigi Nono Padre pittore, zio scultore<br />
Sylvano Bussotti Zio e fratello pittori<br />
CETO BASSO<br />
Giulio Caccini Padre falegname<br />
Antonio Cesti Nono figlio <strong>di</strong> padre pizzicagnolo<br />
Francesco Feo Padre sarto<br />
Baldassarre Galuppi Padre barbiere<br />
Tommaso Traetta Padre agricoltore<br />
Giovanni Paisiello Padre maniscalco<br />
Domenico Cimarosa Padre muratore, madre lavandaia<br />
Francesco Bianchi Origine proletaria<br />
Gaetano Donizetti Padre tessitore<br />
Pietro Mascagni Padre fornaio<br />
Riccatrdo Zandonai Padre calzolaio<br />
CETO ARISTOCRATICO<br />
Pirro Albergati Capacelli Marchese<br />
35
Emanuele d’Astorga Barone<br />
Giovanni Battista Cimador Famiglia patrizia<br />
Michele Carafa Principe<br />
Francesco Sampieri Marchese<br />
Arrigo Boito Madre nobile polacca<br />
Alberto Franchetti Padre barone, madre Rothschild<br />
Fonte: E. Surian, L’operista, in L. Bianconi-G. Pestelli (a cura <strong>di</strong>), Il sistema produttivo e le sue competenze, in Storia<br />
dell’Opera, vol. IV, Torino, EdT/Musica, 1987, pp. 294 - 345: pp. 306-307<br />
36
Tav. 3 – Alunni ammessi nel <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini tra il 1765 ed il 1794<br />
FIGLIOLO Classi <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o<br />
AQUILAR<br />
Carlo Leopoldo<br />
Ranieri<br />
BENAVENTO<br />
Antonio Francesco<br />
Geltrudo<br />
BIANCONCINI<br />
Giuseppe<br />
BUCCELLA<br />
Andrea<br />
CAPRIOLO<br />
Raffaele Gennaro<br />
COLSON<br />
Natale<br />
COMPARETTI<br />
Gaetano<br />
Anno <strong>di</strong><br />
ammissione<br />
Anni <strong>di</strong><br />
Permanenza<br />
Età Plegio Provenienza<br />
Oboe 1781 8 17 Gaspare Aquilar,<br />
padre<br />
- 1796 - - - -<br />
Oboe<br />
e violino<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
1792 8 - Pascale De Sio,<br />
negoziante<br />
<strong>di</strong> canape e funi<br />
1779 8 - Felice Pedone<br />
Maestro sartore<br />
1779 10 15 Francesco Braj<br />
Maestro sartore<br />
1767 12 21 Tommaso<br />
Piccolo<br />
Maestro<br />
perucchiero<br />
1779 10 - Luigi Zaurenghi<br />
Maestro<br />
Bologna<br />
Livorno<br />
-<br />
<strong>Napoli</strong><br />
-<br />
-<br />
37
CONTI<br />
Giuseppe Giovanni<br />
Romualdo<br />
CORELLI<br />
Filippo<br />
CORNET<br />
Alessandro<br />
COSTA<br />
Gaetano<br />
DEL VECCHIO<br />
Michele<br />
DI LEONARDI<br />
Thomas Francisus<br />
DI LORENZO<br />
Alessandro<br />
Francesco Saverio<br />
DOMENICUCCI<br />
Giuseppe<br />
FINOCCHIO<br />
Alessandro Stefano<br />
o canto indoratore<br />
Fagotto 1794 7 15 Vincenzo Conti <strong>Napoli</strong><br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
1781 10 14 Onofrio Corelli<br />
prof. <strong>di</strong> tromba<br />
1776 8 - Nicola<br />
Gramigna,<br />
calzolaio<br />
1779 10 16 Gaetano Albano<br />
Maestro<br />
trombonaro<br />
1779 8 - D. Luigi<br />
Gonzales,<br />
orologiaio<br />
<strong>Napoli</strong><br />
-<br />
-<br />
<strong>Napoli</strong><br />
- 1769 - - Pasquale Au<strong>di</strong>co Palermo<br />
Musico 1765 10 12 Domenico Di<br />
Lorenzo<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Maestro scarparo<br />
1792 8 - Nicola Mancini<br />
Maestro organaro<br />
1782 12 13 Ranieri Bartalini<br />
Pr. Caramanica<br />
<strong>Napoli</strong><br />
-<br />
Pisa<br />
38
FORCIGNANO<br />
Giuseppe Maria<br />
Quintino<br />
GARGANO<br />
Joseph Maria<br />
Raphael<br />
GUIDA<br />
Gaetano<br />
LAUDANNA<br />
Michelangelo<br />
Costanzo<br />
LIBERATO<br />
Michele Carlo alias<br />
Bologna<br />
LICIO<br />
Arcangelo<br />
LISIO<br />
Giuseppe<br />
Salvatore<br />
Maria<br />
MARGARITA<br />
Fer<strong>di</strong>nandus Francis<br />
MARZANO<br />
Eliseo<br />
Tenore 1769 10 20 Gennaro<br />
Pompilio,<br />
negoziante<br />
Gallipoli<br />
- 1794 - 10 - -<br />
Canto 1779 10 - Giovanni<br />
Sportello<br />
Maestro<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
frangiaro<br />
1768 8 20 Bartolomeo<br />
Renzi<br />
Maestro sartore<br />
1779 12 - Gaetano Zuccaio<br />
Maestro vetraro<br />
e<br />
Biase Bologna,<br />
patrigno<br />
-<br />
Frasso (BN?)<br />
Musico 1766 6 18 Fer<strong>di</strong>nando Licio<br />
Prof. Di oboe<br />
<strong>Napoli</strong><br />
Oboe 1779 10 13 Giuseppe Parlati<br />
officiale Banco<br />
<strong>di</strong> S. Giacomo<br />
<strong>Napoli</strong><br />
tromba 1781 10 - Nicola Mancino<br />
Maestro organaro<br />
Socivo<br />
Fiati,<br />
1781 - 16 Antonio Castel <strong>di</strong><br />
corde<br />
Manfre<strong>di</strong> Sangro<br />
-<br />
39
o canto Maetrso<br />
Calzolaio<br />
MORRONE<br />
Violino 1791 10 12 Antonio Sapio <strong>Napoli</strong><br />
Gaetano Luigi<br />
Capo Mastro<br />
Crispino<br />
Fabricatore<br />
MURGANZA Fiati,<br />
1781 10 - Nicola Mancini -<br />
Fer<strong>di</strong>nando<br />
corde<br />
o canto<br />
Maestro organaro<br />
PIAZZA<br />
Musico 1766 5 20 Pascale Mennillo -<br />
Pascale<br />
Maestro<br />
Carrozziero<br />
PITTALUCA Fiati,<br />
1781 12 21 Emanuele <strong>Napoli</strong><br />
Giuseppe Tommaso corde<br />
Conversano<br />
Francesco<br />
o canto<br />
negoziante<br />
porcellane<br />
<strong>di</strong><br />
e vini stranieri<br />
RAIMONDI<br />
Canto<br />
1791 3 - D. Raffaele Bitonto<br />
don Filippo, da tenore<br />
Raimon<strong>di</strong>,<br />
sacerdote<br />
padre, notaro<br />
RONGHI<br />
- 1791 - 19 Agostino Connio, Genova<br />
Augustinus Maria,<br />
negoziante in<br />
sacerdote<br />
Compagnia <strong>di</strong><br />
Vallin e<br />
SANSONE<br />
Fiati,<br />
1768 5 23<br />
Wolsinglon<br />
Saverio D’Amico -<br />
Santi<br />
corde<br />
o canto<br />
Maestro cordaro<br />
40
SCOLART<br />
Giovanni Domenico<br />
SERUGHI<br />
Giuseppe<br />
TILLE<br />
Giuseppe<br />
VEREREI<br />
Pietro Luca<br />
Benedetto<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
1791 12 13 Vincenzo<br />
Muccar<strong>di</strong><br />
Maestro<br />
falegname<br />
Musico 1766 8 18 Giovanni<br />
Cristiani<br />
Fiati,<br />
corde<br />
o canto<br />
Maestro sartore<br />
1779 10 15 Domenico<br />
Monelli<br />
Maestro. sartore<br />
<strong>Napoli</strong><br />
Tropea<br />
Parigi<br />
Musico 1766 10 15 Carmine Milone <strong>Napoli</strong><br />
Fonte: APT, Sezione Alunni e Convittori<br />
.<br />
Nota: Il trattino in<strong>di</strong>ca che il dato non è conosciuto.<br />
41
Tav. 4 - Figlioli ammessi nel <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini tra 1745 e 1762<br />
Anno<br />
<strong>di</strong><br />
Ammissione<br />
Nome Anni <strong>di</strong><br />
Permanenza<br />
Qualifica degli stu<strong>di</strong><br />
<strong>musicali</strong><br />
1758 ACCRESCA Agostino 10 Soprano<br />
1752 AMICONE Antonio 8 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1755 ANTONINO Sabbato 10 Fagotto<br />
1761 ARSIDI Pietro 8 Oboe<br />
1758 ATTENA Giovanni 10 Violino<br />
1761 AUGENTI Damiano 10 Soprano<br />
1759 AULETTA Fer<strong>di</strong>nando 10 Tenore<br />
1754 BELLI don Sabbato 10 Contralto<br />
1761 BLASCO Giovanni 10 Non stabilito<br />
1760 BLASCO Pietro 10 Violino<br />
1760 BRUNO Giovanni 10 Soprano<br />
1758 CALDAROLA Niccolò 10 Tenore<br />
1759 CALENZA Luigi 10 Tromba<br />
1758 CARPUTI Giuseppe 10 Violino<br />
1761 CARRATURA Giovanni<br />
8 Violino<br />
Antonio<br />
1758 CASTELLANO Giuseppe 10 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1761 CAUOLO Pasquale 7 Contralto<br />
1758 COLLURA Giuseppe 10 Tromba<br />
1761 COMITAS Gregorio 10 Violino<br />
1753 COPPOLA Niccolò 10 Soprano<br />
42
1757 COSCUI Uomobuono 10 Contralto<br />
1756 CUCCI Carlo 10 Violino<br />
1754 CURCI Antonio 10 Tromba<br />
1759 CURCI Leonardo 10 Soprano<br />
1755 D’ANTONIO Niccolò 10 Contralto<br />
1761 D’ELIA Giovanni 9 Violino<br />
1758 D’ORZI Tommaso 10 Oboe<br />
1761 DAVID Antonio 8 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1758 DE DOMENICO Emanuele 10 Oboe<br />
1761 DI FALCO Giuseppe 8 Violino<br />
1757 DI ZANNI Giovanni 10 Violoncello<br />
1759 ELFER Niccolò 10 Violino<br />
1762 EXTRAFALLACE Gaetano 6 Oboe<br />
1762 FAVALE Francesco 6 Basso<br />
1761 FERRETTI Cesare 5 Maestro cappella<br />
1757 FIERI Giuseppe 10 Violino<br />
1752 FINI Saverio 10 Contralto<br />
1759 GABRIELLI Antonio 8 Tenore<br />
1762 GALLO Andrea 10 Tromba<br />
1758 GALLO Giovan Battista 10 Oboe<br />
1760 GALLO Vincenzo 8 Tenore<br />
1761 GHIALRDI Angelo 10 Violino<br />
1754 GRAVINA Gaetano 10 Violino<br />
1757 GRISOLIA Emanuele 10 Violino<br />
1759 GROSSO Giovanni 10 Violoncello<br />
1753 IGNESTI Michele 8 Violino<br />
43
1757 INCOCCIA Lorenzo 10 Contralto<br />
1755 IOVERAS Francesco 10 Violino<br />
1761 LANGELLOTTI Niccolò 10 Soprano<br />
1759 LANGLE’ Onorato 8 Violino<br />
1753 LENZI Francesco 10 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1757 LEOCI Francesco 10 Violino<br />
1759 LONGO Giuseppe 8 Basso<br />
1755 LONZI Marco 10 Contralto<br />
1752 MAENZANO Giovanni 8 Contrabbasso<br />
1751 MAIO Antonio 10 Soprano<br />
1755 MASIELLO don Niccolò 10 Basso<br />
1759 MASULLO Ignazio 10 Soprano<br />
1754 MOROSETTI Gaetano 10 Violoncello<br />
1758 NARDILLO Costantino 10 Tromba<br />
1760 NATALE Tommaso 10 Violino<br />
1761 PALLERINI Carlo 8 Oboe<br />
1757 PARAVICINO Agostino 10 Oboe<br />
1758 PARISI Gaetano 10 Violino<br />
1762 PELLINI Giacomo 10 Contrabbasso<br />
1754 PETRUCCI Francesco 8 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1759 PIETRICONE Flaminio 10 Violino<br />
1759 PINTO Andrea 10 Violino<br />
1758 POLIDEI Angelo 10 Tenore<br />
1755 POLITO Aniello 10 Violino<br />
1758 POLLONI Gaetano 10 Violino<br />
1759 PRATO Nunziante 10 Violino<br />
44
1759 QUINTAVALLE Tommaso 10 Contralto<br />
1753 RANA Gennaro 10 Oboe<br />
1762 RICCA Tommaso 10 Soprano<br />
1757 ROMANO don Angelo 10 Violino<br />
1757 ROMANO Francesco 10 Tenore<br />
1759 RONDANINI Benedetto 10 Violino<br />
1761 ROSSETTI Antonio 12 Violino<br />
1754 RUIZ Filippo 10 Violino<br />
1760 SALA Domenico 10 Violino<br />
1761 SALZANO Niccolò 8 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1759 SCOTTI Giuseppe 10 Violino<br />
1755 SENECA Pasquale 10 Contralto<br />
1759 SPAGNOLO Filippo 10 Tromba<br />
1760 TARNASSI Gaetano 4 Soprano<br />
1745 TORNESE Gioacchino 8 Contralto<br />
1762 TREMOLITI Michelangelo 10 Non stabilito<br />
1752 TRITTO Giacomo 8 Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
1758 ZAMBROTTI Francesco 10 Soprano<br />
Fonte: APT, Sezione Alunni e Convittori<br />
Note: Il periodo <strong>di</strong> permanenza in istituto varia tra i sette e i <strong>di</strong>eci anni e riteniamo che tale variazione<br />
sia in relazione all’età del figliolo al momento dell’ammissione. Naturalmente non abbiamo alcuna<br />
certezza che il periodo <strong>di</strong> permanenza riportato in tabella sia stato effettivamente rispettato, per i<br />
motivi già espressi prima.<br />
45
Tav. 5 – Allievi del <strong>Conservatori</strong>o della Pietà <strong>dei</strong> Turchini negli anni 1781 e 1791 – 1806<br />
Figliolo Anno<br />
<strong>di</strong><br />
ammissi<br />
one<br />
Anno<br />
<strong>di</strong><br />
Licen<br />
za<br />
AGIANESE 1781 - Entra il 22 giugno: suona il violino male<br />
ALTIERI<br />
Raffaele e Michele<br />
1806 - Fratelli<br />
ALTOBELLO Donato 1798 - Uscì nel Governo Repubblicano come Reo <strong>di</strong> Stato,<br />
fu preso con le armi alla mano<br />
ALTRUI 1781 - Entra il 22 giugno: suona il violino me<strong>di</strong>ocremente<br />
ANGELOTTI Nicola 1803 - Suona il contrabbasso e canta da tenore.<br />
Per essere arrivato alla piazza <strong>di</strong> II tenore passa agli alunni<br />
AUXILIA Francesco 1795 1799 Palermitano. Riammesso nel 1803 come alunno<br />
AVETA Raffaele 1793 - Napoletano<br />
AZZELLINI Nicola 1795 1796 Uscito con licenza, fu riammesso nel 1798 a piazza franca<br />
BARDARO’ Vincenzo 1793 1798 Regnicolo. Per non poter pagare il Delegato lo situa<br />
nel <strong>Conservatori</strong>o <strong>di</strong> S. Onofrio; rientra alla Pietà<br />
<strong>dei</strong> Turchini a piazza franca, per 5 anni, come I violoncello.<br />
BARESE Raffaele 1794 1796 Espulso<br />
BARTILOMO Pietro 1805 1806 Di Gravina. Licenziato<br />
BASILE Giovanni 1800 1801 Tornato al suo Paese no è più rientrato<br />
BELLOT Giovanni 1806 - -<br />
BENOVEI Raffaele 1794 1797 -<br />
BERLENTIS Giovanni 1795 1796 Uscito con licenza<br />
BERLENTIS Stefano 1795 1796 Uscito con licenza<br />
Note<br />
46
BETRONICI Giovan<br />
Battista<br />
1797 1799 Uscito per non poter pagare<br />
BILLEMA Luigi 1793 - Napoletano<br />
BIRAZZO Luigi 1803 - -<br />
BOCCARDI Filippo 1805 - -<br />
BOLOGNA 1781 - Inetto e birbo. Espulso con fede <strong>dei</strong> maestri.<br />
BOSSI 1781 - Entra il 22 giugno: appena solfeggia<br />
BRANCACCIO<br />
Gaetano<br />
1804 1806 Si è fatto soldato<br />
BUONAMICI Ettore 1805 1806 Uscito per non aver voluto pagare<br />
BUONNICI Antonio 1794 1795 Uscito con licenza<br />
CALABRESE<br />
1802 - Passato agli alunni per non poter pagare con obbligo<br />
Francesco<br />
però <strong>di</strong> servire per 6 anni forzosi nel suono del Corno da<br />
caccia<br />
invece del violino e <strong>di</strong> copiare un foglio <strong>di</strong> carta <strong>di</strong> musica<br />
al giorno<br />
CALDERANO<br />
1789 - Entrò per 5 anni, ma dal momento che si rivelò “buono” e<br />
Giovanni<br />
che<br />
Cantava bene “da buffo2, fu mantenuto<br />
CAPALDO Modestino 1796 - Nel 1800 passa agli Alunni<br />
CAPOLINO Gennaro 1798 1799 Licenziato<br />
CAPRANICA Giovan 1792 1796 Basso. Esonerato dal pagamento con l’obbligo <strong>di</strong> copiare<br />
Lorenzo<br />
carte<br />
CARACCIOLO<br />
Vincenzo<br />
1802 1805 Ritiratosi per motivi <strong>di</strong> salute<br />
CARAMELLI<br />
Giuseppe<br />
1805 1805 Rimpatriato a Roma<br />
47
CARLINI Lorenzo e<br />
Luigi<br />
1806 - Fratelli<br />
CARLUCCI Nicola 1793 1793 Regnicolo. Uscito e rimpatriato per sue serie e gravi<br />
in<strong>di</strong>sposizioni<br />
CASSANO Luigi 1804 1805 Rimpatriato a Lecce<br />
CASTELLANO<br />
Michele<br />
1796 - Essendo partito dal <strong>Conservatori</strong>o, non è più tornato<br />
CASTIGNACE<br />
Giuseppe<br />
1799 1802 Uscito per non poter pagare<br />
CAVALLERI<br />
Bartolomeo<br />
don 1806 1806 Licenziato<br />
CECCARINI Carlo 1804 - -<br />
CERVELLI Francesco 1793 1796 Regnicolo.Essendo asceso al Sacerdozio si ritirò nel suo<br />
Paolo<br />
Paese<br />
CHERUBINO<br />
Francesco Paolo<br />
1794 1796 Regnicolo. (fratello <strong>di</strong> Salvatore) Esce per non poter pagare<br />
CHERUBINO<br />
1794 1796 Regnicolo (fratello <strong>di</strong> Franceso P.) Esce per non poter<br />
Salvatore<br />
pagare<br />
CHIOCCA Giuseppe 1796 1799 Suona il corno da caccia. Per la sua abilità passa agli<br />
alunni.<br />
Arrestato come Reo <strong>di</strong> Stato<br />
CIORMONE Pasquale 1798 1801 Licenziato<br />
CIPOLLA Giacomo 1806 - Convittore per 6 anni: tre anni col pagamento <strong>di</strong> d. 45<br />
e tre anni franco in qualità <strong>di</strong> alunno, come da istrumento<br />
CIRALLO Gaetano 1794 1795 Siciliano<br />
COLAVITO Rocco 1796 1797 Licenziato<br />
COLONNA don 1803 1805 Sud<strong>di</strong>acono. Gli fu abbassata la retta per aver l’ incarico <strong>di</strong><br />
48
Gabriele insegnare<br />
a leggere e a scrivere ai figlioli.<br />
Uscito per sua grave malattia è passato a miglior vita<br />
COSTANZO Salvatore 1795 1796 Espulso<br />
COZZI Gennaro 1793 1799 Napoletano. Passato a piazza franca perché I oboe,<br />
viene espulso per essere mancato alle musiche <strong>di</strong> S. Maria<br />
delle Grazie<br />
CRISTIANO Federico 1796 1799 Licenziato per problemi <strong>di</strong> salute<br />
D’ALIA don Michele 1801 - Fuggito<br />
D’ANDRIZZA<br />
1803 - -<br />
Giuseppe<br />
D’ASPURA Giacomo 1804 1806 Sortito dal <strong>Conservatori</strong>o. Si è situato nella Marina<br />
DACOSTA Custo<strong>di</strong>o 1797 1798 -<br />
DE CARO Nicola 1794 1795 Si ritirò nel suo Paese perché “inutile”<br />
DE DOMINICIS don<br />
Antonio<br />
1801 1802 Partito con suo padre<br />
DE GREGORJ 1805 1805 Uscito per non aver voluto pagare<br />
Domenico<br />
DEL PRETE Carlo 1805 - Problemi <strong>di</strong> pagamenti<br />
DEL VECCHIO 1781 - Maestro <strong>di</strong> Cappella: se non profitta in 4 mesi espellerlo<br />
DELLA BARRA Luigi 1792 1793 Esonerato dal pagamento per essere I violino<br />
Giuliano<br />
DEMETRIO Francesco 1805 1805 Suona il violino. Ricevuto per alunno,<br />
è stato mandato via prima <strong>di</strong> mettere la veste<br />
DEONCHIA Donato 1794 1800 Esonerato dal pagamento con obbligo <strong>di</strong> copiare carte (30<br />
fogli al mese). Contrabbasso<br />
DI FRANCESCO 1793 1795 Regnicolo, espulso<br />
49
Francesco Saverio<br />
DI GIORGIO Carlo 1794 1796 Espulso<br />
DI GREGORIO 1791 1794 Regnicolo.Grazie all’intervento del Mattei, paga d. 40<br />
Domenico<br />
anziché d. 60<br />
DI RAIMONDO Pietro 1800 1806 Espulso per non aver rispettato la regola <strong>di</strong> non uscir solo<br />
poi riammesso e licenziato<br />
DOGLIO Giuseppe 1803 - -<br />
DONINI Francesco 1795 1797 Licenziato per non aver voluto più pagare;<br />
è entrato nella Banda del Reggimento <strong>di</strong> Terra <strong>di</strong> Lavoro<br />
FANIZZI Pasquale 1804 - -<br />
FATICATI Antonio 1793 1796 Napoletano. Suona il clarinetto.<br />
Proveniente dall’Albergo <strong>dei</strong> Poveri. Espulso dal<br />
<strong>Conservatori</strong>o.<br />
FATTORINI Alderano 1802 1802 Si è licenziato per non volersi applicare alla musica<br />
FERRANTE Antonio 1800 1802 Tornato a casa perché ammalato.<br />
Entra nel Seminario <strong>di</strong> Nola per farsi sacerdote<br />
FIANO (ZIANO) Luigi 1803 - Gli fu abbassata la retta<br />
FISCARELLI - - Entra il 22 giugno: appena solfeggia<br />
FONTANA Agostino 1795 1799 Ischitano. Riammesso nel 1801 come alunno<br />
FORMIGLI Giovanni 1804 - Licenziato per non voler pagare<br />
FRANCHINI Giuseppe 1806 - -<br />
FRODI Vincenzo 1794 - Regnicolo. Per le sue abilità passa a piazza franca nel 1800<br />
GALLO Camillo 1794 - Napoletano. Si è applicato alle scienze ed uscito dal<br />
<strong>Conservatori</strong>o<br />
GALLO Vincenzo 1796 - Passato agli Alunni nel 1798 dopo una fede <strong>di</strong> d. 24,<br />
pagata dal padre Ignazio presso il Banco <strong>dei</strong> Poveri<br />
GAMBERALE 1804 1804 Milanese, è fuggito dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
50
Giovanni<br />
GARGANO Nicola 1798 - Espulso per non aver pagato<br />
GARGANO Vincenzo 1803 - Uscito per non poter pagare<br />
GARGIULO Raffaele 1797 - Uscito, si è fatto soldato <strong>di</strong> cavalleria<br />
(GAZZARINI ) 1800 - Ritirato dal padre poiché è stato licenziato il fratello<br />
Francesco<br />
maggiore<br />
(GAZZARINI) Roberto 1800 1801 Espulso perché incorreggibile<br />
GENTILE Federico 1804 1806 Gli fu abbassata la retta per profitto. Fu ritirato a Firenze<br />
dai genitori<br />
GENTILE Filippo 1806 - Palermitano. Ammalatosi è tornato a casa ed è esonerato<br />
dal pagamento per tutta la durata della sua malattia.<br />
GERMANO Francesco 1792 1793 Rimpatriato<br />
GIANCOLA 1781 - Eunuco, soprano, tenore, non profitta per volontà. Espulso<br />
GIANNATTASIO<br />
Basilio<br />
1793 1793 Espulso<br />
GIANNI Pasquale 1806 - -<br />
GIARROCCHI<br />
1794 - Gli vengono restituiti 25 d. anticipati per il semestre<br />
Giuseppe Antonio<br />
perché ha rinunciato all’ammissione in <strong>Conservatori</strong>o<br />
GODINO Gaetano 1797 1798 Ricevuto perché utile al <strong>Conservatori</strong>o. Espulso perché<br />
ladro;<br />
reintegrato per essere stato <strong>di</strong>scolpato.<br />
Arrestato in <strong>Conservatori</strong>o, nel 1799, come Reo <strong>di</strong> Stato.<br />
IACONO Paolo 1794 1797 Regnicolo. Fuggito dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
LA MARRA Domenico 1793 - Napoletano. Contralto. Passato a piazza franca come I<br />
contralto;<br />
Arrestato con armi alla mano nella resa <strong>di</strong> Castellammare<br />
come reo <strong>di</strong> stato.<br />
51
LA MARRA Pietro 1805 1806 Rimpatriato<br />
LAFAJA Carlo 1804 - Gli fu abbassata la retta<br />
LARICCHIA Giacomo 1796 1797 Licenziato con la restituzione del semestre anticipato<br />
LASTRINO Carlo 1805 1806 -<br />
LEGGI<br />
Raffaele<br />
Vittorio 1795 1801 Licenziato per mancanze gravi<br />
LEONGITO Marco 1793 1794 Regnicolo. Sortito dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
LIBERATORE Teofilo 1802 1802 Uscito<br />
LONGONE Francesco<br />
Antonio<br />
1796 Uscito con licenza del Vicerettore Carlo Fiorillo<br />
LONGONI<br />
1797 1796 Uscito con licenza<br />
Francescantonio<br />
LUCIANO Tobia 1805 - Passato agli alunni<br />
MAGLIONE Pasquale 1797 1801 Espulso perché in<strong>di</strong>sciplinato<br />
MAGRINA Giuseppe 1793 1793 Napoletano. Si è licenziato<br />
MANCINO 1781 - Cattivo soprano, viene affidato al mastricello Cornetti<br />
con una <strong>di</strong>lazione <strong>di</strong> <strong>quattro</strong> mesi<br />
MANFREDI Venanzio 1793 1793 Regnicolo. Espulso perché incorreggibile<br />
MANFROCI Nicola 1805 - Gli fu abbassata la retta<br />
MANNI Nicola 1805 - Nel 1806 gli fu abbassata la retta<br />
MARCHELLI<br />
Domenico<br />
1800 - Genovese. Passa agli alunni<br />
MARCHESE Ignazio 1793 1796 Napoletano. Fuggì dal <strong>Conservatori</strong>o per farsi soldato<br />
MARESCALCHI 1802 1805 Uscito per non aver voluto pagare<br />
Ercole Michele<br />
MARINI Luigi<br />
Giovanni<br />
1793 1794 Estero. Uscito per non poter pagare<br />
52
MAROTTA Raffaele 1795 1796 E’ stato cacciato via<br />
MARTINO Pietro 1804 1805 Licenziato<br />
MAURINO Antonio 1793 1793 Napoletano. Si è licenziato per alcuni giusti motivi<br />
MAURINO Fer<strong>di</strong>nando 1793 1794 Napoletano. Uscito<br />
MAURINO Pasquale 1793 1793 Napoletano. Si è licenziato<br />
MAZZARDI Giuseppe 1797 - Uscito per non poter pagare<br />
MEGLIO Donato 1801 - Nel 1802 passa alla piazza <strong>di</strong> II tenore e poi a tenore <strong>dei</strong><br />
Antonio<br />
Reali Or<strong>di</strong>ni<br />
MERLI primo 1781 - Entra il 22 giugno: suona il violino da principiante<br />
MERLI secondo 1781 - Entra il 22 giugno: tenore, principiante<br />
MIGLIETTA don 1796 - Nel gennaio del 1798 percepisce d. 18 come alunno;<br />
Serafino<br />
Obbligato a far da Maestro <strong>di</strong> Lettere<br />
MODUGNO Raffaele 1798 1798 Uscito per non poter pagare<br />
MONTI don Filippo 1793 1795 -<br />
MONTUORI<br />
Baldassarre<br />
don 1802 - Passato agli alunni nel 1806<br />
MORRONE Desiderio 1793 1798 Estero. Rimpatriato con licenza<br />
MORRONE Michele 1804 1806 Espulso per gravi delitti<br />
MUSTO Gabriele 1795 1801 Entra con l’obbligo <strong>di</strong> servire per 12 anni; espulso perché<br />
incorreggibile<br />
NANI Angelo 1804 - Maldese, è trapassato<br />
NANULA Raffaele 1803 - Gli fu abbassata la retta<br />
NARDULLI<br />
Antonio<br />
Vito 1793 - Napoletano. Se ne è uscito per esser matto<br />
NERI Pietro Francesco<br />
Paolo Benedetto<br />
1792 1796 Uscito per non poter pagare<br />
NICASTRO 1781 - Basso. Perentorio: se non profitta in <strong>quattro</strong> mesi espellerlo<br />
53
ORLAN Fer<strong>di</strong>nando 1795 - Uscito con licenza<br />
ORLANDO Antonio 1802 - Ritrovandosi abile nel servire viene esonerato dal<br />
pagamento<br />
dopo il primo semestre; nel 1806 passa agli alunni<br />
PADUINO Domenico 1803 1803 Uscito per non poter pagare<br />
PALMA Gaetano 1804 1805 Rimpatriato a Lecce<br />
PANCALLO 1781 - Entra il 22 giugno: tenore, principiante e <strong>di</strong> cattiva voce<br />
PANIGADA Antonio 1794 1795 Napoletano. Si è fatto soldato<br />
PAOLINO Giovanni 1806 - -<br />
PASANESE Pasquale 1806 - -<br />
PAUSI don Saverio 1804 1806 -<br />
PELLETTIERI Renato 1793 1795 Espulso<br />
PEROCINO<br />
Antonio<br />
Vito 1797 1798 Partito dal <strong>Conservatori</strong>o non è più tornato<br />
PERRINO Domenico<br />
Angelo<br />
1793 1793 Napoletano. Sortito dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
PERSICO<br />
Maria<br />
Giovanni 1794 - Nel 1801 passa agli Alunni<br />
PETRAROLO Luigi 1802 1804 Licenziato per non aver pagato<br />
PEZZONI don Raffaele 1804 1805 Uscito per non aver ricevuto licenza dal Vescovo <strong>di</strong> Aversa<br />
PIACENZA<br />
Domenico<br />
don 1804 1806 -<br />
PIESCHI Michele, seu<br />
Carlo<br />
1793 1793 Napoletano. Si è licenziato per alcuni giusti motivi<br />
PIGNATARI Spiri<strong>di</strong>one 1805 - -<br />
POFFA<br />
Francescantonio<br />
1795 1801 Estero. Passato a piazza franca perché in Concorso il 12<br />
marzo 1797;<br />
54
POPOLIZIO<br />
Vincenzo e Michele<br />
1806 -<br />
ha occupato per sei anni la IV piazza <strong>di</strong> Maestro <strong>di</strong> cappella<br />
-<br />
QUARZOLI Luigi 1796 - Suona l’oboe e per la mancanza <strong>di</strong> tale strumento paga<br />
meno.<br />
Fuggito sulle navi inglesi<br />
RAI Giovanni Pietro 1793 1794 Estero<br />
RECUPIDO ANTONIO 1798 1798 Si ritirò al suo Paese per servire da Officiale Militare<br />
RECUPIDO Giuseppe 1794 1797 Essendo I tenore gli viene abbassata la retta.<br />
Si è licenziato per “istrumentarsi “ nel Teatro Nuovo<br />
RECUPITO Pascale 1796 1799 Uscito per non poter pagare<br />
RICCI don Michele 1800 - Abbassata la retta e abbonato l’attrasso<br />
perché serve da Prefetto e da I violoncello<br />
RISOLO Giuseppe 1796 1796 -<br />
RODRIGUEZ Pasquale 1794 1802 Napoletano. Passato a piazza franca per 8 anni forzosi<br />
per il bisogno del luogo <strong>di</strong> corni da caccia .<br />
ROMAGNOLI<br />
Giovanni<br />
1797 1798 -<br />
ROMANI Stefano 1794 1799 Per le sue abilità gli fu abbassata la retta. Rimpatriato a<br />
Pisa<br />
RONDANINI Diodato 1793 1794 Napoletano; stu<strong>di</strong>a violino.Proveniente dall’Albergo <strong>dei</strong><br />
Poveri.<br />
Passa a miglior vita.<br />
RONDANINI Gaetano 1793 1796 Napoletano, stu<strong>di</strong>a violino. Proveniente dall’Albergo <strong>dei</strong><br />
Poveri;<br />
Fuggì per entrare nella Banda <strong>di</strong> Caltanissetta<br />
ROTOLO 1781 - Entra il 22 giugno: principiante <strong>di</strong> solfeggio<br />
55
RUBINO Salvatore 1801 - Obbligo <strong>di</strong> servire per 10 anni<br />
RUGGIERO Giuseppe 1794 1797 Napoletano. Fuggito dal <strong>Conservatori</strong>o con la veste<br />
SAFIO Santo 1793 1796 Regnicolo. Abile a servire. Fuggì<br />
Si fece soldato in Capua, nel Reggimento del Re<br />
SALOMONI Raffaele 1803 1805 Ha preso l’abito religioso<br />
SALVAGGIUOLO<br />
Giuseppe Oronzio<br />
1798 1799 Tornato al suo Paese, non se hanno più notizie<br />
SAMMARTINO don 1800 1803 Prescelto come Prefetto, licenziato<br />
Donato<br />
SAPIENZA Pietro 1802 1806 Moscovita. Gli fu abbassata la retta per aver profittato nella<br />
musica<br />
SARACINO Antonio 1804 1806 Leccese. Uscito per non aver pagato<br />
SARAGONI Angelo 1795 1799 Fuggito dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
SARONE<br />
Battista<br />
Giovan 1806 1806 Ritirato in Bavaria<br />
SCALIGINE Angelo<br />
Maria<br />
1800 - Passato agli Alunni<br />
SCOTTO Francesco 1794 1797 Genovese. Rimpatriato con licenza<br />
SECANTE Antonio 1796 - Passato subito agli alunni<br />
SIGISMONDI<br />
1792 1797 Estero,esce per rimpatriarsi a Roma<br />
Domenico<br />
SORIANI Vincenzo 1806 - Clerico<br />
SPALLETTA Raffaele 1795 1800 Gli viene abbonato l’attrasso<br />
SPONTINI Gaspare 1793 1795 Estero. Esonerato dal pagamento con obbligo <strong>di</strong> copiare<br />
carte;<br />
Fuggì dal <strong>Conservatori</strong>o per alcuni delitti<br />
STICHELER Antonio 1805 1806 -<br />
56
SUSINNO Michele 1797 1798 Espulso perché incorreggibile<br />
TAFURO Gennaro 1804 - Essendo morto il padre si è ritirato dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
TAGLIAFERRI 1793 1794 Napoletano. Suona il clarinetto. Proveniente dall’Albergo<br />
Gaetano<br />
<strong>dei</strong> Poveri.<br />
Fuggì dal <strong>Conservatori</strong>o<br />
TARANTINO Gaetano 1798 1799 Si appartò dal <strong>Conservatori</strong>o come Reo <strong>di</strong> Stato,<br />
fu preso con la resa <strong>di</strong> Castellammare<br />
TELLA<br />
Pietro<br />
(ZELLA?) 1797 1798 Licenziato per non aver voluto pagare<br />
TERDONE Giuseppe 1799 - Licenziato<br />
TESTA Vincenzo 1806 - -<br />
TINTO Francesco 1803 1804 Passato da alunno a convittore. Uscito per non voler più<br />
pagare<br />
TORDE Felice 1801 - Gli fu abbassata da retta perché serviva da prefetto;<br />
Per essere un buon maestro <strong>di</strong> cappella passa agli alunni<br />
TROTTA Placido 1794 - Regnicolo. Fuggì dopo aver rubato alcuni argenti della<br />
Cesario<br />
Chiesa<br />
URGESE don Rocco 1794 1796 Regnicolo. Sud<strong>di</strong>acono. Uscito con licenza<br />
VALVASSANI<br />
Giacomo<br />
1804 - Nel 1806 gli fu abbassata la retta<br />
VEGORIO Francesco 1794 - Napoletano. Licenziato e riammesso più volte per mancati<br />
pagamenti<br />
VICECONTE<br />
Giuseppe Vincenzo<br />
1794 1802 Napoletano. Licenziato per alcuni delitti<br />
VICECONTE Pietro 1802 - -<br />
VINACCI Giuseppe 1796 - Suona il violoncello. Licenziato per non poter pagare,<br />
riammesso a piazza franca<br />
57
VITULA Giuseppe 1795 1799 Passato a miglior vita<br />
Fonte: APT, Sezione Alunni e Convittori<br />
.<br />
Note: Il trattino in<strong>di</strong>ca che il dato non è conosciuto.<br />
58