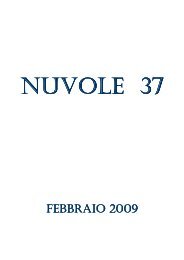INNOVAZIONI TECNOLOGICHE MILITARI E SOCIETÀ ... - Nuvole
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE MILITARI E SOCIETÀ ... - Nuvole
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE MILITARI E SOCIETÀ ... - Nuvole
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
parecchie file. Le formazioni di picchieri e alabardieri erano così dense da sembrare istrici gigantesche.<br />
Questo modo di combattere era praticamente invincibile. La cavalleria nobiliare corazzata non era in<br />
grado di sfondare queste masse di fanti e praticamente perse d’utilità. L’epoca del feudalesimo iconizzato<br />
nel nobile cavaliere corazzato venne a morire anche perché le battaglie erano ormai decise dai fanti<br />
professionisti (svizzeri o lanzichenecchi) armati di lunghe picche o alabarde. Parimenti inutili erano le<br />
armi da fuoco, sia che fossero cannoni o armi da fuoco portatili (archibugi). Contrariamente a quanto<br />
scritto su molti manuali di storia di scuola media le prime armi da fuoco apparse nel XV secolo servivano<br />
a ben poco sul campo di battaglia e non è a esse che si deve far risalire il tramonto della cavalleria<br />
feudale. Il loro impiego utile era limitato agli assedi dove per considerazioni economiche e psicologiche e<br />
di brutale efficienza nel demolire i muri spodestarono le artigliere a contrappeso (trabucchi) che avevano<br />
dominato il medioevo.<br />
I cannoni campali erano oggetti pesanti, ingombranti con gittata utile di duecento metri circa.<br />
Sparavano palle di ghisa o ferro non esplosive che al massimo potevano fare danni contro pochi<br />
sfortunati fanti presi d’infilata. I tempi di ricarica erano lentissimi: una decina di colpi l’ora al massimo.<br />
Una volta posizionati non potevano più essere mossi con facilità ed erano utili solo se erano protetti dalla<br />
fanteria e collocati in posizioni trincerate.<br />
Le armi da fuoco portatili come l’archibugio con accensione a miccia avevano una portata<br />
efficace di una trentina di metri. I tempi di ricarica dell’archibugio erano di circa un colpo al minuto e<br />
l’archibugiere doveva destreggiarsi tra polvere d’innesco, micce accese, forcelle d’appoggio, bacchette di<br />
caricamento ed altro armamentario. Fatta una scarica sul nemico bisognava scappare a gambe levate di<br />
fronte ad una massa di picche che avanzava determinata a infilzare l’archibugiere distante solo una<br />
trentina di passi.<br />
Per rendere efficiente l’archibugio era necessario far si che “vi sia sempre fuoco in aria” come<br />
scriveva Raimondo Principe di Montecuccoli nel 1673 nel trattato “Delle Battaglie”. In altri termini<br />
occorreva che vi fossero salve continuamente indirizzate sul nemico senza tempi morti. La soluzione fu<br />
trovata dai cugini olandesi Maurizio e Giovanni Principi di Nassau. I moschettieri (archibugieri) vennero<br />
schierati in righe di tre uomini di profondità e addestrati a sparare “a comando” per sezioni o righe. Non<br />
vi era più una sola scarica di tutti i moschetti sul nemico, ma una successione cadenzata di salve<br />
effettuata a comando. In tal modo sempre secondo il Montecuccoli: ... E però la moschetteria non deve<br />
scaricare tutta una volta, ma compartirsi in più salve, sì che, fattasi l’ultima, abbiano i primi<br />
moschettieri già ricaricato” .<br />
Dapprincipio, l’innovazione organizzativa introdotta dai due principi luterani olandesi non<br />
interessò molto gli storici di tattica. Già nel XIII e XIV secolo gli arcieri inglesi avevano adottato<br />
sporadicamente tecniche di tiro a comando. In realtà il fuoco a salve cadenzate si diffuse immediatamente<br />
in tutti gli eserciti occidentali ed ebbe vaste ripercussioni al di fuori del campo di battaglia. Per ottenere<br />
che gli uomini eseguissero le scariche di moschetto a comando e all’unisono erano necessari molte<br />
condizioni. In primo luogo si dovevano esercitare continuamente i soldati a manovrare, caricare e<br />
sparare. Divenne necessaria una disciplina feroce per mantenere la coesione e la sincronizzazione dei<br />
reparti, che dovevano per necessità tecniche del fucile “ad avancarica in piedi” caricare le loro armi a un<br />
tiro di sasso dal nemico. La complessità del addestrare, comandare gli uomini in battaglia e ottenere le<br />
scariche cadenzate rese necessario migliorare o meglio definire ex novo la “catena di comando”.<br />
La catena di comando consisteva in un sistema gerarchizzato di poteri e responsabilità<br />
individuate, limitate e strutturate a piramide, con le quali era possibile trasmettere ordini dai livelli più<br />
elevati a quelli più bassi. L’affermarsi di questo sistema di comando impose l’introduzione di un sistema<br />
di “gradi” ai quali corrispondeva una specifica funzione e autorità. I soldati furono così abituati a<br />
identificare il rango con la funzione e a ubbidire a superiori nominati burocraticamente. I rapporti di<br />
subordinazione assunsero sempre più caratteri funzionali e non personali. L’ubbidienza si prestava al<br />
superiore burocratico e non al proprio signore feudale come invece avveniva negli eserciti medievali.<br />
Il sistema dei gradi e delle responsabilità funzionali implicavano una distinzione di ruoli tale da<br />
produrre una “divisione del lavoro” articolata sul campo di battaglia. In altri termini la divisione del<br />
lavoro apparve sistematicamente e diffusamente negli eserciti barocchi, prima che si diffondesse nella<br />
2