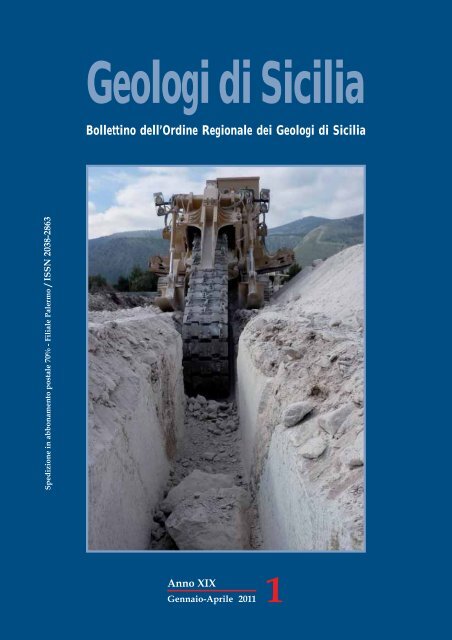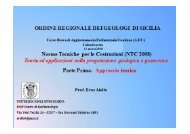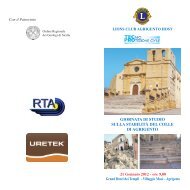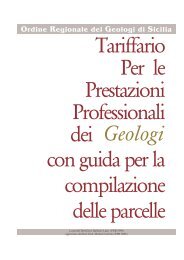Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale 70% - Filiale Palermo / ISSN 2038-2863<br />
<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />
Bollettino dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />
<strong>Anno</strong> XIX<br />
1<br />
Gennaio-Aprile <strong>2011</strong>
<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />
<strong>Anno</strong> XIX - n. 1<br />
Gennaio-Aprile <strong>2011</strong><br />
Direttore e<strong>di</strong>toriale<br />
Pietro Todaro<br />
Direttore responsabile<br />
Nicolò Lo Bue<br />
Redazione<br />
Pietro Todaro, Carlo Cassaniti,<br />
Antonio Gallitto<br />
Segreteria<br />
Giusy Lo Presti<br />
Comitato <strong>dei</strong> Garanti<br />
Rosa Silvia Cannavò, Carlo Cassaniti,<br />
Francesco Criscenti, Saro Di Raimondo,<br />
Emanuele Doria, Antonio Gallitto,<br />
Corrado Ingallina, Giovanni Noto,<br />
Salvatore Palillo, Antonella Parrinello,<br />
Vincenzo Pinizzotto, Biagio Privitera,<br />
Pietro Todaro, Roberto Torre,<br />
Fabio Tortorici.<br />
Referenti Scientifici ed Esperti<br />
Valerio Agnesi, Aurelio Aureli,<br />
Giovanni Bruno, Fabio Cafiso,<br />
Mario Cosentino, Pietro Cosentino,<br />
Sebastiano Imposa, Fabio Lentini,<br />
Vincenzo Liguori, Giuseppe Montana,<br />
Giuseppe Patanè, Giovanni Randazzo,<br />
Attilio Sulli, Francesco Schilirò.<br />
Direzione, Redazione,<br />
Amministrazione e Pubblicità<br />
<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong><br />
90144 Palermo - Via Lazio, 2/A<br />
Tel. 091.6269470 - Fax 091.6269471<br />
www.geologi<strong>di</strong>sicilia.it<br />
info@geologi<strong>di</strong>sicilia.it<br />
E<strong>di</strong>tore<br />
Scientific Books <strong>di</strong> G. Cafaro<br />
90127 Palermo - Via L. Giuffrè, 52<br />
Tel./Fax 091.6512048<br />
E-mail: info@me<strong>di</strong>calbooks.it<br />
Progetto grafico e fotocomposizione<br />
Aldo Priulla - Palermo<br />
Stampa<br />
Euroservice Punto Grafica p.soc.coop.<br />
Concessionaria Pubblicità<br />
Scientific Books <strong>di</strong> G. Cafaro<br />
90127 Palermo - Via L. Giuffrè, 52<br />
Tel./Fax 091.6512048<br />
E-mail: info@me<strong>di</strong>calbooks.it<br />
- Bollettino dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />
SOMMARIO<br />
3 E<strong>di</strong>toriale / Incarichi pubblici, che cosa sta cambiando<br />
<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />
4-8 La scoperta <strong>di</strong> una struttura megalitica “dolmen”<br />
a Galenzo Aquilea <strong>di</strong> Sciacca (AG)<br />
<strong>di</strong> Francesco Lo Bue<br />
8 Il Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />
A Sabrina Polizzi la Prima e<strong>di</strong>zione<br />
9-18 La “crisi <strong>di</strong> salinità messiniana”<br />
e le evaporiti siciliane<br />
<strong>di</strong> Roberto Gulli<br />
18 Si rinnovano i Consigli Direttivi delle Associazioni<br />
<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> Agrigento, Ragusa e Siracusa<br />
19-25 Bilancio consuntivo al 31-12-2009<br />
26 Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />
Seconda e<strong>di</strong>zione<br />
27-30 EPAP / Il patrimonio previdenziale dell’Ente<br />
è sempre in aumento<br />
<strong>di</strong> Arcangelo Pirrello<br />
30 Le Scienze della Terra nella Scuola<br />
<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />
31 Recensioni / Abbiamo letto per voi<br />
a cura <strong>di</strong> Pietro Todaro<br />
32-39 Rinvenimento <strong>di</strong> un’antica cava <strong>di</strong> pietre<br />
da macina nel litorale <strong>di</strong> Letojanni (ME)<br />
<strong>di</strong> Alvise Ucosich<br />
La copertina:<br />
Moderne tecniche <strong>di</strong> trenching:<br />
il taglio del calcare mesozoico<br />
<strong>di</strong> Fondo Raffo a Palermo,<br />
per la posa <strong>dei</strong> sottoservizi<br />
(Foto <strong>di</strong> P. Todaro)
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
L’EDITORIALE<br />
INCARICHI PUBBLICI,<br />
CHE COSA STA CAMBIANDO<br />
Dal nove <strong>di</strong> Giugno <strong>di</strong> quest’anno, entrerà definitivamente<br />
in vigore il D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006<br />
“Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> contratti pubblici relativi a lavori, servizi<br />
e forniture”, con le ultime variazioni introdotte dal<br />
D.P.R. 207/2010. Tra le novità sostanziali che riguardano<br />
i professionisti troviamo l’in<strong>di</strong>rizzo verso la<br />
modalità <strong>di</strong> affidamento degli incarichi tramite l’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa, rispetto a quella<br />
al massimo ribasso. Si intravede pertanto una tenue<br />
luce in fondo a quel tunnel costruito dal D.P.R. 554/99<br />
prima e dal famigerato “Decreto Bersani” convertito<br />
con la Legge 248/2006. Questo cambio <strong>di</strong> tendenza è<br />
stato da lungo tempo auspicato da tutti i Consigli<br />
nazionali delle Professioni tecniche; stu<strong>di</strong> eseguiti dal<br />
nostro CNG, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri<br />
ed anche dall’OICE (l’organo <strong>di</strong> rappresentanza<br />
delle società <strong>di</strong> ingegneria), hanno da tempo evidenziato<br />
come il sistema delle offerte al massimo ribasso,<br />
legato anche alla mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina delle tariffe,<br />
ci ha condotto verso un andamento <strong>dei</strong> ribassi che<br />
hanno raggiunto un valore me<strong>di</strong>o pari ad oltre il 45%<br />
ed uno massimo superiore all’82% con punte dell’<br />
86% per le società <strong>di</strong> ingegneria. Questo andamento<br />
del “libero mercato”, oltre ad esasperare il regime concorrenziale,<br />
porta a conseguenti ed evidenti ripercussioni<br />
sulla qualità della progettazione; per noi geologi<br />
il problema <strong>di</strong>venta ancora più evidente quando<br />
l’importo su cui effettuare il ribasso include anche<br />
l’importo delle indagini o quando ci presentiamo alle<br />
gare in RTP. In pratica si sta verificando con la committenza<br />
pubblica quello che già da anni lamentavamo<br />
con la committenza privata, in cui l’onorario per<br />
la prestazione, se ancora <strong>di</strong> onorario si può parlare, è<br />
in continua e verticale <strong>di</strong>scesa nonostante l’introduzione<br />
delle NTC che avrebbero dovuto segnare la svolta<br />
qualitativa della nostra professione.<br />
Un tentativo per ridurre questa tendenza era stato<br />
fatto con la Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio<br />
scorso “Linee guida per l’affidamento <strong>dei</strong> servizi attinenti<br />
all’architettura ed all’ingegneria”, l’Autorità <strong>di</strong><br />
vigilanza sui contratti pubblici <strong>di</strong> lavori, servizi e forniture<br />
che, per quanto concerne la determinazione dell’importo<br />
a base <strong>di</strong> gara ha precisato che il corrispettivo<br />
va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001,<br />
almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno<br />
nuovo, emanato ai sensi dell’articolo 92, comma 2,<br />
del Co<strong>di</strong>ce, “tenendo conto delle tariffe previste per<br />
le categorie professionali interessate”; ma questa<br />
determinazione ha avuto poco seguito soprattutto in<br />
<strong>Sicilia</strong>, dove la Circolare dell’Assessorato <strong>Regionale</strong><br />
per i LL.PP. del 18/9/2006 ha stabilito un doppio regime<br />
normativo: per i lavori pubblici l’applicazione della<br />
normativa regionale mentre per i beni, servizi e forniture<br />
si rimanda al Co<strong>di</strong>ce 163/2006 con le successive<br />
mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni. Questa evidente con-<br />
<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />
trad<strong>di</strong>zione, tutta isolana, consente attualmente una<br />
grande autonomia alle S.A., per cui si assiste continuamente<br />
a ban<strong>di</strong> <strong>di</strong> gara con impostazioni completamente<br />
<strong>di</strong>fferenti, svariati criteri <strong>di</strong> scelta <strong>dei</strong> requisiti<br />
e forte permanenza del fattore <strong>di</strong>screzionalità.<br />
Da <strong>di</strong>versi mesi ormai, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong>,<br />
insieme alle Consulte Regionali degli Architetti<br />
e degli Ingegneri ed a <strong>di</strong>verse associazioni <strong>di</strong> categoria,<br />
sta partecipando al Tavolo <strong>di</strong> Lavoro per gli appalti<br />
istituito dall’Assessore <strong>Regionale</strong> alle Infrastrutture<br />
e Mobilità, nelle cui sedute, spesso <strong>di</strong>battute, ha fornito<br />
il suo contribuito sia alla preparazione <strong>di</strong> una serie<br />
<strong>di</strong> proposte del mondo professionale siciliano rivolte<br />
al governo regionale, sia a puntualizzare le specifiche<br />
richieste della categoria <strong>dei</strong> geologi per quanto concerne<br />
la stesura delle Linee Guida del Co<strong>di</strong>ce; questo<br />
<strong>di</strong>alogo, che ha visto le professioni tecniche fare fronte<br />
unito, si è concretizzato in un Atto <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo che<br />
impegna la Regione siciliana, ed i Comuni della <strong>Sicilia</strong>,<br />
nonché gli enti, le aziende e le società <strong>di</strong>pendenti<br />
o partecipate, a seguire, nell’effettuazione delle gare<br />
d’appalto <strong>di</strong> lavori e <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> servizi, una<br />
serie <strong>di</strong> criteri che anticipino il recepimento <strong>di</strong>namico<br />
del Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> Contratti secondo il quale l’unico<br />
criterio utilizzabile per la valutazione delle offerte è<br />
quello del “criterio dell’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa”.<br />
Ci auguriamo quin<strong>di</strong> che a breve non si sentirà più<br />
parlare <strong>di</strong> ribassi incre<strong>di</strong>bili, figli comunque <strong>di</strong> una<br />
situazione generale molto <strong>di</strong>fficile, <strong>di</strong> concorrenza esasperata,<br />
legata anche alla scarsità sul territorio <strong>di</strong> ban<strong>di</strong><br />
che consentano la partecipazione <strong>dei</strong> liberi professionisti<br />
senza vincoli a volte farraginosi. Tuttavia la<br />
norma in ingresso non è esente da pecche, poiché prende<br />
in considerazione come criteri l’adeguatezza dell’offerta;<br />
le caratteristiche metodologiche dell’offerta<br />
stessa; il ribasso percentuale unico in<strong>di</strong>cato nell’offerta<br />
economica, che non può essere superiore ad una<br />
percentuale che deve essere fissata nel bando <strong>di</strong> gara<br />
in relazione alla tipologia; la riduzione percentuale<br />
in<strong>di</strong>cata nell’offerta economica con riferimento al<br />
tempo, che non può essere superiore ad una percentuale<br />
che deve essere fissata nel bando <strong>di</strong> gara ed in<br />
ogni caso non superiore al 20%.<br />
Con tale sistema i due criteri <strong>di</strong> ribasso sull’importo<br />
e sul tempo potrebbero <strong>di</strong>ventare ininfluenti, nel<br />
caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso<br />
a quello massimo fissato dal bando <strong>di</strong> gara, lasciando<br />
ampio margine alle scelte <strong>di</strong>screzionali e lasciando<br />
l’Ente comunque libero <strong>di</strong> fissare il ribasso massimo<br />
consentito <strong>di</strong> volta in volta. Speriamo <strong>di</strong> non<br />
cascare dalla padella nella brace.<br />
Un cor<strong>di</strong>ale augurio <strong>di</strong> buon lavoro a tutti Voi<br />
Emanuele Doria<br />
(Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong>)<br />
3
LA SCOPERTA DI UNA STRUTTURA MEGALITICA<br />
“DOLMEN” A GALENZO AQUILEA DI SCIACCA (AG)<br />
Francesco Lo Bue<br />
Geologo, libero professionista - franco.lobue@libero.it<br />
La presente nota illustra il ritrovamento <strong>di</strong> una struttura megalitica <strong>di</strong> tipo dolmenico, ubicata nel territorio<br />
RIASSUNTO<br />
<strong>di</strong> Sciacca in un’area prossima alla strada <strong>di</strong> scorrimento veloce per Palermo, a pochi chilometri dell’abitato.<br />
La scoperta effettuata occasionalmente durante lavori <strong>di</strong> rilevamento geologico potrebbe rivestire, se confermata dalle verifiche archeologiche,<br />
un importante interesse per la storia arcaica dell’isola e aprire nuovi orizzonti sulla conoscenza delle origini <strong>dei</strong> primi inse<strong>di</strong>amenti<br />
delle popolazioni saccensi. Anche dal lato geoculturale emergono contestualmente elementi <strong>di</strong> valore geomorfologico per la<br />
presenza <strong>di</strong> una falesia calcarenitica in un contesto <strong>di</strong> erosione e modellamento in cui la mano dell’uomo preistorico si è sovrapposta<br />
a quella delle azioni <strong>di</strong> lenta evoluzione geo<strong>di</strong>namica, riferibili all’Olocene. Dopo avere collocato il sito nel suo naturale contesto morfologico<br />
e geologico, nell’articolo si accenna al quadro storico-archeologico dell’area, già particolarmente ricca <strong>di</strong> sopravvivenze archeologiche<br />
e inserita nell’ambito del bacino termale <strong>di</strong> Sciacca, con le sue numerose e <strong>di</strong>versificate sorgenti termali.<br />
This note describes the <strong>di</strong>scovery of a megalithic dolmen type structure, located in the territory of Sciacca<br />
ABSTRACT<br />
in an area next to the south-western <strong>Sicilia</strong>n highway Sciacca-Agrigento, a few kilometres from the town.<br />
The <strong>di</strong>scovery was made occasionally during the work of a geological survey and could play, if confirmed by geological testings, a major<br />
interest in the archaic history of the island and open new horizons on the knowledge of the origins of the first settlements of Sciacca<br />
population. Elements of geomorphological value also emerge on the geo-cultural side because of the presence of a calcarenitic cliff in<br />
a context of erosion and modelling in which the hand of prehistoric man superimposed on the slow evolution of the shares of<br />
Geodynamics, referring to the Holocene.After placing the site in its natural, geological and morphological context, the article alludes to<br />
the historical and archaeological area, already very rich in archaeological survivals and placed in the spa basin of Sciacca, with its<br />
many and varied thermal springs.<br />
Lineamenti geomorfologici territoriali<br />
L’area, nella quale abbiamo in<strong>di</strong>viduato la presenza<br />
<strong>di</strong> una struttura megalitica risulta ubicata nella parte<br />
Est del territorio <strong>di</strong> Sciacca in contrada Galenzo Aquilea-San<br />
Giorgio. L’intera zona, che da decenni viene<br />
in<strong>di</strong>cata dagli stu<strong>di</strong>osi come sito <strong>di</strong> frequentazione<br />
arcaica è interessata dalla presenza <strong>di</strong> importanti rinvenimenti<br />
della preistoria siciliana tra cui il Dolmen<br />
<strong>di</strong> Fimmina Morta (<strong>di</strong>stante circa un chilometro dal<br />
luogo in esame) è ubicata a Sud-Est del Monte San<br />
Calogero, luogo preistorico <strong>di</strong> notevole valore archeologico.<br />
A Ovest il paesaggio e la morfologia del territorio<br />
sono caratterizzati dalla valle del torrente Carabollace<br />
che si sviluppa in un articolato e vasto bacino<br />
a reticolo fluviale che nel passato arcaico ha favorito<br />
le prime frequentazioni dell’uomo sicano ed elimo soprattutto<br />
alla foce del Carabollace ed è stato recentemente<br />
oggetto <strong>di</strong> scavi archeologici e stu<strong>di</strong> da parte<br />
della Sovrintendenza <strong>di</strong> Agrigento e del Laboratorio <strong>di</strong><br />
Archeologia della Normale <strong>di</strong> Pisa. Ricerche che hanno<br />
consentito <strong>di</strong> ricostruire un antico approdo navale alla<br />
foce del Carabollace (IV-VI sec. d.C., ed oltre), uno<br />
<strong>dei</strong> più importanti ancoraggi <strong>di</strong> Agrigento e del Lilibeo<br />
<strong>di</strong> navi provenienti dall’Africa.<br />
A Sud il territorio è dominato dal rilievo collinare<br />
<strong>di</strong> Monte Rotondo, mentre ad Est si eleva blandamente<br />
sul fondo-valle, con i sui contorni <strong>di</strong> quadrilatero<br />
irregolare, una estesa formazione <strong>di</strong> calcarenite<br />
rossastra del Calabriano, ricca <strong>di</strong> un notevole conte-<br />
4<br />
Fig. 1. Ubicazione del sito megalitico.<br />
nuto fossile <strong>di</strong> pectini<strong>di</strong>, echini<strong>di</strong> e molluschi. Dai<br />
rilievi eseguiti si evidenzia che la formazione si estende<br />
per largo tratto verso oriente con significativi affioramenti<br />
solo in parte mascherati da modesti depositi<br />
<strong>di</strong> detrito <strong>di</strong> falda della potenza variabile <strong>di</strong> 2,00 –<br />
3,00 m. Da un punto <strong>di</strong> vista strutturale gli affioramenti<br />
mostrano una notevole quiete tettonica attestata<br />
dalla giacitura pressocchè orizzontale degli strati, a<br />
<strong>di</strong>fferenza della zona imme<strong>di</strong>atamente a Sud del monte<br />
Cronio dove si hanno frequenti rotture <strong>di</strong> pendenza<br />
attribuibili a <strong>di</strong>scontinuità strutturali. Il complesso<br />
megalitico oggetto dello stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> quota 66 m SLM,<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
icade su una formazione argillosa azzurrina <strong>di</strong> consistenza<br />
me<strong>di</strong>amente plastica che include piccoli cristalli<br />
<strong>di</strong> gesso secondario (Pliocene me<strong>di</strong>o), sottostante<br />
alle bancate <strong>di</strong> calcareniti del terrazzo marino che<br />
affiorano poco lontano, contestuali a Monte Rotondo.<br />
La posizione geografica del sito è definita dalle coor<strong>di</strong>nate:<br />
Lat 37°30’05.00”N; Long 13°09’15.35”E.<br />
Cenni storico-archeologici del territorio<br />
Abbiamo poche testimonianze documentate del<br />
Paleolitico <strong>di</strong> Sciacca, certamente, quando gli effetti<br />
della glaciazione <strong>di</strong> Wurm si estinsero definitivamente<br />
i territori della <strong>Sicilia</strong> ed in particolare quelli meri<strong>di</strong>onali,<br />
furono frequentati verosimilmente dall’uomo<br />
Sapiens, che trovò queste aree ben adatte alle necessità<br />
primor<strong>di</strong>ali della vita quoti<strong>di</strong>ana in forza soprattutto<br />
della ricchezza e <strong>di</strong>ffusione della fauna e della flora.<br />
Infatti, nella parte a Nord e Nord-Est <strong>di</strong> Sciacca sono<br />
stati ritrovati numerosi resti <strong>di</strong> cinghiali e cervi, databili<br />
in questo periodo (Politi A1 ). Negli anni sessanta<br />
una accurata esplorazione all’interno della grotta “Lisaredda”<br />
ha permesso il ritrovamento <strong>di</strong> una cospicua<br />
presenza <strong>di</strong> resti faunistici che indussero a ritenere il<br />
sito uno stanziamento cavernicolo. In una località sita<br />
tra Sciacca e Menfi – Bertolino <strong>di</strong> mare, contrada<br />
Cavarretto sono stati rinvenuti manufatti, datati nel<br />
Paleolitico inferiore, con le caratteristiche del ciottolo<br />
lavorato, riferibili alla facies della Plebble Culture e<br />
degli hacheraux (accette). Ancora a Capo San Marco,<br />
a Rocca Ficuzza, al Nadorello, a Sud del monte Kronio<br />
e nelle vicinanze della Grotta Gallo, risultano ritrovati<br />
da Giulio Perotti2 alcuni chopper (ciottoli lavorati),<br />
pietre scheggiate a forma <strong>di</strong> utensili ed amigdale.<br />
Il passaggio al Neolitico viene a manifestarsi, come<br />
testimoniano le sequenze stratigrafiche, con le prime<br />
testimonianze <strong>di</strong> manipolazione dell’argilla (prime<br />
presenze <strong>di</strong> ceramiche, seppur molto ru<strong>di</strong>mentali),<br />
nuove strategie <strong>di</strong> caccia con mezzi più perfezionati,<br />
prime coltivazioni. Secondo una serie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> con analisi<br />
ra<strong>di</strong>ometriche3 eseguite in rinvenimenti nella <strong>Sicilia</strong><br />
occidentale presso la Grotta dell’Uzzo (Tp), possiamo<br />
in<strong>di</strong>care la metà del VI millennio a.c. come la<br />
data dell’inizio della periodo Neolitico. Alcune testimonianze<br />
<strong>di</strong> stanziamenti neolitici nel territorio <strong>di</strong><br />
Sciacca vengono registrati negli anni ’60 in contrada<br />
Tranchina con frammenti <strong>di</strong> lamine, <strong>di</strong> selci o <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong>ana.<br />
Interessanti sono i rinvenimenti <strong>di</strong> ceramica<br />
1 Politi A., La preistoria dell’agro saccense, Seskera, anno I, n° 1, 1964.<br />
2 Perotti G., Nelle profon<strong>di</strong>tà del Monte Kronio, AA.VV. Le Terme <strong>di</strong><br />
Sciacca, Palermo 1996.<br />
3 D. Cocchi Genick, Manuale <strong>di</strong> Preistoria, Neolitico, volume II Octavo,<br />
Firenze 1994, pp. 270-275. M. Cipolloni Sampò, Il Neolitico nell’Italia<br />
Meri<strong>di</strong>onale e in <strong>Sicilia</strong>, in A. Gui<strong>di</strong> - M. Piperno (a cura <strong>di</strong>),<br />
Italia preistorica, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 334-365.<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Fig. 2. Schizzo pittorico del sito megalitico.<br />
monocroma rossastra (tardo neolitico) attribuiti per gli<br />
evidenti elementi cromatici e stilistici, con fini anse<br />
a tronchetto, allo stile Diana, <strong>di</strong>ffuso in tutta la <strong>Sicilia</strong><br />
(villaggio Pirrone sul Dirillo, Ragusa; Megara<br />
Hyblea, Matrensa, Biancavilla, Catania; piano Vento,<br />
Agrigento). L’archeologo-speleologo S. Tinè 4 , sempre<br />
negli anni sessanta, definisce i ritrovamenti <strong>di</strong> ceramica<br />
all’interno delle grotte del monte San Calogero:<br />
“Stile o facies del Kronio”, che risulta del tutto simile<br />
e pressoché contemporanea alla facies <strong>di</strong> Stentinello,<br />
affiorante nel siracusano ed inquadrabile sempre<br />
nel Neolitico, come i rinvenimenti <strong>di</strong> c.da San Marco.<br />
A partire del III millennio a.c. il quadro evolutivo<br />
archeologico dell’area si presenta più articolato e<br />
<strong>di</strong>versificato. In questa area Sud della <strong>Sicilia</strong> occidentale<br />
si impone come manifestazione particolarmente<br />
importante la facies del bicchiere campaniforme alla<br />
quale risulta associato nell’Isola, ma anche in tanti<br />
altri siti europei, il fenomeno della presenza dolmenica,<br />
seppur sparuta. Così scrive S. Tusa 5 sulle strutture<br />
dolmeniche siciliane e sul rapporto con la cultura<br />
del Bicchiere Campaniforme: “... in molti casi tali<br />
sepolcri, analogamente alla <strong>Sicilia</strong>, sono associati a<br />
ceramiche campaniformi offrendo utili in<strong>di</strong>cazioni a<br />
proposito della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tale tipologia al livello<br />
me<strong>di</strong>terraneo ... in questa area dell’isola riesce a<br />
penetrare portando con sé, certamente, anche valori<br />
4 Tinè S., Saggi <strong>di</strong> scavo nella Galleria del Fico della grotta “Stufe<br />
<strong>di</strong> San Calogero” sul monte Cronio <strong>di</strong> Sciacca, in Società Alpina<br />
delle Giulie, 1962; Lo stile del Cronio in <strong>Sicilia</strong> lo stile <strong>di</strong> Ghar<br />
Dalam a Malta e la successione del Neolitico nelle due isole, in Atti<br />
XIII Riun. Scient. Ist. Ital. <strong>di</strong> Preistoria e Protostoria, Siracusa-Malta<br />
22-26 Ottobre 1968, Firenze 1971.<br />
5 Tusa S., Sole, astri e preistoria in <strong>Sicilia</strong>: rapporti tra morfologia<br />
ed orientamento nelle architetture rituali siciliane dal IV millennio al<br />
II millennio a.c., rel. all’Accademia Naz. Dei Lincei, 15/05/2000, convegno<br />
“L’uomo antico ed il cosmo”.<br />
5
e caratteri simbolici e spirituali che possono avere un<br />
riflesso proprio negli orientamenti...<br />
Il megalitismo dolmenico presenta in <strong>Sicilia</strong> poche<br />
decine <strong>di</strong> evidenze, a questo proposito osserviamo che,<br />
nel contesto nazionale, solo in Puglia e in Sardegna,<br />
aree geografiche, per le loro peculiarità sismiche poco<br />
colpite da intensi terremoti, sono ancora numerose le<br />
presenze <strong>di</strong> dolmen. Cre<strong>di</strong>amo, pertanto, che questo<br />
non sia solo una casualità. Sicuramente la <strong>di</strong>ffusa<br />
antropizzazione del territorio non ha favorito, in genere,<br />
la sopravvivenza <strong>di</strong> queste antichissime strutture,<br />
che peraltro, a <strong>di</strong>fferenza delle tombe ipogeiche presentano<br />
una notevole monumentalità e risultano, pertanto,<br />
più esposte a manomissioni e danneggiamenti<br />
talvolta irreparabili, che determinano la loro scomparsa<br />
dal territorio che li ha ospitato per migliaia <strong>di</strong> anni.<br />
La scoperta del megalito <strong>di</strong> contrada Galenzo Aquilea-<br />
San Giorgio è destinata ad incrementare ulteriormente<br />
il patrimonio archeologico della città <strong>di</strong> Sciacca, ma<br />
soprattutto potrà contribuire alla ricostruzione e datazione<br />
cronologica <strong>dei</strong> siti dolmenici in <strong>Sicilia</strong> ancora<br />
non ben definiti. Sono, infatti, limitati ad una decina i<br />
ritrovamenti <strong>di</strong> dolmen stu<strong>di</strong>ati e riconosciuti come tali<br />
finora in tutta l’isola. Nella parte occidentale ne sono<br />
stati in<strong>di</strong>viduati solo due, uno a Mura Pregne, alle pen<strong>di</strong>ci<br />
del monte Castellaccio (Termini Imerese) ed un<br />
altro a Sciacca in contrada Fimmina Morta ad un chilometro<br />
circa a Sud-Est del megalito in esame <strong>di</strong> cui<br />
solo oggi viene rivelata l’esistenza.<br />
Caratteri morfometrici del megalito<br />
Si accede al sito in oggetto dalla strada statale Sciacca<br />
– Agrigento, all’altezza dello svincolo che porta in<br />
contrada San Giorgio, da qui percorrendo una stradella<br />
laterale, all’incirca in corrispondenza <strong>di</strong> un cavalcavia,<br />
ci si immette in un’area che in modo <strong>di</strong>retto evidenzia<br />
la struttura arcaica megalitica. Il sito, che ospita<br />
il dolmen, si colloca in una ristretta area <strong>di</strong> circa 300<br />
mq <strong>di</strong> forma poligonale irregolare. Da Nord è limitato<br />
da una stradella privata che immette a circa 300 mt<br />
a costruzioni ivi presenti. Nel pianoro che delimita il<br />
sito in esame si <strong>di</strong>stinguono cinque corpi lapi<strong>dei</strong> ciclopici<br />
<strong>di</strong> calcarenite giallina in parte antropizzati la cui<br />
posizione relativa non sembra occasionale come a<br />
mostrare un unico contesto sepolcrale. Verso Est emerge<br />
un corpo con una forma a cupola, scavata in modo<br />
evidente nella sua parte Sud frontale, segue la struttura<br />
megalitica in oggetto, che per <strong>di</strong>mensioni e monumentalità<br />
emerge su tutti gli altri corpi presenti. Più ad<br />
Ovest affiora un megalito <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più ridotte, ma<br />
anche questo con evidenti segni e incavi scolpiti da<br />
antica mano. Un aspetto emblematico è tutto da investigare<br />
e la presenza <strong>di</strong> altri due megaliti <strong>di</strong> natura calcarenitica:<br />
il primo con una forma a stele, posto a circa<br />
6<br />
Fig. 3. Evoluzione antropica del sito.<br />
Fig. 4. Il “dolmen” sopravvissuto.<br />
<strong>2011</strong><br />
1990<br />
tre metri dal megalito principale con evidenti segni incisi.<br />
Il secondo costituisce, approssimativamente, uno <strong>dei</strong><br />
lati perimetrali, quello Ovest, <strong>di</strong> questa area: ha una<br />
lunghezza frontale <strong>di</strong> circa 5,00 metri, con chiare tracce<br />
scolpite in negativo <strong>di</strong> forma rotondeggiante, del<br />
tutto simili a quelli degli altri corpi litologici. Nel piedritto,<br />
lato Ovest, sono rilevabili due incisioni <strong>di</strong> circa<br />
60 cm paralleli con un’altra incisione trasversale, oltre<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
a fossette circolari simili a quelle rilevate negli altri<br />
corpi litologici. Ad un dettagliato rilievo presenta una<br />
altezza <strong>di</strong> circa 3,40 metri, con una larghezza <strong>di</strong> circa<br />
4,80 metri ed una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2,40 metri circa. Sparsi<br />
in tutta l’area si rilevano, come descritto, esotici e<br />
blocchi calcarenitici antropizzati da tagli e piccole<br />
forme da decifrare evidentemente collegabili con il dolmen<br />
e numerosi interventi antropici che potrebbero<br />
essere stati prodotti da coloro che abitarono questi luoghi<br />
nell’antichità. I due piedritti verticali risultano in<br />
buono stato <strong>di</strong> conservazione, sorreggono il lastrone<br />
orizzontale che evidenzia un ce<strong>di</strong>mento nella parte centrale,<br />
causato dall’azione erosiva millenaria e dalla<br />
durabilità della struttura calcarenitica, ma anche dall’attività<br />
delle piante e <strong>dei</strong> muschi che si rinvengono<br />
nella parte superiore del lastrone orizzontale. Fortunatamente<br />
non abbiamo rilevato nell’area del ritrovamento<br />
significativi segni <strong>di</strong> alterazione antropica recente<br />
che possano aver compromesso <strong>di</strong>rettamente il dolmen<br />
sopravvissuto, oltre a quelli precedentemente descritti.<br />
Purtroppo bisogna rilevare che gli inse<strong>di</strong>amenti abitativi,<br />
posti nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze costituiscono un<br />
impatto negativo al paesaggio geoarcheologico locale<br />
togliendo non poco del primitivo fascino del sito che<br />
merita <strong>di</strong> essere adeguatamente recuperato e tutelato.<br />
Valutazioni e considerazioni<br />
comparative con altri siti dolmenici<br />
Ad un primo confronto con il dolmen <strong>di</strong> Fimmina<br />
Morta, il nuovo ritrovamento si presenta con una maggiore<br />
monumentalità e, forse, più antico. Il primo, infatti,<br />
costituito da un grande masso errante, scavato verso<br />
l’interno nella sua parte centrale per ricavarne un’area<br />
funeraria, lo possiamo classificare come un pseudodolmen.<br />
Non risponde infatti ad una caratterizzazione<br />
classica con due piedritti ed uno lastrone <strong>di</strong> copertura;<br />
inoltre, l’orientamento è determinato dalla posizione<br />
del corpo in situ e dall’andamento morfologico del<br />
declivio volto verso oriente. Al contrario la struttura<br />
megalitica <strong>di</strong> recente ritrovamento presenta, invece, una<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Tav. 1 - Morfometria del dolmen<br />
Altezza (m) Larghezza (m) Lunghezza (m)<br />
Dimensioni della struttura megalitica 3,38 2,40 4,48<br />
Piedritto sinistro 2,31 1,29 1,37<br />
Piedritto destro 2,31 2,52 Spessore<br />
Lastrone orizzontale <strong>di</strong> copertura (architrave) Lunghezza 2,46<br />
2,38<br />
Spessore<br />
2,56 1,15<br />
Litologia Calcarenite pleistocenica<br />
classica architettura dolmenica costituita da due piedritti<br />
ed un lastrone d’architrave, ed, inoltre, un orientamento<br />
Nord-Sud con <strong>di</strong>rezione assiale sul solstizio<br />
d’estate, il punto massimo <strong>di</strong> altezza del Sole. Ad un<br />
primo esame mostra tutte le caratteristiche <strong>di</strong> una struttura<br />
megalitica dolmenica, probabilmente con rituale<br />
sepolcrale, il primo rinvenimento in <strong>Sicilia</strong> occidentale,<br />
fra le pochissime nel contesto dell’area del mare<br />
Me<strong>di</strong>terraneo. Abbiamo anche notizia, non ancora verificata<br />
sul piano archeologico, <strong>di</strong> un dolmen presso il<br />
comune <strong>di</strong> Santa Margherita del quale ci riproponiamo<br />
<strong>di</strong> acquisire più ampia documentazione. Il dolmen<br />
<strong>di</strong> Mura Pregne a Termini Imerese o il dolmen <strong>di</strong> Avola<br />
nel siracusano hanno una struttura architettonica complessiva<br />
leggermente <strong>di</strong>versa. Una evidente somiglianza<br />
risulta con il dolmen <strong>di</strong> Roknia in Algeria. Gli stu<strong>di</strong><br />
archeologici, i rilievi scientifici e le analisi, che saranno<br />
eseguite dagli esperti archeologi della storia arcaica<br />
siciliana, consentiranno <strong>di</strong> eliminare le ultime indeterminazioni<br />
e incertezze sull’origine e funzione del<br />
megalito in esame. I preliminari rilievi e grafici eseguiti<br />
nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o ci hanno permesso <strong>di</strong> determinare<br />
una prima ubicazione planimetrica, spaziale e<br />
<strong>di</strong>mensionale del dolmen e <strong>dei</strong> vari corpi megalitici<br />
presenti nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, inoltre <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare<br />
alcuni tratti <strong>di</strong> forme incise nella roccia, ancora da<br />
decifrare e il loro stato <strong>di</strong> conservazione che tutto sommato<br />
mostra <strong>di</strong> avere ben reagito alla vetusta del tempo.<br />
Si deve auspicare che le osservazioni e i dati rilevati<br />
possano essere utili alle autorità preposte, alle quali<br />
sottoponiamo la seguente nota, che riteniamo possa<br />
essere presa in considerazione come un iniziale contributo<br />
per successivi stu<strong>di</strong> e aprire la strada verso un’azione<br />
<strong>di</strong> recupero e tutela del sito.<br />
L’Autore ringrazia sentitamente l’archeologo Primo<br />
Veneroso per il contributo scientifico alla ricerca e,<br />
inoltre, la prof.ssa Antonella Barone per i suoi preziosi<br />
consigli.<br />
I <strong>di</strong>segni sono a cura <strong>di</strong> Gabriella Lo Bue, le foto <strong>di</strong><br />
Francesco Lo Bue.<br />
7
Bibliografia<br />
Aureli A., Bacino termale <strong>di</strong> Sciacca (<strong>Sicilia</strong> S.O.), caratteristiche<br />
idrogeologiche e vulnerabilità, Pitagora e<strong>di</strong>trice Bologna, 1996.<br />
Bernabò Brea L., La <strong>Sicilia</strong> prima <strong>dei</strong> Greci, Milano, 1958.<br />
Bernabò Brea L., Il Neolitico e la prima civiltà <strong>dei</strong> metalli nell’Italia<br />
meri<strong>di</strong>onale, Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> sulla Magna Grecia,<br />
1962, Taranto.<br />
Bernabò Brea L., Il Neolitico me<strong>di</strong>terraneo occidentale, Sources<br />
Archéologiquesde la civilisation éuropéenne, Actes du Colloque<br />
International A.I.E.S.E.E., 1970, Bucarest.<br />
Bernabò Brea L., L’età del rame nell’Italia insulare: la <strong>Sicilia</strong> e le<br />
isole Eolie, Rassegna <strong>di</strong> Archeologia, 1988.<br />
Bovio Marconi J., Sulla <strong>di</strong>ffusione del Bicchiere Campaniforme in<br />
<strong>Sicilia</strong>, Kokalos, IX, 1963.<br />
Camerata Scovazzo R., Ricerche nel territorio <strong>di</strong> Santa Margherita<br />
Belice: materiali e documenti ine<strong>di</strong>ti, Kokalos XXIV, 1978.<br />
Caminneci V. Tra il mare ed il fiume. Dinamiche inse<strong>di</strong>ative nella <strong>Sicilia</strong><br />
occidentale in età tardo antica: il villaggio in c.da Carabollace<br />
(Sciacca). Ass. Internazionale <strong>di</strong> Archeologia Classica, 2010.<br />
Cantone S., Il dolmen <strong>di</strong> Sciacca, in “<strong>Sicilia</strong>”, n° 82, Palermo 1977.<br />
Cassar F., Storia <strong>di</strong> Sciacca dalle origini al sec XIV, ed. Acta <strong>Sicilia</strong>e,<br />
Sciacca, 1997.<br />
Ciaccio M., Sciacca. Notizie storiche e documenti. (a cura <strong>di</strong> F. Lo<br />
Bue), Ed. Storiche Saccensi, 1988.<br />
Cipolloni Sampò, M., Dolmen, “architetture preistoriche in Europa”,<br />
Roma 1990.<br />
Daniel G.E., The Megalith Buildres of Western Europe, London 1958.<br />
Grana A., Orientamenti astronomici <strong>dei</strong> Dolmen <strong>di</strong> La Masecca a<br />
Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, 2010.<br />
Lo Bue F., Geografia termale della <strong>Sicilia</strong>: principali caratteristiche<br />
idrogeologiche, tesi <strong>di</strong> laurea, 1976.<br />
Mascle G. H., Etude géologique des monts Sicani. Rivista italiana <strong>di</strong><br />
Paleontologia e Stratigrafia, Memoria XVI, Milano, 1979.<br />
Mc Connel B., Indagini preistoriche nel territorio <strong>di</strong> Ribera (Ag): le<br />
tombe dell’età del rame in contrada Castello ed a Cozzo Mastrogiovanni,<br />
<strong>Sicilia</strong>.<br />
Panorama, (settimanale), Un dolmen calamita gli archeologi in <strong>Sicilia</strong>,<br />
n° 6, 03/1963.<br />
Pellegrini E., Il mondo delle pietre giganti, in “Archeo” n° 98, aprile<br />
1993.<br />
Politi A., La Preistoria nell’agro saccense, Seskera, anno 1, n° 1,<br />
1964.<br />
Pozzi A., Megalitismo. Architettura sacra della Preistoria, Società<br />
archeologica comense, 2009.<br />
Scuderi S., I Sicani nel territorio <strong>di</strong> Santa Margherita <strong>di</strong> Belice. Atti<br />
del convegno antiche genti <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong> tra Mito, Storia e Tra<strong>di</strong>zioni.<br />
Pro-Loco “Gattopardo-Belice”, Gennaio 2000.<br />
Tinè S., Lo stile del Cronio in <strong>Sicilia</strong>, lo stile <strong>di</strong> Ghar Dalam a Malta<br />
e la successione del Neolitico nelle due isole, in Atti XIII Riunione<br />
Sc. Ital. <strong>di</strong> Preistoria e Protostoria, Siracusa-Malta 22-26 Ottobre<br />
1968, Firenze 1971.<br />
Tusa S., The Megalith Builders and Sicily, Journal Me<strong>di</strong>terraneam<br />
Stu<strong>di</strong>es, 1991.<br />
Tusa S., <strong>Sicilia</strong> Preistorica, Dario Flaccovio e<strong>di</strong>tore, Palermo 1994.<br />
Tusa S., Il megalitismo e la <strong>Sicilia</strong>, in “Prima <strong>Sicilia</strong>. Alle origini<br />
della società siciliana”, Regione <strong>Sicilia</strong>, Ass. Beni culturali, 1997.<br />
Tusa S., Sole, Astri e Preistoria in <strong>Sicilia</strong>, rel. all’Accademia Nazionale<br />
del Lincei, 15/05/2000, Convegno “L’uomo antico e il cosmo”.<br />
Veneroso P., Osservazioni tecniche sulle ceramiche campaniformi siciliane.<br />
In Tusa S. (a cura <strong>di</strong>). La preistoria del Basso Belice e<br />
della <strong>Sicilia</strong> meri<strong>di</strong>onale nel quadro della preistoria siciliana e<br />
me<strong>di</strong>terranea. Palermo 1994.<br />
Veneroso, P., Il Melqart <strong>di</strong> Sciacca e l’Adad <strong>di</strong> Selinunte, Seskera<br />
anno II, n° 4, 1996.<br />
Whitehouse R., Megakiths of the Central Me<strong>di</strong>terraneam, C. Renfrew<br />
(ed.), The Megalithic Monuments of Western Europe, London<br />
1981.<br />
Il Premio <strong>di</strong> laurea “Gaetano Ferruzza”<br />
A Sabrina Polizzi la Prima e<strong>di</strong>zione<br />
L’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong> ha istituito<br />
nel novembre del 2009, il premio <strong>di</strong> laurea intitolato<br />
ed ispirato alla memoria del Geol. Gaetano Ferruzza.<br />
Alla sua prima e<strong>di</strong>zione, il premio si è<br />
focalizzato sulla geologia marina, materia particolarmente<br />
sentita dal compianto collega. Pregevole l’accoglienza<br />
nei giovani laureati che hanno presentato<br />
numerosi elaborati, per i quali la commissione esaminatrice<br />
ha dovuto compiere un serio sforzo per operare<br />
la scelta del vincitore. La Dott.ssa Sabrina Polizzi<br />
con la tesi <strong>di</strong>laurea dal titolo “Rilievo morfo-batimetrico<br />
<strong>di</strong> un settore dell’off-shore della <strong>Sicilia</strong> Nord<br />
Occidentale me<strong>di</strong>ante analisi <strong>di</strong> dati sismo acustici”,<br />
si è aggiu<strong>di</strong>cata l’assegno <strong>di</strong> € 2.500. La commissione,<br />
presieduta dal Prof. Giovanni Randazzo dell’Università<br />
<strong>di</strong> Messina e composta dai Consiglieri Pietro<br />
Todaro, Giovanni Noto e Saro Di Raimondo, ha motivato<br />
tale scelta perchè “il lavoro presentato oltre all’originalità<br />
degli argomenti trattati utilizza una metodologia<br />
avanzata, raggiungendo risultati ottimali anche<br />
nelle refluenze pratiche”. Con l’occasione, il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> esprime i migliori auguri alla vincitrice,<br />
dando appuntamento ai giovani colleghi laureatisi<br />
nel triennio 2008-2010 alla seconda e<strong>di</strong>zione del<br />
Premio <strong>di</strong> Laurea con tema “Fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />
idrogeologico nel territorio siciliano”.<br />
8<br />
Alcuni elementi morfobatimetrici riconosciuti nell’offshore<br />
della <strong>Sicilia</strong> nord-occidentale: a) canyon presenti nel Golfo<br />
<strong>di</strong> Palermo; b) canyon presenti nel Golfo <strong>di</strong> Castellammare;<br />
c) lineamenti tettonici presenti lungo la scarpata continentale<br />
dell’offshore <strong>dei</strong> Monti <strong>di</strong> Palermo; d) frana riconosciuta<br />
lungo la scarpata continentale.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
LA “CRISI DI SALINITÀ MESSINIANA”<br />
E LE EVAPORITI SICILIANE<br />
Roberto Gulli - Dipartimento <strong>di</strong> Scienze della Terra e del Mare - Università <strong>di</strong> Palermo - robertogulli@tin.it<br />
Durante il Messiniano il bacino del Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato da un ra<strong>di</strong>cale cambiamento delle con<strong>di</strong>zio-<br />
RIASSUNTO<br />
ni ambientali. Tale cambiamento è testimoniato dalla presenza nell’area me<strong>di</strong>terranea, ed in particolare in Italia,<br />
<strong>di</strong> cospicui se<strong>di</strong>menti evaporitici (risalenti al Messiniano, Miocene sup.) la cui formazione è riconducibile alla cosiddetta Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana.<br />
I più importanti depositi evaporitici messiniani italiani sono stati rinvenuti, in affioramento e nel sottosuolo, in <strong>Sicilia</strong> (Gruppo della<br />
Gessoso-Solfifera), nella Catena Appenninica (Vena del Gesso) e nell’Italia settentrionale. La ricostruzione degli eventi deposizionali correlati<br />
alla Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana ha favorito, nel corso degli ultimi decenni, lo sviluppo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti ipotesi e modelli circa l’evoluzione<br />
paleoambientale del Me<strong>di</strong>terraneo avvenuta nel corso del tardo Miocene ed, in particolare, durante il Messiniano. Gli stu<strong>di</strong> multi<strong>di</strong>sciplinari<br />
effettuati sui depositi evaporitici, rinvenuti in varie parti del bacino me<strong>di</strong>terraneo, hanno contribuito alla ricostruzione dell’articolata storia<br />
deposizionale del Messiniano che è stata sud<strong>di</strong>visa in tre fasi principali: una fase preevaporitica (7,25-5,96 Ma), durante la quale i se<strong>di</strong>menti<br />
si sono formati in un ambiente caratterizzato da acque profonde (depositi preevaporitici); una fase evaporitica (5,96 – 5,61 Ma), durante<br />
la quale si formarono i depositi evaporitici nei bacini; ed una fase post evaporitica durante la quale si depositarono, all’inizio dello Zancleano<br />
(Pliocene inf.), i se<strong>di</strong>menti riconducibili alla facies Lago-Mare (5,61 – 5,33 Ma). La fase Lago-Mare segnò la fine della CSM e l’inizio<br />
del ritorno del Me<strong>di</strong>terraneo alle con<strong>di</strong>zioni marine normali. In <strong>Sicilia</strong>, i principali depositi evaporitici si trovano, in affioramento e nel sottosuolo,<br />
nell’area centro meri<strong>di</strong>onale (Bacino <strong>di</strong> Caltanissetta) ed occidentale dell’isola. Sotto il profilo litostratigrafico, le evaporiti siciliane<br />
afferiscono al Gruppo della Gessoso Solfifera. Questa unità, nell’ambito della successione litostratigrafica del Messiniano della <strong>Sicilia</strong>, giace<br />
sulla Fm. Tripoli (Messiniano sup., depositi preevaporitici) ed è ricoperta dalla Fm. Trubi (Pliocene inf. – me<strong>di</strong>o, depositi postevaporitici).<br />
During the Messinian, the Me<strong>di</strong>terranean basin was characterized by a drastic change of environmental con-<br />
ABSTRACT<br />
<strong>di</strong>tions. Such change is possible to see by the presence in the Me<strong>di</strong>terranean area, and specially in Italy, of<br />
appreciable evaporite se<strong>di</strong>ments (Messinian evaporites, upper Miocene) the formation of which is referable to Messinian Salinity Crisis.<br />
The most important italian messinian evaporite deposits have been found ? on the surface and subsurface ? in Sicily (Gessoso-Solfiera<br />
Group), in the Appennines (Vena del Gesso) and in the northern Italy. The reconstruction of the depositional events related to the Messinian<br />
Salinity Crisis, in recent decade, has permitted the development of various hypotheses and models about the palaeoenvironmental<br />
evolution of Me<strong>di</strong>terranean during the late Miocene and, in particular, during the Messinian. Multi<strong>di</strong>sciplinary stu<strong>di</strong>es which were done<br />
about the evaporitic deposits, found in various parts of the Me<strong>di</strong>terranean basin, have contributed to the reconstruction of the Messinian<br />
depositional history which was <strong>di</strong>vided into three main phases: pre-evaporite phase (7,25-5,96 Ma), characterized by the presence<br />
of deposits formed in deep water (pre-evaporitic deposits); evaporite phase (5,96 – 5,61 Ma), during which were formed evaporitic deposits<br />
within the basins; post-evaporite phase during which were deposited, at the start of the Zanclean (lower Pliocene), se<strong>di</strong>ments referable<br />
to the Lago-Mare facies (5,61 – 5,33 Ma). The Lago-Mare phase marked the end of MSC and start of the return of the normal<br />
marine con<strong>di</strong>tions of the Me<strong>di</strong>terranean. In Sicily, the main evaporitic deposits are located ? on the surface and subsurface ? in the southern<br />
(Caltanisseta basin) and western area of the island. The sicilian evaporites belong to the Gessoso-Solfifera Group. This unit, in the<br />
messinian lithostratigraphic succession of Sicily, is located above the Fm. Tripoli (upper Messinian, pre-evaporitic deposits) and below the<br />
Fm. Trubi (lower - middle Pliocene, post-evaporitic deposits).<br />
1. Evoluzione <strong>dei</strong> modelli<br />
interpretativi della CSM<br />
La Crisi <strong>di</strong> Salinità Messiniana, nonostante la sua<br />
breve durata (circa 700 mila anni), rappresenta un’importante<br />
fase della storia del Me<strong>di</strong>terraneo durante la<br />
quale avvennero profon<strong>di</strong> e ra<strong>di</strong>cali cambiamenti<br />
ambientali.<br />
L’interpretazione <strong>di</strong> questo evento geologico è stata<br />
caratterizzata, nel tempo, dalla coesistenza <strong>di</strong> modelli<br />
interpretativi <strong>di</strong>fferenti, a volte anche contrastanti,<br />
circa i meccanismi responsabili delle variazioni delle<br />
con<strong>di</strong>zioni ambientali preesistenti del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Variazioni chimiche e fisiche che condussero, ben presto,<br />
alla formazione <strong>di</strong> spessi e <strong>di</strong>ffusi depositi evaporitici<br />
in tutto il bacino me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Le premesse della crisi <strong>di</strong> salinità del Miocene<br />
superiore vanno ricercate in<strong>di</strong>etro nel tempo, nel Miocene<br />
me<strong>di</strong>o, quando la comunicazione tra la Parateti-<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
de ed il Me<strong>di</strong>terraneo venne interrotta a causa del sollevamento<br />
crostale prodotto dall’orogenesi alpina.<br />
Prima <strong>di</strong> allora, durante l’Oligocene, il collegamento<br />
tra il Me<strong>di</strong>terraneo e la Paratetide era ancora stabile.<br />
L’oceano della Paratetide a quel tempo rappresentava<br />
un braccio <strong>di</strong> mare settentrionale della Tetide<br />
che ricopriva parte dell’Europa centrale e l’Asia occidentale<br />
con acque poco profonde, fig. 1.<br />
Successivamente, la Paratetide venne separata ed<br />
isolata dalla Tetide a causa dell’orogenesi alpina<br />
durante la quale si formarono le catene delle Alpi, <strong>dei</strong><br />
Carpazi, delle Dinari<strong>di</strong>, ecc.<br />
Questo evento trasformò progressivamente la Paratetide<br />
in un bacino interno isolato.<br />
Occlusa la Paratetide, il Me<strong>di</strong>terraneo si trasformò<br />
in un grande bacino profondo, tributario dell’Atlantico,<br />
caratterizzato da una scarsa circolazione termoalina<br />
causata dagli scambi piuttosto limitati con le<br />
masse d’acqua atlantiche. Questi scambi si sarebbero<br />
9
ealizzati attraverso <strong>di</strong>verse vie d’acqua che collegavano<br />
l’Oceano Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo, in particolare<br />
attraverso il “Corridoio Betico” (Spagna) e il<br />
“Corridoio Rifano” (Marocco settentrionale) che erano<br />
due vie d’acqua epicontinentali (in pratica localizzate<br />
su crosta continentale) poco profonde (da alcune<br />
decine a poche centinaia <strong>di</strong> metri), figura 2.<br />
Durante il Miocene superiore, la comunicazione tra<br />
l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo s’interruppe a causa<br />
della chiusura <strong>dei</strong> corridoi d’acqua preesistenti, tra<br />
7,6Ma e 6,8Ma (secondo Martín et alii, 2000; Garcés<br />
et alii, 2001) o 6,0Ma e 5,65–5,4Ma (secondo Krijgsman<br />
et alii, 1996, 1999b; Warny et alii, 2003). Per<br />
spiegare questo evento sono state ipotizzate <strong>di</strong>verse<br />
possibili cause quali il sollevamento tettonico dell’area<br />
– come conseguenza degli eventi tettonici compressivi<br />
che innescarono o riattivarono il sollevamento<br />
delle catene circumme<strong>di</strong>terranee (Pedley e Grasso,<br />
1993; Butler et alii, 1995, 1999) – il concomitante<br />
cambiamento delle con<strong>di</strong>zioni climatiche globali che<br />
produssero un aumento del volume <strong>dei</strong> ghiacci dell’Antartide<br />
(durante il tardo Messiniano) che portò,<br />
per conseguenza, ad un abbassamento generale del<br />
livello del mare (Hsü et alii, 1973, 1978; Hodell et<br />
alii, 1986; Cita & Corselli, 1993; Robertson, 1998);<br />
il raccorciamento crostale orizzontale causato dalla<br />
formazione <strong>di</strong> falde tettoniche (Weijermars, 1988).<br />
L’entità dell’abbassamento del livello del mare a<br />
livello globale per alcuni autori raggiunse un valore<br />
<strong>di</strong> alcune decine <strong>di</strong> metri (Aharon et alii, 1993; Hodell<br />
et alii, 2001) mentre per altri un valore fino a 80 –<br />
100 m (Zhang e Scott, 1996).<br />
Malgrado l’ipotesi del sollevamento tettonico dell’area<br />
rimanga quella più accre<strong>di</strong>tata, è possibile che<br />
10<br />
Fig. 1. La paratetide durante il Miocene me<strong>di</strong>o.<br />
la concomitanza <strong>di</strong> tutti i predetti fattori abbia avuto<br />
un ruolo chiave nella determinazione del processo <strong>di</strong><br />
chiusura del collegamento tra l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo<br />
(Rouchy e Saint Martin, 1992).<br />
Questa chiusura provocò la progressiva riduzione<br />
del volume d’acqua nel Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Tale situazione condusse alla cosiddetta Crisi <strong>di</strong> Salinità<br />
Messiniana del Miocene superiore durante la quale<br />
le acque del bacino Me<strong>di</strong>terraneo passando da con<strong>di</strong>zioni<br />
normali a con<strong>di</strong>zioni ipersaline favorirono la formazione<br />
e l’accumulo <strong>di</strong> potenti depositi evaporitici.<br />
All’inizio degli anni settanta l’interpretazione dell’origine<br />
delle evaporiti me<strong>di</strong>terranee si fondava,<br />
essenzialmente, su due modelli contrapposti: il modello<br />
della soglia chiusa (Drooger, 1973; Hsü et alii,1973,<br />
1978) – secondo cui la deposizione evaporitica sarebbe<br />
avvenuta in seguito al <strong>di</strong>sseccamento completo del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo – e il modello della soglia aperta<br />
(Schmalz, 1970; Selli, 1973) in base al quale la deposizione<br />
evaporitica sarebbe avvenuta all’interno <strong>di</strong> un<br />
bacino parzialmente ristretto soggetto a perio<strong>di</strong>ca<br />
comunicazione con l’esterno e caratterizzato da un<br />
sistema <strong>di</strong> circolazione dell’acqua anti-estuario.<br />
Tra i sostenitori del modello della soglia chiusa,<br />
poi, alcuni autori ritennero che, al tempo della deposizione<br />
messiniana, la topografia del Me<strong>di</strong>terraneo<br />
fosse simile a quella attuale (Hsu et alii, 1973); altri,<br />
tra cui Nesteroff (1973), ritennero invece che i bacini<br />
profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo si fossero formati, a partire<br />
dalla fine del Messiniano, per progressiva subsidenza<br />
degli iniziali bacini superficiali in risposta alla<br />
tettonica verticale connessa alla futura fase <strong>di</strong> oceanizzazione<br />
del Me<strong>di</strong>terraneo sviluppatasi a partire dal<br />
Pliocene, figura 3.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
Fig. 2. I corridoi Betico e Rifano che collegavano l’Atlantico con il Me<strong>di</strong>terraneo prima della loro chiusura durante il Miocene<br />
superiore (da Benson et alii, 1991).<br />
g<strong>di</strong>S<br />
Fig. 3. Il Me<strong>di</strong>terraneo durante il Miocene secondo i <strong>di</strong>versi modelli interpretativi (da Ricci Lucchi, 1980).<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
11
Secondo il modello del bacino profondo <strong>di</strong>sseccato<br />
(Hsu et alii, 1973), il Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato<br />
da un contesto paleogeografico molto articolato consistente<br />
in bacini <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà<br />
sud<strong>di</strong>visi, schematicamente, in bacini ampi e profon<strong>di</strong><br />
– la cui localizzazione era quasi corrispondente a quella<br />
delle attuali aree più profonde – ed in bacini più<br />
piccoli e poco profon<strong>di</strong> principalmente marginali.<br />
Secondo questo modello la crisi <strong>di</strong> salinità si sarebbe<br />
sviluppata in due fasi: durante la prima fase le<br />
perio<strong>di</strong>che comunicazioni tra Atlantico e Me<strong>di</strong>terraneo<br />
avrebbero consentito la formazione delle brine<br />
nelle porzioni più profonde <strong>dei</strong> bacini e la conseguente<br />
deposizione <strong>di</strong> alite e <strong>di</strong> sali potassici; durante la<br />
seconda fase la completa chiusura delle comunicazioni<br />
con l’Atlantico avrebbe causato una rapida <strong>di</strong>minuzione<br />
del livello marino e la conseguente esposizione<br />
subaerea delle aree periferiche che sarebbero<br />
state erose.<br />
Le successioni evaporitiche più potenti – che raggiunsero<br />
spessori anche superiori ai 1600 m – si sarebbero<br />
formate all’interno <strong>dei</strong> bacini più profon<strong>di</strong>, mentre<br />
le successioni evaporitiche meno potenti si<br />
sarebbero formate all’interno <strong>dei</strong> bacini marginali<br />
(Hsu et alii, 1973, 1975; Cita et alii, 1978; Rouchy,<br />
1982a).<br />
I depositi evaporitici <strong>dei</strong> bacini profon<strong>di</strong> furono<br />
sud<strong>di</strong>visi in evaporiti inferiori ed evaporiti superiori.<br />
In particolare, le evaporiti inferiori comprendevano la<br />
spessa unità <strong>di</strong> sale – composta, in prevalenza, da alite<br />
ed in subor<strong>di</strong>ne anche da sali <strong>di</strong> potassio e <strong>di</strong> magnesio<br />
– sovrapposta all’unità pre-salina composta da sol-<br />
12<br />
Fig. 4. Distribuzione ed estensione <strong>dei</strong> se<strong>di</strong>menti evaporitici messiniani nel Me<strong>di</strong>terraneo (da Rouchy e Caruso, 2006).<br />
fati <strong>di</strong> calcio ed alite contenenti intercalazioni <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti<br />
non evaporitici e clastici.<br />
Alla deposizione evaporitica sarebbe seguita, alla<br />
fine del Messiniano, la deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti (post<br />
evaporitici) contenenti faune tipiche d’acque salmastre<br />
poco profonde e ad affinità paratetidea. Tali se<strong>di</strong>menti<br />
rappresentano la cosiddetta fase <strong>di</strong> “lago-mare”,<br />
definizione, quest’ultima, introdotta per la prima volta<br />
da Ruggieri (1967) per in<strong>di</strong>care l’ambiente oligoalino<br />
che si sarebbe instaurato nel Me<strong>di</strong>terraneo durante la<br />
fine del Messiniano.<br />
Alla fase <strong>di</strong> chiusura del Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe<br />
seguita, a partire dal Pliocene inferiore, la riapertura<br />
della comunicazione tra il Me<strong>di</strong>terraneo e l’Atlantico<br />
che avrebbe consentito l’ingresso <strong>di</strong> nuova acqua marina<br />
dall’Atlantico ed il ripristino delle con<strong>di</strong>zioni marine<br />
normali nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
A partire dalla seconda metà degli anni novanta,<br />
i nuovi stu<strong>di</strong> e le nuove ricerche, condotte internamente<br />
ed esternamente al bacino Me<strong>di</strong>terraneo,<br />
hanno focalizzato la loro attenzione sia sulla cronologia<br />
<strong>dei</strong> principali eventi evaporitici e sul loro contesto<br />
deposizionale, sia sui cambiamenti ambientali<br />
avvenuti in corrispondenza del passaggio tardo Messiniano/Pliocene<br />
rilanciando il <strong>di</strong>battito riguardante<br />
l’interpretazione dell’evento evaporitico messiniano,<br />
figura 4.<br />
Secondo Krijgsman et alii (1999) l’inizio della<br />
Crisi <strong>di</strong> Salinità fu un evento sincrono che coinvolse<br />
tutto il Me<strong>di</strong>terraneo 5,96 milioni d’anni fa.<br />
Durante tale crisi le acque del Me<strong>di</strong>terraneo si sarebbero<br />
mantenute allo stesso livello <strong>di</strong> quelle dell’Atlan-<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
tico e, pertanto, la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />
inferiore sarebbe avvenuta in acque profonde (circa<br />
5,96 - 5,60Ma) (Krijgsman et alii, 1999, Krijgsman e<br />
Meijer, 2008). Alla fine della deposizione del ciclo evaporitico<br />
inferiore lo spessore della colonna d’acqua<br />
sarebbe <strong>di</strong>venuto estremamente ridotto. Questo evento<br />
avrebbe coinciso con il breve episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> prosciugamento/erosione<br />
coevo alla <strong>di</strong>sconformità che in <strong>Sicilia</strong><br />
separa le evaporiti del ciclo evaporitico inferiore da<br />
quello superiore. Questa interruzione intra Messiniana<br />
sarebbe durata circa 90.000 anni.<br />
Alla deposizione delle evaporiti inferiori seguì<br />
quella delle evaporiti del ciclo superiore (5,60 -<br />
5,33Ma) in un ambiente tipo lago-mare (biofacies<br />
lago-mare) caratterizzato da faune (molluschi, ostraco<strong>di</strong><br />
e <strong>di</strong>noflagellati) ad affinità paratetidea, figura 5.<br />
L’ipotesi avanzata da Butler et alii (1996, 1999),<br />
si fonda sullo stu<strong>di</strong>o del bacino evaporitico della <strong>Sicilia</strong><br />
centrale che viene associato ad un complesso gruppo<br />
<strong>di</strong> sub-bacini poco profon<strong>di</strong> (inferiori a 200 m <strong>di</strong><br />
profon<strong>di</strong>tà) coincidenti con depressioni strutturali (sinclinali)<br />
antistanti alla catena Maghrebide. Secondo<br />
Butler et alii, 1995; Clauzon et alii, 1996 e Ri<strong>di</strong>ng et<br />
alii, 1998, la deposizione evaporitica nei bacini profon<strong>di</strong><br />
del Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe avvenuta in tempi <strong>di</strong>fferenti<br />
rispetto a quella avvenuta nel bacino siciliano.<br />
Questa <strong>di</strong>acronia, secondo l’ipotesi <strong>di</strong> Butler (1996),<br />
postdaterebbe la deposizione del ciclo evaporitico<br />
inferiore della <strong>Sicilia</strong> perché durante la deposizione<br />
evaporitica nei bacini profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo, il<br />
bacino evaporitico della <strong>Sicilia</strong> si sarebbe trovato in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> prosciugamento.<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Tale ipotesi è suffragata, secondo Butler (1996,<br />
1999), dalla presenza in <strong>Sicilia</strong> della marcata <strong>di</strong>sconformità<br />
che separa il ciclo evaporitico inferiore da<br />
quello superiore. Secondo questa ipotesi, inoltre, il<br />
rapporto geometrico <strong>di</strong> onlap delle evaporiti superiori<br />
rispetto a quelle inferiori sarebbe la conseguenza<br />
del progressivo ripristino della tavola d’acqua, nel<br />
bacino siciliano, in concomitanza della deposizione del<br />
ciclo evaporitico superiore. Secondo Butler (1996,<br />
1999), inoltre, il ritorno alle con<strong>di</strong>zioni marine normali<br />
del bacino sarebbe stato sancito (in <strong>Sicilia</strong>) dalla<br />
deposizione dell’Arenazzolo durante il tardo Messiniano.<br />
L’Arenazzolo è un se<strong>di</strong>mento post-evaporitico<br />
d’acqua profonda contenente delle faune dulcicole-salmastre,<br />
ad affinità paratetidea, che rappresenta la<br />
cosiddetta fase <strong>di</strong> lago-mare, figura 5.<br />
Secondo Clauzon et alii (1996), la deposizione evaporitica<br />
sarebbe avvenuta in due momenti <strong>di</strong>stinti. Inizialmente<br />
la deposizione avrebbe interessato i bacini<br />
marginali poco profon<strong>di</strong> (compreso il bacino della<br />
<strong>Sicilia</strong> centrale) e, successivamente, quelli profon<strong>di</strong>.<br />
Anche per questo autore, le evaporiti “profonde” postdaterebbero<br />
tutta la successione evaporitica <strong>dei</strong> bacini<br />
marginali tra cui quella del bacino della <strong>Sicilia</strong> centrale.<br />
Per Clauzon et alii (1996), durante la deposizione<br />
delle evaporiti nei bacini profon<strong>di</strong>, il bacino della <strong>Sicilia</strong><br />
centrale sarebbe stato sottoposto ad erosione subaerea,<br />
figura 5.<br />
Il modello evaporitico proposto da Ri<strong>di</strong>ng et alii<br />
(1998) si basa sullo stu<strong>di</strong>o effettuato nel bacino <strong>di</strong><br />
Sorbas (Spagna sud-orientale). Secondo questo autore,<br />
si sono succedute tre fasi evaporitiche. Durante la<br />
Fig. 5. Correlazione<br />
tra i principali eventi<br />
Messiniani secondo<br />
i vari modelli<br />
interpretativi proposti<br />
da vari autori<br />
(da Rouchy e Caruso,<br />
2006).<br />
13
prima fase sarebbe avvenuta la deposizione del gesso<br />
nei bacini marginali. Durante la seconda fase sarebbe<br />
avvenuto il prosciugamento <strong>dei</strong> bacini marginali (con<br />
erosione <strong>dei</strong> margini) e la contemporanea deposizione<br />
delle evaporiti nei bacini profon<strong>di</strong> del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
La terza fase sarebbe stata segnata dal ritorno<br />
delle con<strong>di</strong>zioni marine durante il tardo Messiniano e<br />
dalla deposizione del gesso all’interno <strong>di</strong> piccoli bacini<br />
marginali (come quello <strong>di</strong> Sorbas). Secondo Ri<strong>di</strong>ng<br />
(1998), inoltre, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lago-mare sarebbero<br />
state raggiunte, nel tardo Messiniano, solo in alcune<br />
aree marginali <strong>di</strong> limitata estensione, figura 5.<br />
Secondo le ipotesi formulate da Lu e Meyers<br />
(2006), invece, la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />
inferiore sarebbe avvenuto in un contesto dominato<br />
dall’esistenza <strong>di</strong> acque relativamente profonde, mentre<br />
la deposizione delle evaporiti del ciclo superiore<br />
si sarebbe verificata in seguito alla precipitazione <strong>dei</strong><br />
sali da salamoie marine miscelate con un significativo<br />
apporto <strong>di</strong> acque continentali (Lu et alii, 2001,<br />
2002). Per Lu e Meyers (2006), inoltre, l’abbassamento<br />
del livello del mare e gli eventi erosivi che ne conseguirono<br />
avrebbero coinvolto solo le aree marginali<br />
mentre nella parte centrale <strong>dei</strong> bacini la presenza d’acqua<br />
sarebbe stata costante.<br />
Anche per Rouchy e Caruso (2006) le fasi evaporitiche<br />
a scala me<strong>di</strong>terranea furono due. Secondo il loro<br />
modello interpretativo, le evaporiti del ciclo inferiore<br />
– contenenti calcari, gessi, spesse e massicce unità <strong>di</strong><br />
sale (alite) e <strong>di</strong> sali <strong>di</strong> potassio e <strong>di</strong> magnesio (depositatisi<br />
nei bacini più profon<strong>di</strong> ed in <strong>Sicilia</strong>) – si sarebbero<br />
deposte durante il maggiore periodo d’abbassamento<br />
del livello dell’acqua nei bacini e<br />
contemporaneamente con il principale evento erosivo<br />
<strong>dei</strong> margini. Per Rouchy e Caruso (2006), inoltre, la<br />
deposizione evaporitica nei bacini marginali ed in quelli<br />
profon<strong>di</strong> sarebbe iniziata con una lieve <strong>di</strong>acronia.<br />
Essi concordano con Butler (1995) e Krijgsman (1999)<br />
sul fatto che la <strong>di</strong>sconformità intra-messiniana – che<br />
in <strong>Sicilia</strong> separa il ciclo evaporitico inferiore da quello<br />
superiore – rappresenterebbe un importante evento<br />
erosivo avvenuto in concomitanza con il massimo<br />
abbassamento del livello dell’acqua nel bacino del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Durante la deposizione delle evaporiti del ciclo<br />
superiore il chimismo dell’acqua del Me<strong>di</strong>terraneo iniziò<br />
a cambiare – a causa dell’incremento dell’apporto<br />
d’acqua dolce nel bacino – fino a quando, alla fine<br />
del Messiniano, tutto il Me<strong>di</strong>terraneo fu caratterizzato<br />
da un ambiente dominato da acque salmastre (facies<br />
lago-mare) contenenti organismi oligoalini (Rouchy,<br />
Caruso et alii, 2006).<br />
Tale ipotesi verrebbe suggerita anche da Roveri e<br />
Manzi (2006) and Krijgsman et alii (2008) sulla base<br />
dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> alcuni bivalvi parateti<strong>dei</strong>.<br />
14<br />
Secondo Butler et alii (1995), Ri<strong>di</strong>ng et alii (1998)<br />
e Braga et alii (2006), invece, la facies lago-mare<br />
sarebbe stata determinata da localizzati fenomeni <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>luizione dell’acqua (dovuti ad apporti d’acqua dolce)<br />
contenuta all’interno <strong>dei</strong> bacini marginali.<br />
Essi ritengono, inoltre, che il ripristino nel Me<strong>di</strong>terraneo<br />
delle con<strong>di</strong>zioni marine sarebbe avvenuto<br />
durante il Messiniano superiore.<br />
Anche Grossi et alii (2008) ipotizza che durante<br />
l’evento lago-mare il Me<strong>di</strong>terraneo sarebbe stato sud<strong>di</strong>viso<br />
in vari bacini in<strong>di</strong>pendenti e che ciascuno <strong>di</strong><br />
questi, in<strong>di</strong>pendentemente dagli altri, avrebbe subito<br />
<strong>dei</strong> cambiamenti ambientali <strong>di</strong>fferenziati.<br />
È stato stimato che la fase lago-mare durò da<br />
175.000 anni (Krijgsman et alii, 1999a, b) a 250.000<br />
anni (Vai, 1997).<br />
Il record se<strong>di</strong>mentario relativo alla biofacies lagomare<br />
è costituito da una notevole varietà <strong>di</strong> litologie<br />
tra cui marne, carbonati, sabbie, conglomerati, paleosuoli,<br />
brecce (Rouchy et alii, 2001), mentre dal punto<br />
<strong>di</strong> vista paleontologico, generalmente, tale biofacies è<br />
caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> una fauna dulcicolasalmastra<br />
ad affinità paratetidea in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong> acque<br />
poco profonde con fondali prossimi all’esposizione<br />
subaerea.<br />
Se<strong>di</strong>menti caratterizzati da biofacies tipiche <strong>di</strong> lagomare<br />
sono stati ritrovati nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo<br />
centrale (bacino delle Baleari, bacino tirrenico), del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo orientale e <strong>di</strong> quello occidentale (bacino<br />
algero-provenzale), in Spagna e in Francia (bacino<br />
del Rhone), nelle isole Egee e nell’isola <strong>di</strong> Corfù.<br />
In Italia depositi ascrivibili alla facies lago-mare si<br />
ritrovano sia sul versante tirrenico sia sul versante<br />
adriatico della penisola, negli Appennini settentrionali<br />
e centrali, in Toscana (Cava Serre<strong>di</strong>, bacino <strong>di</strong> Ribolla<br />
e <strong>di</strong> Volterra), in <strong>Sicilia</strong> (Eraclea Minoa, Pasquasia-Capodarso),<br />
in Emilia Romagna e Marche.<br />
All’inizio dello Zancleano (Pliocene inferiore),<br />
l’ambiente lago-mare subì un progressivo cambiamento<br />
del proprio chimismo grazie all’apporto, nel Me<strong>di</strong>terraneo,<br />
<strong>di</strong> acqua marina proveniente dall’Atlantico.<br />
Tale evento condusse al ripristino delle normali con<strong>di</strong>zioni<br />
marine nel Me<strong>di</strong>terraneo (circa 5,2 Ma) – testimoniate<br />
dalla ricomparsa <strong>di</strong> microfaune marine e dalla<br />
scomparsa degli organismi oligoalini – e sancì la fine<br />
della crisi <strong>di</strong> salinità.<br />
Il ritorno del Me<strong>di</strong>terraneo alle con<strong>di</strong>zioni marine<br />
normali, durante il Pliocene inferiore, avvenne grazie<br />
alla riapertura dello Stretto <strong>di</strong> Gibilterra (5.33Ma, Hilgen<br />
e Langereis, 1993) ed al conseguente ripristino<br />
della comunicazione tra l’Atlantico ed il Me<strong>di</strong>terraneo<br />
(Cita, 1975a,b; Iaccarino et alii,1999; Blanc, 2002;<br />
Rouchy et alii, 2001 e 2007).<br />
Quest’apertura si sarebbe prodotta come <strong>di</strong>retta<br />
conseguenza della tettonica (Kastens, 1992; Hodell et<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
Fig. 6. Sezione interpretativa del bacino della <strong>Sicilia</strong> centrale<br />
che illustra la relazione tra le principali unità evaporitiche<br />
messiniane (da Rouchy, 1982a; Garcia-Veigas et alii, 1995).<br />
alii, 1994); <strong>di</strong> faglie trascorrenti, <strong>di</strong> faglie normali o<br />
della loro combinazione (Campillo et alii, 1992; Maldonedo,<br />
1999); come risultato della combinazione tra<br />
processi tettonici ed eustatismo.<br />
Il modello proposto da Loget et alii (2005, 2006)<br />
interpreta l’apertura dello stretto <strong>di</strong> Gibilterra come<br />
conseguenza dell’erosione regressiva, prodotta dai<br />
sistemi fluviali che sfociavano nel bacino del Me<strong>di</strong>terraneo,<br />
innescatasi in risposta all’abbassamento<br />
generale del livello del mare nel Me<strong>di</strong>terraneo. A testimonianza<br />
<strong>di</strong> ciò sono state in<strong>di</strong>viduate profonde incisioni<br />
fluviali lungo la regione me<strong>di</strong>terranea – in particolare<br />
in Spagna e in Marocco (nell’area dello stretto<br />
<strong>di</strong> Gibilterra) – e la presenza <strong>di</strong> canyons sottomarini,<br />
con orientamento E-W, nell’area dello stretto <strong>di</strong> Gibilterra<br />
(Campillo et alii,1992).<br />
La formazione <strong>di</strong> una profonda incisione in corrispondenza<br />
della soglia <strong>di</strong> Gibilterra avrebbe agito da<br />
canale <strong>di</strong> comunicazione preferenziale tra l’Atlantico<br />
ed il Me<strong>di</strong>terraneo – in concomitanza con l’innalzamento<br />
del livello dell’oceano Atlantico – che si sarebbe<br />
trasformato, nel tempo, in un ingresso permanente<br />
attraverso cui l’acqua avrebbe defluito all’interno<br />
del bacino Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
2. I depositi Messiniani in <strong>Sicilia</strong><br />
In <strong>Sicilia</strong> affiorano tra le più complete successioni<br />
evaporitiche depositatesi nel Me<strong>di</strong>terraneo. La gran<br />
parte degli affioramenti <strong>di</strong> rocce evaporitiche sono<br />
concentrati nella porzione occidentale (Santa Ninfa,<br />
Salemi, Castelvetrano, Ciminna, Baucina, Sambuchi,<br />
Petralia, Alimena, Nicosia) e centro meri<strong>di</strong>onale del-<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
l’isola (area <strong>di</strong> Caltanissetta, Agrigento, Gela, Licata,<br />
Siculiana, Cattolica Eraclea). Nella porzione orientale,<br />
invece, le evaporiti costituiscono degli affioramenti<br />
sparsi e <strong>di</strong> limitata estensione areale.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista litostratigrafico, i depositi evaporitici<br />
siciliani sono identificati dal Gruppo della Gessoso-Solfifera.<br />
Stratigraficamente, questo Gruppo poggia<br />
sui depositi preevaporitici messiniani della<br />
Formazione Tripoli (Miocene superiore) ed è ricoperta,<br />
in <strong>di</strong>scordanza, dalle calcilutiti e dalle calcisiltiti<br />
pelagiche (Formazione Trubi) del Pliocene inferiore<br />
(fase postevaporitica).<br />
Il Gruppo della Gessoso-Solfifera si <strong>di</strong>vide in due<br />
unità: un’unità evaporitica inferiore ed un’unità evaporitica<br />
superiore.<br />
L’unità evaporitica inferiore è costituita, dal basso<br />
verso l’alto, dalle seguenti litologie: 1) calcari evaporitici<br />
(calcari algali, laminiti dolomitiche, ecc.) generalmente<br />
conosciuti come “Calcare <strong>di</strong> base”, 2) gessi<br />
selenitici e laminati (in genere primari) con intercalazioni<br />
<strong>di</strong> marne gessose, 3) sali (principalmente cloruri)<br />
passanti verso l’alto e lateralmente ad argille e gessareniti.<br />
L’unità evaporitica superiore è costituita, dal basso<br />
verso l’alto, dalle seguenti litologie: 1) gessi (selenitici,<br />
balatini e clastici) intercalati da livelli argillo-sabbiosi<br />
e carbonatico-gessosi, 2) calcari bioclastici passanti<br />
verso l’alto e lateralmente a gessi, 3) sabbie<br />
argillose (Arenazzolo), figura 6.<br />
Le due unità evaporitiche sono separate da una<br />
superficie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scordanza intra-messiniana che è stata<br />
interpretata (Butler et alii, 1995; Krijgsman et alii,<br />
1999a,b) come una testimonianza <strong>di</strong> un importante episo<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> esposizione subaerea creatosi in concomitanza<br />
con la fine della deposizione dell’unità evaporitica<br />
inferiore.<br />
Litostratigrafia del Messiniano - Pliocene inferiore.<br />
- Formazione Tripoli.<br />
L’unità, già descritta da Mottura (1871) e Baldacci<br />
(1886) come una formazione <strong>di</strong>atomitica e marnoso/calcarea<br />
che si sviluppa nell’ambito della Gessoso-Solfifera<br />
<strong>di</strong> numerosissime località della <strong>Sicilia</strong>, è<br />
<strong>di</strong>ffusa anche in Calabria, Grecia e Africa settentrionale<br />
e con equivalenti perfino nell’Appennino settentrionale<br />
(Marche) e centrale (Maiella). Gli affioramenti<br />
più tipici si rinvengono nel bacino <strong>di</strong> Caltanissetta<br />
(sezione <strong>di</strong> riferimento: Falconara).<br />
In <strong>Sicilia</strong> la formazione è costituita da un’alternanza<br />
ritmica <strong>di</strong> strati <strong>di</strong>atomitici e marnoso calcarei <strong>di</strong><br />
spessore decimetrico fino a metrico. Al suo interno è<br />
riconoscibile un pattern ciclico dato dalla sovrapposizione<br />
or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> tre litotipi: marne omogenee <strong>di</strong> colore<br />
grigio-verdastro, laminiti bruno-rossastre (sapropel),<br />
laminiti biancastre (<strong>di</strong>atomiti).<br />
15
Questa ciclicità se<strong>di</strong>mentaria, controllata dalle<br />
variazioni <strong>dei</strong> parametri orbitali, consente un eccellente<br />
controllo stratigrafico. La correlazione tra le<br />
sezioni <strong>di</strong> Gibliscemi, Falconara e Capodarso fornisce<br />
un totale <strong>di</strong> 49 cicli dalla base al tetto della formazione.<br />
Nella <strong>Sicilia</strong> centrale il Tripoli si trova al tetto della<br />
Formazione Terravecchia ed è separata da questa da<br />
un limite graduale; nella <strong>Sicilia</strong> meri<strong>di</strong>onale (sezioni<br />
<strong>di</strong> Gibliscemi e Falconara), invece, il Tripoli poggia<br />
con contatto netto e concordante sulla Formazione<br />
Licata, costituita da alternanze ritmiche <strong>di</strong> marne e<br />
sapropel. Il limite, posto in corrispondenza della prima<br />
comparsa <strong>di</strong> strati <strong>di</strong>atomitici, viene a coincidere con<br />
un cambiamento nella tipologia della ciclicità se<strong>di</strong>mentaria<br />
che da bipartita passa a tripartita.<br />
Il limite superiore della formazione è dato dal passaggio<br />
netto, o localmente graduale, ai depositi basali<br />
del Gruppo della Gessoso-solfifera (rappresentati nel<br />
bacino <strong>di</strong> Caltanissetta dal Calcare <strong>di</strong> Base appartenente<br />
alla Formazione Cattolica) e coincide con l’inizio<br />
della crisi <strong>di</strong> salinità messiniana.<br />
In affioramento il Tripoli si presenta <strong>di</strong> colore bianco,<br />
friabile e leggero ed al tatto lascia una patina bianca<br />
pulverulenta.<br />
Nel sottosuolo i livelli marnosi dell’unità sono ricchi<br />
d’idrocarburi, contengono gas e sono bituminosi.<br />
Lungo la formazione possono rinvenirsi sottili strati<br />
<strong>di</strong> calcareniti tufacee (come intercalazioni), selce grigio-bruna<br />
e noduli ovoidali <strong>di</strong> zolfo <strong>di</strong>sseminati all’interno<br />
della roccia.<br />
Lo spessore della formazione è soggetto a notevoli<br />
variazioni laterali poiché da valori massimi <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />
decine <strong>di</strong> metri (fino a 60 m) si passa, entro brevi<br />
<strong>di</strong>stanze, a valori <strong>di</strong> spessore pressoché nulli.<br />
Il contenuto fossilifero comprende una ricca ittiofauna,<br />
foraminiferi planctonici e bentonici, ra<strong>di</strong>olari,<br />
<strong>di</strong>atomee e nannoplancton calcareo.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista cronostratigrafico il Tripoli è<br />
attribuito al Miocene Superiore (Messiniano preevaporitico).<br />
Gruppo della Gessoso Solfifera.<br />
Complesso evaporitico inferiore<br />
- Calcare <strong>di</strong> base.<br />
Il Calcare <strong>di</strong> Base è rappresentato da calcari, <strong>di</strong><br />
colore bianco o grigio, stratificati o da banchi massicci<br />
<strong>di</strong> spessore variabile da 1 a 15 m. La roccia<br />
contiene, localmente, pseudomorfi <strong>di</strong> alite. Il numero<br />
totale <strong>dei</strong> banchi calcarei varia da un minimo <strong>di</strong><br />
6 ad un massimo <strong>di</strong> 13. I banchi principali sono<br />
alternati a livelli (spessi da 30 a 150 cm) costituiti<br />
da marne calcaree, calcari laminati, dolomie o, più<br />
raramente, da gessi. A volte questi banchi appaiono<br />
brecciati.<br />
16<br />
Talvolta il passaggio dai banchi calcarei alle intercalazioni<br />
marnose avviene me<strong>di</strong>ante l’interposizione<br />
<strong>di</strong> ritmiti calcaree laminate.<br />
L’unità è spesso ricoperta da depositi evaporitici<br />
laminati (gesso balatino), <strong>di</strong> natura clastica (gessareniti,<br />
gessosiltiti) e/o <strong>di</strong> precipitazione primaria.<br />
Lo spessore del Calcare <strong>di</strong> Base varia da 20 a circa<br />
60 m in funzione del numero e dello spessore degli<br />
strati che lo compongono.<br />
L’area tipo del Calcare <strong>di</strong> Base è il bacino <strong>di</strong> Caltanissetta<br />
e le sezioni <strong>di</strong> riferimento si trovano in prossimità<br />
<strong>di</strong> Marianopoli, Riesi (Serra Pirciata), Caltanissetta<br />
(T. Vaccarizzo), Favara. L’unità si trova a tetto<br />
del Tripoli, con passaggio netto o, talora, graduale (per<br />
ispessimento delle intercalazioni carbonatiche e scomparsa<br />
<strong>dei</strong> livelli <strong>di</strong>atomitici), oppure ricopre in <strong>di</strong>scordanza<br />
la Formazione Terravecchia.<br />
Lateralmente e verso l’alto, questo calcare passa<br />
ad un’unità clastica – costituita da gessoru<strong>di</strong>ti, gessareniti<br />
e calcareniti – messa in posto da processi<br />
gravitativi e facente parte della Formazione <strong>di</strong> Cattolica.<br />
Il contenuto fossilifero dell’unità è scarso (rari<br />
Orbulina, Globigerinoides, resti <strong>di</strong> pesci) sebbene sono<br />
stati riconosciuti anche frammenti <strong>di</strong> vegetali terrestri<br />
e, in alcuni livelli, stromatoliti algali.<br />
L’origine del Calcare <strong>di</strong> Base è evaporitica essendosi<br />
formato nelle acque ipersaline delle porzioni periferiche<br />
del Bacino <strong>di</strong> Caltanissetta in un ambiente<br />
ristretto e perio<strong>di</strong>camente soggetto a <strong>di</strong>sseccamento.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni paleoambientali sono in linea <strong>di</strong> massima<br />
confermate dalle analisi isotopiche anche se alcuni<br />
valori non escludono processi <strong>di</strong> riduzione batterica<br />
<strong>dei</strong> solfati.<br />
Alcuni autori ipotizzano rapporti d’eteropia tra il<br />
Calcare <strong>di</strong> Base – depostosi in corrispondenza degli<br />
alti strutturali del bacino – ed il Tripoli depostosi nelle<br />
aree più depresse.<br />
L’unità è classificata come membro della Formazione<br />
<strong>di</strong> Cattolica facente parte del Gruppo della Gessoso-Solfifera.<br />
In questo litotipo è concentrata, in gran parte, la<br />
mineralizzazione solfifera (da ciò Calcare Solfifero).<br />
Questo calcare affiora <strong>di</strong>ffusamente nella zona centro<br />
meri<strong>di</strong>onale della <strong>Sicilia</strong> compresa tra Agrigento, Caltanissetta,<br />
Enna, Centuripe, Caltagirone, Gela e lungo<br />
la fascia <strong>di</strong> territorio compresa tra Ribera, Mussomeli,<br />
Nicosia e Petralia.<br />
- Gessi Inferiori (Gessi <strong>di</strong> Cattolica Eraclea).<br />
La sequenza inizia con un banco massiccio <strong>di</strong> gessi<br />
(spessore tra i 20 e i 50 m) che si susseguono uno<br />
sopra l’altro (senza intervalli pelitici) e che sono costituiti<br />
da grossi cristalli (fino a 20 - 30 cm <strong>di</strong> lunghezza)<br />
<strong>di</strong> gesso selenitico geminato. Segue una zona carat-<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
terizzata da sottili strati selenitici alternati a lamine e<br />
strati carbonatici <strong>di</strong> spessore inferiore al metro. Verso<br />
l’alto, le lamine carbonatiche <strong>di</strong>ventano progressivamente<br />
più irregolari ed ondulate, coprono i cristalli<br />
selenitici degli strati sottostanti che, a volte, le attraversano.<br />
Nel complesso i Gessi Inferiori sono composti da<br />
se<strong>di</strong>ci grossi cicli d’evaporiti che, in alcune zone della<br />
<strong>Sicilia</strong>, formano <strong>dei</strong> depositi spessi varie centinaia <strong>di</strong><br />
metri.<br />
Questi gessi sono presenti nel territorio compreso<br />
tra Casteltermini, Agrigento e Ribera (<strong>Sicilia</strong> meri<strong>di</strong>onale).<br />
- Torbi<strong>di</strong>ti gessose.<br />
Al <strong>di</strong> sopra <strong>dei</strong> gessi si rinvengono (spesso solo in<br />
profon<strong>di</strong>tà) delle torbi<strong>di</strong>ti gessose (spessore <strong>di</strong> circa<br />
70 m) composte da sabbie gessose gradate formate da<br />
elementi selenitici e, a volte, contenenti intraclasti<br />
marnosi. Queste torbi<strong>di</strong>ti sfumano, verso l’alto, in<br />
marne verdastre contenenti pirite ed un’abbondante<br />
quantità <strong>di</strong> foraminiferi.<br />
- Salgemma e sali potassico-magnesiaci.<br />
La successione litostratigrafica <strong>di</strong> questi depositi<br />
vede, dal basso verso l’alto, la presenza <strong>di</strong> uno strato<br />
basale costituito da una breccia composta d’anidrite,<br />
spesso bituminosa, con frammenti <strong>di</strong> marna nerastra.<br />
Associati alla breccia basale vi sono strati<br />
d’anidrite a lamine.<br />
Seguono superiormente i depositi salini.<br />
Il corpo salino è così composto dal basso verso<br />
l’alto:<br />
- salgemma con noduli anidritici,<br />
- salgemma con lamine molto fitte d’anidrite che,<br />
verso l’alto, <strong>di</strong>ventano sempre più sottili fino a<br />
dar luogo ad un banco <strong>di</strong> salgemma puro e compatto,<br />
- intervallo pelitico spesso alcuni decimetri,<br />
- salgemma con lamine anidritico-polialitiche<br />
molto pieghettate,<br />
- intercalazioni <strong>di</strong> strati <strong>di</strong> sali potassico-magnesiaci<br />
(con prevalenza <strong>di</strong> kainite ed in minor misura<br />
da carnallite, silvite e bischovite),<br />
- salgemma molto puro, a grana grossa, con lamine<br />
argilloso-anidritiche <strong>di</strong> aspetto stilolitico regolarmente<br />
<strong>di</strong>stanziate <strong>di</strong> 10-30 cm,<br />
- marne anidritiche <strong>di</strong> colore verde scuro e anidrite<br />
a lamine millimetriche (spessore totale <strong>di</strong> circa<br />
15 m),<br />
- salgemma con frequenti e spesse intercalazioni<br />
<strong>di</strong> lamine anidritiche.<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Questa successione rappresenta la sequenza normale<br />
delle facies saline che è stata riscontrata nell’area<br />
d’Agrigento.<br />
I depositi salini sono concentrati, principalmente,<br />
nella porzione centro meri<strong>di</strong>onale della <strong>Sicilia</strong> in corrispondenza<br />
<strong>di</strong> una vasta fascia comprendente il territorio<br />
d’Agrigento, Ribera, Racalmuto, Caltanissetta,<br />
Enna, Centuripe, Caltagirone, Gela.<br />
Lo spessore del corpo salino raggiunge i 400/500<br />
m (zona <strong>di</strong> Porto Empedocle) nelle aree dove la<br />
deformazione tettonica fu meno intensa; più <strong>di</strong> 1000<br />
m (zona <strong>di</strong> Racalmuto) dove la deformazione tettonica<br />
del corpo salino avvenne con maggiore intensità.<br />
Complesso evaporitico superiore<br />
Questo complesso è separato da quello inferiore da<br />
una netta <strong>di</strong>scordanza in corrispondenza della quale si<br />
è formato un livello <strong>di</strong> gessareniti e <strong>di</strong> calcareniti.<br />
- Gessi Superiori (Gessi <strong>di</strong> Pasquasia).<br />
I depositi gessosi sono quantitativamente inferiori<br />
rispetto ai se<strong>di</strong>menti terrigeni.<br />
Nella zona centro-meri<strong>di</strong>onale della <strong>Sicilia</strong> (zona<br />
centrale del bacino evaporitico, area compresa tra<br />
Porto Empedocle, Caltanissetta, Enna, Casteltermini,<br />
Ribera, Eraclea Minoa) il complesso evaporitico superiore<br />
è rappresentato da una successione <strong>di</strong> 7 cicli ciascuno<br />
<strong>dei</strong> quali composto (dal basso verso l’alto) da<br />
argille marnose e marne, sabbie gradate e laminate a<br />
foraminiferi planctonici, laminiti calcaree bianche,<br />
lamine millimetriche <strong>di</strong> gesso microcristallino (gesso<br />
balatino), gesso selenitico.<br />
Nella zona marginale meri<strong>di</strong>onale del bacino evaporitico<br />
(area compresa tra Caltanissetta, Piazza<br />
Armerina, Licata, Agrigento) il complesso evaporitico<br />
superiore raggiunge spessori ridotti o è completamente<br />
assente. In tal caso i Trubi poggiano <strong>di</strong>rettamente<br />
sul Calcare <strong>di</strong> Base o sui terreni sottostanti.<br />
Nella zona marginale settentrionale del bacino evaporitico<br />
(fascia compresa tra Sciacca - Ribera,<br />
Casteltermini, Nicosia) le successioni <strong>di</strong>ventano prevalentemente<br />
terrigene e sostituiscono quasi del tutto<br />
i gessi.<br />
- Arenazzolo.<br />
L’unità è prevalentemente costituita da sabbie<br />
giallo-brune <strong>di</strong> composizione arcosica e scarsamente<br />
cementate. Localmente può presentarsi come una<br />
calcarenite arenacea grossolana, poco cementata e<br />
<strong>di</strong> colore bianco-verdastra, con strutture se<strong>di</strong>mentarie<br />
trattive a piccola scala. Nelle sezioni <strong>di</strong> riferimento<br />
(Capo Rossello ed Eraclea Minoa) ubicate<br />
nell’area tipo <strong>di</strong> Agrigento alle arenarie si intercalano<br />
irregolarmente livelli argillosi. L’Arenazzolo<br />
17
giace, con limite netto, sul membro delle Marne a<br />
Congeria e su quello gessoso-marnoso (evaporiti<br />
superiori) della formazione <strong>di</strong> Pasquasia. Verso l’alto<br />
l’unità passa, ancora con limite netto, alla Formazione<br />
<strong>dei</strong> Trubi.<br />
In <strong>Sicilia</strong>, l’Arenazzolo è stato riconosciuto ampiamente<br />
in affioramento e descritto in numerosi sondaggi.<br />
Il suo spessore, fino a qualche decina <strong>di</strong> metri,<br />
mostra notevoli variazioni laterali.<br />
Il contenuto fossilifero – rappresentato soprattutto<br />
da faune rimaneggiate – comprende foraminiferi<br />
planctonici e bentonici, frammenti <strong>di</strong> briozoi ed echini<strong>di</strong>.<br />
Tra le specie autoctone sono da ricordare ostraco<strong>di</strong><br />
ad affinità paratetidea.<br />
- Formazione <strong>dei</strong> Trubi.<br />
La formazione <strong>dei</strong> Trubi affiora in numerosissime<br />
località della <strong>Sicilia</strong> ed in Calabria (fino alla Stretta<br />
<strong>di</strong> Catanzaro). In <strong>Sicilia</strong>, questa formazione giace sui<br />
depositi del Gruppo della Gessoso-Solfifera.<br />
La formazione è costituita da un’alternanza ritmica<br />
<strong>di</strong> marne (<strong>di</strong> colore grigio chiaro) e <strong>di</strong> calcari ricchi<br />
in plancton calcareo (<strong>di</strong> colore bianco). Questi litotipi<br />
sono pressoché privi <strong>di</strong> frazione terrigena. La<br />
formazione è stratificata. Gli strati posseggono uno<br />
spessore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 20-30 cm.<br />
Il contenuto in plancton calcareo è abbondante e<br />
risulta, generalmente, ben conservato e <strong>di</strong>versificato.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista cronostratigrafico l’unità è da<br />
riferire allo Zancleano (Pliocene inferiore) ed alla parte<br />
basale del Piacenziano (Pliocene me<strong>di</strong>o).<br />
In particolare, nella sezione <strong>di</strong> Eraclea Minoa, la<br />
base della formazione è riconosciuta come GSSP del<br />
limite Miocene/Pliocene e dello Zancleano.<br />
Dal basso verso l’alto, sono state <strong>di</strong>stinte nei Trubi<br />
<strong>di</strong> Capo Rossello (stratotipo del piano Zancleano del<br />
Pliocene inferiore) quattro biozone a foraminiferi<br />
planctonici (acme <strong>di</strong> Sphaeroi<strong>di</strong>nellopsis; biozona a<br />
Globorotalia margaritae; biozona <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione concomitante<br />
<strong>di</strong> Globorotalia margaritae e Globorotalia<br />
puncticulata con Globorotalia puncticulata e Sphaeroi<strong>di</strong>nellopsis,<br />
fino all’estinzione <strong>di</strong> questo genere). La<br />
formazione è stata inquadrata anche in un contesto<br />
biostratigrafico a nannofossili e sono state riconosciute<br />
le biozone ad Amaurolithus tricorniculatus, a Reticulofenestra<br />
pseudoumbilica e a Discoaster tamalis<br />
fino all’estinzione degli sfenoliti.<br />
I Trubi sanciscono la fine della deposizione evaporitica<br />
ed il ritorno nel Me<strong>di</strong>terraneo, alla fine della<br />
CSM, alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mare aperto.<br />
Ringraziamenti<br />
Ringrazio il dott. Antonio Caruso per la lettura critica<br />
del manoscritto.<br />
18<br />
Bibliografia<br />
Blanc P.L., 2006. Improved modelling of the Messinian Salinity Crisis<br />
and conceptual implications. Palaeo 238, 349-372.<br />
Govers R., Meijer P., Krijgsman W., 2009. Regional isostatic response<br />
to Messinian Salinity Crisis events. Tectonophysics 463, 109-<br />
129.<br />
Guerra-Merchán A., Serrano F. et alii, 2010. Messinian Lago-Mare<br />
deposits near the Strait of Gibraltar (Malaga Basin, S Spain).<br />
Palaeo 285, 264-276.<br />
Jolivet L., Augier R. et alii, 2006. Lithospheric-scale geodynamic context<br />
of the Messinian Salinity Crisis. Se<strong>di</strong>mentary Geology 188-<br />
189, 9-33.<br />
Manzi V., Lugli S., Ricci Lucchi F., Roveri M., 2005. Deep-water<br />
clastic evaporites deposition in the Messinian Adriatic foredeep<br />
(northern Apennines, Italy): <strong>di</strong>d the Me<strong>di</strong>terranean ever dry out?<br />
Se<strong>di</strong>mentology 52, 875-902.<br />
Mezzadri P., 1988. La serie gessoso solfifera della <strong>Sicilia</strong> ed altre<br />
memorie geo-minerarie. R. De Nicola e<strong>di</strong>tore.<br />
Rouchy J.M., Caruso A., Pierre C. et alii, 2007. The end of the Messinian<br />
salinity crisis: Evidences from the Chelif Basin (Algeria).<br />
Palaeo 254, 386-417.<br />
Rouchy J.M., Suc J.P. et alii, 2006. The Messinian Salinity Crisis<br />
revisited. Se<strong>di</strong>mentary Geology 188-189, 1-8.<br />
Rouchy J.M., Caruso A., 2006. The Messinian Salinity Crisis in the<br />
Me<strong>di</strong>terranean basin: A reassessment of the data and an integrated<br />
scenario. Se<strong>di</strong>mentary Geology 188-189, 35-67.<br />
Roveri M., Manzi V., 2006. The Messinian Salinity Crisis: loking for<br />
a new para<strong>di</strong>gm? Palaeo 238, 386-398.<br />
Schreiber B. C., Lugli S. & Babel M., 2007. Evaporites Through Space<br />
and Time. <strong>Geologi</strong>cal Society, London, Special Publications, 285,<br />
1-13.<br />
Servizio <strong>Geologi</strong>co Nazionale. Carta geologica d’Italia – 1:50.000: catalogo<br />
delle Formazioni. Quaderni del Servizio <strong>Geologi</strong>co d’Italia.<br />
SI RINNOVANO I CONSIGLI DIRETTIVI<br />
DELLE ASSOCIAZIONI GEOLOGI<br />
DI AGRIGENTO, RAGUSA E SIRACUSA<br />
AGeoAG AGRIGENTO<br />
TALMI SALVATORE – Presidente<br />
CALOGERO PECORARO – Vice Presidente<br />
ELISABETTA AGNELLO – Segretario<br />
GIUSEPPE LOMBARDO – Tesoriere<br />
DOMENICO VETRO – Consigliere<br />
ANTONIO ALBA – Consigliere<br />
GIOACCHINO VOLPE – Consigliere<br />
AGeoRG RAGUSA<br />
PIETRO SPADARO – Presidente<br />
ANTONIA CUGNO GARRANO – Vice Presidente<br />
ROSARIO ZACCARIA – Segretario<br />
DAVIDE UCCIARDO – Tesoriere<br />
ANGELO CRISCIONE - Consigliere<br />
GIANMARIO SESSA – Consigliere<br />
MICHELE ZOCCO – Consigliere<br />
AGeoSir SIRACUSA<br />
SANTO GERACITANO – Presidente<br />
ANGELO GILOTTI – Vice Presidente<br />
ANTONIO GALLITTO - Segretario<br />
ANDREA GIUNTA – Tesoriere<br />
ANTONIO SPADARO – Consigliere<br />
MARIA GIOMPAPA – Consigliere<br />
SEBASTIANO MATARAZZO – Consigliere<br />
LUCIANO ARENA – Consigliere<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2009<br />
Il sottoscritto dr. Alfredo Palmieri, Revisore Unico del suddetto<br />
<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong>, presenta la propria relazione <strong>di</strong> accompagnamento,<br />
da allegare al ren<strong>di</strong>conto generale relativo all’esercizio<br />
2009.<br />
Preliminarmente si dà atto in particolare:<br />
• <strong>di</strong> avere vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto <strong>dei</strong><br />
principi <strong>di</strong> corretta amministrazione, tenendo conto delle<br />
norme <strong>di</strong> comportamento del collegio sindacale raccomandate<br />
dall’or<strong>di</strong>ne Nazionale <strong>dei</strong> Dottori Commercialisti e degli<br />
esperti contabili;<br />
• <strong>di</strong> essere stato informato sulle delibere assunte ed in generale<br />
sull’andamento della gestione e sulla sua preve<strong>di</strong>bile evoluzione,<br />
nonché sulle operazioni <strong>di</strong> maggior rilievo effettuate<br />
dal Collegio;<br />
• <strong>di</strong> aver acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto<br />
organizzativo del Collegio e a tale riguardo non vi<br />
sono osservazioni particolari da riferire;<br />
• <strong>di</strong> aver valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e<br />
contabile, nonché l’affidabilità <strong>di</strong> quest’ultimo a rappresentare<br />
correttamente i fatti <strong>di</strong> gestione, me<strong>di</strong>ante l’ottenimento <strong>di</strong><br />
informazioni dai responsabili delle funzioni e un circoscritto<br />
esame documentale.<br />
Si è proceduto all’esame del progetto <strong>di</strong> bilancio consuntivo al<br />
31/12/2009 e della relazione del Tesoriere. A tal riguardo si è<br />
verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni<br />
<strong>di</strong> cui si è avuto conoscenza, senza osservazioni al riguardo.<br />
Il bilancio sottoposto all’attenzione del sottoscritto, redatto<br />
seguendo l’impostazione prevista dagli articoli 2424 e 2425 del<br />
Co<strong>di</strong>ce Civile, ed alle in<strong>di</strong>cazioni dell’art. 2427, è conforme alle<br />
norme contenute negli articoli 2423 e 2423 bis e tiene altresì<br />
in conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente<br />
al trattamento delle singole voci dello Stato<br />
Patrimoniale ed all’iscrizione <strong>dei</strong> ricavi, <strong>dei</strong> proventi e <strong>dei</strong> costi<br />
ed oneri nel Conto Economico. Lo schema <strong>di</strong> bilancio adottato,<br />
però, non riporta le lettere e i numeri obbligatoriamente previsti<br />
dagli articoli sopra richiamati ed è privo <strong>di</strong> nota integrativa.<br />
Il ren<strong>di</strong>conto generale dell’esercizio 2009 mostra un <strong>di</strong>savanzo<br />
<strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> € 7.862,83 che si riassume nei seguenti valori:<br />
ATTIVO:<br />
Fabbricati<br />
(al netto del f. amm. <strong>di</strong> € 60.837,76) € 319.215,58<br />
Mobili, macc. d’ufficio ecc.<br />
(al netto del f.a. <strong>di</strong> € 28.133,32) € 11.308,70<br />
Cre<strong>di</strong>ti v/Or<strong>di</strong>ni/CNG/iscritti € 119.182,92<br />
Cre<strong>di</strong>ti v/erario e <strong>di</strong>versi € 5.478,00<br />
Cre<strong>di</strong>ti per depositi cauzionali € 29,44<br />
Cassa, Banca e c/c postale € 108.561,50<br />
Ratei attivi € 202,89<br />
TOTALE ATTIVO € 563.979,03<br />
PASSIVO:<br />
Patrimonio netto € 449.621,36<br />
Debiti <strong>di</strong> finanziamento € 52.134,72<br />
Debiti <strong>di</strong> funzionamento € 29.332,23<br />
Debiti T.F.R € 39.357,89<br />
Ratei passivi € 1.395,21<br />
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO € 571.841,41<br />
Disavanzo <strong>di</strong> gestione - € 7.862,38<br />
TOTALE A PAREGGIO € 563.979,03<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Il <strong>di</strong>savanzo <strong>di</strong> gestione trova conferma nel conto economico<br />
che in<strong>di</strong>ca:<br />
RICAVI E PROVENTI: .................................... € 358.502,98<br />
COSTI DELLA GESTIONE:<br />
Personale ........................................................ € 71.718,79<br />
Materie prime e <strong>di</strong> consumo .......................... € 3.110,15<br />
Prestazioni <strong>di</strong> servizi ...................................... € 279.212/95<br />
Oneri finanziari................................................ € 19,16<br />
Imposte e tasse .............................................. € 4.241,00<br />
Ammortamenti ................................................ € 8.063,31<br />
........................................................................ € 366.365,36<br />
Disavanzo <strong>di</strong> gestione anno 2009 .............. - € 7.862,38<br />
TOTALE A PAREGGIO .................................. € 358.502,98<br />
La suddetta esposizione in<strong>di</strong>ca come i tre aspetti qualificanti<br />
siano, pur nella loro complessità e connessione, ben equilibrati,<br />
consolidati ed oggettivi.<br />
Il patrimonio ha subito un decremento <strong>di</strong> € 7.862,38 per effetto<br />
del <strong>di</strong>savanzo <strong>di</strong> gestione. Al fine della determinazione del<br />
valore del patrimonio, seppur correttamente esposto in bilancio,<br />
andrebbe tenuto conto della sua consistenza reale ben maggiore<br />
se si considera che il fabbricato <strong>di</strong> proprietà dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>Regionale</strong> è esposto al suo valore storico e non all’attuale valore<br />
<strong>di</strong> mercato, notevolmente superiore.<br />
Per quanto attiene alle principali voci dell’Attivo, si nota l’elevato<br />
valore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti verso gli iscritti che, se <strong>di</strong> vecchia data<br />
o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile recupero, andrebbero rettificati con conseguente<br />
accantonamento al Fondo Svalutazione Cre<strong>di</strong>ti, praticamente<br />
assente in bilancio. Il sottoscritto raccomanda il Consiglio ad<br />
un approfon<strong>di</strong>mento circa la eventuale staticità <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti con<br />
un’analisi per singola posizione, attivando eventuali procedure<br />
<strong>di</strong> recupero cre<strong>di</strong>to.<br />
Per ciò che riguarda la liqui<strong>di</strong>tà presente in bilancio, si evidenzia<br />
che essa si è notevolmente ridotta nel confronto con il precedente<br />
esercizio, in linea con una speculare <strong>di</strong>minuzione delle<br />
passività a breve e consolidate; Si invita il Consiglio ha valutare<br />
modalità alternative <strong>di</strong> utilizzo per una più red<strong>di</strong>tizia gestione<br />
della liqui<strong>di</strong>tà.<br />
Il risultato negativo <strong>di</strong> esercizio può essere ricondotto essenzialmente<br />
alla presenza della voce spese congressuali che incide<br />
per € 43.850,00 ed all’incremento della voce spese generali,<br />
a tali voci però sono corrisposte economie <strong>di</strong> spesa con<br />
riferimento ad altri costi, in particolare per consulenze e organi<br />
istituzionali; peraltro, va segnalato che la voce spese congressuali<br />
denota un importante vivacità dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e del suo<br />
Consiglio in tema <strong>di</strong> formazione professionale continua e approfon<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> particolari tematiche professionali.<br />
L’aspetto finanziario, dato dal confronto tra i valori <strong>di</strong> segno<br />
opposto, si presenta abbastanza sod<strong>di</strong>sfacente ed in grado <strong>di</strong><br />
permettere una gestione regolare, puntuale e rispettosa <strong>di</strong> ogni<br />
adempimento sia nei riguar<strong>di</strong> degli iscritti che <strong>dei</strong> terzi.<br />
In conclusione, per quanto precede, lo Scrivente esprime parere<br />
favorevole alla approvazione del bilancio consuntivo chiuso<br />
al 31/12/2009.<br />
Il Revisore Unico<br />
(Dr. Alfredo Palmieri)<br />
19
I dati finali del bilancio consuntivo al<br />
31/12/2009 necessitano, come sempre, <strong>di</strong><br />
ulteriori considerazioni e precisazioni al<br />
fine <strong>di</strong> meglio interpretare l’operato dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>Regionale</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong> anche in<br />
considerazione <strong>di</strong> quanto stabilito dal<br />
Consiglio Nazionale in merito alla redazione<br />
<strong>dei</strong> bilanci consuntivi.<br />
Per quanto riguarda la determinazione<br />
degli ammortamenti del 2009 si precisa<br />
quanto segue:<br />
- sul fabbricato è stata calcolata l’ottava<br />
quota costante pari ad Euro 7.604,87;<br />
il fondo ammortamento fabbricati passa<br />
da Euro 53.232,89 ad Euro 60.837,76<br />
- il conto “Attrezzature e sistemi informatici”<br />
passa da € 39.135,02 ad €<br />
39.442,02; è stata calcolata un’altra<br />
quota <strong>di</strong> ammortamento pari ad €<br />
151,44 ed è stato integralmente<br />
ammortizzato l’importo <strong>di</strong> € 307,00<br />
quale unico acquisto del 2009, per cui<br />
il relativo fondo ammortamento passa<br />
da € 27.674,88 ad € 28.133,32.<br />
La voce 1.02.001 Cre<strong>di</strong>ti verso iscritti pari<br />
ad Euro 119.185,56 è comprensiva sia <strong>dei</strong><br />
residui attivi del 2009 che <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti degli<br />
anni pregressi non ancora incassati per<br />
Albi, Elenchi speciali; il fondo svalutazione<br />
cre<strong>di</strong>ti rimane invariato ad € 2,64.<br />
20<br />
LA RELAZIONE DEL TESORIERE<br />
I cre<strong>di</strong>ti verso <strong>di</strong>versi ammontano ad €<br />
5.478,00 e sono legati ad un cre<strong>di</strong>to per<br />
contributi da terzi per € 4.965,00 e <strong>di</strong><br />
pareri <strong>di</strong> congruità che saranno poi<br />
riscossi nel 2010.<br />
I ratei attivi per € 202,89 sono relativi<br />
agli interessi attivi maturati sui c/c bancario<br />
e postale.<br />
La voce Ratei passivi, pari ad € 1.395,21<br />
si riferiscono ad interessi passivi sul<br />
mutuo maturati al 31/12/2009 ma pagati<br />
assieme alla quota capitale nel mese <strong>di</strong><br />
gennaio 2010.<br />
I debiti per T.F.R. relativamente alle due<br />
<strong>di</strong>pendenti si sono ridotti da € 52.510,32<br />
ad € 39.357,89 tenendo conto della quota<br />
<strong>di</strong> competenza 2009 ma anche per l’anticipazione<br />
del TFR concessa ad una delle<br />
2 <strong>di</strong>pendenti giustificata dall’acquisto della<br />
sua prima casa; l’importo erogato è stato<br />
<strong>di</strong> € 18.031,22.<br />
Per i debiti <strong>di</strong> funzionamento si specifica<br />
quanto segue:<br />
- I contributi previdenziali ed assistenziali<br />
ammontano ad Euro 3.468,68 comprensivi<br />
<strong>dei</strong> contributi a carico dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>;<br />
- IRPEF conto erario per € 2.393,89<br />
comprende le ritenute su professionisti<br />
cod. 1040 e ritenute <strong>dei</strong> <strong>di</strong>pendenti cod.<br />
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA<br />
CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO € 217.650,66<br />
RISCOSSIONI In c/ competenza 318.048,73 € 359.877,20<br />
In c/ residui 41.828,47<br />
PAGAMENTI In c/ competenza 374.927,07 € 468.966,36<br />
In c/ residui 94.039,29<br />
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO € 108.561,50<br />
RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti 63.321,09 € 124.990,90<br />
Esercizio in corso 61.669,81<br />
RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti 158.673,84 € 182.381,58<br />
Esercizio in corso 23.707,74<br />
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 51.170,82<br />
L’utilizzazione dell’avanzo <strong>di</strong> amministrazione per l’esercizio successivo risulta così prevista<br />
1001, versati regolarmente con F24 a<br />
gennaio del 2010;<br />
- I debiti v/ Organi Istituzionali al 31/12<br />
2009 ammontavano complessivamente<br />
ad € 8.258,17 e sono stati regolarmente<br />
pagati nel gennaio 2010;<br />
- tra i debiti <strong>di</strong>versi figurano debiti v/ la<br />
Montepaschi SERIT; ed inoltre debiti<br />
per compensi a professionisti, assicurazioni<br />
<strong>di</strong>pendenti e per imposta IRAP<br />
competenza 2009 che verrà pagata a<br />
saldo nel 2010.<br />
La voce 1.02.003 cre<strong>di</strong>ti per depositi cauzionali<br />
per Euro 29,44 rimane invariata.<br />
A fine anno il debito per il mutuo ancora<br />
da pagare per l’acquisto della nostra<br />
sede <strong>di</strong> via Lazio n. 2, ammonta ad €<br />
52.134,72, precisando che la rata relativa<br />
al secondo semestre 2009 è stata<br />
pagata nel 2010.<br />
Si precisa inoltre, che le nostre <strong>di</strong>sponibilità<br />
liquide a fine 2009 considerando il<br />
saldo del c/c bancario e postale e delle<br />
somme liquide in cassa risultavano pari<br />
ad € 108.561,50.<br />
IL TESORIERE<br />
(Dott. Geol. Saro Di Raimondo)<br />
Palermo, 23/06/2010<br />
Parte Vincolata<br />
Parte Disponibile € 51.170,82<br />
Totale Risultato <strong>di</strong> Amministrazione € 51.170,82<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE<br />
PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Differenze GESTIONE DI CASSA<br />
INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE<br />
CODICE DESCRIZIONE<br />
g<strong>di</strong>S<br />
11 001 0001 Spese riunioni Consiglio 4.000,00 4.000,00 3.186,78 813,22 4.000,00 3.186,78<br />
11 001 0002 Rimborso Att. Consiglieri 85.000,00 85.000,00 84.721,57 275,00 84.996,57 -3,43 84.721,57<br />
11 001 0003 Spese Consiglieri (Att. varie) 10.000,00 10.000,00 9.8391,90 9.839,90 -160,10 9.839,90<br />
11 001 0004 Assicurazioni 10.000,00 10.000,00 4.426,50 3.657,87 8.084,37 -1.915,63 4.426,50<br />
11 001 0005 CNG riunioni/rappresentanza 7.000,00 7.000,00 6.773,16 6.773,16 -226,84 6.773,16<br />
11 001 0006 Rimb.Convegni,Riunioni,Conf. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00<br />
11 001 0007 Rimborsi 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
11 001 0008 Congresso ORG, Part. Congr. 35,000,00 8.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00<br />
11 001 0009 Promozionali 4.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.438,20 1.438,20 -61,80 1.438,20<br />
11 001 0010 Contributi Comitati Organizzat 6.500,00 -3.500,00 3.000,00 2.445,11 2.445,11 -554,89 2.445,11<br />
11 001 AFFARI ISTITUZ. E PROMOZIONALI 191.700,00 2.850,00 194.550,00 186.881,22 4.746,09 191.627,31 -2.922,69 186.881,22<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
11 002 0001 Stipen<strong>di</strong> 54.000,00 54.000,00 54,000,00 54.000,00 54.000,00<br />
11 002 0002 Contributi 12.500,00 12.500,00 10.417,40 2.082,60 12.500,00 10.417,40<br />
11 002 0003 Indennità <strong>di</strong> fine rapporto 6.000,00 6.000,00 4.878,79 4.878,79 -1.121,21<br />
11 0020004 Assicurazioni 340,00 340,00 340,00 340,00<br />
11 002 SPESE PERSONALE 72.840,00 72.840,00 64.417,40 7.301,39 71.718,79 -1.121,21 64.417,40<br />
11 003 0001 Affitti + condominio 3.500,00 3.500,00 3.491,98 3.491,98 -8,02 3.491,98<br />
11 003 0002 Elettricità, Gas, EAS 1.700,00 250,00 1.950,00 1.940,34 1.940,34 -9,66 1.940,34<br />
11 003 0003 Manutenzione locali e attrez. 3.000,00 3.000,00 2.999,10 2.999,10 -0,90 2.999,10<br />
11 003 0004 Telefoniche 3.000,00 3.000,00 2.996,08 2.996,08 -3,92 2.996,08<br />
11 003 0005 Nettezza Urbana 500,00 -500,00<br />
11 003 0006 Spese adattamento locali 100,00 100,00 -100,00<br />
11 003 0007 Postali 6.000,00 6.000,00 5.999,25 5.999,25 -0,75 5.999,25<br />
11 003 0008 Cancelleria e stampati 2.000,00 2.000,00 1.814,15 96,00 1.910,15 -89,85 1.814,15<br />
11 003 0009 Acquisto libri, riviste, varie 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
11 003 0010 Spese contratti <strong>di</strong> servizi 3.500,00 3.500,00 3.178,94 3.178,94 -321,06 3.178,94<br />
11 003 0011 Oneri <strong>di</strong>versi (timbri) 4.500,00 4.500,00 4.473,11 4.473,11 -36,89 4.473,11<br />
11 003 0012 Consulenze e prest. prof. 13.000,00 13.000,00 12.932,71 12.932,71 -67,29 12.932,71<br />
11 003 0013 Elezioni, creaz. commissioni 9.000,00 2.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00<br />
11 003 0014 Per<strong>di</strong>te su cre<strong>di</strong>ti 2.000,00 2.000,00 -2.000,00<br />
11 003 0017 Varie 500,00 500,00 493,33 493,33 -6,67<br />
11 003 0018 Aggio Esattoria 8.000,00 8.000,00 6.231,47 6.231,47 -1.768,53 493,33<br />
11 003 0019 Pubblicità<br />
11 003 SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO 61.500,00 2.650,00 64.150,00 53.418,99 6.327,47 59.746,46 -4.403,54 53.418,99<br />
11 005 0002 Pubblicazioni non perio<strong>di</strong>che 1.000,00 -1.000,00<br />
11 005 0003 Spese spe<strong>di</strong>z.-stampa, Rivista 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00<br />
11 005 SPESE PER PUBBLICAZIONI 26.000,00 -1.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00<br />
11 006 0001 Oneri bancari 150,00 150,00 19,16 19,16 -130,84 19,16<br />
11 006 0002 Imposte su interessi attivi 190,00 190,00 -190,00<br />
11 006 0003 Altre imposte 4.500,00 4.500,00 4.241,00 4.241,00 -259,00 4.241,00<br />
11 006 0004 Interessi passivi su mutuo 3.800,00 3.800,00 3.549,33 3.549,33 -250,00 3.549,33<br />
11 006 USCITE FINANZIARIE 8.640,00 8.640,00 7.809,49 7.809,49 -830,51 7.809,49<br />
11 007 0001 Nucleo <strong>di</strong> valutazione 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
11 007 0002 Revisore <strong>dei</strong> conti 1.500,00 1.500,00 11,92 1.488,08 1.500,00 11,92<br />
11 007 ORGANI ISTITUZIONALI 2,400,00 2.400,00 11,92 2.388,08 2.400,00 11,92<br />
11 010 0001 Mutuo bancario passivo 19.250,00 19.250,00 18.810,00 18.810,20 -439,80 18.810,20<br />
11 010 MUTUI PASSIVI 19.250,00 19.250,00 18.810,00 18.810,20 -439,80 18.810,20<br />
11 TOTALE SPESE CORRENTI 382.330,00 4.500,00 386.830,00 356.349,00 20.763,03 377.112,25 -9.717,75 356.349,22<br />
13 001 0001 Acq. Imp. Macc., attezz., mobili 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00<br />
13 001 ACQUISTO BENI STRUMENTALI 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00<br />
13 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00<br />
14 001 0001 Ritenute Previd. ed assistenziali 4.251,57 686,40 4.937,97 4.937,97 4.251,57<br />
14 001 0002 Ritenute IRPEF Prof.sti 3.309,31 3.209,31 3.209,31 3.209,31<br />
14 001 0003 Trattenute sindacali 281,68 281,68 281,68<br />
14 001 0005 Ritenute IRPEF <strong>di</strong>pendenti 9.535,97 1.976,63 11.512,60 11.512,60 9.535,97<br />
14 001 0006 Uscite per contrassegni pt 1.274,00 1.274,00 1.274,00 1.274,00<br />
14 001 VERSAMENTI PER CONTO TERZI 18.270,85 2.944,71 21.215,56 21.215,56 18.270,85<br />
14 USCITE PER PARTITE DI GIRO 18.270,85 2.944,71 21.215,56 21.215,56 18.270,85<br />
TOTALE USCITE Euro 387.330,00 387.330,00 374.927,07 78.605,96 398.634,81 11.304,81 374.927,07<br />
TOTALE GENERALE Euro 387.330,00 387.330,00 398.634,81<br />
21
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE<br />
22<br />
PREVISIONI SOMME ACCERTATE Differenze GESTIONE DI CASSA<br />
INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni Previsioni Differenze<br />
CODICE DESCRIZIONE<br />
01 001 0001 Albo professionale 155.330,00 155.330,00 106,817,28 48.512,72 155,330,00 106.817,28<br />
01 001 0002 Elenco speciale 14.840,00 14.840,00 7.420,20 7.419,80 14.840,00 7.420,20<br />
01 001 0003 Tassa iscrizione Albo 23.000,00 23.000,00 12.800,00 12.800,00 -10.200,00 12.800,00<br />
01 001 0004 Tassa iscrizione Elenco Speciale 800,00 800,00 -800,00<br />
01 001 ENTRATE TRIBUTARIE 193.970,00 193.970,00 127.037,48 55.932,52 182.970,00 -11.000,00 127.037,48<br />
01 002 0001 Contributi da terzi 8.000,00 8.000,00 6.899,87 4.965,00 11.864,87 3.864,87 6.899,87<br />
01 002 0003 Varie 500,00 500,00 4.017,07 4.017,07 3.517,07 4.017.07<br />
01 002 0004 Partecipazioni a conf. e/o corsi 35.000,00 35.000,00 30.400,00 30.400,00 -4.600,00 30.400.00<br />
01 002 ENTRATE STRAORDINARIE 43.500,00 43.500,00 41.316,94 4.965,00 46.281,94 2.781,94 41.316.94<br />
01 003 0001 Pareri <strong>di</strong> congruità 149.130,00 149.130,00 128.066,94 513,00 128.579,94 -20.550,06 128.066,94<br />
01 003 0002 Certificati, Timbri, Tessere 500,00 500,00 460,00 460,00 -40,00 1460,00<br />
01 003 ENTRATE PER SERVIZI 149.630,00 149.630,00 128.526,94 513,00 129.039,94 -20.590,06 128.526,94<br />
01 004 0001 Interessi bancari c/c 30,00 30,00 8,21 2,89 11,10 -18,90 8,21<br />
01 004 0002 Interessi postali 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
01 004 ENTRATE FINANZIARIE 230,00 230,00 8,21 202,89 211,10 -18,90 8,21<br />
01 TOTALE ENTRATE CORRENTI 387.330,00 387.330,00 296.889,57 61.613,41 358.502,98 -28.827,02 296.889,357<br />
03 001 0001 Ritenute Previd. ed Assist. 4.937,97 4.937,97 4.937,97 4.937,97<br />
03 001 0002 Ritenute IRPEF Prof.sti 3.209,31 3.209,31 3.209,31 3.209,31<br />
03 001 0003 Trattenute sindacali 281,68 281,68 281,68 281,68<br />
03 001 0005 Ritenute IRPEF <strong>di</strong>pendenti 11.512,60 11.512,60 11.512,60 11.512,60<br />
03 001 0006 Entrate per contrassegni <strong>di</strong> posta 1.217,60 56,40 1.274,00 1.274,00 1.217,60<br />
03 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI 21.159,16 56,40 21.215,56 21.215,56 21.159,16<br />
03 USCITE PER PARTITE DI GIRO 21.159,16 56,40 21.215,56 21.215,56 21.159,16<br />
TOTALE ENTRATE € 387.330,00 387.330,00 318.048,73 61.669,81 379.718,54 -7.611,46 318.048,973<br />
Disavanzo <strong>di</strong> amministrazione dell’esercizio 18.916,27<br />
TOTALE GENERALE € 387.330,00 387.330,00 398.634,81<br />
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI<br />
CODICE DESCRIZIONE INIZIALI VARIAZIONI RISCOSSE DA RISCUOTERE DELL’ANNO RESIDUI FINALI<br />
21 001 0001 Albo professionale 83.576,46 37.095,46 46.481,00 48.512,72 94.993,72<br />
21 001 0002 Elenco speciale 21.204,27 4.432,23 16.772,04 7.419,80 24.191,84<br />
21 001 ENTRATE TRIBUTARIE 104.780,73 41.527,69 63.253,04 55.932,52 119.185,56<br />
21 002 0001 Contributi <strong>di</strong> terzi 4.965,00<br />
21 002 ENTRATE STRAORDINARIE 4.965,00<br />
21 003 0001 Pareri <strong>di</strong> congruità 513,00 513,00<br />
21 003 0005 Cauzione affrancatrice 29,44 29,44 29,44<br />
21 003 ENTRATE PER SERVIZI 29,44 29,44 513,00 542,44<br />
21 004 0001 Interessi attivi bancari 0,69 0,69 2,89 2,89<br />
21 004 0002 Interessi attivi postali 173,19 173,19 200,00 200,00<br />
21 004 ENTRATE FINANZIARIE 173,88 173,88 202,89 202,89<br />
21 RESIDUO ENTRATE CORRENTI 104.984,05 41.701,57 63.282,48 61.613,41 124.895,89<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
23 001 0006 Entrate per contrassegni posta 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01<br />
23 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01<br />
23 RESIDUO ENTRATE PART. DI GIRO 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01<br />
TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro 105.149,56 Euro 41.828,47 Euro 63.321,09 Euro 61.669,81 Euro 124.990,90<br />
g<strong>di</strong>S
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI<br />
CODICE DESCRIZIONE INIZIALI VARIAZIONI PAGATE DA PAGARE DELL’ANNO RESIDUI FINALI<br />
g<strong>di</strong>S<br />
31 001 0001 Spese riunioni Consiglio 201,90 201,90 813,22 813,22<br />
31 001 0002 Rimborso Att. Consiglieri 28.922,80 28.922,80 275,00 275,00<br />
31 001 0003 Spese Consiglieri (Att. varie) 484,00 484,30<br />
31 001 0004 Assicurazioni 3.657,87 3.657,87<br />
31 001 0005 CNG riunioni/rappresentanza 2.854,00 2.854,00<br />
31 001 0008 Congresso ORG, Part. Congr. 1.424,00 1.200,00 224,00 224,00<br />
31 001 0010 Contributi Comitati Organizzat 3.300,00 3.300,00<br />
31 001 SPESE PER RIMBORSI 37.187,00 36.963,00 224,00 4.746,09 4.970,00<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
31 002 0002 Contributi 2.184,47 1.757,36 427,11 2.082,60 2.509,71<br />
31 002 0003 Indennità <strong>di</strong> fine rapporto 52.510,32 18.031,22 34.479,10 4.878,79 39.357,89<br />
31 001 0004 Assicurazioni 340,00 340,00<br />
31 002 ONERI DEL PERSONALE 54.694,79 19.788,58 34.906,21 7.301,39 42.207,60<br />
31 003 0001 Residui Affitti + condominio 505,00 505,00<br />
31 003 0004 Telefoniche 621,00 621,50<br />
31 003 0008 Cancelleria e stampati 1.235,00 1.235,00 96,00 96,00<br />
31 003 0010 Spese contratti <strong>di</strong> servizi 1.155,00 1.155,00<br />
31 003 0011 Oneri <strong>di</strong>versi (timbri) 972,42 972,42<br />
31 003 0012 Consulenze e prest. prof 7.833,47 7.833,477<br />
31 003 0013 Elezioni, creaz. commissioni 250,00 250,00<br />
31 003 0014 Per<strong>di</strong>te su cre<strong>di</strong>ti 2,64 2,64 2,64<br />
31 003 0015 Ammortamenti 60.158,79 60.158,79 60.158,79<br />
31 003 0018 Aggio Esattoria 7.880,00 7.880,00 6.231,47 14.111.47<br />
31 003 SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO 80.613,82 12.572,39 68.041,43 6.327,47 74.368,90<br />
31 006 0004 Interessi passivi mutuo 1.395,21 1.395,21 1.395,21<br />
31 006 USCITE FINANZIARIE 1.395,21 1.395,21 1.395,21<br />
31 007 0001 Nucleo <strong>di</strong> valutazione 900,00 900,00 900,00 1.800,00<br />
31 007 0002 Revisore <strong>dei</strong> conti 1.599,44 1.599,44 1.488,08 1.488,08<br />
31 007 ORGANI ISTITUZIONALI 2.499,44 1.599,44 900,00 2.388,08 3.288,08<br />
31 010 0001 Mutuo bancario passivo 71.862,39 19.727,67 52.134,72 52.134,72<br />
31 010 MUTUI PASSIVI 71.862,39 19.727,67 52.134,72 52.134,72<br />
31 RESIDUO SPESE CORRENTI 248.252,65 90.651,08 157.601,57 20.763,03 178.364,60<br />
33 001 0001 Acquisto mobili e macchine uff. 734,40 734,40<br />
33 001 ACQUISTO BENI STRUMENTALI 734,40 734,40<br />
33 RESIDUO SPESE IN C/CAPITALE 734,40 734,40<br />
34 001 0001 Ritenut. Previd. Assistenziali 936,21 663,64 272,57 686,40 958,97<br />
34 001 0002 Ritenute IRPEF Prof.sti 416,40 416,40<br />
34 001 0003 Trattenute sindacali 382,34 382,34 281,68 664,02<br />
34 001 0004 Uscite partecipaz. Corsi 0,10 0,10 0,10<br />
34 001 0005 Ritenute IRPEF Dipendenti 1.991,03 1.573,77 417,26 1.976,63 2.393,89<br />
34 001 VERSAMENTI PER CONTO TERZI 3.726,08 2.653,81 1.072,27 2.944,71 4.016,98<br />
34 RESIDUO PARTITE DI GIRO 3.726,08 2.653,81 1.072,27 2.944,71 4.016,98<br />
TOTALE RESIDUI PASSIVI Euro 252.713,13 Euro 94.039,29 Euro 158.673,84 Euro 23.707,74 Euro 182.381,58<br />
IL PRESIDENTE IL TESORIERE IL SEGRETARIO<br />
(Dott. Geol. Gian Vito Graziano) (Dott. Geol. Saro Di Raimondo) (Dott. Geol. Fabio Tortorici)<br />
23
24<br />
CONTO DEL PATRIMONIO<br />
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2009<br />
(IV DIRETTIVA CEE)<br />
1 ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008<br />
01.01 IMMOBILIZZAZIONI € 330.524.28 € 338.280.59<br />
Immobilizzazioni immateriali<br />
Costi capitalizzati ZERO ZERO<br />
Immobilizzazioni materiali<br />
Fabbricati 380.053,34 380.053,34<br />
- F.do Amm.to fabbricati<br />
Mobili e macchine d’ufficio<br />
60.837,76 53.232,89<br />
Attrezzature e sistemi informatici 39.442,02 39.135,02<br />
- F.do ammortamento 28.133,32 27.674,88<br />
330.524,28 338.280,59<br />
01.02 ATTIVO CIRCOLANTE € 233.251,86 € 321.236,86<br />
€ 119.182,92 € 104.778,09<br />
01.02.01 Cre<strong>di</strong>ti verso Or<strong>di</strong>ni/CNG/Iscritti 119.185,56 104.780,73<br />
- F.do svalutazione cre<strong>di</strong>ti 2,64 2,64<br />
01.02.02 Cre<strong>di</strong>ti v/erario e <strong>di</strong>versi € 5.478,00 € -78,09<br />
01.02.03 Cre<strong>di</strong>ti per depositi cauzionali € 29,44 € 29,44<br />
01.02.04 Disponibilità liquide € 108.561,50 € 216.429,33<br />
Cassa 12.375,35 36.177,97<br />
Banche 57.550,90 107.378,45<br />
C/c/Postale 38.635,25 72.872,91<br />
Sub-totale 108.561,50 216.429,33<br />
01.03 Ratei e Risconti attivi<br />
2 PASSIVO<br />
Ratei attivi<br />
Risconti attivi<br />
€ 202,89 € 339,39<br />
TOTALE ATTIVO € 563.979,03 € 659.856,84<br />
2.01 PATRIMONIO NETTO € 441.758,98 € 449.621,36<br />
(<strong>di</strong> cui avanzo/<strong>di</strong>savanzo <strong>di</strong> gestione) - 7.862,38 57.082,93<br />
2.02 CONFERIMENTI<br />
2.03 DEBITI<br />
2.03.01 Debiti <strong>di</strong> finanziamento € 52.134,72 € 72.964,37<br />
2.03.02 Debiti <strong>di</strong> funzionamento € 29.332,23 € 83.365,58<br />
Debiti v/iscritti<br />
Fornitori ZERO 19.309,43<br />
Fatture da ricevere ZERO ZERO<br />
Debiti per trattenute sindacali 664,02 382,34<br />
Contributi previdenziali ed assistenza 3.468,68 3.120,68<br />
Irpef c/erario 2.393,89 2.407,43<br />
Organi istituzionali compensi 8.258,17 48.870,49<br />
Debiti <strong>di</strong>versi 14.547,47 9.275,21<br />
Sub-totale 29.332,23 83.365,58<br />
2.03.03 Debiti TFR € 39.357,89 € 52.510,32<br />
2.04 Ratei e Risconti passivi<br />
Ratei passivi<br />
Risconti passivi<br />
€ 1.395,21 € 1.395,21<br />
TOTALE PASSIVO € 563.979,03 € 659.856,84<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2009<br />
(IV DIRETTIVA CEE)<br />
CONTO ECONOMICO 31/12/2009 31/12/2008<br />
3 PROVENTI DELLA GESTIONE € 358.502.98 € 384.139.23<br />
03.01 PROVENTI DALLE QUOTE € 182.970.00 € 180.500.00<br />
Albo e Elenco 182.970,00 180.500,00<br />
TOTALI ALTRI PROVENTI € 175.532.98 € 203.639.23<br />
03.02 Entrate Straor<strong>di</strong>narie (Corsi) 30.400,00 10.156,69<br />
Contributi e varie 15.881,94 350,00<br />
03.02 PROVENTI DIVERSI<br />
(Pareri congruità ecc.)<br />
129.039,94 189.134,31<br />
Sopravvenienze attive 3.819,38<br />
03.03 INTERESSI ATTIVI 211,10 178,85<br />
4 COSTI DELLA GESTIONE<br />
Sub-totale 175.532,98 203.639,23<br />
04.01 PERSONALE € 71.718,79 € 70.443,98<br />
Stipen<strong>di</strong> 54.000,00 52.585,38<br />
Oneri previdenziali, assistenziali 12.500,90 12.590,29<br />
TFR 4.878,79 4.928,31<br />
Assicurazioni personale <strong>di</strong>pendenti 340,00 340,00<br />
Sub-totale 71.718,79 70.443,98<br />
04.02 ACQUISTI MAT. PRIME E DI CONSUMO € 3.110,15 € 2.773,92<br />
04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO € 279.212,95 € 241.604,68<br />
Manutenzione ed assistenza 2.999,10 1.821,360<br />
Utenze 4.936,42 5.382,61<br />
Tipografiche 25.000,00 24.952,50<br />
Assicurazioni 8.084,37 8.084,37<br />
Consulenze 12.932,71 17.752,53<br />
Organi istituzionali 142.092,94 153.020,23<br />
Spese congressuali 43.852,00 ZERO<br />
Interessi passivi mutuo 3.549,33 3.800,00<br />
Spese generali 35.768,08 26.790,84<br />
Sub-totale 279.212,95 241.604,68<br />
04.04 ONERI FINANZIARI € 19,16 € 88,61<br />
04.05 GODIMENTI BENI DI TERZI ZERO ZERO<br />
Fitti passivi ZERO ZERO<br />
04.06 TRASFERIMENTI AGLI ORDINI / CNG<br />
04.07 IMPOSTE E TASSE € 4.241,00 € 4.389,00<br />
04.08 AMMORTAMENTI € 8.063,31 € 7.756,11<br />
SVALUTAZIONE CREDITI ZERO ZERO<br />
04.09 ONERI STRAORDINARI ZERO ZERO<br />
TOTALE € 366.365,36 € 327.056,30<br />
AVANZO DISAVANZO DI GESTIONE € 7.862,38 € 57.082,93<br />
TOTALE A PAREGGIO € 358.502,98 € 384.139,23<br />
IL PRESIDENTE IL TESORIERE IL SEGRETARIO<br />
(Dott. Geol. Gian Vito Graziano) (Dott. Geol. Saro Di Raimondo) (Dott. Geol. Fabio Tortorici)<br />
25
26<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
EPAP<br />
IL PATRIMONIO PREVIDENZIALE<br />
DELL’ENTE È SEMPRE IN AUMENTO<br />
Arcangelo Pirrello<br />
Egregio Presidente, egregi Consiglieri, egregio<br />
Direttore responsabile <strong>di</strong> “<strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong>”, cari<br />
amici e colleghi,<br />
Sono a chiedervi <strong>di</strong> ospitare su <strong>Geologi</strong> <strong>di</strong> <strong>Sicilia</strong><br />
un mio intervento, contenuto nell’allegato, che servi-<br />
L’Epap e gli altri enti <strong>di</strong> previdenza<br />
sono tenuti, almeno ogni tre<br />
anni, a presentare al Ministro del<br />
Lavoro un bilancio tecnico attuariale<br />
elaborato secondo i limiti e i<br />
parametri <strong>di</strong> base imposti dal Ministero<br />
del Lavoro stesso. Si tratta <strong>di</strong><br />
uno strumento in<strong>di</strong>spensabile per la<br />
programmazione <strong>di</strong> un Ente <strong>di</strong> previdenza<br />
poiché permette <strong>di</strong> proiettare<br />
la situazione attuale d’iscritti e<br />
contributi, con le variazioni storiche<br />
registrate, in un arco si tempo<br />
più o meno lungo, in genere dai<br />
trenta ai cinquanta anni. Sulla base<br />
del bilancio tecnico attuariale un<br />
Ente <strong>di</strong> previdenza opera le proprie<br />
scelte <strong>di</strong> base in funzione, soprattutto,<br />
delle uscite (che sono sostanzialmente<br />
le rivalutazioni <strong>di</strong> legge<br />
<strong>dei</strong> montanti e le pensioni) e delle<br />
entrate (che sono i contributi e le<br />
ren<strong>di</strong>te degli investimenti). Ad<br />
esempio un ente <strong>di</strong> previdenza<br />
molto maturo che paga molte pensioni<br />
e pensioni elevate perché<br />
riguardano anche lavoratori che<br />
hanno coperto l’intero arco lavorativo<br />
- da giovani, all’età pensionabile<br />
– non può fare la stessa programmazione<br />
e le stesse scelte<br />
negli investimenti <strong>di</strong> un ente giovane<br />
come il nostro (e il nostro è il<br />
più giovane in assoluto) che ha<br />
poche uscite rispetto alle entrate<br />
perché ha ancora pochi pensionati e<br />
pensioni limitate mentre, in un<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Arcangelo Pirrello<br />
modo o nell’altro, contribuiscono<br />
tutti gli iscritti attivi.<br />
Per dare dati concreti, secondo<br />
il bilancio tecnico dell’Epap approvato<br />
dal CdA il 3 <strong>di</strong>cembre u.s., nei<br />
prossimi cinquanta anni il saldo tra<br />
le entrate e le uscite previdenziali<br />
risulta sempre positivo, il saldo tra<br />
le entrate e le uscite totali annuali<br />
risulta sempre positivo, il patrimonio<br />
della gestione previdenziale<br />
dell’Ente è sempre in aumento.<br />
Dunque dati piuttosto buoni che, in<br />
un arco <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong> cinquanta anni,<br />
fanno registrare un avanzo tecnico<br />
<strong>di</strong> gestione, attualizzato ad oggi, <strong>di</strong><br />
rà a tranquillizzare i colleghi siciliani dopo l’articolo<br />
del collega Giovanni Ventura Bordenga nell’ultimo<br />
numero della rivista. Come avrete modo <strong>di</strong> leggere,<br />
l’articolo non scende in polemica ma chiarisce la reale<br />
situazione dell’Ente. Vi ringrazio se vorrete accogliere<br />
questa mia richiesta.<br />
circa ottocento milioni <strong>di</strong> euro. È il<br />
caso <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re che questi dati sono<br />
stati ottenuti con i parametri e le<br />
limitazioni imposti dal Ministero<br />
che, a parere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi colleghi<br />
attuari, non sono proprio pessimistici.<br />
Sta <strong>di</strong> fatto però, che anche<br />
usando il massimo del pessimismo<br />
consentibile ed il massimo della<br />
prudenza, si ottiene un avanzo tecnico<br />
<strong>di</strong> gestione – per i prossimi<br />
cinquanta anni e attualizzato ad<br />
oggi – non inferiore ai quattrocento<br />
milioni <strong>di</strong> euro.<br />
Possiamo dunque <strong>di</strong>re, intanto,<br />
che le pensioni sono assicurate per i<br />
prossimi cinquanta anni e senza<br />
alcun aumento <strong>di</strong> contribuzione o<br />
<strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> servizi ed assistenza.<br />
Tranne, sia chiaro, che dopo<br />
ampio <strong>di</strong>battito, non si decida <strong>di</strong><br />
ritoccare in aumento i contributi<br />
soggettivi, ma solo per aumentare le<br />
pensioni poiché, come ormai tutti<br />
sanno, per adesso sono inadeguate<br />
al tenore <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> un professionista<br />
che non ha altro introito o pensione<br />
integrativa o pensione da altro Ente.<br />
Possiamo infine affermare che,<br />
nonostante le limitazioni sull’entità<br />
delle pensioni determinate da una<br />
legge ormai obsoleta (il d.gls<br />
103/96) che da <strong>di</strong>eci anni si tenta <strong>di</strong><br />
far emendare, l’Epap gode <strong>di</strong> ottima<br />
salute. Questa affermazione che<br />
è solo una piana inferenza sottesa a<br />
dati assolutamente oggettivi, sarà<br />
27
certamente gra<strong>di</strong>ta agli iscritti e<br />
potrà tranquillizzarli sul presente e<br />
sul futuro del loro Ente <strong>di</strong> previdenza.<br />
Credo che ce ne fosse bisogno,<br />
atteso che da circa un anno si sono<br />
martellati i siti e la posta elettronica,<br />
<strong>di</strong>ffondendo notizie errate sull’Epap.<br />
Qualcuno ha messo ad<strong>di</strong>rittura<br />
in dubbio la correttezza <strong>dei</strong><br />
bilanci dell’Epap, come se i nostri<br />
bilanci oltre che approvati dal Cda<br />
e dal Cig non fossero anche certificati<br />
da una società <strong>di</strong> revisione,<br />
controllati dal collegio sindacale<br />
che per due terzi rappresenta i<br />
ministeri vigilanti, dai Ministri del<br />
Lavoro e dell’Economia, dalla commissione<br />
ministeriale per la spesa<br />
previdenziale, dalla commissione<br />
parlamentare bicamerale <strong>di</strong> controllo<br />
sugli enti <strong>di</strong> previdenza e<br />
dalla Corte <strong>dei</strong> Conti. Certo, abbiamo<br />
avuto tre anni <strong>di</strong>fficili dovuti<br />
alla crisi globale che oltre a mettere<br />
in <strong>di</strong>fficoltà tutti gli enti <strong>di</strong> previdenza,<br />
ha messo in ginocchio ogni<br />
organizzazione economica e finanziaria<br />
e perfino interi stati. Qualcuno<br />
potrà anche chiedersi perché<br />
solo da meno <strong>di</strong> un anno si sentono<br />
tali <strong>di</strong>cerie visto che l’Epap ha sempre<br />
prontamente denunciato le <strong>di</strong>fficoltà<br />
dalla gestione finanziaria<br />
dovute alla crisi: il fallimento <strong>di</strong><br />
Lehman brothers che ci ha visti<br />
esposti per due titoli obbligazionari<br />
per un totale <strong>di</strong> 15,7 milioni è stata<br />
da me annunciata sul sito dell’Ente<br />
il 20 settembre 2008, appena cinque<br />
giorni dopo il fallimento della<br />
banca. La risposta è semplice: le<br />
elezioni del 2010.<br />
La crisi finanziaria globale:<br />
abbiamo agito non solo con trasparenza<br />
ma anche in modo attivo e<br />
con coraggio. Abbiamo capito che<br />
questa non era una semplice crisi<br />
passeggera ma una crisi <strong>di</strong> “sistema”<br />
e ci siamo dotati <strong>di</strong> nuove procedure<br />
per investire in modo più<br />
consapevole, attivo dal punto <strong>di</strong><br />
vista della gestione del rischio e<br />
soprattutto con <strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> serrati<br />
controlli in tempo reale. Ormai,<br />
infatti, non ci si può fidare che <strong>dei</strong><br />
28<br />
controlli severi e tempestivi: non si<br />
può fare affidamento sulle garanzie<br />
fornite dalle banche perchè tutte le<br />
banche, anche le più grosse, falliscono<br />
né si può fare affidamento<br />
sui dati forniti dalle società <strong>di</strong><br />
rating, anche le più quotate. Tutto<br />
questo noi e gli altri enti, prima<br />
della crisi non potevamo saperlo,<br />
come nessun altro lo ha saputo.<br />
La nuova strategia d’investimento<br />
è stata sviluppata durante<br />
tutto il 2009, un anno nel quale<br />
abbiamo avuto una gestione finanziaria<br />
positiva e pari al 3,39%,<br />
come si evince nel bilancio consuntivo.<br />
L’Epap, però, così come tutti<br />
gli Enti <strong>di</strong> Previdenza privati,<br />
risponde alla norma civilistica (art.<br />
2426 del Co<strong>di</strong>ce Civile) per la<br />
quale i titoli sono iscritti in bilancio<br />
al minore tra costo <strong>di</strong> acquisto e<br />
valore <strong>di</strong> mercato, ed è questo che<br />
ha penalizzato pesantemente il<br />
bilancio consuntivo 2009 che è<br />
uscito con un avanzo d’amministrazione<br />
negativo e pari a -9.202.100.<br />
Di contro, lo stesso art. 2426 del<br />
C.C. prescrive che “tale minor<br />
valore non può essere mantenuto<br />
nei successivi bilanci se ne sono<br />
venuti meno i motivi”; pertanto<br />
l’EPAP ha registrato il recupero <strong>di</strong><br />
valore <strong>dei</strong> titoli al 31.12.2009<br />
rispetto al valore delle svalutazioni<br />
prima accantonate. Nessun artificio,<br />
dunque, l’Epap ha solo ubbi<strong>di</strong>to<br />
a una norma <strong>di</strong> legge. Simile<br />
ragionamento vale per la svalutazione<br />
cre<strong>di</strong>ti per 7.464.092: una<br />
mo<strong>di</strong>fica regolamentare ha, infatti,<br />
reso maggiormente restrittivi i trattamenti<br />
previdenziali per coloro<br />
che non sono in regola con la contribuzione<br />
(l’iscritto non in regola<br />
con il pagamento <strong>dei</strong> contributi non<br />
ha <strong>di</strong>ritto alla corrispondente prestazione).<br />
Ciò ha reso necessario<br />
l’adeguamento della svalutazione<br />
<strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti per il contributo soggettivo<br />
prima accantonato e non più<br />
esposto a rischio.Va da sé che un<br />
bilancio si può leggere come si<br />
vuole; noi lo leggiamo nello stesso<br />
modo <strong>dei</strong> Ministeri e degli altri<br />
organi <strong>di</strong> controllo. Altri arrivano<br />
semplicemente a sommare gli<br />
avanzi d’amministrazione e le per<strong>di</strong>te<br />
senza conteggiare gli introiti,<br />
che pure ci sono stati nonostante la<br />
crisi, quadruplicando così le per<strong>di</strong>te<br />
effettive.<br />
A produrre <strong>di</strong>sinformazione<br />
sugli enti <strong>di</strong> previdenza ci si mettono<br />
anche i giornali economici che,<br />
pure accre<strong>di</strong>tati <strong>di</strong> grande competenza<br />
(sole 24 ore e italia oggi), non<br />
<strong>di</strong>sdegnano <strong>di</strong> cercare “l’uomo che<br />
morde il cane” che fa notizia e fa<br />
vendere i giornali e non viceversa:<br />
che non fa notizia.<br />
E allora ecco le pagelle <strong>di</strong> comparazione<br />
tra enti non comparabili,<br />
i risultati <strong>dei</strong> bilanci degli enti,<br />
anch’essi non comparabili perché,<br />
ad esempio, alcuni Enti hanno<br />
legittimamente ritenuto <strong>di</strong> approfittare<br />
della legge 185 <strong>di</strong> fine 2008<br />
che dava facoltà <strong>di</strong> contabilizzare<br />
in bilancio i titoli mobiliari al valore<br />
della fine del 2007 (ante crisi),<br />
mentre altri Enti (come l’Epap), per<br />
grande trasparenza, non ne hanno<br />
approfittato ed hanno contabilizzato<br />
i titoli al valore reale. Ultimamente<br />
sono arrivati a scrivere (sole<br />
24 ore del 10/12/2010) che Epap ed<br />
altri Enti avevano acquistato azioni<br />
della Lehman brothers, spacciando<br />
la sottoscrizione <strong>di</strong> obbligazioni a<br />
basso rischio come azioni del<br />
colosso bancario statunitense fallito.<br />
Anch’io, in qualità <strong>di</strong> semplice<br />
iscritto, se avessi letto – e sul sole<br />
24 ore – che il mio ente ha investito<br />
in azioni della Lemahnn Brothers,<br />
sarei saltato in aria (e avrei<br />
dato ragione a chi <strong>di</strong>ce che ci comportiamo<br />
come una banca d’affari).<br />
Grave, gravissimo, nonostante la<br />
successiva errata correge dello<br />
stesso quoti<strong>di</strong>ano che pochissimi<br />
avranno letto, relegata com’era in<br />
un angoletto. Epap non ha mai<br />
comprato azioni lehman brothers;<br />
e non solo non si trattava d’azioni<br />
ma d’obbligazioni, ma non erano<br />
nemmeno titoli ad alto rischio,<br />
bensì a basso rischio; si trattava,<br />
infatti, <strong>di</strong> due strumenti a capitale<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
garantito da lehman brothers hol<strong>di</strong>ng<br />
che fino al giorno prima del<br />
fallimento era accre<strong>di</strong>tata <strong>di</strong> un<br />
rating altissimo (la tripla A). E che<br />
<strong>di</strong>re, poi, <strong>di</strong> parlamentari che<br />
riprendono le notizie errate e ne<br />
fanno interrogazioni in parlamento?<br />
Nulla, naturalmente, ai sensi<br />
dell’Art. 67 della costituzione “Ogni<br />
membro del parlamento rappresenta<br />
la Nazione…”, dunque ha il <strong>di</strong>ritto/dovere<br />
<strong>di</strong> presentare tutte le<br />
interrogazioni parlamentari che<br />
vuole, anche “…senza vincolo <strong>di</strong><br />
mandato”, come abbiamo visto <strong>di</strong><br />
recente. E allora mi trovo nella<br />
strana situazione <strong>di</strong> ringraziare il<br />
Senatore Lannutti per le due interrogazioni<br />
presentate e la stampa<br />
(sole e italia) - per averle riprese<br />
con grande enfasi perché così, contrariamente<br />
alla mia natura che è<br />
quella <strong>di</strong> lavorare per l’Ente piuttosto<br />
<strong>di</strong> occuparmi delle polemiche,<br />
ho dovuto rispondere ad ogni falsa<br />
affermazione che da meno <strong>di</strong> un<br />
anno infanga l’immagine dell’Ente.<br />
L’ho fatto sul sito dell’Epap. Prego<br />
i colleghi geologi siciliani <strong>di</strong> consultarlo.<br />
E voglio pure togliermi un<br />
altro sassolino: durante le elezioni<br />
le password, agli iscritti siciliani,<br />
sono arrivate in ritardo per via <strong>di</strong> un<br />
grave ritardo postale per il quale è<br />
stato avviato un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
rivalsa nei confronti delle poste;<br />
ebbene, qualcuno si chiede perché<br />
le password non sono state inviate<br />
(peraltro risparmiando) nello stesso<br />
plico contenente le schede elettorali<br />
che, invece, sono arrivate in<br />
tempo; rispondo rassicurandovi che<br />
non sono improvvisamente rimbecillito:<br />
ho già spiegato in una<br />
comunicazione sul sito che, mentre<br />
le schede le abbiamo inviate a cura<br />
dell’Epap, per intuibili motivi <strong>di</strong><br />
sicurezza, le password sono state<br />
costruite e confezionate in segretezza<br />
dalla società che si è occupata<br />
del voto elettronico, in un luogo<br />
assolutamente segreto che nessuno<br />
dell’Epap (men che meno il presidente)<br />
conosce e, naturalmente,<br />
sono state spe<strong>di</strong>te a cura della stes-<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
sa società, con procedure e tempi<br />
del tutto estranee all’Epap; la stessa<br />
lettera <strong>di</strong> accompagnamento<br />
dove si spiegavano le modalità, a<br />
firma del presidente dell’Epap era<br />
un formato pdf già firmato e fornito<br />
prima. La prima e unica volta<br />
che il sottoscritto ha visto una <strong>di</strong><br />
quelle buste è stata quando è arrivata<br />
(in ritardo) nel proprio stu<strong>di</strong>o e<br />
l’ha votata.<br />
Infine, a chi giovano tutte queste<br />
calunnie che sporcano l’immagine<br />
degli Enti <strong>di</strong> previdenza privati?<br />
È necessario chiederselo per non<br />
avere reazioni sproporzionate. Analizziamo<br />
i fatti.<br />
La crisi mobiliare ha colpito<br />
ogni stato, ente locale e organizzazione<br />
economica; anche gli Enti<br />
privati naturalmente, che sono state<br />
le prime vittime <strong>di</strong> un sistema bancario<br />
non sufficientemente controllato<br />
dagli stati. Orbene, nel nostro<br />
Paese, lo Stato non solo non <strong>di</strong>fende<br />
gli Enti con alcuna azione <strong>di</strong><br />
rivalsa giu<strong>di</strong>ziaria o extra giu<strong>di</strong>ziaria<br />
ma rivolge agli Enti stessi generiche<br />
raccomandazioni alla “prudenza”<br />
guardandosi bene, come del<br />
resto in passato, dal dare precise e<br />
cogenti <strong>di</strong>rettive su come investire<br />
e lasciando così intatta agli Enti la<br />
responsabilità <strong>di</strong> altre eventuali<br />
ripercussioni negative. Le conclusioni<br />
cui è giunta l’indagine conoscitiva<br />
della commissione bicamerale<br />
e cioè che le “casse <strong>di</strong> previdenza<br />
private non devono privilegiare<br />
la red<strong>di</strong>tività a qualunque<br />
costo: l’importante è preservare i<br />
patrimoni che sono finalizzati a<br />
pagare le pensioni degli iscritti”<br />
sono certamente con<strong>di</strong>visibili in<br />
termini <strong>di</strong> enunciazione <strong>di</strong> principio,<br />
ma non escludono che gli Enti<br />
previdenziali privati abbiano finora<br />
seguito il principio medesimo.<br />
Negli Enti ex d.lgs. 103/96 a contribuzione<br />
pura come l’Epap, ad<br />
esempio, abbiamo sempre seguito<br />
tale principio; anche perché <strong>di</strong><br />
eventuali plus valenze non sappiamo<br />
che farcene poiché, per legge,<br />
non possiamo usarle per impingua-<br />
re i montanti in<strong>di</strong>viduali e aumentare<br />
le pensioni. A noi basta, come<br />
prescrive la legge, ricapitalizzare<br />
annualmente i montanti della variazione<br />
me<strong>di</strong>a quinquennale del PIL<br />
nominale (che per l’anno in corso è<br />
precipitata all’1,79% contro il<br />
3,32% dello scorso anno). Né, tali<br />
eventuali plus valenze, possono<br />
servire per la sostenibilità, da questo<br />
punto <strong>di</strong> vista, infatti, tutti gli<br />
Enti ex 103 come l’Epap godono<br />
splen<strong>di</strong>da salute.<br />
Leggendo queste ed altre “raccomandazioni<br />
alla prudenza agli<br />
Enti <strong>di</strong> previdenza” non si può fare<br />
a meno <strong>di</strong> pensare ai titoli “derivati”<br />
che per <strong>di</strong>versi miliar<strong>di</strong> sono<br />
stati sottoscritti dagli enti locali,<br />
agli interventi a sostegno delle banche<br />
e degli stati in fallimento (Grecia<br />
– Irlanda … altri?) ed allo stesso<br />
PIL negativo prodotto nello<br />
scorso anno nel nostro paese per<br />
cui, per legge, abbiamo ricapitalizzato<br />
i nostri montanti <strong>di</strong> appena<br />
l’1,79% senza prospettive migliori<br />
per i prossimi anni poiché quel PIL<br />
negativo continuerà a “far me<strong>di</strong>a”<br />
ancora per quattro anni. Questo, il<br />
PIL negativo, è l’unico vero danno<br />
della crisi finanziaria sulle nostre<br />
pensioni e non l’hanno prodotto gli<br />
Enti <strong>di</strong> previdenza.<br />
Perché tutto ciò? Ma perché fa<br />
comodo scre<strong>di</strong>tare gli Enti <strong>di</strong> previdenza<br />
privati da quel virtuosismo<br />
amministrativo <strong>di</strong> cui finora la stessa<br />
commissione bicamerale per il<br />
controllo degli enti <strong>di</strong> previdenza<br />
ha dato ampio atto. Fa gioco ad un<br />
preciso ed antico <strong>di</strong>segno che ogni<br />
tanto fa capolino a prescindere dal<br />
colore <strong>dei</strong> governi: la statalizzazione<br />
degli Enti <strong>di</strong> previdenza privati;<br />
a questo punto “privati” della loro<br />
autonomia. La grave affermazione<br />
precedente è sotto gli occhi <strong>di</strong> tutti,<br />
basta volerla vedere. S’inizia con<br />
l’inserire tra gli enti pubblici dell’elenco<br />
ISTAT della finanziaria. Si<br />
coinvolgono, dunque, gli Enti <strong>di</strong><br />
previdenza privati nella legge 122<br />
(la finanziaria <strong>di</strong> Luglio 2010) in<br />
due articoli (8 e 9) che riguardano il<br />
29
personale e gli investimenti immobiliari;<br />
due articoli che assimilano,<br />
<strong>di</strong> fatto, gli Enti previdenziali privati<br />
agli Enti pubblici. Dopo una<br />
serie <strong>di</strong> “duelli al fioretto” tra gli<br />
Enti <strong>di</strong> previdenza rappresentati<br />
dall’Adepp e i ministeri del Lavoro/Economia<br />
dove la contropartita<br />
al riconoscimento degli enti privati<br />
come “privati” e non come pubblici,<br />
sembrava essere l’intervento<br />
finanziario degli Enti nel progetto<br />
Social Housing - ovvero la costruzione<br />
<strong>di</strong> case da dare in affitto a<br />
precise categorie sociali, intervento<br />
che bonariamente richiesto dal<br />
Governo ha avuto l’adesione <strong>di</strong><br />
massima da parte <strong>di</strong> molti Enti – i<br />
ministeri emanano una circolare<br />
esplicativa della legge 122, dove<br />
non si danno <strong>di</strong>rettive cogenti (per<br />
il solito gioco delle responsabilità)<br />
ma si danno “in<strong>di</strong>cazioni” che, <strong>di</strong><br />
fatto, limitano fortemente l’autonomia<br />
degli Enti.<br />
Tutto questo mentre in parlamento<br />
è un fioccare <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni <strong>di</strong><br />
legge (ce ne sono ben tre) il cui<br />
unico obiettivo (almeno <strong>di</strong> due <strong>di</strong><br />
questi) è quello della costituzione<br />
della cosiddetta “inps <strong>dei</strong> professionisti”<br />
statalizzata e unificata. Il<br />
tutto, per <strong>di</strong>rla in termini cru<strong>di</strong>, per<br />
mettere le mani sui patrimoni degli<br />
Enti <strong>di</strong> previdenza privati che,<br />
adesso, ammontano a circa trenta<br />
miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro.<br />
Va da sé che tutte le notizie o<br />
semplici impressioni negative sugli<br />
enti previdenziali in generale, sulla<br />
sostenibilità delle sette casse storiche<br />
in particolare e sui presunti<br />
pericoli <strong>di</strong> commissariamento,<br />
vanno a sostegno <strong>di</strong> questo nefando<br />
progetto che, ritengo, sia ormai<br />
chiaro e ben avviato. Non ci resta<br />
d’ora in poi che sventare e denunciare<br />
con tutti i mezzi, la manovra<br />
primaria e le remore ad essa secondarie,<br />
ed in questo deve essere in<br />
prima linea l’Adepp poiché si tratta<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere tutti gli Enti previdenziali<br />
privati.<br />
Il Presidente dell’Epap<br />
Arcangelo Pirrello<br />
30<br />
Le Scienze della Terra nella Scuola<br />
<strong>di</strong> Emanuele Doria<br />
Spesso il mondo professionale ed il mondo della scuola vengono<br />
visti come due entità <strong>di</strong>stinte e separate, anche se sono moltissimi<br />
i colleghi insegnanti e quelli che si <strong>di</strong>vidono tra attività professionale<br />
ed insegnamento, sovente in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> precariato,<br />
motivati innanzitutto dalla grande passione per la geologia. In questo<br />
periodo molto travagliato per la scuola, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Regionale</strong> ha<br />
ritenuto opportuno far sentire la sua voce in merito alle “In<strong>di</strong>cazioni<br />
Nazionali per i Licei” emanate dal Ministero dell’Istruzione.<br />
In tale documento veniva <strong>di</strong> fatto ridotto al lumicino lo spazio de<strong>di</strong>cato<br />
all’insegnamento delle Scienze della Terra nelle scuole superiori,<br />
potenziale fattore limitante anche nella scelta della facoltà<br />
universitaria. Tale azione, portata avanti con l’ORG della Toscana<br />
e l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti <strong>di</strong> Scienze Naturali),<br />
ha trovato riscontro nella versione definitiva delle In<strong>di</strong>cazioni Nazionali.<br />
Riportiamo <strong>di</strong> seguito il testo della lettera pervenutaci da parte<br />
<strong>di</strong> Enrico Campolmi, Presidente dell’Anisn.<br />
Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali<br />
In occasione della recente emanazione da parte del MPI delle<br />
In<strong>di</strong>cazioni Nazionali per i licei (il documento contenente gli obiettivi<br />
specifici <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento della scuola dopo il rior<strong>di</strong>no), importanti<br />
prese <strong>di</strong> posizione da parte del mondo delle scienze della Terra<br />
sono riuscite a mo<strong>di</strong>ficare l’impianto del testo, inizialmente molto<br />
penalizzante per questa <strong>di</strong>sciplina.<br />
Nel marzo scorso il ministero aveva infatti presentato una prima<br />
bozza delle In<strong>di</strong>cazioni in cui le scienze della Terra avevano un ruolo<br />
assolutamente marginale. Erano insegnate soltanto al primo anno<br />
e ricomparivano esclusivamente al quinto anno del solo liceo scientifico,<br />
all’interno <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>menti proposti a conclusione<br />
del programma.<br />
Nelle settimane successive tuttavia la FIST, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong><br />
della Toscana e della <strong>Sicilia</strong>, nonché <strong>di</strong>versi soci ANISN sono<br />
intervenuti in modo autorevole e deciso. A seguito <strong>di</strong> ciò nella stesura<br />
finale delle In<strong>di</strong>cazioni, presentata il 26 maggio le scienze della<br />
Terra, oltre che nel primo biennio, compaiono anche nel secondo<br />
biennio <strong>dei</strong> licei ove le scienze si insegnano per quattro anni e del<br />
quinto anno <strong>dei</strong> licei scientifico, classico, linguistico e delle scienze<br />
umane.<br />
Al <strong>di</strong> là del giu<strong>di</strong>zio complessivo sulle In<strong>di</strong>cazioni, ciò ha consentito<br />
alle scienze della Terra <strong>di</strong> riacquistare, una posizione più consona<br />
al loro ruolo culturale e scientifico, ma anche civile, sociale ed<br />
economico.<br />
Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante<br />
risultato, auspichiamo che esso posta costituire una positivo<br />
esempio per future iniziative.<br />
Il gruppo <strong>di</strong> lavoro sulla <strong>di</strong>dattica<br />
delle Scienze della Terra - ANISN<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
RECENSIONI<br />
Abbiamo letto per voi<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
a cura <strong>di</strong> Pietro Todaro<br />
La fine del mondo secondo il Bud<strong>di</strong>smo:<br />
Secondo il Buddhismo, la fine avverrà lentamente, con piccoli ed impercettibili cambiamenti in<br />
ogni momento, in ogni minuto. Perfino nelle nostre relative e brevi vite potremo notarlo e vederne<br />
la verità in questo. Già adesso il clima sta cambiando, gli animali si estinguono e le risorse<br />
del mondo vengono a mancare. In realtà, vedremo il mondo giungere verso la fine. Benchè questo<br />
sia inevitabile, non avverrà necessariamente così presto.Buddha insegnò che questi fenomeni<br />
non sono il risultato del volere <strong>di</strong> <strong>di</strong>o, ma sono ampiamente sotto il nostro controllo.<br />
Alberto Castellani<br />
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (seconda e<strong>di</strong>zione)<br />
pagg. 344 – Euro 32,00 – HOEPLI<br />
L’interesse per questo volume è certamente prioritario per gli ingegneri strutturisti; i geologi possono<br />
trovarvi in<strong>di</strong>rettamente utili concetti sull’interazione delle strutture con l’azione sismica che alla luce delle<br />
nuove norme per le costruzioni NTC08 deve essere valutata nella sua risposta sismica locale (RSL).<br />
Gli autori sono due noti docenti <strong>di</strong> ingegneria sismica al Politecnico <strong>di</strong> Milano: Alberto Castellani è professore<br />
or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Costruzioni in zona sismica, Ezio Faccioli è professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> ingegneria sismica.<br />
Il testo è rivolto agli studenti <strong>di</strong> ingegneria per l’ambiente e il territorio con in<strong>di</strong>rizzo in “<strong>di</strong>fesa del<br />
suolo” e fa seguito all’emanazione della Carta <strong>di</strong> pericolosità sismica del territorio nazionale. Un testo<br />
che ci consente una visione più ampia e inter<strong>di</strong>sciplinare degli effetti sismici <strong>di</strong> sito (cap.8) per l’influenza<br />
<strong>dei</strong> profili stratigrafici con gli effetti <strong>di</strong> amplificazione e risonanza. Interessanti sono gli approfon<strong>di</strong>menti<br />
sull’amplificazione topografica e sugli effetti <strong>di</strong> liquefazione del terreno (Cap.9) in piano e in pen<strong>di</strong>o<br />
in relazione ai fattori geologici e idrogeologici.<br />
Paola Gattinoni, Enrico Pizzarotti, Elisabetta Scattolini, Laura Scesi<br />
STABILITÀ DEI PENDII E DEI FRONTI DI SCAVO IN ROCCIA<br />
pagg. 275 - Euro 55,00 - E<strong>di</strong>zioni PEI<br />
Un testo originale per il tema che si propone <strong>di</strong> raccogliere i principali problemi sulla <strong>di</strong>namica <strong>dei</strong> versanti<br />
in roccia e i complessi fenomeni che la con<strong>di</strong>zionano. Nella sua prima parte il testo illustra le<br />
moderne tecniche per in<strong>di</strong>viduare i movimenti franosi nella fase iniziale, quando è più <strong>di</strong>fficile leggerne<br />
sul terreno le tracce, ma è meno costoso porvi rime<strong>di</strong>o con gli interventi. Viene affrontato successivamente<br />
lo stu<strong>di</strong>o sistematico delle aree critiche dal punto <strong>di</strong> vista strutturale finalizzato all’in<strong>di</strong>viduazione<br />
delle cause <strong>dei</strong> crolli e della loro modellazione. Infine si perviene alla descrizione delle metodologie <strong>di</strong><br />
intervento per la messa in sicurezza <strong>dei</strong> versanti. Alcuni esempi applicativi consentono <strong>di</strong> collegare gli<br />
aspetti teorici analizzati con la sintesi <strong>dei</strong> risultati <strong>dei</strong> rilievi condotti. Un testo ben illustrato e <strong>di</strong> facile<br />
interpretazione per chiarezza e praticità nell’esposizione <strong>dei</strong> vari argomenti che guida il lettore in un<br />
approccio tecnico-scientifico <strong>di</strong> elevata affidabilità.<br />
Angelo Silvio Rabuffetti<br />
FONDAZIONI SUPERFICIALI - Progetto e calcolo geotecnico secondo le nuove NTC<br />
Pagg. 236 – Euro 68,00 – DEI – Tipografia del Genio Civile<br />
L’argomento trattato riguarda esclusivamente il progetto geotecnico delle fondazioni superficiali in applicazione<br />
delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni – DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e Circolare<br />
CSLLPP n. 617/2009. Tutti i passaggi del progetto geotecnico sono assistiti con l’aiuto <strong>di</strong> un programma<br />
<strong>di</strong> calcolo che consente <strong>di</strong> determinare la capacità portante allo SLU con il metodo <strong>di</strong> Vesic<br />
che deriva da un aggiornamento delle classiche formule <strong>di</strong> Terzaghi-Buismann. Il calcolo <strong>dei</strong> ce<strong>di</strong>menti<br />
è affrontato sia per le sabbie (ce<strong>di</strong>mento elastico) sia per le argille (consolidazione primaria) in termini<br />
<strong>di</strong> SLE. Completa la trattazione il calcolo del modulo <strong>di</strong> sottofondo (coefficiente <strong>di</strong> Winkler), definito<br />
in base ai dati raccolti con la campagna geognostica e alle caratteristiche geometriche delle<br />
fondazioni. L’autore de<strong>di</strong>ca il testo alla lettura <strong>di</strong> ingegneri e geologi ritenuti i primi fruitori per una corretta<br />
progettazione delle fondazioni.<br />
Massimo Grecchi<br />
MANUALE DI MONITORAGGIO PER L’EMERGENZA IDROGEOTECNICA<br />
pagg. 416 – Euro 38,00 – E<strong>di</strong>zioni Geo-graph – Segrate<br />
In un momento in cui in <strong>Sicilia</strong> e non solo si vivono momenti <strong>di</strong> emergenza idrogeologica che mettono<br />
in primo piano le urgenze <strong>di</strong> una continua e sistematica osservazione dell’evolversi <strong>dei</strong> fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />
questo volume è assolutamente attuale e merita <strong>di</strong> figurare tra i testi specialistici del geologo. La<br />
tecnica del monitoraggio è <strong>di</strong>venuta ancor più determinante con l’entrata in vigore delle nuove NTC che<br />
introducono la necessità <strong>dei</strong> Piani <strong>di</strong> controllo e monitoraggio sia in fase <strong>di</strong> verifica <strong>dei</strong> livelli <strong>di</strong> ammissibilità<br />
<strong>dei</strong> ce<strong>di</strong>menti e sforzi che in applicazione del Metodo osservazionale che costituisce una vera<br />
rivoluzione nel campo della progettazione in situazioni d’incertezza e complessità geolgico-geotecnica.<br />
La stessa tecnica <strong>di</strong> monitoraggio ambientale ha anche superato l’iniziale utilizzo per l’allarme e la prevenzione<br />
per trasformarsi in una scienza a sé in grado <strong>di</strong> qualificare modelli e procedure per l’interpretazione<br />
modellistica <strong>dei</strong> fenomeni naturali. Il volume è in<strong>di</strong>rizzato a tutti gli esperti del settore geologi,<br />
ingegneri, tecnici intendendo unire i fondamenti della tecnologia <strong>dei</strong> <strong>di</strong>spositivi e degli strumenti <strong>di</strong><br />
rilevamento (che sono numerosissimi e ben descritti) all’analisi delle tecniche più recenti d’integrazione<br />
e interpretazione. Meto<strong>di</strong> e strumenti sono accompagnati da una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni e figure, oltre a schemi<br />
<strong>di</strong> monitoraggio de<strong>di</strong>cati.<br />
31
RINVENIMENTO DI UN’ANTICA CAVA DI PIETRE<br />
DA MACINA NEL LITORALE DI LETOJANNI (ME)<br />
Alberto Ucosich - Geologo, libero professionista - Messina<br />
1. Premessa<br />
Il lungo arenile, pressoché integro nella sua naturale<br />
preservazione, che giace tra il limite settentrionale<br />
dell’abitato <strong>di</strong> Letojanni ed il Fondaco Parrino<br />
(Comune <strong>di</strong> Forza d’Agrò) nasconde una scogliera che<br />
in epoca remota è stata utilizzata come cava per trarne<br />
mole per frantoio.<br />
Nell’anno 2005 una serie <strong>di</strong> mareggiate ha rimosso<br />
i se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> spiaggia per un breve periodo, permettendo<br />
allo scrivente <strong>di</strong> rinvenire codesto sito <strong>di</strong> interesse<br />
storico ed archeologico lì dove la sabbia lo aveva<br />
nascosto per decenni; due ulteriori e più forti mareggiate<br />
nei mesi <strong>di</strong> Gennaio 2009 e 2010 hanno messo<br />
a nudo altri tratti <strong>di</strong> scogliera consentendo una più<br />
approfon<strong>di</strong>ta indagine. In seguito è stata inviata la<br />
segnalazione alla Soprintendenza <strong>dei</strong> Beni CC. AA.<br />
<strong>di</strong> Messina, che non era ancora a conoscenza del sito.<br />
2. Inquadramento morfologico del sito<br />
La cava in oggetto è ubicata a circa 2 km a Nord<br />
del centro abitato <strong>di</strong> Letojanni, nel vasto arenile compreso<br />
tra le foci degli impluvi denominati “Pietrabianca”,<br />
“Milianò” ed “Oliveri”; trovasi alle coor<strong>di</strong>nate<br />
WB 290 949 della tavoletta scala 1:25.000 “Forza<br />
D’Agrò”, Foglio 262 I S.E.<br />
Essa è ricavata su una piatta scogliera alta circa<br />
un metro sul livello del mare, che <strong>di</strong> norma risulta<br />
celata dai depositi <strong>di</strong> spiaggia; la roccia è sempre visibile,<br />
oltre la battigia, nel suo prolungamento in mare<br />
in forma <strong>di</strong> serie parallele <strong>di</strong> scogli sommersi che si<br />
estendono fino alla batimetrica -3 m; il fondale che<br />
si <strong>di</strong>parte dalla riva oltre la barriera <strong>di</strong> scogli è essen-<br />
32<br />
zialmente sabbioso, generalmente regolare, e <strong>di</strong>grada<br />
con una pendenza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 10°.<br />
La lunga spiaggia, larga in me<strong>di</strong>a 50-60 m, inizia<br />
presso la foce del T. San Filippo a SW e termina in<br />
corrispondenza <strong>di</strong> un piccolo promontorio roccioso<br />
poco oltre il T. Oliveri a NE. Essa è delimitata a monte<br />
da ripi<strong>di</strong> versanti collinari nei quali si trovano ubicate<br />
la ferrovia ME-CT, la SS.114 e la A20.<br />
Riguardo all’esposizione verso la mutevolezza<br />
degli eventi meteo-marini, l’area si trova esposta <strong>di</strong>rettamente<br />
verso i venti <strong>di</strong> Grecale e Levante (NE ed E)<br />
e <strong>di</strong> Scirocco (SE). Riguardo all’esposizione verso<br />
Libeccio, Maestrale e Tramontana l’area risulta sufficientemente<br />
protetta dai rilievi montuosi.<br />
La spiaggia risulta essere in equilibrio rispetto ai<br />
fattori <strong>di</strong> erosione e <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione. Ciò nonostante,<br />
in qualche annata la violenza delle mareggiate ha<br />
fatto retrocedere l’arenile temporaneamente <strong>di</strong> parecchi<br />
metri, come è avvenuto in occasione della serie<br />
<strong>di</strong> forti sciroccate protrattesi tra l’inverno e la primavera<br />
del 2005, che ha traslato ingenti masse <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mento<br />
sabbioso verso NE, portandole a ridosso del<br />
promontorio presso il T. Oliveri e causando l’eccezionale<br />
messa a nudo <strong>di</strong> un tratto <strong>di</strong> scogliera emersa<br />
esteso <strong>di</strong>versi mq; tale affioramento è rimasto visibile<br />
per l’intera estate successiva permettendo per la<br />
prima volta allo scrivente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarne i segni <strong>di</strong><br />
un’attività estrattiva. Le prime mareggiate settembrine<br />
del 2005 causate dai venti provenienti da Grecale<br />
hanno <strong>di</strong> nuovo celato il sito riportando in posto la<br />
sabbia precedentemente asportata.<br />
Un’altra serie <strong>di</strong> eccezionali mareggiate provenienti<br />
da E-SE occorse tra il 10 ed il 14 Gennaio 2009,<br />
con una fase parossistica nel giorno 13, ha fatto emergere<br />
un più ampio tratto <strong>di</strong> scogliera lungo buona parte<br />
dell’arenile; dopo due settimane, la maggior parte <strong>di</strong><br />
questa era <strong>di</strong> nuovo sepolta sotto una coltre <strong>di</strong> nuovi<br />
se<strong>di</strong>menti.<br />
L’ultima riemersione della scogliera si è avuta<br />
durante l’ultima mareggiata <strong>di</strong> Libeccio del 27 Gennaio<br />
2010.<br />
Tali estremi fenomeni <strong>di</strong> erosione e successivo ripascimento<br />
del litorale non erano stati mai notati prima<br />
dai residenti e con tutta probabilità non accadevano<br />
da almeno 30-40 anni; trattasi <strong>di</strong> eventi inconsueti che<br />
però in passato sono sicuramente accaduti più volte,<br />
permettendo agli antichi cavatori <strong>di</strong> rinvenire e <strong>di</strong><br />
sfruttare il sito.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
3. Caratteristiche geolitologiche<br />
L’assetto geologico del tratto <strong>di</strong> litorale ove è ubicata<br />
la cava è costituito da uno spesso deposito se<strong>di</strong>mentario<br />
<strong>di</strong> origine marina ed alluvionale, <strong>di</strong> recente<br />
formazione, giacente su un basamento <strong>di</strong> scisti filla<strong>di</strong>ci<br />
appartenenti alla “Unità <strong>di</strong> S. Marco D’Alunzio”<br />
del Complesso Calabride, i quali formano anche le<br />
pen<strong>di</strong>ci collinari retrostanti il rilevato ferroviario. Una<br />
propaggine rocciosa filla<strong>di</strong>ca forma il piccolo promontorio<br />
roccioso che chiude a settentrione il tratto <strong>di</strong> litorale<br />
in oggetto.<br />
Alla sommità <strong>dei</strong> versanti si rinvengono una<br />
sequenza <strong>di</strong> conglomerati ed arenarie oligocenici<br />
appartenenti al Flysch <strong>di</strong> Capo d’Orlando, sovrapposti<br />
stratigraficamente alle filla<strong>di</strong>.<br />
La fascia litoranea pianeggiante è costituita da<br />
depositi alluvionali e marini recenti; da un punto <strong>di</strong><br />
vista granulometrico, questi sono formati essenzialmente<br />
da livelli sabbioso-ghiaiosi sciolti poco classati,<br />
talvolta con ciottoli e blocchi lapi<strong>dei</strong>, in cui si può<br />
riconoscere una natura prevalentemente metamorfica,<br />
mentre nella frazione più fine si possono <strong>di</strong>stinguere<br />
elementi quarzosi, k-feldspato, miche. Hanno stratificazione<br />
incrociata e giacitura sub-orizzontale, con<br />
soventi contatti eteropici.<br />
I Conglomerati Costieri - La scogliera situata<br />
lungo la linea <strong>di</strong> costa consiste in livelli e bancate <strong>di</strong><br />
conglomerati dotati <strong>di</strong> un grado <strong>di</strong> cementazione elevato<br />
e formati da sabbie, ghiaie e ciottoli arrotondati<br />
<strong>di</strong> natura cristallina con macrofossili, in cui prevale<br />
ora l’una, ora l’altra classe granulometrica.<br />
Lo spessore si aggira intorno a 1-2 metri; l’orientazione<br />
degli strati varia tra i 10° ed i 30°. La parte<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
emersa della scogliera è <strong>di</strong> solito costantemente nascosta<br />
dai se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> spiaggia; ha un andamento pianeggiante<br />
e dolcemente <strong>di</strong>gradante verso mare; la parte<br />
sommersa, che si spinge circa fino alla batimetrica <strong>di</strong><br />
–3 m, affiora dal fondo marino poco oltre la battigia<br />
ed è sempre visibile.<br />
Con i dati rilevati è stato possibile ricostruire una<br />
sezione litologica che ben evidenzia l’andamento stra-<br />
33
tigrafico in con<strong>di</strong>zioni normali, con la scogliera ricoperta<br />
dalla spiaggia.<br />
Tale roccia conglomeratica non appartiene Flysch<br />
<strong>di</strong> Capo d’Orlando, ma si è generata, in epoca olocenica,<br />
all’interno <strong>dei</strong> se<strong>di</strong>menti sciolti <strong>di</strong> spiaggia<br />
me<strong>di</strong>ante la deposizione <strong>di</strong> cemento carbonatico ad<br />
opera <strong>di</strong> flui<strong>di</strong> interstiziali in presenza <strong>di</strong> una falda<br />
acquifera fortemente mineralizzata. Questo tipo <strong>di</strong><br />
materiale litoide si rinviene in vari punti lungo tutto<br />
il litorale <strong>di</strong> Letojanni, ed affiora, con caratteristiche<br />
analoghe, anche nella Zona Falcata <strong>di</strong> Messina e nella<br />
Penisola <strong>di</strong> Torre Faro.<br />
4. Descrizione della cava<br />
La cava è costituita da un basso e piatto scoglio<br />
<strong>di</strong> durissima roccia in cui sono visibili <strong>di</strong>versi crateri<br />
larghi e circolari; tali avelli, che a prima vista parrebbero<br />
essere un tipo <strong>di</strong> “marmitte” <strong>di</strong> erosione, sono<br />
in realtà <strong>di</strong> origine antropica e rappresentano i punti<br />
da cui sono state estratte pietre da macina.<br />
Gli scavi misurano quasi tutti 2,00 m. <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro,<br />
con una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 0,45-0,50 m; alcuni perfori<br />
più piccoli misurano f =1,40 m. Le mole ancora<br />
in posto o appena abbozzate misurano f =1,40 e h =<br />
0,45 m. All’interno <strong>di</strong> alcuni avelli è stato possibile<br />
osservare la parte relitta rimasta dopo il taglio della<br />
base della mola.<br />
In totale, sono stati contati 216 avelli <strong>di</strong> scavo,<br />
10 scavi abbozzati ed una mola quasi completata pronta<br />
da tagliare alla base. Una serie <strong>di</strong> scavi si trovano<br />
a cavallo del solco <strong>di</strong> battigia e tra questi è visibile<br />
una mola abbozzata la cui lavorazione è stata interrotta<br />
probabilmente a causa <strong>di</strong> una cavità prodottasi<br />
col <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> un grosso ciottolo. È anche presente<br />
uno scavo <strong>di</strong> forma rettangolare da cui è stata probabilmente<br />
ricavata una vasca.<br />
Le serie <strong>di</strong> perfori sono <strong>di</strong>sposte in maniera da<br />
sfruttare il maggiore spazio <strong>di</strong>sponibile; alcune sono<br />
poste in linea dove i segmenti <strong>di</strong> scogliera sono stretti<br />
e lunghi; invece, dove la superficie della roccia si<br />
allarga, i segni <strong>di</strong> scavo sono strettamente <strong>di</strong>sposti a<br />
quinconce. In taluni casi la roccia, anziché verticalmente,<br />
è stata tagliata in senso obliquo seguendo l’orientazione<br />
verso mare degli strati.<br />
5. Considerazioni storiche<br />
I segni <strong>di</strong> attività estrattiva <strong>di</strong> pietre da macina in<br />
zone litorali non sono infrequenti: in passato sono stati<br />
rinvenuti anche in altri due siti a Giar<strong>di</strong>ni Naxos e<br />
Capo d’Orlando. Sulla sponda calabra dello stretto è<br />
segnalata la presenza <strong>di</strong> una cava analoga nello stesso<br />
materiale conglomeratico, nella spiaggia <strong>di</strong> Capo<br />
dell’Armi.<br />
34<br />
Notizie su attività estrattive sui conglomerati <strong>di</strong><br />
spiaggia presso la città <strong>di</strong> Messina si hanno dallo<br />
SPALLANZANI, che verso la fine del <strong>di</strong>ciottesimo<br />
secolo annotò come tali “pud<strong>di</strong>nghe” riuscissero a<br />
riformarsi nel giro <strong>di</strong> una quarantina <strong>di</strong> anni, fornendo<br />
così sempre nuova materia prima ai cavatori. Egli,<br />
ancora, associava all’origine <strong>di</strong> tale fenomeno la circolazione<br />
<strong>di</strong> acqua biancastra, evidentemente fortemente<br />
mineralizzata, <strong>di</strong> origine termale.<br />
La peculiarietà del conglomerato <strong>di</strong> scogliera era<br />
tale che i cavatori si sobbarcavano i <strong>di</strong>sagi dovuti alla<br />
lavorazione della roccia sulla battigia a contatto con<br />
l’acqua <strong>di</strong> mare ed ai tempi <strong>di</strong>pendenti dalle con<strong>di</strong>zioni<br />
meteomarine; questi erano prezzi da pagare pur<br />
<strong>di</strong> ottenere manufatti da una roccia <strong>di</strong> qualità elevata,<br />
compatta e priva <strong>di</strong> fratture.<br />
Nell’entroterra, infatti, sono rari gli affioramenti<br />
lapi<strong>dei</strong> <strong>di</strong> siffatte caratteristiche, poiché le arenarie si<br />
presentano in genere troppo friabili ed i calcari dolomitici<br />
fessurati e poco omogenei.<br />
I cavatori per tagliare la roccia approfittavano <strong>dei</strong><br />
rari eventi in cui la scogliera veniva portata alla luce<br />
dalle mareggiate o, più probabilmente, una volta conosciuta<br />
l’ubicazione della roccia, asportavano la sabbia<br />
fino a mettere a luce manualmente il fronte <strong>di</strong> scavo.<br />
Tale attività risale ad epoche sconosciute, sicuramente<br />
antecedenti fine ‘800 ed è probabilmente da<br />
ascrivere ai perio<strong>di</strong> in cui la coltivazione <strong>di</strong> olivi e il<br />
sorgere <strong>di</strong> frantoi nella zona erano in tale espansione<br />
da rendere economicamente vantaggiosa l’apertura <strong>di</strong><br />
una cava apposita per le macine.<br />
La parte della scogliera dove si trovano la mola<br />
quasi completata e gli altri vicini abbozzi <strong>di</strong> scavo, si<br />
presume essere l’ultima ad essere sfruttata prima della<br />
cessazione dell’attività estrattiva.<br />
La lavorazione della roccia avveniva eseguendo<br />
uno scavo circolare massimo 2 metri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, più<br />
largo ed un po’ più profondo della mola da cavare,<br />
onde avere lo spazio per tagliarla alla base. L’orientazione<br />
avveniva preferibilmente in modo da mantenere<br />
i lati paralleli all’immersione degli strati, consentendo<br />
così, me<strong>di</strong>ante la parziale sovrapposizione<br />
delle sagome <strong>di</strong> scavo, un migliore sfruttamento dell’esiguo<br />
banco conglomeratico (ve<strong>di</strong> sezione).<br />
Essa avveniva talvolta a pelo dell’acqua, in qualunque<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> marea; d’altra parte, dall’interpretazione<br />
dalle tavole e<strong>di</strong>te dall’Istituto Idrografico<br />
della Marina, si evince che le maree sigiziali nello<br />
Stretto <strong>di</strong> Messina non mostrano escursioni superiori<br />
a 30 cm.<br />
Per l’aiuto prestato per il riconoscimento del sito<br />
e per le notizie storiche si ringraziano:<br />
- il Dott. Arch. Giovanni Mauro, Sindaco <strong>di</strong> Letojanni;<br />
- il Dott. Geol. Alfredo Natoli, <strong>di</strong> Messina;<br />
- l’Avv. Marco Cutuli, <strong>di</strong> Messina.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
6. Documentazione fotografica<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
C<br />
A<br />
B<br />
Figg. 1-1a-1b-1c.<br />
Un tratto dell’area<br />
<strong>di</strong> interesse<br />
come si presentava<br />
dopo le mareggiate<br />
del gennaio 2009;<br />
sullo sfondo, la rupe<br />
del castello <strong>di</strong> S. Alessio.<br />
35
Fig. 2a. Stesso tratto<br />
<strong>di</strong> spiaggia<br />
in con<strong>di</strong>zioni normali.<br />
36<br />
Fig. 2. Particolare<br />
<strong>di</strong> un tratto <strong>di</strong> spiaggia<br />
con la scogliera<br />
messo a nudo.<br />
Fig. 2b. Stesso tratto<br />
<strong>di</strong> spiaggia<br />
durante una mareggiata.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Fig. 3. Serie <strong>di</strong> escavazioni <strong>di</strong>sposte in linea.<br />
37
38<br />
Figg. 4-5. Serie <strong>di</strong> escavazioni <strong>di</strong>sposte a quinconce.<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
g<strong>di</strong>S
Fig. 7. Abbozzo <strong>di</strong> scavo.<br />
g<strong>di</strong>S<br />
1 • <strong>2011</strong><br />
gennaio-aprile<br />
Fig. 6. Mola quasi<br />
completata ancora<br />
attaccata alla base.<br />
Fig. 8. La matrice<br />
<strong>di</strong> una mola dopo che<br />
è stato effettuato<br />
il taglio della base.<br />
39