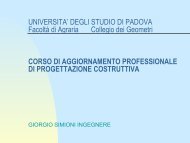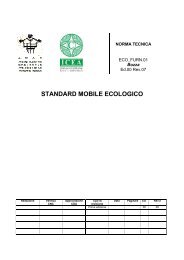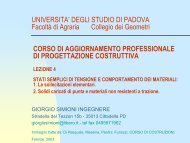Atti del 46° Corso di Cultura in Ecologia - Dipartimento Tesaf ...
Atti del 46° Corso di Cultura in Ecologia - Dipartimento Tesaf ...
Atti del 46° Corso di Cultura in Ecologia - Dipartimento Tesaf ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CORSO DI CULTURA IN ECOLOGIA<br />
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA<br />
DIP.TO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI<br />
Pubblicazione <strong>del</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong><br />
ATTI DEL <strong>46°</strong> CORSO<br />
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
A cura <strong>di</strong><br />
V<strong>in</strong>icio Carraro e Tommaso Anfo<strong>di</strong>llo<br />
Centro Stu<strong>di</strong> per l'Ambiente Alp<strong>in</strong>o, L. Susmel<br />
S. Vito <strong>di</strong> Cadore, 7-10 giugno 2010
PREMESSA<br />
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>Atti</strong> <strong>del</strong> <strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giu gno 2010<br />
Il <strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>di</strong> <strong>Ecologia</strong> affronta il tem a <strong>del</strong>la gestione dei boschi cedui.<br />
Che sia tema importante e <strong>di</strong> attualità lo <strong>di</strong>mostrano alcuni dati: il recente rapporto ISPRA 97/2009<br />
mette bene <strong>in</strong> risalto che l’Italia è il primo importatore mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> legna da ardere: tra il 1996 e il<br />
2006 le importazioni <strong>di</strong> legna sono quasi quadruplicate <strong>in</strong> quantità, passando da 164.843 Mg a<br />
796.960 Mg, e più che sestuplicate <strong>in</strong> valore, passando da 9,8 milioni <strong>di</strong> US$ a quasi 72 milioni <strong>di</strong><br />
US$. Contestualmente i boschi cedui rappresentano oltre 1/3 <strong>del</strong>la superficie a bosco <strong>del</strong> nostro<br />
paese (IFNC 2007) ma <strong>in</strong> molte aree montane e coll<strong>in</strong>ari dove dom<strong>in</strong>a il bosco ceduo sono stati<br />
molto accentuati i fenomeni <strong>di</strong> emigrazione verso le città, con conseguente spopolamento ed<br />
abbandono <strong>del</strong>le attività tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong> coltivazione <strong>del</strong> bosco.<br />
Il quadro che si forma cosi è contrad<strong>di</strong>ttorio: da un lato si osserva una notevole richiesta <strong>in</strong>terna <strong>del</strong><br />
prodotto pr<strong>in</strong>cipale <strong>del</strong> ceduo (legna da ardere) dall’altro un generale abbandono <strong>del</strong>la coltivazione.<br />
E’ evidente che problematiche <strong>di</strong> natura sociale, <strong>in</strong>frastrutturale e ad ambientale si <strong>in</strong>trecciano a<br />
quelle più propriamente tecniche formando un quadro complesso. Ciò obbliga ad una analisi <strong>di</strong><br />
dettaglio, caso per caso, <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> proporre soluzioni tecnico-gestionali <strong>in</strong><br />
grado <strong>di</strong> ottimizzare i benefici che tale forma <strong>di</strong> governo può fornire.<br />
L’obiettivo <strong>del</strong> corso è proprio questo: presentare <strong>di</strong>verse analisi e soluzioni tecniche <strong>in</strong> grado <strong>di</strong><br />
massimizzare i benefici che il bosco ceduo può fornire tenendo <strong>in</strong> considerazione e rispettando tutti<br />
i v<strong>in</strong>coli che le <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> sostenibilità economica, sociale ed ambientale impongono.<br />
Il <strong>di</strong>rettore <strong>del</strong> <strong>Corso</strong> Tommaso Anfo<strong>di</strong>llo
SOMMARIO<br />
PRINCIPI E METODI PER IL RESTAURO FORESTALE<br />
(CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BOSCHI CEDUI) 5<br />
Robero Mercurio<br />
IL CEDUO TRA PASSATO E ATTUALITÀ: OPZIONI COLTURALI E DINAMICA<br />
DENDRO-AUXONOMICA E STRUTTURALE NEI BOSCHI DI ORIGINE CEDUA 27<br />
Gianfranco Fabbio<br />
LASELVICOLTURA NEL PIANO FORESTALE REGIONALE DELL’UMBRIA 51<br />
Francesco Grohmann, Mauro Frattegiani, Giorgio Iorio, Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
LA NUOVA NORMATIVA FORESTALE DELL’UMBRIA 63<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann<br />
NUOVE TECNICHE D’INTERVENTO NEI BOSCHI CEDUI:<br />
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO SUMMACOP 73<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
IL CEDUO COME OPERA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA<br />
LA STABILITÀ DEI CEDUI INVECCHIATI 85<br />
Marco Conedera, Mario Pividori, Gianni Boris Pezzatti, Eric Gehr<strong>in</strong>g<br />
SELVICOLTURA DELLE CERRETE (PROVE DI MATRICINATURA E CONVERSIONE) 97<br />
Paolo Cantiani<br />
SELVICOLTURA DEI CEDUI DI CASTAGNO 119<br />
Maria Chiara Manetti<br />
BOSCHI CEDUI E RETE NATURA 2000 139<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
DINAMISMI STRUTTURALI E DI ACCRESCIMENTO IN BOSCHI CEDUI ABBANDONATI<br />
ED IN CONVERSIONE DELL‘APPENNINO CENTRALE 161<br />
Francesco Renzaglia, Emi<strong>di</strong>a Sant<strong>in</strong>i, Matteo Giove, Carlo Urb<strong>in</strong>ati<br />
UNGULATI E BOSCO CEDUO 177<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i<br />
LA SELVICOLTURA D’ALBERO E LE SPECIE SPORADICHE NEI CEDUI 189<br />
Francesco Pelleri
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>Atti</strong> <strong>del</strong> <strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giu gno 2010<br />
PRINCIPI E METODI PER IL RESTAURO FORESTALE<br />
(CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BOSCHI CEDUI)<br />
ROBERTO MERCURIO<br />
UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DIP. GESAF
6<br />
RICHIAMI DI ECOLOGIA FORESTALE<br />
Roberto Mercurio<br />
ODUM (1973) def<strong>in</strong>isce un sistema ecologico o ecosistema come ”un’unità che <strong>in</strong>clude tutti gli<br />
organismi (la comunità) <strong>in</strong> una data area <strong>in</strong>teragenti con l’ambiente fisico e <strong>in</strong> modo tale che un<br />
flusso <strong>di</strong> energia porta a una ben def<strong>in</strong>ita struttura trofica, a una <strong>di</strong>versità biotica e a una<br />
ciclizzazione <strong>del</strong>la materia (cioè a scambi <strong>di</strong> materia fra viventi e non viventi) all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong><br />
sistema”.<br />
KIMMINS (2004) spiega il significato <strong>di</strong> un ecosistema con c<strong>in</strong>que pr<strong>in</strong>cipali attributi: <strong>di</strong> struttura<br />
(un ecosistema è composto dalle subcomponenti biotica e abiotica), <strong>di</strong> funzione (costante<br />
scambio <strong>di</strong> materia e <strong>di</strong> energia tra l’ambiente fisico e la comunità dei viventi), <strong>di</strong> complessità (che<br />
risulta dall’alto livello d’<strong>in</strong>tegrazione biologica che è propria <strong>del</strong>l’ecosistema), d’<strong>in</strong>terazione e<br />
<strong>in</strong>ter<strong>di</strong>pendenza (l’<strong>in</strong>terconnessione tra i vari componenti viventi e non viventi <strong>del</strong>l’ecosistema è<br />
tale che il cambiamento <strong>di</strong> uno determ<strong>in</strong>a il conseguente cambiamento <strong>in</strong> quasi tutti gli altri), <strong>di</strong><br />
cambiamento temporale (un ecosistema non è statico ma sottoposto a cont<strong>in</strong>ui cambiamenti <strong>di</strong><br />
materia ed energia, d’<strong>in</strong>tere strutture e funzioni).<br />
Un bosco va qu<strong>in</strong><strong>di</strong> considerato come un sistema ecologico complesso e <strong>di</strong>namico, <strong>in</strong>teressato<br />
da <strong>di</strong>sturbi naturali e antropici.<br />
Il <strong>di</strong>sturbo è def<strong>in</strong>ito come un evento relativamente <strong>di</strong>screto e impreve<strong>di</strong>bile nel tempo che altera<br />
la struttura e il funzionamento <strong>di</strong> ecosistemi, comunità o popolazioni, attraverso mo<strong>di</strong>fiche che<br />
<strong>in</strong>teressano le risorse, il substrato e l’ambiente fisico (PICKETT e WHITE 1985). Nella <strong>di</strong>namica <strong>del</strong>le<br />
foreste il regime dei <strong>di</strong>sturbi naturali è una componente fondamentale e non un fatto eccezionale<br />
che mo<strong>di</strong>fica il normale processo <strong>di</strong>namico (PACI 2004).<br />
KIMMINS (2004) considera il <strong>di</strong>sturbo come un evento allogeno, se causato da un fattore esterno<br />
e come un evento autogeno, se causato nell’ambito <strong>del</strong>l’ecosistema.<br />
Tra le azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, PACI (2004) <strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue due orig<strong>in</strong>i: quelle naturali a loro volta separate<br />
<strong>in</strong> una componente abiotica (fuoco, fulm<strong>in</strong>e, stress ambientali, siccità, basse e alte temperature,<br />
ecc., tempeste, alluvioni, frane, valanghe, eruzioni vulcaniche) e biotica (esplosioni demografiche<br />
d’<strong>in</strong>setti e funghi, sovraccarico <strong>di</strong> fauna selvatica) e quelle antropiche (<strong>di</strong>ssodamento,<br />
<strong>di</strong>sboscamento, <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o, sovrapascolamento, <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento, attività belliche). Ovviamente al <strong>di</strong> là<br />
<strong>del</strong>lo schematismo <strong>di</strong>dattico queste due orig<strong>in</strong>i possono sovrapporsi.<br />
Gli effetti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>sturbo variano <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la magnitu<strong>di</strong>ne, <strong>del</strong>la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong><br />
popolamento al <strong>di</strong>sturbo, <strong>del</strong>la superficie <strong>in</strong>teressata, <strong>del</strong>la frequenza, <strong>del</strong>la <strong>di</strong>stribuzione spaziale,<br />
<strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervallo <strong>di</strong> tempo.<br />
L’ecosistema forestale è dotato <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> resistenza e <strong>di</strong> resilienza: la resistenza<br />
comprende la capacità <strong>di</strong> un sistema a resistere a stress esterni; la resilienza rappresenta l’abilità<br />
<strong>di</strong> un sistema a ritornare allo stato precedente un <strong>di</strong>sturbo (LARSEN 1995).<br />
Degradazione non significa <strong>di</strong>sturbo (STANTURF 2005). Dal <strong>di</strong>sturbo si passa al degrado quando<br />
si supera la soglia <strong>del</strong>la resilienza naturale <strong>di</strong> un ecosistema forestale.<br />
Lo stato <strong>di</strong> degrado <strong>di</strong> un ecosistema forestale risulta dai cambiamenti nella composizione<br />
specifica, nella struttura, nella funzionalità, nella frammentazione, per arrivare f<strong>in</strong>o al cambiamento<br />
<strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> suolo forestale (deforestazione). Ciò determ<strong>in</strong>a, però, anche l’alterazione dei cicli dei<br />
nutrienti, <strong>del</strong>l’acqua, <strong>del</strong> carbonio, la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> fertilità <strong>del</strong> suolo, la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità e la<br />
scomparsa <strong>di</strong> molte specie vegetali e animali. Inoltre ha riflessi <strong>di</strong>retti sul benessere <strong>del</strong>l’uomo per<br />
l’esaurimento <strong>del</strong>le risorse idriche, il <strong>di</strong>ffondersi <strong>di</strong> eventi calamitosi, la limitazione <strong>del</strong>l’uso<br />
tra<strong>di</strong>zionale <strong>del</strong>le risorse forestali.<br />
LO STATO DEI BOSCHI ITALIANI<br />
Per il II Inventario Forestale Nazionale (IFNC 2007), nel 2005, i fenomeni <strong>di</strong> degrado<br />
<strong>in</strong>teressavano il 22.6% <strong>del</strong>la superficie forestale nazionale pari a 1.9 milioni <strong>di</strong> ettari (leggermente<br />
<strong>in</strong>feriore ai 2.2 milioni <strong>di</strong> ettari <strong>del</strong> I Inventario Forestale Nazionale, CASTELLANI et al. 1988). Le<br />
cause più frequenti <strong>di</strong> degrado erano dovute a danni prodotti da <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>, pascolo, fauna selvatica,<br />
eventi meteorici e climatici <strong>in</strong>tensi, attacchi parassitari. La superficie <strong>in</strong>teressata da fenomeni <strong>di</strong><br />
degrado sarebbe superiore se si considerasse anche lo stato <strong>di</strong> degrado prodotto dall’abbandono<br />
colturale (ad esempio dei rimboschimenti).
SIGNIFICATI E OBIETTIVI DEL RESTAURO FORESTALE<br />
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 7<br />
Il term<strong>in</strong>e restauro è ambiguo e si presta a molte <strong>in</strong>terpretazioni nei vari campi <strong>del</strong> sapere.<br />
In ecologia secondo una posizione purista, restauro significa “ritorno <strong>di</strong> un ecosistema allo stato<br />
<strong>in</strong> cui si presume che fosse stato <strong>in</strong> assenza <strong>del</strong>l’impatto <strong>del</strong>l’uomo” (HOBBS e NORTON 1996).<br />
In effetti, se fosse questo il significato vero <strong>di</strong> restauro, si tratterebbe <strong>di</strong> perseguire un obiettivo<br />
<strong>di</strong>scutibile e <strong>di</strong>fficilmente realizzabile perché non si potrà mai ricreare lo stato orig<strong>in</strong>ario <strong>in</strong> tutte le<br />
sue funzioni anche perché non le conosciamo. Le foreste sono state, sono e saranno sempre<br />
fortemente <strong>in</strong>fluenzate dall’azione <strong>di</strong>retta e <strong>in</strong><strong>di</strong>retta <strong>del</strong>l’uomo.<br />
Inoltre, <strong>in</strong> Italia, nella maggior parte dei casi assume rilevanza il paesaggio culturale, il<br />
paesaggio forestale storicizzato risultato non solo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni ecologiche locali ma anche <strong>del</strong>la<br />
storia umana. In questo caso occorre tener conto non solo degli aspetti ecologici ma anche <strong>di</strong> quelli<br />
estetici. Un paesaggio storicizzato può essere conservato solo cont<strong>in</strong>uando la prassi colturale<br />
tra<strong>di</strong>zionale (caso <strong>del</strong> sostegno f<strong>in</strong>anziario accordato agli agricoltori da alcuni Enti per cont<strong>in</strong>uare lo<br />
sfalcio dei pascoli alp<strong>in</strong>i). L’uomo, <strong>in</strong> questo caso, rappresenta l’elemento centrale che ha<br />
realizzato e che può conservare un determ<strong>in</strong>ato paesaggio storicizzato.<br />
STANTURF (2005) <strong>in</strong>quadra il restauro forestale (Forest Restoration) <strong>in</strong> un ampio contesto che<br />
<strong>di</strong>pende dal tipo <strong>di</strong> copertura forestale e uso <strong>del</strong> suolo e considera varie attività:<br />
Reconstruction (si parte da un uso <strong>del</strong> suolo agricolo per ricreare/ricostruire un uso forestale sia<br />
me<strong>di</strong>ante rimboschimento che per successione secondaria).<br />
Reclamation (si parte da un uso <strong>del</strong> suolo extra agricolo/forestale per procedere alla<br />
sistemazione <strong>del</strong> terreno e al rimboschimento), <strong>in</strong> modo tale da consentire una qualche forma <strong>di</strong><br />
riutilizzazione, come nel caso <strong>di</strong> aree estrattive.<br />
Rehabilitation (si parte da un uso <strong>del</strong> suolo forestale per procedere al riprist<strong>in</strong>o <strong>di</strong> struttura,<br />
composizione specifica, rimozione <strong>di</strong> specie estranee al contesto) term<strong>in</strong>i specifici <strong>di</strong> Conversion o<br />
<strong>di</strong> Transformation <strong>in</strong><strong>di</strong>cano azioni per il passaggio da rimboschimenti <strong>di</strong> conifere a popolamenti <strong>di</strong><br />
latifoglie autoctone. MASSA (2005) dà al term<strong>in</strong>e riabilitazione il significato <strong>di</strong> “riprist<strong>in</strong>o parziale <strong>del</strong>le<br />
proprietà essenziali orig<strong>in</strong>arie”. In quest’ambito può rientrare il restauro dei boschi cedui.<br />
Replacement (si parte da un uso <strong>del</strong> suolo non forestale per sostituirlo con un uso <strong>del</strong> suolo<br />
forestale, anche con popolamenti <strong>di</strong> specie non autoctone che possono essere poi trasformati <strong>in</strong><br />
foreste naturali).<br />
Nel contesto <strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo l’approccio nord-americano (SER 2002) non è adeguato o,<br />
almeno, spesso non è adeguato. Infatti il restauro forestale si muove nell’ambito non solo<br />
ecologico ma anche storico-culturale e paesaggistico.<br />
Pertanto il restauro forestale consiste nel: rimuovere i fattori <strong>di</strong> degrado (es. sovra<br />
pascolamento cont<strong>in</strong>uato), attuare <strong>in</strong>terventi volti al riprist<strong>in</strong>o <strong>del</strong>la densità, <strong>del</strong>la composizione<br />
specifica <strong>di</strong> specie autoctone (e non), <strong>del</strong>la struttura, e funzionalità <strong>del</strong>l’ecosistema/popolamento,<br />
alla riduzione <strong>del</strong>la frammentazione degli habitat naturali, applicare una gestione (forestale)<br />
sostenibile, monitorare il lavoro svolto.<br />
Il restauro forestale rappresenta una componente <strong>del</strong> restauro ambientale (o <strong>del</strong> restauro<br />
ecologico) e <strong>del</strong> restauro <strong>del</strong> paesaggio. In questo testo si prende <strong>in</strong> considerazione il restauro<br />
forestale a livello <strong>di</strong> popolamento (Forest Restoration), almeno <strong>di</strong> alcune dec<strong>in</strong>e <strong>di</strong> ettari, ma con<br />
evidenti riflessi a livello <strong>di</strong> paesaggio (Forest Landscape Restoration) (PIUSSI e MAIROTA 2003,<br />
AGNOLETTI 2007).<br />
L’abbandono colturale, anche se giustificato <strong>in</strong> casi specifici, non significa restauro forestale<br />
perché il restauro prevede sempre un’azione puntuale e consapevole <strong>del</strong>l’uomo. Il concetto<br />
ispiratore <strong>del</strong> restauro forestale è che l’uomo deve guidare i processi <strong>di</strong>namici, <strong>in</strong>fatti, se vengono<br />
lasciati all’evoluzione naturale, possono determ<strong>in</strong>are conseguenze anche <strong>di</strong>sastrose per il<br />
benessere e la salute <strong>del</strong>l’uomo. La natura evolve sempre verso nuovi equilibri che non tengono<br />
conto <strong>del</strong>le necessità <strong>del</strong>l’uomo, ma sono funzionali alle caratteristiche omeostatiche<br />
<strong>del</strong>l’ecosistema.<br />
I METODI DI RESTAURO DEI BOSCHI CEDUI<br />
In passato è stato proposto un ampio programma a livello italiano per il restauro dei cedui<br />
consistente nella conversione (RICCI 1998) ma che non ha avuto alcun esito.<br />
Nella regione me<strong>di</strong>terranea il governo a ceduo presenta un forte legame storico con la società<br />
rurale f<strong>in</strong> dal periodo etrusco-romano (DI BERENGER 1863, GABBRIELLI 2002). Perciò si deve
8<br />
Roberto Mercurio<br />
considerare nell’ambito <strong>del</strong> restauro forestale non solo gli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> conversione e<br />
trasformazione, ma tutte quelle operazioni che possono migliorare la gestione tra<strong>di</strong>zionale dei<br />
boschi cedui.<br />
Strategie <strong>di</strong> mitigazione degli impatti nel governo a ceduo: la selvicoltura<br />
1. Allungamento dei cicli <strong>di</strong> utilizzazione (turni).<br />
L’allungamento <strong>del</strong> turno è una pratica adottata <strong>in</strong> passato non per scelta colturale ma per<br />
con<strong>di</strong>zionamenti <strong>del</strong> mercato. L’aumento <strong>del</strong> numero <strong>di</strong> anni tra un taglio e l’altro ha <strong>in</strong>dubbiamente<br />
effetti positivi; ad esempio riduce l’asportazione degli elementi nutritivi, migliora la fertilità <strong>del</strong> suolo<br />
e non <strong>in</strong>fluisce sulla facoltà pollonifera se non supera una soglia limite variabile da specie a specie,<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>e accresce il potenziale <strong>di</strong> fruttificazione <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e.<br />
Per i cedui <strong>di</strong> leccio l’allungamento dei turni rispetto a quelli consuetu<strong>di</strong>nari ha conseguenze<br />
positive oltre che <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne ecologico anche <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne produttivo consentendo <strong>di</strong> ottenere produzioni<br />
rilevanti senza alcuna <strong>di</strong>fficoltà per la r<strong>in</strong>novazione agamica. L’allungamento <strong>del</strong> turno permette<br />
<strong>in</strong>oltre la riduzione, a parità <strong>di</strong> massa legnosa asportata, <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong>le tagliate con<br />
conseguenze positive sulla qualità <strong>del</strong> paesaggio (HERMANIN e POLLINI 1990, BERNETTI 1995).<br />
DEL FAVERO (2008) suggerisce <strong>di</strong> <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere la durata <strong>del</strong> turno secondo le <strong>di</strong>verse unità<br />
tipologiche: turni <strong>di</strong> 15 anni da adottare nelle leccete tipiche, <strong>di</strong> 25-30 anni nelle leccete con<br />
orniello, carp<strong>in</strong>o nero e roverella e turni > 30 anni nelle leccete dove compaiono gli elementi<br />
termofili <strong>del</strong>la macchia e la sughera. Per la roverella e il cerro la durata <strong>del</strong> turno dovrebbe essere<br />
<strong>di</strong> 18-20 anni secondo una l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> tendenza <strong>in</strong> atto da alcuni anni, ciò evita tra l’altro la<br />
semplificazione <strong>del</strong>la composizione a scapito <strong>del</strong>le specie meno efficienti nell’uso <strong>del</strong>le risorse<br />
idriche, conservando sempre buoni livelli produttivi (BIANCHI e LA MARCA 1984). Per le altre tipologie<br />
<strong>di</strong> boschi ci si può orientare sui seguenti valori:<br />
-18 anni per gli orno-ostrieti,<br />
-30-50 anni per il castagno (<strong>in</strong> effetti, sono sempre molto richiesti dal mercato anche<br />
assortimenti provenienti da cedui con turni <strong>di</strong> 15 anni),<br />
-30 anni per il faggio.<br />
n Matric<strong>in</strong>atura<br />
Nella scelta <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e bisogna tener conto che queste oggi non svolgono solo una<br />
funzione riproduttiva, ma anche <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità (vegetale e animale) e<br />
contribuiscono a determ<strong>in</strong>are il valore estetico e tecnologico <strong>del</strong> popolamento. La scelta <strong>del</strong>le<br />
matric<strong>in</strong>e deve pertanto essere orientata maggiormente dagli aspetti qualitativi anziché<br />
quantitativi, secondo questi criteri:<br />
La specie: nella scelta, oltre alle specie che costituiscono la componente pr<strong>in</strong>cipale <strong>del</strong> bosco,<br />
occorre considerare anche le specie arboree spora<strong>di</strong>che o a legname pregiato o <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse<br />
faunistico (ad esempio la sughera nella macchia me<strong>di</strong>terranea; la rovere, sorbi e ciliegi nei cedui <strong>di</strong><br />
cerro; l’acero montano, il frass<strong>in</strong>o maggiore, sorbi e ciliegi nei cedui <strong>di</strong> faggio).<br />
L’orig<strong>in</strong>e: sono da preferire i soggetti <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e gamica.<br />
La forma <strong>del</strong> fusto: deve essere dritto, privo <strong>di</strong> rami nella metà <strong>in</strong>feriore, la forma <strong>del</strong>la chioma<br />
deve essere equilibrata-simmetrica, nel complesso la matric<strong>in</strong>a deve essere <strong>in</strong> buono stato<br />
vegetativo.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e: il <strong>di</strong>ametro deve essere > 13 cm (LA MARCA et al. 1995), il<br />
rapporto <strong>di</strong> snellezza (rapporto tra l’altezza totale <strong>del</strong>la pianta e il <strong>di</strong>ametro a 1.30 m) deve essere<br />
basso (< 0.75 per le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> cerro secondo MANZARI e MORETTI 1988).<br />
L’età <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e: pari a 1 e 2 turni <strong>del</strong> ceduo.<br />
Il numero <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e: < 80 soggetti a ettaro nel caso <strong>del</strong> leccio e <strong>del</strong>le querce caducifoglie.<br />
Il grado <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e: < 50%.<br />
La modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura: uniforme, a gruppi (GROHMANN et al. 2002), a<br />
fasce.<br />
3. Altre misure da considerare per una gestione razionale:<br />
- la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le specie arboree consociate,
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 9<br />
- il rilascio dei residui <strong>del</strong>la lavorazione <strong>in</strong> cordonate, soprattutto nei terreni <strong>in</strong> pendenza, dove<br />
non vi sia il rischio <strong>di</strong> <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> agenti patogeni,<br />
- la cura <strong>del</strong>le modalità <strong>di</strong> taglio <strong>del</strong>le ceppaie: l’emissione <strong>di</strong> polloni veri è facilitato dalla<br />
ceduazione bassa e dal taglio durante il periodo <strong>di</strong> riposo vegetativo;<br />
- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> transito e <strong>di</strong> pascolo nei 3-4 anni successivi al taglio;<br />
- il <strong>di</strong>vieto <strong>del</strong>l’utilizzo <strong>in</strong>tegrale <strong>del</strong>la biomassa epigea (full-tree logg<strong>in</strong>g), almeno nelle zone<br />
sensibili per pendenza elevata e rischi <strong>di</strong> erosione.<br />
Strategie <strong>di</strong> mitigazione degli impatti nel governo a ceduo: la pianificazione territoriale<br />
Nel caso particolare dei cedui matric<strong>in</strong>ati, <strong>in</strong> aree particolarmente sensibili, si può prevedere <strong>di</strong><br />
evitare la omogeneizzazione degli <strong>in</strong>terventi (conversioni, ceduazioni, ecc.): ossia procedere a una<br />
zonizzazione <strong>del</strong> territorio dei possibili <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> rapporto a scelte gestionali e ai <strong>di</strong>versi effetti<br />
prodotti sul paesaggio.<br />
Ampiezza <strong>del</strong>la tagliata<br />
Alla <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>la tagliata sono legati aspetti <strong>di</strong> sostenibilità economica ed ecologica<br />
<strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento. Da essa <strong>in</strong>fatti <strong>di</strong>pende la quantità <strong>di</strong> massa legnosa prelevabile e l’organizzazione<br />
<strong>del</strong> cantiere e i riflessi sul piano ecologico e paesaggistico. La valutazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>mensione<br />
massima <strong>del</strong>la tagliata è qu<strong>in</strong><strong>di</strong> molto complessa perché <strong>di</strong>pende da molti fattori.<br />
A titolo <strong>di</strong> orientamento, per limitare gli impatti sull’ambiente, le superfici <strong>del</strong>le tagliate<br />
dovrebbero essere 30%. La contiguità tra una tagliata e quella successiva dovrebbe essere non<br />
<strong>in</strong>feriore a 3 anni.<br />
Forma <strong>del</strong>la tagliata<br />
La forma, per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne estetico ed ecologico, dovrebbe essere più larga che lunga<br />
oppure la tagliata potrebbe essere <strong>in</strong>terposta a una matric<strong>in</strong>atura a fasce o a fasce boscate non<br />
tagliate secondo le curve <strong>di</strong> livello (DEL FAVERO 2008). Ampiezza e forma <strong>del</strong>la tagliata sono <strong>in</strong><br />
relazione anche con il danno da brucatura da parte <strong>di</strong> ungulati selvatici (GIOVANNINI et al. 2003):<br />
meglio una tagliata <strong>di</strong> 5 ettari che c<strong>in</strong>que <strong>di</strong> 1 ettaro, riducendo gli ecotoni si riduce l’attrattività per<br />
gli ungulati.<br />
Restrizioni particolari<br />
Ulteriori limitazioni all’ampiezza <strong>del</strong>le tagliate potrebbero essere <strong>in</strong>trodotte non solo <strong>in</strong> funzione<br />
<strong>del</strong>la pendenza, ma anche <strong>del</strong>l’ero<strong>di</strong>bilità dei suoli, <strong>del</strong>la morfologia, fertilità, accessibilità, dalla<br />
<strong>di</strong>stanza dai corsi d’acqua e dai cr<strong>in</strong>ali.<br />
Sono <strong>in</strong>oltre da prevedere il rilascio <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> rispetto lungo le strade, i cr<strong>in</strong>ali, i corsi d’acqua e<br />
gli impluvi.<br />
In situazioni particolarmente degradate e <strong>in</strong>accessibili occorre valutare l’opportunità <strong>di</strong> lasciare i<br />
popolamenti all’evoluzione naturale.<br />
Nelle aree visibili da strade la tagliata <strong>di</strong> un ceduo emerge chiaramente sullo sfondo almeno nei<br />
primi due anni dopo il taglio per cui si possono mettere <strong>in</strong> atto una serie <strong>di</strong> misure (ampiezza e<br />
forma <strong>del</strong>la tagliata, tipo <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura, marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la tagliata ecc.), variabili <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong> grado<br />
<strong>di</strong> visibilità, per ridurre gli impatti soprattutto nelle zone ad alta valenza turistica.<br />
Un caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o relativo all’impatto visivo <strong>di</strong> attività selvicolturali sul paesaggio è stato condotto<br />
nel Parco Regionale <strong>del</strong>le Serre (Calabria), ve<strong>di</strong> nota allegata <strong>di</strong> SCARFÒ e MERCURIO.<br />
Recupero <strong>di</strong> attività selvicolturali tra<strong>di</strong>zionali<br />
Il ceduo a sterzo, caso dei boschi <strong>di</strong> faggio<br />
A seguito <strong>di</strong> cambiamenti sociali ed economici che hanno determ<strong>in</strong>ato il progressivo abbandono<br />
<strong>del</strong> trattamento a sterzo nei boschi <strong>di</strong> faggio, negli ultimi anni si è fatta presente la necessità <strong>di</strong><br />
sod<strong>di</strong>sfare le esigenze <strong>del</strong>l’uso civico <strong>di</strong> legnatico con l’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong> non pregiu<strong>di</strong>care la qualità<br />
<strong>del</strong>l’ambiente. Per questo è stata valutata l’opportunità <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>are il trattamento <strong>del</strong> taglio a<br />
sterzo (COPPINI e HERMANIN 2007).<br />
In esperienze per il recupero <strong>del</strong> trattamento a sterzo <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> faggio <strong>in</strong>vecchiati COPPINI e<br />
HERMANIN (2007) e COPPINI et al. (2008), hanno messo a confronto varie tesi:
10<br />
Roberto Mercurio<br />
-<strong>in</strong>tervento moderato: si asporta un solo pollone <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni per ceppaia,<br />
-<strong>in</strong>tervento <strong>in</strong>cisivo: si asporta quasi tutto il piano dom<strong>in</strong>ante (polloni e matric<strong>in</strong>e) e <strong>di</strong>radamento<br />
dei polloni <strong>in</strong>terme<strong>di</strong> e dom<strong>in</strong>ati,<br />
-<strong>in</strong>tervento geometrico: si asportano i polloni <strong>di</strong> una metà <strong>del</strong>la ceppaia.<br />
Esse sono state applicate <strong>in</strong> soprassuoli (con polloni più vecchi <strong>del</strong>l’età <strong>di</strong> 60 anni) con:<br />
1. utilizzazioni ritardate f<strong>in</strong>o a 10 anni oltre il limite normale <strong>di</strong> ceduazione,<br />
2. utilizzazioni ritardate f<strong>in</strong> da 10 a 20 anni oltre il limite normale <strong>di</strong> ceduazione,<br />
3. utilizzazioni ritardate f<strong>in</strong>o a oltre 20 anni rispetto al limite normale <strong>di</strong> ceduazione.<br />
L’<strong>in</strong>tervento moderato è quello che fornisce il maggior <strong>in</strong>cremento <strong>di</strong> volume a ettaro.<br />
Il ricaccio <strong>del</strong>le ceppaie tagliate a sterzo è stato <strong>in</strong> genere buono, mentre nelle ceppaie (<strong>di</strong><br />
confronto) tagliate a raso il ricaccio è stato scarso o assente.<br />
Da queste esperienze COPPINI et al. (2008) hanno proposto il trattamento a sterzo semplificato<br />
alternato. Esso si articola <strong>in</strong> due perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> curazione (<strong>di</strong> 14 e 19 anni) <strong>in</strong> cui viene sud<strong>di</strong>viso il turno,<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> nella ceppaia ci sono solo due classi cronologiche rispetto alle tre <strong>del</strong> trattamento classico:<br />
-taglio <strong>di</strong> tutti polloni e rilascio <strong>di</strong> un solo pollone per ceppaia,<br />
-taglio <strong>del</strong> pollone <strong>di</strong> maggiore <strong>di</strong>mensione e rilascio <strong>di</strong> tutti gli altri.<br />
Il taglio alla caronese<br />
Un trattamento simile è il taglio alla caronese <strong>di</strong>ffuso nelle Caronie <strong>in</strong> Sicilia. Al momento <strong>del</strong><br />
taglio allo scadere <strong>del</strong> turno viene rilasciato su ogni ceppaia un pollone per essere tagliato allo<br />
scadere <strong>di</strong> quello successivo, lo scopo <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> pollone non è quello <strong>di</strong> svolgere la funzione<br />
<strong>di</strong> matric<strong>in</strong>a ma solo <strong>di</strong> poter ottenere assortimenti <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni.<br />
Trasformazione da ceduo semplice a ceduo a sterzo, caso dei cedui <strong>di</strong> faggio<br />
I vantaggi <strong>di</strong> questa operazione risiedono nel fatto che è possibile conservare nel tempo la<br />
vitalità <strong>del</strong>le ceppaie e mantenere costante la copertura <strong>del</strong> terreno. POGGI (1960) <strong>in</strong> esperienze<br />
realizzate nell’Appenn<strong>in</strong>o toscano propone <strong>di</strong> eseguire, <strong>in</strong> un ceduo trattato a taglio raso maturo,<br />
tre <strong>in</strong>terventi successivi <strong>di</strong>stanziati a 1/3 <strong>del</strong> turno <strong>di</strong> 24 anni creando così tre classi cronologiche.<br />
Conversione <strong>del</strong> ceduo matric<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> ceduo composto<br />
Metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura progressiva<br />
Allo scadere <strong>del</strong> turno si taglia il ceduo, si rilasciano un certo numero <strong>di</strong> allievi e matric<strong>in</strong>e <strong>in</strong><br />
modo da portare il numero e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le varie classi cronologiche verso quelle prestabilite<br />
dal ceduo composto e conseguire l’equilibrio tra la “fustaia” e il “ceduo” (CIANCIO e NOCENTINI<br />
2004). Le matric<strong>in</strong>e devono essere quelle con le migliori caratteristiche fenotipiche sia <strong>del</strong>la specie<br />
pr<strong>in</strong>cipale che <strong>di</strong> altre presenti, <strong>di</strong>stribuite uniformemente sulla superficie (CIANCIO et al.1983).<br />
Riprist<strong>in</strong>o <strong>del</strong> ceduo composto<br />
In molte zone <strong>del</strong>l’Italia centrale i cedui composti <strong>di</strong> querce caducifoglie, a causa <strong>del</strong>la<br />
sospensione <strong>del</strong>le ceduazioni e <strong>di</strong> tagli impropri, presentano una struttura atipica non ben<br />
def<strong>in</strong>ibile: il ceduo tende a scomparire per effetto <strong>del</strong>lo squilibrio creatosi con la fustaia. Un<br />
chiarimento term<strong>in</strong>ologico da un punto <strong>di</strong> vista selvicolturale è necessario. Il ceduo composto non<br />
va confuso con il “ceduo <strong>in</strong>tensamente matric<strong>in</strong>ato” risultato dal modo <strong>in</strong> cui, dagli anni ’70 almeno<br />
nell’Italia centrale, veniva fatto rilasciare un numero <strong>di</strong> allievi e matric<strong>in</strong>e assai superiore a quello<br />
previsto dalle norme forestali. Una matric<strong>in</strong>atura che superi i 150 soggetti a ettaro deprime oltre<br />
che la crescita dei polloni anche la vitalità <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong>mostrandosi negativa per la<br />
conservazione e la produzione <strong>del</strong> ceduo.<br />
I cambiamenti economici e sociali (deruralizzazione, mancanza <strong>di</strong> manodopera specializzata)<br />
hanno messo <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione la vali<strong>di</strong>tà attuale <strong>di</strong> tale forma <strong>di</strong> gestione. Tuttavia il mantenimento<br />
<strong>del</strong> ceduo composto si giustifica, soprattutto <strong>in</strong> alcune aree ad alta valenza storica e turistica (ad<br />
esempio il Chianti, Toscana), per conservare l’identità paesaggistica e culturale. Ma non solo. La<br />
rivalutazione <strong>del</strong> ceduo composto trova <strong>in</strong>teresse per la valorizzazione <strong>di</strong> quei prodotti e sapori<br />
locali tra<strong>di</strong>zionali come le carni <strong>di</strong> su<strong>in</strong>o (C<strong>in</strong>ta senese e comunque su<strong>in</strong>i neri) allevato allo stato<br />
brado nei querceti. Inoltre:
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 11<br />
-per mantenere la produzione legnosa da dest<strong>in</strong>are alla produzione <strong>di</strong> energia r<strong>in</strong>novabile<br />
(filiera corta),<br />
-per valorizzare le attività venatorie (c<strong>in</strong>ghiali),<br />
-per consentire la costante copertura <strong>del</strong> suolo che attenua gli effetti <strong>del</strong> taglio e valorizza<br />
l’ambiente.<br />
Le opere <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>o si possono cosi riassumere.<br />
La matric<strong>in</strong>atura è l’elemento fondamentale <strong>di</strong> una gestione <strong>del</strong> ceduo composto. Lo<br />
svecchiamento <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> 5-6 turni e oltre è <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile per mantenere la fisionomia <strong>del</strong><br />
ceduo composto e per rivitalizzare il ceduo; si pone tuttavia il problema <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> ricaccio<br />
<strong>del</strong>le ceppaie <strong>in</strong>vecchiate. BERNETTI (1987) ritiene che nelle ceppaie <strong>di</strong> cerro e roverella, con<br />
<strong>di</strong>ametri <strong>di</strong> 40-45 cm, si possono avere alte probabilità <strong>di</strong> un mancato ricaccio. Esperienze<br />
riguardanti il taglio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> più turni <strong>in</strong> cedui composti <strong>di</strong> cerro, hanno messo <strong>in</strong> evidenza<br />
che, dopo 2 anni dal taglio, la mortalità <strong>del</strong>le ceppaie <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e più vecchie era circa <strong>del</strong> 20%<br />
(BIANCHI e GIOVANNINI 2006). Prove sperimentali <strong>in</strong> cedui composti <strong>di</strong> roverella e leccio nel Chianti<br />
senese, con eccesso numerico <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong>le classi adulte, hanno mostrato che il taglio <strong>di</strong> tali<br />
soggetti dà comunque luogo, <strong>in</strong> alta percentuale (60%), all’emissione <strong>di</strong> nuovi polloni (BECAGLI et<br />
al. 2006).<br />
Diversamente, la tramarratura <strong>del</strong>le ceppaie e l’allevamento successivo dei migliori polloni dà<br />
sempre buoni risultati (GAMBI e PROIETTI PLACIDI 1991).<br />
Le specie più <strong>in</strong><strong>di</strong>cate per costituire la matric<strong>in</strong>atura sono quelle che hanno un frutto più<br />
appetibile (roverella), migliori qualità tecnologiche <strong>del</strong> legno (farnia, rovere, farnetto), maggiori<br />
esigenze <strong>di</strong> luce (roverella vs cerro). Il numero <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, considerando le funzioni <strong>in</strong><strong>di</strong>cate,<br />
dovrebbe essere <strong>di</strong> (80) 120 (140) a ettaro, <strong>di</strong>stribuite <strong>in</strong> 4 (5) classi cronologiche. Il numero <strong>del</strong>le<br />
matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse classi cronologiche (<strong>di</strong> età crescente), considerato un turno <strong>di</strong> 20 anni, può<br />
essere 40-30-30-20. In concomitanza <strong>del</strong> taglio <strong>del</strong> ceduo si elim<strong>in</strong>ano le matric<strong>in</strong>e deperienti e a<br />
chioma espansa per sostituirle ciascuna con uno o due allievi. Il grado <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e,<br />
per assicurare il buon funzionamento <strong>del</strong> sistema, deve essere <strong>in</strong>feriore al 60% (PATRONE 1940).<br />
Molta attenzione va riservata alla qualità <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e. Occorre privilegiare gli allievi (o<br />
matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la I classe) nati da seme e comunque i soggetti senza danni <strong>di</strong> natura biotica e<br />
abiotica, con chioma equilibrata, <strong>in</strong>serita <strong>in</strong> alto, con fusto dritto e basso rapporto ipso-<strong>di</strong>ametrico.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e nello spazio deve essere uniforme.<br />
LA MARCA (2006), a seguito <strong>di</strong> prove comparative eseguite <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> leccio <strong>del</strong> Gargano, ritiene<br />
che il ceduo composto (140 matric<strong>in</strong>e a ettaro) fornisca un’elevata produzione <strong>di</strong> ghianda adatta<br />
per l’alimentazione <strong>del</strong>la fauna selvatica e <strong>del</strong> bestiame, offra una buona stabilità fisica <strong>del</strong>le piante<br />
ed anche una significativa produzione legnosa; <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, rispetto al ceduo più o meno <strong>in</strong>tensamente<br />
matric<strong>in</strong>ato garantisca effetti positivi anche dal punto <strong>di</strong> vista paesaggistico-ambientale.<br />
Nei boschi dove il grado <strong>di</strong> copertura è <strong>in</strong>feriore al 50% occorre procedere con sem<strong>in</strong>e e/o<br />
piantagioni <strong>di</strong> latifoglie <strong>del</strong>la stessa serie <strong>di</strong>namica, usando materiale vivaistico <strong>di</strong> provenienza<br />
locale. Dopo questi <strong>in</strong>terventi il pascolo <strong>di</strong> animali domestici deve essere escluso per almeno 5<br />
anni, provve<strong>di</strong>menti devono essere presi anche a protezione dalla fauna selvatica.<br />
Conversione dei cedui <strong>in</strong> fustaia<br />
La conversione dei cedui <strong>in</strong> fustaia si può attuare <strong>in</strong> determ<strong>in</strong>ate situazioni strutturali e<br />
ambientali: ad esempio laddove il soprassuolo ha già un’età avanzata e una buona <strong>di</strong>fferenziazione<br />
sociale per <strong>in</strong>terruzione <strong>del</strong>le ceduazioni, nelle stazioni favorevoli per giacitura e <strong>di</strong> buona fertilità,<br />
per precise scelte gestionali (uso turistico, esigenze <strong>di</strong> gestione faunistica, conservazione <strong>di</strong><br />
specie arboree <strong>di</strong> particolare <strong>in</strong>teresse, barriere visive, ecc.) e più <strong>in</strong> generale <strong>di</strong> carattere<br />
ambientale e paesaggistico.<br />
I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conversione applicati <strong>in</strong> Italia sono i seguenti:<br />
• Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conversione per via naturale.<br />
• Da ceduo semplice o matric<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> fustaia coetanea.<br />
- Metodo <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>vecchiamento. Nella sua formulazione orig<strong>in</strong>aria (LORENZ e PARADE 1837) si<br />
prevede <strong>di</strong> far <strong>in</strong>vecchiare il ceduo f<strong>in</strong>o a quando non abbia perduto la sua capacità pollonifera. Si<br />
eseguono solo leggeri <strong>di</strong>radamenti a carattere sanitario prima <strong>di</strong> arrivare ai tagli <strong>di</strong> conversione.<br />
Secondo AMORINI e FABBIO (1993) non si tratta <strong>di</strong> un vero e proprio metodo perché non prevede la<br />
esecuzione <strong>di</strong> alcun <strong>in</strong>tervento, ma si basa sull’abbandono colturale <strong>del</strong> ceduo <strong>in</strong> attesa che
12<br />
Roberto Mercurio<br />
pressione selettiva e concorrenza esplich<strong>in</strong>o completamente la loro azione f<strong>in</strong>o al compimento <strong>del</strong><br />
ciclo biologico degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui residui e l’affermazione <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione naturale.<br />
- Metodo <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento (AMORINI e FABBIO 1987, 1988). Si rifà al precedente con la<br />
<strong>di</strong>fferenza che, dopo un periodo <strong>di</strong> attesa oltre lo scadere <strong>del</strong> turno <strong>del</strong> ceduo, è prevista una serie<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti (3-4) dal basso o misti, moderati (con funzione <strong>di</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento all’alto fusto il<br />
primo e <strong>di</strong> perfezionare successivamente il cambiamento <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong> bosco con i<br />
<strong>di</strong>radamenti successivi). La densità <strong>del</strong> soprassuolo transitorio si mantiene relativamente elevata<br />
per non favorire il ricaccio <strong>del</strong>le ceppaie. La struttura è monoplana. Il taglio <strong>di</strong> conversione vero e<br />
proprio segue le procedure dei tagli a buche o dei tagli successivi e il taglio <strong>di</strong> sementazione si<br />
esegue quando le piante sono <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>are abbondantemente e le ceppaie hanno perso<br />
la capacità pollonifera.<br />
- Metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong>tensiva (AUBERT 1920). Poco dopo lo scadere <strong>del</strong> turno <strong>del</strong><br />
ceduo si esegue un primo <strong>di</strong>radamento dall’alto, molto forte (elim<strong>in</strong>ando le matric<strong>in</strong>e più vecchie e<br />
malformate), e si rilascia un numero elevato tra allievi e matric<strong>in</strong>e propriamente dette (500-600<br />
soggetti a ettaro). Seguono altri <strong>di</strong>radamenti (1-2) e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e i tagli <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione che si eseguono<br />
<strong>in</strong>torno ai 60 anni. Questo metodo è adatto alla proprietà privata perché attenua il sacrificio<br />
economico <strong>in</strong> quanto è possibile ottenere red<strong>di</strong>ti dalle ceduazioni durante il cambiamento <strong>del</strong><br />
governo e si abbrevia la fase transitoria.<br />
Da ceduo semplice o matric<strong>in</strong>ato o composto <strong>in</strong> fustaia <strong>di</strong>setanea<br />
Metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura progressiva<br />
Si attua nei casi <strong>in</strong> cui non si vuole sospendere imme<strong>di</strong>atamente l’utilizzazione <strong>del</strong> ceduo. Con<br />
questo metodo viene rilasciato un numero crescente (progressivo) <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e (<strong>in</strong> realtà polloni<br />
meglio conformati) (100-150) ad ogni utilizzazione <strong>del</strong> ceduo f<strong>in</strong>o ad ottenere una struttura<br />
<strong>di</strong>setaneiforme <strong>in</strong> cui la r<strong>in</strong>novazione da seme viene favorita applicando un trattamento assimilabile<br />
al taglio saltuario (CIANCIO et al. 1983).<br />
Caso <strong>del</strong>la conversione dei cedui <strong>di</strong> faggio<br />
Nei cedui che hanno superato i 40-50 anni, sufficientemente densi e ben sviluppati <strong>in</strong> altezza, <strong>in</strong><br />
presenza <strong>di</strong> specie <strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong> buone con<strong>di</strong>zioni pedologiche (Galium odoratum, Sanicula europaea,<br />
ecc.), su suolo profondo, su pendenze moderate e lontano dai cr<strong>in</strong>ali, è opportuno orientarsi verso<br />
la conversione <strong>in</strong> fustaia poiché molte ceppaie potrebbero non riprendersi dopo il taglio.<br />
Il metodo <strong>di</strong> conversione più appropriato è quello <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento che ha avuto<br />
maggiore <strong>di</strong>ffusione <strong>in</strong> Italia. Gli <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong>iziano dopo un periodo <strong>di</strong> attesa <strong>di</strong> 1.5-2 volte il turno e<br />
consistono nel taglio <strong>di</strong> avviamento e <strong>in</strong> perio<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>radamenti dal basso (o misti), tesi a selezionare<br />
sulla ceppaia i polloni migliori, dom<strong>in</strong>anti, che costituiranno il soprassuolo transitorio. Con il primo<br />
<strong>in</strong>tervento si rilasciano circa 1500-2400 polloni ad ettaro, 1-2 per ceppaia. Le matric<strong>in</strong>e più<br />
sviluppate vengono rimosse gradualmente. Seguono alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa 10 anni altri <strong>di</strong>radamenti<br />
<strong>in</strong> modo da rilasciare 800-1000 polloni ad ettaro. I tagli <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione (tagli <strong>di</strong> conversione veri e<br />
propri) avvengono <strong>in</strong>torno a 80 anni. In altre parole, <strong>in</strong>torno a questa età, costatate con<strong>di</strong>zioni<br />
pedologiche e microclimatiche favorevoli ad accogliere la r<strong>in</strong>novazione naturale, si <strong>in</strong>izia con un<br />
taglio <strong>di</strong> sementazione cui segue la serie dei tagli previsti dal sistema a tagli successivi. Con<br />
questo modo <strong>di</strong> procedere si ottiene una fustaia coetanea monoplana.<br />
Tra gli altri meto<strong>di</strong> applicati si <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guono: il metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong>tensiva nei cedui <strong>del</strong>la<br />
Sila (AVOLIO e CIANCIO 1991) e il metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura progressiva <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> faggio<br />
<strong>del</strong>l’Appenn<strong>in</strong>o toscano (CIANCIO e NOCENTINI 2004).<br />
Alcuni Autori (WOLYNSKI 2002, DE TURCKEIM 2003) consigliano <strong>di</strong> orientarsi verso una struttura<br />
multiplana (<strong>di</strong>setanea <strong>in</strong> senso lato) per assicurare ai soprassuoli una maggiore stabilità, resilienza,<br />
una produzione legnosa <strong>di</strong> maggior valore con m<strong>in</strong>ori impatti ambientali e paesaggistici. Questo<br />
obiettivo si può conseguire me<strong>di</strong>ante <strong>in</strong>terventi frequenti e leggeri che consentono la valorizzazione<br />
dei soggetti migliori liberandoli dai competitori, l’apertura <strong>di</strong> piccole buche (nei tratti più adulti) per<br />
favorire la r<strong>in</strong>novazione anche <strong>di</strong> altre latifoglie <strong>di</strong> pregio.<br />
Conversione dei cedui <strong>di</strong> cerro<br />
Tra i meto<strong>di</strong> proposti, quello che ha avuto la maggiore <strong>di</strong>ffusione <strong>in</strong> Italia è il metodo <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong><br />
avviamento (AMORINI e FABBIO 1987, 1988, 1989, AMORINI et al. 2006). Consiste nel <strong>di</strong>radamento<br />
<strong>del</strong>le ceppaie <strong>del</strong> ceduo “<strong>in</strong>vecchiato” rispetto all’età m<strong>in</strong>ima prevista (da ¼ a ½ <strong>del</strong> turno) con un
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 13<br />
<strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> tipo basso o misto che seleziona i migliori soggetti per costituire una struttura<br />
monoplana a densità sufficientemente elevata (1500-2500 piante ad ettaro), segue dopo 10-15<br />
anni un <strong>di</strong>radamento per perfezionare l’assetto strutturale <strong>del</strong> soprassuolo e poi altri <strong>di</strong>radamenti<br />
(3-4) alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 15-20 anni f<strong>in</strong>o ad arrivare ai tagli <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione (taglio <strong>di</strong> conversione vero e<br />
proprio).<br />
Altre sperimentazioni hanno riguardato:<br />
-sempre con il metodo <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento, LA MARCA et al. (2009 b), <strong>in</strong> esperienze <strong>del</strong><br />
Gargano <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro <strong>di</strong> circa 40 anni, hanno messo a confronto tesi con rilascio<br />
<strong>di</strong> 1200-1600 soggetti ad ettaro.<br />
-Metodo <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong>tensiva, sensu AMORINI e FABBIO (1993), (rilascio con il primo<br />
<strong>di</strong>radamento <strong>di</strong> 500/600-800 soggetti ad ettaro) applicato nei cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro <strong>del</strong><br />
Gargano da LA MARCA et al. (2002, 2009 a).<br />
-Metodo <strong>di</strong> MAGINI (<strong>in</strong>e<strong>di</strong>to, <strong>in</strong> GIANNINI e PIUSSI 1976) applicato nei cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro<br />
<strong>del</strong>la Toscana da GUIDI (1976) e monitorato nella sua applicazione da FABBIO e AMORINI (2006).<br />
Le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>di</strong> CUTINI e BENVENUTI (1996), CUTINI (1997), DI MATTEO et al. (2009) su tagli <strong>di</strong><br />
avviamento nei cedui <strong>di</strong> cerro hanno <strong>di</strong>mostrato che migliorano la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> risorse idriche <strong>del</strong><br />
popolamento.<br />
Queste esperienze hanno mostrato che l’avviamento all’alto fusto <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fertilità me<strong>di</strong>obuone<br />
è sostenibile da un punto <strong>di</strong> vista economico e capace <strong>di</strong> accelerare ulteriormente il<br />
cambiamento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo verso strutture più articolate e complesse.<br />
Conversione dei cedui <strong>di</strong> leccio<br />
Tra i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conversione sperimentati vi è quello <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento (AMORINI et al.<br />
1996). Secondo DEL FAVERO (2008) si può applicare ai cedui <strong>di</strong> leccio anche il metodo <strong>del</strong>la<br />
matric<strong>in</strong>atura progressiva, rilasciando al momento <strong>del</strong> taglio <strong>del</strong> ceduo oltre agli usuali 100 allievi<br />
anche altre 20-25 matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong> ciclo precedente, passando cioè attraverso la fase a ceduo<br />
composto.<br />
Molti Autori (DUCREY e TOTH 1992, CUTINI e MASCIA 1996, FABBIO et al. 1996, AMORINI et al.<br />
1996, DAFIS e KAKOUROS 2006) concordano che l’avviamento all’alto fusto favorisce<br />
un’organizzazione strutturale più complessa e una migliore funzionalità dei popolamenti.<br />
Esperienze <strong>di</strong> conversione eseguite <strong>in</strong> Aspromonte <strong>in</strong> cedui matric<strong>in</strong>ati <strong>di</strong> 30 anni hanno messo a<br />
confronto: a) <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> debole <strong>in</strong>tensità ripetuti a brevi <strong>in</strong>tervalli <strong>di</strong> tempo, b) rilascio sulle ceppaie<br />
dom<strong>in</strong>ate dei polloni con altezza > 3-3.5 m e rilascio sulle ceppaie dom<strong>in</strong>anti <strong>di</strong> uno o due polloni<br />
scelti fra quelli fenotipicamente migliori. I primi risultati hanno messo <strong>in</strong> evidenza che nel primo<br />
caso, prelevando il 30% <strong>del</strong>la massa (circa il 60% <strong>in</strong> numero <strong>di</strong> polloni), non si alterano<br />
significativamente le con<strong>di</strong>zioni strutturali <strong>del</strong> soprassuolo né l’efficacia <strong>del</strong>la conservazione <strong>del</strong><br />
suolo né si provoca un impatto negativo dal punto <strong>di</strong> vista ambientale e paesaggistico (IOVINO e<br />
MENGUZZATO 2001, CIANCIO et al. 2002).<br />
Le ricerche <strong>di</strong> LA MARCA et al. (2008), <strong>in</strong> prove comparative <strong>di</strong> trattamento su cedui <strong>di</strong> leccio <strong>del</strong><br />
Gargano, hanno mostrato che gli <strong>in</strong>crementi registrati nelle aree sottoposte a conversione risultano<br />
nettamente superiori rispetto ai valori calcolati per le aree lasciate ad evoluzione naturale. COTILLAS<br />
et al. (2009) hanno <strong>di</strong>mostrato che i <strong>di</strong>radamenti nei cedui <strong>di</strong> leccio migliorano lo stato idrico <strong>in</strong><br />
ambiente me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conversione per via artificiale.<br />
Si procede al taglio <strong>del</strong> ceduo e si provvede subito dopo all’<strong>in</strong>troduzione <strong>di</strong> latifoglie e/o conifere<br />
(<strong>di</strong>verse da quelle <strong>del</strong> popolamento esistente che si presuppongono più <strong>in</strong>teressanti per rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
accrescimento o qualità tecnologica <strong>del</strong> legno) me<strong>di</strong>ante sem<strong>in</strong>a o piantagione. Questa procedura,<br />
ampiamente utilizzata <strong>in</strong> passato, trova oggi scarsa applicazione <strong>in</strong> Italia.<br />
I boschi degradati da <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o e pascolo<br />
Le comunità vegetali me<strong>di</strong>terranee sono state def<strong>in</strong>ite come resilienti al fuoco (LAVOREL 1999),<br />
cioè <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> ricostituirsi <strong>in</strong> seguito al danneggiamento parziale o totale <strong>del</strong>la parte epigea.<br />
Dopo un <strong>di</strong>sturbo le piante possono r<strong>in</strong>novarsi secondo due pr<strong>in</strong>cipali strategie: per ricaccio<br />
<strong>del</strong>le ceppaie e per germ<strong>in</strong>azione <strong>di</strong> semi (PAUSAS 2001, BUHK et al. 2007), sulle quali dovranno<br />
essere stabilite le modalità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento.
14<br />
Roberto Mercurio<br />
Prima <strong>di</strong> decidere il tipo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento può essere utile l’analisi <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o<br />
e valutare il danno biologico sofferto dall’ecosistema (LEONE e LOVREGLIO 2008). In particolare, per<br />
quanto riguarda la valutazione <strong>del</strong> danno biologico, si può fare riferimento ad alcuni parametri che<br />
sono <strong>in</strong> relazione con le caratteristiche <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o, <strong>in</strong> modo da stimare il danno probabile a livello<br />
<strong>di</strong> suolo, vegetazione e fauna, così da avere un buon punto <strong>di</strong> partenza per determ<strong>in</strong>are quando e<br />
come <strong>in</strong>tervenire (BALDINI et al. 2007). Per valutare le possibilità <strong>di</strong> sopravvivenza post-<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o dei<br />
soggetti arborei, oltre ad una stima visuale effettuata <strong>in</strong> tempi <strong>di</strong>versi, si può far riferimento ad<br />
appositi mo<strong>del</strong>li (LEONE e LOVREGLIO 2008), come proposto per la roverella da ANFODILLO et al.<br />
(1997). Completa l’analisi prelim<strong>in</strong>are la verifica <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> recupero <strong>del</strong>la vegetazione <strong>in</strong><br />
seguito al passaggio <strong>del</strong> fuoco (MAZZOLENI e ESPOSITO 2004). Sulla base <strong>di</strong> queste <strong>in</strong>formazioni si<br />
possono decidere le priorità, le zone, i criteri e i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento.<br />
Caso dei boschi <strong>di</strong> querce caducifoglie<br />
La ricostituzione si esplicita nel riprist<strong>in</strong>o <strong>del</strong>la funzionalità dei s<strong>in</strong>goli soggetti e <strong>del</strong><br />
popolamento nel suo complesso ed <strong>in</strong> particolare gli <strong>in</strong>terventi si <strong>di</strong>fferenziano a livello <strong>di</strong>:<br />
-ceppaia: la tramarratura <strong>del</strong>le ceppaie <strong>del</strong>le piante danneggiate (GAMBI e PROIETTI PLACIDI<br />
1991) stimola l’emissione <strong>di</strong> nuovi polloni, a cui segue la selezione dei migliori polloni;<br />
-pianta: rimonda e capitozza tura – raccorciamento <strong>del</strong>le branche pr<strong>in</strong>cipali – <strong>del</strong>la chioma dei<br />
soggetti deperienti;<br />
-popolamento: r<strong>in</strong>foltimento per via artificiale (se il grado <strong>di</strong> copertura è < 50%) con sem<strong>in</strong>e, o<br />
meglio, con piantagioni <strong>di</strong> latifoglie <strong>del</strong>la stessa serie <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> vegetazione: rovere, ciliegio,<br />
sorbo domestico, ciavar<strong>del</strong>lo, acero campestre, acero opalo, farnetto, frass<strong>in</strong>o ossifillo. Nel caso <strong>di</strong><br />
situazioni <strong>di</strong> particolare degrado <strong>di</strong> possono impiegare specie più rustiche (sorbo domestico,<br />
perastro, ecc.) (SARDIN et al. 2003). Il materiale vivaistico oltre che <strong>di</strong> provenienza locale deve<br />
essere <strong>di</strong> buona qualità. Le lavorazioni <strong>del</strong> suolo sono <strong>in</strong> genere localizzate, ma possono essere<br />
più importanti nel caso <strong>di</strong> compattazione provocata dal pascolo per migliorare la struttura <strong>del</strong> suolo.<br />
Circa la <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong>le piant<strong>in</strong>e si può privilegiare la <strong>di</strong>sposizione a gruppi piuttosto che quelle<br />
con sesti regolari.<br />
Il pascolo, e comunque il transito <strong>del</strong> bestiame, va escluso negli anni seguenti (4-5) gli <strong>in</strong>terventi<br />
<strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>o.<br />
Caso dei boschi <strong>di</strong> querce semprever<strong>di</strong><br />
La capacità <strong>di</strong> resilienza al fuoco <strong>di</strong> queste formazioni è molto elevata, anche se la parte epigea<br />
viene completamente elim<strong>in</strong>ata può riformarsi velocemente, per cui gli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>o sono<br />
spesso <strong>di</strong> modesta entità e consistono nell’agevolare il ritorno <strong>del</strong>la vegetazione orig<strong>in</strong>aria.<br />
L’<strong>in</strong>tervento <strong>del</strong>l’uomo ha lo scopo <strong>di</strong> accelerare la ricostituzione dei popolamenti. Le ricerche <strong>di</strong><br />
JACQUET e PRODON (2007) hanno <strong>di</strong>mostrato che il tempo <strong>di</strong> ricostituzione <strong>del</strong> popolamento è <strong>di</strong> 6-<br />
18 anni per i boschi <strong>di</strong> sughera e <strong>di</strong> 40 per quelli <strong>di</strong> leccio, mentre per la ricostituzione <strong>del</strong>l’avifauna<br />
occorrono 5-7 anni nelle sugherete e 30 anni nelle leccete.<br />
Nel caso specifico <strong>del</strong>la ricostituzione dei boschi <strong>di</strong> leccio, oltre agli <strong>in</strong>terventi sopra esposti,<br />
sono risultate efficaci le potature <strong>di</strong> riforma nelle piante deperienti (TRABAUD 1996). Per sollecitare<br />
la pianta ad emettere nuovi polloni ra<strong>di</strong>cali si può applicare un taglio che va sotto il nome <strong>di</strong><br />
débourdage o saut du piquet che consiste nel tagliare i polloni a 20-25 cm da terra e poi nel<br />
percuoterli con il dorso <strong>del</strong>la scure per spaccare la ceppaia (COSTE 1984, GAMBI 1986).<br />
Le sugherete sono formazioni <strong>di</strong> particolare rilevanza ambientale ed economica, per cui la<br />
tecnica <strong>di</strong> coltivazione e <strong>di</strong> recupero si è particolarmente sviluppata <strong>in</strong> tutto il bac<strong>in</strong>o <strong>del</strong><br />
Me<strong>di</strong>terraneo. La sughera è considerata una pirofita passiva <strong>in</strong> quanto grazie alla sua spessa<br />
corteccia può resistere meglio <strong>di</strong> altre latifoglie (ad esempio leccio, roverella) al passaggio <strong>del</strong><br />
fuoco, <strong>in</strong>oltre ha un’ alta capacità <strong>di</strong> recupero dopo l’<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o (LETREUCH-BELAROUCI et al. 2009).<br />
BELTRAN (2004) ritiene che, prima <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervenire dopo il passaggio <strong>del</strong> fuoco, occorra attendere<br />
la primavera e il secondo autunno per valutare lo stato sanitario <strong>di</strong> ogni pianta.<br />
MERCURIO e SABA (1998) riferiscono <strong>di</strong> esperienze <strong>di</strong> ricostituzione <strong>di</strong> sugherete bruciate <strong>in</strong><br />
Sardegna. Gli <strong>in</strong>terventi risultavano <strong>di</strong>versificati <strong>in</strong> rapporto alle <strong>di</strong>verse situazioni dei popolamenti<br />
<strong>in</strong>teressati da una maggiore o m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o. Gli <strong>in</strong>terventi sono stati i seguenti :<br />
a) la tramarratura al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong> colletto. La <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>le ceppaie ltre turno variava tra 8 e<br />
65 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. La mortalità <strong>del</strong>le ceppaie è stata molto ridotta (5-9%).
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 15<br />
b) La potatura <strong>di</strong> formazione su piante ancora non demaschiate. Ha riguardato il taglio dei rami<br />
f<strong>in</strong>o a 2\3 <strong>del</strong>l’altezza <strong>del</strong>la pianta per favorire lo sviluppo <strong>di</strong> una cima unica, vigorosa e dritta, per<br />
migliorare la qualità <strong>del</strong>le plance <strong>di</strong> sughero e per facilitare le operazioni <strong>di</strong> raccolta.<br />
c) La potatura <strong>di</strong> riforma nelle piante più adulte. Ha <strong>in</strong>teressato l’asportazione <strong>del</strong> 40% <strong>del</strong>la<br />
chioma (branche secche, deperienti, ecc.) per stimolare la ripresa vegetativa; la percentuale <strong>di</strong><br />
mortalità è stata <strong>del</strong> 2%.<br />
d) Il r<strong>in</strong>foltimento con sughera o mista al p<strong>in</strong>o marittimo (se il grado <strong>di</strong> copertura è < 50%). E’<br />
stato eseguito me<strong>di</strong>ante una lavorazione localizzata, comprendente <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> preparazione<br />
<strong>del</strong> suolo:<br />
- buche, 1.00 x 1.00 x 0.60 m (profon<strong>di</strong>tà) su pendenze > 40%,<br />
- piazzole, 2.30 x 1.20 x 0.80-1.00 m su pendenze < 25%,<br />
- segmenti <strong>di</strong> gradone 1.00-1.20 x 0,60 m su pendenze <strong>del</strong> 25-40% e con l’apertura <strong>di</strong> buche<br />
tra i gradoni. La percentuale <strong>di</strong> mortalità dei semenzali è stata dall’ 8.2 al 18.7% e le cause sono<br />
riconducibili alla siccità estiva dei tre anni seguenti la piantagione e ai danni provocati dai c<strong>in</strong>ghiali.<br />
Nei segmenti <strong>di</strong> gradone e nelle piazzole é stato registrato un accrescimento più importante dei<br />
semenzali rispetto alle buche a causa <strong>di</strong> una maggiore profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> lavorazione <strong>del</strong> suolo e alla<br />
maggiore capacità <strong>di</strong> ritenuta idrica.<br />
Tra gli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> miglioramento rientrano anche l’estrazione <strong>del</strong> sughero fiammato nell’anno<br />
successivo al passaggio <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o se la pianta è stata decorticata già da alcuni anni e a<br />
con<strong>di</strong>zione che non abbia subito gravi danni, <strong>di</strong>versamente è conveniente la tramarratura (DETTORI<br />
et al. 2001); la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> lotta agli <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>; la sospensione <strong>del</strong> pascolo.<br />
Monitoraggio per la valutazione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong> restauro forestale<br />
Ogni <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> restauro va successivamente monitorato attraverso <strong>in</strong><strong>di</strong>catori ecologici per<br />
valutare il grado <strong>di</strong> funzionamento <strong>del</strong> sistema forestale.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
MERCURIO R. (2010). Appunti per il restauro <strong>del</strong>la foresta me<strong>di</strong>terranea. CLUEB, Bologna (<strong>in</strong><br />
stampa).<br />
NOTA AGGIUNTIVA – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI VISIVI DELLE OPERAZIONI<br />
FORESTALI SUL PAESAGGIO NEL PARCO REGIONALE DELLE SERRE (CALABRIA)<br />
<strong>di</strong> Scarfò Francesco e Mercurio Roberto<br />
Introduzione<br />
Certi <strong>in</strong>terventi selvicolturali comportano, per motivi economico-f<strong>in</strong>anziari, l’ esecuzione <strong>di</strong><br />
tagliate che per le loro caratteristiche (ampiezza, forma, ecc.) possono avere ripercussioni negative<br />
non solo da un punto <strong>di</strong> vista ambientale ma anche estetico-paesaggistico, soprattutto all’<strong>in</strong>terno<br />
<strong>del</strong>le aree protette. Tagliate molto ampie dai conf<strong>in</strong>i regolari sono percepite <strong>in</strong> genere<br />
negativamente come <strong>in</strong>naturali ossia come un’alterazione dei luoghi, almeno <strong>in</strong> certi contesti,<br />
secondo un immag<strong>in</strong>ario <strong>di</strong>ffuso nell’op<strong>in</strong>ione pubblica.<br />
L’obiettivo <strong>di</strong> questo stu<strong>di</strong>o è <strong>di</strong> utilizzare la tecnologia GIS per:<br />
1) valutare la visibilità <strong>del</strong>le operazioni forestali lungo una strada ad alta frequentazione turistica<br />
S.S.110;<br />
2) produrre una mappa <strong>del</strong>la sensitività (sensivity map; sensu Lucas 1991 The design of forest<br />
landscapes. Oxford University Press) <strong>del</strong>le aree visibili;<br />
3) fornire una metodologia per valutare una gestione alternativa <strong>del</strong>le aree maggiormente<br />
esposte e per l’allocazione <strong>del</strong>le risorse.
16<br />
Metodologia<br />
Roberto Mercurio<br />
L’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è situata nelle Serre (Appenn<strong>in</strong>o calabrese) e compresa nel Parco Regionale<br />
<strong>del</strong>le Serre (Fig. 1), dove era stato realizzato <strong>in</strong> precedenza uno stu<strong>di</strong>o sulle tipologie forestali<br />
(Mercurio e Spamp<strong>in</strong>ato 2006, I tipi forestali <strong>del</strong>le Serre calabre, Laruffa).<br />
Fig. 1 Area stu<strong>di</strong>o e dettaglio <strong>in</strong> cui sono messe <strong>in</strong> evidenza le tipologie forestali la S.S.110 e i VP.<br />
Per valutare l’impatto visivo <strong>del</strong>le attività selvicolturali è utilizzata l’analisi <strong>del</strong>la sensitività <strong>del</strong><br />
paesaggio. La sensitività <strong>del</strong> paesaggio deriva da un giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong> paesaggio quando è<br />
visibile dal pubblico e dal grado d’importanza ai f<strong>in</strong>i ricreativi. La valutazione degli impatti<br />
selvicolturali sul paesaggio è funzione <strong>di</strong> molti fattori. In questo lavoro, il paesaggio e le attività<br />
selvicolturali sono state analizzate attraverso i seguenti aspetti: qualità <strong>del</strong> paesaggio forestale e<br />
fragilità visiva <strong>del</strong> paesaggio (visual fragility, Alonso et al. 1983, Visual impact assessment<br />
methodology for <strong>in</strong>dustrial development site review <strong>in</strong> Spa<strong>in</strong>. John Wiley and Sons, New York).<br />
Tutte le analisi sono state condotte con ArcGIS 8.0 (ESRI) che ha consentito <strong>di</strong> produrre gli strati<br />
<strong>in</strong>formativi <strong>in</strong> formato raster necessari per le analisi.<br />
Analisi <strong>del</strong>la visibilità<br />
Consente <strong>di</strong> stabilire le aree visibili da punti prefissati (viewpo<strong>in</strong>t, VP) con l’uso <strong>di</strong> un Digital<br />
Elevation Mo<strong>del</strong> (DEM). Sono stati cosi <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati 6 VP lungo la S.S.110 (raccogliendo le<br />
coor<strong>di</strong>nate geografiche con GPS) mentre il DEM <strong>del</strong>l’area stu<strong>di</strong>o è stato presso il Centro<br />
Cartografico Regionale. IL DEM <strong>in</strong> quanto mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong>gitale <strong>del</strong>la superficie terrestre non tiene conto<br />
<strong>del</strong>la presenza <strong>di</strong> oggetti quali strade, vegetazione, e<strong>di</strong>fici ecc.. Per ovviare a questa limitazione è<br />
stato costruito il Digital Surface Mo<strong>del</strong> (DSM) secondo l’eqn. 1 che tiene <strong>in</strong> considerazione l’altezza<br />
<strong>del</strong>la vegetazione per un’analisi più veritiera:<br />
DSM = [DEM] + [altezza reale sul livello <strong>del</strong> DEM <strong>di</strong> ogni s<strong>in</strong>gola tipologia forestale] (eqn. 1)<br />
Qualità <strong>del</strong> paesaggio forestale<br />
La qualità <strong>del</strong> paesaggio forestale è stata valutata attraverso l’uso <strong>di</strong> un <strong>in</strong><strong>di</strong>ce basato sulle<br />
<strong>in</strong>formazioni ottenute <strong>del</strong>l’analisi tipologica e su una valutazione qualitativa <strong>del</strong>le caratteristiche dei<br />
tipi forestali e connesse con gli aspetti paesaggistici e <strong>di</strong> visibilità (tab. 1):<br />
1) struttura (mono-, bi-, multiplana);<br />
2) composizione specifica (mono-, bi-, plurispecifica);<br />
3) fenologia <strong>del</strong>le specie;
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 17<br />
4) orig<strong>in</strong>e <strong>del</strong>le specie (nativa, non nativa);<br />
5) età (giovane, adulto, vecchio);<br />
6) grado <strong>di</strong> copertura (aperto, semiaperto, chiuso).<br />
Per la valutazione qualitativa è stato messo appunto un sistema basato su tre classi qualitative<br />
(basso, me<strong>di</strong>o, alto) attribuito a ogni caratteristica dei tipi forestali cui è associato un punteggio<br />
(tab. 2):<br />
1 = qualità bassa;<br />
2 = qualità me<strong>di</strong>a;<br />
3 = qualità alta.<br />
In questo modo ogni caratteristica rappresenta una variabile che può variare da 1 a 3.<br />
Analisi <strong>del</strong>la fragilità visiva<br />
L’analisi <strong>del</strong>la fragilità visiva consente <strong>di</strong> analizzare la capacità <strong>del</strong> paesaggio <strong>di</strong> mitigare la<br />
visibilità <strong>del</strong>le operazioni forestali dai VP. Sono state <strong>in</strong><strong>di</strong>viduate 3 caratteristiche <strong>del</strong> paesaggio<br />
che <strong>in</strong>fluenzano la visibilità:<br />
1) la pendenza <strong>del</strong>le aree visibili da VP (PAV);<br />
2) l’altezza me<strong>di</strong>a dei VP rispetto alle aree visibili (AAV);<br />
3) la <strong>di</strong>stanza dei VP rispetto alle aree visibili (DAV).<br />
Tab. 1. Caratteristiche <strong>del</strong>le tipologie forestali utilizzate per la costruzione <strong>del</strong>l’<strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong><br />
paesaggio forestale.<br />
Variabile Caratteristiche Valore<br />
Struttura<br />
Mono-; Bi- ;<br />
Multiplana<br />
1; 2; 3<br />
Composizione Mono-; Bi-;<br />
1; 2; 3<br />
specifica<br />
Plurispecifica<br />
Fenologia<br />
Non appariscenti;<br />
appariscenti<br />
1; 3<br />
Orig<strong>in</strong>e Non nativo; Nativo 1; 3<br />
Età<br />
Giovane; Adulto;<br />
Vecchio<br />
1; 2; 3<br />
Sistema Ceduo; Fustaia; Non 1; 2; 3<br />
selvicolturale<br />
gestito<br />
Grado <strong>di</strong> 81-100%; 51-80 %; 1; 2; 3<br />
copertura<br />
1-50%<br />
Qualità elevata<br />
Massimo<br />
21<br />
Qualità bassa<br />
M<strong>in</strong>imo<br />
7<br />
Tab. 2. Matrice e relativi punteggi per la costruzione <strong>del</strong>l’In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong> paesaggio forestale (1 =<br />
basso; 2 = me<strong>di</strong>o e 3 = qualità elevata).<br />
Variabili Struttura Composizion<br />
e specifica<br />
Variabilità<br />
fenologica<br />
Orig<strong>in</strong>e Età<br />
Sistema<br />
selvicolturale<br />
Grado <strong>di</strong><br />
copertura<br />
Categorie forestali Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val.<br />
Boschi <strong>di</strong> faggio 3 2 3 3 3 2 2 18<br />
Boschi <strong>di</strong> castagno 1 1 3 3 1 1 1 11<br />
Boschi <strong>di</strong> querce<br />
caducifoglie<br />
2 2 1 1 2 2 2 12<br />
Boschi <strong>di</strong> leccio 2 3 1 3 1 1 2 13<br />
Macchie<br />
me<strong>di</strong>terranee ed<br />
arbusteti<br />
Rimboschimenti <strong>di</strong><br />
conifere<br />
Aree agricole e<br />
pascolive<br />
1 1 1 3 1 1 1 9<br />
1 1 1 1 2 2 1 9<br />
1 1 1 1 1 1 2 8<br />
Tot
18<br />
Roberto Mercurio<br />
Come per la qualità <strong>del</strong> paesaggio forestale, anche per quest’analisi sono state attribuite a<br />
ciascuna caratteristica <strong>del</strong> paesaggio <strong>del</strong>le classi <strong>di</strong> visibilità (bassa, me<strong>di</strong>a, alta) associate a un<br />
punteggio (tab. 3): 1 = visibilità bassa; 2 = visibilità bassa; 3 = visibilità alta.<br />
Tab. 3. Caratteristiche <strong>del</strong> paesaggio forestale utilizzate per la costruzione <strong>del</strong>la carta <strong>del</strong>la fragilità visiva.<br />
Variabile Classi <strong>di</strong> impatto Valore<br />
PAV 0-33%; 34-66%; >66 % 1; 2; 3<br />
AAV Aree sopra h me<strong>di</strong>a dei VP; aree sotto h me<strong>di</strong>a dei VP 1; 3<br />
DVP 3001-5000 m; 1001-3000 m; 0-1000 m 1; 2; 3<br />
Fragilità alta<br />
Fragilità<br />
bassa<br />
Massimo<br />
M<strong>in</strong>imo<br />
Per la PAV, sono state rilevate le pendenza massime e m<strong>in</strong>ime, successivamente sono state<br />
create 3 classi: 0-33% = 1; 33-66% = 2; >66% = 3. Per AAV le aree visibili collocate al <strong>di</strong> sopra<br />
<strong>del</strong>l’altezza me<strong>di</strong>a dei VP sono considerate a bassa visibilità (1) mentre quelle al <strong>di</strong> sotto ad alta<br />
visibilità (3). Per DAV è stata scelta la <strong>di</strong>stanza massima entro la quale la visibilità degli <strong>in</strong>terventi<br />
colturali é nulla, successivamente sono state create 3 classi: 0-1000 m = 3; 10001-3000 m = 2;<br />
3001-5000 m = 1.<br />
Analisi <strong>del</strong>la sensitività <strong>del</strong> paesaggio<br />
Quest’analisi riassume tutte le precedenti e <strong>in</strong><strong>di</strong>ca l’impatto visivo potenziale generato dalle<br />
operazioni forestali nelle aree visibili <strong>in</strong> un determ<strong>in</strong>ato paesaggio. Gli strati <strong>in</strong>formativi sono stati<br />
sommati ottenendo un nuovo strato con valori da 10 a 30 (eqn. 2, tab. 4).<br />
Landscape Sensitivity Analysis of Visible Areas = [FLQI] + [Fragility] (eqn. 2).<br />
Per <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare le classi <strong>di</strong> sensitività il range (21) è stato <strong>di</strong>viso per 3 ottenendo l’ampiezza<br />
<strong>del</strong>le s<strong>in</strong>gole classi:<br />
valori 10-16 = sensitività bassa; 17-23 sensitività me<strong>di</strong>a; 23-30 sensitività alta.<br />
Tab. 4. Classificazione <strong>del</strong>le classi <strong>di</strong> sensitività.<br />
Sensitività Classi <strong>di</strong> impatto<br />
Le aree ad alta sensitività sono caratterizzate da alta visibilità, alta fragilità<br />
Valori<br />
Alta<br />
visiva. Si tratta <strong>di</strong> aree molto sensibili agli impatti paesaggistici generati<br />
dalle attività selvicolturali e localizzate <strong>in</strong> prossimità <strong>di</strong> punti panoramici<br />
(VP) a una <strong>di</strong>stanza <strong>in</strong>feriore ai 1000 m e a pendenza elevata (> 66 %).<br />
Le aree a me<strong>di</strong>a sensitività sono caratterizzate da visibilità me<strong>di</strong>a, me<strong>di</strong>a<br />
24-30<br />
Me<strong>di</strong>a fragilità visiva. Queste aree sono localizzate <strong>in</strong> prossimità dei punti<br />
panoramici (VP) ma a <strong>di</strong>stanze > 1000 m e a pendenza me<strong>di</strong>a (33-66 %).<br />
Le aree a bassa sensitività sono caratterizzate da bassa visibilità, bassa<br />
fragilità visiva. Queste aree sono localizzate aree <strong>di</strong>stanti dai punti<br />
17-23<br />
Bassa panoramici (VP) ma a <strong>di</strong>stanze > 3000 m a pendenza variabile. In queste<br />
gli impatti paesaggistici <strong>del</strong>le attività selvicolturali <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uiscono<br />
drasticamente f<strong>in</strong>o a <strong>di</strong>ventare impercettibili.<br />
10-16<br />
Risultati e <strong>di</strong>scussione<br />
Le analisi condotte hanno consentito <strong>di</strong> valutare, qualitativamente e quantitativamente, gli<br />
impatti causati dalle operazioni forestali nelle aree visibili da 6 punti panoramici localizzati lungo la<br />
S.S.110. Successivamente è stato possibile sud<strong>di</strong>videre gli impatti per categoria forestale <strong>in</strong> modo<br />
da poter <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare le tipologie maggiormente esposte a impatti visivi. L’analisi <strong>di</strong> visibilità e <strong>di</strong><br />
sensitività per categoria forestale è riassunto nelle fig. 2 e 3 e nella Tab. 5.<br />
Le tipologie più visibili sono quelle dei Boschi <strong>di</strong> leccio (BL) seguite da quelle dei Boschi <strong>di</strong><br />
faggio (BF), <strong>del</strong>le Aree agricole e pascolive (AAP) è quelle <strong>del</strong>le Macchie me<strong>di</strong>terranee e arbusteti<br />
9<br />
3
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 19<br />
(MMA), <strong>in</strong> m<strong>in</strong>ima parte sono visibili le tipologie dei Rimboschimenti <strong>di</strong> conifere (RB), dei Boschi <strong>di</strong><br />
castagno (BC) e dei Boschi <strong>di</strong> querce caducifoglie (BQC).<br />
C<br />
Fig. 2. A) viewsheed; B) viewsheed 3D; C) <strong>del</strong>la sensivtiità <strong>del</strong>l’area stu<strong>di</strong>o.<br />
Le tipologie maggiormente visibili, sono da considerare maggiormente esposte agli impatti e<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> quelle che necessitano maggiore attenzione sotto gli aspetti <strong>del</strong>la gestione e <strong>del</strong>la<br />
pianificazione, mentre quelle meno visibili sono meno soggette a impatto e necessitano <strong>di</strong> m<strong>in</strong>ori<br />
attenzioni.<br />
La Tab. 5 assieme alla Fig. 2 consentono valutare quantitativamente e qualitativamente le<br />
tipologie maggiormente esposte e la loro localizzazione. Le aree ad alta sensitività sono<br />
localizzate <strong>in</strong> prossimità <strong>del</strong>la strada e <strong>in</strong> quelle aree a forte pendenza governate a ceduo. In<br />
questo caso la carta fornisce un dato molto veritiero <strong>in</strong> quanto l’area stu<strong>di</strong>o è caratterizzata da<br />
pendenze elevate (tipiche dei rilievi montuosi calabresi) e da boschi cedui <strong>di</strong> leccio. La carta <strong>del</strong>la<br />
sensitività sud<strong>di</strong>vide le aree visibili <strong>in</strong> 3 classi per le quali è necessario applicare <strong>di</strong>verse misure <strong>di</strong><br />
mitigazione.
20<br />
Roberto Mercurio<br />
Tab. 5. Classificazione <strong>del</strong>le tipologie forestali visibili dalla S.S.110 secondo la visibilità e la sensitività (ha).<br />
In parentesi tonde (%).<br />
Tipologie forestali Visibilità Sensitività<br />
Boschi <strong>di</strong> leccio<br />
Boschi <strong>di</strong> faggio<br />
Aree agricole e pascolive<br />
Macchie me<strong>di</strong>terranee ed arbusteti<br />
Rimboschimenti <strong>di</strong> conifere<br />
Boschi <strong>di</strong> castagno<br />
Boschi <strong>di</strong> querce caducifoglie<br />
TOTALE<br />
709.8<br />
(63.6)<br />
211.4<br />
(18.9)<br />
131.1<br />
(11.7)<br />
34.4<br />
(3.1)<br />
16.7<br />
(1.5)<br />
9.9<br />
(0.9)<br />
2.3<br />
(0.2)<br />
1115.5<br />
(100)<br />
Basso Me<strong>di</strong>o Alto<br />
128.9 229.8 351.1<br />
(18.2) (32.4) (49.5)<br />
35.1<br />
117.3 59.0<br />
(16.6) (55.5) (27.9)<br />
19.5<br />
25.2 86.4<br />
(14.9) (19.2) (65.9)<br />
15.6<br />
6.4 12.4<br />
(45.3) (18.6) (36.0)<br />
0.0<br />
8.0 8.7<br />
-<br />
(47.9) (52.1)<br />
0.0<br />
4.0 5.9<br />
-<br />
(40.4) (59.6)<br />
0.0<br />
2.0 0.3<br />
-<br />
(87.0) (13.0)<br />
439.3 249.4 426.7<br />
(39.4) (22.4) (38.3)<br />
Le aree a “sensitività alta” sono quelle <strong>in</strong> cui è necessario adottare degli accorgimenti nella<br />
gestione or<strong>di</strong>naria. Esempi sono la limitazione <strong>del</strong>l’ampiezza <strong>del</strong>le tagliate, l’ esecuzione <strong>di</strong> marg<strong>in</strong>i<br />
irregolari contro i marg<strong>in</strong>i tipicamente regolari (anche se questi sono dovuti alle forme regolari <strong>del</strong><br />
mosaico catastale che fa da riferimento per i limiti <strong>di</strong> tagliata), la <strong>di</strong>rezione <strong>del</strong>le tagliate secondo le<br />
curve <strong>di</strong> livello, l’esecuzione <strong>di</strong> fasce orizzontali o cluster (matric<strong>in</strong>atura a gruppi) <strong>di</strong> alberi all’<strong>in</strong>terno<br />
<strong>del</strong>le tagliate.<br />
Le aree a “sensitività me<strong>di</strong>a” sono <strong>in</strong>vece quelle aree <strong>in</strong> cui bastano alcuni accorgimenti nella<br />
gestione or<strong>di</strong>naria meno restrittivi <strong>del</strong>le precedenti. Le aree a “sensitività bassa” sono quelle <strong>in</strong> cui<br />
non sono necessari accorgimenti preventivi <strong>del</strong>la gestione. In un certo senso la classificazione<br />
consente <strong>di</strong> poter guidare la gestione verso 3 <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi:<br />
1) conservazioni stico;<br />
2) misto nelle aree a sensitività me<strong>di</strong>a;<br />
3) produttivistico nelle aree a sensitività bassa.<br />
La Fig. 3 consente <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare e valutare i VP <strong>in</strong> cui l’impatto potenziale è maggiore. La Fig. 3<br />
mette <strong>in</strong> evidenza come i BL siano visibili da quasi tutti i VP scelti per l’analisi (VP1, VP2, VP3,V<br />
P4).<br />
Fig. 3 Tipologie forestali visibili dai s<strong>in</strong>goli VP.
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 21<br />
Mentre i BF sono visibili <strong>in</strong> misura maggiore solo dal VP6. Se ne deduce che, per i BL,<br />
adottando <strong>del</strong>le misure mirate per limitare gli impatti nelle aree visibili dai VP3, VP3 e VP4 é<br />
possibile limitare gli impatti <strong>del</strong>l’80%. O <strong>in</strong> altre parole <strong>in</strong>vestire parte <strong>del</strong>le risorse economiche<br />
<strong>di</strong>sponibili per limitare gli impatti dai suddetti VP rappresenta un <strong>in</strong>vestimento oculato e <strong>di</strong> sicuro<br />
successo per gli obiettivi prefissati.<br />
Conclusioni<br />
La metodologia proposta fornisce un valido strumento tecnico-scientifico e pratico-applicativo,<br />
sia per gli stu<strong>di</strong>osi che per i gestori, per mantenere o <strong>in</strong>crementare il valore estetico <strong>del</strong> paesaggio<br />
forestale all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un’area protetta. La gestione <strong>del</strong>le risorse forestali deve prendere <strong>in</strong><br />
considerazione molti aspetti e deve tenere conto <strong>di</strong> tutti gli stakeholders. Poter bilanciare gli usi<br />
<strong>del</strong>le risorse forestali nello spazio e nel tempo è un traguardo cui si deve aspirare specialmente<br />
all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>le aree protette. Le analisi <strong>di</strong> visibilità e <strong>di</strong> sensitività forniscono ai gestori molti<br />
vantaggi. Primo, la possibilità <strong>di</strong> valutare gli impatti potenziali <strong>in</strong> modo realistico, potendo<br />
identificare le aree maggiormente soggette a impatto. La mitigazione degli impatti visuali non<br />
richiede cambiamenti <strong>del</strong> sistema selvicolturale, ma suggerisce <strong>di</strong> implementare degli accorgimenti<br />
per i cedui collocati <strong>in</strong> prossimità <strong>del</strong>le strade o <strong>in</strong> aree visibili ai VP molto vic<strong>in</strong>i alle strade e a<br />
elevata pendenza. Secondo, la metodologia consente <strong>di</strong> valutare la corretta allocazione <strong>del</strong>le<br />
risorse economiche richieste per la mitigazione degli impatti. Terzo, la metodologia permette <strong>di</strong><br />
produrre una cartografia dettagliata <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile nei processi decisionali <strong>di</strong> gestione forestale e<br />
territoriale.<br />
(il lavoro <strong>in</strong> esteso è <strong>in</strong> revisione presso una rivista).
22<br />
Roberto Mercurio
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 23
24<br />
Roberto Mercurio
Pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> per il restauro forestale 25
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>Atti</strong> <strong>del</strong> <strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giu gno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
IL CEDUO TRA PASSATO E ATTUALITÀ: OPZIONI COLTURALI E<br />
DINAMICA DENDRO-AUXONOMICA E STRUTTURALE<br />
NEI BOSCHI DI ORIGINE CEDUA<br />
GIANFRANCO FABBIO<br />
CENTRO DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA (CRA-SEL) – AREZZO
28<br />
PREMESSA<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Il bosco ceduo è il prodotto <strong>di</strong> un’area geografica anticamente abitata e <strong>di</strong> un ambiente sociale<br />
che ha conservato forti ra<strong>di</strong>ci rurali f<strong>in</strong>o a un passato molto recente. E’ un sistema <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e<br />
antropica, creato, mantenuto e perfezionato con funzioni em<strong>in</strong>entemente produttive e <strong>di</strong>ffuso <strong>in</strong><br />
Italia su quasi 3.700.000 ettari (INFC 2005). Il ceduo ha conosciuto il periodo <strong>di</strong> massima<br />
espansione con il primo sviluppo <strong>in</strong>dustriale e poi il ri<strong>di</strong>mensionamento a seguito <strong>del</strong>la <strong>di</strong>ffusione<br />
dei combustibili fossili nel secolo scorso. I cedui attuali si sono orig<strong>in</strong>ati qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> tempi molto<br />
<strong>di</strong>versi: già utilizzati per secoli come tali o ricavati dalla conversione <strong>del</strong>le fustaie soltanto tra ‘800 e<br />
‘900. I prodotti pr<strong>in</strong>cipali, legna da ardere e carbone vegetale, hanno avuto un target globale e<br />
alimentato un mercato vastissimo dati gli usi primari <strong>di</strong> dest<strong>in</strong>azione: riscaldamento, cottura <strong>del</strong><br />
cibo, energia per la produzione.<br />
L’analisi attuale <strong>del</strong>la sostenibilità <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo non può presc<strong>in</strong>dere da un fatto<br />
essenziale: è spesso impossibile separare gli effetti <strong>del</strong>le tecniche colturali dalla gestione<br />
complessiva <strong>del</strong> suolo e <strong>del</strong> soprassuolo. Nel ceduo si sono sovrapposti <strong>in</strong>fatti numerosi usi multipli<br />
(legna, frasca per foraggio, pascolo, raccolta <strong>del</strong>la lettiera, colture agrarie <strong>in</strong>tercalari, utilizzazione<br />
degli arbusti <strong>del</strong> sottobosco, <strong>di</strong>cioccatura, raccolta <strong>del</strong> legno morto, etc.) e applicate forme estreme<br />
<strong>di</strong> trattamento come la capitozza e lo sgamollo, ma anche tecniche sofisticate come il ceduo a<br />
sterzo e cure colturali <strong>di</strong> recupero come il r<strong>in</strong>foltimento, la ltre tur e la tramarratura. E’ pertanto<br />
<strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere a posteriori gli effetti <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo da quelli collegati alla somma degli<br />
usi e dei <strong>di</strong>sturbi complementari operati <strong>in</strong>sieme e per perio<strong>di</strong> anche molto lunghi sul suolo e sul<br />
soprassuolo. Questa è una realtà con<strong>di</strong>visa dagli altri Paesi me<strong>di</strong>terranei, dove alcuni fattori (fuoco<br />
e pascolo, soprattutto) hanno agito <strong>in</strong> modo determ<strong>in</strong>ante sulle fertilità residue nell’area <strong>del</strong> ceduo.<br />
Obiettivo <strong>di</strong> questo contributo è <strong>di</strong> riassumere la <strong>di</strong>namica recente, analizzare lo stato attuale,<br />
<strong>di</strong>scutere le prospettive <strong>di</strong> selvicoltura e <strong>di</strong> gestione, i problemi e le opportunità <strong>di</strong> ciascuna opzione<br />
colturale.<br />
LA STORIA RECENTE<br />
I lavori <strong>di</strong> storia forestale documentano anche l’ultimo periodo, ricco <strong>di</strong> cambiamenti per una<br />
forma <strong>di</strong> coltivazione pure orig<strong>in</strong>atasi <strong>di</strong> molti secoli fa. Riferisce Hippoliti (2001), dei problemi<br />
collegati all’aumento <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> carbone nel primo ‘900 e come l’Italia <strong>di</strong>venta nel periodo<br />
1906-13 da esportatore, Paese importatore <strong>di</strong> carbone (L’Alpe 1909 e 1916). (…) i 9/10 <strong>del</strong><br />
carbone prodotto erano utilizzati per la cottura <strong>del</strong> cibo e, durante il secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale, la<br />
sola città <strong>di</strong> Roma consumava annualmente 900mila qu<strong>in</strong>tali <strong>di</strong> carbone vegetale (Giordano 1971).<br />
Questa produzione, testimoniata dalla <strong>di</strong>ffusione capillare <strong>del</strong>le carbonaie ancora oggi facilmente<br />
riconoscibili <strong>in</strong> qualsiasi ceduo, era favorita dal potere calorifico più che doppio rispetto alla legna e<br />
dalla m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong>cidenza dei costi <strong>di</strong> trasporto <strong>del</strong> prodotto già trasformato. Date le <strong>di</strong>mensioni ottimali<br />
per questo tipo <strong>di</strong> produzione (2-10 cm) i turni erano molto brevi, da 8 a 12 anni nei cedui <strong>di</strong><br />
quercia e nella macchia, da 12 a 20 anni nel faggio. La carbonella veniva prodotta con <strong>di</strong>ametri<br />
<strong>in</strong>feriori a 2 cm o la fasc<strong>in</strong>a altrimenti commercializzata come tale per forni e fornaci. E ancora, <strong>in</strong><br />
Umbria nel periodo tra il 1800 ed il 1880 (…) per sopperire al raddoppio <strong>del</strong>la popolazione (…) ed<br />
<strong>in</strong> particolare per la costruzione <strong>del</strong>le l<strong>in</strong>ee ferroviarie (…) cadono al taglio le migliori fustaie <strong>di</strong><br />
cerro, faggio e castagno (…) che vengono poi per la massima parte tenute a ceduo (P.F. Regione<br />
Umbria 1998-2007). Oggi, nella stessa regione oltre 85% dei boschi (percentuale massima tra le<br />
regioni italiane) sono cedui. Alcune tra le pr<strong>in</strong>cipali foreste <strong>di</strong> leccio <strong>del</strong>la Sardegna, mantenutesi ad<br />
alto fusto nonostante gli usi civici <strong>di</strong> legnatico, ghiandatico ed erbatico f<strong>in</strong>o all’avvento <strong>del</strong> Regno<br />
d’Italia, sono ridotte a ceduo <strong>in</strong> pochi decenni tra il 1870 e l’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong> secolo successivo (Ente<br />
Foreste R.S.). Lo stesso accade per i residui alto fusti <strong>di</strong> quercia (cerro soprattutto) nella<br />
Maremma, nel Lazio e nelle regioni meri<strong>di</strong>onali (Bernetti 1983°). Il periodo tra la f<strong>in</strong>e <strong>del</strong>l’800 ed i<br />
primi <strong>del</strong> ‘900 assume qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un’importanza particolare nella storia recente <strong>del</strong> bosco ceduo.<br />
L’analisi <strong>del</strong>le statistiche (Agnoletti 2003) documenta la <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione significativa <strong>del</strong>la superficie<br />
forestale e l’<strong>in</strong>versione <strong>del</strong> rapporto tra ceduo e fustaia tra il 1868 ed il 1911. I motivi: l’aumento<br />
demografico (dall’unità al 1925 la popolazione raddoppia soprattutto nelle zone montane), le<br />
necessità <strong>del</strong>l’agricoltura, il fabbisogno energetico <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>dustria che nel 1861 si concentrava<br />
ancora per l’85% su legna e carbone vegetale. (…) Nel 1911, la popolazione rurale era molto<br />
superiore a quella urbana (5:1), ma il fabbisogno era sod<strong>di</strong>sfatto con crescente ricorso alla legna
Gianfranco Fabbio<br />
raccolta fuori dal bosco, con il taglio <strong>di</strong> alberature, siepi e potatura <strong>di</strong> piante agrarie. (…) La<br />
quantità legna da ardere proveniente da fuori foresta era superiore, o quasi il doppio <strong>di</strong> quella<br />
proveniente dai boschi propriamente detti. Questo “autoconsumo” rurale, parzialmente sv<strong>in</strong>colato<br />
dal mercato <strong>del</strong>la legna e <strong>del</strong> carbone, è qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un elemento da tenere presente quando si collega<br />
la produzione <strong>di</strong> legna e carbone alla superficie dei cedui (Agnoletti 2002). Sull’<strong>in</strong>fluenza <strong>del</strong>le<br />
Leggi forestali, ancora Agnoletti riferisce come la legge “liberista” <strong>del</strong> 1877, abolendo <strong>di</strong> fatto le<br />
restrizioni al taglio, produce la riduzione <strong>del</strong>la superficie complessiva <strong>del</strong> bosco (1870-1912) e<br />
l’evoluzione verso il ceduo. Poca <strong>in</strong>fluenza ha la legge Luzzatti <strong>del</strong> 1910 (che istituisce comunque il<br />
demanio forestale). Maggiore peso ha la legge <strong>del</strong> 1923, ma un’<strong>in</strong>versione <strong>di</strong> tendenza si verifica<br />
solo negli anni ’20, ed <strong>in</strong> modo più generalizzato dopo il 1950 per il mutato rapporto tra<br />
popolazione e risorse forestali (legna e carbone coprono soltanto l’11% <strong>del</strong> fabbisogno energetico<br />
nazionale). Una notazione <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e sulla relazione tipo <strong>di</strong> proprietà/estensione <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo;<br />
la prevalente proprietà privata (76.3% contro il 66% per il bosco <strong>in</strong> generale) è spesso portata a<br />
spiegare la grande <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong> ceduo. In realtà, questo rappresenta la tipologia più estesa sia<br />
nella regione dove la proprietà privata è più elevata (Toscana, 86%), sia <strong>in</strong> quella a prevalente<br />
proprietà pubblica (Abruzzo, 80%) (Agnoletti op. cit.).<br />
Queste <strong>in</strong>formazioni testimoniano i cambiamenti importanti ancora avvenuti nel secolo scorso; il<br />
massimo sviluppo a <strong>in</strong>izio ‘900 e poi la f<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>torno agli anni ’50, <strong>di</strong> quella che Bagnaresi (1981)<br />
def<strong>in</strong>isce <strong>in</strong> modo felice “la civiltà <strong>del</strong> ceduo”. Il Congresso nazionale <strong>di</strong> selvicoltura <strong>del</strong> 1954 ed il<br />
Convegno sul bosco ceduo <strong>di</strong> Siena <strong>del</strong> 1958 (Pavari 1955 e 1958) sanciscono la crisi <strong>del</strong> sistema.<br />
Analizzando i fattori <strong>di</strong> <strong>in</strong>erzia nelle forme <strong>di</strong> gestione successivamente agli anni ’50, Pettenella<br />
(2002) <strong>in</strong><strong>di</strong>vidua c<strong>in</strong>que fattori: la frammentazione <strong>del</strong>l’offerta, la staticità <strong>del</strong>la struttura fon<strong>di</strong>aria, la<br />
scarsa <strong>di</strong>fferenziabilità dei prodotti legnosi dei cedui, la natura <strong>di</strong> bene pubblico <strong>di</strong> molti nuovi<br />
prodotti e servizi forniti dai cedui, la ridotta convenienza <strong>del</strong>le modalità alternative <strong>di</strong> gestione,<br />
come le ragioni pr<strong>in</strong>cipali <strong>del</strong> processo <strong>in</strong>compiuto <strong>di</strong> trasformazione dei sistemi produttivi. A fronte<br />
<strong>di</strong> questo, nonostante tutti gli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori <strong>del</strong> cambiamento socio-economico avvenuto nell’ultimo<br />
periodo propendano per un decl<strong>in</strong>o <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> biomasse per uso energetico, l’Autore<br />
segnala un prelievo complessivo <strong>di</strong> 3.3 milioni nel 1971 e <strong>di</strong> 5.2 milioni <strong>di</strong> metri cubi nel 1999.<br />
Questi dati si raccordano bene con quelli (<strong>in</strong> milioni <strong>di</strong> qu<strong>in</strong>tali) riportati da Hippoliti (op. cit.): 50<br />
annualmente nel triennio 1955-57, 17 nel 1976, 30 ad <strong>in</strong>izio anni ’90, a descrivere le oscillazioni <strong>del</strong><br />
prelievo nel periodo (fig. 1).<br />
Fig. 1<br />
LA DINAMICA DEL FENOMENO<br />
Il quadro attuale<br />
Il <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uito <strong>in</strong>teresse economico per legna da ardere e carbone ha prodotto forme <strong>di</strong> gestione<br />
<strong>di</strong>fferenziate <strong>di</strong> (i) mantenimento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo secondo parametri <strong>di</strong> coltivazione meno<br />
<strong>in</strong>tensivi (allungamento dei turni); (ii) evoluzione <strong>di</strong> post-coltura per sospensione <strong>del</strong>le utilizzazioni;<br />
(iii) avviamento ad alto fusto, quest’ultimo soprattutto nella proprietà pubblica. La geografia <strong>del</strong><br />
bosco ceduo vede qu<strong>in</strong><strong>di</strong> oggi consolidarsi tre aree <strong>di</strong>st<strong>in</strong>te <strong>in</strong> cui convivono tipi fisionomicostrutturali<br />
sempre più <strong>di</strong>versificati, seppure orig<strong>in</strong>ati da una matrice comune (tab. 1).<br />
L’area <strong>del</strong> ceduo a regime<br />
I boschi attualmente governati a ceduo rappresentano ancora una quota parte importante <strong>del</strong>la<br />
superficie orig<strong>in</strong>ale; nelle regioni centrali e centro-meri<strong>di</strong>onali, dove si concentra la maggiore<br />
29
30<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> cedui, l’area correntemente utilizzata è soprattutto quella <strong>del</strong>la fascia <strong>di</strong> vegetazione<br />
<strong>in</strong>terme<strong>di</strong>a (cedui a prevalenza <strong>di</strong> querce) occupata dai boschi più produttivi e accessibili. Non<br />
sono qui compresi i cedui <strong>di</strong> castagno che, per caratteri propri (<strong>di</strong>ffusione oltre l’areale orig<strong>in</strong>ario,<br />
riconversione a ceduo <strong>di</strong> molti castagneti da frutto <strong>in</strong> abbandono colturale, produttività, varietà <strong>di</strong><br />
assortimenti e conseguenti opzioni colturali nell’ambito <strong>del</strong>la stessa forma <strong>di</strong> governo, capacità <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novazione agamica anche ad età avanzata), rappresentano una realtà a parte nel panorama<br />
generale <strong>del</strong> ceduo.<br />
L’area complessiva <strong>di</strong> utilizzazione, variabile <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le oscillazioni <strong>del</strong> prezzo <strong>di</strong> mercato<br />
<strong>del</strong> prodotto, è formata da boschi <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong> 50 anni fa per età, densità, struttura.<br />
Tab. 1 – Le statistiche INFC (2005) sulle superfici a ceduo <strong>in</strong> Italia per classi <strong>di</strong> età e tipologie.<br />
Classi <strong>di</strong> età ettari tipologia ettari<br />
giovani (
Gianfranco Fabbio<br />
vegetazione <strong>di</strong> latifoglie. Il bosco ha <strong>in</strong>fatti recuperato gli spazi scoperti e va rioccupando le<br />
superfici limitrofe nei coltivi e pascoli abbandonati, creando nuove strutture ecotonali.<br />
Le strutture<br />
Fortemente <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uiti o scomparsi i cedui composti, sacrificati nel periodo <strong>di</strong> massimo prelievo e<br />
<strong>di</strong> impoverimento generalizzato <strong>del</strong>le provvigioni (l’uso per traverse negli anni <strong>di</strong> sviluppo massiccio<br />
<strong>del</strong>la rete ferroviaria ha comportato la scomparsa <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e <strong>in</strong> regioni <strong>in</strong>tere) o venuta meno la<br />
pratica <strong>del</strong> pascolo <strong>in</strong> bosco che aveva nelle grosse piante fruttifere l’elemento essenziale <strong>del</strong>la<br />
forma d’uso, la struttura <strong>di</strong> gran lunga più <strong>di</strong>ffusa rimane quella <strong>del</strong> ceduo matric<strong>in</strong>ato. La tecnica <strong>di</strong><br />
matric<strong>in</strong>atura ha alimentato e tuttora provvede elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione ben noti tra gli addetti ai<br />
lavori. Il tema è svolto, particolarmente per i cedui <strong>di</strong> quercia, da Bernetti 1983°, 1999; La Marca<br />
1987, 1989, 1992. Ma vale la pena ricordare quanto scrive già nel 1942 Meren<strong>di</strong>, <strong>in</strong> un’epoca <strong>in</strong> cui<br />
i cedui semplici, o ritornati tali, erano assai più <strong>di</strong>ffusi a seguito <strong>del</strong>le eccessive utilizzazioni. (…)<br />
Innanzi tutto, bisogna <strong>in</strong>tendersi bene sulla funzione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>a e cioè sull’ufficio che essa<br />
deve assolvere. A <strong>di</strong>re il vero potrebbe apparire superfluo entrare <strong>in</strong> siffatto argomento se nonché<br />
su <strong>di</strong> esso non sempre si hanno idee chiare (…). [e, a proposito dei cedui <strong>di</strong> querce] (…) Il numero<br />
<strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e deve essere sempre <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong> temperamento <strong>del</strong>le specie che compongono il<br />
ceduo per quanto riguarda il bisogno <strong>di</strong> luce, ma si tratta <strong>di</strong> necessità talmente ovvie da rendere<br />
superflua qualsiasi <strong>di</strong>mostrazione (…). Qualsiasi eccessivo rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e (…) mentre da un<br />
lato non arrecherebbe nessun beneficio al miglioramento <strong>del</strong>la densità <strong>del</strong> bosco, provocherebbe<br />
<strong>in</strong>vece una sensibile <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione nella produttività <strong>del</strong>le ceppaie a motivo <strong>del</strong>l’aduggiamento a cui<br />
dovrebbero <strong>in</strong>evitabilmente sottostare (…). Questo documento è importante perché mette <strong>in</strong><br />
evidenza la tendenza già allora a matric<strong>in</strong>are eccessivamente boschi pure ra<strong>di</strong> e sovrautilizzati e<br />
che sicuramente necessitavano <strong>di</strong> una re<strong>in</strong>tegrazione <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e, ma anche perché motiva <strong>in</strong><br />
modo chiaro la scelta tecnica da adottare, richiamando alla funzione <strong>di</strong> queste piante ed a una<br />
regola fondata nella bio-ecologia <strong>del</strong>le specie componenti. La con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> questi pr<strong>in</strong>cipi non è<br />
stata evidentemente così facile, se a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> settanta anni la querelle è ancora <strong>in</strong> corso su<br />
boschi molto più densi e meno <strong>in</strong>tensivamente utilizzati.<br />
L’area <strong>in</strong> evoluzione naturale per sospensione <strong>del</strong> trattamento<br />
Questa superficie è <strong>in</strong> espansione sia per la maggiore marg<strong>in</strong>alità economica che ha<br />
<strong>in</strong>teressato prima i cedui <strong>di</strong> faggio, poi i cedui <strong>di</strong> quercia e misti meno produttivi e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un’ampia<br />
fascia dei cedui me<strong>di</strong>terranei, ma anche per la crescita rapida <strong>del</strong>la superficie complessiva <strong>del</strong>le<br />
aree a vario livello protette che <strong>in</strong>cludono vaste estensioni <strong>di</strong> bosco ceduo: dal 6.7% (dato IFN<br />
1985) al 13.6% <strong>del</strong>la superficie forestale (Ciancio et al. 2002; Cullotta et al. 2004). L’ampia gamma<br />
<strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> vegetazione <strong>in</strong>teressate, le <strong>di</strong>fferenti composizioni e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> le strategie naturali <strong>di</strong><br />
evoluzione a livello specifico e <strong>di</strong> comunità, hanno prodotto <strong>di</strong>namiche più o meno accelerate che<br />
comunque convergono <strong>in</strong> una con<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> post-coltura (Bernetti 1981). Dove lo stato<br />
precedente era <strong>di</strong> estrema degradazione e la copertura <strong>in</strong>terrotta <strong>in</strong> modo permanente, la<br />
ricostituzione naturale è lenta ed avviene attraverso fasi arbustive pioniere, che tuttavia vedono<br />
anche la partecipazione <strong>di</strong> specie arboree più vitali che tendono a sostituire la specie prima<br />
prevalente. E’ questo ad esempio il caso dei boschi ra<strong>di</strong> <strong>di</strong> querce (Toscana), dove spesso il leccio<br />
<strong>di</strong>mostra maggiore capacità <strong>del</strong>la roverella a riprist<strong>in</strong>are lo strato arboreo <strong>in</strong>terrotto. Dove viceversa<br />
la con<strong>di</strong>zione pregressa era <strong>di</strong> buona fertilità, tutti i parametri <strong>del</strong> bosco mostrano una progressione<br />
positiva, data anche la giovane età dei soprassuoli alla sospensione <strong>del</strong> taglio. La densità è spesso<br />
colma e il procedere <strong>del</strong>l’età alimenta un’area <strong>di</strong> mortalità evidente a carico soprattutto, dove il<br />
bosco è misto, <strong>di</strong> quelle specie arboree ed arbustive competitive nei turni brevi <strong>del</strong> ceduo, ma<br />
recessive ad età maggiori per la chiusura superiore <strong>del</strong>le specie dom<strong>in</strong>anti. Scompaiono così, <strong>in</strong><br />
pochi anni, specie prima <strong>di</strong>ffuse anche se accessorie nella struttura verticale, non funzionali <strong>in</strong><br />
questa fase evolutiva. Nel contempo si vengono a creare ambienti più articolati dove, la maggiore<br />
età e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la migliorata capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>azione, pongono le premesse per una successiva,<br />
maggiore <strong>di</strong>versità strutturale, compositiva e cronologica <strong>del</strong>le popolazioni rappresentate. Il<br />
carattere <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione aggregata sulle ceppaie si mantiene molto più a lungo per le specie<br />
tolleranti <strong>del</strong>l’ombra (faggio, leccio), meno per le specie eliofile (cerro) che riducono precocemente<br />
il numero dei polloni portati ai soli soggetti dom<strong>in</strong>anti e ltre turno s. Se il percorso evolutivo<br />
rimane comune, la <strong>di</strong>namica apparente è controllata soprattutto dalla fertilità <strong>del</strong>la stazione e dal<br />
temperamento specifico.<br />
31
32<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
L’area <strong>del</strong>l’avviamento ad alto fusto<br />
M<strong>in</strong>oritaria rispetto alle altre, ma non per questo meno <strong>in</strong>teressante, rappresenta l’opzione<br />
colturale al mantenimento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo. Il Convegno sul miglioramento <strong>del</strong> bosco ceduo<br />
<strong>di</strong> Bologna (AA. VV. 1979) prevedeva possibile <strong>in</strong> un qu<strong>in</strong><strong>di</strong>cennio la conversione ad alto fusto o a<br />
ceduo composto <strong>di</strong> almeno 240.000 ettari <strong>di</strong> cedui semplici <strong>di</strong> faggio e <strong>di</strong> 50.000 ettari <strong>di</strong> querceti a<br />
foglia decidua, <strong>in</strong> particolare <strong>di</strong> cerro allo stato puro o misto; vale a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> 19.000 ettari l’anno per<br />
15 anni. Il dato <strong>di</strong>sponibile all’Inventario nazionale <strong>del</strong> 1985 conta 71.100 ettari <strong>di</strong> fustaie transitorie;<br />
secondo l’INFC (2005), la superficie attuale raddoppia a 151.000 ettari (tab. 1). Da tenere<br />
presente che il protocollo <strong>di</strong> rilievo adottato nell’ultimo Inventario registra soltanto i soprassuoli<br />
con tracce evidenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento <strong>del</strong>le ceppaie e non tiene qu<strong>in</strong><strong>di</strong> conto <strong>di</strong> quelli <strong>in</strong> avviamento<br />
più lontano con fisionomie già simili a giovani fustaie da seme.<br />
L’area degli avviamenti ad alto fusto, concentrata soprattutto nella proprietà pubblica, nasce nel<br />
piano <strong>del</strong> faggio dove il ceduo <strong>di</strong>venta marg<strong>in</strong>ale prima, si amplia poi al piano <strong>del</strong>le querce<br />
caducifoglie (cerro) ed <strong>in</strong>teressa attualmente anche il piano me<strong>di</strong>terraneo-montano <strong>del</strong>le querce<br />
semprever<strong>di</strong> (leccio). I boschi costituiti con l’avviamento e perio<strong>di</strong>camente <strong>di</strong>radati assumono<br />
presto fisionomia e struttura <strong>di</strong> fustaia, da cui il term<strong>in</strong>e “fustaia da polloni” (Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1986).<br />
La presenza <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e non sgomberate già nella fase <strong>di</strong> avviamento e l’aspetto tipico dei polloni,<br />
che filano <strong>in</strong> altezza e mantengono per molti anni chiome raccolte <strong>in</strong> alto e compresse<br />
lateralmente, rimangono a testimoniare i tratti orig<strong>in</strong>ali. Soltanto dopo i 40, 50 anni <strong>di</strong> età, la<br />
fisionomia dei dendrotipi <strong>di</strong>venta più simile a quella <strong>di</strong> piante nate da seme. La composizione<br />
specifica nel piano pr<strong>in</strong>cipale riflette, <strong>in</strong> gran parte, quella <strong>in</strong>izialmente presente: la specie<br />
dom<strong>in</strong>ante più s<strong>in</strong>goli elementi o piccoli gruppi <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>verse, riservati dove ancora vitali e<br />
capaci <strong>di</strong> competere nel piano pr<strong>in</strong>cipale. Le densità molto m<strong>in</strong>ori dei soprassuoli <strong>in</strong> avviamento e<br />
le strutture tendenzialmente monoplane per i <strong>di</strong>radamenti <strong>di</strong> tipo basso e misto che caratterizzano<br />
la prima fase <strong>del</strong> ciclo <strong>di</strong> conversione, producono maggiore penetrazione <strong>di</strong> luce superiore e<br />
laterale. Queste con<strong>di</strong>zioni favoriscono, particolarmente nella fascia <strong>del</strong>le querce caducifoglie<br />
floristicamente più ricca, l’<strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> un sottopiano <strong>di</strong> latifoglie a foliazione precoce e tolleranti<br />
<strong>del</strong>l’ombra che, secondo i caratteri stazionali, possono formare un livello accessorio cont<strong>in</strong>uo,<br />
<strong>di</strong>st<strong>in</strong>to dalla copertura superiore. L’<strong>in</strong>gresso <strong>di</strong> altre specie, già associate all’attuale querceto, è<br />
considerato un effetto positivo <strong>del</strong>l’avviamento (Bernetti 1983b, 1987, 1999). La ricomposizione<br />
specifica è proposta anche per via artificiale (“ ltre turno stal”), dove vi siano chiarie <strong>di</strong> ampiezza<br />
sufficiente o queste si vengano a creare per lo sgombero precoce <strong>di</strong> <strong>in</strong>gombranti matric<strong>in</strong>e, sia nel<br />
piano <strong>del</strong>le querce che <strong>in</strong> quello superiore <strong>del</strong> faggio (Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1989). Le età massime dei<br />
cedui <strong>in</strong> avviamento sono a oggi <strong>di</strong> 50-60 anni per i cedui avviati 25-30 anni fa.<br />
La <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica e strutturale nei soprassuoli oltre turno (da: Amor<strong>in</strong>i e<br />
Fabbio 2009)<br />
Qualsiasi ipotesi <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong> bosco ceduo <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> post-coltura non può presc<strong>in</strong>dere dalla<br />
conoscenza <strong>del</strong>la sua evoluzione dendro-strutturale, essendo questa tipologia un soprassuolo <strong>di</strong><br />
“neo-formazione”, privo <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> riferimento. La ricerca su questo tema, <strong>in</strong>iziata all’<strong>in</strong>izio degli<br />
anni ’70 con la realizzazione dei primi protocolli, prendeva atto (i) <strong>del</strong>la variazione naturale (reattiva)<br />
alla sospensione <strong>del</strong>la coltivazione (<strong>in</strong>vecchiamento <strong>del</strong> ceduo); (ii) <strong>del</strong>la necessità <strong>di</strong><br />
monitorare <strong>in</strong> tempo reale questa evoluzione; (iii) <strong>del</strong>la possibilità <strong>di</strong> governare la nuova situazione<br />
attraverso una selvicoltura de<strong>di</strong>cata (soluzione pro-attiva <strong>del</strong>l’avviamento). Obiettivi <strong>in</strong>iziali furono<br />
quelli <strong>di</strong> verificare la vulnerabilità <strong>del</strong> sistema non più gestito (evoluzione <strong>di</strong> post-coltura); <strong>di</strong><br />
identificare durata, <strong>in</strong>tensità e risultati <strong>del</strong>la apparente crisi strutturale (mortalità elevate); <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>viduare la popolazione a questa associata (il complesso <strong>del</strong> soprassuolo o la componente<br />
naturalmente recessiva?). Su questi punti si articolavano le basi biologiche per supportare una<br />
gestione conservativa basata sull’evoluzione per via naturale come per costruire e validare, <strong>in</strong><br />
concorso con la prima, l’opzione <strong>del</strong>l’avviamento a partire dallo stesso soprassuolo <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e<br />
cedua.<br />
La sperimentazione, condotta su protocolli permanenti, ha validato sia l’ipotesi auxonomica <strong>di</strong><br />
Bernetti (1980), che le teorie <strong>di</strong> riequilibrio <strong>del</strong>la massa ra<strong>di</strong>cale a quella epigea <strong>di</strong> Clauser (1981) e<br />
<strong>di</strong> affrancamento ra<strong>di</strong>cale (Amor<strong>in</strong>i et al. 1990b) (fig. 2).<br />
In con<strong>di</strong>zioni <strong>in</strong>iziali <strong>di</strong> densità e fertilità sufficienti, lo sviluppo positivo oltre le età <strong>del</strong>la<br />
tra<strong>di</strong>zionale “maturità” economica è il risultato <strong>di</strong> una competizione fortemente asimmetrica tra le
Gianfranco Fabbio<br />
componenti dom<strong>in</strong>ante e dom<strong>in</strong>ata, secondo il mo<strong>del</strong>lo evidenziato dalla ricostruzione<br />
<strong>del</strong>l’auxonomia <strong>di</strong> componenti sociali <strong>di</strong>verse (Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1986, 1988, 1989, 1990).<br />
8,0<br />
7,0<br />
6,0<br />
Ricostruzione <strong>del</strong>lo sviluppo <strong>del</strong>la massa epigea oltre le età <strong>di</strong> normale ceduazione<br />
5,2<br />
m³h<br />
5,0<br />
4,2<br />
a 4,0<br />
3,0<br />
2,4<br />
- ¹<br />
a -1 prima<br />
culm<strong>in</strong>azione<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
Fig. 2 – Incremento me<strong>di</strong>o <strong>del</strong>la massa corrente <strong>in</strong> un ceduo a prevalenza <strong>di</strong> cerro oltre turno.<br />
5,05<br />
La ripetizione <strong>di</strong> cicli <strong>di</strong> competizione decadali e sub-decadali (fig. 3), seleziona precocemente<br />
una sub-popolazione <strong>di</strong> soggetti dom<strong>in</strong>anti che sostiene lo sviluppo <strong>di</strong> complesso <strong>del</strong> soprassuolo,<br />
riassorbendo la forte mortalità naturale osservata f<strong>in</strong>o dai primi anni seguenti l’<strong>in</strong>terruzione <strong>del</strong>le<br />
utilizzazioni.<br />
Contributi successivi hanno def<strong>in</strong>ito la sostenibilità <strong>del</strong>l’evoluzione naturale dei soprassuoli e<br />
formalizzato i criteri per <strong>in</strong>traprendere il loro avviamento all’alto fusto (Amor<strong>in</strong>i 1994; Fabbio 1994;<br />
Amor<strong>in</strong>i et al. 1996, 1998°, 1998b; Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1999). I protocolli orig<strong>in</strong>ali e gli altri<br />
successivamente realizzati si sono sviluppati <strong>in</strong> modo flessibile, con un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> monitoraggio e<br />
<strong>di</strong> trattamento adattativo, funzione <strong>del</strong>le conoscenze progressivamente acquisite dalla<br />
comparazione tra le tesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica naturale e quelle <strong>di</strong> avviamento.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o dei caratteri bio-ecologici <strong>del</strong>la copertura arborea, <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>ci <strong>di</strong> produttività e funzionalità<br />
nelle <strong>di</strong>fferenti opzioni colturali e <strong>di</strong> gestione (Cut<strong>in</strong>i 1994 e 1997; Cut<strong>in</strong>i e Benvenuti 1998; Fabbio<br />
et al. 1998) si sono affiancati agli stu<strong>di</strong> dendro-auxonomici che avevano contribuito a validare le<br />
ipotesi <strong>di</strong> base.<br />
Fig. 3 – Andamento auxonomico (valori me<strong>di</strong>) <strong>di</strong> polloni dom<strong>in</strong>anti, <strong>in</strong>terme<strong>di</strong> e sub-dom<strong>in</strong>ati <strong>di</strong> cerro.<br />
Elaborazione da analisi <strong>del</strong> fusto. Si evidenziano i cicli successivi <strong>di</strong> competizione, la progressiva<br />
<strong>di</strong>fferenziazione tra le classi e la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> competitività dei soggetti sub-dom<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>l’età.<br />
5,35<br />
5 10 14 16 20 32 38 44 47 52<br />
6,57<br />
età anni<br />
6,92<br />
6,95<br />
seconda<br />
culm<strong>in</strong>azione<br />
età me<strong>di</strong>a esplorata dalle tavole alsometriche periodo osservato a oggi<br />
6,62<br />
6,01<br />
33
34<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
La realizzazione <strong>di</strong> relazioni ltre turno s per la stima dei volumi e <strong>del</strong>le componenti la<br />
biomassa arborea per le <strong>di</strong>verse specie e dendrotipi <strong>di</strong> neoformazione (Amor<strong>in</strong>i et al. 1995 e 2000;<br />
Bran<strong>di</strong>ni e Tabacchi 1996; Nocetti et al. 2007) e la verifica <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> accumulo <strong>del</strong>la<br />
necromassa legnosa (Bert<strong>in</strong>i et al. 2007), hanno consentito la def<strong>in</strong>izione quantitativa dei fenomeni<br />
osservati. Le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i più recenti hanno permesso <strong>di</strong> aggiornare i dati su alcuni dei protocolli <strong>in</strong>iziali<br />
f<strong>in</strong>o alle età attuali <strong>di</strong> circa 60 anni (Benvenuti e Cantiani 2003; Manetti 2005; Amor<strong>in</strong>i et al. 2006;<br />
Manetti e Gugliotta 2006; Cut<strong>in</strong>i e Hajny 2006; Fabbio e Amor<strong>in</strong>i 2006; Manetti e Bartolucci 2007).<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> tipo eco-fisiologico, volti ad approfon<strong>di</strong>re anche gli elementi <strong>di</strong> funzionamento collegati ai<br />
cambiamenti ambientali <strong>in</strong> corso (Di Matteo et al. 2005 e 2007), sulla allocazione <strong>del</strong> carbonio e<br />
<strong>del</strong>l’azoto nel sistema (Tunno et al. 2007) e su alcuni <strong>di</strong>sturbi emergenti <strong>di</strong> natura biotica (Roversi<br />
2007), sono stati realizzati sugli stessi siti o hanno ampliato la gamma <strong>di</strong> osservazioni negli ultimi<br />
anni. A questi contributi, elencati <strong>in</strong> bibliografia, si rimanda per approfon<strong>di</strong>menti.<br />
Sostenibilità <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo a ceduo<br />
Il ceduo rappresenta un’ere<strong>di</strong>tà colturale e culturale <strong>in</strong>sieme e una frazione importante <strong>di</strong> quella<br />
risorsa bosco cui oggi una società prevalentemente urbana chiede <strong>di</strong> esprimere non soltanto<br />
funzioni <strong>di</strong> produzione, ma <strong>di</strong> conservazione e protezione ambientale, <strong>di</strong> ricreazione e <strong>di</strong><br />
valorizzazione <strong>di</strong> un paesaggio rurale percepito come “naturale” anche se <strong>in</strong> realtà molto<br />
umanizzato. Gli stessi fattori <strong>di</strong> tipo economico e sociale che tra la f<strong>in</strong>e <strong>del</strong> 1800 e l’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong> 1900<br />
hanno determ<strong>in</strong>ato l’aumento ulteriore <strong>del</strong>la superficie coltivata a ceduo, hanno prodotto<br />
successivamente un’evoluzione <strong>di</strong> segno opposto e l’accelerazione <strong>del</strong> cambiamento nell’ultimo<br />
periodo. Nuovi “bisogni primari” tendono sostituirsi e porsi come prioritari rispetto a quelli<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente def<strong>in</strong>iti. La m<strong>in</strong>ore necessità <strong>di</strong> un valore <strong>di</strong>retto <strong>del</strong> bosco consente <strong>di</strong> chiedere la<br />
realizzazione <strong>di</strong> quei valori <strong>in</strong><strong>di</strong>retti (Nocent<strong>in</strong>i 2002), prima assolutamente secondari o ad<strong>di</strong>rittura<br />
non considerati tali. Questa domanda esprime l’attenzione crescente verso una risorsa naturale<br />
chiamata a controllare anche alcuni effetti negativi <strong>del</strong>l’attività umana sull’ambiente. E’ la fase <strong>del</strong>la<br />
“gestione forestale sociale” come def<strong>in</strong>ita da Kimm<strong>in</strong>s (1992 <strong>in</strong> Farrell et al. 2000). Presupposto<br />
perché questa si realizzi è il riconoscimento concreto <strong>del</strong>le esternalità prodotte dalla coltivazione<br />
<strong>del</strong> bosco, <strong>in</strong> quanto base <strong>del</strong> mantenimento <strong>del</strong> mosaico colturale e motivo <strong>del</strong>la presenza attiva<br />
<strong>del</strong>l’uomo sul territorio. In mancanza <strong>di</strong> questo, l’abbandono cont<strong>in</strong>uerà a prevalere sul recupero<br />
colturale (Del Favero 2000).<br />
Le <strong>di</strong>fferenze positive per età me<strong>di</strong>e, densità e struttura <strong>del</strong> bosco, i caratteri orig<strong>in</strong>ali <strong>di</strong><br />
semplicità <strong>di</strong> gestione e garanzia <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione naturale (fase critica <strong>di</strong> qualsiasi forma <strong>di</strong><br />
trattamento <strong>del</strong> bosco), reversibilità e flessibilità, alta resilienza ai <strong>di</strong>sturbi (collaudata da secoli <strong>di</strong><br />
coltivazione <strong>in</strong>tensiva ed usi multipli e validata dalla ripresa seguita alla m<strong>in</strong>ore pressione<br />
<strong>del</strong>l’ultimo periodo), consentono <strong>di</strong> assumere che la forma <strong>di</strong> governo, applicata su superfici<br />
complessive più ridotte e secon<strong>di</strong> criteri meno <strong>in</strong>tensivi, abbia carattere <strong>di</strong> sostenibilità. Tutti i<br />
parametri <strong>del</strong>la coltivazione a ceduo contribuiscono a garantirne la stabilità, f<strong>in</strong>o a che l’uso non<br />
eccede la capacità funzionale <strong>del</strong> sistema. A tale proposito, Del Favero (op. cit.), analizzando la<br />
gestione forestale per la produzione legnosa a f<strong>in</strong>i energetici, pone il problema se il sistema ceduo<br />
possa ritenersi sostenibile anche nell’ottica <strong>di</strong> una selvicoltura naturalistica. Esam<strong>in</strong>ata la capacità<br />
<strong>di</strong> risposta a tutti i fattori che garantiscono il funzionamento <strong>del</strong> sistema bosco, l’autore conclude<br />
che la forma <strong>di</strong> governo è sostenibile quando sia applicata a specie <strong>in</strong>serite nel proprio ambiente<br />
ecologico, e non siano presenti fattori stazionali particolarmente limitanti. Una serie <strong>di</strong> accorgimenti<br />
tecnici (forma, <strong>di</strong>sposizione, estensione e successione <strong>del</strong>le tagliate, lunghezza dei turni,<br />
realizzazione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura) può utilmente <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire l’impatto ecologico, fisionomico e qu<strong>in</strong><strong>di</strong><br />
visivo <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo, mentre è evidente il risultato positivo sulla conservazione <strong>del</strong><br />
paesaggio <strong>in</strong>teso come espressione <strong>del</strong>l’identità culturale e colturale <strong>di</strong> un territorio. In questo<br />
senso è auspicabile il mantenimento <strong>del</strong>la forma d’uso che crea il mosaico cronologico, aumenta le<br />
fasce ecotonali e la <strong>di</strong>versità complessiva, favorendo anche la creazione perio<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> habitat <strong>di</strong>versi<br />
(il soprassuolo maturo e le tagliate) necessari per molte popolazioni animali. Si riducono nel<br />
contempo la omogeneizzazione e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la “banalizzazione” <strong>di</strong> contesti paesistici che, sebbene<br />
come già detto percepiti oggi come naturali da una popolazione prevalentemente urbana, sono <strong>in</strong><br />
realtà dovuti alla cont<strong>in</strong>uata attività <strong>del</strong>l’uomo.
Le possibili opzioni<br />
Gianfranco Fabbio<br />
Il cambiamento <strong>in</strong> atto presenta <strong>del</strong>le opportunità. La <strong>di</strong>namica recente ha prodotto una<br />
maggiore <strong>di</strong>versità complessiva <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i fisionomici, strutturali e funzionali, ha aumentato la<br />
capacità <strong>di</strong> risposta alle richieste emergenti, prodotto nuovi habitat e consentito l’affermazione <strong>di</strong><br />
nicchie ecologiche prima assenti. Tutte le opzioni sviluppatesi nell’ultimo periodo trovano<br />
applicazione <strong>in</strong> un territorio estremamente variato nei caratteri fisici, nell’economia e tessuto<br />
sociale locali, nella vocazione <strong>di</strong> sviluppo e nelle connessioni esistenti o implementabili con aree<br />
limitrofe.<br />
Questo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>venta un assunto importante per la gestione <strong>del</strong> cambiamento perché<br />
riconosce le possibilità venutesi a creare e perché si oppone a tesi riduttive <strong>di</strong> mantenimento<br />
generalizzato <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> coltivazione tra<strong>di</strong>zionale, così come <strong>di</strong> conservazione passiva <strong>del</strong><br />
bosco “<strong>in</strong>terrotto” <strong>in</strong> fasi <strong>di</strong>verse o ancora <strong>di</strong> tutela mirata ad un’unica componente <strong>del</strong> sistema o<br />
forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità. Tali tesi f<strong>in</strong>iscono per avere un contenuto puramente ideologico e convergono <strong>in</strong><br />
una mancata percezione <strong>del</strong> problema reale (la gestione) che ha per oggetto un luogo fisico, il<br />
territorio, e richiede qu<strong>in</strong><strong>di</strong> una visione <strong>di</strong> scala (Fuhrer 2000). Il tema <strong>del</strong>le relazioni tra gestione<br />
sostenibile, selvicoltura, abbandono colturale, <strong>di</strong>versità, conservazione, sono trattati <strong>in</strong> una serie <strong>di</strong><br />
articoli <strong>di</strong> Frankl<strong>in</strong>, 1993; Roberts e Gilliam, 1995; Larsen, 1995; Di Castri, 1996; Hanouskova et<br />
al., 1999; Farrell et al., 2000; Piussi e Farrell, 2000; Bengtsson et al., 2000; Scarascia Mugnozza et<br />
al., 2000; Fuhrer, 2000; Teissier Du Cros, 2001; Palmberg-Lerche, 2001. Le analisi, i punti <strong>di</strong> vista,<br />
le ipotesi <strong>di</strong> lavoro, si adattano bene al bosco ceduo, date la complessità <strong>del</strong>le situazioni e la<br />
gamma <strong>del</strong>le possibili opzioni esistenti per questa tipologia <strong>di</strong> bosco.<br />
E’ questo un punto chiave perché il <strong>di</strong>battito ha spesso contrapposto i vantaggi <strong>di</strong> una soluzione<br />
rispetto ad un’altra o ha teso a <strong>di</strong>mostrare la esclusività <strong>di</strong> una scelta non riconoscendo, <strong>di</strong> fatto, la<br />
complementarietà suggerita dalla eterogeneità <strong>del</strong>le situazioni, vale a <strong>di</strong>re dalla storia <strong>del</strong> bosco,<br />
dal suo stato e dalle forme d’uso correnti, dalla potenzialità <strong>del</strong>la stazione, dai valori e dalle funzioni<br />
prevalenti che si <strong>in</strong>tendono tutelare od implementare. Perché funzione prevalente: a ciascuna<br />
scelta colturale (ceduazione, abbandono, avviamento) sono associabili lo svolgimento <strong>di</strong> funzioni<br />
comuni, proprie <strong>del</strong> bosco come tale, <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalle caratteristiche collegate. Ciò che<br />
cambia è evidentemente il livello o capacità <strong>di</strong> ciascuna opzione <strong>di</strong> assolvere ad una o più funzioni<br />
ritenute prem<strong>in</strong>enti, così come i requisiti <strong>di</strong> base per scelte <strong>di</strong>verse possono essere comuni (ad<br />
esempio un livello sufficiente <strong>di</strong> fertilità e <strong>di</strong> densità sia per la cont<strong>in</strong>uazione <strong>del</strong>la ceduazione che<br />
per l’avviamento ad alto fusto). Anche nell’ambito <strong>di</strong> corpi estesi e cont<strong>in</strong>ui <strong>di</strong> bosco ceduo, dove<br />
apparentemente l’orig<strong>in</strong>e comune e le ridotte variazioni cronologiche sembrano imporre scelte<br />
unificanti, è possibile realizzare soluzioni <strong>di</strong>fferenti alla scala m<strong>in</strong>ima <strong>di</strong> gestione che si<br />
ricompongono e si ripetono a scala superiore, a formare un mosaico colturale coerente (Fabbio et<br />
al. 2003). Progettate le scelte colturali secondo le funzioni giu<strong>di</strong>cate localmente prevalenti e<br />
verificata la loro applicabilità al bosco esistente sulla base <strong>di</strong> criteri ed <strong>in</strong><strong>di</strong>catori fondati<br />
(sostenibilità <strong>del</strong>la gestione), si avrà l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> cosa fare, come fare, dove e perché. Le<br />
comb<strong>in</strong>azioni spaziali risultanti dovranno essere realizzate rispettando <strong>di</strong>mensioni (massime e<br />
m<strong>in</strong>ime) compatibili per ciascuna unità, e curando che le connessioni fisiche siano le più funzionali<br />
ad assicurare una cont<strong>in</strong>uità ecologica tra i <strong>di</strong>versi ambienti (Frankl<strong>in</strong> 1993).<br />
La selvicoltura e la gestione<br />
Come talvolta accade <strong>in</strong> letteratura emergono, nel complesso <strong>del</strong>la produzione, lavori<br />
anticipatori <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipi e meto<strong>di</strong> che, per paradosso o proprio per loro natura, esprimono<br />
compiutamente la loro orig<strong>in</strong>alità a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni. Un articolo <strong>di</strong> Bernetti “Il trattamento a ltre<br />
turno sta mo<strong>di</strong>ficato” pubblicato nel 1983 illustra, con molto anticipo sui successivi criteri ed<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>catori <strong>di</strong> sostenibilità, l’<strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> tipo assestatorio e colturale per comprensori<br />
prevalentemente or<strong>di</strong>nati secondo la forma <strong>di</strong> governo <strong>del</strong> ceduo <strong>in</strong> cui vi sia la necessità o<br />
l’opportunità <strong>di</strong> percorrere anche alternative colturali. La consueta chiarezza <strong>di</strong> trattazione e la<br />
capacità <strong>di</strong> “banalizzare” pr<strong>in</strong>cipi complessi <strong>di</strong> gestione forestale, consentono <strong>di</strong> estrapolare l<strong>in</strong>ee<br />
guida applicabili più <strong>in</strong> generale a situazioni <strong>in</strong> cui le <strong>di</strong>verse opzioni colturali siano comunque<br />
bilanciate, e suggeriscono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> i criteri <strong>di</strong> collocazione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le superfici lasciate<br />
all’evoluzione naturale e <strong>di</strong> quelle avviate ad alto fusto. Se ne ricavano pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> una gestione<br />
flessibile e adattativa capace <strong>di</strong> adeguarsi ai risultati prodotti e monitorati <strong>in</strong> tempo reale. Le<br />
considerazioni <strong>di</strong> tipo ltre turno sta svolte da Bernetti richiamano un precedente articolo <strong>di</strong><br />
35
36<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Cantiani (1963) sul metodo colturale, che coniuga strettamente selvicoltura e formulazione dei<br />
criteri <strong>di</strong> gestione nella situazione <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong> irregolarità e variabilità <strong>del</strong> bosco. I pr<strong>in</strong>cipi <strong>del</strong> metodo<br />
colturale sono bene applicabili <strong>in</strong>fatti non solo alla coesistenza <strong>di</strong> tipologie <strong>di</strong>verse per orig<strong>in</strong>e, età,<br />
composizione e forma <strong>di</strong> governo, ma anche a superfici prima omogenee come quelle <strong>del</strong> ceduo e<br />
poi <strong>di</strong>fferenziatesi, <strong>in</strong> cui si ritenga utile o necessario sviluppare la <strong>di</strong>versificazione <strong>in</strong> atto e qu<strong>in</strong><strong>di</strong><br />
governare le progressive, ulteriori scelte colturali.<br />
Elementi caratterizzanti le aree <strong>di</strong> opzione<br />
Discussi i term<strong>in</strong>i generali <strong>del</strong>la questione, si possono riassumere, per i <strong>di</strong>versi obiettivi<br />
prevalenti <strong>di</strong> coltivazione, conservazione, cambiamento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo, gli elementi positivi<br />
e negativi che si pongono <strong>in</strong> prospettiva per la selvicoltura e la gestione.<br />
Area <strong>di</strong> coltivazione <strong>del</strong> ceduo<br />
Punto <strong>di</strong> vista produttivo<br />
- biomasse unitarie superiori;<br />
- allocazione proporzionalmente maggiore <strong>del</strong>la biomassa epigea nel legno, rispetto alle età dei<br />
turni tra<strong>di</strong>zionali;<br />
- aumento dei <strong>di</strong>ametri <strong>di</strong> utilizzazione rispetto a quelli tipici per la produzione <strong>di</strong> legna da<br />
ardere;<br />
- maggiore costo <strong>di</strong> trasformazione per la necessità <strong>di</strong> spacco;<br />
- possibilità <strong>di</strong> creare valore aggiunto commercializzando prodotti già confezionati (es. pezzi da<br />
stufa);<br />
- aumento <strong>del</strong>la resa <strong>del</strong> lavoro <strong>di</strong> taglio, allestimento ed esbosco per le maggiori <strong>di</strong>mensioni<br />
unitarie;<br />
- possibilità <strong>di</strong> ceduare i soprassuoli meglio serviti e <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accessibilità migliori;<br />
- opportunità <strong>di</strong> migliorare i meto<strong>di</strong> e le dotazioni tecniche per l’esbosco <strong>del</strong> materiale, riducendo<br />
l’impatto sulle ceppaie e sul suolo forestale.<br />
Punto <strong>di</strong> vista biologico<br />
- possibilità <strong>di</strong> valorizzare gli spot <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità specifica presenti, naturalmente <strong>in</strong>se<strong>di</strong>atisi <strong>in</strong><br />
sistemi meno <strong>di</strong>sturbati per la maggiore <strong>di</strong>stanza dall’ultima ceduazione;<br />
- maggiore età me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le ceppaie e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> eventualità <strong>di</strong> un riscoppio meno vigoroso o <strong>di</strong><br />
carenza localizzata <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione su una quota parte <strong>del</strong>la superficie;<br />
- massima resilienza ai <strong>di</strong>sturbi <strong>in</strong> genere ed a quelli dovuti a una futura, maggiore <strong>in</strong>cidenza <strong>di</strong><br />
eventi climatici sfavorevoli per la giovane età dei soprassuoli, co<strong>in</strong>cidente con la fase <strong>di</strong> sviluppo<br />
più <strong>di</strong>namica;<br />
- elevata capacità <strong>di</strong> stoccaggio <strong>di</strong> carbonio (s<strong>in</strong>k) per il rapido aumento <strong>del</strong>la biomassa epigea<br />
nel periodo <strong>di</strong> permanenza previsto e utilizzo <strong>di</strong> una risorsa r<strong>in</strong>novabile <strong>in</strong> alternativa ai combustibili<br />
fossili non riproducibili;<br />
- mantenimento <strong>di</strong> una elevata variabilità spazio-temporale degli habitat per la successione a<br />
breve term<strong>in</strong>e degli sta<strong>di</strong> <strong>in</strong>iziali e f<strong>in</strong>ali <strong>di</strong> coltivazione.<br />
Punto <strong>di</strong> vista colturale<br />
- soprassuoli più strutturati, che consentono una migliore <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione degli allievi e/o <strong>del</strong>le<br />
matric<strong>in</strong>e e un rilascio più coerente;<br />
- occasione <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>nare i criteri <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura secondo una regola funzionale, riducendo<br />
drasticamente il numero dei rilasci, ma migliorando la scelta dei soggetti e la loro <strong>di</strong>stribuzione<br />
spaziale;<br />
- possibile esigenza <strong>di</strong> dover <strong>in</strong>tegrare, negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi il taglio,<br />
localizzate mancanze <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione agamica e da seme;<br />
- opportunità <strong>di</strong> realizzare aggiustamenti nell’organizzazione spaziale e temporale <strong>del</strong>le tagliate<br />
<strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le opzioni colturali complementari (evoluzione naturale, avviamento) sviluppabili su<br />
superfici a<strong>di</strong>acenti o <strong>in</strong>terconnesse.
Gianfranco Fabbio<br />
Obiettivi generali<br />
Qualificare i criteri <strong>di</strong> gestione colturale e certificare le produzioni. Riconoscere e attribuire il<br />
valore economico alla serie <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> carattere ambientale, sociale, culturale prodotti per la<br />
collettività e non remunerati dalla produzione materiale (Del Favero op. cit.; Merlo e Rojas Briales<br />
2000; Pettenella op. cit.).<br />
Area <strong>in</strong> evoluzione naturale<br />
Punto <strong>di</strong> vista produttivo<br />
- gli stessi motivi che hanno determ<strong>in</strong>ato la formazione <strong>di</strong> questa area, escludono un preve<strong>di</strong>bile<br />
<strong>in</strong>teresse <strong>di</strong> questo tipo. Molta parte <strong>del</strong>le superfici suscettibili <strong>di</strong> utilizzazione appaiono consolidate<br />
e poco sensibili alle perio<strong>di</strong>che oscillazioni <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> mercato. Ne fanno parte anche i cedui già<br />
esclusi dall’area <strong>di</strong> produzione perché a funzione protettiva, quelli a fertilità ridotta, i soprassuoli<br />
<strong>in</strong>clusi <strong>in</strong> aree protette. In quest’ultimo caso, si pone già il problema <strong>di</strong> ceduare il bosco su superfici<br />
localizzate per provvedere alla fauna il pabulum <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile venuto meno per la sospensione<br />
generalizzata dei tagli e per il progressivo riassorbimento <strong>del</strong>le superfici scoperte (praterie, pascoli<br />
e campi abbandonati) da parte <strong>del</strong> bosco. Una funzione nuova trova così una soluzione antica. Il<br />
<strong>di</strong>mensionamento corretto <strong>del</strong>le popolazioni animali sostenibili dal sistema <strong>del</strong>le aree protette,<br />
<strong>di</strong>venta l’elemento chiave per non trasformare criteri <strong>di</strong> gestione coerente <strong>in</strong> un evidente<br />
paradosso.<br />
Punto <strong>di</strong> vista biologico<br />
- naturale <strong>in</strong>cremento <strong>del</strong>la biomassa unitaria f<strong>in</strong>o ai limiti <strong>del</strong>la capacità portante <strong>del</strong>la stazione;<br />
- presenza <strong>di</strong> un’area <strong>di</strong> mortalità per senescenza e competizione a livello <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale e<br />
specifico;<br />
- riorganizzazione <strong>del</strong>la potenzialità <strong>di</strong> post-coltura;<br />
- ricomposizione strutturale più o meno <strong>di</strong>namica secondo le fasce <strong>di</strong> vegetazione a livello <strong>di</strong><br />
complessità e <strong>di</strong>versità specifica preesistenti;<br />
- possibile presenza <strong>di</strong> sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> recessione, naturali nel processo <strong>di</strong> riavvio evolutivo;<br />
- eventualità <strong>di</strong> sta<strong>di</strong> successionali precoci;<br />
- <strong>in</strong>cremento degli habitat, <strong>del</strong>le connessioni funzionali, e <strong>di</strong>fferenziazione <strong>di</strong> nuove nicchie<br />
ecologiche rispetto all’ambiente precedente, biologicamente semplificato e più uniforme;<br />
- possibile iperattività <strong>di</strong> agenti biologici (funghi, <strong>in</strong>setti) favoriti dall’aumento notevole <strong>del</strong>la<br />
necromassa e dallo stato vegetativo scadente <strong>in</strong>dotto nella componente recessiva <strong>del</strong>la<br />
popolazione dal maggiore livello <strong>di</strong> competizione;<br />
- maggiore sensibilità a <strong>di</strong>sturbi <strong>di</strong> natura abiotica;<br />
- più elevato rischio <strong>di</strong> <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o <strong>in</strong> aree sensibili.<br />
Punto <strong>di</strong> vista colturale<br />
- apparente caos fisionomico-strutturale <strong>in</strong> un contesto precedentemente or<strong>di</strong>nato dalla<br />
coltivazione;<br />
- r<strong>in</strong>novata attenzione dove l’evoluzione trascorsa mostra i segni <strong>di</strong> una possibile accelerazione<br />
dei processi <strong>in</strong> atto, (es. utile liberazione e allevamento <strong>di</strong> gruppi specifici <strong>di</strong> <strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento recente,<br />
riduzione selettiva <strong>del</strong>la densità a favorire il naturale cambiamento fisionomico e strutturale o<br />
anticipare utilmente la fase <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione);<br />
- necessità <strong>di</strong> prevenire il maggiore rischio <strong>di</strong> <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o secondo le fasce <strong>di</strong> vegetazione e la<br />
posizione relativa <strong>del</strong> bosco;<br />
- possibilità <strong>di</strong> regolare i marg<strong>in</strong>i <strong>di</strong> connessione con le altre forme colturali presenti, guidando le<br />
l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> formazione degli ecotoni.<br />
Obiettivi generali<br />
Monitorare la <strong>di</strong>namica dei sistemi <strong>di</strong> transizione nella fase <strong>di</strong> post-coltura. In<strong>di</strong>viduare gli sta<strong>di</strong> e<br />
le componenti più fragili o sensibili ai <strong>di</strong>sturbi. Proporre soluzioni mirate per accelerare la<br />
ricomposizione naturale attraverso <strong>in</strong>terventi compatibili dal punto <strong>di</strong> vista ambientale ed<br />
economico. Prevedere i fattori <strong>di</strong> rischio e anticipare le possibili soluzioni con una gestione<br />
flessibile e <strong>di</strong> tipo adattativo.<br />
37
38<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Area <strong>del</strong>l’avviamento ad alto fusto<br />
Punto <strong>di</strong> vista produttivo<br />
- sostenuto <strong>in</strong>cremento <strong>del</strong>la biomassa arborea per la perio<strong>di</strong>ca riduzione <strong>del</strong>la densità <strong>del</strong><br />
soprassuolo;<br />
- <strong>in</strong>teresse per le masse raccolte che hanno macchiatico positivo già al taglio <strong>di</strong> avviamento o,<br />
successivamente, dal primo <strong>di</strong>radamento (tab. 2, 3, 4);<br />
- necessità <strong>di</strong> prima lavorazione (spacco) <strong>di</strong> un prodotto <strong>di</strong>fficilmente collocabile <strong>in</strong> un mercato<br />
<strong>di</strong>verso da quello <strong>del</strong>la legna da ardere;<br />
- m<strong>in</strong>ori costi <strong>di</strong> allestimento ed esbosco.<br />
Punto <strong>di</strong> vista biologico<br />
- forte accelerazione verso densità, struttura e fisionomia <strong>di</strong> fustaia;<br />
- semplificazione notevole <strong>del</strong>la struttura verticale nelle prime fasi;<br />
- cambiamento <strong>del</strong> microclima <strong>in</strong>terno per aumento <strong>del</strong>la ra<strong>di</strong>azione e m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong>tercettazione<br />
<strong>del</strong>le piogge;<br />
- progressivo aumento <strong>del</strong>lo spazio biologico verticale;<br />
- <strong>in</strong>cremento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>versità specifica per <strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento naturale <strong>di</strong> un piano accessorio nelle<br />
fasce <strong>di</strong> vegetazione floristicamente più ricche;<br />
- possibilità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tegrare artificialmente la <strong>di</strong>versità specifica ove vi sia lo spazio naturale (chiarie)<br />
o questo si crei per l’abbattimento <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e, già nella prima fase <strong>di</strong> avviamento;<br />
- mantenimento <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong>namico per la riduzione perio<strong>di</strong>ca <strong>del</strong> livello <strong>di</strong> competizione<br />
(<strong>di</strong>radamenti) a favorire la piena potenzialità <strong>di</strong> sviluppo <strong>del</strong>la popolazione selezionata;<br />
- creazione <strong>di</strong> nuovi habitat, connessioni funzionali e nicchie ecologiche;<br />
- per<strong>di</strong>ta degli habitat tipici <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong> ceduo e <strong>del</strong>la loro ripetibilità spazio-temporale per<br />
l’aumento <strong>del</strong> tempo <strong>di</strong> permanenza.<br />
Punto <strong>di</strong> vista colturale<br />
- creazione <strong>di</strong>retta, a partire dal soprassuolo orig<strong>in</strong>ario, <strong>di</strong> strutture con fisionomia <strong>di</strong> alto fusto;<br />
- aumento <strong>del</strong>la capacità naturale <strong>di</strong> <strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>verse (secondo le fasce);<br />
- possibilità <strong>di</strong> allevamento mirato <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>verse, anche spora<strong>di</strong>che, già presenti nel<br />
soprassuolo orig<strong>in</strong>ario;<br />
- anticipazione <strong>del</strong> ciclo successivo da seme;<br />
- opportunità <strong>di</strong> realizzare compiutamente la <strong>di</strong>fferenziazione fisionomico-strutturale <strong>del</strong> bosco<br />
orig<strong>in</strong>ale, selezionando le superfici suscettibili <strong>di</strong> avviamento (caratteristiche stazionali e <strong>di</strong><br />
soprassuolo idonee a supportare il cambiamento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo);<br />
- possibilità <strong>di</strong> regolare estensione <strong>del</strong>le superfici e forme <strong>di</strong> connessione con le altre opzioni<br />
colturali, <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong> contesto e <strong>del</strong>le funzioni localmente prevalenti.<br />
Obiettivi generali<br />
Superare l’obiezione per un cambiamento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo che non realizza<br />
imme<strong>di</strong>atamente una valorizzazione <strong>del</strong>la funzione produttiva attraverso assortimenti <strong>di</strong> maggior<br />
pregio. Acquisire coscienza che l’operazione produce, già nella fase <strong>di</strong> transizione, elementi<br />
importanti <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> un sistema più strutturato e pone le premesse <strong>di</strong> maggiore complessità<br />
e ricchezza biologica ottenibili soltanto con i tempi <strong>di</strong> permanenza funzionale tipici <strong>del</strong>l’alto fusto.<br />
Considerare sempre la soluzione avviamento come opzione nel contesto operativo.<br />
Economia <strong>del</strong>l’avviamento ad alto fusto (da: Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 2009)<br />
Se l’esistenza <strong>del</strong>le basi biologiche è fondamentale per la scelta <strong>del</strong>l’avviamento, altrettanto<br />
importante è la sua fattibilità <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> economia <strong>di</strong> realizzazione, essendo quello economico il<br />
determ<strong>in</strong>ante pr<strong>in</strong>cipale <strong>del</strong>la selvicoltura reale. A tale proposito, f<strong>in</strong>o dall’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong>la<br />
sperimentazione, fu posta attenzione al costo o al ricavo possibile dalle operazioni <strong>di</strong> coltivazione<br />
(tipo ed <strong>in</strong>tensità dei <strong>di</strong>radamenti). Il progressivo slittamento <strong>del</strong>le età <strong>di</strong> avviamento dai 20-25 anni<br />
agli attuali 30-35 anni, per l’<strong>in</strong>vecchiamento generalizzato dei soprassuoli, pone il tecnico gestore<br />
<strong>in</strong> una situazione ottimale per le masse <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> unitarie superiori su cui <strong>in</strong>tervenire, già con il taglio<br />
<strong>di</strong> avviamento. Nella tab. 2 sono rappresentati, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i quantitativi, i risultati per sei casi <strong>di</strong><br />
avviamento <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro <strong>di</strong> collocazione <strong>di</strong>versa <strong>in</strong> Toscana (area sub-costiera,<br />
coll<strong>in</strong>are <strong>in</strong>terna e pre-appenn<strong>in</strong>ica) e un sito <strong>di</strong> faggeta pre-appenn<strong>in</strong>ico. Il mo<strong>del</strong>lo colturale
Gianfranco Fabbio<br />
applicato, dopo 2-3 <strong>in</strong>terventi, tende a far convergere i parametri dendrometrici <strong>di</strong> s<strong>in</strong>tesi (massa<br />
totale e relativo <strong>in</strong>cremento me<strong>di</strong>o) verso valori simili.<br />
Tab. 2 – Statistiche dendrometriche relative ai risultati <strong>del</strong> trattamento <strong>di</strong> avviamento <strong>in</strong> 6 siti <strong>di</strong> cerro e <strong>in</strong> 1<br />
sito <strong>di</strong> faggio. Il numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti all’attualità (compreso il taglio <strong>di</strong> avviamento) è ( ).<br />
Età n°poll. H dom m.corr. m.<strong>in</strong>terc. m.tot. Imv tot<br />
Quercus cerris<br />
52 548 25,3 255 189(2-3) 444 8,5<br />
55 723 25,5 333 112 (2) 445 8,0<br />
45 402 24,1 196 160 (2) 356 7,9<br />
46 1120 23,7 269 107 (2) 376 8,2<br />
54 350 26,8 291 223 (3) 514 9,5<br />
53 513 24,5 280 143 (2) 423 8,0<br />
Quercus cerris (me<strong>di</strong>a)<br />
51 609 25,0 271 156 (2-3) 426 8,4<br />
Fagus sylvatica<br />
57 450 24,4 273 272 (3) 545 9,6<br />
Nella tab. 3 sono rappresentate le equivalenze produttive tra il ciclo parziale <strong>di</strong> avviamento f<strong>in</strong>o<br />
alle età osservate e i cicli <strong>di</strong> ceduo virtualmente possibili nello stesso <strong>in</strong>tervallo.<br />
Tab. 3 – Equivalenze produttive tra il ciclo parziale <strong>di</strong> avviamento e i cicli <strong>di</strong> ceduo virtualmente possibili<br />
nello stesso <strong>in</strong>tervallo, <strong>in</strong> siti <strong>di</strong> cerro e <strong>di</strong> faggio.<br />
Quercus cerris<br />
51<br />
età me<strong>di</strong>a<br />
avviamento<br />
271<br />
massa corrente<br />
156<br />
massa <strong>in</strong>terc.<br />
426<br />
massa tot.<br />
Ipotesi 3 turni <strong>di</strong> ceduo = 17 x 3 = 51 anni<br />
17 anni 52 m³ 17 anni 52 m³ 17 anni 52 m³ = 156 m³<br />
+<br />
+ +<br />
25 anni 78 m³<br />
+<br />
Fagus sylvatica<br />
57<br />
età me<strong>di</strong>a<br />
28 anni 136 m³<br />
+<br />
Ipotesi 2 turni <strong>di</strong> ceduo = 25 x 2 = 50 anni<br />
25 anni 78 m³<br />
+<br />
avviamento<br />
273<br />
massa corrente<br />
272<br />
massa <strong>in</strong>terc.<br />
Ipotesi 2 turni <strong>di</strong> ceduo = 28 x 2 = 56 anni<br />
28 anni 136 m³<br />
+<br />
= 156 m³<br />
545<br />
massa tot.<br />
= 272 m³<br />
I casi si riferiscono ai valori me<strong>di</strong> dalla tabella precedente (cerro) e al valore reale (faggio). La<br />
quantità <strong>di</strong> legna raccolta nei 2-3 <strong>in</strong>terventi è elevata e corrisponde a produzioni f<strong>in</strong>ali <strong>di</strong> buon livello<br />
<strong>di</strong> altrettanti cicli <strong>di</strong> ceduo. Il dato sottol<strong>in</strong>ea la possibilità <strong>di</strong> condurre una selvicoltura sostenibile<br />
anche sotto l’aspetto produttivo ai prezzi correnti <strong>del</strong>la legna e <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni me<strong>di</strong>o-buone <strong>di</strong><br />
esbosco.<br />
Nella tab. 4 si riportano 3 casi reali <strong>di</strong> avviamento (ceduo <strong>di</strong> cerro) eseguito alle età<br />
correntemente praticate, comprese tra 34 e 36 anni. Applicando i valori me<strong>di</strong> percentuali <strong>di</strong> raccolta<br />
ai dati <strong>del</strong>le tesi <strong>di</strong> controllo (ceduo <strong>in</strong> evoluzione naturale) <strong>di</strong> aree <strong>in</strong>serite <strong>in</strong> protocolli <strong>di</strong><br />
monitoraggio e per un range <strong>di</strong> età (29-40 anni) simile, si ottengono i valori <strong>di</strong> massa <strong>in</strong>tercalare<br />
che sarebbero stati utilizzati. Queste masse rappresentano un utile per la gestione e confermano<br />
come lo slittamento <strong>del</strong>le età me<strong>di</strong>e <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento renda ancora più conveniente, anche<br />
sotto l’aspetto produttivo, l’<strong>in</strong>vestimento colturale realizzato.<br />
39
40<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Tabella 4 – Parametri dendrometrici (prima <strong>del</strong> <strong>di</strong>radamento) e <strong>di</strong> utilizzazione (%) per avviamenti ad età<br />
<strong>in</strong>torno ai 35 anni (cedui <strong>di</strong> cerro) e simulazione dei risultati <strong>del</strong>la sua applicazione a soprassuoli non <strong>di</strong>radati<br />
<strong>di</strong> età simile (29-40 anni).<br />
CONCLUSIONI<br />
Casi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o reali<br />
età n°poll. G hdom vol. <strong>di</strong>radamento<br />
anni n° m² m m³ n° G vol.<br />
34 4728 29,3 20,6 171 81% 56% 39%<br />
35 3181 33,2 18,1 227 79% 51% 47%<br />
36 4282 30,0 15,2 n.d. 65% 48% n.d.<br />
valori me<strong>di</strong><br />
35 4064 30,8 18,0 199 75% 52% 43%<br />
simulazione dei valori <strong>in</strong>tercalari ottenibili con l’esecuzione <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento da<br />
casi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o reali (cedui <strong>in</strong> evoluzione naturale) a età <strong>di</strong> 29-40 anni<br />
età n°poll. G hdom vol. <strong>di</strong>radamento<br />
anni n° m² m m³ n° G vol.<br />
29 4191 35,4 18,7 259 3143 18,4 111<br />
32 5416 30,0 20,3 210 4062 15,6 90<br />
35 4509 30,2 17,5 191 3382 15,7 82<br />
38 4052 33,3 21,7 263 3039 17,3 113<br />
40 3589 41,3 22,6 351 2692 21,5 151<br />
valori me<strong>di</strong><br />
35 4351 34,0 20,2 255 3264 17,7 109<br />
Il cambiamento degli ultimi 40, 50 anni è il risultato <strong>del</strong>l’ elaborazione “naturale” <strong>di</strong> un’area molto<br />
vasta <strong>del</strong>la superficie forestale; questa ha prodotto <strong>di</strong>versità fisionomico-strutturale, <strong>di</strong><br />
composizione, funzionale, venuta meno una esigenza d’uso primaria omogeneizzante il sistema<br />
<strong>del</strong> bosco ceduo. In futuro questa evoluzione, coerente con lo sviluppo dei fattori economici, sociali<br />
e culturali, potrebbe non essere sufficiente e compatibile sia da un punto <strong>di</strong> vista biologico che per<br />
le aspettative emergenti collegate all’ambiente naturale e al bosco <strong>in</strong> particolare. Lo scenario<br />
potenziale sarà, <strong>di</strong> fatto, ancora governato dalle leggi economiche sia per gli aspetti <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong>retta che per gli <strong>in</strong>vestimenti necessari a <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzare, dove giu<strong>di</strong>cato opportuno, verso un<br />
evoluzione mirata una quota parte <strong>del</strong> bosco sottratta all’uso tra<strong>di</strong>zionale. Come già accaduto per<br />
molte <strong>del</strong>le soluzioni proposte nei convegni storici sul ceduo e per le <strong>in</strong>iziative attuate <strong>in</strong> seguito,<br />
tutto rischia <strong>di</strong> rimanere pura “accademia” se <strong>in</strong> contrasto con la fattibilità economica.<br />
La superficie ancora utilizzata è importante e capace <strong>di</strong> bilanciare le <strong>in</strong>cognite <strong>di</strong> quella <strong>in</strong><br />
sospensione <strong>del</strong> trattamento; nella gestione a ceduo la <strong>di</strong>namica nel ciclo <strong>di</strong> permanenza <strong>del</strong><br />
soprassuolo è nota, così come lo è la capacità <strong>di</strong> reazione ai <strong>di</strong>sturbi. Il perio<strong>di</strong>co azzeramento<br />
<strong>del</strong>la biomassa fuori terra consente <strong>di</strong> ripartire con un processo comunque molto <strong>di</strong>namico<br />
<strong>in</strong>nescato dalla pronta r<strong>in</strong>novazione per via agamica. In s<strong>in</strong>tesi, conosciamo bene possibilità e limiti<br />
<strong>di</strong> una forma <strong>di</strong> governo consolidata sulle pr<strong>in</strong>cipali formazioni <strong>di</strong> latifoglie. Venuta meno la<br />
convenienza economica alla utilizzazione per uso energetico, potremmo assistere <strong>in</strong> breve tempo<br />
ad un abbandono massiccio <strong>di</strong> qualsiasi forma <strong>di</strong> coltivazione <strong>del</strong> bosco <strong>in</strong> aree molto estese,<br />
accorpate e cronologicamente poco <strong>di</strong>fferenziate. Le conseguenze non sarebbero soltanto quelle<br />
più imme<strong>di</strong>atamente evidenti <strong>di</strong> una omogeneizzazione e banalizzazione <strong>del</strong> paesaggio rurale, ma<br />
anche quelle preve<strong>di</strong>bili <strong>di</strong> un’evoluzione <strong>in</strong>controllata verso fenomeni caotici. Questi ultimi,<br />
perfettamente naturali e capaci <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>are un nuovo equilibrio <strong>di</strong>namico nei tempi lunghi, sono<br />
poco desiderabili <strong>in</strong> ambienti rurali tuttora abitati e a cui viceversa chie<strong>di</strong>amo, più che <strong>in</strong> passato, <strong>di</strong><br />
assolvere ad una somma <strong>di</strong> funzioni che necessitano <strong>di</strong> <strong>in</strong>siemi or<strong>di</strong>nati, <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> esprimere<br />
capacità <strong>di</strong>fferenziate sulla base <strong>di</strong> strutture e parametri che solo la coltivazione, per quanto<br />
estensiva, può assicurare.<br />
Nell’area consolidata <strong>di</strong> <strong>in</strong>terruzione <strong>del</strong>le utilizzazioni l’età me<strong>di</strong>a è <strong>in</strong>torno ai 50 anni, il che<br />
significa conclusione <strong>del</strong>la fase più <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> ricomposizione successiva alla sospensione <strong>del</strong>la<br />
ceduazione ed <strong>in</strong>izio <strong>di</strong> una fase biologicamente più <strong>del</strong>icata. L’avanzamento <strong>del</strong>le età potrebbe
Gianfranco Fabbio<br />
<strong>in</strong>fluire sullo stato vegetativo <strong>di</strong> complesso <strong>del</strong>la popolazione <strong>in</strong> funzione <strong>di</strong> una raggiunta capacità<br />
portante <strong>del</strong>la stazione nelle fertilità m<strong>in</strong>ori o <strong>del</strong>la maggiore sensitività a <strong>di</strong>sturbi. Potrebbero<br />
verificarsi stagnazione <strong>del</strong>l’accrescimento, danni biotici facilitati anche dalle mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>in</strong> atto,<br />
(<strong>in</strong>fe<strong>del</strong>tà climatica e ricorrenti eventi estremi), <strong>di</strong>fficilmente controllabili se generalizzati e<br />
contemporanei su ampie superfici. Le conoscenze <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo sulla <strong>di</strong>namica bio-ecologica e<br />
strutturale <strong>di</strong> queste formazioni, così come sulla sensibilità e capacità <strong>di</strong> adattamento <strong>del</strong>le specie<br />
componenti alle con<strong>di</strong>zioni <strong>del</strong>l’ambiente <strong>di</strong> crescita ed ai trend climatici emergenti, sono <strong>in</strong>fatti<br />
forzatamente limitate alle età attualmente osservabili.<br />
Per questa somma <strong>di</strong> motivi, l’attenzione scientifica si deve focalizzare sul monitoraggio <strong>del</strong><br />
funzionamento dei sistemi <strong>di</strong> transizione che si sono naturalmente prodotti nell’area orig<strong>in</strong>ale.<br />
Maggiore conoscenza deve essere prodotta sul livello <strong>di</strong> efficienza bio-ecologica espresso dalla<br />
<strong>di</strong>namica naturale e su quello potenzialmente perseguibile con <strong>in</strong>terventi capaci <strong>di</strong> controllare<br />
componenti o fasi critiche <strong>del</strong> sistema <strong>in</strong> evoluzione. A ciascun tipo <strong>di</strong> gestione corrisponde un<br />
mo<strong>del</strong>lo fisionomico-strutturale e funzionale, <strong>di</strong> cui occorre prevedere potenzialità, limiti e capacità<br />
<strong>di</strong> risposta ai <strong>di</strong>sturbi. A questo impegno scientifico si deve sommare una maggiore attenzione<br />
laddove si applica una selvicoltura attiva: nell’area <strong>del</strong> mantenimento <strong>del</strong>la forma <strong>di</strong> governo a<br />
ceduo si devono legittimare <strong>in</strong> modo compiuto le utilità <strong>di</strong>rette ed <strong>in</strong><strong>di</strong>rette associate alla<br />
coltivazione <strong>del</strong> bosco; <strong>in</strong> quella <strong>del</strong>l’avviamento è necessario comprendere che si tratta <strong>di</strong> un<br />
<strong>in</strong>vestimento su basi biologiche fondate e validate <strong>in</strong> via sperimentale, capace <strong>di</strong> produrre benefici<br />
<strong>di</strong>retti ed <strong>in</strong><strong>di</strong>retti nel me<strong>di</strong>o e lungo periodo, non riducibile soltanto a realizzare utilità imme<strong>di</strong>ate.<br />
La base scientifica esistente non ha f<strong>in</strong>ora trovato una applicazione concreta e <strong>di</strong>ffusa perché<br />
implica decisori politici e la <strong>di</strong>sponibilità a produrre un pensiero coerente <strong>di</strong> politica forestale e<br />
ambientale. Questo deve poi tradursi <strong>in</strong> una efficiente filiera decisionale e trovare riscontro nei<br />
regolamenti <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong>la gestione tecnica. Il successo dei <strong>di</strong>versi progetti <strong>di</strong> ricerca applicata<br />
svolti ed <strong>in</strong> corso sul tema <strong>del</strong> bosco ceduo, ossia la loro ricaduta pratica, è strettamente collegato<br />
alla capacità <strong>di</strong> <strong>in</strong>terazione <strong>del</strong>le parti cui spettano compiti e responsabilità <strong>di</strong>verse, perfettamente<br />
complementari ma non sovrapponibili. Al ricercatore la responsabilità <strong>di</strong> produrre un miglioramento<br />
<strong>del</strong>le conoscenze scientifiche, al decisore politico la volontà <strong>di</strong> <strong>in</strong>traprendere un percorso logico e<br />
l’<strong>in</strong>put ai responsabili tecnico-amm<strong>in</strong>istrativi <strong>di</strong> realizzare gli strumenti regolatori per il trasferimento<br />
nella prassi operativa.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Agnoletti M. 2002 – Bosco ceduo e paesaggio: processi generali e fattori locali. In: Il bosco ceduo<br />
<strong>in</strong> Italia. A cura <strong>di</strong> O. Ciancio e S. Nocent<strong>in</strong>i. AISF, Firenze: 21-62.<br />
Agnoletti M. 2003 – Note sui pr<strong>in</strong>cipali mutamenti avvenuti negli ecosistemi forestali italiani<br />
dall’unità ad oggi. SISEF <strong>Atti</strong> 3: 127-132.<br />
Amor<strong>in</strong>i E. 1994 – Evoluzione <strong>del</strong>la struttura, <strong>del</strong>la composizione specifica e <strong>del</strong>la biometria <strong>in</strong> una<br />
cerreta mista <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua, <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong> trattamento. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992):<br />
7-40.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Gambi G. 1977 – Il metodo <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>vecchiamento nella conversione dei cedui <strong>di</strong> faggio.<br />
Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, VIII (1979): 21-42.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1986 – Stu<strong>di</strong>o auxometrico <strong>in</strong> un ceduo <strong>in</strong>vecchiato e <strong>in</strong> una fustaia da polloni <strong>di</strong><br />
faggio, sull’Appenn<strong>in</strong>o toscano: Primo contributo. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XIV (1983): 283-328.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1988 – L’avviamento all’altofusto nei cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro. Risultati <strong>di</strong> una<br />
prova sperimentale a 15 anni dalla sua impostazione. Primo contributo. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo,<br />
XVII (1986): 7-101.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1989° – L’avviamento all’alto fusto nei cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro. Risultati <strong>di</strong> una<br />
prova sperimentale a 15 anni dalla sua impostazione. Stu<strong>di</strong>o auxometrico. Secondo contributo. Ann.<br />
Ist. Sper. Selv. Arezzo, XVIII (1987): 19-70.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1989b – Considerazioni sull’avviamento all’altofusto dei boschi cedui. In: Il bosco<br />
nell’Appenn<strong>in</strong>o. Storia, vegetazione, ecologia, economia e conservazione <strong>del</strong> bosco appenn<strong>in</strong>ico.<br />
Centro Stu<strong>di</strong> “Valleremita” Fabriano: 99-107.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1990a – Le « vieillissement » des taillis en Italie : étude auxométrique et<br />
traitement de la futaie sur souches. Procee<strong>di</strong>ngs IUFRO, XIX World Congress. Montreal, August<br />
1990, Vol. 1: 363-374.<br />
41
42<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G., Frattegiani M., Manetti M.C. 1990b – L’affrancamento ra<strong>di</strong>cale dei polloni. Stu<strong>di</strong>o<br />
sugli apparati ra<strong>di</strong>cali <strong>in</strong> un soprassuolo avviato ad ltre turn <strong>di</strong> faggio. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo,<br />
XIX (1988): 201-261.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1991 – Ricerche sull’ “<strong>in</strong>vecchiamento” dei cedui: riflessi sul trattamento <strong>di</strong><br />
conversione. L’It. For. Mont., XLV (3): 193-204.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Manes F. 1994° – Aspetti selvicolturale , ltre turno sta ed e<strong>di</strong>fici <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong><br />
conversione. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, xxiii (1992): 5-6.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1994b – The coppice area <strong>in</strong> Italy. General aspects, cultivation trends and state of<br />
knowledge. In: Procee<strong>di</strong>ngs of the workshop “Improvement of coppice forests <strong>in</strong> the Me<strong>di</strong>terranean<br />
region”. Arezzo, 1992. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 292-298.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G., Tabacchi G. 1995 – Le faggete <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e agamica: evoluzione naturale e<br />
mo<strong>del</strong>lo colturale per l’avviamento ad alto fusto. <strong>Atti</strong> Sem<strong>in</strong>ario “Funzionalità <strong>del</strong> sistema faggeta”.<br />
AISF, Firenze 16-17 Novembre: 331-345.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1999 – Evoluzione <strong>del</strong> bosco ceduo sull’Appenn<strong>in</strong>o e opportunità per una<br />
selvicoltura <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>o. II Congresso Società Italiana <strong>di</strong> Selvicoltura e <strong>Ecologia</strong> Forestale. 20-22<br />
Ottobre, Bologna.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G., Tabacchi G. 1995 – Le faggete <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e agamica: evoluzione naturale e<br />
mo<strong>del</strong>lo colturale per l’avviamento ad alto fusto. <strong>Atti</strong> Sem<strong>in</strong>ario “Funzionalità <strong>del</strong> sistema faggeta”.<br />
AISF, Firenze 16 – 17 Novembre: 331-345.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Cut<strong>in</strong>i A., Fabbio G., Manetti M.C. 1996° – Stu<strong>di</strong> su struttura e processi<br />
ecologici <strong>in</strong> popolamenti <strong>di</strong> leccio <strong>del</strong>la Sardegna meri<strong>di</strong>onale. Comunicazioni <strong>di</strong> ricerca ISAFA, 96/1:<br />
35-47.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Cut<strong>in</strong>i A., Fabbio G. 1996b – Struttura e produttività <strong>di</strong> popolamenti <strong>di</strong><br />
leccio <strong>in</strong> Sardegna. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> VII Congresso <strong>del</strong>la Società Italiana <strong>di</strong> <strong>Ecologia</strong>. Napoli 11-14<br />
Settembre 17: 133-137.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Cut<strong>in</strong>i A., Fabbio G. 1997 – Gestion visant la conservation des ecosystemes de chene<br />
vert residuel en Sardaigne (Italie). Comptes Rendus du XI Congrès Forestier Mon<strong>di</strong>al. Antalya,<br />
13-22 Octobre vol.2 : 171.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Cut<strong>in</strong>i A., Fabbio G., Manetti M.C. 1998a – Silvicultural treatment of holm oak<br />
(Quercus ilex L.) coppices <strong>in</strong> Southern Sar<strong>di</strong>nia: th<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g and related effects on stand structure and<br />
canopy cover. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 27 (1996): 167-176.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Cut<strong>in</strong>i A., Di Lorenzo M.G., Fabbio G. 1998b – Treatment of Turkey oak<br />
(Quercus cerris L.) coppice. Structure, biomass and silvicultural options. Ann. Ist. Sper. Selv.<br />
Arezzo, 27 (1996): 121-129.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Di Lorenzo M.G., Fabbio G. 1998c – Intensity of standards release and shoots<br />
dynamics <strong>in</strong> a Turkey oak (Q.cerris L.) coppice. First contribution. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo,<br />
27 (1996): 105-111.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 1999 – La gestione <strong>del</strong> bosco ceduo nelle aree protette. In: <strong>Atti</strong> Sem<strong>in</strong>ario<br />
SBI “Gestione <strong>del</strong>le risorse agro-forestali <strong>in</strong> aree protette” Ancona 19-21/02. Informatore<br />
Botanico Italiano 33 (1), 2001: 164- 168.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Bran<strong>di</strong>ni P., Fabbio G., Tabacchi G. 2000 – Mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> previsione <strong>del</strong>le masse legnose e<br />
<strong>del</strong>le biomasse per i cedui <strong>di</strong> cerro <strong>del</strong>la Toscana centro-meri<strong>di</strong>onale. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo,<br />
29 (1998): 41-56.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G, Cantiani P. 2002° – Aspetti s elvicolturali. In: Gestione sostenibile e<br />
multifunzionale dei boschi cedui: il progetto SUMMACOP. Esperienze, attività e risultati. Autori<br />
vari. UE e Regione Umbria, Perugia 182p.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Cantiani P., Fabbio G. 2002b – Pr<strong>in</strong>cipali valutazioni sulla risposta degli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori<br />
dendrometrici e strutturali <strong>in</strong> querceti decidui <strong>del</strong>l’Umbria sottoposti a <strong>di</strong>verso trattamento<br />
colturale. In: Il progetto TRASFORM (a cura <strong>di</strong>) Ferretti M., Frattegiani M., Grohmann F., Sav<strong>in</strong>i P.<br />
Regione Umbria, Perugia 96p.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G., Cantiani P. 2006 – Avviamento ad alto fusto e <strong>di</strong>namica naturale nei cedui a<br />
prevalenza <strong>di</strong> cerro. Risultati <strong>di</strong> una prova sperimentale a 35 anni dalla sua impostazione. Il<br />
protocollo <strong>di</strong> Valsavignone (Arezzo) Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 33 (2003-04): 115-132.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Fabbio G. 2009 – I boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua nella selvicoltura italiana: sperimentazione,<br />
ricerca, prassi operativa. <strong>Atti</strong> III Congresso Nazionale <strong>di</strong> Selvicoltura, Taorm<strong>in</strong>a, vol II: 201-207.<br />
Autori vari 1979 – Il miglioramento dei cedui italiani. Acc. Naz. Agric. Bologna 401p.<br />
Bagnaresi U. 1981 – Il ceduo: una coltura attuale? Dendronatura (2): 13-31.
Gianfranco Fabbio<br />
Bengtsson J., Nilsson S.G., Franc A., Menozzi P. 2000 – Bio<strong>di</strong>versity, <strong>di</strong>sturbances, ecosystem<br />
function and management of European forests. For. Ec. And Manag. 132: 39-50.<br />
Benvenuti C., Cantiani P. 2003 – Il trattamento selvicolturale <strong>del</strong>le fustaie transitorie <strong>di</strong> cerro. Interventi<br />
propedeutici alla fase <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione. In: <strong>Atti</strong> IV congresso SISEF, Potenza: 27-31.<br />
Bernetti G. 1980 – L’auxometria dei boschi cedui italiani. L’It. For. Mont., XXXV (1): 1-24.<br />
Bernetti G. 1981 – Ipotesi sullo sviluppo dei boschi cedui e relative considerazioni selvicolturali e<br />
ltre turno sta. Monti e Boschi (5): 61-66.<br />
Bernetti G. 1983° – I cedui <strong>di</strong> querce caducifoglie. Cellulosa e Carta 34 (5): 6-12.<br />
Bernetti G. 1983b – Il trattamento a ltre turno sta mo<strong>di</strong>ficato. Monti e Boschi (1): 16-20.<br />
Bernetti G. 1987 – I cedui <strong>di</strong> querce caducifoglie nell’Italia centrale: proposte <strong>di</strong> politica forestale.<br />
Cell. E C. 38 (5): 4-10.<br />
Bernetti G. (1999) – Conseguenze <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> querce (Quercus cerris L. e Q.<br />
pubescens Willd.) <strong>di</strong> buona fertilità con turno superiore a 15 anni. Monti e Boschi (2): 30-31.<br />
Bert<strong>in</strong>i G., Fabbio G., Piovosi M. 2007 – Densità <strong>di</strong> biomassa e necromassa arborea epigea <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong><br />
cerro <strong>in</strong> <strong>in</strong>vecchiamento <strong>in</strong> Toscana. VI Congresso <strong>del</strong>la Società Italiana <strong>di</strong> Selvicoltura ed <strong>Ecologia</strong><br />
Forestale. Arezzo, 25-27/09/2007. Poster.<br />
Bran<strong>di</strong>ni P., Tabacchi G. 1996 – Mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> previsione <strong>del</strong> volume e <strong>del</strong>la biomassa per i polloni <strong>di</strong> leccio<br />
e <strong>di</strong> corbezzolo <strong>in</strong> boschi cedui <strong>del</strong>la Sardegna meri<strong>di</strong>onale. Comunicazioni <strong>di</strong> ricerca ISAFA, 96/1:<br />
59-69.<br />
Cantiani M. 1963 – Sviluppi <strong>del</strong> metodo colturale nell’assestamento forestale. L’It. For. Mont., XVIII<br />
(1): 46-48.<br />
Ciancio O., Corona P.M., Nocent<strong>in</strong>i S., Marchetti M. 2002 – L<strong>in</strong>ee guida per la gestione sostenibile<br />
<strong>del</strong>le risorse forestali e pastorali nei Parchi nazionali. AISF, Firenze: 300p.<br />
Clauser F. 1981 – Un’ipotesi auxonomica da verificare. Monti e Boschi, XXXII (2/3): 97-98.<br />
Cullotta S., Cut<strong>in</strong>o I., Fabbio G., Gaspar<strong>in</strong>i P., La Mantia T., Maggiore V., Marchetti M., Tosi V.<br />
2003 – Protected forest areas <strong>in</strong> Europe-analysis and harmonisation Country report-Italy. Cost<br />
Action E27 (PROFOR) 35p.<br />
Cut<strong>in</strong>i A. 1994 – In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> area fogliare, produzione <strong>di</strong> lettiera ed efficienza <strong>di</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong><br />
conversione. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 147-166.<br />
Cut<strong>in</strong>i A. 1994 – La stima <strong>del</strong> LAI con il metodo <strong>del</strong>le misure <strong>di</strong> trasmittanza <strong>in</strong> popolamenti <strong>di</strong>radati<br />
e non <strong>di</strong>radati <strong>di</strong> cerro. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 167-181.<br />
Cut<strong>in</strong>i A. 1997 – Drought effects on canopy properties and productivity <strong>in</strong> th<strong>in</strong>ned and unth<strong>in</strong>ned<br />
Turkey oak stands. Plant Biosystems, 131 (1): 59-65.<br />
Cut<strong>in</strong>i A., Benvenuti C. 1998 – Effects of silvicultural treatment on canopy cover and soil water content <strong>in</strong><br />
a Quercus cerris L. Coppice. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 27 (1996): 65-70.<br />
Cut<strong>in</strong>i A., Hajny M. 2006 – Effetti <strong>del</strong> trattamento selvicolturale su produzione <strong>di</strong> lettiera, caratteristiche<br />
<strong>del</strong>la copertura ed efficienza <strong>di</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong> conversione. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 33<br />
(2002-04): 133-142.<br />
Del Favero R. 2000 – Gestione forestale e produzione legnosa a f<strong>in</strong>i energetici. Sherwood (59): 5-<br />
9.<br />
Di Castri F. 1996 – Me<strong>di</strong>terranean <strong>di</strong>versity <strong>in</strong> a global economy. In: International Symposium on<br />
Me<strong>di</strong>terranean Diversity, Rome ENEA: 21-30.<br />
Di Matteo G., De Angelis P., Scarascia Mugnozza G. 2005 – Applicazione <strong>di</strong> tecniche isotopiche per<br />
valutare l’impatto ltre turno sta <strong>di</strong> <strong>in</strong>terventi selvicolturali <strong>di</strong> conversione all’alto fusto <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong><br />
specie me<strong>di</strong>terranee. Forest@ 2(4): 367-377.<br />
Di Matteo G., De Angelis P., Scarascia Mugnozza G. 2007 – Variazioni eco-fisiologiche <strong>in</strong> tre cedui<br />
me<strong>di</strong>terranei <strong>di</strong>sposti lungo un gra<strong>di</strong>ente altimetrico. Forest@ 4 (3): 310-323.<br />
Dowgiallo G., Pasqu<strong>in</strong>i A. 1994 – Indag<strong>in</strong>i pedologiche condotte su aree permanenti <strong>in</strong> cerrete<br />
miste <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 73-99.<br />
Ente Foreste Regione Sardegna (n.c.) – Le foreste demaniali <strong>di</strong> Settefratelli, Montimannu e Pula.<br />
Doc. <strong>in</strong>terni 16p.<br />
Fabbio G. 1994 – D<strong>in</strong>amica <strong>del</strong>la popolazione arborea <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong> <strong>in</strong>vecchiamento. Ann.<br />
Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 41-72.<br />
Fabbio G. 2006 – Il trattamento <strong>di</strong> avviamento ad alto fusto nei cedui <strong>di</strong> cerro. Sostenibilità biologica ed<br />
economica e tecniche <strong>di</strong> realizzazione. Relazione convegno “Selvicoltura sostenibile nei boschi<br />
cedui” Progetto Arsia-Reg. Toscana, Arezzo, 24/10.<br />
43
44<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua<br />
Fabbio G. 2007 – Opzioni colturali per i boschi cedui e <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua <strong>di</strong> cerro: obiettivi,<br />
complementarietà e connessioni sul territorio. Relazione “Progetto Ri.Selv.Italia. Le esperienze nel<br />
Centro-Sud Italia: presentazione dei risultati”. Potenza, 19-21/06/2007.<br />
Fabbio G. 2007 – Selvicoltura, funzionalità e gestione sostenibile dei cedui nell’area appenn<strong>in</strong>ica e<br />
me<strong>di</strong>terranea. Progetto “Riselvitalia” 3.2. Relazione f<strong>in</strong>ale, 15p. http//www.ricercaforestale.it<br />
Fabbio G., Manetti M.C., Puxeddu M. 1996 – La lecceta: un ecosistema <strong>in</strong> “riserva”. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> VII<br />
Congresso <strong>del</strong>la Società Italiana <strong>di</strong> <strong>Ecologia</strong>. Napoli 11-14 Settembre 17: 139-143.<br />
Fabbio G., Cut<strong>in</strong>i A., Mascia V. 1998 – Silvicultural treatment of holm oak coppices (Q.ilex L.) <strong>in</strong><br />
Southern Sar<strong>di</strong>nia: effects of canopy and crop th<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g on microclimate. Ann. Ist. Sper. Selv.<br />
Arezzo, 27 (1996): 55- 63.<br />
Fabbio G., Amor<strong>in</strong>i E., Cut<strong>in</strong>i A. 1998 – Towards a susta<strong>in</strong>able management of Me<strong>di</strong>terranean<br />
forest: the MEDCOP experience (1994-98). Proceed. VII International Congress of Ecology,<br />
“INTECOL”. Florence, 19-25 July. Contribution to the Symposium “Perspectives <strong>in</strong> susta<strong>in</strong>able<br />
land use of marg<strong>in</strong>al areas, land abandonment and restoration”: 295-308.<br />
Fabbio G., Iov<strong>in</strong>o F., Menguzzato G., Tabacchi G. 2002 – Confronto fra mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> previsione <strong>del</strong>la<br />
biomassa arborea elaborati per cedui <strong>di</strong> leccio. In: Il bosco ceduo <strong>in</strong> Italia. A cura <strong>di</strong> O. Ciancio<br />
e S. Nocent<strong>in</strong>i. AISF, Firenze: 469-495.<br />
Fabbio G., Merlo M., Tosi V. 2003 – Silvicultural management <strong>in</strong> ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong><strong>in</strong>g bio<strong>di</strong>versity and<br />
resistance of forests <strong>in</strong> Europe-the Me<strong>di</strong>terranean region. J. Of Env. Manag., 67 (1) Special<br />
Issue: 67-76.<br />
Fabbio G., Amor<strong>in</strong>i E. 2006 – Avviamento ad alto fusto e <strong>di</strong>namica naturale nei cedui a prevalenza <strong>di</strong><br />
cerro. Risultati <strong>di</strong> una prova sperimentale a 35 anni dalla sua impostazione. Il protocollo <strong>di</strong> Caselli<br />
(Pisa) Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 33 (2003-04): 79-104.<br />
Fabbio G., Bert<strong>in</strong>i G., Calderisi M., Ferretti M. 2008 – Status and trend of tree growth and mortality<br />
rate at the CONECOFOR plots, 1997-2004. Ann. CRA-SEL, Arezzo 34 (2005-2006): 11-20.<br />
Fabbio G., Bert<strong>in</strong>i G. 2009 – Monitoraggio, gestione, selvicoltura. <strong>Atti</strong> III Congresso Nazionale <strong>di</strong><br />
Selvicoltura, Taorm<strong>in</strong>a, vol I: 217-225.<br />
Farrell E.P., Fuhrer E., Ryan D., Andersson F., Huttl R., Piussi P. 2000 – European forest<br />
ecosystems: buil<strong>di</strong>ng the future on the legacy of the past. For. Ec. And Manag. 132: 5-20.<br />
Frankl<strong>in</strong> J.F. 1993 – Preserv<strong>in</strong>g bio<strong>di</strong>versity: species, ecosystems, or landscapes? Ecol. Appl. 3<br />
(2): 202-205.<br />
Fuhrer E. 2000 – Forest functions, ecosystem stability and management. For. Ec. And Manag. 132:<br />
29-38.<br />
Gabbrielli A. 1967 – Pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> v<strong>in</strong>colo forestale <strong>in</strong> alcune <strong>di</strong>sposizioni me<strong>di</strong>cee <strong>del</strong> XVI e XVII secolo.<br />
Ann. AISF 16, Firenze: 179-199.<br />
Gabbrielli A. 1980 – Selvicoltura toscana nel ‘700 (Prima parte). Ann. AISF 29, Firenze: 211-242.<br />
Gabbrielli A. 1985 – Selvicoltura toscana nel ‘700 (Seconda parte). Ann. AISF 34, Firenze: 179-<br />
226.<br />
Gambi G. 1968 – Le conversioni dei cedui <strong>in</strong> altofusto sull’Appenn<strong>in</strong>o tosco-emiliano. Ann. Acc.<br />
Naz. Agric. Bologna, III serie, LXXVIII: 1-49.<br />
Grignetti A., Vitale M., Manes F. 1994 – Stu<strong>di</strong>o ecofisiologico condotto su aree permanenti <strong>in</strong><br />
cerrete miste <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, XXIII (1992): 101-146.<br />
Gui<strong>di</strong> G. 1976 – Primi risultati <strong>di</strong> una prova <strong>di</strong> conversione <strong>in</strong> un ceduo matric<strong>in</strong>ato <strong>di</strong> cerro. Ann.<br />
Ist. Sper. Selv. Arezzo, VI (1975): 253-278.<br />
Hanouskova I., O’Sullivan P.E., Witkowski Z. 1999 – Perspective <strong>in</strong> susta<strong>in</strong>able land use of<br />
marg<strong>in</strong>al areas, land abandonment and restoration. In: Perspectives <strong>in</strong> Ecology (A. Far<strong>in</strong>a ed.).<br />
Leiden The Netherl. Backhuys Publ.: 295-308.<br />
Hippoliti G. 2001 – Sul governo a ceduo <strong>in</strong> Italia (XIX-XX secolo). In: Storia e risorse forestali. A<br />
cura <strong>di</strong> M. Agnoletti. AISF, Firenze: 353-374.<br />
ISAFA-MAF 1985 – Inventario Forestale Nazionale. S<strong>in</strong>tesi metodologica e risultati.<br />
ISAFA-MiPAAF-CFS 2005 – Inventario Nazionale <strong>del</strong>le Foreste e dei Serbatoi <strong>di</strong> Carbonio.<br />
Risultati.<br />
La Marca O., Mattioli M., Iorio G. 1987 – Ricerche sull’ottimizzazione <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura<br />
nei cedui <strong>di</strong> cerro. II contributo: il soprassuolo arboreo nei primi due anni <strong>del</strong> ciclo produttivo.<br />
Ann. AISF 36, Firenze: 3-33.<br />
La Marca O., Mar<strong>in</strong>o A., Mattioli M. 1989 – Osservazioni su ghiande <strong>di</strong> cerro prodotte da matric<strong>in</strong>e<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>versa età. In: Prospettive <strong>di</strong> valorizzazione <strong>del</strong>le cerrete <strong>del</strong>l’Italia meri<strong>di</strong>onale. Potenza, 3-<br />
4/10/1988. Reg. Basilicata. 1-3/89: 295-332.
Gianfranco Fabbio<br />
La Marca O. 1992 – Pr<strong>in</strong>cipali risultati <strong>del</strong>le ricerche sulla valorizzazione dei boschi <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong> Italia.<br />
Cell. E C. 43 (2): 28-32.<br />
Larsen J.B. 1995 – Ecological stability of forests and susta<strong>in</strong>able silviculture. For. Ec. And Manag.<br />
73: 85-96.<br />
Manetti M.C. 2005 – Le formazioni forestali a prevalenza <strong>di</strong> leccio: selvicoltura per la conservazione e<br />
il riprist<strong>in</strong>o. V Congresso <strong>del</strong>la Società Italiana <strong>di</strong> Selvicoltura ed <strong>Ecologia</strong> Forestale “Foreste e<br />
Società: cambiamenti, conflitti e s<strong>in</strong>ergie”. Tor<strong>in</strong>o, 27-30/09/2005. Poster.<br />
Manetti M.C., Gugliotta O. 2006 – Effetto <strong>del</strong> trattamento <strong>di</strong> avviamento ad ltre turn sulla <strong>di</strong>versità<br />
specifica e strutturale <strong>del</strong>le specie legnose <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro. Ann. Ist. Sper. Selv. Arezzo, 33<br />
(2002-04): 105-114.<br />
Manetti M.C., Bartolucci S. 2007 – Le formazioni forestali a prevalenza <strong>di</strong> leccio: gestione su base<br />
bio-ecologica. Relazione “Progetto Ri.Selv.Italia. Le esperienze nel Centro-Sud Italia:<br />
presentazione dei risultati”. Potenza, 19-21/06 2007.<br />
Meren<strong>di</strong> A. 1942 – Boschi cedui e matric<strong>in</strong>atura. La Rivista Forestale Italiana. IV (1-3):33-36.<br />
Merlo M., Rojas Briales E. 2000 – Public goods and externalities l<strong>in</strong>ked to Me<strong>di</strong>terranean forests:<br />
economic nature and policy. Land Use Policy 17, 197-208.<br />
Nocent<strong>in</strong>i S. 2002 – Inquadramento etico. In: L<strong>in</strong>ee guida per la gestione sostenibile <strong>del</strong>le risorse<br />
forestali e pastorali nei Parchi nazionali. A cura <strong>di</strong> O. Ciancio, P. Corona, M. Marchetti, S.<br />
Nocent<strong>in</strong>i. AISF, Firenze: 47-62.<br />
Nocetti M., Bert<strong>in</strong>i G., Fabbio G., Tabacchi G. 2007 – Equazioni <strong>di</strong> previsione <strong>del</strong>la fitomassa arborea<br />
per i soprassuoli <strong>in</strong> avviamento ad ltre turn <strong>in</strong> Toscana. Forest@ 4 (2): 204-212.<br />
Palmberg-Lerche C. 2001 – Conservation of forest biological <strong>di</strong>versity and forest genetic resources.<br />
Forest Genetic Resources, 28 FAO.<br />
Pavari A. 1955 – Il problema dei boschi cedui <strong>in</strong> Italia. Monti e Boschi (8): 339-350.<br />
Pavari A. 1958 – Il miglioramento dei cedui dal punto <strong>di</strong> vista forestale. Relazione al Convegno<br />
Nazionale sul Bosco Ceduo <strong>di</strong> Siena.<br />
Pettenella D. 2002 – Fattori <strong>di</strong> <strong>in</strong>erzia nelle forme <strong>di</strong> gestione e nuovi sviluppi <strong>del</strong> mercato per i<br />
boschi cedui. In: Il bosco ceduo <strong>in</strong> Italia. A cura <strong>di</strong> O. Ciancio e S. Nocent<strong>in</strong>i. AISF, Firenze:<br />
541-560.<br />
Piussi P. 1980 – Il trattamento a ceduo <strong>di</strong> alcuni boschi toscani dal XVI al XX secolo. Dendronatura<br />
1 (2):8-15.<br />
Piussi P. 1982 – Utilizzazione <strong>del</strong> bosco e trasformazione <strong>del</strong> paesaggio: il caso <strong>di</strong> Monte Falcone<br />
(XVII-XIX secolo). Quaderni storici XVII, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna, 49 (1): 84-107.<br />
Piussi P., Stiavelli S. 1986 – Dal documento al terreno. Archeologia <strong>del</strong> bosco <strong>del</strong>le Pianora (coll<strong>in</strong>e<br />
<strong>del</strong>le Cerbaie, Pisa). Quaderni storici XXI, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna, 62 (2): 445-466.<br />
Piussi P., Zanzi Sulli A. 1997 – Selvicoltura e storia forestale. AISF 46, Firenze: 25-42.<br />
Piussi P., Farrell E.P. 2000 – Interactions between society and forest ecosystems: challenges for<br />
the near future. For. Ec. And Manag. 132: 21-28.<br />
Roberts M.R., Gilliam F.S. 1995 – Patterns and mechanisms of plant <strong>di</strong>versity <strong>in</strong> forested<br />
ecosystems: implications for forest management. Ec. Appl. 5 (4): 969-977.<br />
Roversi P.F. 2007 – D<strong>in</strong>amica <strong>di</strong> popolazione <strong>del</strong>la Processionaria <strong>del</strong>la quercia e mo<strong>del</strong>li previsionali<br />
a breve term<strong>in</strong>e. Relazione “Progetto Ri.Selv.Italia. Le esperienze nel Centro-Sud Italia:<br />
presentazione dei risultati”. Potenza, 19-21/06/2007.<br />
Scarascia-Mugnozza G., Oswald H., Piussi P., Radoglou K. 2000 – Forests of the Me<strong>di</strong>terranean<br />
region: gaps <strong>in</strong> knowledge and research needs. For. Ec. And Manag. 132: 97-109.<br />
Susmel L. 1981 – Ceduo o ltre turn? Motivo <strong>di</strong> una filosofia. Econ. Mont. (4): 2-5.<br />
Teissier du Cros E. 2001 – Conserv<strong>in</strong>g forest genetic resources: objectives, research, networks.<br />
Forest Genetic Resources Management and Conservation. INRA DIC, Paris: 4-5.<br />
Tunno I., Di Matteo G., Bert<strong>in</strong>i G., Piovosi M., Fabbio G., De Angelis P. 2007 – Determ<strong>in</strong>azione dei<br />
pool <strong>di</strong> carbonio e azoto <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> cerro ltre turno. VI Congresso <strong>del</strong>la Società Italiana <strong>di</strong><br />
Selvicoltura ed <strong>Ecologia</strong> Forestale. Arezzo, 25-27/09/2007. Poster.<br />
Zanzi Sulli A., Di Pasquale G. 1993 – Funzioni <strong>del</strong>le “matric<strong>in</strong>e” dei cedui nella teoria selvicolturale<br />
<strong>del</strong> XVIII e XIX secolo. Rivista <strong>di</strong> Storia <strong>del</strong>l’Agricoltura. 1: 109-121.<br />
45
46<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua
Gianfranco Fabbio<br />
47
48<br />
Il ceduo tra passato e attualità: opzioni colturali e <strong>di</strong>namica dendro-auxonomica<br />
e strutturale nei boschi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e cedua
Gianfranco Fabbio<br />
49
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
LASELVICOLTURA NEL PIANO<br />
FORESTALE REGIONALE DELL’UMBRIA*<br />
FRANCESCO GROHMANN 1 , MAURO FRATTEGIANI 2 , GIORGIO IORIO 3 , PAOLA SAVINI 1<br />
1 SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA – REGIONE UMBRIA<br />
2 CONSULENTE SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA REGIONE UMBRIA<br />
3 COMUNITÀ MONTANA VALNERINA, NORCIA (PG)<br />
* estratto dagli atti <strong>del</strong> III Congresso nazionale <strong>di</strong> selvicoltura <strong>di</strong> Taorm<strong>in</strong>a (ME)
52<br />
Francesco Grohmann et al.
La selvicoltura nel Piano Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
53
54<br />
Francesco Grohmann et al.
La selvicoltura nel Piano Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
55
56<br />
Francesco Grohmann et al.
La selvicoltura nel Piano Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
57
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
La selvicoltura nel Piano Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
59
60<br />
Francesco Grohmann et al.
La selvicoltura nel Piano Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
61
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
LA NUOVA NORMATIVA FORESTALE DELL’UMBRIA<br />
ADRIANO GIUSTI, FRANCESCO GROHMANN<br />
SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA - REGIONE UMBRIA
64<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann<br />
Nel 1999 la Regione <strong>del</strong>l’Umbria si è dotata <strong>di</strong> un Piano Forestale Regionale (PFR) avente<br />
vali<strong>di</strong>tà decennale. Il Piano costituisce il quadro <strong>di</strong> riferimento per l’azione regionale nel settore<br />
forestale e l’<strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> obiettivi ed azioni ritenuti necessari per dare concretezza agli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi<br />
scaturiti <strong>in</strong> sede <strong>in</strong>ternazionale <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> foreste.<br />
L’obiettivo guida <strong>del</strong> PFR è <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare nuove motivazioni ad una gestione attiva <strong>del</strong>le risorse<br />
forestali da parte dei proprietari, pubblici o privati, o eventualmente <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> servizio da questi<br />
<strong>del</strong>egate.<br />
Gli strumenti <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong> PFR sono:<br />
• l’adeguamento <strong>del</strong>la normativa forestale, attraverso la redazione <strong>di</strong> un testo unico e<br />
l’aggiornamento <strong>del</strong>le prescrizioni <strong>di</strong> massima e <strong>di</strong> polizia forestale;<br />
• la presenza <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> pianificazione <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> dare effettiva concretezza agli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi<br />
stabiliti dal PFR ed articolato <strong>in</strong> un livello regionale (PFR), un livello comprensoriale (piani forestali<br />
comprensoriali relativi al territorio <strong>di</strong> una comunità montana, <strong>di</strong> un’area protetta, <strong>di</strong> un bac<strong>in</strong>o<br />
idrografico) e un livello aziendale o <strong>in</strong>teraziendale (piani <strong>di</strong> gestione forestale);<br />
• le fonti f<strong>in</strong>anziarie.<br />
Con l’approvazione <strong>del</strong> “Testo unico per le foreste” (legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)<br />
e <strong>del</strong> relativo “Regolamento <strong>di</strong> attuazione” (regolamento regionale 17 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 7) si è<br />
conclusa l’attività <strong>di</strong> revisione <strong>del</strong>la normativa forestale.<br />
TESTO UNICO PER LE FORESTE<br />
Il Testo unico assorbe, <strong>in</strong>tegra e aggiorna la <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a precedentemente articolata <strong>in</strong> 11 leggi<br />
regionali ed un regolamento, per la quasi totalità risalenti al periodo 1977-1983. Già a partire dalla<br />
metà degli anni ‘80 e successivamente con maggiore vigore, tali norme avevano evidenziato la loro<br />
<strong>in</strong>capacità <strong>di</strong> tenere il passo con l’evoluzione <strong>del</strong>le conoscenze tecnico-scientifiche, degli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi<br />
nazionali ed <strong>in</strong>ternazionali e <strong>del</strong>le attenzioni al settore da parte <strong>del</strong>l’op<strong>in</strong>ione pubblica, pur<br />
garantendo un sufficiente livello <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong> patrimonio forestale. Inoltre, tali norme, essendo<br />
anteriori, non potevano tenere conto <strong>di</strong> alcuni car<strong>di</strong>ni fondamentali che oggi <strong>in</strong>cidono, più o meno<br />
<strong>di</strong>rettamente, nell’attività <strong>del</strong> settore:<br />
• la legge 431/85, conosciuta come “legge-Galasso” che ha esteso a tutti i boschi il v<strong>in</strong>colo<br />
paesaggistico-ambientale, normativa ora assorbita dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490<br />
concernente il “Testo unico <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> beni culturali ed ambientali”;<br />
• le determ<strong>in</strong>azioni assunte nella Conferenza su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro<br />
nel 1992 e relative alla formulazione <strong>di</strong> politiche volte alla gestione forestale sostenibile ed alla<br />
conservazione <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità;<br />
• il processo paneuropeo avviato a livello europeo (Hels<strong>in</strong>ki, 1993) e che ha portato<br />
all’approvazione <strong>di</strong> 4 risoluzioni (gestione sostenibile <strong>del</strong>le foreste, conservazione <strong>del</strong>la<br />
bio<strong>di</strong>versità, cooperazione <strong>in</strong>ternazionale, adeguamento <strong>del</strong>le foreste europee ai cambiamenti<br />
climatici) e ad un sistema <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipi ed <strong>in</strong><strong>di</strong>catori <strong>di</strong> gestione sostenibile (Lisbona, 1998);<br />
• la Convenzione quadro sui cambiamento climatici (Kyoto, 1997) che ha portato le foreste al<br />
centro <strong>del</strong>le politiche <strong>di</strong> sviluppo economico quale ecosistema <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> sequestrare i gas serra;<br />
• il documento sulla Strategia forestale <strong>del</strong>l’Unione europea – COM (1998) 649 def. <strong>del</strong> 18<br />
novembre 1998 – che stabilisce gli obiettivi e le azioni <strong>del</strong>l’U.E. nel settore forestale attribuendo<br />
particolare rilievo alla promozione <strong>di</strong> una gestione, conservazione e sviluppo sostenibili <strong>del</strong>le<br />
foreste, al mantenimento e valorizzazione <strong>del</strong>le risorse <strong>del</strong>la selvicoltura e all’estensione <strong>del</strong>le<br />
superfici boschive;<br />
• il Regolamento 1257/99 relativo allo sviluppo rurale e che costituisce, relativamente al settore<br />
forestale, lo strumento per mettere <strong>in</strong> atto la Strategia forestale <strong>del</strong>l’Unione europea.<br />
In aggiunta a quanto contenuto nella precedente normativa regionale, si è ritenuto necessario<br />
legiferare <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> produzione e commercializzazione <strong>di</strong> materiale forestale <strong>di</strong> moltiplicazione<br />
al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> colmare una lacuna ormai storica e derivante <strong>in</strong> massima parte dall’impostazione <strong>del</strong>la<br />
legge nazionale <strong>di</strong> riferimento, la legge n. 269/73.<br />
In term<strong>in</strong>i generali, la f<strong>in</strong>alità <strong>del</strong> Testo unico è cercare, per quanto possibile, la semplificazione<br />
normativa e lo snellimento <strong>del</strong>le procedure burocratiche garantendo al contempo la tutela e la<br />
salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong> patrimonio forestale e <strong>del</strong> territorio dal punto <strong>di</strong> vista idrogeologico. Più <strong>in</strong><br />
particolare il tentativo è quello <strong>di</strong> superare la contrapposizione creatasi negli anni passati fra<br />
esigenze <strong>di</strong> conservazione e produzione <strong>di</strong> materie prime, aspetto che trova giusta soluzione nella<br />
gestione multifunzionale e sostenibile <strong>del</strong>le risorse forestali.
La nuova normativa forestale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO<br />
L’approvazione <strong>del</strong> Regolamento <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong> Testo unico ha costituito l’ultima tappa<br />
<strong>del</strong>l’azione <strong>di</strong> revisione <strong>del</strong>la normativa forestale regionale prevista dal Piano Forestale Regionale.<br />
Il Regolamento è stato impostato su due capisal<strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipali:<br />
• garantire un’efficace azione <strong>di</strong> tutela dei boschi e <strong>del</strong> territorio sotto l’aspetto idrogeologico;<br />
• non creare ostacolo allo svolgimento <strong>del</strong>le attività tra<strong>di</strong>zionali e sostenibili.<br />
Gran parte <strong>del</strong> Regolamento tratta le norme <strong>di</strong> tutela forestale e idrogeologica (avendo <strong>in</strong>fatti<br />
sostituito il regolamento regionale 1/81 relativo a “Prescrizioni <strong>di</strong> massima e <strong>di</strong> polizia forestale per<br />
i boschi e i terreni <strong>di</strong> montagna sottoposti a v<strong>in</strong>coli”) le cui f<strong>in</strong>alità, <strong>in</strong><strong>di</strong>cate all’articolo 2, sono:<br />
a) il mantenimento e lo sviluppo <strong>del</strong>le funzioni produttive nella gestione forestale;<br />
b) il mantenimento e l’appropriato miglioramento <strong>del</strong>le risorse forestali e <strong>del</strong> loro contributo al<br />
ciclo <strong>del</strong> carbonio;<br />
c) il mantenimento <strong>del</strong>la salute e vitalità <strong>del</strong>l’ecosistema forestale;<br />
d) il mantenimento, la conservazione e l’appropriato miglioramento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>versità biologica negli<br />
ecosistemi forestali;<br />
e) il mantenimento e l’appropriato miglioramento <strong>del</strong>le funzioni protettive nella gestione<br />
forestale;<br />
f) il mantenimento dei <strong>di</strong>ritti locali, il miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo <strong>del</strong>le<br />
funzioni sociali dei boschi.<br />
Tali f<strong>in</strong>alità co<strong>in</strong>cidono con i sei criteri stabiliti dalle Risoluzioni <strong>del</strong>le Conferenze <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isteriali<br />
sulla protezione <strong>del</strong>le foreste <strong>in</strong> Europa (Strasburgo, Hels<strong>in</strong>ki e Lisbona), cui l’Italia ha aderito, e<br />
che sono stati pertanto richiamati sia nel Decreto Legislativo <strong>di</strong> Orientamento e modernizzazione<br />
<strong>del</strong> settore forestale (n. 227/01) che nella Legge forestale <strong>del</strong>la Regione Umbria.<br />
Al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> garantire il rispetto dei criteri <strong>del</strong>la gestione forestale sostenibile, la <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a proposta<br />
è più dettagliata rispetto a quanto stabilito dal precedente regolamento e prevede <strong>di</strong>verse soluzioni<br />
<strong>in</strong>novative.<br />
L’<strong>in</strong>novazione pr<strong>in</strong>cipale <strong>in</strong>trodotta dal Regolamento, <strong>in</strong> analogia a quanto vigente <strong>in</strong> Toscana,<br />
è, sempre mantenendo un canale preferenziale per gli <strong>in</strong>terventi che vengono condotti nel rispetto<br />
<strong>del</strong> regolamento e dei piani <strong>di</strong> gestione forestale, quella <strong>di</strong> lasciare aperta la possibilità <strong>di</strong><br />
presentare qualsiasi proposta progettuale, nel quadro <strong>del</strong>la più ampia flessibilità <strong>di</strong> scelta<br />
selvicolturale. In quest’ultimo caso, la proposta <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento dovrà però essere valutata sia per<br />
verificarne il rispetto <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>alità <strong>del</strong>la Legge forestale regionale e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> il rispetto dei criteri <strong>di</strong><br />
gestione forestale sostenibile, che dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la compatibilità con le norme vigenti <strong>in</strong><br />
materia <strong>di</strong> tutela ambientale e <strong>del</strong> paesaggio.<br />
Considerata la particolarità dei boschi umbri che per l’85% sono governati a ceduo, particolare<br />
attenzione è stata prestata alle prescrizioni forestali che consentono <strong>di</strong> garantire la migliore<br />
r<strong>in</strong>novazione per via agamica dei boschi, mitigando le mo<strong>di</strong>fiche temporanee che comunque le<br />
utilizzazioni forestali possono produrre. Consentire <strong>in</strong> modo chiaro e trasparente il governo a<br />
ceduo, nel rispetto <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong>l’ecosistema forestale, è con<strong>di</strong>zione <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile anche<br />
per valorizzare l’uso <strong>del</strong>le risorse r<strong>in</strong>novabili a f<strong>in</strong>i energetici. A questo proposito nella Tabella 1<br />
sono riportati alcuni cambiamenti <strong>in</strong>trodotti dal regolamento relativamente al trattamento dei boschi<br />
cedui.<br />
Resta fermo che l’unica garanzia concreta <strong>del</strong>l’effettiva applicazione <strong>del</strong>la gestione sostenibile<br />
risiede nella presenza <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> pianificazione forestale per i quali il regolamento stabilisce le<br />
procedure <strong>di</strong> approvazione e le modalità <strong>di</strong> compilazione.<br />
Nei lavori preparatori <strong>del</strong> Regolamento, uno degli aspetti che ha richiesto maggiore impegno è<br />
stato cercare <strong>di</strong> coniugare lo snellimento <strong>del</strong>le procedure per i citta<strong>di</strong>ni con la tutela <strong>del</strong> patrimonio<br />
forestale e <strong>del</strong> territorio e la prevenzione dei danni. Da questo punto <strong>di</strong> vista si segnala<br />
l’<strong>in</strong>troduzione <strong>del</strong> silenzio assenso, nei casi <strong>in</strong> cui è prevista l’autorizzazione, e <strong>del</strong>la sola<br />
comunicazione preventiva per <strong>di</strong>versi <strong>in</strong>terventi che precedentemente necessitavano <strong>di</strong><br />
autorizzazione. Inoltre, le procedure <strong>di</strong>vengono via via più complesse al crescere <strong>del</strong> possibile<br />
impatto degli <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> modo da favorire e <strong>di</strong>ffondere approcci che provoch<strong>in</strong>o piccole<br />
perturbazioni all’ecosistema forestale o <strong>in</strong> alternativa la presentazione <strong>di</strong> un piano pluriennale <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>tervento. L’obiettivo è far sì che l’attività produttiva non sia <strong>in</strong>ibita o resa <strong>di</strong>fficoltosa e che, con<br />
un’adeguata organizzazione e pianificazione <strong>del</strong>le attività, sia possibile snellire notevolmente le<br />
procedure burocratiche rispetto alla situazione precedente, garantendo al contempo il<br />
65
66<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann<br />
miglioramento quali-quantitativo <strong>del</strong>le risorse. In tal senso, nella Tabella 2 si riporta, a titolo <strong>di</strong><br />
esempio e s<strong>in</strong>teticamente, per i pr<strong>in</strong>cipali aspetti trattati dal Regolamento, il raffronto fra la<br />
situazione precedente e quella attuale.<br />
Rivestono notevole importanza le novità <strong>in</strong>trodotte con l’istituzione <strong>del</strong>l’elenco <strong>del</strong>le <strong>di</strong>tte<br />
boschive idonee all’utilizzo dei boschi conto terzi (la precedente normativa si limitava<br />
all’utilizzazione dei boschi pubblici) e <strong>del</strong>l’elenco degli operatori forestali (Box 1), con l’obiettivo<br />
primario <strong>di</strong> riconoscere la professionalità <strong>di</strong> chi lavora <strong>in</strong> bosco e <strong>di</strong> garantire con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> maggiore<br />
sicurezza sul luogo <strong>di</strong> lavoro per gli addetti al settore. Peraltro, non esiste gestione, né tanto meno<br />
gestione sostenibile, se manca personale adeguatamente formato <strong>di</strong>sposto a lavorare <strong>in</strong> bosco.<br />
Per questo, massima attenzione è stata posta a garantire il lavoro a chi sa operare ed ha <strong>in</strong>vestito<br />
per migliorare l’operatività <strong>del</strong>la propria azienda. Il lavoro <strong>in</strong> bosco costituisce ancora oggi una <strong>del</strong>le<br />
poche attività produttive <strong>del</strong>le zone montane <strong>di</strong>rettamente legata al territorio che riesce a rimanere<br />
<strong>in</strong> vita senza sostegno f<strong>in</strong>anziario. Pertanto, le attività <strong>del</strong>la filiera bosco-legno, se valorizzate e<br />
riconosciute, possono contribuire sia al mantenimento dei posti <strong>di</strong> lavoro che alla creazione <strong>di</strong><br />
nuove e più qualificate possibilità occupazionali legate, ad esempio, all’uso <strong>del</strong>le biomasse forestali<br />
ai f<strong>in</strong>i energetici.<br />
Altri elementi <strong>di</strong> novità riguardano l’<strong>in</strong>serimento, nelle norme <strong>di</strong> tutela forestale, <strong>di</strong> aspetti legati<br />
alla conservazione <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità ed al miglioramento <strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong> bosco nel contenimento<br />
<strong>del</strong>l’effetto serra, come ad esempio:<br />
• il rilascio <strong>in</strong> bosco <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> alberi a f<strong>in</strong>i bioecologici;<br />
• il governo all’alto fusto dei boschi <strong>di</strong> faggio posti al limite altitu<strong>di</strong>nale <strong>del</strong>la vegetazione<br />
arborea;<br />
• il rilascio <strong>in</strong> bosco <strong>del</strong>le ramaglie, adottando le necessarie precauzioni ai f<strong>in</strong>i ant<strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o;<br />
• la salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione <strong>del</strong>le specie rare e spora<strong>di</strong>che presenti nei boschi;<br />
• l’<strong>in</strong>centivazione ad ottenere strutture più complesse nelle fustaie coetanee già a partire dai<br />
<strong>di</strong>radamenti.<br />
Inf<strong>in</strong>e, con il regolamento sono state <strong>in</strong>trodotte mo<strong>di</strong>fiche alle tabelle <strong>del</strong>le specie arboree<br />
sottoposte a tutela, <strong>del</strong>le specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e <strong>del</strong>le specie utilizzabili<br />
per gli impianti (imboschimenti, rimboschimenti e arboricoltura da legno). Le mo<strong>di</strong>fiche rispetto alle<br />
tabelle allegate all’ex L.R. n. 49/87 tengono conto <strong>del</strong> miglioramento <strong>del</strong>le conoscenze sul<br />
patrimonio floristico-vegetazionale <strong>del</strong>l’Umbria ed <strong>in</strong> particolare:<br />
• sono state <strong>in</strong>serite alcune specie arboree autoctone da tutelare ed altre non autoctone<br />
vengono ora tutelate solo nelle aree e<strong>di</strong>ficabili, tenuto conto che gli alberi <strong>di</strong> rilevante <strong>in</strong>teresse<br />
sono comunque tutelati <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalla specie;<br />
• sono state <strong>in</strong>serite fra le specie erbacee da proteggere le specie considerate critiche nella lista<br />
rossa <strong>del</strong>la flora regionale;<br />
• sono state escluse dalle specie utilizzabili per gli impianti alcune specie esotiche estranee<br />
all’ambiente umbro che possono, pertanto, essere utilizzate solo nell’ambito <strong>di</strong> progetti<br />
sperimentali.<br />
CONCLUSIONE<br />
Con il rior<strong>di</strong>no <strong>del</strong>la normativa forestale regionale l’Umbria ha <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzato la propria azione su<br />
nuovi b<strong>in</strong>ari maggiormente aderenti agli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi scaturiti a livello <strong>in</strong>ternazionale.<br />
E’ chiaro che la vali<strong>di</strong>tà <strong>del</strong>la nuova <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a ed <strong>in</strong> particolare la capacità <strong>di</strong> favorire il<br />
raggiungimento degli obiettivi stabiliti potrà essere valutata solo fra qualche anno. In ogni caso, si<br />
ritiene che con l’approvazione <strong>del</strong> Testo unico e <strong>del</strong> relativo regolamento <strong>di</strong> attuazione la Regione<br />
<strong>del</strong>l’Umbria possa <strong>in</strong>serirsi a pieno titolo fra le amm<strong>in</strong>istrazioni che promuovono la gestione<br />
forestale sostenibile.<br />
Ora per dare effettiva concretezza ai pr<strong>in</strong>cipi e criteri <strong>del</strong>la gestione forestale sostenibile è<br />
necessario che <strong>di</strong>vent<strong>in</strong>o operativi anche i restanti strumenti <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong> PFR: la<br />
pianificazione forestale e le fonti f<strong>in</strong>anziarie.<br />
Per quanto concerne la pianificazione forestale, nell’ambito <strong>del</strong> progetto <strong>di</strong> ricerca Riselvitalia<br />
(f<strong>in</strong>anziato dal M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>le Politiche Agricole e Forestali e sviluppato nel biennio 2001-2002) è<br />
stata ulteriormente messa a punto la metodologia già sperimentata <strong>in</strong> Umbria con la realizzazione<br />
<strong>di</strong> piani <strong>di</strong> gestione forestale su circa 11.000 ettari relativi a 15 <strong>di</strong>verse proprietà. Nel 2003 è<br />
prevista <strong>in</strong>oltre la realizzazione <strong>di</strong> un primo esempio <strong>di</strong> piano forestale comprensoriale per il bac<strong>in</strong>o<br />
idrografico <strong>del</strong> Lago Trasimeno.
La nuova normativa forestale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
Ma il decollo su vasta scala <strong>del</strong>la pianificazione forestale è <strong>di</strong>rettamente legato all’avvio <strong>del</strong>le<br />
misure forestali contenute nel Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale per l’Umbria nell’ambito <strong>del</strong>le quali<br />
importanza rilevante è stata riservata alla redazione dei piani <strong>di</strong> gestione forestale. In ogni caso,<br />
l’aver armonizzato il PFR con la strategia <strong>del</strong>l’Unione europea nel settore forestale ha reso il Piano<br />
<strong>di</strong> Sviluppo Rurale il pr<strong>in</strong>cipale motore <strong>del</strong>la politica forestale regionale. Ora il problema,<br />
certamente non facile, è quello <strong>di</strong> riuscire a riservare adeguati stanziamenti per le misure forestali,<br />
poiché si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre i fon<strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibili con il “mondo agricolo” che è certamente dotato <strong>di</strong><br />
maggiore capacità contrattuale.<br />
BOX 1 - ELENCHI DITTE ED OPERATORI BOSCHIVI<br />
Per l’iscrizione all’elenco <strong>del</strong>le <strong>di</strong>tte boschive è sufficiente presentare domanda all’ente competente per territorio<br />
(Comunità Montane o Comuni il cui territorio non è compreso <strong>in</strong> nessuna Comunità Montana) completa, <strong>in</strong> particolare,<br />
<strong>del</strong>le <strong>in</strong>formazioni tecniche necessarie per essere <strong>in</strong>seriti <strong>in</strong> una <strong>del</strong>le tre fasce <strong>in</strong> cui l’elenco e sud<strong>di</strong>viso:<br />
a) <strong>di</strong>tte idonee all’utilizzo <strong>di</strong> qualsiasi estensione <strong>di</strong> bosco;<br />
b) <strong>di</strong>tte idonee all’utilizzo <strong>di</strong> superfici <strong>in</strong>feriori a <strong>di</strong>eci ettari per s<strong>in</strong>gola proprietà;<br />
c) <strong>di</strong>tte idonee all’utilizzo <strong>di</strong> superfici <strong>in</strong>feriori a due ettari per s<strong>in</strong>gola proprietà.<br />
Tale sud<strong>di</strong>visione attualmente è f<strong>in</strong>alizzata pr<strong>in</strong>cipalmente a dare garanzie a chi ha concretamente <strong>in</strong>vestito per<br />
migliorare la propria dotazione <strong>di</strong> personale qualificato, <strong>di</strong> macch<strong>in</strong>e e <strong>di</strong> attrezzature. In ogni caso, si tratta <strong>di</strong> un primo<br />
passo verso una <strong>di</strong>fferenziazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>tte che <strong>in</strong> un prossimo futuro dovrà tenere conto non tanto <strong>del</strong>la superficie quanto<br />
<strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> operare <strong>in</strong> certi tipi <strong>di</strong> soprassuoli o <strong>di</strong> adottare determ<strong>in</strong>ati sistemi <strong>di</strong> utilizzazione.<br />
Per l’iscrizione all’elenco degli operatori forestali, occorre effettuare una prova pratica presso l’ente competente per<br />
territorio f<strong>in</strong>alizzata a verificare che il richiedente abbia sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti:<br />
a) tecniche <strong>di</strong> utilizzo <strong>in</strong> sicurezza <strong>del</strong>la motosega;<br />
b) tecniche per operare <strong>in</strong> sicurezza nei lavori <strong>in</strong> bosco;<br />
c) tecniche <strong>di</strong> abbattimento e potatura;<br />
d) <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale con particolare riferimento all’utilizzo <strong>del</strong>la motosega.<br />
Per evitare un impatto troppo forte sul settore, nel primo anno <strong>di</strong> applicazione <strong>del</strong> Regolamento verranno iscritti<br />
automaticamente nell’elenco degli operatori tutti coloro i quali sono titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>tta boschiva iscritta nell’apposito elenco o<br />
possono attestare <strong>di</strong> aver effettuato nel triennio precedente la presentazione <strong>del</strong>la domanda almeno 120 giornate<br />
lavorative <strong>in</strong> bosco come addetto all’uso <strong>del</strong>le motosega per le operazioni <strong>di</strong> abbattimento.<br />
Anche <strong>in</strong> questo caso si tratta solo <strong>di</strong> un primo passo verso una maggiore professionalità <strong>di</strong> tutti gli addetti, poiché<br />
l’obbligo <strong>del</strong>l’iscrizione vige esclusivamente per gli addetti alle operazioni <strong>di</strong> abbattimento, spalcatura e potatura eseguite<br />
con la motosega.<br />
Per entrambi gli elenchi il Regolamento specifica i casi <strong>in</strong> cui sia necessario procedere alla sospensione o revoca<br />
<strong>del</strong>l’idoneità. A questo riguardo fra i motivi per i quali è prevista la sospensione <strong>del</strong>l’idoneità per le <strong>di</strong>tte boschive si<br />
segnalano <strong>in</strong> particolare:<br />
- l’esecuzione <strong>di</strong> tagli con personale privo <strong>del</strong>l’iscrizione all’elenco;<br />
- essere stato condannato <strong>in</strong> via def<strong>in</strong>tiva per violazione alle norme <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> tutela ambientale e <strong>del</strong> paesaggio.<br />
Tabella 1.<br />
67
68<br />
Tabella 2.<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann<br />
INFOARTICOLO<br />
Autori: Adriano Giusti, Dirigente <strong>del</strong> Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed<br />
economia montana <strong>del</strong>la Regione <strong>del</strong>l’Umbria. E-mail agrimontane@regione.umbria.it<br />
Francesco Grohmann, Responsabile Sezione forestazione <strong>del</strong> Servizio programmazione<br />
forestale, faunistico-venatoria ed economia montana <strong>del</strong>la Regione <strong>del</strong>l’Umbria. E-mail<br />
forestazione@regione.umbria.it<br />
Parole Chiave: Normativa forestale, Legge Forestale Regionale, Regolamento, gestione<br />
forestale sostenibile, Umbria.<br />
Abstract: The new forest law <strong>in</strong> the Umbria Region<br />
The revision of forestry legislation <strong>in</strong> the Umbria Region has been concluded with the pass<strong>in</strong>g of<br />
the “Umbria Region forestry law” and relative “Regulations” for its putt<strong>in</strong>g <strong>in</strong>to practice. In this article<br />
the po<strong>in</strong>ts promot<strong>in</strong>g Susta<strong>in</strong>able Forest Management are dealt with; <strong>in</strong> particular, grater flexibility<br />
of silvicultural options, simplification of bureaucratic procedures and the recognition of professional<br />
qualifications of operators <strong>in</strong> the sector.
La nuova normativa forestale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
69
70<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann
La nuova normativa forestale <strong>del</strong>l’Umbria<br />
71
72<br />
Adriano Giusti, Francesco Grohmann
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
NUOVE TECNICHE D’INTERVENTO NEI BOSCHI CEDUI:<br />
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO SUMMACOP<br />
PAOLA SAVINI<br />
SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA - REGIONE UMBRIA
74<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
PREMESSA: ALCUNI RICHIAMI AL PROGETTO SUMMACOP<br />
SUMMACOP è un progetto <strong>di</strong>mostrativo che propone un <strong>di</strong>verso approccio ai boschi governati<br />
a ceduo, basato sulla <strong>di</strong>versificazione degli <strong>in</strong>terventi selvicolturali <strong>in</strong> relazione alle caratteristiche<br />
ambientali, forestali e al contesto socio-economico <strong>in</strong> cui il bosco è <strong>in</strong>serito.<br />
L’obiettivo generale è quello <strong>di</strong> aumentare la flessibilità <strong>del</strong> sistema gestionale e la capacità <strong>del</strong><br />
bosco <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le <strong>di</strong>verse richieste sociali, garantendo comunque la sostenibilità ambientale ed<br />
economica degli <strong>in</strong>terventi colturali.<br />
Il progetto è stato realizzato su quattro aree <strong>di</strong>mostrative e <strong>in</strong> ogni area sono state adottate<br />
soluzioni colturali <strong>di</strong>verse <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l’area e dei benefici richiesti.<br />
In s<strong>in</strong>tesi, le scelte colturali attuate possono essere così riassunte:<br />
- ceduazioni con matric<strong>in</strong>atura a gruppi;<br />
- ceduazioni su piccole superfici;<br />
- tagli <strong>di</strong> avviamento all’alto fusto;<br />
- <strong>di</strong>radamenti puntuali;<br />
- <strong>in</strong>terventi per la valorizzazione turistico-<strong>di</strong>dattica;<br />
- sospensione temporanea degli <strong>in</strong>terventi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> tipologie d’<strong>in</strong>tervento per lo più già co<strong>di</strong>ficate e alcune <strong>di</strong> esse risultano anche<br />
frequentemente adottate. Tra le tipologie meno conosciute e sperimentate va <strong>in</strong>vece <strong>in</strong>serita la<br />
ceduazione con rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e per gruppi e per questo motivo si è ritenuto importante<br />
descrivere con maggiore dettaglio le scelte colturali adottate nel progetto SUMMACOP per<br />
l’applicazione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> trattamento.<br />
E’ comunque utile riba<strong>di</strong>re, prima <strong>di</strong> addentrarsi nell’analisi <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura per gruppi, che il<br />
progetto SUMMACOP non è <strong>in</strong>centrato su questa tipologia <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento e non <strong>in</strong>tende promuovere<br />
la sostituzione tout court <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura tra<strong>di</strong>zionale con quella a gruppi. La proposta<br />
SUMMACOP è quella <strong>di</strong> applicare una gestione più flessibile <strong>del</strong> bosco, adottando <strong>di</strong> volta <strong>in</strong> volta<br />
le tecniche colturali ritenute più idonee per la situazione e per gli obiettivi prefissati, anche<br />
attraverso una maggiore <strong>di</strong>versificazione colturale e strutturale.<br />
LA MATRICINATURA PER GRUPPI: BREVE RASSEGNA BIBLIOGRAFICA<br />
La possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire le matric<strong>in</strong>e per gruppi è citata <strong>in</strong> molti testi <strong>di</strong> selvicoltura e su<br />
numerosi lavori che approfon<strong>di</strong>scono gli aspetti legati alla ceduazione. Nella maggior parte dei casi<br />
però viene semplicemente segnalata questa opportunità colturale senza addentrarsi troppo nei<br />
particolari attuativi o nelle motivazioni che ne giustificano l’applicazione (DE BERENGER, 1887),<br />
così come risultano piuttosto rare le citazioni che facciano riferimento ad applicazioni concrete.<br />
Per quanto riguarda le motivazioni, DUHAMEL DU MONCEAU (1772) segnala i rischi legati<br />
all’ombreggiamento <strong>del</strong>le ceppaie provocato da un eccessivo numero <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e e <strong>in</strong><strong>di</strong>vidua<br />
l’opportunità <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificare nei boschi parti con piante <strong>di</strong> alto fusto e parti “da taglio”, da “…spartire<br />
<strong>in</strong> guisa, che chiunque voglia comprare <strong>del</strong> legname d’un bosco, possa a suo talento trovarne…”.<br />
L’opportunità <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificare spazialmente le scelte colturali viene prospettata anche da<br />
FAVERO (1852), il quale prevede zone ad alto fusto anche all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> boschi governati a ceduo,<br />
al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> permettere una produzione <strong>di</strong> legname <strong>di</strong> pregio, non ottenibile dalla semplice<br />
matric<strong>in</strong>atura.<br />
Questo aspetto viene poi sviluppato da PERRIN (1954), che evidenzia come il rilascio a gruppi<br />
migliori la forma <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e e favorisca l’<strong>in</strong>se<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> soggetti da seme.<br />
Più dettagliato è PERONA, alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong> 1800, che ipotizza numerosi vantaggi nel rilascio <strong>del</strong>le<br />
matric<strong>in</strong>e per gruppi: <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce l’aduggiamento <strong>del</strong> ceduo nelle zone aperte, migliora la forma e la<br />
vigoria <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, permette <strong>di</strong> tenere conto <strong>del</strong>le eventuali variazioni nella qualità <strong>del</strong> suolo, è<br />
più facile da ottenere e conservare.<br />
In tempi più recenti, CIANCIO et al. (1984) e successivamente PIUSSI (1994) sottol<strong>in</strong>eano il<br />
fatto che la matric<strong>in</strong>atura per gruppi può favorire le operazioni <strong>di</strong> esbosco, soprattutto nel caso <strong>di</strong><br />
utilizzo <strong>del</strong>le gru a cavo.
Nuove tecniche d’<strong>in</strong>tervento nei boschi cedui: l’esperienza <strong>del</strong> progetto SUMMACOP<br />
Fig. 1. Immag<strong>in</strong>e satellitare <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> Monte<br />
Subasio dopo l’<strong>in</strong>tervento <strong>del</strong> 2001. (immag<strong>in</strong>e<br />
Ikonos)<br />
Fig. 2. L’area <strong>di</strong> Monte Subasio. Visione parziale degli<br />
<strong>in</strong>terventi effettuati nel 2001. (foto Sav<strong>in</strong>i)<br />
Molto meno frequenti sono le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni su come e quando rilasciare i gruppi: la maggior parte<br />
degli Autori <strong>in</strong><strong>di</strong>ca il faggio quale specie che più si avvantaggia da questo modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire le<br />
matric<strong>in</strong>e (CIANCIO et al., op. cit.; PIUSSI, op. cit.; PERRIN, op. cit.), ma PERRIN lo considera<br />
necessario anche per i cedui <strong>di</strong> querce e <strong>in</strong> particolare per la farnia.<br />
Ed è proprio PERRIN che fornisce <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni quantitative e pratiche per la realizzazione dei<br />
gruppi: l’Autore propone <strong>di</strong> sottoporre a ceduazione circa il 25% <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> bosco, mentre<br />
nella parte restante vengono allevati gruppetti coetanei <strong>di</strong> raggio pari all’altezza dom<strong>in</strong>ante, scalati<br />
per 5-6 classi <strong>di</strong> età e <strong>di</strong>radati <strong>in</strong> occasione <strong>del</strong> taglio <strong>del</strong> ceduo, con taglio a raso dei gruppi più<br />
vecchi. Nelle aree dove i gruppi più vecchi vengono tagliati a raso, la r<strong>in</strong>novazione può anche<br />
avvenire per piantagione.<br />
Nonostante la matric<strong>in</strong>atura per gruppi sia stata ritenuta valida dai prestigiosi Autori sopra<br />
richiamati, è poco frequente r<strong>in</strong>tracciare citazioni <strong>di</strong> esempi applicativi. Secondo BERNETTI (1987),<br />
che cita la matric<strong>in</strong>atura a gruppi per i cedui <strong>di</strong> faggio, questa forma <strong>di</strong> trattamento non è mai stata<br />
applicata <strong>in</strong> Toscana (ad eccezione <strong>del</strong>le foreste <strong>di</strong> Acquer<strong>in</strong>o e Luogomano, <strong>in</strong>teressate <strong>in</strong> passato<br />
da un particolare sistema <strong>di</strong> rilascio <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e che può essere riferito alla matric<strong>in</strong>atura per<br />
gruppi).<br />
CIANCIO et al. (op. cit.) riportano <strong>in</strong>vece <strong>del</strong>la documentazione fotografica relativa<br />
all’applicazione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura per gruppi <strong>in</strong> un bosco <strong>di</strong> cerro <strong>del</strong>la Val <strong>di</strong> Taro (Emilia<br />
Romagna): non vengono riportati dati quantitativi su questa esperienza, ma dalla foto si deduce<br />
una <strong>di</strong>mensione dei gruppi ben <strong>in</strong>feriore a quella proposta da PERRIN, con un raggio pari a circa<br />
1/3 <strong>del</strong>l’altezza dom<strong>in</strong>ante.<br />
PERRIN (op. cit.) è sicuramente il più attento nell’identificare zone dove risulti applicata la<br />
matric<strong>in</strong>atura per gruppi e cita <strong>in</strong> particolare alcune foreste <strong>di</strong> farnia <strong>del</strong>l’Alta Alsazia e alcune<br />
formazioni <strong>di</strong> rovere <strong>del</strong>la Francia Centro – occidentale, dove la matric<strong>in</strong>atura per gruppi veniva<br />
applicata da <strong>di</strong>versi decenni.<br />
Tornando <strong>in</strong> Italia, prove <strong>di</strong> applicazione sperimentale <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura per gruppi sono state<br />
recentemente effettuate <strong>in</strong> boschi a prevalenza <strong>di</strong> cerro a Pietralunga, dove il metodo è stato<br />
messo a confronto con una ceduazione caratterizzata da una matric<strong>in</strong>atura uniformemente<br />
<strong>di</strong>stribuita sul terreno (FERRETTI et al., 2000).<br />
75
76<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
Un altro aspetto importante da evidenziare riguarda i riferimenti normativi: <strong>in</strong> Umbria, le attuali<br />
Prescrizioni <strong>di</strong> Massima e <strong>di</strong> Polizia Forestale (REGIONE DELL’UMBRIA, 1981) considerano la<br />
matric<strong>in</strong>atura per gruppi come opzione selvicolturale alternativa alla matric<strong>in</strong>atura uniformemente<br />
<strong>di</strong>stribuita sul terreno, prevedendo come unica clausola una <strong>di</strong>stanza tra i gruppi <strong>in</strong>feriore ai 20 m.<br />
Già nel 1930 le norme <strong>in</strong> vigore nella prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Perugia, approvate con D.M. <strong>del</strong> 29 Ottobre<br />
1930, prevedevano la possibilità <strong>di</strong> effettuare una matric<strong>in</strong>atura per gruppi (CAMERA DI<br />
COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PERUGIA, 1952) con un numero <strong>di</strong> piante da<br />
rilasciare uguale a quello previsto per la matric<strong>in</strong>atura uniforme.<br />
L’art. 51 prevedeva <strong>di</strong> rilasciare le matric<strong>in</strong>e “<strong>di</strong>stribuite possibilmente <strong>in</strong> modo uniforme su tutta<br />
la superficie <strong>del</strong>la tagliata od a gruppi, a seconda che possano o no resistere all’isolamento, con<br />
preferenza però per i luoghi dove la loro presenza potrà meglio favorire la r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong> bosco.<br />
In ogni caso i gruppi non devono rimanere a <strong>di</strong>stanza maggiore <strong>di</strong> m 25 l’uno dall’altro.”<br />
L’<strong>in</strong>serimento <strong>di</strong> questa opzione selvicolturale è probabilmente dovuto ad <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni fornite alle<br />
prov<strong>in</strong>cie successivamente all’entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la legge Serpieri. Non sono state r<strong>in</strong>tracciate<br />
menzioni relative alla matric<strong>in</strong>atura per gruppi all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> normative precedenti al 1923, mentre<br />
le prescrizioni <strong>di</strong> massima <strong>del</strong>la prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne <strong>del</strong> 1880 e quelle <strong>di</strong> Firenze <strong>del</strong> 1890<br />
prescrivevano espressamente una <strong>di</strong>stribuzione uniforme <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura.<br />
ASPETTI SIGNIFICATIVI CHE CARATTERIZZANO LA MATRICINATURA PER GRUPPI<br />
• ALLEVAMENTO MATRICINE: la matric<strong>in</strong>atura per gruppi non altera le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
stabilità <strong>del</strong>le piante <strong>in</strong>terne e limita i <strong>di</strong>fetti provocati da un brusco isolamento <strong>del</strong>le piante qualora<br />
esse siano poste all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> gruppo. In alcuni casi specifici può essere previsto il <strong>di</strong>radamento<br />
<strong>del</strong> gruppo al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> valorizzare alcune piante can<strong>di</strong>date.<br />
• CREAZIONE/VALORIZZAZIONE MICROHABITAT: le emergenze presenti all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un<br />
ecosistema forestale non vengono considerate nel caso <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura uniforme. Possono <strong>in</strong>vece<br />
essere considerate nella matric<strong>in</strong>atura per gruppi se i gruppi vengono <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati <strong>in</strong> corrispondenza<br />
<strong>di</strong> particolari situazioni (affioramenti rocciosi, <strong>di</strong>rupi, ristagni, presenza <strong>di</strong> specie rare…). Attraverso<br />
l’applicazione <strong>di</strong> una matric<strong>in</strong>atura per gruppi aumentano notevolmente le fasce <strong>di</strong> ecotone e può<br />
essere mantenuta <strong>in</strong> queste zone la <strong>di</strong>versificazione strutturale <strong>del</strong> bosco, evitando il taglio <strong>del</strong>le<br />
piante dom<strong>in</strong>ate e <strong>del</strong>lo strato arbustivo.<br />
• VIGORIA DELLE CEPPAIE E DEI POLLONI: le ceppaie dovrebbero risentire meno<br />
<strong>del</strong>l’effetto aduggiante <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, soprattutto rispetto a matric<strong>in</strong>ature particolarmente <strong>in</strong>tense.<br />
Sebbene non vi siano dati probanti a riguardo, è probabile che l’effetto “qu<strong>in</strong>ta” svolto dalla<br />
presenza dei gruppi eserciti un’azione <strong>di</strong> “accompagnamento laterale“ che stimola l’accrescimento<br />
<strong>in</strong> altezza dei giovani polloni.<br />
• ASPETTI PAESAGGISTICI: <strong>in</strong>dubbiamente l’impatto paesaggistico è <strong>di</strong>verso e molto<br />
probabilmente è necessario “abituarsi” alla vista <strong>di</strong> un certo tipo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento. L’effetto <strong>del</strong>la<br />
matric<strong>in</strong>atura a gruppi <strong>di</strong>pende soprattutto dal contesto <strong>in</strong> cui è <strong>in</strong>serito il bosco e <strong>in</strong> particolare il<br />
suo impatto visivo risulta m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> zone caratterizzate da una mosaicatura <strong>di</strong> elementi forestali ed<br />
elementi agricoli (sem<strong>in</strong>ativi e/o pascoli). In generale, rispetto ad una matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong>tensa e<br />
uniformemente <strong>di</strong>stribuita, la matric<strong>in</strong>atura a gruppi è maggiormente impattante nel caso <strong>di</strong><br />
paesaggio vissuto (il visitatore all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> bosco), ma questo effetto può essere attenuato<br />
<strong>di</strong>sponendo i gruppi ai marg<strong>in</strong>i <strong>del</strong>le zone maggiormente frequentate.<br />
• BIODIVERSITÀ: la maggiore <strong>di</strong>versificazione strutturale <strong>in</strong>trodotta dalla matric<strong>in</strong>atura a<br />
gruppi e la presenza <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> ecotone dovrebbe generalmente garantire una maggiore<br />
ricchezza floristica e faunistica rispetto ad <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura uniformemente <strong>di</strong>stribuita,<br />
soprattutto nel caso <strong>di</strong> gruppi con <strong>di</strong>mensioni superiori all’altezza dom<strong>in</strong>ante dei polloni.<br />
• ASPETTI PRODUTTIVI: la produzione risulta più concentrata nello spazio e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> si<br />
limitano i tempi <strong>di</strong> spostamento. La mancanza <strong>di</strong> una matric<strong>in</strong>atura <strong>di</strong>ffusa su tutta la superficie<br />
semplifica le operazioni <strong>di</strong> abbattimento ed esbosco.<br />
• PROTEZIONE IDROGEOLOGICA: la matric<strong>in</strong>atura a gruppi dovrebbe fornire maggiori<br />
garanzie nel caso <strong>di</strong> rischi <strong>di</strong> erosione concentrati <strong>in</strong> alcune porzioni <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento,<br />
mentre l’effetto protettivo svolto dalle matric<strong>in</strong>e è probabilmente <strong>in</strong>feriore rispetto ad una<br />
matric<strong>in</strong>atura tra<strong>di</strong>zionale nel caso <strong>in</strong> cui i rischi idrogeologici siano uniformemente presenti su tutta<br />
la superficie.<br />
• PROFESSIONALITÀ DEI TECNICI: è sicuramente l’aspetto più penalizzante per la<br />
matric<strong>in</strong>atura a gruppi. Per potere ottenere i vantaggi sopra riportati è necessario che i gruppi da
Nuove tecniche d’<strong>in</strong>tervento nei boschi cedui: l’esperienza <strong>del</strong> progetto SUMMACOP<br />
rilasciare siano <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati con attenzione da tecnici <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> valutare le <strong>di</strong>verse esigenze <strong>del</strong><br />
bosco e non solamente quelle produttive. L’<strong>in</strong>serimento <strong>del</strong>la martellata nei cedui costituirebbe<br />
un’<strong>in</strong>novazione e conseguentemente un aumento dei costi nella maggior parte <strong>del</strong>le regioni<br />
italiane, dove questi <strong>in</strong>terventi sono effettuati senza una segnatura prelim<strong>in</strong>are <strong>del</strong>le piante da<br />
rilasciare. Sulla base <strong>del</strong>le esperienze personali, si ritiene però importante sottol<strong>in</strong>eare che la<br />
realizzazione <strong>di</strong> una martellata per gruppi richiede un tempo <strong>in</strong>feriore rispetto alla martellata <strong>di</strong> un<br />
ceduo con matric<strong>in</strong>atura uniformemente <strong>di</strong>stribuita e con un numero <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e ad ettaro<br />
superiore a 200.<br />
I DATI DI SUMMACOP<br />
I boschi sottoposti a ceduazione con matric<strong>in</strong>atura per gruppi sono localizzati nelle aree<br />
<strong>di</strong>mostrative <strong>di</strong> Monte Subasio e <strong>di</strong> Monte Peglia (figure 3 e 4).<br />
Fig. 3. Localizzazione degli <strong>in</strong>terventi con<br />
matric<strong>in</strong>atura a gruppi nell’area <strong>di</strong>mostrativa <strong>di</strong> Monte<br />
Peglia.<br />
Fig. 4. Localizzazione degli <strong>in</strong>terventi con<br />
matric<strong>in</strong>atura a gruppi nell’area <strong>di</strong>mostrativa <strong>di</strong> Monte<br />
Subasio<br />
Complessivamente, la superficie <strong>in</strong>teressata da questo tipo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento è pari a circa 51.900<br />
m² e gli <strong>in</strong>terventi sono stati effettuati <strong>in</strong> prevalenza nell’<strong>in</strong>verno 2000-2001 e completati nell’<strong>in</strong>verno<br />
2001-2002 (tabella 1). In tabella sono riportate le pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche descrittive dei<br />
popolamenti <strong>in</strong> esame, mentre <strong>in</strong> tabella 3 sono descritte le caratteristiche <strong>di</strong>mensionali dei gruppi<br />
rilasciati.<br />
Tabella 1 – Riepilogo dei pr<strong>in</strong>cipali <strong>in</strong>terventi con matric<strong>in</strong>atura a gruppi<br />
Area <strong>di</strong>mostrativa Anno <strong>in</strong>tervento<br />
Superficie <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>tervento (ha)<br />
Monte Subasio 2001 1.40<br />
Monte Subasio 2002 2.78<br />
Monte Peglia 2001 1.01<br />
L’elevata eterogeneità che emerge nella <strong>di</strong>mensione dei gruppi è legata alle caratteristiche dei<br />
popolamenti nelle <strong>di</strong>verse situazioni ma anche alla volontà <strong>di</strong> verificare nel tempo la <strong>di</strong>versa<br />
evoluzione che avranno i gruppi <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le loro <strong>di</strong>mensioni, soprattutto per gli aspetti<br />
vegetazionali, faunistici e paesaggistici.<br />
Per quanto riguarda i valori <strong>di</strong> copertura è necessario precisare che non è considerato l’effetto<br />
<strong>di</strong> copertura dovuto al marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la tagliata e ai gruppi che sono a contatto con il marg<strong>in</strong>e stesso.<br />
Tali valori acquistano particolare importanza nel caso <strong>di</strong> tagliate <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni come quelle<br />
<strong>in</strong>teressate dal progetto e pertanto il valore <strong>di</strong> copertura risulta sensibilmente sottostimato.<br />
Infatti, se si considerano i valori me<strong>di</strong> <strong>del</strong>le <strong>di</strong>mensioni dei gruppi alla base (9.90 m), l’ampiezza<br />
me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le chiome (1.58 m), la <strong>di</strong>stanza me<strong>di</strong>a tra i gruppi (15.75 m) e ipotizzando gruppi circolari<br />
uniformemente <strong>di</strong>stribuiti, il grado <strong>di</strong> copertura risulterebbe pari al 20,4%. Tale valore risulta<br />
paragonabile a quello presente <strong>in</strong> un ceduo semplicemente matric<strong>in</strong>ato con 200-250 piante per<br />
77
78<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
ettaro uniformemente <strong>di</strong>stribuite (secondo l’<strong>in</strong>ventario Forestale Regionale <strong>del</strong>l’Umbria, il numero<br />
me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e nei cedui <strong>di</strong> querce caducifoglie è pari a 239 piante a ettaro).<br />
Tabella 2 – Pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche dei popolamenti <strong>in</strong>teressati da <strong>in</strong>tervento con matric<strong>in</strong>atura a gruppi<br />
Numero piante (N/ha)<br />
Area basimetrica (m²/ha)<br />
Diametro me<strong>di</strong>o (cm)<br />
Monte Subasio<br />
(<strong>in</strong>tervento 2001)<br />
Area <strong>di</strong>mostrativa<br />
Monte Peglia<br />
(<strong>in</strong>tervento 2001)<br />
Specie pr<strong>in</strong>cipale Quercus cerris Quercus cerris<br />
matric<strong>in</strong>e 206 175<br />
polloni 3033 1496<br />
totale 3239 1671<br />
matric<strong>in</strong>e 12,99 7,99<br />
polloni 18,74 16,33<br />
totale 31,73 24,32<br />
matric<strong>in</strong>e 28,3 24,1<br />
polloni 8,9 11,8<br />
totale 11,2 13,6<br />
Altezza me<strong>di</strong>a (m)<br />
matric<strong>in</strong>e<br />
polloni<br />
20,9<br />
11,1<br />
18,1<br />
13,1<br />
totale 12,7 14,1<br />
Massa legnosa stimata (t/ha) 141 127<br />
Tabella 3 – Pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche dei gruppi <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e<br />
Monte Subasio<br />
(<strong>in</strong>tervento 2001)<br />
Monte Peglia Valori complessivi<br />
(<strong>in</strong>tervento 2001) (<strong>in</strong>terventi 2001)<br />
Numero gruppi 1 - 15 7 22<br />
Valore me<strong>di</strong>o m 15,72 15,81 15,75<br />
Distanza tra i gruppi Valore massimo m 19,94 19,88 19,94<br />
Valore m<strong>in</strong>imo m 9,82 9,86 9,82<br />
Numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> piante per ogni gruppo - 24 29 25,59<br />
Dimensione me<strong>di</strong>a dei gruppi alla base dei tronchi<br />
Dimensione me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>la chioma degli alberi<br />
m<br />
m<br />
8,64<br />
1,58<br />
12,6 9,90<br />
2 1,59 1,58<br />
Dimensione dei gruppi al Valore me<strong>di</strong>o m 11,8 15,72 13,05<br />
marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la proiezione Valore massimo m 6,14 11,43 6,14<br />
<strong>del</strong>le chiome<br />
Valore m<strong>in</strong>imo m 19,56 19,66 19,66<br />
Copertura dei gruppi % 12,58 13,46 12,95<br />
1 Sono stati considerati esclusivamente i gruppi completamente <strong>in</strong>clusi nella superficie utilizzata. Sono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> esclusi i gruppi a contatto<br />
con il marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la tagliata.<br />
2 Valore stimato<br />
Per valutare la concorrenza esercitata dai gruppi sulla componente cedua va poi considerato<br />
che l’azione <strong>di</strong> copertura non viene effettuata <strong>di</strong>rettamente sulle ceppaie tagliate, se non su quelle<br />
che si trovano sotto la proiezione <strong>del</strong>le chiome al marg<strong>in</strong>e dei gruppi. Utilizzando i dati riportati nel<br />
mo<strong>del</strong>lo precedentemente illustrato, la porzione <strong>di</strong> terreno tagliata che risulterebbe ombreggiata<br />
<strong>di</strong>rettamente dai gruppi sarebbe pari al 9,95%.<br />
All’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>le esperienze effettuate, la scelta dei gruppi <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e si è basata sui seguenti<br />
criteri:
Nuove tecniche d’<strong>in</strong>tervento nei boschi cedui: l’esperienza <strong>del</strong> progetto SUMMACOP<br />
• evitare <strong>di</strong> avere una <strong>di</strong>stanza tra i gruppi superiore ai 20 m (nel rispetto <strong>del</strong>le prescrizioni <strong>di</strong><br />
massima vigenti);<br />
• cercare <strong>di</strong> valorizzare la presenza <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> specie pregiate e <strong>di</strong> buona forma<br />
<strong>in</strong>serendoli all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> gruppo oppure <strong>di</strong> salvaguardare, ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong> mantenimento <strong>del</strong>la<br />
bio<strong>di</strong>versità, la presenza <strong>di</strong> specie arboree spora<strong>di</strong>che;<br />
• utilizzare alberi stabili per <strong>del</strong>imitare i marg<strong>in</strong>i dei gruppi (<strong>in</strong> alcuni casi, all’esterno degli<br />
alberi stabili <strong>del</strong> gruppo sono stati rilasciati alcuni polloni dom<strong>in</strong>ati per limitarne l’espansione <strong>del</strong>la<br />
chioma e ridurre l’effetto <strong>di</strong> isolamento improvviso causato dal taglio);<br />
• rilasciare una maggiore copertura <strong>in</strong> zone soggette a fenomeni erosivi (es. zone <strong>di</strong> cresta e<br />
compluvi);<br />
• evitare <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervenire <strong>in</strong> zone non percorribili o <strong>di</strong>fficilmente accessibili (affioramenti rocciosi,<br />
rupi…);<br />
Inoltre, nei limiti imposti dai criteri sopra elencati, si è cercato <strong>di</strong> calibrare la densità dei gruppi <strong>in</strong><br />
funzione <strong>del</strong>la pendenza, <strong>del</strong>l’esposizione e <strong>del</strong>l’altezza dom<strong>in</strong>ante <strong>del</strong> popolamento.<br />
Nelle zone a maggiore acclività si è cercato <strong>di</strong> aumentare la densità dei gruppi ma soprattutto <strong>di</strong><br />
ridurre la <strong>di</strong>stanza lungo le l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> massima pendenza, mentre si è cercato <strong>di</strong> mantenere una<br />
<strong>di</strong>stanza maggiore tra i gruppi nel caso <strong>di</strong> terreni esposti a Nord e a Ovest. L’altezza dom<strong>in</strong>ante <strong>del</strong><br />
popolamento ha <strong>in</strong>fluito <strong>in</strong> alcuni casi nella scelta nelle <strong>di</strong>mensioni dei gruppi mentre non è stata<br />
considerata nella scelta <strong>del</strong>le <strong>di</strong>stanze tra i gruppi.<br />
CONCLUSIONI<br />
La modalità con cui viene gestita la matric<strong>in</strong>atura rappresenta sicuramente l’aspetto più<br />
caratterizzante <strong>del</strong>la selvicoltura nell’ambito <strong>del</strong> governo a ceduo. Molto spesso identificata<br />
erroneamente con il numero <strong>di</strong> piante da rilasciare, la gestione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura implica <strong>in</strong>vece<br />
scelte colturali ben più articolate che ne determ<strong>in</strong>ano la composizione specifica, la densità, la<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>in</strong> classi cronologiche e <strong>di</strong>mensionali, la <strong>di</strong>stribuzione spaziale.<br />
Quest’ultimo aspetto, seppure già affrontato dalla letteratura forestale europea, è stato molto<br />
probabilmente quello meno approfon<strong>di</strong>to e stu<strong>di</strong>ato.<br />
L’esperienza condotta all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> progetto SUMMACOP, seppure parziale e bisognosa <strong>di</strong><br />
ulteriori approfon<strong>di</strong>menti, vuole essere uno stimolo a verificare <strong>in</strong> maniera più ampia le potenzialità<br />
colturali e produttive legate alla matric<strong>in</strong>atura per gruppi, consapevoli che non può e non deve<br />
essere applicata <strong>in</strong> maniera sistematica <strong>in</strong> sostituzione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura uniformemente<br />
<strong>di</strong>stribuita, ma può essere proposta come possibile alternativa soprattutto <strong>in</strong> quelle situazioni<br />
caratterizzate da un‘elevata eterogeneità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni micro-stazionali.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
BERNETTI G., 1987 – I boschi <strong>del</strong>la Toscana. Edagricole, Bologna.<br />
CIANCIO O., MERCURIO R., NOCENTINI S., ECCHER A., 1983 – Tecniche <strong>di</strong> miglioramento e<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conversione e trasformazione. L’Italia agricola, 120 (4):77-86.<br />
DI BERENGER A., 1887 – Selvicoltura. E<strong>di</strong>tore Riccardo Marghieri <strong>di</strong> Gius, Napoli.<br />
DUHAMEL DE MONCEAU H., 1772 - Del governo dei boschi ovvero mezzi <strong>di</strong> ritrar vantaggio dalle<br />
macchie e da ogni genere <strong>di</strong> piante da taglio e <strong>di</strong> dar loro una giusta stima, Venezia (trad. dal<br />
francese).<br />
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI PERUGIA, 1952 – Prescrizioni <strong>di</strong><br />
massima e <strong>di</strong> polizia forestale per i boschi e terreni <strong>di</strong> montagna sottoposti a v<strong>in</strong>colo nella<br />
prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Perugia. Tipografia tuderte, To<strong>di</strong>.<br />
FAVERO L., 1852 – Riserva degli allievi nei boschi. Il coltivatore. Volume primo.<br />
FERRETTI M., GROHMANN F. SAVINI P., 2000 – TRASFORM – Un progetto per la valutazione<br />
<strong>del</strong>la risposta <strong>di</strong> querceti decidui a forme <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> trattamento colturale <strong>in</strong> Umbria. In: SISEF,<br />
<strong>Atti</strong> 2: 3-8.<br />
FRATTEGIANI M., GROHMANN F., SAVINI P., 2000 – Innovazione e gestione dei boschi cedui: il<br />
progetto Summacop. Sherwood, 71:5-9.<br />
PERONA V., 1891 - Economia forestale – Trattamento dei boschi. Biblioteca Vallar<strong>di</strong>.- Piccola<br />
Enciclope<strong>di</strong>a illustrata.<br />
79
80<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i<br />
PERRIN H., 1954 – Selvicoltura. Tomo II. Trad. <strong>di</strong> G. Bernetti, Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze<br />
Forestali, Firenze.<br />
PIUSSI P., 1994 – Selvicoltura generale. UTET, Tor<strong>in</strong>o.<br />
REGIONE DELL’UMBRIA, 1981 – Regolamento regionale 8 Giugno 1981, n.1 – Prescrizioni <strong>di</strong><br />
massima e <strong>di</strong> polizia forestale per i boschi e i terreni <strong>di</strong> montagna sottoposti a v<strong>in</strong>coli.<br />
Supplemento or<strong>di</strong>nario al Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale n.31 <strong>del</strong> 10-6-1981.<br />
REGIONE DELL’UMBRIA, 1999 – Inventario Forestale Regionale. Supplemento or<strong>di</strong>nario n.1 al<br />
Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale n.22 <strong>del</strong> 21 Aprile.
Nuove tecniche d’<strong>in</strong>tervento nei boschi cedui: l’esperienza <strong>del</strong> progetto SUMMACOP<br />
81
82<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i
Nuove tecniche d’<strong>in</strong>tervento nei boschi cedui: l’esperienza <strong>del</strong> progetto SUMMACOP<br />
83
84<br />
Paola Sav<strong>in</strong>i
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
IL CEDUO COME OPERA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA<br />
LA STABILITÀ DEI CEDUI INVECCHIATI<br />
MARCO CONEDERA 1 , MARIO PIVIDORI 2 , GIANNI BORIS PEZZATTI 1 , ERIC GEHRING 1<br />
1 WSL GRUPPO DI RICERCA ECOSISTEMI INSUBRICI, CH-6500 BELLLINZONA, SVIZZERA<br />
2 DIP. TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI – UNIVERSITÀ DI PADOVA
86<br />
INTRODUZIONE<br />
Marco Conedera et al.<br />
La funzione protettiva <strong>del</strong>la copertura forestale contro i pericoli naturali e i vantaggi <strong>di</strong> un elevato<br />
grado <strong>di</strong> copertura forestale per la prevenzione dei processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto idrogeologico sono<br />
ampiamente riconosciuti nella tra<strong>di</strong>zione forestale (Wu e Swanston 1980; Ziemer 1981; Gray e<br />
Megahan 1981, Selby 1981). Di tale assunto tengono conto <strong>in</strong> chiave tecnica i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> previsione<br />
<strong>del</strong> rischio frana ed <strong>in</strong> chiave normativa la stessa legislazione forestale. I mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> stabilità <strong>del</strong><br />
suolo considerano <strong>in</strong>fatti la presenza <strong>di</strong> una copertura forestale un elemento migliorativo ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong><br />
contrasto ai movimenti destabilizzanti <strong>del</strong> terreno (Corom<strong>in</strong>as 1992; Van Westen 1993; Carrara et<br />
al. 1995). In modo <strong>del</strong> tutto analogo e consequenziale, s<strong>in</strong> dai suoi albori la legislazione forestale<br />
nella maggior parte <strong>del</strong>le realtà europee ha ritenuto la presenza <strong>di</strong> una sufficiente copertura<br />
boschiva nelle zone montane una premessa essenziale per la stabilità dei versanti. Non a caso per<br />
la realtà italiana il R.D. 21 Marzo 1912 n°442 fa r iferimento alle opere estensive, a quel tempo<br />
essenzialmente <strong>in</strong>tese come rimboschimenti, per la stabilizzazione dei versanti e non a caso lo<br />
stesso RD 3267/23, che ha per oggetto il contenimento <strong>del</strong> <strong>di</strong>ssesto idrogeologico, si concentra<br />
particolarmente sull’<strong>in</strong>troduzione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> buona gestione selvicolturale.<br />
La presenza <strong>di</strong> una copertura boschiva, tuttavia, non può essere considerata a priori e <strong>in</strong> tutti i<br />
casi una garanzia <strong>di</strong> stabilità <strong>del</strong> suolo. I popolamenti forestali hanno <strong>in</strong>fatti una loro <strong>di</strong>namica<br />
<strong>in</strong>terna che comporta anche fasi <strong>di</strong> <strong>in</strong>stabilità e <strong>di</strong> crolli su superfici più o meno gran<strong>di</strong>, soprattutto<br />
nella fase <strong>di</strong> <strong>in</strong>vecchiamento e senescenza <strong>del</strong>la componente arborea, durante la quali la funzione<br />
stabilizzante non è garantita (Pividori et al. 2008; Conedera et al. 2009).<br />
Nel caso <strong>di</strong> boschi artificiali e gestiti dall’uomo come i cedui, queste fasi <strong>di</strong> senescenza e <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>stabilità possono manifestarsi <strong>in</strong> modo repent<strong>in</strong>o e <strong>in</strong>controllato dando orig<strong>in</strong>e localmente a<br />
problemi <strong>di</strong> <strong>in</strong>stabilità dei versanti.<br />
In questo contributo vengono <strong>di</strong>scussi i problemi legati all’<strong>in</strong>vecchiamento dei cedui dal punto <strong>di</strong><br />
vista <strong>del</strong>la loro funzione <strong>di</strong> protezione idrogeologica dei versanti.<br />
LE PARTICOLARITÀ DELLA GESTIONE A CEDUO<br />
Il ceduo è una forma <strong>di</strong> governo <strong>del</strong> bosco basata sul pr<strong>in</strong>cipio <strong>del</strong>la riproduzione agamica, vale<br />
a <strong>di</strong>re <strong>del</strong>la produzione <strong>di</strong> polloni a partire dall’attivazione <strong>di</strong> gemme dormienti <strong>del</strong> ceppo o <strong>del</strong>le<br />
ra<strong>di</strong>ci che rimangono dopo l’elim<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la parte aerea esistente. La gestione a ceduo sfrutta<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la capacità <strong>di</strong> alcune specie <strong>di</strong> emettere polloni <strong>in</strong> seguito a un <strong>di</strong>sturbo <strong>del</strong>la parte aerea per<br />
velocemente riequilibrare il rapporto tra biomassa epigea e ipogea. Questa capacità pollonifera<br />
varia molto da specie a specie, essendo per esempio molto scarsa se non assente nella maggior<br />
parte <strong>del</strong>le conifere <strong>in</strong><strong>di</strong>gene e molto ricca <strong>in</strong> alcune specie <strong>di</strong> latifoglie (per esempio Castanea,<br />
Quercus, Fagus, Ostrya, Alnus). La capacità pollonifera può variare <strong>in</strong>oltre <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>l’età e<br />
<strong>del</strong>lo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> sviluppo <strong>del</strong>l’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo, come si verifica per alcune specie quali il faggio e la quercia<br />
che subiscono una drastica riduzione <strong>di</strong> questa facoltà <strong>in</strong> età adulta (Bernetti 1995). Un’altra<br />
caratteristica saliente <strong>di</strong> alcune specie come il castagno, il faggio e l’acero, è la loro capacità <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novare l’apparato ra<strong>di</strong>cale a ogni taglio <strong>di</strong> ceduazione (Lees 1981; Bedeneau e Pages 1984;<br />
Aymard e Fredon 1986).<br />
L’elevato vigore <strong>del</strong> riscoppio pollonifero dopo il taglio <strong>di</strong> ceduazione è dovuto alla grandezza<br />
<strong>del</strong>l’apparato ra<strong>di</strong>cale e alla corrispondente <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> riserve <strong>di</strong> carboidrati. La velocità <strong>di</strong><br />
crescita dei polloni tende <strong>in</strong> seguito a <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire rapidamente con il progressivo sviluppo <strong>del</strong>la parte<br />
aerea e il riequilibrio tra componenti aeree e sotterranee <strong>del</strong>la ceppaia.<br />
Queste caratteristiche fisiologiche unite alla matrice orig<strong>in</strong>ariamente rurale <strong>di</strong> utilizzo <strong>del</strong> ceduo<br />
hanno fatto si che i turni <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> questa forma <strong>di</strong> governo siano sempre stati<br />
tendenzialmente corti, variando <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la specie e <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> assortimento da produrre tra i<br />
5 e i 25 anni. Da questi criteri <strong>di</strong>scendono anche le forme <strong>di</strong> trattamento che possono essere<br />
semplici (taglio raso) o a sterzo, vale a <strong>di</strong>re <strong>in</strong>tervenendo solo una parte <strong>del</strong>la ceppaia e rilasciando<br />
dei polloni per più turni (Piussi 1994). La ceduazione semplice è applicata soprattutto nel caso<br />
<strong>del</strong>le specie eliofile come il castagno, procedendo eventualmente, e a seconda <strong>del</strong>le tra<strong>di</strong>zioni o<br />
costrizioni legali locali, al rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e (ceduo matric<strong>in</strong>ato). Il ceduo a sterzo è <strong>in</strong>vece<br />
soprattutto <strong>in</strong><strong>di</strong>cato per le specie sciafile come il faggio.<br />
Per la sua natura forestale, la gestione a ceduo è stata per lo più conf<strong>in</strong>ata nelle zone <strong>di</strong><br />
versante, dove la morfologia <strong>del</strong> terreno non è adatta a pratiche agricole più <strong>in</strong>tensive. In queste<br />
situazioni la copertura forestale ha da sempre avuto, oltre che una funzione produttiva,
Il ceduo come opera <strong>di</strong> sistemazione idraulica – la stabilità dei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
un’importante funzione idrogeologica <strong>di</strong> stabilizzazione e <strong>di</strong> protezione dei versanti. La corretta e<br />
regolare gestione a ceduo dei boschi <strong>di</strong> versante garantisce una adeguata protezione <strong>del</strong> suolo<br />
grazie alla presenza <strong>di</strong> apparati ra<strong>di</strong>cali ben sviluppati e <strong>di</strong> una biomassa aerea proporzionalmente<br />
contenuta. Per contro, i cedui castanili abbandonati e fuori turno tendono a <strong>di</strong>fettare nella<br />
r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong>l’apparato ra<strong>di</strong>cale (Bedeneau e Pages 1984) e a sviluppare con il passare <strong>del</strong><br />
tempo una biomassa aerea sproporzionatamente abbondante.<br />
INSTABILITÀ DEI CEDUI ABBANDONATI<br />
Da stu<strong>di</strong> effettuati su cedui castanili nel Nord <strong>del</strong>l’Italia e al Sud <strong>del</strong>la Svizzera emerge<br />
chiaramente come una <strong>del</strong>le prime conseguenze <strong>del</strong>la <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> crescita <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong> <strong>in</strong>terventi<br />
è una progressiva e <strong>in</strong>esorabilmente situazione <strong>di</strong> <strong>in</strong>stabilità seguita da crolli <strong>di</strong> s<strong>in</strong>gole ceppaie o<br />
gruppi <strong>di</strong> ceppaia (Vogt et al. 2006; Pividori et al. 2008; Conedera et al. 2009). In cedui castanili <strong>di</strong><br />
60 anni posti su pen<strong>di</strong>i <strong>di</strong> acclività me<strong>di</strong>a attorno ai 30° la densità dei crolli si aggira tra 1.3 e 1. 5<br />
eventi all’ettaro.<br />
Come illustrato da Pividori et al. (2008), il crollo <strong>del</strong>le ceppaie non è un evento unico, ma è un<br />
fenomeno progressivo e <strong>di</strong>luito nel tempo che può dare orig<strong>in</strong>e a importanti buche all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong><br />
soprassuolo (Fig. 1).<br />
Figura 1. Buca orig<strong>in</strong>ata dal crollo multiplo <strong>di</strong> ceppaie <strong>di</strong> castagno (foto P. Bomio).<br />
E’ <strong>in</strong>fatti stato <strong>di</strong>mostrato come nei cedui castanili le buche orig<strong>in</strong>ate dal crollo <strong>di</strong> una prima<br />
ceppaia tendono a estendersi per il progressivo co<strong>in</strong>volgimento <strong>del</strong>le ceppaie che vengono a<br />
trovarsi al bordo dei crolli, probabilmente <strong>in</strong> seguito all’improvvisa mancanza <strong>di</strong> protezione e<br />
sostegno (Fig. 2).<br />
Locarno<br />
10m<br />
Bell<strong>in</strong>zona<br />
10m<br />
Gravesano<br />
Figura 2. Esempi <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica <strong>in</strong> crolli <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> ceppaie <strong>in</strong> tre cedui castanili abbandonati <strong>del</strong> Sud <strong>del</strong>la<br />
Svizzera. I cerchi ver<strong>di</strong> rappresentano ceppaie sane ancora <strong>in</strong> pie<strong>di</strong>; i triangoli arancioni rappresentano<br />
ceppaie ancora <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> ma danneggiate dai crolli. Le ombreggiature corrispondono all’anno <strong>di</strong> crollo <strong>del</strong>le<br />
rispettive ceppaie, la l<strong>in</strong>ea rossa rappresenta il bordo <strong>del</strong>la buca che si è venuta a creare (Fonte: Vogt et al.<br />
2006, leggermente mo<strong>di</strong>ficato).<br />
10m<br />
anno<br />
1996<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
87
88<br />
Marco Conedera et al.<br />
Questi tipi <strong>di</strong> crollo si verificano soprattutto nel castagno, nel faggio, nella quercia e nella<br />
rob<strong>in</strong>ia, ma posso co<strong>in</strong>volgere anche altre specie quali l’ontano, il ciliegio, l’abete rosso, il frass<strong>in</strong>o,<br />
ecc.<br />
Figura 3. Box-plots <strong>di</strong> alcune caratteristiche scelte <strong>del</strong>la popolazione <strong>di</strong> ceppaie schiantate (<strong>in</strong> celeste)<br />
rispetto a quelle <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> (<strong>in</strong> arancione) (Fonte: Conedera et al. 2009).<br />
Stu<strong>di</strong> comparativi sulle caratteristiche <strong>di</strong> popolamenti <strong>di</strong> castagno con <strong>di</strong>fferente suscettibilità al<br />
fenomeno hanno <strong>in</strong><strong>di</strong>cato come gli schianti siano tendenzialmente concentrati <strong>in</strong> avvallamenti e<br />
nelle zone a maggior pendenza, dove a parità <strong>di</strong> età i popolamenti mostrano una maggiore<br />
biomassa aerea (altezze e <strong>di</strong>ametri maggiori). Le due popolazioni analizzate non presentano<br />
<strong>in</strong>vece <strong>di</strong>fferenze statisticamente significative per quanto riguarda la profon<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> terreno (Fig. 3),<br />
il numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> polloni per ceppaia e l’<strong>in</strong>cremento ra<strong>di</strong>ale me<strong>di</strong>o tra il 1990 e il 1995 (Vogt et al.<br />
2006; Conedera et al. 2009).<br />
Una <strong>di</strong>mostrazione <strong>in</strong><strong>di</strong>retta <strong>del</strong>l’esistenza <strong>di</strong> un accentuato squilibrio soprattutto nelle ceppaie<br />
che crescono <strong>in</strong> situazioni <strong>di</strong> piede <strong>di</strong> scarpata o <strong>di</strong> impluvio è stata fornita da Gehr<strong>in</strong>g (2010)<br />
attraverso lo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong> rapporto tra la superficie fogliare (LA = leaf area) e la corrispondente<br />
sezione trasversale dei tessuti conduttori attivi nel fusto (SA = sapwood area). L’autore, stu<strong>di</strong>ando<br />
il rapporto tra LA/SA (Fig. 4), ha potuto <strong>di</strong>mostrare come nelle stazioni più favorevoli come i pie<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
scarpata o le conche, gli alberi tendono ad allocare più risorse nell’apparato fogliare e a ridurre la<br />
proporzione <strong>di</strong> tessuto legnoso. Come riportato da Mazzoleni (1990) <strong>in</strong> questi casi il rapporto tra<br />
biomassa aerea e parte ra<strong>di</strong>cale tende a essere proporzionalmente più elevato.<br />
Queste osservazioni sono state confermate anche da Pividori et al. (2008), i quali hanno<br />
<strong>di</strong>mostrato che le <strong>di</strong>mensioni dei piatti ra<strong>di</strong>cali esposti dopo la caduta <strong>del</strong>le ceppaie stramature<br />
evidenziano sistemi <strong>di</strong> ancoraggio sotto<strong>di</strong>mensionati rispetto al volume aereo <strong>del</strong>la ceppaia.<br />
L’analisi <strong>del</strong>le curve <strong>di</strong> <strong>in</strong>cremento ra<strong>di</strong>ale annuo <strong>di</strong> polloni <strong>di</strong> ceppaie cadute rispetto a quelle <strong>in</strong><br />
pie<strong>di</strong> hanno <strong>in</strong>oltre evidenziato come, f<strong>in</strong>o all’età <strong>di</strong> 30 anni, le piante schiantate mostrano una<br />
crescita tendenzialmente maggiore rispetto alle piante <strong>in</strong> pie<strong>di</strong>. In seguito questa <strong>di</strong>fferenza si<br />
attenua e, dopo il c<strong>in</strong>quantesimo anno <strong>di</strong> età, si <strong>in</strong>verte ad<strong>di</strong>rittura (Fig. 5).<br />
La maggiore riduzione <strong>di</strong> crescita nelle piante cadute rispetto a quelle rimaste <strong>in</strong> piede lascia<br />
supporre una generale situazione <strong>di</strong> sofferenza e una mancanza <strong>di</strong> vitalità <strong>di</strong> questi <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui più<br />
vitali e rigogliose <strong>in</strong> gioventù. Uno stato <strong>di</strong> crisi che a livello meccanico si traduce <strong>in</strong> uno squilibrio<br />
tra sistema ra<strong>di</strong>cale, non <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novarsi e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> tendenzialmente piccolo e la forte<br />
biomassa epigea.
Il ceduo come opera <strong>di</strong> sistemazione idraulica – la stabilità dei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
dosso versante conca<br />
Figura 4. Boxplots dei valori <strong>di</strong> LA/SA (= leaf area / sapwood area) dei s<strong>in</strong>goli polloni <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la loro<br />
posizione microtopografica. Lettere <strong>di</strong>fferenti rappresentano <strong>di</strong>fferenze significative tra le categorie <strong>di</strong><br />
microtopografia (p < 0.05, test non parametrico a coppie secondo Wilcoxon, con correzione <strong>di</strong> Holm per i<br />
valori <strong>di</strong> p); n = numero <strong>di</strong> polloni per ogni categoria (fonte: Gehr<strong>in</strong>g 2010).<br />
Particolarmente soggetti al crollo sono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> i popolamenti (e specialmente quegli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui)<br />
con una biomassa importante poste <strong>in</strong> stazioni a forte pendenza o negli avvallamenti, dove il<br />
terreno è al contempo più <strong>in</strong>stabile e più fertile. Il processo <strong>di</strong> crollo sembrerebbe qu<strong>in</strong><strong>di</strong><br />
riconducibile a uno squilibrio statico degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui. Questo squilibrio espone l’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo <strong>in</strong> questione<br />
agli eventi meteorologici puntuali (colpo <strong>di</strong> vento, neve bagnata), anche <strong>di</strong> lieve <strong>in</strong>tensità.<br />
Larghezza anello [mm/100]<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1950<br />
1953<br />
1956<br />
1959<br />
1962<br />
1965<br />
1968<br />
ceppaie ribaltate ceppaie <strong>in</strong> pie<strong>di</strong><br />
1971<br />
1974<br />
1977<br />
1980<br />
Anno solare<br />
Figura 5. Curve <strong>di</strong> crescita ra<strong>di</strong>ale annua per il periodo 1950-2004 <strong>di</strong> 45 polloni <strong>di</strong> ceppaie cadute e <strong>di</strong> 45<br />
polloni <strong>di</strong> ceppaie <strong>in</strong> pie<strong>di</strong>. Le l<strong>in</strong>ee verticali <strong>in</strong><strong>di</strong>cano l’errore standard (Fonte: Conedera et al. 2009).<br />
1983<br />
1986<br />
1989<br />
1992<br />
1995<br />
1998<br />
2001<br />
2004<br />
89
90<br />
Marco Conedera et al.<br />
Secondo Vogt et al. (2006) sarebbe ad<strong>di</strong>rittura possibile stimare <strong>in</strong> modo affidabile la probabilità<br />
<strong>di</strong> schianto considerando semplicemente alcuni parametri base quali l’acclività <strong>del</strong> pen<strong>di</strong>o, la sua<br />
conformazione (profilo orizzontale e verticale) e l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> popolamento.<br />
In conclusione, il crollo <strong>del</strong>le ceppaie nei cedui <strong>in</strong>vecchiati non sembra essere un fenomeno<br />
estemporaneo o locale, ma piuttosto un processo <strong>in</strong> atto, non limitato a una zona specifica e non<br />
concentrato <strong>in</strong> annate particolari. In generale il rischio <strong>di</strong> crolli <strong>di</strong> ceppaie nei cedui abbandonati è<br />
dest<strong>in</strong>ato ad aumentare con il passare <strong>del</strong> tempo, data la naturale tendenza ad aumentare <strong>del</strong>la<br />
massa legnosa aerea presente <strong>in</strong> bosco e il persistere <strong>del</strong> <strong>di</strong>s<strong>in</strong>teresse alla cura e manutenzione<br />
dei popolamenti.<br />
Come visto <strong>in</strong> Pividori et al. (2008), non <strong>di</strong> raro il crollo <strong>di</strong> una prima ceppaia ne co<strong>in</strong>volge altre<br />
per effetto dom<strong>in</strong>o, causando un’ulteriore destabilizzazione <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong> soprassuolo: <strong>in</strong><br />
questo ultimo caso sono <strong>in</strong>teressate <strong>in</strong> particolare le piante poste a monte, che dopo aver<br />
approfittato <strong>del</strong> vuoto per aumentare i ritmi <strong>di</strong> crescita e essersi sbilanciate verso la buca possono<br />
trovarsi a loro volta <strong>in</strong> una situazione <strong>di</strong> squilibrio meccanico. Il fenomeno dei ribaltamenti può<br />
pertanto essere ritenuto un possibile <strong>in</strong><strong>di</strong>catore s<strong>in</strong>tetico <strong>del</strong> raggiungimento <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni favorevoli<br />
all’<strong>in</strong>nesco <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto. Una conferma a tale ipotesi è pervenuta da un lavoro realizzato da<br />
Pozzi (2005), nel quale l’Autore ha <strong>di</strong>mostrato come per le con<strong>di</strong>zioni <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>in</strong> Valcuvia<br />
(VA) l’affidabilità <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>zione dei fenomeni franosi attraverso il mo<strong>del</strong>lo denom<strong>in</strong>ato Shalstab<br />
(Montgomery e Dietrich 1994) è piuttosto bassa applicando valori <strong>di</strong> default <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong><br />
bosco ma tende a migliorare sensibilmente ove tali valori vengano abbassati <strong>in</strong> relazione alla<br />
presenza <strong>di</strong> boschi <strong>in</strong> avanzato stato <strong>di</strong> <strong>in</strong>vecchiamento.<br />
ASPETTI PRATICI<br />
Il fenomeno <strong>del</strong> crollo <strong>del</strong>le ceppaie nei cedui abbandonati può portare nel tempo a<br />
conseguenze particolarmente gravi, visto l’ampiezza e la generale funzione <strong>di</strong> protezione <strong>del</strong>le<br />
superfici <strong>in</strong>teressate. In zone particolarmente acclivi tali fenomeno possono ad<strong>di</strong>rittura portare a<br />
ulteriori fenomeni pregiu<strong>di</strong>zievoli alla funzionalità <strong>del</strong> bosco, quali l’ostruzione dei corsi d’acqua da<br />
parte <strong>del</strong>le piante a terra, il trasporto a valle <strong>di</strong> tronchi, l’occlusione <strong>del</strong>le aste torrentizie e la<br />
creazioni <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> dam-break, la destabilizzazione dei pen<strong>di</strong>i con un aumento <strong>del</strong>l’erosione<br />
superficiale e <strong>del</strong> trasporto solido nelle aste sottese (Abbe e Mongomery, 2003, Stefan<strong>in</strong>i, 2010),<br />
l’aumento <strong>del</strong> carico <strong>di</strong> combustibile a terra e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> fiamma nel caso <strong>di</strong> passaggio <strong>di</strong><br />
un <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o boschivo.<br />
Allo stato attuale <strong>del</strong>le conoscenze e nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dei risultati qui presentati,<br />
possono essere tratte alcune prime <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni operative <strong>di</strong> tipo gestionale ai f<strong>in</strong>i pianificatori<br />
forestali e non.<br />
Una ceduazione tempestiva (condotta per esempio entro i 30 anni) è la premessa migliore per<br />
evitare sovraccarichi meccanici dei versanti a rischio e per garantire una rigenerazione <strong>del</strong> corredo<br />
forestale (Aymard e Fredon 1986). Anche <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong> piante già ribaltate, la ceduazione, purché<br />
avvenga quando la ceppaia sia ancora parzialmente ancorata al terreno, potrebbe portare alla<br />
generazione <strong>di</strong> un nuovo <strong>in</strong><strong>di</strong>viduo e <strong>di</strong> conseguenza alla formazione <strong>di</strong> un nuovo apparato<br />
ra<strong>di</strong>cale.<br />
In sede pianificatoria esecutiva, i piani <strong>di</strong> assestamento forestale dovranno prevedere una<br />
scansione temporale degli <strong>in</strong>terventi tenendo conto <strong>del</strong>l’età dei popolamenti che, a parità <strong>di</strong> altri<br />
fattori, <strong>di</strong>verrà il parametro decisionale pr<strong>in</strong>cipale.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Abbe T.B., Montgomery D.R., 2003 – Patterns and processes of wood debris accumulation <strong>in</strong> the<br />
Queets river bas<strong>in</strong>, Wash<strong>in</strong>gton. Geomorphology, 51, 81-107.<br />
Aymard M., Fredon.J., 1986 - Study of the relationship between roots and coppice shoots <strong>in</strong><br />
Castanea sativa. Ann. Sci. For., 43, 3, 351-363.<br />
Bedeneau M., Pages L., 1984 - Study of the growth r<strong>in</strong>gs of roots of coppiced trees. Ann. Sci. For.<br />
41, 1, 59-68.<br />
Bernetti G., 1995 – Selvicoltura speciale, UTET, Tor<strong>in</strong>o, pp. 415.
Il ceduo come opera <strong>di</strong> sistemazione idraulica – la stabilità dei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
Carrara, A., Car<strong>di</strong>nali, M., Guzzetti, F. Reichenbach, P., 1995 -. GIS technology <strong>in</strong> mapp<strong>in</strong>g<br />
landslide hazard. Carrara A, Guzzetti F (eds) Geographical <strong>in</strong>formation system <strong>in</strong> assens<strong>in</strong>g<br />
natural hazard, Kluwer, Dordrecht, The Nederlands, 135-175 pp<br />
Conedera M., Fonti P., Nicoloso A, Meloni F., Pividori M., 2009 - Ribaltamento <strong>del</strong>le cappaie <strong>di</strong><br />
castagno. In<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>le zone a rischio e proposte selvicolturali. Sherwood 15, 5: 15-18.<br />
Corom<strong>in</strong>as J., 1992 - Landslide risk assessment and zon<strong>in</strong>g Plann<strong>in</strong>g the use of the earth's<br />
surface. International advanced workshop, Santander, Spa<strong>in</strong> 1-5 November 1989., pp. 141-173.<br />
Gehr<strong>in</strong>g E., 2010 - Suitability of the leaf to sapwood area relationship as an <strong>in</strong><strong>di</strong>cator of the<br />
response of the chestnut tree (Castanea sativa Mill.) to environmental constra<strong>in</strong>ts. Travail de<br />
Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation, Université de<br />
Lausanne, pp. 84.<br />
Gray D.H., Megahan W.F., 1981 - Forest vegetation removal and slope stability <strong>in</strong> the Idaho<br />
batholith. Research Paper, Intermounta<strong>in</strong> Forest and Range Experiment Station, USDA Forest<br />
Service, INT-271, pp. 23.<br />
Lees J.C., 1981 - Three generations of red maple stump sprouts. Fredericton, NB. Maritimes<br />
Forest Research Centre, M-X-199, 1-9.<br />
Mazzoleni S., 1990 - Relazioni tra aree fogliari e superfici <strong>di</strong> conduzione nel fusto nell'analisi <strong>di</strong><br />
gra<strong>di</strong>enti ambientali. L<strong>in</strong>ea ecologica, pp. 27-30.<br />
Montgomery D.R., Dietrich W.E., 1994 - A physically based mo<strong>del</strong> for the topographic control on<br />
shallow landsli<strong>di</strong>ng. Water Resources Research,. 30, 4, pp. 1153-1171.<br />
Pividori M., Meloni F., Nicoloso A., Pozzi E., Arienti R., Conedera M., 2008 - Ribaltamento <strong>del</strong>le<br />
ceppaie <strong>di</strong> castagno. Due casi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>in</strong> cedui <strong>in</strong>vecchiati. Sherwood 14, 149: 17-21.<br />
Piussi P., 1994 – Selvicoltura generale, UTET, Tor<strong>in</strong>o, pp. 421.<br />
Pozzi E., 2005 - Mo<strong>del</strong>lazione dei franamenti superficiali: il caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Val Maggiore e<br />
Torrente San Giulio (Varese). Tesi <strong>di</strong> Laurea. Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Padova. Facoltà <strong>di</strong><br />
Agraria. <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> Laurea <strong>in</strong> Scienze Forestali e Ambientali.<br />
Selby M.J., 1981 - Slopes and weather<strong>in</strong>g. Gregory, K. J.; Wall<strong>in</strong>g, D. E. : Man and environmental<br />
processes., pp. 105-122.<br />
Stefan<strong>in</strong>i E., 2010 – Con<strong>di</strong>zioni fluvio-morfologiche e selvicolturali nella formazione <strong>di</strong> depositi<br />
legnosi <strong>in</strong> alveo: il caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong> torrente Riale (VA). Tesi <strong>di</strong> Laurea magistrale. Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Padova. Facoltà <strong>di</strong> Agraria. <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> Laurea <strong>in</strong> Scienze Forestali e Ambientali.<br />
pp.128.<br />
Van Westen C.J., 1993 -. Application of Geographic Information System to landslide hazard<br />
zonation. ITC-Pubblications n° 15 ITC, Enschede, pp .245.<br />
Vogt J., Fonti P., Conedera M., Schröder B., 2006 - Temporal and spatial dynamic of stool<br />
uproot<strong>in</strong>g <strong>in</strong> abandoned chestnut coppice forests. For. Ecol. Man, 235, 1-3, 88-95.<br />
Wu T.H., Swanson D.N., 1980 - Risk of landslides <strong>in</strong> shallow soils and its relation to clearcutt<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
southeastern Alaska. For. Sci. 26, 3, 495-510.<br />
Ziemer R.R., 1981 - Some effects of silvicultural options on the stability of slopes, Stream<br />
Improvement Technical Bullet<strong>in</strong>, 344, 6-17.<br />
91
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Il ceduo come opera <strong>di</strong> sistemazione idraulica – la stabilità dei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
93
94<br />
Marco Conedera et al.
Il ceduo come opera <strong>di</strong> sistemazione idraulica – la stabilità dei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
95
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
SELVICOLTURA DELLE CERRETE<br />
(PROVE DI MATRICINATURA E CONVERSIONE)<br />
PAOLO CANTIANI<br />
CRA-SEL, CENTRO DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA, AREZZO
98<br />
INTRODUZIONE<br />
Paolo Cantiani<br />
Negli ultimi anni il CRA SEL ha impostato una serie prove sperimentali sul trattamento<br />
selvicolturale <strong>di</strong> cedui <strong>di</strong> cerro puri e misti. In Appenn<strong>in</strong>o il ceduo rappresenta ancora la forma <strong>di</strong><br />
governo prevalente <strong>del</strong> bosco. La ricerca selvicolturale ha stu<strong>di</strong>ato f<strong>in</strong>o ad oggi solo marg<strong>in</strong>almente<br />
i meccanismi ecologici e funzionali, pur assai complessi, <strong>del</strong> sistema ceduo. D’altronde il limitato<br />
valore economico ha fatto sì che la selvicoltura <strong>del</strong> ceduo sia stata soprattutto effettuata dagli<br />
utilizzatori <strong>del</strong> bosco stesso e sia stata regolata da una serie <strong>di</strong> leggi e regolamenti spesso<br />
tecnicamente <strong>in</strong>adeguati, basati sulla consuetu<strong>di</strong>ne, che hanno prodotto norme e v<strong>in</strong>coli alla<br />
gestione non sempre tecnicamente motivati.<br />
In realtà la selvicoltura <strong>del</strong> ceduo, nella sua apparente semplicità tecnica, deve rispondere ad<br />
una moltitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> funzioni: la produzione <strong>di</strong> legna da ardere <strong>in</strong> primis, ma anche la protezione<br />
idrogeologica, il pascolo, la produzione <strong>di</strong> altri assortimenti legnosi, la <strong>di</strong>versità specifica e<br />
paesaggistica ecc. La politica gestionale <strong>del</strong> ceduo prevede qu<strong>in</strong><strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> alternative<br />
strategicamente e prospettivamente determ<strong>in</strong>anti: i) la ceduazione, ii) la conversione a fustaia; iii)<br />
l’abbandono colturale.<br />
Il contributo riporta i primi risultati <strong>di</strong> una ricerca a carattere multi<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are effettuata nel<br />
territorio <strong>del</strong>le Coll<strong>in</strong>e Metallifere (Grosseto) (Progetto Arsia – Regione Toscana “Selvicoltura<br />
sostenibile nei boschi cedui”). Si s<strong>in</strong>tetizzano i risultati relativi a: 1) una prova sperimentale <strong>di</strong><br />
ceduazione con rilasci <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura <strong>di</strong>fferenziati per modalità ed <strong>in</strong>tensità e 2) i risultati <strong>di</strong> una<br />
prova <strong>di</strong> avviamento all’alto fusto per la valutazione <strong>del</strong>la caratterizzazione genetica dei soggetti<br />
rilasciati.<br />
L’esigenza <strong>di</strong> operare una sperimentazione sull’<strong>in</strong>tensità ottimale <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong><br />
cerro <strong>del</strong>la Toscana meri<strong>di</strong>onale è stata dettata dalla constatazione <strong>del</strong>l’aumento <strong>in</strong><strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>ato <strong>del</strong><br />
numero e <strong>del</strong>le classi cronologiche dei rilasci nei cedui appenn<strong>in</strong>ici negli ultimi decenni. Le<br />
prescrizioni <strong>di</strong> massima e polizia forestale <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong> ceduo matric<strong>in</strong>ato<br />
mantennero f<strong>in</strong>o alle ultime revisioni <strong>del</strong> 1963 lo schema orig<strong>in</strong>ario <strong>del</strong> testo <strong>del</strong> 1878 che<br />
prevedeva un rilascio m<strong>in</strong>imo <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e contenuto (20 – 50 rilasci <strong>di</strong> piante da seme o polloni <strong>di</strong><br />
buona conformazione a seconda <strong>del</strong>la specie) (FIORUCCI 2009). Nei cedui a funzione multipla<br />
(legna da ardere-pascolo oppure legna da ardere-assortimenti per travi ferroviarie o da e<strong>di</strong>lizia,<br />
tronchetti da imballaggio, puntelli da m<strong>in</strong>iera, pali per l’agricoltura) la dotazione <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e è<br />
aumentata localmente f<strong>in</strong>o a strutture assimilabili a quelle <strong>del</strong> ceduo composto. Il rilascio cospicuo<br />
<strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e ha avuto un impulso notevole, proprio quando crollarono le richieste <strong>del</strong> mercato per gli<br />
assortimenti da matric<strong>in</strong>a, con l’applicazione <strong>del</strong>la legge 42/2004 (“Legge Galasso”) e le sue<br />
successive mo<strong>di</strong>fiche che lasciarono <strong>in</strong>alterato il senso <strong>del</strong> testo. La f<strong>in</strong>alità <strong>del</strong>le prescrizione sulla<br />
matric<strong>in</strong>atura avevano l’obiettivo prioritario <strong>di</strong> assolvimento <strong>del</strong>la sola esigenza funzionale<br />
paesaggistica, con raccomandazioni sulle modalità <strong>di</strong> rilascio che, pur senza entrare nello specifico<br />
tecnico <strong>di</strong> numero e qualità dei rilasci, <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzavano verso utilizzazioni con rilasci abbondanti<br />
preferibilmente <strong>di</strong> soggetti <strong>di</strong> più classi. Gran parte <strong>del</strong>la successiva legislazione regionale ha<br />
tradotto queste l<strong>in</strong>ee guida <strong>in</strong> v<strong>in</strong>coli spesso tecnicamente immotivati.<br />
La politica <strong>di</strong> conversione <strong>del</strong> ceduo all’alto fusto nei boschi <strong>di</strong> proprietà pubblica è<br />
conseguenza <strong>del</strong>la marg<strong>in</strong>alizzazione economica <strong>di</strong> molto cedui appenn<strong>in</strong>ici a partire dagli anni 70<br />
<strong>del</strong> secolo scorso. La conversione <strong>del</strong>le faggete cedue ha avuto spesso la valenza <strong>di</strong> esplicare la<br />
funzione <strong>di</strong> protezione idrogeologica <strong>del</strong>le pen<strong>di</strong>ci montane; la scelta gestionale per i boschi <strong>di</strong><br />
cerro è stata spesso contestata, soprattutto perché non giustificata da considerazioni <strong>di</strong> tipo<br />
economico. Interventi correttamente effettuati <strong>in</strong> cerrete cedue hanno determ<strong>in</strong>ato popolamenti<br />
prettamente monospecifici, monoplani e regolari, spesso con un piano dom<strong>in</strong>ato costituto da<br />
polloni <strong>di</strong> specie maggiormente tolleranti <strong>del</strong>l’ombra (BENVENUTI E CANTIANI 2003), strutturalmente<br />
assai simili alle cerrete <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e gamica <strong>del</strong>l’Appenn<strong>in</strong>o centro meri<strong>di</strong>onale. I problemi gestionali<br />
attuali <strong>di</strong> questi popolamenti sono legati alla loro dest<strong>in</strong>azione futura; la sperimentazione si sta<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> attualmente <strong>in</strong>centrando sul trattamento <strong>del</strong>le fustaie per la valutazione <strong>del</strong>la loro<br />
r<strong>in</strong>novazione e sulla composizione e struttura <strong>del</strong>le fustaie <strong>di</strong> nuova generazione.
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
LA SPERIMENTAZIONE SULLE MODALITA’ DI MATRICINATURA 1<br />
La ricerca <strong>in</strong>tende fornire <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni sulla def<strong>in</strong>izione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> cedui a prevalenza<br />
<strong>di</strong> cerro. A tal f<strong>in</strong>e il protocollo sperimentale prevede tesi <strong>di</strong>fferenziate <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong> ceduo al<br />
f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> monitorare nel tempo le risposte <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione agamica e gamica, i parametri<br />
ecofisiologici sulla luce e la <strong>di</strong>namica floristica. Le tesi <strong>di</strong> trattamento hanno previsto: i) taglio raso<br />
senza rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e, ii) ceduazione con rilascio <strong>di</strong> 50 matric<strong>in</strong>e per ettaro, iii) ceduazione con<br />
rilascio <strong>di</strong> 140 matric<strong>in</strong>e per ettaro, iiii) ceduazione con rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e a gruppi. E’ stata<br />
analizzata la struttura dendrometrica <strong>del</strong> popolamento prima <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento e le risposte al<br />
trattamento <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> accrescimento <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione agamica e <strong>di</strong> affermazione <strong>di</strong> quella<br />
gamica. Dopo l’utilizzazione è stata valutata l’entità <strong>del</strong> danno ai ricacci da brucatura <strong>del</strong> capriolo.<br />
La funzione pr<strong>in</strong>cipale <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura nei cedui a prevalenza <strong>di</strong> specie caducifoglie è stata<br />
comunemente ritenuta quella <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una dotazione <strong>di</strong> piante, quando possibile <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e<br />
gamica, atte alla “fruttificazione e <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>azione necessaria per la sostituzione <strong>del</strong>le ceppaie<br />
deperienti o <strong>in</strong> forte decl<strong>in</strong>o produttivo” (CIANCIO E NOCENTINI, 2004). Tuttavia ZANZI SULLI e DI<br />
PASQUALE (1993) osservano come <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> querce caducifoglie, anche <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong><br />
abbondante <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>azione da parte <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, la densità <strong>di</strong> semenzali è scarsa e <strong>in</strong> alcuni<br />
casi nulla.<br />
Sulla modalità ed <strong>in</strong>tensità ottimale <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura molti selvicoltori hanno <strong>di</strong>scusso già dalla<br />
prima metà <strong>del</strong> secolo scorso. Una dettagliata analisi è fornita da MERENDI (1942) che consiglia <strong>di</strong><br />
evitare nel ceduo matric<strong>in</strong>ato un numero elevato <strong>di</strong> rilasci. Anche riguardo alla scelta <strong>del</strong>le piante<br />
con fenotipo adatto alla funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>azione, il MERENDI raccomanda <strong>di</strong> privilegiare soggetti<br />
<strong>di</strong> buona vigoria ma il meno possibile ramosi e a chioma espansa, <strong>in</strong> modo da non deprimere, con<br />
l’aduggiamento che ne deriverebbe, la vigoria dei polloni <strong>del</strong> nuovo ciclo.<br />
A partire dagli anni ’70 si è assistito ad un aumento progressivo dei rilasci nei cedui appenn<strong>in</strong>ici<br />
che si è andato consolidando <strong>in</strong> prassi operativa. La consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> rilasciare un numero <strong>di</strong><br />
matric<strong>in</strong>e superiore a quanto consentito ha rappresentato nei fatti la risposta alla volontà -mai resa<br />
esplicita- <strong>di</strong> creare da un lato con<strong>di</strong>zioni più favorevoli per la conversione <strong>del</strong> ceduo a fustaia e,<br />
dall’altro, <strong>di</strong> mitigare l’impatto <strong>del</strong>l’asportazione quasi totale <strong>del</strong>la biomassa arborea ad ogni<br />
utilizzazione <strong>di</strong> f<strong>in</strong>e turno. Con ciò sono state attribuite alle matric<strong>in</strong>e, seppure <strong>in</strong> maniera empirica<br />
e non suffragata da risultati sperimentali probanti, ulteriori funzioni oltre quella specifica <strong>di</strong><br />
produzione <strong>di</strong> seme, quali la protezione <strong>del</strong> suolo e il mantenimento, seppur a livelli m<strong>in</strong>imi, <strong>di</strong> una<br />
copertura forestale cont<strong>in</strong>ua nel tempo. Per HIPPOLITI (2001) la funzione <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e è<br />
soprattutto quella “<strong>di</strong> ottenere, al loro taglio, nuove ceppaie per sostituire quelle che si<br />
esauriscono” 2 .<br />
L’aumento <strong>del</strong> numero <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e è stato generalizzato ma ha raggiunto <strong>in</strong> alcune zone<br />
<strong>in</strong>tensità tali (200 ad ettaro ed oltre) da rendere problematica la gestione a ceduo e determ<strong>in</strong>are<br />
una generale <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la qualità dei rilasci.<br />
Il problema dei rapporti tra <strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura, r<strong>in</strong>novazione da seme, ricaccio dei<br />
polloni e produttività è stato affrontato nell’ultimo ventennio con ricerche soprattutto su cedui a<br />
prevalenza <strong>di</strong> cerro (MAETZKE E TORRINI, 1996 – AMORINI et al 1996 - CORONA et al., 1986 – LA<br />
MARCA et al., 1987 – BECHETTI E GIOVANNINI, 1998 – LA MARCA et al 1996 - AMORINI et al., 2002 –<br />
CANTIANI et al. 2002). Gli stu<strong>di</strong> concordano sulla relazione <strong>di</strong>retta tra aumento <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le<br />
chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e e m<strong>in</strong>ore vigoria <strong>del</strong>le ceppaie. BERNETTI (1995) osserva che una <strong>in</strong>tensità<br />
<strong>di</strong> rilascio superiore a 170-200 matric<strong>in</strong>e per ettaro si avvic<strong>in</strong>a ad un avviamento ad altofusto rado<br />
cui corrisponde un grave pericolo <strong>di</strong> deperimento <strong>del</strong>le ceppaie. L’eccessiva dotazione <strong>di</strong> rilasci,<br />
contestualmente all’allungamento dei turni, determ<strong>in</strong>erebbe anche una mo<strong>di</strong>ficazione <strong>del</strong>la<br />
composizione specifica a favore <strong>di</strong> piante tolleranti l’ombra (MAETZKE E TORRINI op. cit. – BERNETTI,<br />
1999), agendo anche sull’aumento <strong>di</strong> mortalità <strong>del</strong>le ceppaie <strong>del</strong>le specie querc<strong>in</strong>e (BECHETTI E<br />
GIOVANNINI, 1998).<br />
1 Da CANTIANI P., AMORINI E., PIOVOSI M., 2006 - Effetti <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura sulla ricostituzione <strong>del</strong>la copertura e<br />
sull’accrescimento dei polloni <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Arezzo XXXIII:<br />
9-20.<br />
2 Una <strong>di</strong>sam<strong>in</strong>a esauriente <strong>del</strong>le varie “funzioni” attribuite nel corso <strong>del</strong> tempo alle matric<strong>in</strong>e è desumibile da CIANCIO E<br />
NOCENTINI (2004), HIPPOLITi (2001), MAETZKE E TORRINI (1996), PIUSSI (1994), ZANZI SULLI E DI PASQUALE (1993), LA MARCA<br />
(1991).<br />
99
100<br />
Materiali e meto<strong>di</strong><br />
Paolo Cantiani<br />
Il popolamento oggetto <strong>del</strong>la ricerca è un ceduo <strong>di</strong> 34 anni a prevalenza <strong>di</strong> cerro per il 66% <strong>in</strong><br />
numero e il 76% <strong>in</strong> area basimetrica, misto con roverella soprattutto nel piano dom<strong>in</strong>ato ed altre<br />
specie (nell’or<strong>di</strong>ne, rispetto all’area basimetrica: orniello, sorbo domestico, perastro, acero<br />
campestre, ciliegio e spora<strong>di</strong>ci carp<strong>in</strong>o bianco, acero opalo e ciavar<strong>del</strong>lo, con una dotazione<br />
complessiva <strong>di</strong> 2110 ceppaie per ettaro. Lo strato arbustivo è a prevalenza <strong>di</strong> g<strong>in</strong>epro ed erica –<br />
soprattutto nei tratti a m<strong>in</strong>ore fertilità-, con spora<strong>di</strong>ci fusagg<strong>in</strong>e e prugnolo. Secondo la tipologia<br />
forestale <strong>del</strong>la Toscana il popolamento è da ascriversi al tipo Cerreta mesofila coll<strong>in</strong>are – variante<br />
con arbusti sp<strong>in</strong>osi <strong>del</strong> pruneto e con perastro (Bernetti e Mon<strong>di</strong>no, 1998).<br />
Il ceduo è fortemente matric<strong>in</strong>ato (230 matric<strong>in</strong>e ad ettaro per un’area basimetrica rispetto al<br />
totale <strong>del</strong> 29%). La tendenza al rilascio <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e è prassi nei cedui <strong>del</strong>le<br />
Coll<strong>in</strong>e Metallifere che producevano <strong>in</strong> passato sia legna da ardere sia assortimenti per le m<strong>in</strong>iere<br />
(BERNETTI E MONDINO, 1998). I rilasci, per circa l’80% <strong>di</strong> cerro, sono per il 66% <strong>di</strong> un turno <strong>del</strong><br />
ceduo. Il popolamento, appartenente alla III classe <strong>di</strong> fertilità (GALIANO, 1992) è <strong>in</strong> avanzata fase <strong>di</strong><br />
strutturazione sociale, con una marcata <strong>di</strong>fferenziazione dei polloni; il piano <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e è ormai<br />
quasi raggiunto dai polloni dom<strong>in</strong>anti e si è <strong>in</strong>staurata una forte competizione nelle ceppaie e tra le<br />
ceppaie (il numero me<strong>di</strong>o dei polloni portati è pari a 1,5).<br />
Il sito sperimentale è posto a quota me<strong>di</strong>a 610 m. s.l.m., esposizione prevalente NO e<br />
pendenza me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> 20%.<br />
La me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le temperature annue è pari a 14,5°C (6 ,1°C me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> mese più freddo – 23,5°C<br />
me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> mese più caldo) (Staz. Massa Marittima). La piovosità me<strong>di</strong>a è pari a 942 mm (AMORINI<br />
et al. 1996). Il substrato geologico deriva dalle formazioni mar<strong>in</strong>e appartenenti al complesso <strong>del</strong>le<br />
argille scagliose ofiolitifere con Calcari Silicei (Palomb<strong>in</strong>i). Tali litotipi, per la loro elevata ero<strong>di</strong>bilità,<br />
provocano, alle maggiori pendenze, fenomeni <strong>di</strong> erosione areale e ruscellamento <strong>di</strong>ffuso (AA.VV,<br />
2004). L’analisi dei parametri dendrometrici e strutturali <strong>del</strong> popolamento prima <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento è<br />
stata realizzata per campionamento sistematico nell’<strong>in</strong>verno 2001. Sono state prelim<strong>in</strong>armente<br />
materializzate sul terreno 17 sezioni <strong>di</strong> forma quadrata e superficie pari a 2.500 m 2 . Le 17 aree <strong>di</strong><br />
saggio permanenti (circolari con raggio fisso <strong>di</strong> 12 metri) sono state poste al centro <strong>del</strong>le sezioni.<br />
Il protocollo ha previsto la def<strong>in</strong>izione e la realizzazione <strong>di</strong> quattro <strong>di</strong>st<strong>in</strong>te tesi <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong><br />
ceduo:<br />
ceduo semplice con rilascio <strong>del</strong>le sole specie spora<strong>di</strong>che 3 (CS) su una superficie <strong>di</strong> 2.500 m 2 ;<br />
ceduo semplice matric<strong>in</strong>ato con rilascio, oltre che <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che, <strong>di</strong> 50 matric<strong>in</strong>e ha -1<br />
(CM 50) su una superficie <strong>di</strong> 5.000 m 2 ;<br />
ceduo semplice matric<strong>in</strong>ato con rilascio, oltre che <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che, <strong>di</strong> 140 matric<strong>in</strong>e ha -1<br />
(CM 140) su una superficie <strong>di</strong> 5.000 m 2 ;<br />
ceduo semplice matric<strong>in</strong>ato con rilascio, oltre che <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che, <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura per<br />
gruppi (CM gruppi) su una superficie <strong>di</strong> 5.000 m 2 .<br />
Per le tesi CM 50 e CM 140 la scelta dei rilasci (che si è <strong>di</strong>fferenziata solo per il numero <strong>di</strong><br />
matric<strong>in</strong>e) ha seguito la logica <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura tra<strong>di</strong>zionale, ovvero sostanziale equi<strong>di</strong>stanza tra i<br />
soggetti rilasciati, compatibilmente con la scelta <strong>di</strong> buoni fenotipi (per forma e <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>la<br />
chioma e stabilità meccanica complessiva). I rilasci hanno riguardato <strong>in</strong> percentuale maggiore i<br />
soggetti <strong>di</strong> un turno; <strong>in</strong> subor<strong>di</strong>ne sono stati scelti soggetti <strong>di</strong> due turni. Secondo le consuetu<strong>di</strong>ni <strong>in</strong><br />
vigore nel territorio è stata lasciata libertà ai tecnici <strong>del</strong>la Comunità Montana <strong>di</strong> rilasciare tutti i<br />
soggetti <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che (che non sono state considerate ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la def<strong>in</strong>izione <strong>del</strong>le tesi <strong>di</strong><br />
trattamento). La tesi CM 50 è costituita da 46 matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> cerro e 4 <strong>di</strong> roverella (area basimetrica<br />
1,0 m 2 ha -1 ; percentuale <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong> suolo 4,7%); la tesi CM 140 è costituita da 116 matric<strong>in</strong>e<br />
<strong>di</strong> cerro, 14 <strong>di</strong> roverella, 6 <strong>di</strong> orniello e 4 <strong>di</strong> sorbo domestico (area basimetrica 2,9 m 2 ha -1 ;<br />
percentuale <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong> suolo 15,6%).<br />
Il trattamento <strong>del</strong>la tesi CM gruppi si <strong>di</strong>fferenzia dalle tra<strong>di</strong>zionali tecniche <strong>di</strong> ceduazione.<br />
Questa modalità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura attualmente <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o su <strong>di</strong>versi protocolli <strong>del</strong> CRA SEL,<br />
3 A partire dall’approvazione <strong>del</strong> Regolamento Forestale <strong>del</strong>la Regione Toscana (18 maggio 2003), al momento<br />
<strong>del</strong>l’utilizzazione è imposto il rilascio <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> specie “spora<strong>di</strong>che” con particolari caratteristiche strutturali.
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
recepita <strong>in</strong> molte normative forestali regionali, è stata proposta da <strong>di</strong>versi autori per il miglioramento<br />
dei cedui soprattutto <strong>di</strong> faggio (CIANCIO et al., 1983). BERNETTI (1998) per i cedui <strong>di</strong> cerro <strong>del</strong>la<br />
Toscana la propone come un possibile miglioramento nelle stazioni a scarsa fertilità; si tratta <strong>in</strong>fatti<br />
<strong>di</strong> una modalità <strong>di</strong> rilascio strettamente correlata ad un appropriato stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>la stazione e <strong>del</strong><br />
popolamento. Per “gruppo” si <strong>in</strong>tende una porzione <strong>di</strong> bosco, <strong>di</strong> estensione e forma non<br />
rigidamente co<strong>di</strong>ficate, rilasciata <strong>in</strong>tatta al momento <strong>del</strong> taglio (CANTIANI et al, 2002, AMORINI et al.<br />
2002, GROMHANN et al. 2002, FIORUCCI 2009). L’<strong>in</strong>sieme dei soggetti non sottoposti a ceduazione<br />
rappresenta la dotazione <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong> ceduo. Talora, oltre ai gruppi, sono stati rilasciati anche<br />
soggetti s<strong>in</strong>goli reputati adatti ad assolvere positivamente le funzioni <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>a (es. piante <strong>di</strong><br />
rovere o <strong>di</strong> sorbo <strong>di</strong> qualità morfologiche e sviluppo sod<strong>di</strong>sfacenti; piante <strong>di</strong> ciliegio con corteggio <strong>di</strong><br />
polloni per educazione <strong>del</strong> fusto). In l<strong>in</strong>ea generale per la scelta dei rilasci sono state privilegiate<br />
porzioni <strong>di</strong> soprassuolo <strong>in</strong> situazioni microstazionali particolari (ad esempio dossi a scarsa fertilità<br />
stazionale). Il gruppo <strong>di</strong> rilasci (<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni variabili) deve prevedere la presenza <strong>di</strong> alcune piante<br />
che possano garantire la sua stabilità. Un ulteriore parametro <strong>del</strong> gruppo può essere la presenza<br />
locale <strong>di</strong> specie particolari (spora<strong>di</strong>che o <strong>di</strong> pregio). All’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> gruppo non viene generalmente<br />
previsto alcun <strong>in</strong>tervento. Tra i possibili vantaggi offerti da questa modalità <strong>di</strong> trattamento rispetto<br />
alla matric<strong>in</strong>atura tra<strong>di</strong>zionale elencati da GRHOMANN et al. (2002), si menzionano la protezione<br />
idrogeologica <strong>di</strong> microstazioni sfavorite, la maggiore complessità strutturale con ripercussioni sul<br />
mantenimento <strong>di</strong> particolari microhabitat, un maggior pregio paesaggistico, la maggiore facilità <strong>di</strong><br />
concentrazione <strong>del</strong>le vie <strong>di</strong> esbosco, la possibilità <strong>di</strong> allevamento <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> pregio a f<strong>in</strong>i<br />
produttivi, il mantenimento <strong>di</strong> un elevato valore <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità specifica per le specie arboree e per le<br />
specie degli strati arbustivo ed erbaceo.<br />
E’ stato effettuato per le <strong>di</strong>verse tesi un rilievo mirato alla def<strong>in</strong>izione <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>le<br />
matric<strong>in</strong>e dopo l’utilizzazione.<br />
E stata annualmente caratterizzato il valore <strong>del</strong> LAI e <strong>del</strong>la trasmittanza nella banda <strong>del</strong> PAR<br />
(ra<strong>di</strong>azione fotos<strong>in</strong>teticamente attiva) nelle aree sperimentali sottoposte a ceduazione tramite<br />
campionamento sistematico.<br />
Per la determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> ricaccio <strong>del</strong>le ceppaie e <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong> nuovo ciclo<br />
agamico, sono stati rilevati la vitalità e l’accrescimento dei polloni nelle 5 stagioni vegetative<br />
successive all’utilizzazione. A tale scopo, successivamente al taglio <strong>del</strong> ceduo - relativamente alle<br />
tre tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare - è stato realizzato un transect <strong>di</strong> 300 m 2 per tesi <strong>di</strong> trattamento.<br />
Sono state def<strong>in</strong>ite topograficamente e numerate con cartell<strong>in</strong>o <strong>di</strong> ferro tutte le ceppaie all’<strong>in</strong>terno<br />
<strong>del</strong> transect. Per ogni ceppaia è stata identificata la specie e sono state effettuate le misure relative<br />
al suo <strong>di</strong>ametro (con doppia misurazione a croce, rispetto a <strong>di</strong>rezioni prefissate).<br />
Complessivamente sono state censite 201 ceppaie.<br />
Dopo ogni stagione vegetativa su ciascuna ceppaia sono state effettuati i seguenti rilievi:<br />
conta dei polloni vivi<br />
altezza dei polloni dom<strong>in</strong>anti (i c<strong>in</strong>que polloni più alti per ceppaia)<br />
<strong>di</strong>ametro al colletto dei polloni dom<strong>in</strong>anti<br />
area <strong>di</strong> <strong>in</strong>sidenza dei ricacci per ceppaia.<br />
Per il rilievo <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong> danno da morso degli ungulati ai ricacci è stato adottato il<br />
seguente protocollo <strong>di</strong> valutazione <strong>del</strong> danno (tabella 1)<br />
Tabella 1. Scala dei danni da morso alle ceppaie (da Giovann<strong>in</strong>i, Ch<strong>in</strong>es e Gandolfo, 2003)<br />
Classe Tipo <strong>di</strong> danno Proporzione <strong>di</strong> polloni brucati<br />
0<br />
Assenza <strong>di</strong> danno Nessuna traccia <strong>di</strong> brucatura<br />
I Brucatura lieve N
102<br />
Paolo Cantiani<br />
Il protocollo <strong>di</strong> rilievo <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione gamica nelle tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare ha previsto<br />
un campionamento sistematico sul transect (36 aree quadrate <strong>di</strong> 0,5 metri <strong>di</strong> lato per tesi <strong>di</strong><br />
trattamento) per il rilievo <strong>del</strong>la specie, <strong>del</strong> numero e <strong>del</strong>l’altezza <strong>di</strong> ciascun semenzale. In tal modo<br />
è stato possibile attribuire per le tre tesi <strong>di</strong> trattamento a matric<strong>in</strong>atura regolare l’<strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novazione IR, da MAGINI (1967).<br />
Dopo la qu<strong>in</strong>ta stagione vegetativa è stato effettuato un <strong>in</strong>ventario <strong>del</strong> popolamento per<br />
ciascuna tesi <strong>di</strong> trattamento <strong>in</strong> aree <strong>di</strong> saggio circolari (10 metri <strong>di</strong> raggio) poste al centro <strong>del</strong>le<br />
parcelle sperimentali.<br />
Risultati e <strong>di</strong>scussione<br />
Nella tabella 2 si riportano i parametri dendrometrici e strutturali <strong>di</strong> s<strong>in</strong>tesi <strong>del</strong> popolamento<br />
prima <strong>del</strong>l’utilizzazione.<br />
Tabella 2. Pr<strong>in</strong>cipali parametri dendro-strutturali <strong>del</strong> ceduo al momento <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento. (numero polloni,<br />
area basimetrica, <strong>di</strong>ametro ed altezza me<strong>di</strong>, volume dendrometrico. Parametri riferiti ad ettaro).<br />
dom<strong>in</strong>anti codom<strong>in</strong>anti subdom<strong>in</strong>ate dom<strong>in</strong>ate tot polloni matric<strong>in</strong>e poll+matr<br />
n h -1 319 267 407 2226 3218 230 3448<br />
m 2 h -1 4.9 3.7 4.1 8.5 21.1 8.5 29.3<br />
Dgm 13.9 13.2 11.4 7.0 9.2 21.2 10.4<br />
hm 13.0 12.7 11.6 8.1 10.1 14.4 12.3<br />
m 3 h -1 181.3<br />
Parametri <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e nelle tesi <strong>di</strong> trattamento<br />
I rilasci per le tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare, tutti <strong>di</strong> cerro <strong>di</strong> un turno salvo rare eccezioni,<br />
presentano caratteristiche molto simili fra tesi, per <strong>di</strong>ametro e area <strong>di</strong> <strong>in</strong>sidenza <strong>del</strong>le chiome. I<br />
valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> altezza totale e <strong>di</strong> <strong>in</strong>serzione <strong>del</strong>la chioma sono relativamente superiori nella tesi CM<br />
140 (tabella 3).<br />
Tabella 3. Parametri <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e rilasciate nelle tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare (CM 50 e CM 140)<br />
CM 50 CM 140<br />
<strong>di</strong>am me<strong>di</strong>o cm 15.6 15.7<br />
area basimetrica totale m 2 1.03 2.93<br />
alt me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> <strong>in</strong>serzione m 6.0 7.1<br />
altezza totale m 13.3 14.2<br />
La tesi CM gruppi è costituita da 22 gruppi ha -1 <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni molto variabili (<strong>in</strong> me<strong>di</strong>a 62 m 2<br />
con un range da 7 ad oltre 200 m 2 )e da 14 matric<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>gole per un’area basimetrica complessiva<br />
<strong>di</strong> 3,4 m 2 ha -1 e una copertura <strong>del</strong> suolo pari al 19,6%. La composizione specifica rispetto all’area<br />
basimetrica è così articolata: 60% cerro, 23% roverella, 4% ciliegio, 13% altre specie.<br />
Nella tabella 4 si riportano il grado <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e e dei gruppi per le<br />
<strong>di</strong>verse tesi <strong>di</strong> trattamento al 2000 e al 2004.<br />
Tabella 4. Parametri <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e per tesi <strong>di</strong> trattamento. Area <strong>di</strong> <strong>in</strong>sidenza <strong>del</strong>le chiome al 2000 e 2004<br />
e <strong>in</strong>crementi nel periodo (Ip) <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro e altezza me<strong>di</strong>.<br />
% copertura <strong>del</strong>le chiome Diametro (cm) Altezza (m)<br />
2000 2004 2000 2004 Ip 2000 2004 Ip<br />
CM 50 4.7 6.1 15.6 18.5 3.0 13.3 13.5 0.2<br />
CM 140 15.6 16.4 15.7 18.5 2.8 14.2 14.9 0.7<br />
CM gruppi 19.6 23.2 13.1 15.2 2.1 17.3 17.6 0.3
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
Per una corretta valutazione <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong> suolo <strong>del</strong>le chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e nella tesi CM<br />
gruppi si deve considerare che solo una quota <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong>le chiome <strong>in</strong>siste <strong>di</strong>rettamente<br />
sulle ceppaie <strong>in</strong> quanto, come detto, all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> gruppo tutte le ceppaie sono state <strong>in</strong>tegralmente<br />
rilasciate. La CM 50 evidenzia <strong>in</strong>crementi maggiori relativamente ai parametri area <strong>di</strong> <strong>in</strong>sidenza<br />
<strong>del</strong>le chiome e <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o. La copertura <strong>del</strong>le chiome nella tesi CM gruppi aumenta <strong>in</strong> misura<br />
maggiore rispetto alle tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare; le matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la tesi CM 140 crescono<br />
maggiormente <strong>in</strong> altezza nel periodo considerato.<br />
Dai valori <strong>di</strong> PAR comparati col controllo si desume che dopo il taglio la chioma <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e<br />
assorbe dal 2% (Tesi CS) al 15% (tesi CM140) <strong>del</strong>la ra<strong>di</strong>azione fotos<strong>in</strong>teticamente attiva. Il LAI già<br />
al 5° anno <strong>di</strong> vegetazione mostra una quasi completa ripresa per tutte le tesi. In analoghi protocolli<br />
la ripresa totale <strong>del</strong> LAI è stata registrata all’8° anno <strong>di</strong> vegetazione (CUTINI 2006)<br />
Parametri <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione agamica e gamica per tesi <strong>di</strong> trattamento<br />
Si analizza la <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> mortalità <strong>del</strong>le ceppaie nel corso <strong>del</strong> qu<strong>in</strong>quennio per tesi <strong>di</strong><br />
trattamento a matric<strong>in</strong>atura regolare. La figura 1 riporta la percentuale <strong>del</strong>le ceppaie che non hanno<br />
ricacciato dopo l’<strong>in</strong>tervento e quella <strong>del</strong>le ceppaie morte nel corso <strong>del</strong>le c<strong>in</strong>que stagioni vegetative<br />
seguenti l’utilizzazione.<br />
Figura 1. Percentuale <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong> cerro che non hanno ricacciato e <strong>di</strong> ceppaie morte dal secondo al<br />
qu<strong>in</strong>to anno <strong>del</strong> ciclo <strong>del</strong> ceduo.<br />
L’assenza <strong>di</strong> ricaccio subito dopo l’utilizzazione e la mortalità complessiva nei 5 anni successivi<br />
al taglio aumentano considerevolmente all’aumentare <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong> terreno da parte <strong>del</strong>le<br />
chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e. L’andamento registrato è <strong>in</strong> accordo con quanto riscontrato da BECHETTI E<br />
GIOVANNINI (1998) per i cedui <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong> Umbria. Anche CORONA et al. (1986) hanno trovato<br />
correlazioni positive tra copertura <strong>del</strong>le chiome e mortalità dei polloni <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> cerro. Nelle tesi<br />
con matric<strong>in</strong>e il dato <strong>di</strong> mortalità <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong> cerro è risultato assai elevato, arrivando per la tesi<br />
CM 140 a più <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>le ceppaie censite (733 ceppaie ad ettaro). Nella tesi CM 50 il 27 %<br />
<strong>del</strong>le ceppaie morte erano situate sotto la copertura <strong>di</strong>retta <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e rilasciate, la percentuale<br />
sale al 48,8% nella tesi CM 140.<br />
Le ceppaie hanno subito un grave danneggiamento dovuto al morso <strong>del</strong> capriolo soprattutto al<br />
riscoppio dopo l’utilizzazione. La figura 2 evidenzia la ripartizione percentuale <strong>del</strong> danneggiamento<br />
da brucatura <strong>del</strong>le ceppaie dopo la prima stagione vegetativa.<br />
Tra le specie querc<strong>in</strong>e le ceppaie <strong>di</strong> cerro sono quelle più danneggiate dal morso dei caprioli.<br />
Tra le altre specie l’orniello e il sorbo domestico sono <strong>in</strong>tegralmente esenti dal danno.<br />
La brucatura dei polloni sembra avere <strong>in</strong>fluito <strong>di</strong>rettamente sulla sopravvivenza e sullo sviluppo<br />
<strong>del</strong>le ceppaie negli anni successivi. L’86% <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong> cerro che avevano subito danni da<br />
brucatura nella prima stagione non sono sopravvissute alle successive due stagioni vegetative.<br />
All’alta <strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong> danno può aver concorso l’esiguità <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong>la tagliata (2,5 ettari al<br />
primo anno <strong>del</strong> ceduo) che, come <strong>di</strong>mostrano GIOVANNINI et al. (2003) appare <strong>in</strong>versamente<br />
proporzionale all’<strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la brucatura. Altro fattore concorrente può essere stato l’ubicazione<br />
<strong>del</strong>la tagliata, riparata da porzioni <strong>di</strong> ceduo maturo e relativamente <strong>di</strong>stante da strade e aree<br />
e<strong>di</strong>ficate.<br />
103
104<br />
Paolo Cantiani<br />
Figura 2. Ceppaie <strong>di</strong> cerro, roverella e altre specie. Ripartizione percentuale <strong>del</strong>le classi <strong>di</strong> danno al<br />
term<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la prima stagione vegetativa dall’utilizzazione.<br />
In fig 3,4,5 si riassume l’andamento dei parametri dendrometrici <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong> cerro (numero<br />
<strong>di</strong> polloni portati per ceppaia, <strong>di</strong>ametro e altezza me<strong>di</strong> dei polloni dom<strong>in</strong>anti) nelle tesi a ceduazione<br />
regolare nel periodo analizzato.<br />
Figura 3. Cerro. Andamento <strong>del</strong> numero me<strong>di</strong>o dei polloni per ceppaia nelle tesi CS, CM 50 e CM 140.<br />
Il numero dei polloni portati per ceppaia non sembra essere con<strong>di</strong>zionato dalla copertura <strong>del</strong>le<br />
chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e nei primi 5 anni <strong>di</strong> osservazione come osservano anche BECHETTI E<br />
GIOVANNINI (op. cit.) <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> specie querc<strong>in</strong>e. Come già osservato da LA MARCA et<br />
al. (1996), il cerro <strong>di</strong>mostra una tendenza all’emissione <strong>di</strong> nuovi polloni anche nei primi anni<br />
successivi a quella <strong>del</strong>l’utilizzazione, con un bilancio tra natalità e mortalità positivo (figura 3).<br />
Questo fenomeno è stato <strong>in</strong>izialmente più marcato nella tesi CS, mentre le due tesi con matric<strong>in</strong>e<br />
hanno avuto un andamento sostanzialmente simile tra loro.<br />
L’andamento dei parametri <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o e altezza me<strong>di</strong>a dei polloni dom<strong>in</strong>anti nei 5 anni <strong>di</strong><br />
osservazione mostra <strong>di</strong>fferenze tra la tesi CS e le due tesi con matric<strong>in</strong>e (Figure 4 e 5). L’analisi<br />
Anova relativa al <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o dei polloni dom<strong>in</strong>anti tra la tesi CS e le due tesi con matric<strong>in</strong>e<br />
considerate comulativamente mostra <strong>di</strong>fferenze significative nei 5 rilievi annuali. La stessa analisi<br />
per l’altezza me<strong>di</strong>a ha evidenziato <strong>di</strong>fferenze significative solo per i rilievi 2002 e 2005 (tabella 5).<br />
L’analisi <strong>del</strong>la varianza per le tre tesi <strong>di</strong> trattamento considerate s<strong>in</strong>golarmente non è<br />
significativa per l’altezza me<strong>di</strong>a dei polloni dom<strong>in</strong>anti, mentre lo è per il <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o,<br />
relativamente agli anni 2002, 2003 e 2004 (tabella. 6)<br />
L’<strong>in</strong>ventario dendrometrico dei polloni effettuato (con soglia <strong>di</strong> cavallettamento 3 cm <strong>di</strong><br />
circonferenza a 1,30 metri <strong>di</strong> altezza) dopo il 5° a nno <strong>del</strong> ciclo <strong>del</strong> ceduo, mostra sensibili<br />
<strong>di</strong>fferenze nello sviluppo dei polloni tra tesi <strong>di</strong> trattamento (tabella 7).
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
La tesi priva <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e (CS) presenta il maggior numero <strong>di</strong> polloni <strong>di</strong> altezza superiore a 1,30<br />
metri. In questa tesi si riscontra anche la maggior <strong>di</strong>versità specifica. La tesi a gruppi (CM gruppi)<br />
ha il valore <strong>di</strong> area basimetrica totale più elevato; il contributo a livello specifico è quasi <strong>in</strong>teramente<br />
dovuto al cerro. In questa tesi i polloni <strong>di</strong> cerro hanno mostrato il maggior sviluppo, come è<br />
testimoniato dai valori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o e altezza me<strong>di</strong>a rispetto a quelli <strong>del</strong>le altre tesi. Tra le due<br />
tesi a matric<strong>in</strong>atura regolare (CM 50 e CM 140) non si notano sensibili <strong>di</strong>fferenze a livello <strong>di</strong> densità<br />
e <strong>di</strong> area basimetrica ad ettaro. I parametri <strong>di</strong> sviluppo dei polloni (<strong>di</strong>ametro e altezza me<strong>di</strong>)<br />
<strong>di</strong>m<strong>in</strong>uiscono però all’aumentare <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong>le chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e.<br />
m<br />
c<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
C S<br />
C M50<br />
C m140<br />
Figura 4. Cerro. Andamento <strong>del</strong> <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o dei polloni dom<strong>in</strong>anti per tesi <strong>di</strong> trattamento CS, CM 50 e<br />
CM 140.<br />
m<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
CS<br />
CM50<br />
Cm140<br />
Figura 5. Cerro. Andamento <strong>del</strong>l’altezza me<strong>di</strong>a dei polloni dom<strong>in</strong>anti per le tesi <strong>di</strong> trattamento CS, CM 50 e<br />
CS 140.<br />
105
106<br />
Paolo Cantiani<br />
Tabella 5. Diametro e altezza dom<strong>in</strong>anti me<strong>di</strong>. Anova tra tesi CS e tesi con matric<strong>in</strong>e.<br />
confronto tra tesi senza matric<strong>in</strong>e e tesi matric<strong>in</strong>ate (valori <strong>di</strong> F). p
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
Il rilievo effettuato subito dopo il taglio <strong>di</strong> utilizzazione ha messo <strong>in</strong> evidenza l’assenza <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novazione da seme <strong>del</strong>le due specie querc<strong>in</strong>e nel ceduo maturo. Nella tesi CM 140 l’IR dal terzo<br />
al qu<strong>in</strong>to anno <strong>del</strong> nuovo ciclo <strong>del</strong> ceduo mostra valori più elevati rispetto alle altre tesi e ha un<br />
trend positivo nel triennio (raddoppia il suo valore nel corso <strong>del</strong> periodo). I valori <strong>in</strong>feriori sono stati<br />
registrati nella tesi CM 50 che evidenzia un andamento oscillante nei tre anni <strong>di</strong> osservazione. E’<br />
<strong>in</strong>teressante l’andamento <strong>del</strong>l’<strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione nella tesi senza matric<strong>in</strong>atura (CS) che al terzo<br />
anno presenta il valore più elevato tra le tesi <strong>di</strong> trattamento analizzate. L’<strong>in</strong><strong>di</strong>ce ha il suo picco dopo<br />
la 4° stagione vegetativa per poi tornare l’anno su ccessivo ai valori registrati al term<strong>in</strong>e <strong>del</strong> terzo<br />
anno. In questa tesi <strong>di</strong> trattamento le due querce hanno <strong>di</strong>mostrato capacità <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione<br />
nonostante che piante portaseme fossero presenti solo ad un marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la tagliata. La<br />
germ<strong>in</strong>azione a <strong>di</strong>stanza potrebbe avere avuto come vettore determ<strong>in</strong>ante la piccola fauna<br />
selvatica, quali i topi ed altri ro<strong>di</strong>tori (LA MARCA et al, 1987). Analoghe osservazioni su fenomeni <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novazione da seme <strong>in</strong> zone prive <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e sono state effettuate da PISCINA (1995) <strong>in</strong> cedui<br />
misti <strong>di</strong> faggio e cerro <strong>del</strong>l’appenn<strong>in</strong>o parmense. L’analisi dovrà proseguire per i successivi sta<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
sviluppo <strong>del</strong> ceduo per la valutazione <strong>del</strong>la capacità effettiva <strong>di</strong> sopravvivenza dei semenzali,<br />
considerando che l’altezza me<strong>di</strong>a dei semenzali <strong>di</strong> querce al qu<strong>in</strong>to anno è pari a circa 25<br />
centimetri mentre l’altezza me<strong>di</strong>a dei polloni è <strong>di</strong> poco <strong>in</strong>feriore a 3 metri.<br />
L’α-<strong>di</strong>versità specifica (<strong>di</strong>versità specifica a scala locale) aumenta <strong>in</strong> tutte le tesi a partire dal<br />
secondo anno <strong>del</strong> ceduo (soprattutto per le specie annuali) per poi <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire già dal 3° anno e<br />
rimanere costante f<strong>in</strong>o alla 5° stagione vegetativa. La tesi a gruppi <strong>di</strong>mostra una maggiore<br />
variabilità specifica con specie annuali (allo scoperto) e specie forestali (all’<strong>in</strong>terno dei gruppi). In<br />
generale il recupero <strong>del</strong>le specie forestali è maggiore <strong>in</strong> modo <strong>di</strong>retto con la copertura <strong>del</strong>le chiome<br />
<strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e (BARAGATTI et al. 2006).<br />
L’analisi <strong>del</strong>la percezione <strong>del</strong>la popolazione alle mutazioni paesaggistiche dovute ai <strong>di</strong>versi<br />
trattamenti selvicolturali (FAGARAZZI et al. 2006) evidenzia un generico basso gra<strong>di</strong>mento per tutte<br />
le tesi <strong>di</strong> trattamento, sia <strong>del</strong> ceduo che, anche se <strong>in</strong> misura m<strong>in</strong>ore, <strong>del</strong>la tesi <strong>di</strong> avviamento ad alto<br />
fusto soprattutto nei pr<strong>in</strong>i 3-4 anni dal l’<strong>in</strong>tervento.<br />
La sperimentazione conferma l’importanza <strong>di</strong> applicare una corretta modalità <strong>del</strong> trattamento <strong>del</strong><br />
ceduo ai f<strong>in</strong>i <strong>di</strong> ottimizzare la sua produttività, compatibilmente con una corretta funzionalità <strong>del</strong><br />
sistema, che si esprime nella conservazione <strong>di</strong> una elevata <strong>di</strong>versità specifica e complessità<br />
strutturale e nella adeguata densità <strong>del</strong>le ceppaie. In questo senso il trattamento può agire sulla<br />
modalità <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura e sul turno <strong>del</strong> ceduo; altri importanti accorgimenti gestionali<br />
riguardano la superficie e la <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong>le tagliate.<br />
Operare un’accurata analisi <strong>del</strong> ceduo <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> pianificazione è utile per fornire elementi circa<br />
la scelta <strong>del</strong> trattamento e le sue modalità ottimali. L’analisi <strong>del</strong> popolamento non dovrebbe essere<br />
semplicemente basata sull’accertamento <strong>del</strong>l’età, quanto sulla determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong> tipo strutturale<br />
conseguente all’evoluzione <strong>del</strong> popolamento stesso. Nell’eventualità che il popolamento si<br />
presentasse <strong>in</strong> uno sta<strong>di</strong>o avanzato <strong>di</strong> strutturazione e si scegliesse comunque <strong>di</strong> effettuare<br />
l’utilizzazione, sarebbe opportuno prescrivere al momento <strong>del</strong> taglio un r<strong>in</strong>foltimento <strong>del</strong>le ceppaie<br />
con specie idonee alla stazione, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> regolare la densità e riprist<strong>in</strong>are un buon livello <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versità specifica.<br />
I risultati <strong>del</strong>la ricerca hanno confermato quanto già noto sugli effetti deprimenti <strong>del</strong>l’eccesso <strong>di</strong><br />
matric<strong>in</strong>atura sullo sviluppo <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione agamica. E’ risultata particolarmente evidente la forte<br />
<strong>in</strong>fluenza <strong>del</strong>l’eccesso <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e sulla capacità <strong>di</strong> ricaccio <strong>del</strong>le<br />
ceppaie e sulla sopravvivenza giovanile dei polloni. Anche lo sviluppo dei polloni nei primi anni <strong>del</strong><br />
ciclo appare <strong>in</strong>versamente correlato alla copertura <strong>del</strong>le chiome <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e.<br />
La ricerca ha evidenziato una correlazione positiva tra numero <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e e germ<strong>in</strong>azione <strong>di</strong><br />
semenzali. Al contempo si è osservata una tendenza alla r<strong>in</strong>novazione da seme anche nella tesi<br />
priva <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e. Circa l’effettiva capacità <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione da seme a costituire nuove ceppaie<br />
<strong>in</strong> sostituzione <strong>di</strong> quelle esaurite, sarà necessario seguire la <strong>di</strong>namica <strong>del</strong>la nuova generazione<br />
gamica, analizzando soprattutto la competizione con i polloni.<br />
Circa la scelta <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e da rilasciare ci pare importante riba<strong>di</strong>re l’opportunità <strong>di</strong> preservare<br />
un numero limitato <strong>di</strong> rilasci, soprattutto <strong>di</strong> un turno, <strong>di</strong> buon fenotipo. Sulla composizione specifica<br />
<strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, ferma restando l’importanza <strong>del</strong> rilascio <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che, ciò non dovrebbe<br />
essere effettuato <strong>in</strong><strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>atamente, ma sarebbe opportuno scegliere esclusivamente i soggetti<br />
107
108<br />
Paolo Cantiani<br />
ben conformati che possano garantire un adeguato sviluppo futuro. Considerazioni analoghe<br />
possono essere effettuate circa il rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> più <strong>di</strong> due cicli <strong>del</strong> ceduo. Il loro numero<br />
dovrebbe essere contenuto e la scelta dovrebbe cadere solamente su soggetti che <strong>di</strong>mostr<strong>in</strong>o<br />
buona vitalità e struttura <strong>del</strong>la chioma. Le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> più cicli tendono <strong>in</strong>fatti a formare chiome<br />
eccessivamente espanse e le loro ceppaie al taglio rischiano <strong>di</strong> non essere <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> ricacciare<br />
(<strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> cerro LA MARCA et al. 1987 hanno osservato l’esaurirsi <strong>di</strong> ceppaie <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> 3 o più<br />
cicli <strong>del</strong> ceduo). Per le medesime considerazioni, il rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e particolarmente annose, a<br />
funzione <strong>di</strong> microhabitat e per f<strong>in</strong>alità estetico-paesaggistiche, dovrebbe limitarsi a qualche unità<br />
per ettaro.<br />
La sperimentazione <strong>del</strong>la modalità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura per gruppi ha dato risultati <strong>in</strong>coraggianti <strong>in</strong><br />
term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> accrescimento <strong>del</strong> piano dei polloni. La ricerca dovrà qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> futuro mirare alla<br />
valutazione <strong>del</strong>l’effettivo miglioramento <strong>del</strong>le funzioni che tale forma <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura si prefigge<br />
(funzioni paesaggistiche, <strong>in</strong>cremento <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità specifica e strutturale, creazione <strong>di</strong><br />
microhabitat per la fauna, protezione <strong>di</strong> particolari stazioni vulnerabili, ecc.). Ad oggi riteniamo che<br />
tale modalità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura possa essere adottata nella prassi operativa, a patto che la scelta dei<br />
gruppi sia affidata ad un tecnico esperto e sia conseguenza <strong>di</strong> un’accurata analisi stazionale e <strong>del</strong><br />
popolamento.<br />
I gravi danni riscontrati sui ricacci <strong>del</strong>le ceppaie per la brucatura <strong>del</strong>la fauna selvatica <strong>in</strong>ducono<br />
a far riflettere sulla necessità <strong>di</strong> una gestione corretta e s<strong>in</strong>ergica <strong>di</strong> tutte le componenti <strong>del</strong> territorio<br />
forestale. Soprattutto nei boschi <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione è necessario un equilibrio tra offerta<br />
alimentare e carico animale. Per contenere l’effetto <strong>del</strong>la brucatura <strong>del</strong>la fauna selvatica <strong>in</strong> zone<br />
vocate pr<strong>in</strong>cipalmente al governo a ceduo, CUTINI et al (2005) propongono la creazione <strong>di</strong> aree<br />
aperte a<strong>di</strong>bite a coltivazioni a perdere che potrebbero “<strong>di</strong>stogliere l’attenzione” dei selvatici dalle<br />
ceppaie <strong>in</strong> r<strong>in</strong>novazione. La pianificazione forestale deve qu<strong>in</strong><strong>di</strong> essere necessariamente <strong>in</strong>tegrata<br />
con quella faunistica e strettamente collegata alla pianificazione territoriale, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> operare<br />
strategie e scelte gestionali funzionali all’effettiva sostenibilità <strong>del</strong>l’attività selvicolturale.<br />
2) LA STRUTTURA SOCIALE E GENETICA DEL CEDUO IN CONVERSIONE 4<br />
L’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è sita nella stessa particella assestamentale ove è stata effettuata la<br />
sperimentazione sul ceduo.<br />
La popolazione appartiene alla tesi <strong>di</strong> avviamento all’alto fusto <strong>di</strong> maggiore <strong>in</strong>tensità. La<br />
superficie <strong>del</strong>la parcella sperimentale è <strong>di</strong> 5.000 m 2 .<br />
L’<strong>in</strong>tervento (s<strong>in</strong>tetizzato nei suoi parametri <strong>in</strong> Tabella 9) ha asportato l’81% dei polloni ed il<br />
56% <strong>del</strong>l’area basimetrica totale e ha <strong>in</strong>teressato <strong>in</strong> pratica tutto il piano dom<strong>in</strong>ato e, nel piano<br />
dom<strong>in</strong>ante, ha <strong>in</strong>ciso soprattutto sui polloni e le matric<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la classe codom<strong>in</strong>ante.<br />
I due grafici <strong>in</strong> Figura 6 mostrano le <strong>di</strong>stribuzioni <strong>di</strong> numero e area basimetrica prima e dopo il<br />
taglio d’avviamento.<br />
Tabella 9<br />
prima dopo Utilizzazione<br />
%<br />
N ha -1 4728 912 80,7<br />
Gm 2 ha -1 29,3 12,9 55,8<br />
dgm 8,9 13,4<br />
hm 10,5 12,9<br />
N ha -1 = n° polloni;<br />
Gm 2 ha -1 = area basimetrica;<br />
dgm = <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> area basimetrica me<strong>di</strong>a;<br />
hm = altezza me<strong>di</strong>a.<br />
4 Da DUCCI F., PROIETTI R., CANTIANI P. 2006 – Struttura genetica e sociale <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong> conversione. Annali<br />
Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Arezzo XXXIII: 143-158. Per la metodologia specifica ed i risultati <strong>del</strong>l’analisi<br />
genetica si rimanda al testo <strong>in</strong>tegrale.
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
Nella porzione centrale <strong>del</strong>la parcella sperimentale è stato realizzato un sistema <strong>di</strong> aree <strong>di</strong><br />
saggio circolari concentriche. In un’area, più piccola e centrale (17 metri <strong>di</strong> raggio), sono state<br />
campionate per le analisi genetiche tutte le piante <strong>di</strong> cerro presenti, sud<strong>di</strong>vise per classi sociali e<br />
per età (polloni, matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> un turno e matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> due turni). Tutte le piante sono state numerate<br />
e geo-referenziate. Complessivamente sono state censite 147 piante, ma è stato possibile<br />
raccogliere materiale vegetale solo da 107 <strong>di</strong> esse.<br />
Figura 6<br />
La Tabella 10 s<strong>in</strong>tetizza la struttura sociale <strong>del</strong> popolamento dopo l’<strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> avviamento<br />
all’alto fusto.<br />
Tabella 10<br />
In Figura 7 ne è riportata la <strong>di</strong>slocazione, relativamente uniforme, nella parcella sperimentale.<br />
Per meglio rilevare e <strong>in</strong>terpretare l’eventuale presenza <strong>di</strong> strutturazione spaziale<br />
<strong>del</strong>l’<strong>in</strong>formazione genetica, la popolazione è stata sud<strong>di</strong>visa <strong>in</strong> quadranti, or<strong>di</strong>nati a partire da quello<br />
<strong>in</strong> alto a destra, <strong>in</strong> senso orario.<br />
Figura 7<br />
cm<br />
109
110<br />
Le analisi genetiche<br />
Paolo Cantiani<br />
La variabilità genetica <strong>del</strong>la popolazione è stata saggiata attraverso marcatori biochimici<br />
(isoenzimi) me<strong>di</strong>ante elettroforesi. Il metodo offre la possibilità <strong>di</strong> esplorare, <strong>in</strong> maniera<br />
relativamente poco costosa e rapida, la struttura genetica nelle popolazioni, per adottare eventuali<br />
<strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> gestione e conservazione. L’<strong>in</strong>formazione sulla possibile presenza <strong>di</strong> alleli rari può<br />
costituire la base per affiancare stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento successivi con marcatori molecolari.<br />
L’estrazione degli enzimi è stata effettuata da gemme <strong>in</strong> riposo vegetativo, da un campione <strong>di</strong><br />
107 piante. Queste sono state attribuite a <strong>di</strong>verse classi sociali: 46 polloni <strong>di</strong> ceppaie “dom<strong>in</strong>ate”,<br />
25 <strong>di</strong> “dom<strong>in</strong>anti”, 6 <strong>di</strong> “codom<strong>in</strong>anti”, 30 matric<strong>in</strong>e (<strong>di</strong> cui 28, “m1”, <strong>di</strong> un turno oltre l’età dei polloni<br />
e 2, “m2”, <strong>di</strong> due turni oltre l’età dei polloni). I polloni, che <strong>in</strong>sieme alle matric<strong>in</strong>e rilasciate dopo il<br />
taglio <strong>di</strong> avviamento, costituiscono l’attuale fustaia transitoria, sono coetanei (34 anni) e derivano<br />
dall’ultimo taglio <strong>del</strong> ceduo.<br />
L’analisi dei parametri <strong>del</strong>la <strong>di</strong>versità <strong>in</strong>terna al gruppo (componente1) ha avuto lo scopo <strong>di</strong><br />
conoscere la situazione <strong>in</strong>iziale <strong>del</strong>la struttura genetica prima <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento, esattamente<br />
nelle stesse con<strong>di</strong>zioni microstazionali <strong>in</strong> cui viene condotto l’esperimento colturale.<br />
Le analisi sulle altre componenti <strong>del</strong> soprassuolo, polloni nel loro complesso (componente 2),<br />
successivamente sud<strong>di</strong>visi per classi sociali (componente “vegetativa”) e matric<strong>in</strong>e (componente<br />
“generativa”), hanno avuto per scopo una stima <strong>del</strong>la variabilità genetica <strong>del</strong>la fustaia transitoria<br />
dopo il primo taglio <strong>di</strong> avviamento. I parametri genetici dei <strong>di</strong>versi gruppi sociali sono stati <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />
confrontati tra loro e con la popolazione totale <strong>di</strong> “Fontalc<strong>in</strong>aldo”, <strong>in</strong>tesa come situazione <strong>in</strong>iziale <strong>di</strong><br />
riferimento.<br />
I dati <strong>di</strong> Fontalc<strong>in</strong>aldo sono stati esam<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> modo da rendere evidenti le caratteristiche<br />
genetiche <strong>del</strong>la popolazione preesistenti all’<strong>in</strong>tervento selvicolturale e quelle <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse<br />
componenti sociali che concorrono alla formazione <strong>del</strong>l’attuale fustaia transitoria. Di conseguenza<br />
gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui analizzati sono stati <strong>di</strong>visi <strong>in</strong> 3 gruppi demografici, <strong>di</strong> cui il secondo, quello relativo alla<br />
componente <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e agamica, <strong>in</strong> due sottogruppi o sotto-classi sociali:<br />
1. – la popolazione totale <strong>di</strong> Fontalc<strong>in</strong>aldo, costituita dalle 107 piante campionate, che<br />
rappresenta il ceduo matric<strong>in</strong>ato preesistente all’<strong>in</strong>tervento selvicolturale;<br />
2. – la componente <strong>di</strong> ceduo semplice, formata dai polloni <strong>del</strong>le ceppaie dom<strong>in</strong>anti, codom<strong>in</strong>anti<br />
e dom<strong>in</strong>ate 5 . E’ importante sottol<strong>in</strong>eare che parte dei polloni costituiscono anche la fustaia<br />
transitoria dopo il primo <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> avviamento all’alto fusto. Essi hanno, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, la doppia veste<br />
<strong>di</strong> “fotografia” <strong>del</strong> ceduo semplice (<strong>di</strong> cui rappresentano le ceppaie) e <strong>del</strong>la fustaia transitoria, la cui<br />
struttura sociale è stata sud<strong>di</strong>visa nelle seguenti sottoclassi:<br />
2.1 – la sotto-classe dom<strong>in</strong>ata;<br />
2.2 – la sotto-classe dom<strong>in</strong>ante (<strong>in</strong>clusi i 6 <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui codom<strong>in</strong>anti);<br />
3. – la componente <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e (tutte le classi <strong>di</strong> età).<br />
L’analisi dei parametri <strong>del</strong>la <strong>di</strong>versità <strong>in</strong>terna al gruppo (componente1) ha avuto lo scopo <strong>di</strong><br />
conoscere la situazione <strong>in</strong>iziale <strong>del</strong>la struttura genetica prima <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento, esattamente<br />
nelle stesse con<strong>di</strong>zioni microstazionali <strong>in</strong> cui viene condotto l’esperimento colturale.<br />
Le analisi sulle altre componenti <strong>del</strong> soprassuolo, polloni nel loro complesso (componente 2),<br />
successivamente sud<strong>di</strong>visi per classi sociali (componente “vegetativa”) e matric<strong>in</strong>e (componente<br />
“generativa”), hanno avuto per scopo una stima <strong>del</strong>la variabilità genetica <strong>del</strong>la fustaia transitoria<br />
dopo il primo taglio <strong>di</strong> avviamento. I parametri genetici dei <strong>di</strong>versi gruppi sociali sono stati <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />
confrontati tra loro e con la popolazione totale <strong>di</strong> “Fontalc<strong>in</strong>aldo”, <strong>in</strong>tesa come situazione <strong>in</strong>iziale <strong>di</strong><br />
riferimento.<br />
Discussione<br />
E’ op<strong>in</strong>ione <strong>di</strong>ffusa che, <strong>in</strong> un ceduo matric<strong>in</strong>ato, la componente sottoposta correntemente a<br />
ceduazione, quella cioè che produce polloni, sia la sola ad avere orig<strong>in</strong>e vegetativa. Le matric<strong>in</strong>e<br />
deriverebbero <strong>in</strong>vece <strong>in</strong> buona parte da r<strong>in</strong>novazione naturale per seme e dovrebbero provvedere<br />
a re<strong>in</strong>tegrare, tramite la <strong>di</strong>spersione, la quota <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità <strong>del</strong>la popolazione che via via va perduta.<br />
5 A questo proposito è tipicamente presente nella popolazione dei polloni una situazione <strong>di</strong> concorrenza <strong>in</strong>traspecifica<br />
asimmetrica, che riflette anche la preesistente situazione tra ceppaie <strong>di</strong> appartenenza (PIUSSI 1994).
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
Esse dovrebbero, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, dare orig<strong>in</strong>e a nuove piante, che dovrebbero sostituire le ceppaie esaurite<br />
e le matric<strong>in</strong>e stesse dopo l’utilizzazione (PAVARI 1953). E’ noto tuttavia che nella maggior parte dei<br />
casi questa <strong>di</strong>namica non sia rispettata (PIUSSI op. cit.), dal momento che le matric<strong>in</strong>e non<br />
giungono mai alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong> loro ciclo bio-ecologico naturale e non si verifica quasi mai la possibilità<br />
<strong>di</strong> produrre, per crollo, le ampie chiarie che, <strong>in</strong> genere, danno orig<strong>in</strong>e a situazioni microambientali<br />
ideali per l’affermarsi <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione. Il ceduo sottostante le matric<strong>in</strong>e tenderà, <strong>in</strong>fatti, a<br />
soffocare lo sviluppo dei semenzali e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la possibilità <strong>di</strong> garantire un regolare apporto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versità “fresca”. I semi <strong>del</strong>le querce coprono <strong>di</strong> solito <strong>di</strong>stanze relativamente brevi a causa <strong>del</strong><br />
loro peso. Esse, dunque, costituiscono l’elemento più “lento” <strong>del</strong> <strong>di</strong>namismo genetico legato alla<br />
<strong>di</strong>spersione <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>formazione genetica. A questo può porre rime<strong>di</strong>o il movimento <strong>di</strong> semi su lunghe<br />
<strong>di</strong>stanze determ<strong>in</strong>ato dagli animali (<strong>in</strong> genere piccoli mammiferi). Le riserve <strong>di</strong> cibo che essi creano<br />
frequentemente f<strong>in</strong>iscono col germ<strong>in</strong>are (KREMER et al. 2002).<br />
Un’altra fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità è il poll<strong>in</strong>e, che rappresenta sicuramente l’elemento più <strong>di</strong>namico ai<br />
f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la <strong>di</strong>spersione. Altro elemento decisamente “statico” dal punto <strong>di</strong> vista genetico, almeno per<br />
tempi lunghi, è il soprassuolo. Il governo a ceduo è ormai reiterato da generazioni nella zona e le<br />
ceppaie rappresentano una situazione “rallentata”, dal punto <strong>di</strong> vista genetico, che può aver avuto<br />
avvio qualche cent<strong>in</strong>aio <strong>di</strong> anni ad<strong>di</strong>etro. In questo lungo lasso <strong>di</strong> tempo, la possibilità che nuove<br />
piante e matric<strong>in</strong>e nate da seme si afferm<strong>in</strong>o <strong>in</strong> gran quantità, contribuendo alla <strong>di</strong>versificazione e<br />
al <strong>di</strong>namismo genetico <strong>del</strong>la foresta, sembrano scarse per quanto detto sopra. Anzi, via via che la<br />
concorrenza tra ceppaie perdura, si assiste ad una loro lenta ma progressiva per<strong>di</strong>ta. Inoltre, la<br />
densità <strong>del</strong> ceduo fa sì che le plantule non abbiano possibilità <strong>di</strong> affermarsi per la concorrenza con<br />
la componente agamica, anche se dopo il taglio si verifica una pronta germ<strong>in</strong>azione (CANTIANI et al<br />
2006, BECAGLI et a. 2006)). Inf<strong>in</strong>e, può contribuire negativamente anche l’elevato carico <strong>di</strong> fauna<br />
selvatica, sottraendo ghiande e pascolando sia la r<strong>in</strong>novazione che i germogli <strong>del</strong>le ceppaie.<br />
Relativamente agli aspetti genetici è possibile notare alcuni fenomeni connessi con la struttura<br />
<strong>del</strong> soprassuolo.<br />
I livelli <strong>di</strong> omozigosi sono elevati rispetto a quelli <strong>di</strong> altre querce. Questo risultato può essere<br />
determ<strong>in</strong>ato dalle caratteristiche <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seche alla popolazione presa <strong>in</strong> esame che, per qualche<br />
ragione pregressa, ha acquisito questa caratteristica.<br />
La componente <strong>di</strong> ceduo semplice, estrapolata dalla popolazione complessiva <strong>di</strong> Fontalc<strong>in</strong>aldo,<br />
presenta gli stessi valori <strong>di</strong> questa , se, però, si vanno ad esam<strong>in</strong>are le matric<strong>in</strong>e, sembra che<br />
l’omozigosi <strong>in</strong> parte si riduca. La maggiore <strong>di</strong>versità nella componente dei polloni si riscontra nella<br />
classe sociale dom<strong>in</strong>ata. I polloni scelti per costituire la fustaia transitoria e le matric<strong>in</strong>e derivano <strong>in</strong><br />
gran parte da turni colturali <strong>di</strong>versi <strong>del</strong>la popolazione, ma quasi tutti hanno probabilmente avuto<br />
orig<strong>in</strong>e da una struttura forestale cristallizzata da lungo tempo, sotto forma <strong>di</strong> ceppaie ceduate. Le<br />
matric<strong>in</strong>e, derivando almeno parzialmente da seme, dovrebbero essere caratterizzate da maggiore<br />
<strong>di</strong>versità; <strong>in</strong>vece il ridotto livello <strong>di</strong> ricchezza allelica e <strong>di</strong> polimorfismo che presentano,<br />
analogamente ai polloni dom<strong>in</strong>anti, <strong>in</strong><strong>di</strong>cano che i vantaggi <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> questo senso<br />
sono limitati. La ricchezza allelica dei vari livelli sembra essere un buon <strong>in</strong><strong>di</strong>catore <strong>di</strong> erosione<br />
genetica relativamente agli scopi <strong>del</strong> nostro lavoro. Il significato <strong>di</strong> questa constatazione è<br />
rafforzato dal fatto che gli alleli assenti, rari e quasi rari solo <strong>in</strong> m<strong>in</strong>ima parte sono gli stessi nei<br />
<strong>di</strong>versi strati sociali esam<strong>in</strong>ati.<br />
Le matric<strong>in</strong>e, risalenti a turni precedenti, sono state probabilmente scelte sulla base <strong>di</strong> una<br />
selezione fenotipica relativamente rigorosa. I cedui <strong>del</strong>le Coll<strong>in</strong>e Metallifere erano, <strong>in</strong>fatti, impiegati<br />
non solo per la produzione <strong>di</strong> legna da ardere ma anche <strong>di</strong> puntelli da m<strong>in</strong>iera. Questi dovevano<br />
rispondere a requisiti <strong>di</strong> forma e qualità tecnologica molto severi. Dai dati ottenuti sembra che la<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità allelica <strong>in</strong>dotta dalla selezione, per quanto determ<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> maniera casuale per<br />
gli aspetti genetici, sia stata <strong>in</strong> questo strato piuttosto elevata e che si sia tradotta, tra l’altro, <strong>in</strong> un<br />
<strong>in</strong>cremento <strong>di</strong> omozigosi. Come sopra accennato, un possibile <strong>in</strong><strong>di</strong>catore <strong>di</strong> questo stato è dato<br />
dall’elevato numero <strong>di</strong> alleli, rari, assenti e/o quasi rari, rilevato nella classe <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, che<br />
denota un forte impoverimento rispetto alla situazione complessiva <strong>del</strong> ceduo matric<strong>in</strong>ato.<br />
La scelta dei polloni da dest<strong>in</strong>are alla fustaia transitoria è stata <strong>in</strong>vece meno restrittiva, essendo<br />
venuti meno i requisiti per le m<strong>in</strong>iere <strong>del</strong>la zona ed essendo necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una elevata<br />
densità <strong>di</strong> piante ad ettaro.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista genetico la classe sociale migliore nella fustaia <strong>di</strong> transizione è quella <strong>del</strong>le<br />
piante dom<strong>in</strong>ate. Infatti, grazie al maggior numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> alleli per locus, al grado <strong>di</strong> polimorfismo<br />
ed eterozigosi maggiori, essa costituisce una riserva <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazione genetica potenzialmente utile<br />
per il futuro bosco. La parte <strong>di</strong> popolazione costituita dai polloni dom<strong>in</strong>ati è probabilmente più ricca<br />
111
112<br />
Paolo Cantiani<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>versità sia perché numericamente più consistente (qu<strong>in</strong><strong>di</strong> con maggiori probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />
<strong>di</strong> <strong>in</strong>formazione), sia perché <strong>in</strong>cluderebbe materiale orig<strong>in</strong>ato da ceppaie cronologicamente e<br />
geneticamente più prossime alla fustaia (geneticamente più ricca) da cui il ceduo fu <strong>in</strong>izialmente<br />
orig<strong>in</strong>ato. Molte <strong>di</strong> queste sarebbero dom<strong>in</strong>ate semplicemente perché hanno perduto vigore,<br />
avviandosi alla conclusione <strong>del</strong> loro ciclo biologico. Altre ceppaie/polloni, anche se più giovani,<br />
sarebbero <strong>in</strong>vece meno competitive per caratteristiche adattative proprie.<br />
Anche se questa classe sociale è quella meno idonea a perpetuarsi nella fustaia transitoria (il<br />
cerro per l’autoecologia <strong>del</strong>la specie non sopporta per lunghi perio<strong>di</strong> la scarsità <strong>di</strong> luce determ<strong>in</strong>ata<br />
dall’affermarsi <strong>di</strong> un piano dom<strong>in</strong>ante tendenzialmente monoplano), tuttavia la variabilità genetica<br />
che contiene costituisce un potenziale importante cui la popolazione potrebbe att<strong>in</strong>gere.<br />
Compatibilmente con la realizzazione dei <strong>di</strong>radamenti che <strong>in</strong>teresseranno successivamente la<br />
fustaia transitoria, parte <strong>del</strong>la popolazione dom<strong>in</strong>ata dovrebbe essere conservata, anche se le<br />
possibilità che alcuni <strong>di</strong> questi <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui arriv<strong>in</strong>o a <strong>di</strong>ssem<strong>in</strong>are <strong>in</strong> maniera significativa quando il<br />
soprassuolo andrà <strong>in</strong> r<strong>in</strong>novazione sono scarse. Essa potrà, tuttavia, produrre piccole quantità <strong>di</strong><br />
ghiande e <strong>di</strong> poll<strong>in</strong>e che saranno vettori <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità e variabilità all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la popolazione stessa.<br />
I polloni <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse classi sono tutti relativamente giovani (34 anni circa), ma è necessario<br />
ricordare che appartengono a ceppaie orig<strong>in</strong>ate da ceduazioni precedenti. Rappresentano, perciò,<br />
una generazione molto più anziana, a struttura “statica” dal punto <strong>di</strong> vista genetico, che ha già<br />
subito una progressiva erosione, a causa <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione da seme quasi assente. Questo può<br />
spiegare perché i vari parametri presi <strong>in</strong> considerazione <strong>in</strong><strong>di</strong>ch<strong>in</strong>o tutti un impoverimento<br />
progressivamente più <strong>in</strong>tenso via via che si sale nelle classi sociali. Il seme è prodotto soprattutto<br />
dallo strato dom<strong>in</strong>ante (<strong>in</strong> grado <strong>di</strong> catturare energia sufficiente), ma i semenzali non sono stati <strong>in</strong><br />
grado <strong>di</strong> partecipare alla r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong> bosco e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, non hanno favorito la variabilità genetica<br />
legata alla riproduzione gamica.<br />
In def<strong>in</strong>itiva, dai risultati ottenuti sembra che effettivamente la forma <strong>di</strong> governo a ceduo tenda<br />
ad impoverire la variabilità <strong>del</strong> soprassuolo, soprattutto per quanto riguarda la ricchezza allelica.. Al<br />
loro <strong>in</strong>terno, almeno sulla base <strong>di</strong> questo caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o che ha considerato una popolazione <strong>del</strong>la<br />
Toscana, sembra che la classe dei polloni nel suo <strong>in</strong>sieme e quella dom<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> particolare,<br />
contengano la maggior riserva <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità nella popolazione. I polloni dom<strong>in</strong>anti e le matric<strong>in</strong>e ne<br />
<strong>di</strong>spongono <strong>in</strong> misura m<strong>in</strong>ore, compensata nei primi, da un lieve maggior livello <strong>di</strong> eterozigosi, che<br />
tuttavia non <strong>di</strong>fferisce significativamente dall’altra categoria (polloni dom<strong>in</strong>anti). Nella situazione <strong>di</strong><br />
Fontalc<strong>in</strong>aldo la sovrapposizione <strong>di</strong> cluster genotipici è grande e costituisce un elemento positivo,<br />
poichè pre<strong>di</strong>spone la futura fustaia ad un buon rimescolamento <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>formazione genetica,<br />
favorevole alle generazioni future. In una situazione morfologica <strong>del</strong> terreno simile a quella <strong>di</strong><br />
Capriano <strong>del</strong> Colle (BS) precedentemente descritta, il selvicoltore non può <strong>in</strong>vece fruire <strong>di</strong> questo<br />
aspetto positivo e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> si troverà costretto ad <strong>in</strong>tervenire culturalmente con piantagioni <strong>di</strong><br />
materiali trasferiti da zone <strong>di</strong>verse <strong>del</strong>la popolazione, per operare artificialmente questo<br />
rimescolamento.<br />
Le matric<strong>in</strong>e non sembrano <strong>in</strong>vece avere tutta l’importanza loro attribuita a priori; sono senza<br />
dubbio un elemento che partecipa alla r<strong>in</strong>novazione, ma sono soprattutto i polloni a contribuire <strong>in</strong><br />
maggior misura alla <strong>di</strong>versità <strong>del</strong> soprassuolo.<br />
Dai risultati sembra che la pressione selettiva esercitata sugli strati sociali dom<strong>in</strong>anti riduca,<br />
anche se <strong>in</strong> maniera casuale, la <strong>di</strong>versità e si può ipotizzare che ciò possa riflettersi sulla struttura<br />
genetica futura.<br />
Alcune <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni operative che si possono trarre da questa <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, riguardano alcuni<br />
accorgimenti ai possibili trattamenti <strong>di</strong> queste formazioni. Nella gestione <strong>del</strong> ceduo l’allungamento<br />
<strong>del</strong> turno tende a selezionare con la competizione naturale le ceppaie dom<strong>in</strong>anti a scapito <strong>di</strong> quelle<br />
<strong>di</strong> m<strong>in</strong>or vigoria. Ciò può favorire nel tempo un impoverimento sia <strong>del</strong>la composizione specifica <strong>del</strong><br />
ceduo orig<strong>in</strong>ario, sia <strong>del</strong>la variabilità <strong>del</strong>le ceppaie <strong>di</strong> cerro nel popolamento. Il trattamento <strong>di</strong><br />
avviamento all’alto fusto dei cedui <strong>di</strong> cerro prevede la selezione dei polloni più vigorosi dalle<br />
ceppaie dom<strong>in</strong>anti. Anche questo trattamento, che anticipa <strong>di</strong> fatto la naturale selezione dei polloni<br />
nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica naturale al cessare <strong>del</strong>la ceduazione, sembra causare nel tempo un<br />
impoverimento <strong>del</strong>la struttura genetica <strong>del</strong> ceduo. Sarebbe qu<strong>in</strong><strong>di</strong> auspicabile <strong>di</strong>versificare<br />
strutturalmente il popolamento transitorio, lasciando spazio anche alla componente dom<strong>in</strong>ata, che<br />
contiene variabilità genetica <strong>in</strong> quantità più elevata, probabilmente risalente alla maggiore<br />
<strong>di</strong>versificazione cronologica <strong>del</strong>le ceppaie. A questo scopo, e sulla base dei risultati ottenuti,<br />
sembrerebbe auspicabile ridurre l’estensione <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> superficie degli <strong>in</strong>terventi colturali,
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
cercando piuttosto <strong>di</strong> realizzare un mosaico <strong>di</strong> tagli <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso tipo, che consenta la partecipazione<br />
alla costruzione <strong>del</strong> pool genico futuro (<strong>del</strong>la fustaia def<strong>in</strong>itiva) <strong>di</strong> tutte le componenti strutturali.<br />
Per <strong>in</strong>crementare l’<strong>in</strong>formazione sul <strong>di</strong>namismo genetico <strong>del</strong>la popolazione <strong>di</strong> cerro stu<strong>di</strong>ata, è<br />
necessario ampliare l’analisi <strong>del</strong>la fustaia transitoria e <strong>del</strong>la componente gamica. Di questa i semi<br />
rappresentano un elemento <strong>di</strong>namico <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse generazioni r<strong>in</strong>tracciabili nella popolazione e<br />
forniscono <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni sull’effettivo scambio tra le <strong>di</strong>verse classi presenti nel soprassuolo. Sarà<br />
dunque su questa categoria riproduttiva che si dovrà concentrare l’attenzione, perché è attraverso<br />
essa che potranno affermarsi le generazioni future, portatrici <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità e variabilità <strong>in</strong> grado <strong>di</strong><br />
sostenere la fustaia def<strong>in</strong>itiva nel tempo.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV., 2004 – Comune <strong>di</strong> Montieri. Piano strutturale. Relazione illustrativa.<br />
www.webgis.<strong>in</strong>fo.montieri<br />
AMORINI E., BRUSCHINI S., CUTINI A., DI LORENZO M.G., FABBIO G., 1996 – Treatment of Turkey oak<br />
(Quercus cerris L.) coppices. Structure, biomass and silvicultural options. Ann. Ist. Sper. per la<br />
Selv. Arezzo. (27): 121-130.<br />
AMORINI E., CANTIANI P, FABBIO G., 2002, - Pr<strong>in</strong>cipali valutazioni sulla risposta degli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori<br />
dendrometrici e strutturali <strong>in</strong> querceti decidui <strong>del</strong>l’Umbria sottoposti a <strong>di</strong>verso trattamento<br />
selvicolturale. In: Ferretti M, Frattegiani M, Grohmann F, Sav<strong>in</strong>i P. (a cura <strong>di</strong>). Il Progetto<br />
TraSFoRM. Regione <strong>del</strong>l’Umbria.<br />
AMORINI E., BRANDINI P., FABBIO G., TABACCHI G., 1998 – Mo<strong>del</strong>li previsionali <strong>del</strong>le masse legnose e<br />
<strong>del</strong>le biomasse per i cedui <strong>del</strong>la Toscana centro-meri<strong>di</strong>onale. Ann. Ist. Sper. per la Selv.<br />
Arezzo. (29): 30-40.<br />
BARAGATTI E., FRATI L., CHIARUCCI A., 2006 – Cambiamenti nella <strong>di</strong>versità <strong>del</strong>la vegetazione <strong>in</strong><br />
seguito a <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> boschi <strong>di</strong> cerro. Annali Istituto Sperimentale per la<br />
Selvicoltura Arezzo XXXIII: 39-50.<br />
BECAGLI C., CANTIANI P., FABBIO G., 2006 – Trattamento sperimentale <strong>in</strong> un ceduo composto <strong>di</strong><br />
roverella e leccio <strong>del</strong> Chianti senese. Primi risultati. Annali Istituto Sperimentale per la<br />
Selvicoltura Arezzo XXXIII: 31-38.<br />
BECHETTI M., GIOVANNINI G., 1998 – La matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> cerro: <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong><br />
Perugia. Sherwood. Foreste e alberi oggi. (34): 21-27.<br />
BENVENUTI C., CANTIANI P. 2003 – Il trattamento selvicolturale <strong>del</strong>le fustaie transitorie <strong>di</strong> cerro.<br />
Interventi propedeutici alla fase <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione. <strong>Atti</strong> IV Congresso SISEF: 27-31.<br />
BERNETTI G., 1995 – Selvicoltura speciale. UTET. Tor<strong>in</strong>o.<br />
BERNETTI G., 1999 – Conseguenze <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> querce (Quercus cerris L. e<br />
quercus pubescens Willd.) <strong>di</strong> buona fertilità con turno superiore a 15 anni . Monti e Boschi (2):<br />
30-31.<br />
BERNETTI G., MONDINO G. P., 1998 - I tipi forestali. Boschi e macchie <strong>di</strong> Toscana. Regione Toscana<br />
- Giunta Regionale.<br />
CANTIANI P, AMORINI E., PIOVOSI M., 2006, - Effetti <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura sulla<br />
ricostituzione <strong>del</strong>la copertura e sull’accrescimento dei polloni <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro.<br />
Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Arezzo XXXIII: 9-20.<br />
CANTIANI P, FERRETTI M, FRATTEGIANI M, GROHMANN F, SAVINI P., 2002, - Il <strong>di</strong>segno sperimentale <strong>del</strong><br />
progetto TraSFoRM. In: Ferretti M, Frattegiani M, Grohmann F, Sav<strong>in</strong>i P. (a cura <strong>di</strong>). Il Progetto<br />
TraSFoRM. Regione <strong>del</strong>l’Umbria.<br />
CIANCIO O., MERCURIO R., NOCENTINI S., ECCHER A., 1983 – Tecniche <strong>di</strong> miglioramento e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
conversione e trasformazione. L’Italia Agricola. 120 (4): 77-86.<br />
CIANCIO O., NOCENTINI S., 2004 – Il bosco ceduo. Selvicoltura, Assestamento, Gestione.<br />
Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze Forestali. Firenze<br />
CORONA P., LA MARCA O., SCHIRONE B., 1986 – Ricerche sull’ottimizzazione <strong>del</strong>la <strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la<br />
matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> cerro: I – Il ceduo composto a maturità. Ann. Acc. It. Sc. For.. Vol.<br />
(35): 123-158.<br />
CUTINI A, 2006 - Taglio <strong>di</strong> avviamento, ceduazione e matric<strong>in</strong>atura: effetti sulle caratteristiche <strong>del</strong>la<br />
copertura forestale <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro. Annali Istituto Sperimentale per la<br />
Selvicoltura Arezzo XXXIII: 21-30.<br />
CUTINI A., AMORINI E., CASTELLUCCI E., 2005 - Rapporto bosco-fauna selvatica: impatto sulla<br />
r<strong>in</strong>novazione <strong>in</strong> boschi <strong>di</strong> latifoglie. S.I.S.E.F. <strong>Atti</strong> 4: 193-199.<br />
113
114<br />
Paolo Cantiani<br />
D.R.E.AM., - 1994 Piano <strong>di</strong> Gestione Forestale 1994-2003. Complesso forestale “Ban<strong>di</strong>te <strong>di</strong><br />
Follonica”.Regione Toscana. Comunità Montana “Coll<strong>in</strong>e Metallifere”.<br />
DUCCI F., PROIETTI R., CANTIANI P., 2006 – Struttura genetica e sociale <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro <strong>in</strong><br />
conversione. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura Arezzo XXXIII: 143-158.<br />
FAGARAZZI C., FRATINI R., RICCIOLI F., 2006 – Valutazione <strong>del</strong>la funzione paesaggistica <strong>del</strong>le fustaie<br />
transitorie <strong>di</strong> cerro nel territorio <strong>del</strong>le Coll<strong>in</strong>e Metallifere. Annali Istituto Sperimentale per la<br />
Selvicoltura Arezzo XXXIII: 169-186.<br />
FIORUCCI E., 2009 – Le matric<strong>in</strong>e nei boschi cedui: le attuali regole <strong>di</strong> rilascio sono ancora valide?<br />
Forest@ (6): 56-65.<br />
GALIANO C., 1992 – La determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la classe <strong>di</strong> fertilità nei boschi <strong>di</strong> querce. Università <strong>di</strong><br />
Firenze. Istituto <strong>di</strong> Selvicoltura. Tesi <strong>di</strong> laurea n° 779.<br />
GROHMANN F., SAVINI P., FRATTEGIANI M., 2002 – La matric<strong>in</strong>atura per gruppi. L’esperienza <strong>del</strong><br />
progetto SUMMACOP. Sherwood. Foreste e alberi oggi. (80): 25-32.<br />
GIOVANNINI G., CHINES A., GANDOLFO G., 2003 – Danni da ungulati selvatici <strong>in</strong> boschi cedui. Effetti<br />
<strong>del</strong>le modalità <strong>di</strong> utilizzazione forestale. Sherwood. Foreste e alberi oggi. (85): 9-20.<br />
HIPPOLITI G., 2001 – Sul governo a ceduo <strong>in</strong> Italia (XIX-XX sec.). In Storia e risorse forestali. A cura<br />
<strong>di</strong> M. Agnoletti. AISF, pp. 353-374.<br />
KREMER A., REMI-PETIT J., DUCOUSSO A., 2002 – Biologie évolutive et <strong>di</strong>versité génétique des<br />
Chênes sessile et pédonculé. Rev. For. Fr., 2 : 111 – 130.<br />
LA MARCA O., MATTIOLI M., IORIO G., 1987 – Ricerche sull’ottimizzazione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura nei<br />
cedui <strong>di</strong> cerro. II contributo: il soprassuolo arboreo nei primi due anni <strong>del</strong> ciclo produttivo. Ann.<br />
Acc. It. Sc.For. (36): 3-33<br />
LA MARCA O., 1991 – Stu<strong>di</strong> e ricerche sull’ottimizzazione <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura nei boschi cedui. L’It.<br />
For. e Mon. (2): 118-132.<br />
LA MARCA O., MARZILIANO : A., SCOTTI R., 1996 – Effects of standard density on coppice structure<br />
development: evaluation 14 year after coppic<strong>in</strong>g <strong>in</strong> a Turkay oak experimental trial. Ann. Ist.<br />
Sper. per la Selv. Arezzo. (27): 161-166.<br />
MAETZKE F., TORRINI L., 1996 – Osservazioni sperimentali sull’effetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>in</strong>tensità <strong>di</strong><br />
matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> cerro <strong>del</strong>la prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Viterbo. L’It. For. e Mon. (6): 411-421.<br />
MAGINI E., 1967 - Ricerche sui fattori <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong>l’abete bianco sull’Appenn<strong>in</strong>o. It. For.<br />
Mont., XXII, 3: 126-147.<br />
MERENDI A., 1942 – Boschi cedui e matric<strong>in</strong>atura. La Rivista Forestale Italiana (1-3): 33-36.<br />
PAVARI A. - 1953 – Governo e trattamento dei boschi. REDA, Bologna.<br />
PISCINA N., 1995-96 – Effetti dei <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> esbosco sull’evoluzione dei cedui. Risultati <strong>di</strong> una<br />
prova sperimentale al Passo <strong>del</strong> Brattello (PR). Tesi <strong>di</strong> Laurea. Facoltà <strong>di</strong> Agraria. Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Firenze. In Ciancio O., Nocent<strong>in</strong>i S., 2004 – Il bosco ceduo. Selvicoltura,<br />
Assestamento, Gestione. Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze Forestali. Firenze<br />
PIUSSI P., 1994 – Selvicoltura generale. UTET. Tor<strong>in</strong>o<br />
URBINATI C.,2009 - Foreste <strong>in</strong> forma. La gestione sostenibile nei boschi <strong>del</strong>le Marche. 159 p.<br />
ZANZI SULLI A., DI PASQUALE G., 1993 – Funzioni <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e dei cedui nella teoria
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
116<br />
Paolo Cantiani
Selvicoltura <strong>del</strong>le cerrete (prove <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura e conversione)<br />
117
118<br />
Paolo Cantiani
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
SELVICOLTURA DEI CEDUI DI CASTAGNO<br />
MARIA CHIARA MANETTI<br />
CRA-SEL, CENTRO DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA, AREZZO
120<br />
IL PROBLEMA CASTAGNO<br />
Maria Chiara Manetti<br />
Il castagno (Castanea sativa Mill.) ha assunto <strong>in</strong> passato ed assume ancora oggi un ruolo<br />
prem<strong>in</strong>ente tra le formazioni forestali italiane, non solo per l’elevata produttività, la qualità e la<br />
varietà degli assortimenti legnosi ma soprattutto per la consistente presenza sul territorio<br />
nazionale; é <strong>in</strong>fatti <strong>di</strong>ffuso dalle Alpi alla Sicilia, spesso <strong>in</strong> comprensori estesi per l’<strong>in</strong>tensa<br />
<strong>di</strong>ffusione e coltivazione cui è stata sottoposto f<strong>in</strong>o al recente passato.<br />
L’evoluzione storica <strong>del</strong>la castanicoltura <strong>in</strong> Italia, <strong>in</strong> relazione alle variazioni <strong>di</strong> superficie e al tipo<br />
<strong>di</strong> governo e trattamento, fornisce un <strong>in</strong>teressante strumento <strong>di</strong> analisi per la valutazione <strong>del</strong>le<br />
con<strong>di</strong>zioni sociali ed economiche nelle aree montane e coll<strong>in</strong>ari. F<strong>in</strong>o alla metà <strong>del</strong> XX secolo il<br />
castagno, sia da frutto che da legno, forniva prodotti <strong>di</strong> fondamentale importanza per l’economia e<br />
la sussistenza <strong>del</strong>le popolazioni; nel 1950 i dati ISTAT riportano superfici pari a 447.000 ha per i<br />
castagneti da frutto e 275.186 ha per i cedui (Boggia 1986). Successivamente, profon<strong>di</strong> mutamenti<br />
economici e sociali (dall’esodo rurale al cambiamento <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> alimentazione, dalla sostituzione<br />
<strong>del</strong> tann<strong>in</strong>o con sostanze s<strong>in</strong>tetiche al decl<strong>in</strong>o <strong>del</strong>la richiesta <strong>del</strong> palo da vite e telegrafico) e la<br />
comparsa <strong>del</strong>le fitopatologie (Cryphonectria parasitica e Phitophtora cambivora) hanno<br />
notevolmente mo<strong>di</strong>ficato le modalità <strong>di</strong> coltivazione <strong>del</strong>la specie e determ<strong>in</strong>ato la ceduazione <strong>di</strong><br />
gran parte dei castagneti da frutto. Attualmente (IFNC 2007) la superficie castanicola totale<br />
ammonta a 788.408 ha <strong>di</strong> cui 147.586 ha da frutto e 605.888 ha da legno.<br />
Il "problema castagno" con tutte le implicazioni connesse <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne patologico, economicosociale<br />
ed ecologico, fu affrontato a livello europeo già nel 1951 quando si ritenne opportuno<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>viduare una Commissione Internazionale <strong>di</strong> Esperti per def<strong>in</strong>ire le l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> un possibile recupero<br />
o mutamento nella dest<strong>in</strong>azione d’uso <strong>di</strong> gran parte dei soprassuoli. Il problema comune a tutti i<br />
paesi <strong>in</strong>teressati (dal Portogallo alla Turchia) era all’epoca il degrado dei castagneti da frutto a<br />
causa <strong>del</strong>le patologie e parzialmente per l’esodo rurale che, se <strong>in</strong> Italia era praticamente agli <strong>in</strong>izi,<br />
<strong>in</strong> Francia era <strong>in</strong> atto già dalla seconda metà <strong>del</strong> 1800 (Amor<strong>in</strong>i e Manetti 2002). Nel corso <strong>del</strong>le<br />
varie sessioni (Commission Internationale du Chataigner 1953; 1955; 1958) i temi trattati<br />
riguardavano pr<strong>in</strong>cipalmente l’ecologia <strong>del</strong>la specie, la sua <strong>di</strong>stribuzione territoriale <strong>in</strong> Europa, la<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le patologie unitamente ai meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa o prevenzione, l’utilizzazione dei prodotti<br />
legnosi, la conservazione <strong>del</strong>le castagne e la def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> politica generale. In s<strong>in</strong>tesi i<br />
risultati più <strong>in</strong>teressanti <strong>del</strong> lavoro <strong>del</strong>la Commissione furono la realizzazione <strong>del</strong>la carta <strong>del</strong>la<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong> castagno (Commission Internationale du Chataigner 1958) e alcune <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne generale per rilanciare la castanicoltura nelle aree ecologicamente favorevoli o per rivedere<br />
la politica <strong>di</strong> utilizzazione <strong>del</strong>le terre. Innanzitutto fu rilevato che la riduzione <strong>del</strong>la superficie<br />
castanicola era <strong>in</strong>evitabile e che risultava necessario razionalizzare la gestione verso due <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi<br />
produttivi ben def<strong>in</strong>iti - legno e frutto. La produzione <strong>del</strong> frutto doveva essere limitata alle zone<br />
ecologicamente migliori ed economicamente più produttive, operando secondo meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
coltivazione <strong>in</strong>tensiva e selezionando varietà resistenti alle patologie. Negli altri casi era opportuno<br />
operare o la conversione <strong>in</strong> ceduo - dove l’<strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong>le malattie si presentava particolarmente<br />
virulenta - o il cambiamento nella dest<strong>in</strong>azione d’uso <strong>del</strong> suolo <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni<br />
economiche locali (agricoltura, pastorizia, sostituzione con specie <strong>di</strong> elevata produttività).<br />
La Commissione Internazionale fu abolita dalla FAO nel 1961 ma contemporaneamente venne<br />
istituito, soprattutto per le pressioni esercitate da Francia, Italia e Svizzera, un gruppo <strong>di</strong> lavoro sul<br />
castagno all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la Commissione Europea <strong>del</strong>le Foreste. Le motivazioni che portarono a tale<br />
risoluzione erano <strong>in</strong>centrate pr<strong>in</strong>cipalmente sul ruolo <strong>del</strong> castagno, non più <strong>di</strong> primo piano<br />
nell’economia <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione, e sulla consapevolezza che il problema era <strong>in</strong>centrato non<br />
più sulle modalità <strong>di</strong> conservazione dei soprassuoli ma sulla loro trasformazione <strong>in</strong> altri tipi <strong>di</strong><br />
coltura forestale. Il gruppo <strong>di</strong> lavoro si riunì una sola volta <strong>in</strong> Francia nel 1962 (Commission<br />
Européenne des Forets 1962) e fu sciolto def<strong>in</strong>itivamente nel 1966. Oltre ai temi affrontati dalla<br />
Commissione, il gruppo <strong>di</strong> lavoro rivolse l’attenzione anche alle modalità <strong>di</strong> gestione dei cedui,<br />
sottol<strong>in</strong>eando la rapida evoluzione <strong>del</strong>la selvicoltura <strong>del</strong> castagno sia per l’aumento <strong>del</strong>le superfici<br />
<strong>di</strong> pert<strong>in</strong>enza <strong>del</strong> ceduo (conversioni da castagneto da frutto) sia per la variazione nella domanda<br />
dei prodotti forniti. La <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> assortimenti <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni aveva<br />
determ<strong>in</strong>ato l’abbandono <strong>del</strong>la pratica dei <strong>di</strong>radamenti; furono così raccomandati stu<strong>di</strong> specifici per<br />
valutare se il ceduo poteva mantenere il ruolo prioritario nell’economia forestale <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ffusione o se, al contrario, fosse più opportuno valorizzare tali superfici con la sostituzione o<br />
l’<strong>in</strong>troduzione <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> maggior valore economico.
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
LA RICERCA IN FUNZIONE DELLA PRODUZIONE LEGNOSA DI QUALITÀ<br />
Dopo un primo periodo, f<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>e degli anni ’60, <strong>in</strong> cui l’attività sperimentale ha <strong>in</strong>teressato<br />
pr<strong>in</strong>cipalmente le possibilità <strong>di</strong> <strong>in</strong>troduzione nei castagneti cedui o da frutto <strong>di</strong> specie considerate<br />
più produttive e meno suscettibili ai problemi fitopatologici, la ricerca si è progressivamente<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzata verso lo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong> trattamento <strong>del</strong> ceduo per <strong>in</strong>crementarne la produzione legnosa<br />
(Moran<strong>di</strong>ni 1966).<br />
L’<strong>in</strong>terrogativo sulla possibilità <strong>di</strong> valorizzare i soprassuoli cedui e la qualità degli assortimenti si<br />
è posto con maggiore evidenza dalla metà degli anni ’70, quasi contemporaneamente <strong>in</strong> Italia e<br />
Francia, paesi caratterizzati da una forte presenza <strong>di</strong> popolamenti <strong>di</strong> età superiore al turno<br />
tra<strong>di</strong>zionale a seguito <strong>del</strong>la crisi dei prodotti tipici <strong>del</strong> ceduo a ciclo breve (Gambi e Amor<strong>in</strong>i 1977;<br />
Cabannes e Rolland 1982). Le soluzioni selvicolturali prospettate erano <strong>in</strong> genere volte sia al<br />
miglioramento <strong>del</strong> ceduo sia alla costituzione <strong>di</strong> soprassuoli a fisionomia <strong>di</strong> fustaia. Nel primo caso<br />
si prevedeva l’allungamento <strong>del</strong> turno f<strong>in</strong>o a 25 anni con l’applicazione <strong>di</strong> 1-2 <strong>di</strong>radamenti precoci e<br />
<strong>di</strong> <strong>in</strong>tensità tale da ottenere con il taglio f<strong>in</strong>ale una <strong>di</strong>screta quantità <strong>di</strong> tronchetti da lavoro<br />
(Bacchetta 1984; Avolio 1987). La seconda opzione selvicolturale (Gambi e Amor<strong>in</strong>i 1978; Vanni<br />
1981; Bourgeois 1987; Gambi 1988; Millot 1990) prevedeva turni variabili da 40 a 70 anni con<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> costituire a f<strong>in</strong>e ciclo un soprassuolo a densità relativamente ridotta (da 150 a 600<br />
piante ad ettaro), caratterizzato da <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> buone <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>ametriche (30-45 cm) idonei alla<br />
produzione <strong>di</strong> assortimenti da sega. L’applicazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti frequenti (5-10 anni) era<br />
con<strong>di</strong>zione fondamentale per migliorare ed esaltare la qualità degli assortimenti f<strong>in</strong>ali. Entrambe le<br />
soluzioni si basavano sulla consapevolezza <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>la specie: rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
accrescimento, forte produttività, buona qualità <strong>del</strong> legno.<br />
Questo complesso <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i è stato tuttavia caratterizzato da approcci puntuali e limitati a<br />
s<strong>in</strong>goli casi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o; il problema <strong>del</strong> trattamento alternativo al ceduo a turno breve è stato<br />
affrontato per la prima volta nella sua complessità da Bourgeois (1992) che evidenziava le<br />
correlazioni tra selvicoltura, tecnologia, biologia ed economia <strong>del</strong>la filiera legno.<br />
Contemporaneamente venivano impostati stu<strong>di</strong> e prove sperimentali (Aumasson e Guerr<strong>in</strong> 1995;<br />
Everard e Christie 1995; Pividori 1995) anche nell’ambito <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> ricerca europei (Forest<br />
1995; Cast 1997; Chesud 2002), il cui obiettivo pr<strong>in</strong>cipale - def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> trattamento<br />
f<strong>in</strong>alizzati alla produzione legnosa <strong>di</strong> qualità - si <strong>in</strong>tegrava con <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i volte a valutare sia l’impatto<br />
degli <strong>in</strong>terventi colturali sulla stabilità e funzionalità dei soprassuoli, sia le valenze ambientali e<br />
paesaggistiche <strong>del</strong>le strutture derivate.<br />
Negli ultimi decenni motivazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne politico, economico e ambientale hanno rilanciato il<br />
castagno come specie <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> fornire assortimenti legnosi <strong>di</strong> pregio e contemporaneamente <strong>di</strong><br />
costituire soprassuoli atti a valorizzare la funzione turistico ricreativa <strong>del</strong> paesaggio forestale<br />
(Pettenella 2001; Manetti et al. 2001; Amor<strong>in</strong>i e Manetti 2002; Pividori et al. 2006). In questa ottica<br />
la def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> trattamento f<strong>in</strong>alizzati a una produzione <strong>di</strong> qualità si è <strong>in</strong>tegrata con<br />
<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i volte a valutare l’impatto degli <strong>in</strong>terventi colturali sulla stabilità e la funzionalità dei<br />
soprassuoli, le valenze ambientali e paesaggistiche, <strong>in</strong> particolare quelle legate alla bio<strong>di</strong>versità nei<br />
castagneti, e i problemi connessi alla filiera e alla qualità <strong>del</strong> legno (Amor<strong>in</strong>i et al. 2000; Gajo e<br />
Marone 2000; Cut<strong>in</strong>i 2001; Rubio e Escudero 2003; Conedera et al. 2004; Manetti et al. 2004;<br />
Gondard et al. 2006; Mattioli et al. 2008; Becagli et al. 2009; Manetti et al. 2009a; Romagnoli e<br />
Sp<strong>in</strong>a 2009; Sp<strong>in</strong>a et al. 2009).<br />
OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL CRA - SEL<br />
L’attività sperimentale <strong>del</strong> CRA-SEL sui cedui <strong>di</strong> castagno è stata avviata nel 1989 con<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> def<strong>in</strong>ire tecniche colturali <strong>in</strong>novative <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> valorizzare le potenzialità <strong>del</strong>la specie<br />
attraverso il miglioramento <strong>del</strong>la qualità dei prodotti, l’aumento <strong>del</strong>la stabilità e <strong>del</strong>la funzionalità dei<br />
soprassuoli, la <strong>di</strong>fferenziazione <strong>del</strong>le strutture e <strong>del</strong> paesaggio.<br />
In questo quadro generale, e nell’ambito <strong>di</strong> progetti nazionali ed europei, sono state affrontate,<br />
anche con l’ausilio <strong>di</strong> unità esterne, tematiche specifiche ed <strong>in</strong> particolare ricerche volte a:<br />
def<strong>in</strong>ire modalità <strong>di</strong> gestione alternative al ceduo a turno breve <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> valorizzare il<br />
potenziale economico <strong>del</strong>la specie e garantire funzionalità e stabilità ai soprassuoli;<br />
valutare le relazioni tra trattamento selvicolturale e strutturazione sociale, accrescimento,<br />
produttività e funzionalità dei popolamenti (sostenibilità ecologica);<br />
121
122<br />
Maria Chiara Manetti<br />
valutare l’applicabilità <strong>di</strong> opzioni selvicolturali <strong>di</strong>fferenti <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la realtà socio-economica<br />
dei territori (sostenibilità socio-economica);<br />
analizzare la funzionalità e l’efficienza dei soprassuoli per determ<strong>in</strong>are e def<strong>in</strong>ire le possibili<br />
potenzialità produttive <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le s<strong>in</strong>gole realtà locali;<br />
def<strong>in</strong>ire le relazioni tra trattamento colturale e cancro corticale, variabilità genetica, <strong>di</strong>fetto <strong>del</strong>la<br />
cipollatura, assortimenti legnosi ritraibili;<br />
comparare la funzionalità e la produttività <strong>del</strong> ceduo semplice e matric<strong>in</strong>ato.<br />
IL CONTESTO ATTUALE<br />
Consistenza <strong>del</strong> patrimonio castanicolo<br />
Il castagno rappresenta una tra le specie più rilevanti nell’esteso panorama <strong>del</strong>le superfici<br />
forestali italiane (pari a 10.467.533 ha, circa 1/3 <strong>del</strong> territorio nazionale - INFC 2004; 2007a;<br />
2007b). I dati <strong>del</strong>l’ultimo <strong>in</strong>ventario forestale nazionale riportano per i castagneti, vale a <strong>di</strong>re la<br />
categoria forestale <strong>in</strong> cui il castagno è la specie prevalente, 788.408 ha pari al 9,2% <strong>del</strong>le superfici<br />
classificate come “bosco alto”. A questi si aggiungono 3.378 ha <strong>di</strong> castagneti censiti nell’ambito<br />
<strong>del</strong>la categoria “altre terre boscate”, quasi equamente ripartiti <strong>in</strong> “boschi bassi”, “boschi ra<strong>di</strong>” e<br />
“boscaglie”. I castagneti italiani sono formazioni ricche <strong>di</strong> biomassa epigea: è stato stimato che<br />
contengano 90.559.828 Mg <strong>di</strong> fitomassa epigea, <strong>di</strong> cui il 76,7 % è nel fusto, il 20,9 % nei rami e il<br />
2,4 % nella ceppaia (INFC 2008). Il dato ad ettaro, 114,9 Mg/ha, è superiore al quello <strong>del</strong><br />
complesso dei boschi alti (101,0 Mg/ha). Dall’INFC emerge <strong>in</strong>oltre che lo stato <strong>di</strong> salute<br />
complessivo dei boschi <strong>di</strong> castagno non è tra i migliori rispetto al complesso <strong>di</strong> tutte le formazioni<br />
forestali italiane: solo il 29,2% è esente da qualunque tipo <strong>di</strong> danno (dato relativo ai boschi alti:<br />
68%); il tipo più <strong>di</strong>ffuso risulta essere quello causato dai parassiti, presenti sul 52,2% dei<br />
soprassuoli a castagno contro 9,1% dei boschi alti.<br />
Secondo l’INFC oltre i 2/3 dei boschi alti <strong>di</strong> castagno (605.868 ha, pari al 76,8%) sono cedui o<br />
soprassuoli ad alto fusto attribuiti alla sottocategoria forestale “castagneti da legno” e il 18,7%<br />
(147.568 ha) sono formazioni <strong>in</strong>cluse <strong>in</strong> quella denom<strong>in</strong>ata “castagneto da frutto, selva castanile”.<br />
Trattamento selvicolturale<br />
Il ceduo matric<strong>in</strong>ato <strong>di</strong> castagno è il tipo <strong>di</strong> trattamento prevalente con turni <strong>di</strong> 15-24 anni,<br />
assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti o raramente 1 a metà turno e rilascio <strong>di</strong> 30-80 matric<strong>in</strong>e ad ettaro. Si tratta<br />
<strong>di</strong> una forma <strong>di</strong> selvicoltura <strong>in</strong>tensiva, orientata a garantire il red<strong>di</strong>to <strong>del</strong> proprietario forestale e<br />
basata sul mantenimento <strong>di</strong> popolamenti monospecifici e coetanei. La partecipazione <strong>di</strong> specie<br />
arboree <strong>di</strong>verse dal castagno è fortemente limitata.<br />
La presenza <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e è una pratica <strong>di</strong>ffusa quasi esclusivamente <strong>in</strong> Italia e giustificata più<br />
dalla consuetu<strong>di</strong>ne che dall’effettivo assolvimento <strong>del</strong>le funzioni attribuite a questa componente<br />
(Manetti et al. 2009b). In primo luogo la vitalità <strong>del</strong>le ceppaie si mantiene f<strong>in</strong>o a tarda età,<br />
l’apparato ra<strong>di</strong>cale è <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> ricostituirsi ad ogni ceduazione e la fruttificazione è precoce:<br />
decade qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la funzione <strong>di</strong> assicurare il ricambio <strong>del</strong>le ceppaie attraverso la r<strong>in</strong>novazione<br />
naturale. In secondo luogo, l’assunto che dalle matric<strong>in</strong>e si possa ottenere legname da lavoro <strong>di</strong><br />
buona qualità non è realistico <strong>in</strong> quanto l’improvviso isolamento, conseguente al taglio <strong>del</strong> ceduo,<br />
con<strong>di</strong>ziona la qualità morfologica <strong>del</strong> fusto e determ<strong>in</strong>a brusche variazioni <strong>del</strong> ritmo <strong>in</strong>crementale,<br />
una <strong>del</strong>la cause pre<strong>di</strong>sponenti il rischio <strong>di</strong> cipollatura. Inf<strong>in</strong>e una matric<strong>in</strong>atura numerosa pregiu<strong>di</strong>ca<br />
la produttività <strong>del</strong> ceduo per l’eccessivo ombreggiamento sui nuovi polloni e, d’altra parte, non<br />
<strong>in</strong>cide sulla copertura <strong>del</strong> suolo che viene comunque assicurata dal rapido accrescimento <strong>del</strong>la<br />
specie.<br />
I cedui <strong>in</strong>vecchiati, prevalenti nelle aree <strong>in</strong> abbandono colturale, sono spesso caratterizzati da<br />
anomalie funzionali e strutturali; l’assenza <strong>di</strong> trattamento e l’elevata competizione hanno <strong>in</strong>fluito<br />
negativamente sull’accrescimento <strong>di</strong>ametrico e sulla qualità <strong>del</strong> legno. I polloni nonostante l’età non<br />
hanno raggiunto le <strong>di</strong>mensioni necessarie per essere impiegati come legname da opera, la<br />
morfologia dei fusti e <strong>del</strong>le chiome è scadente ed il cancro corticale è considerevolmente <strong>di</strong>ffuso.
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
La realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti tar<strong>di</strong>vi o i tagli <strong>di</strong> “avviamento ad alto fusto 6 ”, anche se possono<br />
contribuire alla costituzione <strong>di</strong> popolamenti <strong>di</strong> elevato valore paesaggistico e <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> esercitare<br />
una buona protezione <strong>del</strong> suolo, non <strong>in</strong>ducono apprezzabili miglioramenti da un punto <strong>di</strong> vista<br />
produttivo. I polloni rispondono positivamente al <strong>di</strong>radamento, mo<strong>di</strong>ficando bruscamente il ritmo<br />
<strong>in</strong>crementale e generando qu<strong>in</strong><strong>di</strong> zone ad alto rischio cipollatura.<br />
Attualmente risultano piuttosto <strong>di</strong>ffusi anche soprassuoli caratterizzati da strutture <strong>di</strong>verse da<br />
quelle tipiche sopra descritte. Si tratta per la maggior parte <strong>di</strong> cedui orig<strong>in</strong>atisi dal taglio <strong>del</strong>le selve<br />
da frutto (Conedera et al. 2000; Paci et al. 2003) e, <strong>in</strong> m<strong>in</strong>or misura, <strong>di</strong> giovani fustaie sviluppatesi<br />
<strong>in</strong> seguito alla colonizzazione <strong>di</strong> superfici <strong>in</strong> passato dest<strong>in</strong>ate a produzioni agricole. La<br />
caratteristica comune ad entrambi i tipi <strong>di</strong> soprassuolo è la bassa densità. Nel primo caso la<br />
ceduazione ha determ<strong>in</strong>ato la formazione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> ceppaie costituite da numerosi polloni, dei quali<br />
i più esterni alla ceppaia risultano sciabolati alla base con conseguente formazione <strong>di</strong> legno <strong>di</strong><br />
reazione e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> fortemente soggetti a cipollatura. Nel secondo caso ci troviamo <strong>di</strong> fronte a piante<br />
con elevato sviluppo vegetativo (grazie ad una maggiore profon<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> suolo esplorabile), ma che,<br />
non avendo goduto <strong>del</strong>l’azione <strong>di</strong> educazione <strong>del</strong>le piante vic<strong>in</strong>e, non sempre presentano le<br />
caratteristiche <strong>del</strong> fusto desiderate (soprattutto <strong>di</strong>rittezza e ridotta ramosità).<br />
Potenzialità produttive<br />
Gli aspetti positivi attribuibili al castagno sono riconducibili alla rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> accrescimento, alle<br />
buone caratteristiche <strong>del</strong> legno, all’ampia varietà degli assortimenti ritraibili, all’elevata e quasi<br />
<strong>in</strong>esauribile capacità pollonifera, alla prontezza <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione, alle possibili anticipazioni <strong>del</strong><br />
red<strong>di</strong>to ottenibili con i <strong>di</strong>radamenti e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e alla presenza <strong>di</strong> numerose cultivar ben caratterizzate a<br />
scala locale.<br />
Il castagno può essere considerato una specie a rapida crescita. Le tavole alsometriche dei<br />
cedui <strong>di</strong> varie zone <strong>del</strong>la penisola (Caldarelli 1958; Campar<strong>in</strong>i 1927; Castellani 1982; De Philippis<br />
1948; Gullo 1976; La Marca 1981; Marchetto 1975; Meren<strong>di</strong> 1930; Rispoli 1958) mettono <strong>in</strong> luce,<br />
per la classe <strong>di</strong> fertilità più elevata, valori massimi <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>cremento me<strong>di</strong>o annuo (per età variabili da<br />
4 a 42 anni) spesso superiori a 10 m 3 ha- 1 , con punte <strong>di</strong> 26 m 3 ha- 1 per i cedui <strong>di</strong> 12 anni <strong>del</strong>la<br />
Valle Cau<strong>di</strong>na (AV) e 20,4 m 3 ha- 1 per i cedui <strong>di</strong> 18 anni dei Monti Cim<strong>in</strong>i (VT). Anche nelle zone<br />
dove le esigenze ecologiche <strong>del</strong> castagno non sono sod<strong>di</strong>sfatte appieno gli <strong>in</strong>crementi risultano<br />
comunque piuttosto sostenuti. I ritmi <strong>in</strong>crementali si mantengono elevati a lungo consentendo così<br />
una buona flessibilità nella scelta <strong>del</strong> turno.<br />
Oltre ciò la specie è caratterizzata da un legno <strong>di</strong> buone caratteristiche tecnologiche ed<br />
estetiche (Cas<strong>in</strong>i e De Meo 2001). La possibilità <strong>di</strong> adottare convenientemente turni <strong>di</strong> lunghezza<br />
molto variabile ha consentito, da sempre, <strong>di</strong> ottenere una produzione molto <strong>di</strong>versificata, sia come<br />
assortimenti che come lavorati. Accanto ai prodotti tra<strong>di</strong>zionali se ne stanno <strong>di</strong>ffondendo, negli<br />
ultimi anni, <strong>di</strong> nuovi. In particolare meritano <strong>di</strong> essere segnalati pannelli semilavorati <strong>di</strong> vario tipo,<br />
ad es. quelli dest<strong>in</strong>ati alla realizzazione <strong>di</strong> barriere fonoassorbenti e il palo da impiegare <strong>in</strong> opere <strong>di</strong><br />
bio<strong>in</strong>gegneria, dato che il castagno sostituisce <strong>in</strong> ambiente appenn<strong>in</strong>ico il larice, comunemente<br />
impiegato sulle Alpi (Galeotti 2000).<br />
Particolari caratteristiche tecnologiche sono poi riconosciute, almeno nei luoghi <strong>di</strong> abituale<br />
coltivazione (Buccianti 1992), ad alcune cultivar che proprio per questo motivo vengono def<strong>in</strong>ite<br />
“cultivar da legno”. Le sperimentazioni realizzate (Emiliani et al. 2006; Tani et al. 2010) hanno<br />
evidenziato le forti peculiarità, a livello <strong>di</strong> genotipo e <strong>di</strong> fenotipo, che <strong>di</strong>fferenziano queste cultivar<br />
da quelle da frutto mentre non è ancora stato possibile condurre analisi e test tecnologici sul legno<br />
prodotto da piante allevate al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le aree tra<strong>di</strong>zionali.<br />
Criticità e fattori limitanti<br />
Di contro rappresentano punti <strong>di</strong> debolezza la suscettibilità ai patogeni, la tendenza alla<br />
cipollatura e la scarsa valorizzazione degli assortimenti.<br />
In particolare quest’ultimo fattore è legato sia al tipo <strong>di</strong> gestione applicato che alla struttura <strong>del</strong>la<br />
proprietà e <strong>del</strong>la filiera. Dal punto <strong>di</strong> vista tecnologico le pr<strong>in</strong>cipali limitazioni sono attualmente<br />
6 L’uso <strong>del</strong> term<strong>in</strong>e “avviamento ad alto fusto” per i cedui <strong>di</strong> castagno, non risulta propriamente corretto vista la biologia <strong>del</strong>la<br />
specie e l’obiettivo atteso dall’applicazione <strong>del</strong> trattamento, ma è <strong>in</strong> uso corrente per l’aspetto fisionomico <strong>del</strong>le strutture<br />
conseguenti, assimilabili a fustaie (Amor<strong>in</strong>i e Manetti 1997).<br />
123
124<br />
Maria Chiara Manetti<br />
rappresentate dalla scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> grosse <strong>di</strong>mensioni e dall’elevata <strong>in</strong>cidenza<br />
<strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>la cipollatura. La mancanza <strong>di</strong> assortimenti <strong>di</strong> qualità (tondo da sega, travatura,<br />
ecc) è pr<strong>in</strong>cipalmente imputabile alla forma <strong>di</strong> governo (ceduo) e alla limitata lunghezza dei turni<br />
solitamente adottati. L’eccessiva frammentazione <strong>del</strong>la proprietà, <strong>in</strong> prevalenza privata, costituisce<br />
poi un grave limite; spesso non si raggiungono i valori m<strong>in</strong>imi <strong>di</strong> superficie necessari a garantire la<br />
red<strong>di</strong>tività <strong>del</strong>le colture e a permettere l’accesso ai f<strong>in</strong>anziamenti pubblici. I piccoli proprietari non<br />
sono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare con cont<strong>in</strong>uità le richieste <strong>del</strong>le imprese <strong>di</strong> trasformazione e<br />
commercializzazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e e gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni che si avvalgono così <strong>di</strong> legname <strong>di</strong><br />
importazione anche per assortimenti <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni.<br />
Il castagno è specie molto sensibile alle caratteristiche fisico-chimiche <strong>del</strong> suolo, <strong>in</strong> particolare<br />
alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua nel substrato. L’attuale trend climatico, che vede aumentare le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> stress idrico estivo nell’area me<strong>di</strong>terranea, espone i castagneti, <strong>in</strong> particolare quelli situati alle<br />
quote <strong>in</strong>feriori <strong>del</strong>l’areale <strong>del</strong>la specie, a forme <strong>di</strong> deperimento che già caratterizzano altre entità a<br />
temperamento mesofilo, <strong>in</strong> particolare le querce caducifoglie, con conseguenti possibili per<strong>di</strong>te <strong>di</strong><br />
produttività legnosa.<br />
Valenza ambientale e sociale<br />
I popolamenti <strong>di</strong> castagno hanno rivestito f<strong>in</strong>o alla metà <strong>del</strong> secolo scorso un ruolo prioritario<br />
nell’economia <strong>del</strong>le aree rurali; i successivi mutamenti nell’assetto socio-economico a seguito dei<br />
processi <strong>di</strong> <strong>in</strong>dustrializzazione e la <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la domanda dei prodotti tra<strong>di</strong>zionali <strong>del</strong> ceduo<br />
castanile (paleria), hanno poi notevolmente marg<strong>in</strong>alizzato l’importanza <strong>del</strong>la specie e mo<strong>di</strong>ficato le<br />
modalità <strong>di</strong> coltivazione.<br />
I soprassuoli <strong>di</strong> castagno sono spesso ubicati <strong>in</strong> territori coll<strong>in</strong>ari e montani <strong>di</strong> elevato valore<br />
naturalistico o all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> aree protette nazionali o regionali, la cui economia <strong>di</strong>pende anche da<br />
forme <strong>di</strong> turismo collegate alla qualità dei prodotti e <strong>del</strong> paesaggio agro-forestale; <strong>in</strong>oltre la foresta<br />
<strong>di</strong> castagno è habitat comunitario (9260 Foreste <strong>di</strong> Castanea sativa).<br />
LE ALTERNATIVE COLTURALI<br />
L’analisi <strong>del</strong>le potenzialità e <strong>del</strong>le criticità <strong>del</strong>la specie permette <strong>di</strong> affermare che il rilancio <strong>del</strong>la<br />
selvicoltura <strong>del</strong> castagno, e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> l’applicazione <strong>di</strong> l<strong>in</strong>ee guida e mo<strong>del</strong>li selvicolturali alternativi,<br />
<strong>di</strong>namici e <strong>in</strong>tegrati nel contesto socio-economico, potrebbe avere ripercussioni notevoli sui territori<br />
<strong>di</strong> pert<strong>in</strong>enza e contribuire alla rilocalizzazione e riorganizzazione <strong>del</strong>la produzione e <strong>del</strong>la filiera <strong>del</strong><br />
castagno con conseguenti benefici economici, sociali e ambientali:<br />
• <strong>in</strong>crementare, migliorare e <strong>di</strong>versificare la produzione legnosa,<br />
• attivare filiere secondarie (turismo, funghi, miele),<br />
• migliorare la stabilità e la funzionalità ecologica dei popolamenti,<br />
• valorizzare e promuovere lo sviluppo <strong>del</strong>le risorse e <strong>del</strong>le economie locali,<br />
• ridurre i costi ambientali e sociali derivati dall’importazione <strong>di</strong> legname,<br />
• salvaguardare l’ambiente ed il paesaggio, garantendo sufficienti livelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità<br />
biologica e strutturale,<br />
• promuovere un’azione importante <strong>di</strong> stoccaggio <strong>del</strong> carbonio.<br />
Gli approcci colturali emersi dalla sperimentazione (tabella 1) sono riconducibili a due <strong>di</strong>verse<br />
f<strong>in</strong>alità, selvicoltura produttiva e selvicoltura <strong>di</strong> miglioramento, riferibili a contesti sociali <strong>di</strong>fferenziati<br />
quali l’area <strong>di</strong> gestione attiva e l’area <strong>di</strong> abbandono colturale (Manetti et al. 2009c).<br />
Selvicoltura produttiva<br />
Lo scopo è quello <strong>di</strong> valorizzare le potenzialità economiche <strong>del</strong>la specie attraverso l’aumento<br />
<strong>del</strong>la quantità e il miglioramento <strong>del</strong>la qualità degli assortimenti. Il campo <strong>di</strong> applicazione è esteso a<br />
quei contesti stazionali, strutturali e sociali che permettono il potenziamento <strong>del</strong>le caratteristiche<br />
biologiche (rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> accrescimento, pronta ristrutturazione sociale) e la produzione <strong>di</strong> legname <strong>di</strong><br />
qualità.
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
Tabella 1 – Obiettivi e <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni colturali nell’area gestita e <strong>in</strong> abbandono.<br />
Obiettivo<br />
L<strong>in</strong>ee <strong>di</strong><br />
ricerca<br />
Approcci<br />
selvicolturali<br />
Campo <strong>di</strong><br />
applicazione<br />
F<strong>in</strong>alità<br />
selvicolturali<br />
Output <strong>del</strong>la<br />
ricerca<br />
L<strong>in</strong>ee guida<br />
Presupposti<br />
Area gestita Area <strong>in</strong> abbandono<br />
Mo<strong>di</strong>ficare e rivedere il trattamento storicamente<br />
applicato per ottenere assortimenti <strong>di</strong> pregio e<br />
<strong>di</strong>versificati durante l’<strong>in</strong>tero ciclo produttivo<br />
Struttura e bio<strong>di</strong>versità; ecologia e produttività;<br />
<strong>di</strong>namiche evolutive e r<strong>in</strong>novazione; patologia;<br />
struttura genetica; qualità <strong>del</strong> legno e cipollatura;<br />
analisi socio-economica <strong>del</strong> territorio<br />
125<br />
Analizzare la funzionalità e l’efficienza dei<br />
soprassuoli per determ<strong>in</strong>are le<br />
potenzialità produttive <strong>del</strong>la stazione<br />
Struttura e bio<strong>di</strong>versità; ecologia e<br />
produttività; <strong>di</strong>namiche evolutive e<br />
r<strong>in</strong>novazione<br />
Selvicoltura produttiva Selvicoltura <strong>di</strong> miglioramento<br />
Popolamenti produttivi <strong>di</strong> buona fertilità stazionale<br />
Migliorare la qualità dei prodotti, <strong>di</strong>fferenziare la<br />
gestione, aumentare la stabilità dei soprassuoli,<br />
valorizzare le potenzialità economiche <strong>del</strong>la<br />
specie<br />
Modalità <strong>di</strong> trattamento selvicolturale alternativo<br />
al ceduo a turno breve e valutazione <strong>del</strong>la<br />
fattibilità ecologica, economica e sociale <strong>del</strong>le<br />
varie opzioni:<br />
i) selvicoltura <strong>di</strong> popolamento<br />
ii) selvicoltura ad albero<br />
Allungamento <strong>del</strong> turno e <strong>di</strong>radamenti precoci,<br />
Popolamenti degradati o abbandonati ma<br />
potenzialmente atti alla produzione <strong>di</strong><br />
qualità<br />
Ridurre le anomalie strutturali e<br />
funzionali, valorizzare le potenzialità<br />
economiche<br />
In<strong>di</strong>cazioni sulle modalità <strong>di</strong> trattamento<br />
<strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la struttura dei soprassuoli,<br />
<strong>del</strong>la f<strong>in</strong>alità <strong>del</strong>la gestione e <strong>del</strong>la realtà<br />
socio-economica locale<br />
Interventi attivi quali ceduazioni e<br />
frequenti e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a-forte <strong>in</strong>tensità<br />
<strong>di</strong>radamenti o evoluzione naturale<br />
Buona fertilità stazionale e stato fitosanitario, valutazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>namiche naturali e verifica<br />
<strong>del</strong>la realtà socio-economica<br />
Selvicoltura produttiva – selvicoltura <strong>di</strong> popolamento<br />
Allo scopo sono stati def<strong>in</strong>iti e testati due <strong>di</strong>fferenti mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> trattamento (tabella 2 e 3) che si<br />
<strong>di</strong>fferenziano pr<strong>in</strong>cipalmente per l’<strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> gestione e la qualità degli assortimenti ritraibili alla<br />
f<strong>in</strong>e e durante l’<strong>in</strong>tero ciclo produttivo. I caratteri <strong>di</strong>st<strong>in</strong>tivi sono l’età <strong>del</strong> primo <strong>di</strong>radamento (10 e 15<br />
anni), la lunghezza <strong>del</strong> turno (30 e 50 anni) e la frequenza e l’<strong>in</strong>tensità degli <strong>in</strong>terventi (Amor<strong>in</strong>i et<br />
al. 1997b; Manetti et al. 2002).<br />
Tabella 2 - Mo<strong>del</strong>lo a Turno Me<strong>di</strong>o - Trattamento selvicolturale alternativo al ceduo a turno breve. Sono<br />
riportate la lunghezza <strong>del</strong> turno, la frequenza e l'<strong>in</strong>tensità dei <strong>di</strong>radamenti, le pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche<br />
dendrometriche prima e dopo gli <strong>in</strong>terventi selvicolturali.<br />
Età Altezza<br />
dom<strong>in</strong>ante Polloni<br />
Prima <strong>del</strong> <strong>di</strong>radamento<br />
Area Diametro<br />
basimetrica me<strong>di</strong>o Polloni<br />
Entità <strong>del</strong><br />
<strong>di</strong>radamento<br />
Area<br />
basimetrica Polloni<br />
Dopo il <strong>di</strong>radamento<br />
Area Diametro<br />
basimetrica me<strong>di</strong>o<br />
anni m n ha-¹ m² ha-¹ Cm % % n ha-¹ m² ha-¹ cm<br />
10 > 10 5500 26.9 7.9 50 35 2750 17.5 9<br />
mortalità = 4 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.9 m² ha-¹ an-¹<br />
15 13.5 - 15.5 2640 27 11.4 50 30 1320 18.9 13.5<br />
mortalità = 2 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.6 m² ha-¹ an-¹<br />
22 16.5 - 18.0 1294 30.1 17.2 40 30 776 21.1 18.6<br />
mortalità = 1 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.4 m² ha-¹ an-¹<br />
30 19.0 - 20.0 768 32.3 23.1
126<br />
Maria Chiara Manetti<br />
Tabella 3 - Mo<strong>del</strong>lo a Turno Lungo - Trattamento selvicolturale alternativo al ceduo a turno breve. Sono<br />
riportate la lunghezza <strong>del</strong> turno, la frequenza e l'<strong>in</strong>tensità dei <strong>di</strong>radamenti, le pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche<br />
dendrometriche prima e dopo gli <strong>in</strong>terventi selvicolturali.<br />
Età<br />
Prima <strong>del</strong> <strong>di</strong>radamento<br />
Altezza<br />
dom<strong>in</strong>ante Polloni<br />
Area Diametro<br />
basimetrica me<strong>di</strong>o Polloni<br />
Entità <strong>del</strong><br />
<strong>di</strong>radamento<br />
Area<br />
basimetrica Polloni<br />
Dopo il <strong>di</strong>radamento<br />
Area Diametro<br />
basimetrica me<strong>di</strong>o<br />
Anni m n ha-¹ m² ha-¹ Cm % % N ha-¹ m² ha-¹ cm<br />
15 > 13 3900 31.5 10.1 50 35 1950 20.5 11.6<br />
mortalità = 3 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.6 m² ha-¹ an-¹<br />
22 16.5 - 18.0 1892 31.7 14.6 40 27 1135 23.1 16.1<br />
mortalità = 2 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.4 m² ha-¹ an-¹<br />
30 19.0 - 20.0 1112 34.3 19.8 30 22 779 26.8 20.9<br />
mortalità = 1.5 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.4 m² ha-¹ an-¹<br />
37 21.0 - 22.0 767 35.2 24.2 30 22 537 27.4 25.5<br />
mortalità = 1 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.2 m² ha-¹ an-¹<br />
44 22.5 - 23.0 531 35.8 29.3 30 25 372 26.9 30.3<br />
mortalità = 0 % <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica = 1.0 m² ha-¹ an-¹<br />
50 23.5 - 24.0 370 32.9 33.6<br />
Entrambi i mo<strong>del</strong>li sono caratterizzati da <strong>di</strong>radamenti dal basso o misti che consentono <strong>di</strong><br />
mantenere nel tempo un piano dom<strong>in</strong>ante equilibrato e funzionale, <strong>in</strong> accordo con le caratteristiche<br />
biologiche <strong>del</strong>la specie e le <strong>di</strong>namiche espresse dal ceduo <strong>in</strong> evoluzione naturale (eliofilia,<br />
precocità e rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> accrescimento, attiva riorganizzazione sociale, tendenza a costituire strutture<br />
monoplane). A causa <strong>del</strong>l’alto grado <strong>di</strong> colturalità richiesta, tali mo<strong>del</strong>li devono necessariamente<br />
essere applicati <strong>in</strong> aree <strong>di</strong> buona e ottima fertilità (figura 1) dove è possibile valorizzare al massimo<br />
la capacità produttiva <strong>del</strong>la stazione, sfruttando l’elevato <strong>di</strong>namismo e la forte reattività <strong>del</strong>la specie<br />
agli <strong>in</strong>terventi selvicolturali. Ulteriori peculiarità sono l’adattabilità <strong>del</strong> sistema alle necessità<br />
gestionali <strong>del</strong>la proprietà forestale, pubblica e privata, e il mantenimento <strong>del</strong>la flessibilità tipica <strong>del</strong><br />
governo a ceduo.<br />
Figura 1 - Parametri <strong>di</strong> riferimento per l’applicazione dei mo<strong>del</strong>li<br />
I presupposti base dei mo<strong>del</strong>li – allungamento <strong>del</strong> turno e <strong>di</strong>radamenti forti e frequenti – sono<br />
stati verificati dall’analisi <strong>di</strong> alcuni <strong>in</strong><strong>di</strong>ci quantitativi, qualitativi ed ecologici che hanno verificato la<br />
sostenibilità <strong>del</strong>la gestione sotto il profilo bio-ecologico e funzionale (figura 2). L’analisi dei<br />
parametri quantitativi (densità, accrescimento e produttività) supporta l’adozione <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti <strong>di</strong><br />
tipo forte; la risposta dei soprassuoli a <strong>di</strong>radamenti è risultata sempre positiva anche ad età
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
avanzate con la rapida ricostituzione <strong>del</strong>la copertura ed il recupero <strong>in</strong> tempi brevi <strong>del</strong>la biomassa<br />
asportata. La veloce ricostituzione <strong>del</strong>la copertura e la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> dom<strong>in</strong>anza permettono <strong>di</strong><br />
affermare che <strong>in</strong>terventi ravvic<strong>in</strong>ati risultano sostenibili perché mantengono costante nel tempo un<br />
piano dom<strong>in</strong>ante <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui scelti, con buone caratteristiche morfologiche, caratterizzati da<br />
crescita regolare e sostenuta. La regolarità <strong>del</strong>l’accrescimento è <strong>in</strong>oltre uno dei requisiti necessari<br />
per ridurre l’<strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> cipollatura nel legno <strong>di</strong> castagno. La verifica <strong>del</strong>la sostenibilità<br />
sotto il profilo bio-ecologico e funzionale è stata effettuata verificando l’impatto <strong>del</strong> <strong>di</strong>radamento<br />
sulle caratteristiche <strong>del</strong>la copertura forestale. La riduzione perio<strong>di</strong>ca <strong>del</strong>la copertura e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> dei<br />
valori <strong>di</strong> LAI permette al popolamento <strong>di</strong> mantenere un’alta efficienza ecologica (valori <strong>di</strong> Lai<br />
superiori a 5.0-5.5 determ<strong>in</strong>ano una <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la biomassa prodotta per unità <strong>di</strong> superficie<br />
fogliare). Il confronto tra superfici trattate e aree <strong>di</strong> controllo ha evidenziato <strong>di</strong>fferenze notevoli nei<br />
valori dei parametri ecologici considerati subito dopo l’<strong>in</strong>tervento; le <strong>di</strong>fferenze tendono però ad<br />
annullarsi precocemente e il tempo <strong>di</strong> recupero varia <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>l’età dei soprassuoli.<br />
500<br />
250<br />
0<br />
100<br />
10<br />
50<br />
5<br />
0<br />
0<br />
Volume (m³ ha-¹)<br />
11 17 24 30 43<br />
Polloni dom<strong>in</strong>anti<br />
(%)<br />
11 17 24 35 43<br />
Leaf Area Index (m² m-²)<br />
PD<br />
DD<br />
11 17 24 35 43<br />
Figura 2 - Alcuni degli <strong>in</strong><strong>di</strong>ci che sono stati utilizzati per verificare l’applicabilità dei mo<strong>del</strong>li colturali da un<br />
punto <strong>di</strong> vista strutturale ed ecologico. Sono riportati i valori dei parametri misurati e stimati prima e dopo gli<br />
<strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento, realizzati dall’età <strong>di</strong> 11 anni seguendo le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> gestione a turno<br />
lungo.<br />
Nei popolamenti giovani (10-15 anni) i valori <strong>di</strong> LAI e trasmittanza risultano significativamente<br />
<strong>di</strong>versi solo il primo anno dopo l’<strong>in</strong>tervento, mentre il m<strong>in</strong>or <strong>di</strong>namismo che caratterizza i<br />
popolamenti adulti (35-40 anni), si traduce <strong>in</strong> una più lenta capacità <strong>di</strong> ricostituzione <strong>del</strong>la copertura<br />
anche se le <strong>di</strong>fferenze tendono ad annullarsi già nel corso <strong>del</strong> terzo anno.<br />
Selvicoltura produttiva – selvicoltura ad albero<br />
Una modalità alternativa, applicabile <strong>in</strong> alcuni contesti sociali dove potrebbe essere<br />
economicamente non conveniente o tecnicamente non possibile l’applicazione dei mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong><br />
gestione proposti, è quella cosiddetta “selvicoltura ad albero”che prevede la scelta precoce <strong>di</strong> circa<br />
127
128<br />
Maria Chiara Manetti<br />
80-100 piante ad ettaro, ben conformate e <strong>di</strong> buon sviluppo, che andranno a costituire il<br />
soprassuolo def<strong>in</strong>itivo. L’obiettivo è quello <strong>di</strong> verificare la possibilità <strong>di</strong> produrre legname <strong>di</strong><br />
castagno <strong>di</strong> qualità con turni me<strong>di</strong>o-lunghi (30-50 anni) <strong>in</strong><strong>di</strong>viduando approcci selvicolturali che<br />
permettano <strong>di</strong> raggiungere la massimizzazione <strong>del</strong>la resa <strong>in</strong> rapporto agli <strong>in</strong>vestimenti. Il<br />
trattamento selvicolturale si articola <strong>in</strong> un primo <strong>di</strong>radamento precoce (10 anni) e dall’alto,<br />
f<strong>in</strong>alizzato ad isolare le chiome <strong>del</strong>le piante selezionate, e <strong>in</strong> <strong>di</strong>radamenti successivi che<br />
tenderanno ad evitare l’<strong>in</strong>staurarsi <strong>di</strong> fenomeni competitivi a danno <strong>del</strong>le piante scelte.<br />
Le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i sperimentali sono attualmente <strong>in</strong> atto ed hanno <strong>in</strong>teressato popolamenti giovani,<br />
omogenei, <strong>di</strong> buona fertilità e densità. Il primo <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento è stato effettuato<br />
nell’<strong>in</strong>verno 2007-2008. Questa modalità selvicolturale dovrà ovviamente essere valutata <strong>in</strong><br />
confronto a quella def<strong>in</strong>ita come selvicoltura <strong>di</strong> popolamento non solo da un punto <strong>di</strong> vista<br />
strutturale ed ecologico ma anche economico (tempi <strong>di</strong> esecuzione degli <strong>in</strong>terventi e assortimenti<br />
ritraibili).<br />
Recupero dei soprassuoli abbandonati e/o degradati<br />
Lo scopo è recuperare popolamenti <strong>di</strong> castagno abbandonati o degradati, caratterizzati da<br />
anomalie funzionali e strutturali, ma potenzialmente produttivi (figura 3). Per l’applicazione <strong>di</strong> tale<br />
selvicoltura è necessario analizzare preventivamente le caratteristiche bio-ecologiche e strutturali<br />
dei popolamenti e gli aspetti socio-economici <strong>del</strong> territorio.<br />
Figura 3 - Esempi <strong>di</strong> profilo verticale e pr<strong>in</strong>cipali parametri dendrometrici <strong>di</strong> tipi strutturali rappresentativi<br />
dei popolamenti <strong>di</strong> castagno abbandonati o degradati. (A) = Ceduo <strong>di</strong> 42 anni mai <strong>di</strong>radato caratterizzato da<br />
struttura monoplana, chiome ridotte, compresse e irregolari. (B) = Castagneto da frutto abbandonato a<br />
struttura <strong>di</strong>somogenea e irregolare caratterizzato da ex- castagni da frutto, polloni <strong>di</strong> castagno <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa età e<br />
presenza <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione da seme anche <strong>di</strong> altre specie. (C) = Popolamento <strong>di</strong> 50 anni notevolmente<br />
semplificato e impoverito per tagli fitosanitari <strong>di</strong> forte <strong>in</strong>tensità.<br />
Nella fase <strong>in</strong>iziale, nel breve e me<strong>di</strong>o periodo, lo scopo è ridurre le anomalie strutturali e<br />
aumentare l’efficienza e la stabilità dei popolamenti; nella seconda fase, a lungo term<strong>in</strong>e, il<br />
recupero <strong>di</strong> ampie e importanti aree può contribuire anche allo sviluppo economico <strong>di</strong> aree rurali e<br />
marg<strong>in</strong>ali. E’ necessario qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un cont<strong>in</strong>uo monitoraggio per def<strong>in</strong>ire le <strong>di</strong>namiche evolutive<br />
espresse dai popolamenti e <strong>di</strong> conseguenza pianificare le modalità <strong>di</strong> trattamento.<br />
Le l<strong>in</strong>ee guida possono essere ricondotte a tre ipotesi generali:
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
Preservazione: ovvero assenza <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento e cont<strong>in</strong>uo monitoraggio, laddove le con<strong>di</strong>zioni<br />
stazionali, strutturali, patologiche ed economiche suggeriscono <strong>di</strong> lasciare alla libera e <strong>in</strong><strong>di</strong>sturbata<br />
evoluzione.<br />
Conservazione: mantenimento dei castagneti attraverso <strong>di</strong>radamenti o ceduazioni con l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>are l’efficienza funzionale e produttiva dei soprassuoli.<br />
R<strong>in</strong>aturalizzazione: gestione che assecon<strong>di</strong> l’evoluzione naturale verso sistemi più complessi;<br />
costituzione <strong>di</strong> un bosco misto con partecipazione più o meno importante <strong>del</strong> castagno.<br />
Il ruolo <strong>del</strong>la selvicoltura<br />
Tutto ciò presuppone un cambiamento sostanziale nella modalità <strong>di</strong> gestione dei popolamenti <strong>di</strong><br />
castagno; il passaggio cioè da una selvicoltura <strong>di</strong> attesa o articolata <strong>in</strong> <strong>in</strong>terventi spora<strong>di</strong>ci a una<br />
“selvicoltura attiva, partecipata e sostenuta” che necessita <strong>di</strong> programmazione <strong>in</strong> funzione sia <strong>del</strong>le<br />
caratteristiche stazionali e strutturali dei popolamenti sia degli aspetti socio-economici <strong>del</strong> territorio.<br />
In primo luogo la gestione applicata, f<strong>in</strong>alizzata ad implementare la multifunzionalità dei<br />
popolamenti, deve risultare oltre che sostenibile ecologicamente e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> applicabile <strong>in</strong><br />
popolamenti <strong>di</strong> buona fertilità stazionale e sod<strong>di</strong>sfacente stato fitosanitario, anche possibile<br />
tecnicamente per la presenza <strong>di</strong> personale tecnico qualificato e attuabile economicamente, cioè <strong>in</strong><br />
zone con buona viabilità dove siano presenti imprese <strong>di</strong> utilizzazione e trasformazione.<br />
In secondo luogo, il cambiamento <strong>di</strong> prospettiva, essenziale per una reale valorizzazione <strong>del</strong>la<br />
castanicoltura da legno, è reso evidente nell’aggettivazione <strong>del</strong> term<strong>in</strong>e selvicoltura - attiva,<br />
partecipata, sostenuta. Si parla <strong>di</strong> selvicoltura attiva <strong>in</strong> quanto la scelta <strong>del</strong>le varie opzioni colturali<br />
presuppone un’attenzione particolare all’<strong>in</strong>tero contesto territoriale nella fase <strong>di</strong> pianificazione e un<br />
elevato grado <strong>di</strong> colturalità durante tutto il ciclo produttivo. E’ selvicoltura partecipata <strong>in</strong> quanto la<br />
prevalenza <strong>del</strong>la proprietà privata nei comprensori castanicoli impone <strong>di</strong> giungere a scelte colturali<br />
con<strong>di</strong>vise per superare i conflitti tra gli <strong>in</strong>teressi <strong>del</strong> s<strong>in</strong>golo e quelli <strong>del</strong>la collettività. A tal f<strong>in</strong>e la<br />
pianificazione forestale rappresenta lo strumento <strong>di</strong> elezione per ricondurre le decisioni tecniche <strong>in</strong><br />
ambito politico. Inf<strong>in</strong>e deve essere selvicoltura sostenuta <strong>in</strong> quanto appare <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile il<br />
concorso da parte dei Servizi Forestali Regionali e <strong>del</strong>le Comunità Montane a <strong>in</strong>formare i<br />
proprietari circa le funzioni - economiche, ecologiche, sociali, paesaggistiche e storico-culturali -<br />
proprie dei castagneti e a <strong>in</strong>coraggiare la costituzione <strong>di</strong> associazioni o consorzi per facilitare la<br />
gestione e l’accesso ai contributi previsti dai PSR e dalla normativa comunitaria.<br />
Un’ulteriore aspetto è quello legato alla valorizzazione <strong>del</strong> prodotto legno, ovvero il<br />
riconoscimento che il trattamento selvicolturale applicato sia conforme agli standard <strong>di</strong> gestione<br />
sostenibile <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i ecologici, sociali ed economici (ecocertificazione) oppure che il prodotto sia<br />
caratterizzato da particolari specificità (marchi <strong>di</strong> qualità). Risultano poi fondamentali anche le<br />
azioni pubbliche <strong>di</strong> “sponsorizzazione” o public procurement (Pettenella e Secco 2002) che<br />
possono accordare la preferenza all’impiego <strong>di</strong> legno <strong>di</strong> castagno per la realizzazione <strong>di</strong> opere<br />
f<strong>in</strong>anziate anche con sostegno pubblico (ristrutturazioni <strong>di</strong> immobili rurali, arredamento <strong>di</strong> parchi<br />
pubblici, barriere fonoassorbenti, opere <strong>di</strong> bio<strong>in</strong>gegneria, ecc.). Tale scelta dovrebbe essere<br />
fortemente motivata dal fatto che il castagno assicura buone caratteristiche tecnologiche e <strong>in</strong><br />
particolare non necessita, data la naturale durabilità, <strong>di</strong> trattamenti chimici preservanti che hanno<br />
impatti negativi sull’ambiente.<br />
In def<strong>in</strong>itiva promuovere la coltura e la cultura <strong>del</strong> castagno significa ottenere <strong>in</strong> zone rurali e<br />
montane <strong>in</strong>dubbi benefici non solo economici (legno e filiere aggiuntive) ma anche sociali (aumento<br />
occupazione, valorizzazione <strong>del</strong>le risorse e sviluppo <strong>del</strong>le economie locali), ambientali <strong>di</strong>retti<br />
(miglioramento <strong>del</strong>la funzionalità degli ecosistemi forestali, stoccaggio <strong>del</strong> carbonio) e <strong>in</strong><strong>di</strong>retti<br />
(<strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong> tasso <strong>di</strong> <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento per la riduzione dei flussi <strong>di</strong> importazione, riflessi sulla flora<br />
e sulla fauna per la maggior <strong>di</strong>versificazione <strong>del</strong> paesaggio).<br />
INDAGINI COMPLEMENTARI<br />
Indag<strong>in</strong>i sul <strong>di</strong>fetto <strong>del</strong>la cipollatura<br />
L’obiettivo fissato dal trattamento - produzione legnosa <strong>di</strong> qualità - risulta subor<strong>di</strong>nato all’esame<br />
<strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> legno e soprattutto a <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i specifiche sull’<strong>in</strong>sorgenza <strong>del</strong>la cipollatura la<br />
cui presenza può vanificare gli sforzi <strong>del</strong>la gestione. La cipollatura costituisce un particolare <strong>di</strong>fetto<br />
<strong>del</strong> legno che si manifesta con l’apertura <strong>di</strong> fessurazioni al limite <strong>di</strong> passaggio fra due <strong>di</strong>versi anelli<br />
129
130<br />
Maria Chiara Manetti<br />
<strong>di</strong> accrescimento; queste possono svilupparsi per una parte <strong>del</strong> perimetro o, nei casi più gravi,<br />
<strong>in</strong>teressare l’<strong>in</strong>tera circonferenza f<strong>in</strong>o a provocare il <strong>di</strong>stacco completo <strong>di</strong> due parti <strong>del</strong> tronco. Nel<br />
caso <strong>in</strong> cui la presenza <strong>del</strong> <strong>di</strong>fetto sia facilmente associabile a danni subiti dall’albero durante la<br />
crescita (es. danni da gelo, marciumi, ecc.) la cipollatura viene detta traumatica, quando <strong>in</strong>vece<br />
non esiste nessuna causa apparente che ne possa giustificare la presenza, questa viene def<strong>in</strong>ita<br />
sana. Sulle cause <strong>di</strong> <strong>in</strong>sorgenza sono state formulate numerose ipotesi; nessuna f<strong>in</strong>o ad oggi è<br />
riuscita a spiegare compiutamente i fattori scatenanti, ma i risultati <strong>del</strong>le varie ricerche (Fioravanti<br />
1995; Amor<strong>in</strong>i et al. 1997a; Fonti et al. 2002; Becagli et al. 2006; Sp<strong>in</strong>a et al. 2008; Mori 2009)<br />
concordano nel def<strong>in</strong>ire che la regolarità <strong>del</strong>l’accrescimento rappresenta un requisito importante<br />
per prevenire o almeno ridurre il rischio <strong>di</strong> cipollatura. Il trattamento selvicolturale e, <strong>in</strong> particolar<br />
modo, il regime dei <strong>di</strong>radamenti, può giocare qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un ruolo fondamentale.<br />
L’obiettivo <strong>del</strong>la ricerca condotta dal CRA – SEL è quello <strong>di</strong> verificare <strong>in</strong> quale misura il<br />
trattamento selvicolturale possa esercitare un’azione significativa nel ridurre la formazione <strong>di</strong><br />
cipollatura sana. In particolare, sono analizzate le correlazioni tra trattamento, accrescimento,<br />
<strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong> <strong>di</strong>fetto e qualità <strong>del</strong> legno.<br />
Le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i sperimentali sono state concentrate nell’area castanicola toscana <strong>del</strong> Monte Amiata<br />
(SI) su popolamenti cedui che hanno oltrepassato l’età <strong>del</strong> turno consuetu<strong>di</strong>nario (30-45 anni) e<br />
caratterizzati da un regime dei <strong>di</strong>radamenti <strong>di</strong>fferenziato (1, 2, 3 <strong>in</strong>terventi). I primi risultati hanno<br />
sottol<strong>in</strong>eato che:<br />
• il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> cipollatura si manifesta con maggiore <strong>in</strong>tensità nelle piante sottoposte ad un grado<br />
più elevato <strong>di</strong> competizione;<br />
• le piante cipollate sono caratterizzate da <strong>in</strong>crementi più elevati e irregolari rispetto a quelle<br />
sane;<br />
• la cipollatura è generalmente limitata ai primi metri <strong>di</strong> quota <strong>del</strong> fusto (f<strong>in</strong>o a 2 m);<br />
• la maggior <strong>in</strong>cidenza <strong>del</strong> <strong>di</strong>fetto si riscontra nel periodo imme<strong>di</strong>atamente successivo al primo<br />
<strong>in</strong>tervento selvicolturale, soprattutto se <strong>di</strong> debole <strong>in</strong>tensità ed eseguito <strong>in</strong> età tar<strong>di</strong>va (oltre i 15<br />
anni).<br />
In conclusione <strong>di</strong>radamenti precoci, selettivi e regolari nel tempo, f<strong>in</strong>alizzati a favorire i polloni<br />
migliori e a ridurre la competizione all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la ceppaia e tra i s<strong>in</strong>goli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui, rappresentano le<br />
premesse colturali per ridurre il rischio <strong>del</strong>la cipollatura.<br />
Relazioni tra trattamento e cancro corticale<br />
Il tema è stato affrontato <strong>in</strong> collaborazione con l’Istituto per la Patologia degli Alberi Forestali <strong>di</strong><br />
Firenze (IPAF - CNR) nell’ambito <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> ricerca europeo. L’obiettivo era valutare l’effetto<br />
imme<strong>di</strong>ato e la <strong>di</strong>namica temporale <strong>del</strong>la malattia a seguito degli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento.<br />
Le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i effettuate (Turchetti e Maresi 1990; Santagada et al. 1996; Amor<strong>in</strong>i et al. 2001,<br />
Manetti et al. 2009d) hanno fornito <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni sulla evoluzione <strong>del</strong>la malattia verso forme non letali<br />
che tendono all’equilibrio ecologico ospite-parassita nell’ambito <strong>del</strong>l’ecosistema forestale gestito.<br />
L’effetto sanitario <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento selvicolturale si traduce <strong>in</strong> un’azione <strong>di</strong>retta, con l’elim<strong>in</strong>azione dei<br />
polloni attaccati da cancro normale, e <strong>in</strong> una <strong>in</strong><strong>di</strong>retta con la riduzione <strong>del</strong>la suscettibilità <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale<br />
alla malattia attraverso la selezione dei soggetti più vigorosi, caratterizzati da un’alta capacità <strong>di</strong><br />
accrescimento.<br />
Relazioni tra trattamento e variabilità genetica<br />
La caratterizzazione genetica <strong>del</strong> popolamento, a seguito <strong>del</strong>le pratiche colturali applicate, è<br />
stato un tema trattato <strong>in</strong> collaborazione con l’Istituto <strong>del</strong> CNR per l’Agroselvicoltura <strong>di</strong> Porano.<br />
L’obiettivo era valutare se le caratteristiche genetiche riscontrate <strong>in</strong> un popolamento <strong>di</strong> 50 anni, a<br />
f<strong>in</strong>e turno, potevano essere state compromesse dall’applicazione <strong>di</strong> un trattamento colturale<br />
articolato <strong>in</strong> <strong>di</strong>radamenti precoci, frequenti e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a-forte <strong>in</strong>tensità.<br />
I risultati ottenuti (Amor<strong>in</strong>i et al. 2001) hanno <strong>di</strong>mostrato che il trattamento selvicolturale<br />
applicato non riduce la variabilità genetica <strong>del</strong> popolamento.
Assortimenti legnosi<br />
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> questa l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> ricerca è stata valutata, <strong>in</strong> collaborazione con la <strong>di</strong>tta Calbos s.n.c.<br />
(Bibbiena – Arezzo), la qualità e la quantità degli assortimenti ritraibili <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> 30 anni,<br />
sottoposto a taglio raso.<br />
La valutazione degli assortimenti legnosi ritraibili dal taglio raso ha <strong>in</strong><strong>di</strong>cato che solo il 38% <strong>del</strong>la<br />
massa risulta utilizzabile per assortimenti qualificati (paleria e travatura), il rimanente 62% è<br />
rappresentato da scarti <strong>di</strong> utilizzazione e per tann<strong>in</strong>o.<br />
Confronto tra ceduo semplice e ceduo matric<strong>in</strong>ato<br />
E’ attualmente <strong>in</strong> corso uno stu<strong>di</strong>o per valutare le caratteristiche dei polloni e la produttività <strong>del</strong><br />
soprassuolo ceduo <strong>in</strong> presenza e assenza <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e. Tale l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> ricerca risulta <strong>di</strong> estremo<br />
<strong>in</strong>teresse pratico <strong>in</strong> quanto potrà fornire <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni utili per la def<strong>in</strong>izione <strong>del</strong>le norme forestali<br />
applicabili ai cedui <strong>di</strong> castagno. Va sottol<strong>in</strong>eato <strong>in</strong>fatti che attualmente solo <strong>in</strong> Italia le norme<br />
forestali prevedono il rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e nei cedui <strong>di</strong> castagno.<br />
Nel 2000, nel corso <strong>di</strong> un taglio raso realizzato dalla C.M. <strong>del</strong> Monte Amiata, sono state<br />
<strong>del</strong>imitate due aree <strong>di</strong> saggio <strong>in</strong> cui <strong>in</strong> una si è proceduto al normale rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e - ceduo<br />
matric<strong>in</strong>ato e nell’altra al completo abbattimento <strong>del</strong> soprassuolo - ceduo semplice. Attualmente è<br />
<strong>in</strong> fase <strong>di</strong> monitoraggio la valutazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>namica <strong>del</strong>la copertura e <strong>del</strong>la vitalità <strong>del</strong>le ceppaie<br />
nelle due tesi.<br />
I primi risultati, anche se necessitano <strong>di</strong> ulteriori conferme attraverso l’ampliamento <strong>del</strong> set <strong>di</strong><br />
dati <strong>in</strong> <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni stazionali, hanno <strong>di</strong>mostrato che la presenza <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e deprime<br />
l’accrescimento e riduce la vitalità <strong>del</strong>le ceppaie.<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
Si r<strong>in</strong>graziano per aver reso possibile un approccio multi<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are e <strong>in</strong>tegrato <strong>del</strong>la ricerca ed<br />
aver contribuito a tenere viva la <strong>di</strong>scussione e l’attenzione sulle problematiche legate ai castagneti<br />
da legno: Riccardo Moran<strong>di</strong>ni, già <strong>di</strong>rettore <strong>del</strong>l’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (Arezzo), i<br />
colleghi <strong>del</strong> CRA-SEL Centro <strong>di</strong> ricerca per la selvicoltura (Arezzo) Emilio Amor<strong>in</strong>i, Clau<strong>di</strong>a Becagli,<br />
Umberto Cerofol<strong>in</strong>i, Andrea Cut<strong>in</strong>i, Tessa Giann<strong>in</strong>i, Luigi Mencacci e Francesco Pelleri; nonché<br />
Marco Conedera, Patrick Schleppi e Andreas Z<strong>in</strong>gg (WSL – Svizzera), Fulvio Giu<strong>di</strong>ci (Federlegno<br />
Tic<strong>in</strong>i – Svizzera), Mario Pividori (UNI Padova), Tullio Turchetti (CNR Firenze), Fiorella Villani<br />
(CNR Porano), Roberto Frat<strong>in</strong>i, Alberto Maltoni, Barbara Mariotti, Enrico Marone e Andrea Tani<br />
(UNI Firenze).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Manetti M.C. 1997. Le fustaie da legno <strong>di</strong> castagno <strong>del</strong> Monte Amiata. Annali Istituto<br />
Sperimentale per la Selvicoltura, vol. 28:53-61.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Fioravanti M., Macchioni N., Manetti M.C., Thibaut B., Uzielli L. 1997a.<br />
Stu<strong>di</strong> sulle cause <strong>di</strong> <strong>in</strong>sorgenza <strong>del</strong>la cipollatura nel legno <strong>di</strong> castagno (Castanea sativa Mill.).<br />
<strong>Atti</strong> Convegno Nazionale sul castagno, Cison <strong>di</strong> Valmar<strong>in</strong>o (TV), 23-25 ottobre: 269-292.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Manetti M.C. 1997b. La sostenibilità <strong>del</strong>la produzione legnosa <strong>di</strong> qualità<br />
dal ceduo <strong>di</strong> castagno: mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> trattamento alternativo al ceduo a turno breve. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong><br />
Convegno Nazionale sul Castagno, Cison <strong>di</strong> Valmar<strong>in</strong>o (TV), 23-25 ottobre: 217-231.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Brusch<strong>in</strong>i S., Manetti M.C. 2000. Alternative silvicultural systems <strong>in</strong> chestnut coppice:<br />
effects of the silvicultural practice on stand structure and tree growth. <strong>Ecologia</strong> Me<strong>di</strong>terranea, 26<br />
(1-2): 155-162.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Manetti M.C., Turchetti T., Sansotta A., Villani F. 2001. Impact of the silvicultural<br />
treatment on genetic variability and on Cryphonectria parasitica <strong>in</strong>cidence <strong>in</strong> a chestnut coppice<br />
<strong>in</strong> Central Italy. Forest Ecology and Management, 142: 19-31.<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Manetti M.C. 2002. Selvicoltura nei cedui <strong>di</strong> castagno. Sostenibilità <strong>del</strong>la gestione e<br />
produzione legnosa <strong>di</strong> qualità. In: Il bosco ceduo <strong>in</strong> Italia. Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze<br />
Forestali: 219-248.<br />
131
132<br />
Maria Chiara Manetti<br />
Amor<strong>in</strong>i E., Bartolucci S., Bert<strong>in</strong>i G., Cut<strong>in</strong>i A., Manetti M.C. 2002. Integrated study of factors<br />
<strong>in</strong>volved <strong>in</strong> degraded chestnut forests <strong>in</strong> Central and the Me<strong>di</strong>terranean Europe. Biological<br />
criteria for a susta<strong>in</strong>able development. F<strong>in</strong>al report of CHESUD Project (Contract ERBIC 15 CT<br />
98 0149).<br />
Aumasson P., Guerr<strong>in</strong> J.L. 1995. Consequences of some chestnut silvicultural management<br />
practices <strong>in</strong> the Chevennes for susta<strong>in</strong>able development. In: Susta<strong>in</strong>ability of Me<strong>di</strong>terranean<br />
ecosystems. Case-study of the chestnut forest. Romane F. (ed.), European Commission,<br />
Brussels, Ecosystems research report (19): 165-169.<br />
Avolio S. 1987. Il castagno nell’Italia meri<strong>di</strong>onale (II parte). Cellulosa e Carta, 4: 4-13.<br />
Bacchetta R. 1984. Le châtaignier a bois et la mise en valeur des taillis de châtaignier. Cemagref,<br />
BI n. 322: 75-98.<br />
Becagli C., Amor<strong>in</strong>i E., Manetti M.C. 2006. Incidenza <strong>del</strong>la cipollatura <strong>in</strong> popolamenti cedui <strong>di</strong><br />
castagno da legno <strong>del</strong> Monte Amiata. Annali C.R.A. Istituto Sperimentale Selvicoltura, vol. 33,<br />
2002-2004: 245-256.<br />
Becagli C., Amor<strong>in</strong>i E., Frat<strong>in</strong>i R., Manetti M.C., Marone E. 2009. Problems and prospects of the<br />
chestnut timber cha<strong>in</strong> <strong>in</strong> Tuscany. I Congresso Europeo sul castagno e V Convegno Nazionale<br />
sul Castagno (<strong>in</strong> stampa).<br />
Boggia L. 1986. Il castagno <strong>in</strong> Italia. Cellulosa e Carta, 6: 4-13.<br />
Bourgeois C. 1987. Améliorer les taillis de châtaignier. Forêt Entrerprise n. 44: 8-15.<br />
Bourgeois C. 1992. Le Châtaignier. Un arbre, un bois. Institut pour le Développement Forestier<br />
IDF, Paris. 367 p.<br />
Buccianti M. 1992. Il castagno <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Lucca: storia, strutture, economia. Tipografia San<br />
Marco, Lucca.<br />
Cabannes B. Rolland M. 1982. Enquête sur les possibilités d’amélioration des taillis de châtaignier<br />
en Languedoc-Roussillon. Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-<br />
Roussillon, documento <strong>in</strong>terno: 20 p.<br />
Caldarelli A. 1958. Un nuovo contributo per la lotta e la cura <strong>del</strong> cancro <strong>del</strong>la corteccia <strong>del</strong><br />
castagno (Endothia parasitica). Monti e Boschi, 9: 642-647.<br />
Campar<strong>in</strong>i A. 1927. Produzione e red<strong>di</strong>to dei cedui <strong>di</strong> castagno nell’alto Chianti. L’Alpe, 14,<br />
seconda serie, 334-345.<br />
Cas<strong>in</strong>i L., De Meo I. 2001. Scheda sul legno <strong>di</strong> castagno (Castanea sativa Mill.). Sherwood, 72: 13-<br />
17.<br />
Castellani C. (a cura <strong>di</strong>) 1982. Tavole stereometriche ed alsometriche costruite per i boschi italiani.<br />
Ist. Sper. Per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura, Villazzano (TN).<br />
Commission Européenne des Forets, 1962. Rapport de la première session du groupe de travail<br />
du châtaigner. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, Roma.<br />
Commission Internationale du Chataigner, 1953. Rapport de la deuxième session. Organisation<br />
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, Roma.<br />
Commission Internationale du Chataigner, 1955. Rapport de la troisième session. Organisation des<br />
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, Roma.<br />
Commission Internationale du Chataigner, 1958. Rapport de la quatrième session. Organisation<br />
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, Roma.<br />
Conedera M., Stanga P., Lischer C., Stockli V. 2000. Competition and dynamics <strong>in</strong> abandoned<br />
chestnut orchards <strong>in</strong> southern Switzerland. <strong>Ecologia</strong> Me<strong>di</strong>terranea, 26 (1-2): 101-112.<br />
Conedera M., Manetti M.C., Giu<strong>di</strong>ci F., Amor<strong>in</strong>i E. 2004. Distribution and economic potential of the<br />
Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) <strong>in</strong> Europe. <strong>Ecologia</strong> Me<strong>di</strong>terranea, 30 (2): 179-193.<br />
Cut<strong>in</strong>i A., 2001. New management options <strong>in</strong> chestnut coppices: an evaluation on ecological basis.<br />
Forest Ecology and Management, 141: 165-174.<br />
De Philippis A. 1948. I cedui <strong>di</strong> castagno <strong>del</strong>la penisola Italiana. Jour. For. Suisse, 99.<br />
Emiliani G., Giann<strong>in</strong>i R., Maltoni A., Mariotti B., Paffetti D., Tani A. 2006. Applicazione <strong>di</strong> dati<br />
molecolari, <strong>di</strong> parametri architetturali e <strong>di</strong> caratteri morfologici fogliari nella <strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>azione <strong>di</strong><br />
cultivar <strong>di</strong> Castanea sativa Mill. In <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> IV Convegno Nazionale Castagno 2005. Montella<br />
(AV) 20-22 ottobre 2005.<br />
Everard J., Christie J.M. 1995. Sweet chestnut: silviculture, timber quality and yield <strong>in</strong> the forest of<br />
Dean. Forestry, vol.68 (2): 133-144.<br />
Fioravanti M. 1995. The effect of growth on the quality of chestnut (Castanea sativa Mill.) wood:<br />
anatomical and densitometrical observations. Rapporto <strong>del</strong> Forest Program Project “Innovation<br />
<strong>in</strong> the chestnut timber process<strong>in</strong>g” Contract MA2B-CT92-0002.
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
Fonti P., Giu<strong>di</strong>ci F., Conedera M. 2002. La cipollatura nel legno <strong>di</strong> castagno: un problema centrale<br />
per il rilancio <strong>del</strong>la castanicoltura da legno <strong>di</strong> qualità. Schweiz. Z. Forestwes. 153, 11: 430-436.<br />
Galeotti L. 2000. L’<strong>in</strong>gegneria naturalistica nella sistemazione dei versanti. In Pr<strong>in</strong>cipi e l<strong>in</strong>ee guida<br />
per l’<strong>in</strong>gegneria naturalistica vol. 1. Coll. Fiumi e Territorio. Regione Toscana-Giunta regionale.<br />
Gajo P., Marone E. 2000. Le problematiche <strong>del</strong> legno a livello nazionale ed Europeo, <strong>in</strong>: <strong>Atti</strong> <strong>del</strong><br />
Convegno Risorsa Legno e Territorio, Le prospettive <strong>del</strong> terzo Millennio. Cavalese, 23<br />
settembre 2000, Magnifica Comunità <strong>di</strong> Fiemme.<br />
Gambi G., 1988. Il castagno come pianta da legno. Documento Interno, Istituto Sperimentale<br />
Selvicoltura, Arezzo, 15 p.<br />
Gambi G., Amor<strong>in</strong>i E. 1977. Aspetti particolari nella conversione d’un ceduo <strong>di</strong> castagno <strong>in</strong> fustaia a<br />
produzione <strong>di</strong> legno. Giornata <strong>del</strong> Castagno, Caprese Michelangelo (Arezzo): 253-256.<br />
Gambi G., Amor<strong>in</strong>i E. 1978. Il trattamento <strong>del</strong> castagno e la produzione <strong>di</strong> legname da lavoro dal<br />
ceduo. <strong>Atti</strong> Incontro “Il Castagno nella regione padano-alp<strong>in</strong>a: <strong>di</strong>ffusione, trattamento,<br />
patologia”, Milano: 19-25.<br />
Gondard H., Romane F., Santa Reg<strong>in</strong>a I., Leonar<strong>di</strong> S., 2006. Forest management and plant<br />
species <strong>di</strong>versity <strong>in</strong> chestnut stands of three Me<strong>di</strong>terranean areas. Bio<strong>di</strong>versity and<br />
Conservation 15: 1120-1142.<br />
Groupe des Experts du Chataigner, 1951. Rapport de la première session. Organisation des<br />
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, Roma.<br />
Gullo A. 1976. Indag<strong>in</strong>e auxometrica per l’assestamento dei cedui <strong>di</strong> castagno dei “Piani <strong>del</strong>la<br />
Corona” (RC). Tesi <strong>di</strong> Laurea, ano accedamico 1975-76 Firenze.<br />
INFC 2004. Manuale <strong>di</strong> campagna per i rilievi <strong>di</strong> seconda fase con istruzioni per l'uso<br />
<strong>del</strong>l'applicativo INFOR2. Autori: A. Floris, P. Gaspar<strong>in</strong>i, G. Scr<strong>in</strong>zi, G. Tabacchi, V. Tosi -<br />
Inventario Nazionale <strong>del</strong>le Foreste e dei Serbatoi Forestali <strong>di</strong> Carbonio. MiPAF – Dir. Generale<br />
per le Risorse Forestali Montane e Idriche, Corpo Forestale <strong>del</strong>lo Stato, CRA-ISAFA, Trento.<br />
URL: http://www.sian.it/<strong>in</strong>ventarioforestale/jsp/documentazione.jsp<br />
INFC 2007a. Le stime <strong>di</strong> superficie 2005 – Prima parte. Autori G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di<br />
Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gaspar<strong>in</strong>i, L. Genchi, G. Scr<strong>in</strong>zi, V. Tosi. Inventario Nazionale<br />
<strong>del</strong>le Foreste e dei Serbatoi Forestali <strong>di</strong> Carbonio. MiPAF – Corpo Forestale <strong>del</strong>lo Stato -<br />
Ispettorato Generale, CRA - ISAFA, Trento. URL: http://www.<strong>in</strong>fc.it<br />
INFC 2007b. Le stime <strong>di</strong> superficie 2005 - Seconda parte. Autori G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di<br />
Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gaspar<strong>in</strong>i, I. Salvadori, G. Scr<strong>in</strong>zi, V. Tosi. Inventario<br />
Nazionale <strong>del</strong>le Foreste e dei Serbatoi Forestali <strong>di</strong> Carbonio. MiPAF – Corpo Forestale <strong>del</strong>lo<br />
Stato - Ispettorato Generale, CRA - ISAFA, Trento. URL: http://www.<strong>in</strong>fc.it.<br />
INFC 2008. I caratteri quantitativi - parte 1. Autori P. Gaspar<strong>in</strong>i, F. De Natale, L. Di Cosmo, C.<br />
Gagliano, I. Salvadori, G. Tabacchi, V. Tosi. Inventario Nazionale <strong>del</strong>le Foreste e dei Serbatoi<br />
Forestali <strong>di</strong> Carbonio. MiPAF – Corpo Forestale <strong>del</strong>lo Stato - Ispettorato Generale, CRA - MFP,<br />
Trento.URL: http://www.<strong>in</strong>fc.it.<br />
La Marca O. 1981. Ricerche dendrometriche e auxometriche sui cedui <strong>di</strong> castagno (Castanea<br />
sativa Mill.) <strong>del</strong>la valle <strong>del</strong>l’Irno (AV e SA). Ann. Acc. It. Sci. For. XXX: 3-43.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Becagli C., Conedera M., Giu<strong>di</strong>ci F., 2001. Productive potentiality of<br />
chestnut (Castanea sativa Mill.) stands over Europe. Forest Snow Landscape Research 76 (3):<br />
471-476.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Cut<strong>in</strong>i A. 2002. Alternative silvicultural options for chestnut coppice<br />
stands: evaluation of the susta<strong>in</strong>ability by silvicultural and ecological <strong>in</strong><strong>di</strong>cators. Research<br />
Reports, Forestry and Wood Science and Technology, 67: 77-96.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Becagli C. 2004. Valorizzazione e recupero dei popolamenti <strong>di</strong> castagno<br />
da legno. Sherwood, 106: 5-10.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Becagli C. 2009a. Il ruolo <strong>del</strong> castagno nella selvicoltura italiana:<br />
prospettive colturali e valenza socio-economica. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> III Congresso Nazionale <strong>di</strong> Selvicoltura,<br />
Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze Forestali, vol. II: 842-850.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Becagli C. 2009b. La matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> castagno: retaggio<br />
culturale o esigenza colturale? Comunicazione orale al VII Congresso Nazionale SISEF<br />
sviluppo e adattamento, naturalità e conservazione: opportunità per un sistema forestale <strong>in</strong><br />
transizione. Isernia, 29 settembre – 3 ottobre 2009.<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E. Becagli C., Pelleri F, Pividori M., Schleppi P., Z<strong>in</strong>gg A., Conedera M.<br />
2009c. Quality wood production from chestnut (Castanea sativa Mill.) coppice forests.<br />
133
134<br />
Maria Chiara Manetti<br />
Comparison between <strong>di</strong>fferent silvicultural approaches. I Congresso Europeo sul castagno e V<br />
Convegno Nazionale sul Castagno (<strong>in</strong> stampa).<br />
Manetti M.C., Amor<strong>in</strong>i E., Becagli C., Cut<strong>in</strong>i A., Giann<strong>in</strong>i T. 2009d. Il cancro corticale e la<br />
produzione <strong>di</strong> legno. Forestaviva, n. 4: 28-29.<br />
Marchetto M., 1975. I cedui <strong>di</strong> castagno <strong>del</strong> Monte Amiata. Tesi <strong>di</strong> laurea, anno accademico 1974-<br />
1975 Firenze.<br />
Mattioli W., P<strong>in</strong>elli A., Filibeck G., Portoghesi L., Scoppola A., Corona P., 2008. Relazioni tra<br />
gestione selvicolturale, tipo forestale e <strong>di</strong>versità floristica <strong>in</strong> cedui castanili. Forest@ 5: 136-150.<br />
Meren<strong>di</strong> A. 1930. Produttività e red<strong>di</strong>ti dei cedui <strong>di</strong> castagno. L’Alpe 17, II serie: 20-24.<br />
Millot M. 1990. Les essais châtaigniers a Pompadour (Corrèze). Cemagref, Groupement de<br />
Nogent-sur-Vernisson, <strong>di</strong>vision “Techniques Forestières”. Documento <strong>in</strong>terno.<br />
Moran<strong>di</strong>ni R. 1966. Prospettive <strong>di</strong> conversione dei castagneti <strong>in</strong> cedui ed <strong>in</strong> boschi <strong>di</strong> altre specie.<br />
<strong>Atti</strong> <strong>del</strong> Convegno Internazionale sul Castagno, Cuneo: 151-161.<br />
Mori P. 2009. Cipollatura <strong>del</strong> castagno. Un <strong>di</strong>fetto frequente che la selvicoltura può attenuare.<br />
Sherwood, 151: 20-22.<br />
Paci M., Bianchi L., Maltoni A., Mariotti B. 2003. I castagneti da frutto abbandonati <strong>del</strong>la Toscana.<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Firenze, DISTAF: 79 pp.<br />
Pettenella D. 2001. Market<strong>in</strong>g perspectives and <strong>in</strong>struments for chestnut products and services.<br />
Forest Snow Landscape Research 76 (3): 511-517.<br />
Pettenella D., Secco L. 2002. I prodotti e i servizi che derivano dal castagno: nuovi strumenti <strong>di</strong><br />
market<strong>in</strong>g. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> “Convegno Nazionale Castagno 2001. Marra<strong>di</strong> 25-27 ottobre 2001. Pp. 294-<br />
299.<br />
Pividori M. 1995. Costruzione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>agramma selvicolturale per il bosco ceduo <strong>di</strong> castagno<br />
(Castanea sativa Mill.) <strong>del</strong>la coll<strong>in</strong>a morenica canavesana (TO). Monti e Boschi, 3: 12-17.<br />
Pividori M., Armando F., Conedera M. 2006. D<strong>in</strong>amiche post-colturali <strong>in</strong> un ceduo misto <strong>di</strong><br />
castagno ai suoi limiti ecologici. Forest@ 3 (1): 86-90.<br />
Rispoli E. 1958. I castagneti cedui <strong>del</strong>la montagna <strong>del</strong>la Stella (SA). Monti e Boschi 9: 263-272.<br />
Romagnoli M., Sp<strong>in</strong>a S. 2009. Le <strong>in</strong>terazioni legno-ambiente-selvicoltura nel castagno <strong>del</strong> Lazio. I<br />
Congresso Europeo sul castagno e V Convegno Nazionale sul Castagno (<strong>in</strong> stampa).<br />
Rubio A., Escudero A., 2003. Clear-cut effects on chestnut forest soils under stressful con<strong>di</strong>tion:<br />
lengthen<strong>in</strong>g of time-rotation. Forest Ecology and Management 183: 195-204.<br />
Santagada A., Maresi G., Turchetti T. 1996. Alcune <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni pratiche sulla <strong>di</strong>fesa dei castagneti.<br />
Sherwood, Foreste ed alberi oggi, XII, 518-521.<br />
Sp<strong>in</strong>a S., Agrumi M., Bistoni A., Romagnoli M. 2008. Cipollatura <strong>del</strong> castagno, un caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o nei<br />
Monti Cim<strong>in</strong>i. Sherwood, n 148: 45-50.<br />
Sp<strong>in</strong>a S., Agrumi M., Bistoni A., Cavalli D., Romagnoli M. 2009. Qualità <strong>del</strong> legno <strong>di</strong> castagno <strong>in</strong><br />
alcuni siti <strong>del</strong> Lazio. I Congresso Europeo sul castagno e V Convegno Nazionale sul Castagno<br />
(<strong>in</strong> stampa).<br />
Tani A., Maltoni A., Mariotti B., 2010. Results of experiments on chestnut cultivar for wood<br />
production. Acta Horticulturae Special Issue Acts of Castanea 2009 Food, Timber, Biomass &<br />
Energy <strong>in</strong> Europe 1st European Congress on Chestnut 5° Convegno Nazionale Castagno 13-16<br />
October – Cuneo – Italy.<br />
Turchetti T., Maresi, G. 1990. Indag<strong>in</strong>i sulla <strong>di</strong>ffusione naturale degli isolati ipovirulenti <strong>di</strong><br />
Cryphonectria parasitica <strong>in</strong> alcuni cedui <strong>di</strong> castagno. <strong>Atti</strong> Giornate Fitopatologiche 2, 89-98.<br />
Vanni G. 1981. Conversione dei cedui <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Lucca. Economia Montana, 4: 10-16.
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
135
136<br />
Maria Chiara Manetti
Selvicoltura dei cedui <strong>di</strong> castagno<br />
137
138<br />
Maria Chiara Manetti
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
BOSCHI CEDUI E RETE NATURA 2000<br />
GIORGIO IORIO 1 , MAURO FRATTEGIANI 2<br />
1 COMUNITÀ MONTANA VALNERINA<br />
2 LIBERO PROFESSIONISTA PERUGIA
140<br />
LA RETE NATURA 2000<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
Natura 2000 è il pilastro fondamentale <strong>del</strong>la politica <strong>del</strong>l'Unione Europea (UE) per la protezione<br />
<strong>del</strong>la natura e svolge un ruolo chiave per la bio<strong>di</strong>versità nel territorio <strong>del</strong>l'Unione.<br />
All'<strong>in</strong>izio degli anni '90 l'UE ha deciso <strong>di</strong> dotarsi <strong>di</strong> uno strumento che potesse da un lato attuare<br />
a livello europeo le Convenzioni Internazionali per la protezione <strong>del</strong>la natura e dall'altro superare il<br />
limite <strong>del</strong>la conservazione <strong>di</strong> specie e habitat m<strong>in</strong>acciati attraverso la protezione <strong>di</strong> s<strong>in</strong>gole isole <strong>di</strong><br />
territorio.<br />
Per questo è stata creata una Rete <strong>di</strong> aree costituita da Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS) e<br />
Zone Speciali <strong>di</strong> Conservazione (ZSC). Queste aree sono state designate dagli Stati Membri<br />
rispettivamente <strong>in</strong> base alla Direttiva "Uccelli" (2009/147/CE) 7 e alla Direttiva "Habitat"<br />
(92/43/CEE).<br />
La designazione avviene quando <strong>in</strong> un determ<strong>in</strong>ato territorio sono presenti habitat e specie <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>teresse comunitario elencate <strong>in</strong> queste Direttive.<br />
Nella prima sono elencate le specie <strong>di</strong> avifauna, nella seconda altre specie <strong>di</strong> fauna e <strong>di</strong> flora e -<br />
novità tra le strategie <strong>di</strong> conservazione- gli habitat.<br />
La costruzione <strong>del</strong>la Rete è avvenuta <strong>in</strong> varie fasi.<br />
Le ZPS sono state <strong>in</strong><strong>di</strong>viduate facendo riferimento alle Important Bird Areas (IBAs) <strong>in</strong><strong>di</strong>cate da<br />
BirdLife International, la federazione <strong>in</strong>ternazionale <strong>del</strong>le Associazioni Ambientaliste che hanno<br />
<strong>in</strong>teresse specifico per l'ornitofauna. Con la Direttiva <strong>del</strong> 1979, sostituita nel 2009 con un nuovo<br />
testo che <strong>in</strong> gran parte la ricalca, l'UE ha <strong>in</strong>teso proteggere strettamente alcune specie <strong>di</strong> uccelli<br />
m<strong>in</strong>acciati e ha voluto regolare la caccia e le altre attività connesse per altre specie.<br />
Per le ZSC, la procedura è maggiormente complessa <strong>in</strong> quanto lo Stato Membro propone i Siti<br />
<strong>di</strong> Importanza Comunitaria (pSIC) che l'UE approva <strong>in</strong> SIC dopo una serie <strong>di</strong> verifiche e<br />
approfon<strong>di</strong>menti (figura 1). Successivamente, entro un certa scadenza temporale (mo<strong>di</strong>ficata varie<br />
volte a causa <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicazione <strong>del</strong>le procedure), queste aree <strong>di</strong>ventano ZSC.<br />
Una volta costituita la Rete, gli Stati Membri devono attuare i Piani <strong>di</strong> Gestione (PdG) o le<br />
Misure <strong>di</strong> Conservazione (MdC) per ciascun Sito <strong>in</strong> modo tale da assicurare il mantenimento<br />
<strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente <strong>del</strong> Sito e <strong>del</strong>le specie e degli habitat <strong>in</strong> base alle quali è<br />
stato designato.<br />
La UE ha più volte specificato che la responsabilità <strong>del</strong>l'attuazione <strong>del</strong>le Direttive, <strong>del</strong>le<br />
procedure e <strong>del</strong>le norme connesse è degli Stati Membri. Sono sempre gli Stati membri che devono<br />
def<strong>in</strong>ire i meto<strong>di</strong> da adottare per la redazione dei PdG e <strong>del</strong>le MdC.<br />
In Italia la Direttiva "Uccelli" è stata recepita a livello nazionale con la L.157/1992 e la Direttiva<br />
"Habitat" con il D.P.R. 357/1997 e le loro attuazione è stata <strong>del</strong>egata alle Regioni.<br />
Il D.P.R. 357/1997 contiene gli elenchi <strong>di</strong> riferimento degli habitat (allegato A) e <strong>del</strong>le specie<br />
(allegato B) <strong>in</strong> base alle quali i Siti <strong>del</strong>la Rete sono designati. Sia gli habitat che le specie hanno<br />
due <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> importanza: habitat e specie <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse comunitario e habitat e specie<br />
prioritarie.<br />
Oltre a questi due allegati, il D.P.R. 357/1997 contiene l'elenco <strong>del</strong>le specie <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse<br />
comunitario per le quali viene prevista una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti (allegato D) che sostanzialmente ricalca il<br />
sistema <strong>di</strong> tutela orientato alle specie s<strong>in</strong>gole (<strong>di</strong>sturbo, caccia, cattura, ecc), l'elenco <strong>del</strong>le specie<br />
<strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse comunitario il cui prelievo <strong>in</strong> natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto <strong>di</strong><br />
specifiche misure <strong>di</strong> gestione (allegato E), i meto<strong>di</strong> e mezzi <strong>di</strong> cattura e <strong>di</strong> uccisione nonché le<br />
modalità <strong>di</strong> trasporto vietati (allegato F).<br />
Inoltre il D.P.R. 357/1997 <strong>in</strong><strong>di</strong>ca la procedura tecnico-amm<strong>in</strong>istrativa da attuare per i piani,<br />
progetti e <strong>in</strong>terventi che possono avere una <strong>in</strong>cidenza con lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong> Sito,<br />
specificando l'esclusione solo nei casi <strong>in</strong> cui questi sono <strong>di</strong>rettamente connessi e necessari al<br />
mantenimento <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente <strong>del</strong>le specie e degli habitat presenti<br />
nel Sito stesso.<br />
7 La precedente versione <strong>del</strong>la Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE è stata abrogata con la Direttiva 2009/147/EC.
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
Figura 1 - Iter Procedurale per l’approvazione dei pSIC <strong>in</strong> SIC. (da Natura 2000 Italia <strong>in</strong>forma n.0 - MATT<br />
settembre 2002)<br />
Per gli habitat lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente è def<strong>in</strong>ito quando:<br />
- l'area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o <strong>in</strong> estensione,<br />
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo term<strong>in</strong>e<br />
esistono e possono cont<strong>in</strong>uare ad esistere <strong>in</strong> un futuro preve<strong>di</strong>bile;<br />
- lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>le specie tipiche è sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
Per le specie lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente è def<strong>in</strong>ito quando:<br />
- i dati relativi all'andamento <strong>del</strong>le popolazioni <strong>del</strong>la specie <strong>in</strong><strong>di</strong>cano che essa cont<strong>in</strong>ua e può<br />
cont<strong>in</strong>uare a lungo term<strong>in</strong>e ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui<br />
appartiene;<br />
- l'area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione naturale <strong>del</strong>le specie non è <strong>in</strong> decl<strong>in</strong>o né rischia <strong>di</strong> decl<strong>in</strong>are <strong>in</strong> un<br />
futuro preve<strong>di</strong>bile;<br />
- esiste e cont<strong>in</strong>uerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente aff<strong>in</strong>ché le sue<br />
popolazioni si mantengano a lungo term<strong>in</strong>e.<br />
L'allegato G dà <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni su come deve essere organizzata la relazione o stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>in</strong>cidenza<br />
per i piani e progetti.<br />
Nel caso <strong>di</strong> progetti, piani o <strong>in</strong>terventi che possano avere un impatto significativo sullo stato <strong>di</strong><br />
conservazione <strong>di</strong> un habitat o <strong>di</strong> una specie <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse comunitario all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> sito <strong>del</strong>la Rete<br />
Natura 2000, l’autorizzazione può essere concessa esclusivamente per ragioni <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse<br />
pubblico o per motivi connessi alla salute umana/sicurezza, con adeguate misure <strong>di</strong><br />
compensazione ed eventualmente previa consultazione <strong>del</strong>la Commissione (figura 2).<br />
141
142<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
Figura 2. Considerazione <strong>di</strong> piani e progetti concernenti siti Natura 2000, (da: “Guida all´<strong>in</strong>terpretazione<br />
<strong>del</strong>l´articolo 6 <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva «Habitat» 92/43/CEE”. Commissione Europea, 2000)<br />
Per quanto riguarda i PdG, la Commissione Europea, pur <strong>in</strong><strong>di</strong>cando la non obbligatorietà <strong>del</strong>la<br />
loro redazione, ne ha sistematicamente promosso l'elaborazione. Questo perché si ritiene che
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
questo strumento possa contribuire alla corretta gestione <strong>del</strong>la conservazione dei Siti attraverso un<br />
quadro <strong>di</strong> valutazione <strong>del</strong>la compatibilità <strong>di</strong> usi <strong>di</strong>versi. La CE sostiene che i PdG costituiscono un<br />
modo eccellente per co<strong>in</strong>volgere attivamente nelle decisioni gestionali i pr<strong>in</strong>cipali gruppi <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>teresse che subiscono le conseguenze <strong>del</strong>la designazione <strong>di</strong> un Sito. Inoltre la DG Ambiente<br />
raccomanda che tali PdG abbiano valore giuri<strong>di</strong>co.<br />
Allo stesso tempo ha chiaramente precisato che Natura 2000 non è un sistema <strong>di</strong> riserve<br />
naturali <strong>in</strong>tegrali dove le attività umane devono essere escluse. Anzi ha sottol<strong>in</strong>eato, <strong>in</strong> molti<br />
documenti tecnici e <strong>di</strong>vulgativi, che tranne casi eccezionali, le attività umane sono previste con<br />
modalità <strong>di</strong> gestione ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibili.<br />
A livello <strong>del</strong>l'UE, i dati <strong>di</strong>sponibili più aggiornati sulla costituzione <strong>del</strong>la Rete Natura 2000<br />
risalgono al <strong>di</strong>cembre 2009 e sono illustrati, per i Siti terrestri, nella tabella seguente (tab. 1, fonte<br />
CE - DG Ambiente). L'Italia ha designato una percentuale <strong>di</strong> superficie pari a circa un qu<strong>in</strong>to <strong>di</strong><br />
quella totale, dato che risulta appena superiore alla me<strong>di</strong>a europea.<br />
Stato Membro<br />
Tab. 1<br />
Natura 2000 - Dati Siti Terrestri - <strong>di</strong>cembre 2009<br />
Superficie<br />
territoriale<br />
km²<br />
Superficie<br />
Natura 2000<br />
km²<br />
% Natura 2000<br />
su Territorio<br />
AT 83.859 11.533 13,8<br />
BE 30.528 3.883 12,7<br />
BG 110.910 37.656 34<br />
CY 5.736 1.005 17,5<br />
CZ 78.866 10.986 13,9<br />
DE 357.031 54.898 15,4<br />
DK 43.093 3.840 8,9<br />
EE 45.226 8.012 17,7<br />
ES 504.782 144.697 28,7<br />
FI 338.145 48.839 14,4<br />
FR 549.192 68.726 12,5<br />
GR 131.940 27.723 21<br />
HU 93.030 19.670 21,1<br />
IE 70.280 7.800 11,1<br />
IT 301.333 57.454 19,1<br />
LT 65.301 9.085 13,9<br />
LU 2.597 462 17,8<br />
LV 64.589 7.284 11,3<br />
MT 316 41 13<br />
NL 41.526 5.735 13,8<br />
PL 312.685 60.745 19,4<br />
PT 91.990 19.262 20,9<br />
RO 238.391 42.647 17,9<br />
SE 414.864 57.133 13,8<br />
SI 20.273 7.201 35,5<br />
SK 48.845 14.128 28,9<br />
UK 244.820 17.295 7,1<br />
EU27 4.290.148 754.710 17,6<br />
Si segnala l'elevata percentuale <strong>di</strong> superficie designata nei paesi <strong>di</strong> nuova <strong>in</strong>clusione nell'UE<br />
(Stati balcanici e orientali) che <strong>in</strong> parte è motivata da un maggiore approfon<strong>di</strong>mento<br />
143
144<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
nell'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione dei nuovi habitat, frutto <strong>del</strong>le esperienze <strong>del</strong>le precedenti fasi effettuate nei primi<br />
Stati Membri dal 1992 al 2007.<br />
LE FORESTE E NATURA 2000<br />
Gli habitat forestali <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse comunitario sono quelle "foreste (sub) naturali <strong>di</strong> specie<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>gene <strong>di</strong> impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico<br />
sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong><br />
specie d'<strong>in</strong>teresse comunitario".<br />
L'elenco ha subito alcune mo<strong>di</strong>fiche nel tempo sia per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti conoscitivi e<br />
scientifici che per il processo <strong>di</strong> allargamento <strong>del</strong>l'UE con l'<strong>in</strong>serimento <strong>di</strong> nuovi habitat <strong>del</strong>l'Europa<br />
orientale.<br />
Figura 3.<br />
Secondo i dati <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l'Ambiente e <strong>del</strong>la Tutela <strong>del</strong> Territorio e <strong>del</strong> Mare (MATTM)<br />
sono segnalati per l'Italia i seguenti habitat forestali presenti nelle varie aree biogeografiche<br />
(tabella 2).<br />
La tabella 3 mostra, <strong>in</strong>vece, l'entità <strong>del</strong>la superficie forestale <strong>in</strong>clusa nella Rete Natura 2000 <strong>in</strong><br />
Italia secon<strong>di</strong> i dati <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l'Ambiente e <strong>del</strong>la Tutela <strong>del</strong> Territorio e <strong>del</strong> Mare (MATTM) e<br />
<strong>in</strong> base alla sud<strong>di</strong>visione nelle varie tipologie gestionali <strong>in</strong><strong>di</strong>cate nell'Inventario Nazionale <strong>del</strong>le<br />
Foreste e dei Serbatoi Forestali <strong>di</strong> Carbonio (INFC).<br />
Come si può notare, mentre <strong>in</strong> alcune Regioni i boschi governati a ceduo praticamente sono<br />
<strong>in</strong>esistenti o poco rilevanti, <strong>in</strong> altre (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Toscana) sono il<br />
doppio <strong>del</strong>le fustaie e altre ancora (Marche e Umbria) <strong>in</strong> cui sono circa 5 volte la superficie <strong>del</strong>le<br />
fustaie.<br />
Si può ritenere qu<strong>in</strong><strong>di</strong> che, soprattutto nell'Italia centrale, il governo ceduo ha una rilevanza<br />
notevole <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> superficie occupata nei Siti <strong>del</strong>la Rete Natura 2000.
Tab. 2.<br />
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
Co<strong>di</strong>ce Prioritario Nome ALPINA CONT MED<br />
91 - Forests of Temperate Europe<br />
9110 Luzulo-Fagetum beech forests X X X<br />
9120<br />
Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also<br />
Taxus <strong>in</strong> the shrublayer<br />
X X<br />
9130 Asperulo-Fagetum beech forests X X X<br />
9140<br />
Me<strong>di</strong>o-European subalp<strong>in</strong>e beech woods with Acer and Rumex<br />
arifolius<br />
X<br />
9150<br />
Me<strong>di</strong>o-European limestone beech forests of the Cephalanthero-<br />
Fagion<br />
X X X<br />
9160<br />
Sub-Atlantic and me<strong>di</strong>o-European oak or oakhornbeam forests of the<br />
Carp<strong>in</strong>ion betuli<br />
X X X<br />
9170 Galio-Carp<strong>in</strong>etum oak-hornbeam forests X<br />
9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, screes and rav<strong>in</strong>es X X X<br />
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy pla<strong>in</strong>s X X<br />
91B0 Thermophilous Frax<strong>in</strong>us angustifolia woods X<br />
91D0 * Bog woodland X<br />
91E0 *<br />
Alluvial forests with Alnus glut<strong>in</strong>osa and Frax<strong>in</strong>us excelsior (Alno-<br />
Pa<strong>di</strong>on, Alnion <strong>in</strong>canae, Salicion alvae)<br />
Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus<br />
X X X<br />
91F0<br />
m<strong>in</strong>or, Frax<strong>in</strong>us excelsior or Frax<strong>in</strong>us angustifolia, along the great<br />
rivers (Ulmenion m<strong>in</strong>oris)<br />
X X X<br />
91H0 * Pannonian woods with Quercus pubescens X X X<br />
91K0 Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion) X<br />
91L0 Illyrian Oak-hornbean forests (Erythronio-Carp<strong>in</strong>ion) X X X<br />
91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests X X X<br />
91AA * Eastern white oak woods X<br />
92 - Me<strong>di</strong>terranean deciduous forests<br />
9210 * Apenn<strong>in</strong>e beech forests with Taxus and Ilex X X X<br />
9220 *<br />
Apenn<strong>in</strong>e beech forests with Abies alba and beech forests with Abies<br />
nebrodensis<br />
9250 Quercus trojana woods X<br />
9260 Castanea sativa woods X X X<br />
9280 Quercus fra<strong>in</strong>etto woods X<br />
92A0 Salix alba and Populus alba galleries X X X<br />
92C0<br />
Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion<br />
X<br />
92D0<br />
orientalis)<br />
Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and<br />
Secur<strong>in</strong>egion t<strong>in</strong>ctoriae)<br />
93 - Me<strong>di</strong>terranean scerophyllous forests<br />
9320 Olea and Ceratonia forests X<br />
9330 Quercus suber forests X<br />
9340 Quercus ilex and Quercus rotun<strong>di</strong>folia forests X X X<br />
9350 Quercus macrolepis forests X<br />
9380 Forests of Ilex aquifolium X<br />
94 - Temperate mounta<strong>in</strong>ous coniferous forests<br />
9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alp<strong>in</strong>e Levels X X<br />
9420 Alp<strong>in</strong>e Larix decidua and/or P<strong>in</strong>us cembra forests X<br />
9430 *<br />
Subalp<strong>in</strong>e and montane P<strong>in</strong>us unc<strong>in</strong>ata forests (* if on gypsum or<br />
limestone)<br />
X X<br />
95 - Me<strong>di</strong>terranean and Macaronesian mounta<strong>in</strong>ous coniferous forests<br />
9510 Southern apenn<strong>in</strong>e Abies alba forest X<br />
9530 (Sub-)Me<strong>di</strong>terreanean p<strong>in</strong>e forest with endemic black p<strong>in</strong>es X X X<br />
9540 Me<strong>di</strong>terranean p<strong>in</strong>e forests with endemic Mesogean P<strong>in</strong>es X X X<br />
9560 Endemic forests with Juniperus spp. X<br />
9580 Me<strong>di</strong>terranean Taxus baccata woods X<br />
X<br />
145
146<br />
Tab. 3.<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
La gestione forestale nei siti <strong>del</strong>la Rete Natura 2000<br />
La Commissione Europea (CE) si è occupata varie volte <strong>di</strong> gestione forestale all'<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la<br />
Rete Natura 2000 e <strong>in</strong> particolare nel numero 16 <strong>del</strong>la Newsletter, <strong>in</strong> "LIFE and European forests",<br />
ma soprattutto nella guida <strong>in</strong>terpretativa "Natura 2000 e foreste: sfide e opportunità" pubblicata<br />
nel 2003 (fig. 4).<br />
Fig. 4.
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
Questo documento parte dalla Strategia Forestale Europea che <strong>in</strong>vita i gestori forestali a tenere<br />
conto <strong>del</strong>le seguenti l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità:<br />
idonee misure <strong>di</strong> adeguamento <strong>del</strong> sito me<strong>di</strong>ante una serie <strong>di</strong> tecniche selvicolturali comb<strong>in</strong>ate<br />
con misure accessorie (ad esempio, il rispetto <strong>del</strong> legno morto e <strong>di</strong> altri microhabitat chiave<br />
presenti nelle foreste);<br />
mantenimento <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la vitalità <strong>del</strong>l’ecosistema forestale rafforzando la capacità <strong>di</strong><br />
r<strong>in</strong>novazione, la resilienza e la capacità adattiva degli ecosistemi forestali;<br />
recupero e riprist<strong>in</strong>o <strong>di</strong> zone, specie, popolazioni, habitat ed ecosistemi degradati;<br />
mantenimento <strong>del</strong>la gestione tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> quei sistemi silvo-pastorali con elevati livelli <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità che potrebbero andare perduti se queste zone fossero abbandonate (ad esempio nelle<br />
regioni me<strong>di</strong>terranee);<br />
miglioramento <strong>del</strong>le tecniche <strong>di</strong> taglio, allestimento ed esbosco (produzione) per limitare il più<br />
possibile i danni connessi.<br />
La CE ci ricorda nuovamente che <strong>in</strong> materia <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong>le foreste, le Direttive fissano<br />
soltanto un numero limitato <strong>di</strong> requisiti generali e che non è possibile fornire <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni specifiche<br />
su questione come la restrizione su certi tipi <strong>di</strong> taglio, sulle loro <strong>di</strong>mensioni, sulla durata degli<br />
<strong>in</strong>terventi ecc. <strong>in</strong> quanto <strong>di</strong>pendono dalle misure gestionali specifiche per quel dato Sito (che<br />
dovrebbero essere negoziate a livello locale fra le autorità competenti e i gestori/proprietari <strong>di</strong><br />
foreste).<br />
La prosecuzione <strong>del</strong>le attività economiche nell’ambito <strong>di</strong> una gestione sostenibile <strong>del</strong>le<br />
foreste potrebbe <strong>in</strong> molti casi rientrare <strong>in</strong> una strategia <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>la natura per gli<br />
ecosistemi forestali <strong>in</strong> regioni <strong>in</strong> cui sono ampiamente <strong>di</strong>ffuse tra<strong>di</strong>zioni storiche <strong>di</strong> utilizzo <strong>del</strong>le<br />
foreste come ad esempio nell'Europa me<strong>di</strong>terranea.<br />
In particolare sono ammesse le attività che perturbano la superficie forestale per un tempo e<br />
uno spazio limitato (ad esempio, il taglio a gruppi) o con <strong>in</strong>tensità limitata (ad esempio, il<br />
<strong>di</strong>radamento), a con<strong>di</strong>zione che non pregiu<strong>di</strong>ch<strong>in</strong>o il riprist<strong>in</strong>o <strong>del</strong>la situazione orig<strong>in</strong>aria me<strong>di</strong>ante<br />
r<strong>in</strong>novazione naturale, che può richiedere numerose fasi <strong>di</strong> successione naturale.<br />
Entrando poi negli aspetti tecnico-gestionali, la Guida <strong>in</strong>terpretativa si sofferma su alcuni<br />
elementi chiave <strong>di</strong> cui è necessario tenere conto per attuare la gestione forestale all'<strong>in</strong>terno dei<br />
Siti <strong>del</strong>la Rete:<br />
• forma <strong>di</strong> utilizzazione: taglio raso (<strong>di</strong>mensione), taglio a strisce, taglio a gruppi, taglio a<br />
scelta, assenza <strong>di</strong> utilizzazione;<br />
• tecnica <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione: rimboschimento, moltiplicazione vegetale, r<strong>in</strong>novazione<br />
naturale (con qualsiasi misura aggiuntiva volta ad <strong>in</strong>fluenzare la composizione <strong>del</strong>le<br />
specie);<br />
• utilizzo <strong>di</strong> alberi esotici rispetto a quelli autoctoni; utilizzo <strong>di</strong> composizioni <strong>di</strong> specie<br />
autoctone specifiche <strong>del</strong> sito;<br />
• orig<strong>in</strong>e <strong>del</strong> materiale <strong>di</strong> propagazione forestale (conformemente al quadro<br />
regolamentare obbligatorio <strong>del</strong>la Comunità sul movimento <strong>di</strong> semi da bosco, talee e<br />
postime, è necessario ricordare che l’utilizzo <strong>di</strong> specie autoctone per la riforestazione<br />
può avere risultati negativi e determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento genetico se la provenienza <strong>del</strong><br />
materiale non è verificata);<br />
• durata <strong>del</strong>la rotazione (per popolamenti o per unità arborea);<br />
• aratura o altre attività che perturbano il suolo;<br />
• regimi <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento;<br />
• gestione <strong>di</strong> caccia e pascolo;<br />
• ricorso agli <strong>in</strong>cen<strong>di</strong> prescritti;<br />
• prosecuzione <strong>di</strong> pratiche tra<strong>di</strong>zionali (ad esempio boschi cedui e comuni, taillis-sousfutaie/Mittelwald).<br />
Come si può notare le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni sono <strong>in</strong>fluenzate soprattutto dalle tecniche e dalle tra<strong>di</strong>zioni<br />
forestali dei paesi <strong>del</strong> Centro e Nord Europa (es. arature), mentre -come spesso accade nei<br />
documenti europei- sono poco rilevanti gli aspetti legati all'ambiente e alla socio-economia <strong>del</strong>le<br />
aree me<strong>di</strong>terranee.<br />
In ogni caso si può affermare che la gestione a ceduo non è esclusa <strong>in</strong> via <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipio tra<br />
quelle possibili all'<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la Rete Natura 2000.<br />
147
148<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
Inoltre la Guida <strong>in</strong><strong>di</strong>ca, nel paragrafo de<strong>di</strong>cato all'Italia, che le foreste dei siti italiani <strong>del</strong>la rete<br />
Natura 2000 <strong>di</strong> norma rappresentano aree <strong>in</strong> cui l’<strong>in</strong>tervento umano e il processo naturale si sono<br />
comb<strong>in</strong>ati nei secoli per produrre un equilibrio ecologico. In questo modo, la gestione <strong>di</strong> aree<br />
sem<strong>in</strong>aturali — una componente essenziale per la coerenza <strong>del</strong>la rete Natura 2000 — <strong>di</strong>viene un<br />
mezzo efficace <strong>di</strong> sviluppo per le zone rurali e le foreste che ne fanno parte.<br />
Così lo stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat forestali <strong>di</strong>viene un <strong>in</strong><strong>di</strong>ce <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tegrazione<br />
ambientale <strong>di</strong> attività umane e, contemporaneamente, un banco <strong>di</strong> prova cont<strong>in</strong>uo <strong>del</strong>l’efficacia<br />
degli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi gestionali adottati.<br />
In particolare a riguardo degli habitat forestali me<strong>di</strong>terranei <strong>in</strong> cui prevalgono le specie<br />
querc<strong>in</strong>e (es.: *91H0, 91L0, 91AA, 9340), la Guida propone uno schema <strong>di</strong> massima che prevede<br />
alcune opzioni gestionali <strong>di</strong> riferimento a seconda <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>l'habitat (tabella<br />
4).<br />
Tab. 4.<br />
Habitat <strong>in</strong> stato <strong>di</strong><br />
conservazione:<br />
Opzione A Opzione B<br />
sod<strong>di</strong>sfacente Prosecuzione <strong>del</strong>la coltivazione Conversione dei popolamenti <strong>in</strong><br />
<strong>di</strong> cedui con meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> gestione<br />
meno <strong>in</strong>tensivi che favoriscano<br />
il mantenimento degli alberi e<br />
<strong>del</strong>la <strong>di</strong>versità compositiva;<br />
fustaie<br />
non sod<strong>di</strong>sfacente Conversione dei popolamenti <strong>in</strong> Estensione dei cicli <strong>di</strong> coltivazione,<br />
fustaie se realizzabile da un adozione <strong>di</strong> idonee pratiche <strong>di</strong><br />
punto <strong>di</strong> vista economico ed<br />
ecologico<br />
gestione per il recupero dei cedui<br />
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT<br />
FORESTALI DELLA RETE NATURA 2000<br />
Il D. M. <strong>del</strong> 3 settembre 2002 emanato dal M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l'ambiente e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio e<br />
riguardante le “L<strong>in</strong>ee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
italiana n. 224 <strong>del</strong> 24 settembre 2002), recita:<br />
La gestione <strong>di</strong> un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve rispondere a un unico<br />
obbligo <strong>di</strong> risultato: salvaguardare l'efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie<br />
alle quali il sito è «de<strong>di</strong>cato» contribuendo così a scala locale a realizzare le f<strong>in</strong>alità generali <strong>del</strong>la<br />
<strong>di</strong>rettiva. A tale scopo è necessario tradurre il concetto <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente<br />
<strong>del</strong>l'habitat/specie a scala <strong>di</strong> rete (ve<strong>di</strong> art. 1e-i, <strong>di</strong>rettiva Habitat) <strong>in</strong> parametri rilevabili a scala <strong>di</strong><br />
sito, che forniscano <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni circa le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>la risorsa d'<strong>in</strong>teresse<br />
(<strong>in</strong><strong>di</strong>catori).<br />
Nell’ambito <strong>del</strong>la gestione <strong>di</strong> un dato habitat <strong>in</strong> un sito <strong>del</strong>la rete Natura 2000, gli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori da<br />
utilizzare per valutare lo stato <strong>di</strong> conservazione devono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> permettere <strong>di</strong> ottenere <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni<br />
quantificabili su:<br />
mantenimento <strong>del</strong>l’estensione costante nel tempo;<br />
stato <strong>del</strong>la struttura e <strong>del</strong>la funzionalità ecosistemica <strong>del</strong>l’habitat e trend evolutivi a lungo<br />
term<strong>in</strong>e.<br />
Come specificato nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” (M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l’ambiente e<br />
<strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong> territorio, 2002), lo stato <strong>di</strong> conservazione non può essere valutato esam<strong>in</strong>ando i<br />
s<strong>in</strong>goli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori, <strong>in</strong> specifiche situazioni e <strong>in</strong> determ<strong>in</strong>ati stati temporali: per valutare lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione <strong>di</strong> un habitat è <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile <strong>in</strong>fatti <strong>in</strong>tegrare i <strong>di</strong>versi <strong>in</strong><strong>di</strong>catori (comportando<br />
spesso un approccio multi<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are), su livelli spaziali multipli (dal microhabitat al paesaggio) e<br />
considerando la situazione <strong>in</strong> senso <strong>di</strong>namico (<strong>di</strong>verse scale temporali).<br />
L’impostazione metodologica da seguire per l’analisi degli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori utili a verificare lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione a lungo term<strong>in</strong>e degli habitat d’<strong>in</strong>teresse, come suggerito anche nella guida per la<br />
gestione dei siti natura 2000 (M<strong>in</strong>istero per l’ambiente e la tutela <strong>del</strong> territorio, 2002), può fare
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
riferimento allo schema <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>catori <strong>del</strong>l’Agenzia Europea per l’Ambiente, elaborato da Shaw e<br />
W<strong>in</strong>d (1997) e illustrato <strong>in</strong> figura 5.<br />
Per ciascun <strong>in</strong><strong>di</strong>catore va determ<strong>in</strong>ato l'<strong>in</strong>tervallo che, nello stato <strong>di</strong> conservazione <strong>del</strong>l’habitat o<br />
<strong>del</strong>la specie esam<strong>in</strong>ati, corrisponde a "con<strong>di</strong>zioni favorevoli", rappresentato dalla fascia <strong>in</strong> grigio<br />
nella figura. Entro questo <strong>in</strong>tervallo sono accettabili, e anche fisiologiche, tutte le possibili variazioni<br />
degli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori (per fluttuazioni perio<strong>di</strong>che, andamenti climatici, evoluzione <strong>del</strong>l’ecosistema, ecc.).<br />
La strategia <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> un sito, pertanto, si configura nel mantenimento e nel miglioramento <strong>di</strong><br />
questo stato.<br />
Le <strong>di</strong>namiche naturali che si rispecchiano negli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori possono essere mo<strong>di</strong>ficate da<br />
un'attività antropica dannosa o da una perturbazione naturale, <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> <strong>in</strong>nescare fenomeni <strong>di</strong><br />
degrado <strong>del</strong>la risorsa che, come <strong>in</strong><strong>di</strong>cato schematicamente <strong>in</strong> figura, si manifestano <strong>in</strong> un decl<strong>in</strong>o<br />
più o meno rapido nei valori degli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori, rispetto all’<strong>in</strong>tervallo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni favorevoli.<br />
Figura 5. Cambiamenti nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>del</strong>la risorsa (habitat o specie) nel corso <strong>del</strong> tempo (mo<strong>di</strong>ficato da<br />
Shaw e W<strong>in</strong>d, 1997).<br />
In l<strong>in</strong>ea generale, il Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l’Ambiente<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>vidua 7 gruppi <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>catori, riportati nell’elenco seguente:<br />
COMPLESSITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL MOSAICO TERRITORIALE<br />
• Elenco degli habitat presenti nel sito<br />
• Estensione complessiva <strong>del</strong>l’habitat<br />
• Dimensione <strong>del</strong>la tessera più estesa <strong>del</strong>l’habitat<br />
• Grado <strong>di</strong> aggregazione <strong>del</strong>l’habitat<br />
• Rapporto perimetro/superficie <strong>del</strong>l’habitat<br />
• Me<strong>di</strong>a <strong>del</strong>le <strong>di</strong>stanze m<strong>in</strong>ime tra le tessere <strong>del</strong>l’habitat<br />
ASSETTO FLORISTICO E VEGETAZIONALE<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali <strong>di</strong> elevato valore biogeografico e conservazionistico<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie alloctone vegetali<br />
• Analisi fitosociologica<br />
ASSETTO FORESTALE<br />
• Struttura verticale<br />
• Distribuzione <strong>del</strong>le classi <strong>di</strong>mensionali e tessitura <strong>del</strong>l’habitat<br />
• Grado <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>le chiome<br />
• Processi <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione naturale<br />
• Alterazioni <strong>del</strong>lo stato vegetativo<br />
149
150<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
• Presenza <strong>di</strong> alberi morti <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> e necromassa<br />
• Gra<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> decomposizione <strong>del</strong>la lettiera<br />
• Valore pastorale<br />
• Rapporto tra carico reale e carico potenziale<br />
ASSETTO FAUNISTICO<br />
• Processi <strong>in</strong>formativi <strong>di</strong> base<br />
• Status <strong>del</strong>le zoocenosi<br />
• Composizione <strong>di</strong> zoocenosi guida<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie animali a elevato valore biogeografico<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie animali rare e/o m<strong>in</strong>acciate<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie animali alloctone<br />
• Importanza faunistica <strong>del</strong> sito nel panorama italiano<br />
• Considerazioni relative alle <strong>di</strong>mensioni degli home range <strong>del</strong>le specie animali <strong>in</strong><strong>di</strong>cate<br />
• dalla <strong>di</strong>rettiva uccelli (allegato I) e dalla <strong>di</strong>rettiva habitat (allegato II)<br />
• Posizione <strong>del</strong> sito rispetto al sistema <strong>del</strong>le aree protette<br />
ASSETTO IDROBIOLOGICO (zone umide)<br />
• Composizione, abbondanza e biomassa <strong>del</strong> fitoplancton<br />
• Composizione e copertura-abbondanza <strong>del</strong>l'altra flora acquatica (arboreo-arbustiva,<br />
idrofite emerse, idrofite ra<strong>di</strong>cate flottanti, idrofite ra<strong>di</strong>cate sommerse, idrofite libere)<br />
• Composizione, abbondanza e struttura <strong>di</strong> età <strong>del</strong>la fauna ittica<br />
• Composizione e abbondanza dei macro<strong>in</strong>vertebrati bentonici<br />
• Elementi <strong>di</strong> valore naturalistico (<strong>in</strong> senso ampio e non solo limitato alla specie)<br />
• Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici<br />
• Variazione <strong>del</strong>la profon<strong>di</strong>tà<br />
• Struttura e substrato <strong>del</strong> letto<br />
• Tipo, frequenza, durata <strong>del</strong>l’ alimentazione pr<strong>in</strong>cipale<br />
• Direzione <strong>del</strong>le correnti dom<strong>in</strong>anti<br />
• Esposizione alle onde<br />
• Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici<br />
• Trasparenza<br />
• Con<strong>di</strong>zioni termiche<br />
• Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ossigenazione<br />
• Sal<strong>in</strong>ità<br />
• Con<strong>di</strong>zione dei nutrienti<br />
• Inqu<strong>in</strong>anti specifici<br />
• Inqu<strong>in</strong>amento da tutte le sostanze <strong>del</strong>l'elenco <strong>di</strong> priorità <strong>di</strong> cui è stato accertato lo<br />
scarico nel corpo idrico<br />
• Inqu<strong>in</strong>amento da altre sostanze <strong>di</strong> cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico <strong>in</strong><br />
quantità significative<br />
FATTORI DI DISTURBO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALI<br />
• Effetti <strong>del</strong>la degradazione <strong>del</strong> suolo<br />
• Effetti degli <strong>in</strong>cen<strong>di</strong> boschivi e pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />
• Effetti <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento atmosferico su specie vegetali<br />
ASSETTO SOCIOECONOMICO<br />
• Ripartizione dei regimi <strong>di</strong> proprietà all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> sito<br />
• Rapporto tra variazione percentuale annua <strong>del</strong>la popolazione residente nei comuni<br />
rurali e variazione percentuale annua <strong>del</strong>la popolazione residente nei comuni urbani<br />
• Tasso <strong>di</strong> attività totale <strong>del</strong>la popolazione <strong>in</strong> età lavorativa e tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione<br />
giovanile<br />
• Tasso <strong>di</strong> scolarità<br />
• Presenze turistiche per abitante e unità <strong>di</strong> superficie<br />
• Determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong> grado <strong>di</strong> ruralità
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
Sulla base <strong>del</strong>le considerazioni generali sopra esposte, vengono elencati <strong>di</strong> seguito gli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori<br />
utilizzabili per il settore forestale, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> valutare lo stato <strong>di</strong> conservazione e il valore dei <strong>di</strong>versi<br />
popolamenti considerati habitat <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse comunitario:<br />
• estensione <strong>del</strong>l’habitat all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> sito (<strong>in</strong> percentuale e <strong>in</strong> ettari);<br />
• grado <strong>di</strong> frammentazione (estensione me<strong>di</strong>a dei popolamenti);<br />
• percentuale <strong>di</strong> aree <strong>in</strong>terne [core area], considerando una zona perimetrale <strong>di</strong> 30 m<br />
(percentuale sull’estensione <strong>del</strong>l’habitat);<br />
• livello <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità all’<strong>in</strong>terno degli habitat forestali (ricchezza floristica strato arboreo);<br />
• forma <strong>di</strong> governo attuata (ripartizione percentuale tra ceduo e alto fusto);<br />
• variabilità <strong>del</strong>lo sta<strong>di</strong>o evolutivo (ripartizione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi, con<br />
riferimento alla struttura verticale e alla tessitura);<br />
• <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le classi <strong>di</strong>mensionali e tessitura (ripartizione percentuale tra le <strong>di</strong>verse<br />
classi);<br />
• grado <strong>di</strong> copertura (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi);<br />
• presenza <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi);<br />
• <strong>di</strong>ffusione e composizione <strong>del</strong>lo strato arbustivo (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse<br />
classi);<br />
• alterazioni <strong>del</strong>lo stato vegetativo;<br />
• presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesti (percentuale <strong>di</strong> zone con <strong>di</strong>ssesti);<br />
• alberi morti <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> e necromassa (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi);<br />
• gra<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> decomposizione <strong>del</strong>la lettiera (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse<br />
classi);<br />
• presenza <strong>di</strong> microhabitat (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi);<br />
• dendromassa presente (<strong>di</strong>stribuzione percentuale tra le <strong>di</strong>verse classi <strong>di</strong> area<br />
basimetrica).<br />
Gli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori sopra elencati non sono utilizzabili aprioristicamente per tutte le tipologie <strong>di</strong> habitat<br />
e per tutti i contesti, né possono essere applicati dei valori costanti per ciascun <strong>in</strong><strong>di</strong>catore al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong><br />
valutare se le con<strong>di</strong>zioni risultano favorevoli o meno. A titolo <strong>di</strong> esempio, il numero ottimale <strong>di</strong><br />
piante <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>mensioni all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un popolamento dovrà necessariamente essere m<strong>in</strong>ore<br />
nel caso <strong>di</strong> un bosco a prevalenza <strong>di</strong> roverella rispetto a un bosco a prevalenza <strong>di</strong> leccio, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong><br />
garantire nel tempo la sostenibilità e la conservazione <strong>del</strong>l’habitat <strong>in</strong> questione.<br />
LA GESTIONE A CEDUO DEGLI HABITAT FORESTALI DELLA RETE NATURA 2000<br />
Il governo a ceduo ha, come tutti i sistemi <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong>le foreste, alcuni vantaggi e alcuni<br />
svantaggi. Tra i primi il breve ciclo produttivo, la certezza <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione, la facilità <strong>di</strong> gestione.<br />
Gli svantaggi pr<strong>in</strong>cipali sono <strong>in</strong>vece una maggiore semplificazione <strong>del</strong>l'ecosistema, un più forte<br />
impatto sul paesaggio al momento dei tagli <strong>di</strong> utilizzazione, una m<strong>in</strong>ore protezione <strong>del</strong> suolo a<br />
causa degli <strong>in</strong>terventi ravvic<strong>in</strong>ati nel tempo e <strong>del</strong>la forte <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la copertura <strong>del</strong> suolo ad<br />
ogni ceduazione.<br />
Con il governo a ceduo i cicli <strong>di</strong> produzione hanno una durata <strong>di</strong> qualche decennio.<br />
Attualmente il turno dei boschi governati a ceduo (periodo che <strong>in</strong>tercorre tra una ceduazione e la<br />
successiva) è <strong>di</strong> circa 20 – 30 anni. In passato, legato alla produzione <strong>di</strong> carbone per la quale<br />
servivano piante <strong>di</strong> piccolo <strong>di</strong>ametro, era anche <strong>di</strong> soli 13 -15 anni e ai tempi degli antichi Romani<br />
ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> 5 – 10 anni.<br />
La gestione <strong>del</strong>la fustaia <strong>in</strong>vece avviene <strong>in</strong> base a cicli <strong>di</strong> produzione molto più lunghi e articolati<br />
che durano almeno 80 – 100 anni e che <strong>in</strong> molti casi (secondo le specie, le con<strong>di</strong>zioni <strong>del</strong> bosco e<br />
quelle ambientali) possono prolungarsi anche f<strong>in</strong>o a 120 – 150 anni e oltre.<br />
Nei riguar<strong>di</strong> dei processi <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione, il ceduo sfrutta le capacità proprie <strong>di</strong> alcune specie <strong>di</strong><br />
emettere nuovi getti dalla base <strong>del</strong> fusto tagliato. Questo fatto dà l'opportunità ai nuovi polloni <strong>di</strong><br />
poter utilizzare l'apparato ra<strong>di</strong>cale <strong>del</strong>la ceppaia sulla quale vegetano. In questo modo possono<br />
avere una più rapida crescita <strong>in</strong> altezza (anche più <strong>di</strong> un metro all'anno) che li libera dalla<br />
concorrenza degli altri vegetali e dall’attacco <strong>di</strong> animali erbivori (brucamento degli ungulati e degli<br />
animali domestici). Nella fustaia <strong>in</strong>vece la r<strong>in</strong>novazione avviene da seme con tutte le <strong>in</strong>certezze<br />
151
152<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
che questo comporta. Le piante devono prima <strong>di</strong> tutto produrre seme fertile <strong>in</strong> grande quantità, poi<br />
il seme deve germogliare e le ra<strong>di</strong>chette devono raggiungere il terreno attraverso la lettiera per<br />
potersi ancorare e per potersi rifornire <strong>di</strong> acqua e nutrienti. Inf<strong>in</strong>e devono v<strong>in</strong>cere la competizione<br />
con altri vegetali, <strong>del</strong>la loro stessa specie o <strong>di</strong> altre specie, e sfuggire agli animali erbivori.<br />
Il governo a ceduo si risolve <strong>in</strong> concreto con il taglio <strong>di</strong> utilizzazione che assume anche la<br />
funzione <strong>di</strong> taglio <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong> bosco. Qu<strong>in</strong><strong>di</strong> tra una ceduazione e la successiva, non<br />
sussistendo oggi motivazioni economiche che sp<strong>in</strong>gano ad utilizzare materiale <strong>di</strong> piccole<br />
<strong>di</strong>mensioni, non si <strong>in</strong>terviene con alcun tipo <strong>di</strong> taglio colturale. Questa facilità gestionale è uno dei<br />
pr<strong>in</strong>cipali motivi <strong>del</strong>la grande <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong> governo a ceduo <strong>di</strong> molti boschi <strong>di</strong> latifoglie <strong>del</strong>l’area<br />
me<strong>di</strong>terranea.<br />
Nella fustaia <strong>in</strong>vece gli <strong>in</strong>terventi colturali sono <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabili per controllare e guidare lo<br />
sviluppo <strong>del</strong> bosco e degli alberi che lo costituiscono. Così, nella prima parte <strong>del</strong> turno, si devono<br />
eseguire sfolli e <strong>di</strong>radamenti che riducono il numero <strong>del</strong>le piante. Quando la fustaia entra nella<br />
parte f<strong>in</strong>ale <strong>del</strong> turno si effettuano tagli <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione che hanno lo scopo appunto <strong>di</strong> preparare la<br />
ricostituzione <strong>del</strong> bosco attraverso la nascita e la crescita <strong>del</strong>le giovani piant<strong>in</strong>e.<br />
Il bosco governato a ceduo, per tutti i motivi già visti (età e <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>le piante, uniformità<br />
strutturale <strong>del</strong> bosco), è un ecosistema molto semplificato rispetto a quello <strong>del</strong>la fustaia.<br />
La fustaia, pur nelle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> trattamento che si possono applicare, presenta comunque<br />
una <strong>di</strong>versità strutturale (soprattutto nella <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>mensionale e nella composizione<br />
specifica) che la avvic<strong>in</strong>ano <strong>di</strong> più agli ecosistemi forestali naturali.<br />
La ceduazione è una fase traumatica che il bosco subisce durante la quale viene asporta la<br />
gran parte <strong>del</strong>le piante presenti. Questo può provocare un forte impatto sul paesaggio soprattutto<br />
se si tratta <strong>di</strong> superfici <strong>di</strong> grande ampiezza. Se le tagliate sono situate <strong>in</strong> punti particolari <strong>del</strong>la<br />
visuale, <strong>in</strong>teressando ad esempio rilevanti porzioni dei versanti, il paesaggio viene percepito come<br />
visibilmente e bruscamente alterato, anche se questa mo<strong>di</strong>fica ha <strong>in</strong> genere una durata <strong>di</strong> pochi<br />
anni.<br />
I turni relativamente brevi e i bassi valori <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong> suolo <strong>in</strong> seguito all’utilizzazione <strong>del</strong><br />
ceduo, accentuano temporaneamente i rischi idrogeologici legati a fenomeni <strong>di</strong> erosione e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>lavamento. Rilievi sperimentali effettuati su boschi cedui <strong>di</strong> querce caducifoglie <strong>in</strong> Umbria<br />
(AMORINI et al., 2002) hanno evidenziato che i valori <strong>di</strong> Leaf Area Index (e conseguentemente <strong>di</strong><br />
copertura complessiva <strong>del</strong> suolo) subiscono una drastica <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione nel primo anno dopo la<br />
ceduazione, assumendo però già dal secondo anno valori prossimi a quelli presenti <strong>in</strong> boschi<br />
limitrofi non utilizzati (figura 6).<br />
Leaf Area Index<br />
5.0<br />
4.5<br />
4.0<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
Anno <strong>in</strong>tervento<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Anno <strong>di</strong> rilievo<br />
ceduazione<br />
uniforme<br />
ceduazione<br />
per gruppi<br />
testimone<br />
Figura 6. Andamento <strong>del</strong> Leaf Area Index <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong> cerro sottoposti a <strong>di</strong>verso trattamento (mo<strong>di</strong>ficato da<br />
Amor<strong>in</strong>i et al., 2002).
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
I due o tre decenni che <strong>in</strong>tercorrono tra un taglio ed il successivo, durante i quali si ricostituisce<br />
il soprassuolo, sono d’altra parte un periodo troppo breve per consentire la formazione <strong>di</strong> un suolo<br />
forestale maturo. Va <strong>in</strong>fatti considerato che la ceduazione, provocando un aumento<br />
<strong>del</strong>l'illum<strong>in</strong>azione <strong>del</strong> suolo, accelera da un lato i processi <strong>di</strong> m<strong>in</strong>eralizzazione, ma dall'altro la forte<br />
asportazione <strong>di</strong> biomassa effettuata su tutta la superficie <strong>di</strong> taglio riduce notevolmente la quantità <strong>di</strong><br />
sostanza organica <strong>di</strong>sponibile per la pedogenesi.<br />
In relazione agli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori precedentemente <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> valutare la funzionalità<br />
ecosistemica degli habitat forestali e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> il loro grado <strong>di</strong> conservazione, si riportano nella tabella<br />
5 i potenziali effetti <strong>del</strong>la ceduazione effettuata secondo i meto<strong>di</strong> generalmente e tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
applicati (ceduazione con matric<strong>in</strong>atura uniforme).<br />
Si tratta ovviamente <strong>di</strong> un approccio semplicistico e generalistico, da utilizzare esclusivamente<br />
per una chiarificazione <strong>di</strong> tipo metodologico che evidenzi il processo per la determ<strong>in</strong>azione degli<br />
effetti <strong>del</strong>la ceduazione sulla conservazione degli habitat. Ovviamente, vi possono essere notevoli<br />
<strong>di</strong>fferenze <strong>in</strong> relazione alla composizione specifica <strong>del</strong>la foresta, alle con<strong>di</strong>zioni stazionali (e <strong>in</strong><br />
particolare alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pendenza, esposizione, umi<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> suolo, substrato pedogenetico…),<br />
alle modalità <strong>di</strong> trattamento e ai meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> utilizzazione applicati.<br />
Tabella 5 - Effetti <strong>del</strong>la ceduazione con matric<strong>in</strong>atura uniforme sulla conservazione degli habitat.<br />
In<strong>di</strong>catore<br />
Effetto<br />
ceduazione<br />
(+, =, - )<br />
Estensione habitat =<br />
Grado <strong>di</strong> frammentazione =<br />
Core areas =<br />
Note<br />
La ceduazione non comporta riduzioni <strong>di</strong> superficie<br />
boscata<br />
La ceduazione non comporta riduzioni <strong>di</strong> superficie<br />
boscata<br />
La ceduazione non comporta riduzioni <strong>di</strong> superficie<br />
boscata<br />
Bio<strong>di</strong>versità specifica - Favorite specie pollonifere<br />
Variabilità sta<strong>di</strong>o evolutivo - Non presenti boschi vetusti<br />
Classi <strong>di</strong>mensionali e<br />
tessitura<br />
Presenza e qualità<br />
r<strong>in</strong>novazione<br />
- Le piante gran<strong>di</strong> sono esclusivamente matric<strong>in</strong>e<br />
- +<br />
Grado <strong>di</strong> copertura =<br />
Strato arbustivo +<br />
153<br />
R<strong>in</strong>novazione assicurata, ma quasi esclusivamente<br />
agamica<br />
Dopo il 1°anno, copertura generalmente assicurata d ai<br />
nuovi polloni<br />
Generalmente più <strong>di</strong>ffuso soprattutto <strong>in</strong> querceti e<br />
faggete<br />
Presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesti - Problemi soprattutto per la frequenza <strong>del</strong>le utilizzazioni<br />
Alterazioni <strong>del</strong>lo stato<br />
vegetativo<br />
Necromassa <strong>in</strong> pie<strong>di</strong> e a terra - +<br />
+ Legata alla giovane età dei popolamenti<br />
Ramaglia post- taglio e polloni dom<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> cedui<br />
maturi/<strong>in</strong>vecchiati<br />
Decomposizione lettiera - + M<strong>in</strong>eralizzazione più veloce, ma m<strong>in</strong>ore quantità<br />
Presenza <strong>di</strong> microhabitat -<br />
La carenza <strong>di</strong> piante gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce la presenza <strong>di</strong><br />
microhabitat<br />
Dendromassa presente - Livelli <strong>di</strong> biomassa <strong>in</strong>feriori rispetto a fustaie mature
154<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
SPECIFICHE DI TRATTAMENTO PER LA GESTIONE A CEDUO DEGLI HABITAT FORESTALI<br />
DELLA RETE NATURA 2000<br />
In relazione agli obiettivi <strong>del</strong>la Rete Natura 2000, all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>le superfici governate a ceduo<br />
possono essere adottati particolari accorgimenti idonei <strong>di</strong> volta <strong>in</strong> volta a mitigare gli effetti<br />
potenzialmente negativi <strong>del</strong>le ceduazioni sullo stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat stesso,<br />
migliorando la risposta alla ceduazione <strong>di</strong> alcuni <strong>in</strong><strong>di</strong>catori <strong>in</strong> cui vi può essere un impatto negativo<br />
a seguito degli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> ceduazione tra<strong>di</strong>zionalmente applicati.<br />
Tra le modalità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento che possono <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire l’impatto <strong>del</strong>la ceduazione va <strong>in</strong>nanzitutto<br />
considerata la riduzione <strong>del</strong>le superficie accorpate <strong>di</strong> taglio.<br />
La riduzione <strong>del</strong>le superfici, oltre a <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire l’impatto paesaggistico (che non è un fattore<br />
preso <strong>in</strong> considerazione dal DPR 357/97), porta soprattutto a ridurre i rischi idrogeologici nelle<br />
foreste su versanti, come effetto <strong>del</strong>la m<strong>in</strong>ore lunghezza dei tratti <strong>in</strong> massima pendenza senza<br />
copertura forestale <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> ridurre il <strong>di</strong>lavamento da parte <strong>del</strong>le acque superficiali. Inoltre, la<br />
<strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>le superficie aumenta la densità dei conf<strong>in</strong>i rispetto alle superfici <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento<br />
aumentando situazioni <strong>di</strong> ecotone e conseguentemente la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> microhabitat attribuibile<br />
all’ “effetto <strong>di</strong> marg<strong>in</strong>e”.<br />
La <strong>di</strong>versificazione degli <strong>in</strong>terventi, con alternanza <strong>di</strong> zone governate a ceduo con<br />
matric<strong>in</strong>atura uniforme a zone avviate all’alto fusto, zone ad evoluzione naturale e zone con<br />
matric<strong>in</strong>atura per gruppi, permette <strong>di</strong> ottenere una <strong>di</strong>versificazione <strong>di</strong> ambienti e <strong>di</strong> risorse, anche<br />
su superfici relativamente piccole.<br />
All’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> progetto Summacop (AA.VV. 2002), nella zona <strong>di</strong> Monte Peglia (TR) sono stati<br />
effettuati <strong>in</strong>terventi su circa 6, 4 ettari alternando le <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> gestione senza effettuare<br />
però ceduazioni con matric<strong>in</strong>atura uniforme. I rilievi effettuati hanno mostrato un aumento<br />
statisticamente significativo <strong>del</strong> numero <strong>di</strong> uccelli presente nell’area a seguito degli <strong>in</strong>terventi e un<br />
aumento anche <strong>del</strong>la macro-meso teriofauna. Ulteriori <strong>in</strong>terventi sono stati poi effettuati nell’area<br />
anche nel 2008 da parte <strong>del</strong>la Comunità Montana Monte Peglia e Selva <strong>di</strong> Meana, proseguendo il<br />
<strong>di</strong>segno gestionale impostato all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong> progetto Summacop.<br />
In riferimento agli <strong>in</strong><strong>di</strong>catori precedentemente descritti, la realizzazione <strong>di</strong> <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong>versificati<br />
su piccole superfici permette <strong>di</strong> ottenere migliori performances per quanto riguarda la variabilità<br />
specifica, la variabilità <strong>di</strong> sta<strong>di</strong> evolutivi, la variabilità <strong>di</strong> classi <strong>di</strong>mensionali e <strong>di</strong> tessitura, la<br />
presenza e la qualità <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione, la quantità <strong>di</strong> necromassa, i processi <strong>di</strong> decomposizione<br />
lettiera, la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> microhabitat, la quantità <strong>di</strong> dendromassa presente.<br />
In molti casi e laddove non già previsto dalle norme forestali , sarebbe opportuno prevedere il<br />
rilascio <strong>di</strong> piante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, da calibrare <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento e <strong>del</strong>le<br />
specie presenti, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> evitare un eccessivo ombreggiamento <strong>del</strong>le ceppaie, con un numero <strong>di</strong><br />
piante gran<strong>di</strong> a ettaro variabile tra 1 e 5.<br />
Attraverso il rilascio <strong>di</strong> un numero adeguato <strong>di</strong> piante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, da rilasciare <strong>in</strong> bosco<br />
anche dopo la loro morte, è possibile migliorare la <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le piante <strong>in</strong> classi <strong>di</strong>mensionali,<br />
la tessitura <strong>del</strong> bosco, la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> microhabitat, la quantità <strong>di</strong> dendromassa presente. In<br />
maniera <strong>in</strong><strong>di</strong>retta, solo dopo un periodo me<strong>di</strong>o lungo, sarà possibile ottenere altri vantaggi dal<br />
rilascio <strong>di</strong> piante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni e <strong>in</strong> particolare si potrà verificare una maggiore <strong>di</strong>ffusione<br />
<strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione (per la presenza <strong>di</strong> piante con chiome ampie e libere), una maggiore <strong>di</strong>ffusione<br />
<strong>del</strong>la necromassa (alla morte <strong>del</strong>le piante rilasciate) una maggiore produzione <strong>di</strong> lettiera e<br />
conseguentemente una maggiore produzione <strong>di</strong> suolo organico.<br />
Al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> aumentare la necromassa presente negli ecosistemi forestali (Mason et al., 2003) e la<br />
presenza <strong>di</strong> microhabitat per la fauna, è auspicabile il rilascio <strong>del</strong>la necromassa <strong>in</strong> bosco, e <strong>in</strong><br />
particolare è possibile limitare la bruciatura <strong>del</strong>la ramaglia esclusivamente alle zone a elevato<br />
rischio <strong>di</strong> <strong>in</strong>cen<strong>di</strong>o, evitare la formazione <strong>di</strong> andane, rilasciare le piante morte (<strong>in</strong> pie<strong>di</strong> o a terra). Va<br />
sottol<strong>in</strong>eato che comunque, nella maggior parte dei casi, i boschi cedui risultano poveri <strong>di</strong><br />
necromassa <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni mentre sono sufficientemente provvisti <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> piccole<br />
<strong>di</strong>mensioni. Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo <strong>di</strong> avere legno morto <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non è<br />
però perseguibile nel breve periodo, per assenza <strong>di</strong> legname <strong>di</strong> tali caratteristiche nella struttura
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
<strong>di</strong>mensionale <strong>del</strong> popolamento e pertanto tale obiettivo potrà essere raggiunto solo nel lungo<br />
periodo, attraverso il rilascio <strong>di</strong> piante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni cui si è accennato precedentemente.<br />
Nella def<strong>in</strong>izione dei Piani <strong>di</strong> gestione e <strong>del</strong>le Misure m<strong>in</strong>ime <strong>di</strong> conservazione per la gestione<br />
dei siti <strong>del</strong>la rete Natura 2000 sono state <strong>in</strong>oltre proposte altri accorgimenti adottabili nella gestione<br />
dei boschi cedui (come azioni da <strong>in</strong>centivare o come prescrizioni obbligatorie), volti per lo più a<br />
<strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire gli impatti non sugli habitat ma sulle specie <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse conservazionistico. A titolo <strong>di</strong><br />
esempio: la limitazione <strong>del</strong>le stagioni taglio, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento nelle zone ecotonali, l’utilizzo <strong>di</strong><br />
mezzi a motore per l’esbosco, limitazioni <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento lungo i corsi d’acqua…<br />
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />
"La cosa migliore è che le decisioni sulla gestione a lungo term<strong>in</strong>e vengano prese caso per<br />
caso <strong>in</strong> stretta consultazione con gli attori locali e i proprietari <strong>del</strong> territorio <strong>in</strong>teressato." (da Natura<br />
2000: Conservation <strong>in</strong> partnership, Commissione Europea 2005)<br />
In Italia la maggior parte dei Siti terrestri <strong>del</strong>la Rete Natura 2000, collocata <strong>in</strong> prevalenza nelle<br />
zone alto coll<strong>in</strong>ari e montane, <strong>in</strong>clude territori ad uso agro-silvo-pastorale anche rilevanti e<br />
caratterizzanti i Siti stessi. Molti dei boschi sono gestiti a ceduo.<br />
Nelle foreste <strong>in</strong>teressate poteva essere colta l'opportunità <strong>di</strong> concretizzare l'approccio alla<br />
gestione forestale sostenibile con il supporto <strong>di</strong> motivazioni e f<strong>in</strong>anziamenti adeguati.<br />
Invece, dopo un decennio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, carte, <strong>del</strong>ibere, queste opportunità sembrano bloccate da<br />
un orientamento <strong>di</strong> tipo v<strong>in</strong>colistico basato su prescrizioni tecniche poco applicabili o fissate su<br />
elementi esclusivamente quantitativi e male giustificati, che spesso mettono <strong>in</strong> ri<strong>di</strong>colo anche<br />
alcune tecniche <strong>in</strong>novative e favorevoli alla conservazione degli habitat e dei microhabitat (ad<br />
esempio, nella gestione dei cedui: matric<strong>in</strong>e per gruppi, alberi da rilasciare ad <strong>in</strong>vecchiamento<br />
<strong>in</strong>def<strong>in</strong>ito).<br />
E mentre cont<strong>in</strong>uano ad essere f<strong>in</strong>anziati stu<strong>di</strong>, carte, revisioni degli stu<strong>di</strong> e <strong>del</strong>le carte,<br />
pubblicazioni <strong>di</strong> depliant, carte <strong>in</strong>testate con il logo Natura 2000 o <strong>di</strong> Bio<strong>di</strong>versity 2010, nei Siti non<br />
è ancora arrivato un euro sul territorio e non è stata attivata nessun tipo <strong>di</strong> partecipazione<br />
con gli attori locali e con i proprietari <strong>del</strong> territorio <strong>in</strong>teressato.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV., 2002 – Gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi cedui: il progetto SUMMACOP.<br />
Esperienze, attività, risultati. Regione <strong>del</strong>l’Umbria, Perugia, 192 p.<br />
AA.VV., 2006 - Dossier - Natura 2000 e Foreste. Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi, n°123 (06/06)<br />
AMORINI E., CANTIANI P., FABBIO G., 2002 – Pr<strong>in</strong>cipali valutazioni sulla risposta degli<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>catori dendrometrici e strutturali <strong>in</strong> querceti decidui <strong>del</strong>l’Umbria sottoposti a <strong>di</strong>verso<br />
trattamento colturale. In: FERRETTI M., FRATTEGIANI M., GROHMANN F., SAVINI P. (a cura<br />
<strong>di</strong>) - Il progetto TraSFoR.M. Regione <strong>del</strong>l’Umbria: 45-52.<br />
BARBATI A, CORONA P, GARFÌ G, MARCHETTI M, MAGGIORE A, RONCHERI I., 2002 – La<br />
gestione forestale nei SIC/ZPS <strong>del</strong>la rete Natura 2000: chiavi <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazione e orientamenti<br />
per l’applicazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva habitat. Monti e Boschi, LIII (2): 4-13.<br />
BECCHETTI M., GIOVANNINI G., 1998 – La matric<strong>in</strong>atura nei cedui <strong>di</strong> cerro: <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia<br />
<strong>di</strong> Perugia. Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi, n°3 4 (5/98)<br />
BERNETTI G., 1987 – I boschi <strong>del</strong>la Toscana. Edagricole, Bologna.<br />
BERNETTI G., 1995 – Selvicoltura speciale. UTET, Tor<strong>in</strong>o.<br />
BIANCHI M., CANTIANI P., DE MEO I., FERRETTI F., FRATTEGIANI M., IORIO G., 2009 – La<br />
pianificazione forestale: dagli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi alle scelte <strong>di</strong> dettaglio. Il caso <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong>la Comunità<br />
montana Alto Molise. In: HERMANIN L., LA MARCA O. (a cura <strong>di</strong>) - Scritti <strong>in</strong> onore <strong>di</strong> Mario<br />
Cantiani . E<strong>di</strong>zioni Polistampa, Firenze: 61-74.<br />
BIONDI et al., 2009 – Manuale italiano <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazione degli habitat <strong>del</strong>la Direttiva 92/43/CEE.<br />
SBI. M<strong>in</strong>.Ambiente e <strong>del</strong>la Tutela <strong>del</strong> Territorio e <strong>del</strong> Mare, D.P.N.<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2003 – Interpretation manual of European Union Habitats. EUR 25.<br />
DG Ambiente, Unità Natura e Bio<strong>di</strong>versità, Bruxelles.<br />
155
156<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2000 – La gestione dei siti <strong>del</strong>la Rete Natura 2000. Guida<br />
all’<strong>in</strong>terpretazione <strong>del</strong>l’articolo 6 <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva «Habitat» 92/43/CEE. DG Ambiente, Unità<br />
Natura e Bio<strong>di</strong>versità, Bruxelles. Traduzione italiana.<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2005a – Natura 2000 e foreste: sfide e opportunità. Guida<br />
<strong>in</strong>terpretativa. DG Ambiente, Unità Natura e Bio<strong>di</strong>versità, Bruxelles. Traduzione italiana.<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2005b – Natura 2000. Conservation <strong>in</strong> partnership. Office for Official<br />
Publications of the European Communities, Luxembourg.<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2006a – Interpretation manual of European Union Habitats. EUR 25.<br />
DG Ambiente, Unità Natura e Bio<strong>di</strong>versità, Bruxelles.<br />
EUROPEAN COMMISSION, 2006b – Nature and Bio<strong>di</strong>versity Cases Rul<strong>in</strong>g of the European Court<br />
of Justice. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.<br />
EUROPEAN COMMISSION - Environment Directorate-General, 2006 – Life and European forest.<br />
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.<br />
EUROSITE, 1999 – Eurosite Management Plann<strong>in</strong>g Toolkit 99. TILBURG, Netherlands.<br />
MASON F. NARDI G., TISATO M. (a cura <strong>di</strong>), 2003 – Legno morto: una chiave per la bio<strong>di</strong>versità.<br />
<strong>Atti</strong> <strong>del</strong> Simposio Internazionale 29-31 Maggio – Mantova (Italia). Compagnia <strong>del</strong>le foreste,<br />
Arezzo, 100pp.<br />
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, 2002a – L<strong>in</strong>ee guida per la<br />
gestione dei siti Natura 2000. D.M. <strong>del</strong> 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
italiana n. 224 <strong>del</strong> 24 settembre 2002.<br />
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, 2002b – Manuale per la<br />
gestione dei Siti Natura 2000. Roma, 254 pp.<br />
PERRIN H., 1954 - Selvicoltura. Tomo II. (trad. G. Bernetti, 1981). Accademia Italiana <strong>di</strong> Scienze<br />
forestali, Firenze.<br />
PIUSSI P., 1999 – Selvicoltura generale. UTET, Tor<strong>in</strong>o<br />
REGIONE DELL’UMBRIA, 2005 – Piano Forestale Territoriale per il bac<strong>in</strong>o <strong>del</strong> Lago Trasimeno.<br />
Relazione generale. Dattiloscritto non pubblicato<br />
SHAW P., WIND P., 1997 – Monitor<strong>in</strong>g the con<strong>di</strong>tion and bio<strong>di</strong>versity status of European<br />
Conservation Sites. A <strong>di</strong>scussion paper. F<strong>in</strong>al Draft. Report to the EEA on the behalf of the<br />
ETC/NC, Paris.
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
157
158<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani
Boschi cedui e Rete Natura 2000<br />
159
160<br />
Giorgio Iorio, Mauro Frattegiani
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
DINAMISMI STRUTTURALI E DI ACCRESCIMENTO IN BOSCHI CEDUI<br />
ABBANDONATI ED IN CONVERSIONE DELL'APPENNINO CENTRALE<br />
FRANCESCO RENZAGLIA, EMIDIA SANTINI, MATTEO GIOVE, CARLO URBINATI<br />
DIP. SCIENZE AMBIENTALI E DELLE PRODUZIONI VEGETALI,<br />
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
162<br />
INTRODUZIONE<br />
Francesco Renzaglia et al.<br />
Obiettivo <strong>del</strong>la gestione forestale sostenibile è quello <strong>di</strong> valorizzare nel tempo la<br />
multifunzionalità <strong>del</strong>le risorse <strong>di</strong>sponibili, che spesso conduce anche alla promozione <strong>del</strong> loro ruolo<br />
ecologico-ambientale e socio-culturale, ponendo spesso <strong>in</strong> secondo piano la funzione <strong>di</strong><br />
produzione <strong>di</strong> legno e <strong>di</strong> protezione idrogeologica. Inoltre è abbastanza con<strong>di</strong>viso il concetto che i<br />
boschi abbandonati all’evoluzione naturale non assicurano sempre e comunque le <strong>di</strong>verse funzioni<br />
che ad essi vengono richieste e che possono essere garantite solo con una corretta gestione<br />
selvicolturale.<br />
Da alcuni anni il gruppo <strong>di</strong> <strong>Ecologia</strong> e Gestione Forestale <strong>del</strong> <strong>Dipartimento</strong> SAPROV<br />
<strong>del</strong>l’UNIVPM ha avviato alcune ricerche sui boschi cedui <strong>del</strong>l’Italia centrale per comprenderne i<br />
<strong>di</strong>namismi strutturali <strong>in</strong> seguito all’abbandono colturale e valutarne gli effetti ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la<br />
multifunzionalità richiesta oggi alle formazioni forestali. Il concetto <strong>di</strong> multifunzionalità, pilastro nel<br />
processo <strong>di</strong> gestione sostenibile oggi <strong>di</strong> grande attualità, trova una applicazione pratica solo se<br />
accompagnato da un approccio multiscala, <strong>in</strong> quanto allo stesso soprassuolo non sempre è<br />
possibile assegnare più funzioni contemporaneamente. Il bosco ceduo, caratterizzato da una<br />
conclamata semplicità selvicolturale, quando è abbandonato può <strong>di</strong>ventare un sistema molto<br />
complesso e ancora relativamente poco stu<strong>di</strong>ato.<br />
Presentiamo alcuni dei pr<strong>in</strong>cipali risultati <strong>di</strong> ricerche svolte ed <strong>in</strong> atto soprattutto <strong>in</strong> faggete<br />
<strong>del</strong>l’Appenn<strong>in</strong>o umbro-marchigiano, caratterizzate da cedui <strong>in</strong>vecchiati <strong>in</strong> abbandono o <strong>in</strong><br />
conversione a fustaia, alcuni dei quali anche al limite superiore <strong>del</strong> bosco. All’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> aree<br />
campione <strong>di</strong> vario tipo le analisi sono state condotte con l’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong> rispondere a quesiti quali:<br />
come si stanno organizzando queste cenosi, <strong>in</strong>tensamente utilizzate nei decenni scorsi ed ora <strong>in</strong><br />
gran parte abbandonate? Ci sono cambiamenti dendrometrico-strutturali che con<strong>di</strong>zionano il loro<br />
assetto funzionale? Quali rapporti fra ente proprietari e gestori? Nell’attuare le conversioni è<br />
possibile un orientamento verso strutture più irregolari ottenibili con tagli graduali su piccole<br />
superfici?<br />
DINAMISMI SPAZIO-TEMPORALI IN FAGGETE D’ALTA QUOTA (Renzaglia, 2008;<br />
Renzaglia e Urb<strong>in</strong>ati, <strong>in</strong> prep.)<br />
I Monti <strong>del</strong>la Laga e specificamente il settore marchigiano <strong>del</strong>la Macera <strong>del</strong>la Morte ospitano il<br />
più esteso <strong>di</strong>stretto forestale <strong>del</strong>la regione e la natura arenacea <strong>del</strong> sistema orografico consente al<br />
bosco <strong>di</strong> elevarsi anche a quote prossime ai 1800 m. In due aree <strong>di</strong> saggio permanenti (Fig. 1), una<br />
rappresentativa <strong>del</strong>l’ecotono bosco-non bosco e l’altra, poco <strong>di</strong>stante dalla precedente, nel bosco<br />
chiuso sottostante si è proceduto a determ<strong>in</strong>are: a) l’assetto dendrometrico-strutturale <strong>del</strong>le cenosi<br />
forestali con particolare riferimento alla <strong>di</strong>stribuzione spaziale degli elementi costitutivi <strong>del</strong> bosco<br />
(ceppaie e polloni) per evidenziare eventuali <strong>di</strong>fferenze evolutive e funzionali anche ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la<br />
funzione <strong>di</strong> protezione idrogeologica.<br />
All’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>le aree sperimentali sono state eseguite le seguenti operazioni:<br />
• Delimitazione e perimetrazione <strong>del</strong>le aree con vertici georeferenziati<br />
• In<strong>di</strong>viduazione e cartell<strong>in</strong>atura <strong>di</strong> tutti gli elementi <strong>in</strong><strong>di</strong>viduali (ceppaie, matric<strong>in</strong>e, piante<br />
morte) presenti<br />
• Posizionamento <strong>di</strong> picchetti <strong>in</strong>terme<strong>di</strong> all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>l’area<br />
• Mappatura degli elementi <strong>in</strong><strong>di</strong>viduali<br />
• Misurazione dei pr<strong>in</strong>cipali parametri dendrometrico-strutturali su tutti gli elementi<br />
presenti nelle aree<br />
• Campionamento dendrocronologico sui polloni dom<strong>in</strong>anti e matric<strong>in</strong>e.<br />
In ognuna <strong>del</strong>le due aree si è proceduto alla misurazione dei pr<strong>in</strong>cipali parametri dendrometrici<br />
necessari per caratterizzare la struttura orizzontale e verticale <strong>del</strong> soprassuolo e riportati su<br />
apposite schede <strong>di</strong> rilevamento. La ceppaia è stata rappresentata dal suo pollone <strong>di</strong> maggiori<br />
<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>ametriche che assume qu<strong>in</strong><strong>di</strong> il ruolo <strong>di</strong> centroide su cui è stata apposta l’etichetta <strong>di</strong><br />
numerazione.<br />
Il cavallettamento totale, con soglia m<strong>in</strong>ima <strong>di</strong> 3 cm a 1.30 m <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong> tutti i polloni presenti<br />
sulle ceppaie e <strong>di</strong> tutti gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui monocormici (matric<strong>in</strong>e o polloni affrancati). Le con<strong>di</strong>zioni<br />
vegetative sono state stimate per ogni elemento (sulle ceppaie globalmente per l’<strong>in</strong>sieme dei<br />
polloni presenti) <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni <strong>del</strong>le chiome (es. scarsità <strong>di</strong> foglie, alterazioni <strong>del</strong> loro
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
colore, presenza rami secchi, stroncature <strong>di</strong> parte <strong>del</strong>la chioma) me<strong>di</strong>ante le seguenti classi <strong>di</strong><br />
vigore.<br />
Fig. 1. Localizzazione <strong>del</strong>le due aree permanenti nel sito Valle <strong>del</strong>la Corte nel Parco Nazionale <strong>del</strong> Gran<br />
Sasso-Laga<br />
Per ogni elemento vivo è stata misurata l’altezza dendrometrica e l’altezza d’<strong>in</strong>serzione <strong>del</strong>la<br />
chioma <strong>in</strong> due punti <strong>del</strong> fusto. Per le ceppaie tali altezze sono state rilevate sul pollone più alto, che<br />
nella maggioranza dei casi corrispondeva al pollone centroide. L’altezza <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>serzione <strong>del</strong>la<br />
chioma (primo ramo verde non isolato ma <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uità con il resto <strong>del</strong>la chioma) è stata misurata a<br />
monte (alt. <strong>in</strong>s.chioma 1) ed a valle (alt. <strong>in</strong>s.chioma 2) lungo la l<strong>in</strong>ea <strong>del</strong>la massima pendenza o<br />
rispettivamente <strong>in</strong> <strong>di</strong>rezione N o S <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong> <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione. Sono state <strong>in</strong>oltre rilevate <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione<br />
e <strong>di</strong>rezione dei polloni dom<strong>in</strong>anti non verticali.<br />
Per ogni ceppaia o <strong>in</strong><strong>di</strong>viduo monocormico è stata misurata la proiezione <strong>del</strong>la chioma a terra,<br />
<strong>in</strong>tesa come <strong>di</strong>stanza l<strong>in</strong>eare orizzontale con la base <strong>del</strong> fusto lungo 4 <strong>di</strong>rezioni secondo i 4 punti<br />
car<strong>di</strong>nali.<br />
Per la determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>l’età <strong>del</strong> soprassuolo si è proceduto al prelievo <strong>di</strong> campioni legnosi<br />
effettuato con succhiello <strong>di</strong> Pressler sul fusto legnoso ad un’altezza <strong>di</strong> 130 cm da terra. Sulle<br />
ceppaie il carotaggio (1 carota per pianta) è stato eseguito normalmente sul pollone centroide<br />
(dom<strong>in</strong>ante). In ASP1, caratterizzata da una m<strong>in</strong>ore densità <strong>di</strong> copertura, sono stati carotati tutti i<br />
polloni dom<strong>in</strong>anti <strong>del</strong>le ceppaie presenti. In ASP2, per il maggior numero <strong>di</strong> ceppaie presenti e la<br />
maggiore omogeneità <strong>di</strong>mensionale dei polloni, si è deciso <strong>di</strong> eseguire un campionamento<br />
stratificato e calibrato sulla <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> frequenza dei <strong>di</strong>ametri, su 148 <strong>del</strong>le 635 ceppaie (circa<br />
23%).<br />
Entrambi i popolamenti analizzati sono cedui abbandonati <strong>di</strong> faggio praticamente <strong>in</strong> purezza,<br />
vista la molto spora<strong>di</strong>ca presenza <strong>di</strong> isolati <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia).<br />
Le matric<strong>in</strong>e sono praticamente assenti: nessuna r<strong>in</strong>venuta <strong>in</strong> ASP1 e solo 3 <strong>in</strong> ASP2,<br />
confermando quanto riportato nel capitolo 5 relativamente alle gestione pregressa praticata nella<br />
zona.<br />
In Tab. 1 sono riportati i pr<strong>in</strong>cipali risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati raccolti. Occorre<br />
precisare che per ASP 1, caratterizzate da ampie radure e aree <strong>di</strong> prateria, i dati ad ettaro non<br />
sono facilmente confrontabili con quelli <strong>di</strong> ASP2, se non si procede prima a stimare la percentuale<br />
<strong>di</strong> area boscata rispetto a quella totale <strong>del</strong>l’area.<br />
Le due aree sebbene molto vic<strong>in</strong>e spazialmente, appartenenti allo stesso versante, al<br />
medesimo orizzonte altitu<strong>di</strong>nale, tipologicamente analoghe e caratterizzate da ceduazioni<br />
pregresse hanno un assetto dendrometrico-strutturale ben <strong>di</strong>fferenziate (Fig. 2). ASP1, localizzata<br />
al limite superiore <strong>del</strong> bosco presenta caratteristiche che rispecchiano maggiormente l’esistenza <strong>di</strong><br />
ricorrenti e forti perturbazioni esogene pr<strong>in</strong>cipalmente climatiche, ma con effetti meccanici (es.<br />
elevate escursioni termiche tipiche <strong>del</strong> LSB, gelate precoci o tar<strong>di</strong>ve, ma soprattutto galaverna o<br />
neve pesante primaverile). Sono da annoverare anche effetti comb<strong>in</strong>ati che producono<br />
scivolamenti <strong>di</strong> neve o <strong>di</strong> suolo che tendono a r<strong>in</strong>giovanire le ceppaie più esposte. Queste cenosi <strong>di</strong><br />
limite ed <strong>in</strong> particolare i nuclei isolati hanno, fra le altre, anche una funzione <strong>di</strong> buffer fra il bosco<br />
chiuso sottostante e le praterie sommitali. Nel settore più <strong>in</strong> alto <strong>di</strong> ASP1 sono <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guibili <strong>di</strong>verse<br />
163
164<br />
Francesco Renzaglia et al.<br />
situazioni: quella a quota superiore molto acclive prevalentemente a prateria con nuclei isolati <strong>di</strong><br />
ceppaie, le cui <strong>di</strong>mensioni maggiori sono riscontrabili <strong>in</strong> ambiti a m<strong>in</strong>ore pendenza.<br />
Tab. 1 – Pr<strong>in</strong>cipali caratteri dendrometrici rilevati nelle due aree permanenti (ASP).<br />
Parametro ASP 1<br />
ASP 1<br />
(ha)<br />
ASP 1<br />
(ha*)<br />
ASP 2<br />
ASP 2<br />
(ha)<br />
Elementi cartell<strong>in</strong>ati (N) 381 232 779 713 1606<br />
Ceppaie vive (N) 311 189 636 651 1466<br />
Ceppaie morte cartell<strong>in</strong>ate (N) 4 2 8 57 128<br />
Polloni vivi totali (N) 2915 1773 5961 2075 4673<br />
Polloni morti totali (N) 39 24 80 859 1935<br />
Polloni vivi e morti totali (N) 2954 1797 6041 2934 6608<br />
Polloni vivi / ceppaia (N) 9,4 / / 3,2 /<br />
Polloni morti / ceppaia (N) 0,1 / / 1,2 /<br />
Polloni vivi e morti /ceppaia (N)* [* tot.<br />
9,5 / / 4,1<br />
/<br />
/censiti]<br />
% polloni morti (N morti/ N vivi e N morti) 1,32 / / 29,3 /<br />
Diametro m<strong>in</strong> (cm) 3 / / 6 /<br />
Diametro max (cm) 39 / / 39 /<br />
Diametro me<strong>di</strong>o (dg) (cm) 9,2 / / 12,3 /<br />
Altezza me<strong>di</strong>a (hg) (m) 6,9 / / 13,7 /<br />
Altezza dom<strong>in</strong>ante (Hdom) (m) 11,3 / / 17,2 /<br />
Area basimetrica vivi (Gv) (m 2 ) 19,3 11,8 39,5 24,8 55,8<br />
Area basimetrica morti (Gm) (m 2 ) 0,2 0,1 0,4 2,3 5,3<br />
Area basimetrica totale G (Gtot) (m 2 ) 19,5 11,9 39,9 27,1 61,1<br />
% G morti ( G morti / G vivi e G morti) 1,06 / / 8,6 /<br />
Volume cormometrico polloni vivi (V) (m 3 ) 98,31 59,80 201 193,14 434,99<br />
Volume cormometrico polloni morti (Vm) (m 3 ) 1,01 0,61 2,1 11,66 26,26<br />
Età me<strong>di</strong>a (anni) 44 / / 51 /<br />
Fig. 2. Distribuzione spaziale degli elementi (ceppaie i verde, matric<strong>in</strong>e <strong>in</strong> arancio) <strong>del</strong> bosco ceduo nelle<br />
due aree permanenti.
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
Tali ceppaie sono caratterizzate da uno o più polloni dom<strong>in</strong>anti molto sviluppati attorno ai quali<br />
si struttura il resto <strong>del</strong>la ceppaia, caratterizzata da polloni molto più piccoli, spesso <strong>di</strong> forma e<br />
accrescimento irregolari a causa <strong>del</strong>la ripetuta brucatura da parte bestiame.<br />
A quota <strong>in</strong>feriore <strong>in</strong> prossimità <strong>del</strong> marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong> bosco, <strong>in</strong> corrispondenza <strong>di</strong> repent<strong>in</strong>i aumenti <strong>di</strong><br />
acclività e <strong>del</strong>le irregolarità fisiografiche le ceppaie risentono maggiormente degli accumuli e dei<br />
movimenti <strong>di</strong> neve. Queste risultano spesso senza un pollone veramente dom<strong>in</strong>ante, sono <strong>di</strong> più<br />
<strong>di</strong>fficile identificazione e <strong>di</strong>versi polloni hanno forme sciabolate.<br />
La necromassa rilevata <strong>in</strong> ASP1, <strong>in</strong>tesa come ceppaie, polloni morti o snag è stata molto<br />
<strong>in</strong>feriore alle attese (anche se ancora non esattamente quantificata), probabilmente per<br />
rotolamento <strong>di</strong>retto e/o scivolamenti <strong>del</strong> manto nevoso. ASP1 ha complessivamente una scarsa<br />
quantità <strong>di</strong> necromassa e bassa mortalità dei polloni.<br />
ASP2 risente meno degli effetti <strong>di</strong> limite, anche se questi sono parzialmente presenti nel settore<br />
superiore che scorre <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con una strada forestale, con traffico veicolare controllato dalla locale<br />
Comunanza Agraria. La maggiore protezione dalle perturbazioni climatiche, l’elevata densità e<br />
copertura uniforme la rendono fisionomicamente più omogenea e strutturalmente più avanzata.<br />
Sebbene l’età sia <strong>di</strong> poco superiore rispetto a ASP1 (Fig. 2) il popolamento è caratterizzato<br />
dalla presenza <strong>di</strong> ceppaie appartenenti a classi sociali <strong>di</strong>fferenziate (dom<strong>in</strong>anti e dom<strong>in</strong>ate) con<br />
<strong>di</strong>verse <strong>di</strong>namiche strutturali e funzionali, come <strong>di</strong>mostrano i dati <strong>del</strong>le curve isometriche (Fig. 3) e<br />
la elevata mortalità dei polloni sulle ceppaie (alcune sono risultate composte <strong>in</strong>teramente da polloni<br />
morti).<br />
Fig. 3. Assetto cronologico nelle due aree permanenti<br />
Fig. 4. Assetto ipso<strong>di</strong>ametrico nelle due aree permanenti<br />
165
166<br />
Francesco Renzaglia et al.<br />
Nel bosco ceduo la prevalente presenza <strong>di</strong> ceppaie conferisce al tempo stesso una valenza<br />
standar<strong>di</strong>zzante e <strong>in</strong>erziale al sistema forestale: da un lato potrebbe perdersi <strong>in</strong>fatti l’apporto <strong>del</strong>la<br />
<strong>di</strong>versità <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> tipo genetico, dall’altro ogni ceppaia porta con sé (e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> nei polloni che la<br />
costituiscono) una storia biologica che con<strong>di</strong>ziona la capacità auxologica e <strong>di</strong> adattamento<br />
ecosistemico <strong>di</strong> ogni famiglia <strong>di</strong> polloni. Il bosco ceduo, nella sua semplicità selvicolturale, quando<br />
abbandonato <strong>di</strong>venta un sistema molto più complesso complesso e ancora troppo scarsamente<br />
conosciuto, la cui evoluzione è fondamentale per comprenderne gli effetti sulla capacità <strong>di</strong><br />
garantire le <strong>di</strong>verse funzioni che oggi la società richiede ai boschi. Ovvero la bio<strong>di</strong>versità, la<br />
stabilità dei versanti, l’assorbimento <strong>del</strong> carbonio atmosferico saranno comunque garantite nel<br />
tempo dal bosco ceduo abbandonato? In che modo? Per quanto tempo? F<strong>in</strong>o a che punto?.<br />
A queste domande oggi non è facile dare una risposta, ma operativamente si procede spesso<br />
applicando algoritmi colturali consuetu<strong>di</strong>nari che non sempre sono congrui con le <strong>di</strong>namiche<br />
ambientali <strong>in</strong> atto. Quello <strong>in</strong> oggetto è un caso tipico, dove si tende ad eseguire <strong>in</strong>terventi<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>fferenziati <strong>di</strong> conversione a fustaia coetanea da trattare a tagli successivi. Formazioni<br />
riconducibili a quella <strong>di</strong> ASP2 sarebbero assolutamente <strong>in</strong>adeguate ad un tale tipo <strong>di</strong> trattamento,<br />
che dovrebbe <strong>in</strong>vece essere orientato alla costituzione <strong>di</strong> gruppi omogenei al loro <strong>in</strong>terno, ma<br />
tendenti complessivamente a <strong>di</strong>versificare la struttura. La dest<strong>in</strong>azione naturalistica prevalente ne<br />
trarrebbe comunque vantaggio perché <strong>in</strong> questo modo sarebbe possibile valorizzare anche le<br />
specie accessorie (aceri, sorbi e abete bianco), attualmente spora<strong>di</strong>che (le prime due) o <strong>in</strong> <strong>di</strong>fficoltà<br />
vegetative (la terza) a causa sia <strong>del</strong>la gestione pregressa, ma anche <strong>del</strong> prolungato abbandono.<br />
Dall’altra parte il governo ceduo potrebbe essere recuperato <strong>in</strong> alcune zone sia a supporto <strong>di</strong> un<br />
miglioramento strutturale e funzionale <strong>del</strong>le cenosi ed anche <strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to per la locale<br />
Comunanza Agraria, ancora <strong>in</strong>teressata alla legna da ardere. Nel primo caso cenosi <strong>del</strong> limite<br />
superiore come quelle presenti <strong>in</strong> ASP1, nel breve o me<strong>di</strong>o term<strong>in</strong>e potrebbero essere trattate con<br />
forme <strong>di</strong> ceduazioni particolari, a basso impatto (es. per piccole buche), con eventuale recupero<br />
<strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura o a forme <strong>di</strong> selezione <strong>di</strong> polloni sulla ceppaia, riconducibili a forme <strong>di</strong> ceduo a<br />
sterzo. Va ricordato per esempio che <strong>in</strong> passato <strong>in</strong> molte zone <strong>di</strong> marg<strong>in</strong>e <strong>del</strong> bosco, si procedeva<br />
a conservare fasce <strong>di</strong> rispetto ad utilizzazione ridotta per mantenere una copertura costante, ma<br />
anche una capacità rigenerativa <strong>del</strong>le ceppaie per costituire sistemi più resilienti alle perturbazioni<br />
climatiche e geomorfologiche (rotolamento e scivolamento <strong>di</strong> materiale clastico). Non si <strong>di</strong>mentichi<br />
che la funzione <strong>di</strong> protezione idrogeologica <strong>del</strong>le cenosi <strong>del</strong>la treel<strong>in</strong>e è cruciale alle altre funzioni.<br />
Nel secondo caso <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare le cenosi con f<strong>in</strong>alità produttive (visto l’uso civico locale) potrebbe<br />
facilitare notevolmente le operazioni <strong>di</strong> taglio e abbassare il prezzo <strong>di</strong> macchiatico.<br />
L’impiego <strong>di</strong> aree permanenti nello stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>la vegetazione forestale è fondamentale per<br />
comprenderne i <strong>di</strong>namismi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o e lungo term<strong>in</strong>e che sono quelli che maggiormente <strong>in</strong>teressano<br />
a f<strong>in</strong>i gestionali. Si tratta <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> impegnativi e laboriosi sia <strong>in</strong> campo, sia nella gestione <strong>del</strong>le<br />
<strong>in</strong>formazioni ma necessari per comprendere i complessi processi e <strong>di</strong>namismi spazio-temporali<br />
<strong>del</strong>le cenosi forestali. Lo sforzo profuso è comunque appagante perché ne consegue una grande<br />
mole <strong>di</strong> dati utili per un monitoraggio nel tempo.<br />
LE CONVERSIONI NELLE FAGGETE DEI MONTI DELLA LAGA (AP) (Sant<strong>in</strong>i et al. 2009)<br />
La complessa morfologia <strong>del</strong> territorio e la scarsa accessibilità <strong>di</strong> questa zona montana, hanno<br />
determ<strong>in</strong>ato, a partire dalla seconda metà <strong>del</strong> secolo scorso, l’abbandono <strong>di</strong> molte aree forestali<br />
soprattutto <strong>in</strong> quelle a maggiore altitu<strong>di</strong>ne, caratterizzate oggi da cedui abbandonati praticamente<br />
senza matric<strong>in</strong>atura (Sant<strong>in</strong>i, 2008). Il loro conseguente “<strong>in</strong>vecchiamento”, term<strong>in</strong>e che identifica i<br />
cedui che hanno abbondantemente superato l’età <strong>del</strong> turno, secondo <strong>di</strong>versi autori (Bernetti 1981,<br />
Gambi 1986, Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1983 e 1991) non dovrebbe, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> pr<strong>in</strong>cipio, determ<strong>in</strong>are<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> funzionalità perché i soprassuoli, dopo un periodo <strong>di</strong> stasi, sarebbero <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> produrre<br />
<strong>in</strong>crementi crescenti <strong>in</strong> tempi me<strong>di</strong>o-lunghi. L’abbandono colturale, peraltro, ha causato la presenza<br />
<strong>di</strong> estese superfici <strong>di</strong> cedui <strong>in</strong>vecchiati, per le quali il regolamento forestale regionale prevede<br />
scelte selvicolturali obbligate. Le faggete con età superiore ai 40 anni sono <strong>in</strong>fatti dest<strong>in</strong>ate<br />
all’avviamento a fustaia, processo <strong>in</strong>iziato con fon<strong>di</strong> europei e regionali <strong>in</strong> alcune <strong>del</strong>le proprietà<br />
collettive, dove a trent’anni dai primi <strong>in</strong>terventi si è voluto analizzarne i <strong>di</strong>namismi strutturali e <strong>del</strong>la<br />
qualità dei fusti, per valutarne un’eventuale potenzialità commerciale.<br />
E’ stata realizzata un’analisi s<strong>in</strong>cronica <strong>di</strong> tre soprassuoli contigui, ma <strong>in</strong> <strong>di</strong>fferenti sta<strong>di</strong> <strong>del</strong><br />
processo <strong>di</strong> conversione eseguito con il metodo <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> avviamento: a) un ceduo abbandonato<br />
utilizzato come sito testimone (ST); b) fustaia transitoria sottoposta ad un solo taglio <strong>di</strong>
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
avviamento nel 1973 (S1D); c) fustaia transitoria sottoposta ad un secondo <strong>di</strong>radamento nel 2003<br />
(S2D).<br />
I popolamenti analizzati sono situati nel territorio <strong>del</strong>la Comunanza Agraria <strong>di</strong> Montacuto<br />
(comune <strong>di</strong> Acquasanta Terme, AP) <strong>in</strong> gran parte <strong>in</strong>cluso nel SIC “Valle <strong>del</strong>la Corte”, che a sua<br />
volta rientra nel Parco Nazionale <strong>del</strong> Gran Sasso e Monti <strong>del</strong>la Laga. Il sito ST si trova <strong>in</strong> una<br />
riserva generale orientata, mentre gli altri due <strong>in</strong> riserva <strong>in</strong>tegrale dove è esclusa la conduzione <strong>di</strong><br />
attività agro-silvo-pastorali, fatti salvi i <strong>di</strong>ritti reali e gli usi civici <strong>del</strong>le collettività locali come <strong>in</strong><strong>di</strong>cato<br />
dal Piano <strong>del</strong> Parco (non ancora operativo) e dalla legge 349/1991. Le aree oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sono<br />
ubicate su litotipi pelitico-arenacei identificabili come Flysh terrigeni <strong>del</strong>la Laga, ad un’altitu<strong>di</strong>ne<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1400 m, esposte prevalentemente a nord, con pendenza me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> 55%. I soprassuoli<br />
analizzati hanno un’età prevalente <strong>di</strong> 60 anni e sono tutte faggete localmente <strong>in</strong> purezza ma<br />
appartenenti al tipo “Faggeta mesoneutrofila, variante con abete bianco” (IPLA, 2001).<br />
In ogni sito sono state realizzate tre aree <strong>di</strong> saggio circolari con raggio <strong>di</strong> 12 m per ST e <strong>di</strong> 15 m<br />
per S1D e S2D. Successivamente i dati <strong>di</strong> ogni area sono stati cumulati e me<strong>di</strong>ati per ogni sito. In<br />
ognuna <strong>del</strong>le 9 aree <strong>di</strong> saggio è stato effettuato il cavallettamento totale degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui con soglia<br />
m<strong>in</strong>ima <strong>di</strong> 1 cm a 1,30 m <strong>di</strong> altezza sul fusto e su ogni <strong>in</strong><strong>di</strong>viduo 8 sono state rilevate l’altezza totale,<br />
l’altezza d’<strong>in</strong>serzione <strong>del</strong>la chioma, le proiezioni orizzontali <strong>del</strong>la chioma nelle quattro <strong>di</strong>rezioni<br />
car<strong>di</strong>nali e le con<strong>di</strong>zioni vegetative. Il volume cormometrico <strong>di</strong> SD1 e SD2 è stato determ<strong>in</strong>ato<br />
me<strong>di</strong>ante l’espressione funzionale per le fustaie <strong>di</strong> faggio <strong>del</strong>le tavole <strong>di</strong> cubatura <strong>del</strong>l’ISAFA,<br />
utilizzata anche per il sito testimone <strong>in</strong> quanto il soprassuolo è strutturalmente molto più simile ad<br />
una fustaia che ad un ceduo. Successivamente è stata valutata anche la qualità tecnologica dei<br />
fusti misurati, rilevando la presenza <strong>di</strong> sciabolatura, la lunghezza <strong>del</strong> toppo, la forma (<strong>in</strong> particolar<br />
modo la cil<strong>in</strong>dricità) e la presenza <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fetti quali la s<strong>in</strong>uosità, l’<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione, la presenza <strong>di</strong><br />
fibratura irregolare, <strong>di</strong> no<strong>di</strong>, <strong>di</strong> ferite e/o cicatrici. Ogni fusto é stato virtualmente sud<strong>di</strong>viso <strong>in</strong> tre<br />
toppi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni standard <strong>di</strong>fferenti: il primo dalla base <strong>del</strong> tronco a 4 m, il secondo da 4 a 6 m<br />
ed il terzo f<strong>in</strong>o all’<strong>in</strong>serzione <strong>del</strong>la chioma. Sono state <strong>in</strong><strong>di</strong>viduate tre classi <strong>di</strong> qualità: A (elevata)<br />
che <strong>in</strong><strong>di</strong>vidua i toppi potenzialmente dest<strong>in</strong>ati alla produzione <strong>di</strong> tranciati o sfogliati; B (buona)<br />
relativa a toppi per assortimenti da sega e C (scadente) per toppi commercializzabili solo come<br />
legno energia. In presenza <strong>di</strong> toppi contigui <strong>di</strong> un fusto appartenenti alla stessa classe qualitativa<br />
(solo per le classi A e B) si è proceduto al loro accorpamento secondo classi <strong>di</strong>mensionali relative<br />
a porzioni <strong>di</strong> tronco con lunghezza maggiore o uguale a 8, 6, 4 e 2 m. Tale analisi ha comunque<br />
<strong>in</strong>teressato gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui con <strong>di</strong>ametro superiore a 20 cm.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>ametrica degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui evidenzia una struttura coetaneiforme dei tre<br />
soprassuoli, ma con alcune <strong>di</strong>fferenze sostanziali (Fig.5): ST è caratterizzato dalla tipica curva<br />
asimmetrica verso i <strong>di</strong>ametri <strong>in</strong>feriori; S2D da una curva perfettamente normale con moda nella<br />
classe dei 18-20 cm; S1D presenta <strong>in</strong>vece un’anomala <strong>di</strong>stribuzione caratterizzata da un elevato<br />
numero <strong>di</strong> alberi nelle classi <strong>di</strong>ametriche <strong>in</strong>feriori e che bene evidenzia le modalità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento nei<br />
<strong>di</strong>radamenti. ST è l’unico sito con alberi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro superiore a 35 cm.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione ipsometrica esprime una struttura verticale praticamente monoplana <strong>in</strong> S1D e<br />
S2D, mentre nel sito testimone vi sono <strong>di</strong>namismi ancora attivi fra ceppaie dom<strong>in</strong>anti e<br />
subdom<strong>in</strong>anti, che alcuni autori attribuiscono ad un processo evolutivo strutturale <strong>di</strong> tipo<br />
asimmetrico (Piovesan et al. 1995) pr<strong>in</strong>cipalmente determ<strong>in</strong>ato dalla competizione per la luce<br />
(Amor<strong>in</strong>i e Fabbio 1991). Le provvigioni ad ettaro sono tutte decisamente elevate per le Marche e<br />
superiori (anche <strong>del</strong> doppio nel caso <strong>di</strong> ST e SD1) alle me<strong>di</strong>e (200-220 m 3 /ha) <strong>in</strong><strong>di</strong>cate<br />
dall’Inventario Forestale Regionale (IPLA, 2001). La <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong> volume per classi <strong>di</strong>ametriche<br />
evidenzia andamenti abbastanza regolari nei tre siti (Fig. 6): solo <strong>in</strong> ST il peso <strong>del</strong>le classi me<strong>di</strong>oalte<br />
<strong>di</strong>venta più rilevante. Le curve ipsometriche cumulate dei tre siti, (Fig. 7) descritte da funzioni<br />
semilogaritmiche, <strong>in</strong><strong>di</strong>cano relazioni ipso<strong>di</strong>ametriche molto simili, con alcune <strong>di</strong>fferenze <strong>in</strong> S1D<br />
caratterizzato da una maggiore fertilità, ma anche da <strong>di</strong>namismi <strong>di</strong> concorrenza tra gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>di</strong><br />
m<strong>in</strong>or <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong>ametrica, con<strong>di</strong>zione presente anche <strong>in</strong> ST ma non rilevabile dal grafico, <strong>in</strong><br />
quanto le altezze <strong>in</strong> quel sito sono state misurate solo sul pollone dom<strong>in</strong>ante <strong>di</strong> ogni ceppaia. La<br />
quasi perfetta sovrapposizione <strong>del</strong>le curve <strong>di</strong> ST e SD2 evidenzia ulteriormente che con il taglio <strong>di</strong><br />
avviamento sono stati asportati pr<strong>in</strong>cipalmente gli alberi <strong>di</strong> maggior <strong>di</strong>mensione mentre con il<br />
secondo <strong>di</strong>radamento si è <strong>in</strong>tervenuto sugli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> m<strong>in</strong>or <strong>di</strong>ametro e altezza. La maggiore<br />
stabilità degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui, stimata dal rapporto <strong>di</strong> snellezza, è presente nel sito S2D e <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce<br />
anche <strong>in</strong> modo sensibile negli altri due.<br />
8 Nel sito ST i dati si riferiscono al pollone dom<strong>in</strong>ante<br />
167
168<br />
Francesco Renzaglia et al.<br />
Relativamente alla qualità dei fusti le Figure 8 e 9 s<strong>in</strong>tetizzano, rispettivamente, la <strong>di</strong>stribuzione<br />
dei toppi <strong>di</strong> classe A e B nelle <strong>di</strong>verse classi <strong>di</strong>mensionali e nei tre siti. E’ evidente l’assenza<br />
assoluta <strong>di</strong> toppi <strong>di</strong> classe A con lunghezza superiore o uguale a 8 m, mentre quelli <strong>di</strong> classe B si<br />
trovano solo nel ceduo. La prevalenza <strong>di</strong> toppi <strong>di</strong> più <strong>di</strong> 8 metri <strong>di</strong> classe B nel sito SD1 è attribuibile<br />
alla numerosa presenza <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui che attualmente hanno <strong>di</strong>ametri ridotti.<br />
Esiste <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e una relazione tra <strong>in</strong> numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamenti e la percentuale <strong>di</strong> fusti con danni<br />
meccanici <strong>in</strong>fatti, il sito testimone caratterizzato dall’assenza d’<strong>in</strong>terventi presenta solo il 14% <strong>di</strong><br />
piante lesionate mentre, S1D (un <strong>in</strong>tervento) e S2D (due <strong>in</strong>terventi) ne hanno rispettivamente il 43<br />
ed il 76%; questo fenomeno è attribuibile al concentramento <strong>del</strong> legname effettuato nelle passate<br />
utilizzazioni per avvallamento manuale.<br />
La raccolta dei dati dendrometrici e quelli relativi alla qualità dei fusti, ha permesso <strong>di</strong> analizzare<br />
la struttura dei tre popolamenti e verificarne la potenzialità per la produzione <strong>di</strong> assortimenti <strong>di</strong>versi<br />
dalla legna da ardere. L’analisi ha messo <strong>in</strong> luce un assetto strutturale caratterizzato da elevata<br />
omogeneità che deriva sia dalla gestione pregressa (Renzaglia, 2008), che dai trattamenti<br />
realizzati <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> conversione.<br />
Fig. 5. Distribuzione <strong>di</strong> frequenza <strong>in</strong> classi <strong>di</strong>ametriche (3 cm) degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui nelle tre aree <strong>di</strong> saggio<br />
Fig. 6. Distribuzione <strong>del</strong> volume cormometrico <strong>in</strong> classi <strong>di</strong>ametriche nelle tre aree <strong>di</strong> saggio.
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
Fig. 7. Curve ipsometriche <strong>del</strong>le 3 aree <strong>di</strong> saggio<br />
Fig. 8. Distribuzione per classi <strong>di</strong>mensionali dei toppi <strong>di</strong> classe A nei tre siti d'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e.<br />
Fig. 9. Distribuzione per classi <strong>di</strong>mensionali dei toppi <strong>di</strong> classe B nei tre siti d'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />
169
170<br />
Francesco Renzaglia et al.<br />
Nonostante alcune evidenti <strong>di</strong>fferenze negli assetti <strong>di</strong>ametrici e ipsometrici la struttura<br />
coetaneiforme è chiaramente espressa da tutti i parametri analizzati e prefigura quale risultato<br />
f<strong>in</strong>ale una fustaia coetanea da trattare a tagli successivi, sebbene sia il Piano <strong>di</strong> Gestione <strong>del</strong>le<br />
Proprietà <strong>del</strong>le Comunanze Agrarie dei Monti <strong>del</strong>la Laga, sia il Piano Particolareggiato <strong>di</strong><br />
Assestamento Forestale, non suggeriscano specifici <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi gestionali <strong>in</strong> merito. Tale con<strong>di</strong>zione è<br />
tipicamente associata ad una funzione produttiva <strong>del</strong> bosco, mentre nel sito <strong>in</strong> esame gli usi civici<br />
<strong>di</strong> legnatico, tra<strong>di</strong>zionalmente fondati sul ceduo (legna da ardere e carbone), e la presenza <strong>di</strong><br />
sovrapposti e forti v<strong>in</strong>coli ambientali (parco nazionale e SIC) impongono quantomeno una<br />
riflessione sull’opportunità <strong>di</strong> attuare trattamenti selvicolturali <strong>di</strong>fferenziati e f<strong>in</strong>alizzati a costituire<br />
strutture forestali più eterogenee e stabili. Nonostante le deroghe <strong>di</strong> utilizzazione <strong>in</strong> area a riserva<br />
<strong>in</strong>tegrale, concesse per uso civico, non prive <strong>di</strong> frequenti contenziosi fra le parti, è possibile<br />
prevedere negli anni il completo abbandono <strong>del</strong> bosco, con<strong>di</strong>zione che determ<strong>in</strong>erebbe svantaggi<br />
<strong>di</strong>ffusi per tutti. Una revisione degli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi selvicolturali per <strong>di</strong>versificare i soprassuoli <strong>in</strong> senso<br />
strutturale e compositivo, una volta comprovata la loro sostenibilità, potrebbe dar luogo alla<br />
cont<strong>in</strong>uità gestionale e produttiva per le comunità locali, ma anche migliorare l’attuale assetto<br />
ecosistemico <strong>del</strong>le faggete. Infatti la zonizzazione a riserva <strong>in</strong>tegrale <strong>di</strong> gran parte <strong>del</strong>le faggete <strong>di</strong><br />
Valle <strong>del</strong>la Corte, non è sempre coerente con la tutela e il miglioramento <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità richiesti<br />
dalla Direttiva Habitat per le aree Natura 2000, che comprendono una buona parte dei boschi<br />
suddetti. La presenza <strong>di</strong> habitat prioritari come quello <strong>del</strong>le “Faggete appenn<strong>in</strong>iche con abete<br />
bianco” e “Faggete con tasso e agrifoglio” impongono, nell’area <strong>in</strong> oggetto, <strong>in</strong>terventi selvicolturali<br />
volti a favorire la r<strong>in</strong>novazione e lo sviluppo <strong>di</strong> tali specie accessorie ed <strong>in</strong> particolare l’abete bianco<br />
autoctono, che si trova <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni estremamente precarie, sotto la copertura <strong>del</strong> faggio.<br />
L’orientamento verso strutture più irregolari è giustificabile <strong>in</strong> quanto un’eventuale trattamento a<br />
tagli successivi alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong> processo <strong>di</strong> conversione non potrà mai essere, per motivi paesaggistici<br />
e naturalistici, <strong>di</strong> tipo uniforme, bensì graduale su piccole superfici. Pertanto l’esecuzione <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>terventi selettivi, già nei prossimi <strong>di</strong>radamenti, potrebbe consentire da subito una<br />
sperimentazione atta a testarne gli effetti almeno <strong>in</strong> relazione alle esigenze <strong>di</strong> uso civico. In tal<br />
senso si potrebbe far riferimento ai criteri <strong>in</strong><strong>di</strong>cati per <strong>di</strong>radamenti selettivi con l’obiettivo <strong>di</strong><br />
applicare una più efficiente gestione forestale sostenibile (Piussi, 1985; Wolynski, 2002).<br />
Per quanto riguarda l’aspetto produttivo, una filiera <strong>del</strong> faggio da opera (presente f<strong>in</strong>o alla prima<br />
metà <strong>del</strong> secolo scorso) non è un’obiettivo realistico oggi <strong>in</strong> questa zona <strong>del</strong>l’Appenn<strong>in</strong>o centrale,<br />
sia per i v<strong>in</strong>coli esistenti, sia per le consuetu<strong>di</strong>ni locali <strong>di</strong> utilizzazione forestali. I risultati<br />
<strong>del</strong>l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e evidenziano <strong>in</strong>fatti che f<strong>in</strong>o al 76% degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui rilasciati dopo i <strong>di</strong>radamenti presenta<br />
significativi danni meccanici causati dall’abbattimento e soprattutto dall’avvallamento manuale dei<br />
tronchi sezionati.<br />
Gli <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzi gestionali proposti, f<strong>in</strong>alizzati ad una struttura più irregolare <strong>del</strong>le cenosi e ad una<br />
selvicoltura <strong>di</strong> selezione potrebbero prevedere <strong>in</strong>terventi assimilabili alla cosiddetta selvicoltura<br />
d’albero (Spiecker, 2008) per una produzione limitata, ma <strong>di</strong> elevata qualità, <strong>di</strong> fusti da opera. Se<br />
associati ad una più razionale <strong>di</strong>stribuzione spazio-temporale <strong>del</strong>le utilizzazioni consentirebbe, <strong>in</strong><br />
modo sostenibile, il mantenimento <strong>del</strong>l’uso civico e la valorizzazione <strong>del</strong>le altre importanti funzioni<br />
ecologiche e ambientali (Wolynski et al. 2006).<br />
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />
Una parte notevole <strong>del</strong>le faggete <strong>del</strong>l’appenn<strong>in</strong>o centrale sono state sottoposte a questa forma<br />
<strong>di</strong> governo, e oggi si trovano frequentemente <strong>in</strong> abbandono colturale. Nelle Marche oltre il 65%<br />
<strong>del</strong>la superficie forestale è costituita da cenosi riconducibili al bosco ceduo nelle sue <strong>di</strong>verse<br />
caratterizzazioni strutturali. I boschi <strong>del</strong>la Laga sono peraltro formazioni con una elevata fertilità<br />
stazionale derivante da suoli sciolti e profon<strong>di</strong> che consentono alle cenosi presenti <strong>di</strong> sviluppare<br />
una buona resilienza per recuperare assetti omeostatici alterati. In queste aree è cambiata la<br />
dest<strong>in</strong>azione funzionale prevalente, passando da quella produttiva a quella naturalistica e turisticoricreativa,<br />
che impone spesso notevoli limitazioni d’uso.<br />
La selvicoltura è una scienza ed una tecnica <strong>in</strong>sieme e più <strong>di</strong> altre soffre il problema<br />
<strong>del</strong>l’<strong>in</strong>determ<strong>in</strong>atezza dei suoi effetti nell’arco <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> tecnico forestale, visti i tempi <strong>di</strong> azione e<br />
reazione <strong>del</strong>le cenosi forestali, soprattutto se sv<strong>in</strong>colate dai turni produttivi <strong>del</strong> bosco ceduo. Non è<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> plausibile cont<strong>in</strong>uare ad applicare trattamenti sulla base <strong>di</strong> retroazioni calibrate su<br />
sperimentazioni pregresse e spesso funzionali a f<strong>in</strong>alità produttive. Dall’altro è ancor più<br />
<strong>in</strong>adeguato il ricorrente e standar<strong>di</strong>zzante approccio (<strong>di</strong>retto o <strong>in</strong><strong>di</strong>retto) adottato da molti enti
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
pubblici e privati e consistente nell’evoluzione libera. Questa soluzione forse serve a tranquillizzare<br />
le coscienze <strong>di</strong> tecnici e amm<strong>in</strong>istratori oltre che ad esentarli dal giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong>l’op<strong>in</strong>ione pubblica nel<br />
breve term<strong>in</strong>e, ma complessivamente non li esenta dalla responsabilità <strong>di</strong> contribuire alla riduzione<br />
<strong>del</strong>la multifunzionalità <strong>del</strong>le foreste e dei possibili effetti che questa può determ<strong>in</strong>are, soprattutto se<br />
non si procederà a migliorare la comprensione dei complessi meccanismi ecositemici <strong>di</strong> queste<br />
formazioni.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AMORINI E., FABBIO G., 1983 – Stu<strong>di</strong>o auxometrico <strong>in</strong> un ceduo <strong>in</strong>vecchiato e <strong>in</strong> una fustaia da<br />
polloni <strong>di</strong> faggio, sull’Appenn<strong>in</strong>o toscano. Primo contributo. Annali per l’Istituto Sperimentale per<br />
la Selvicoltura, Arezzo, XIV: 283-328.<br />
AMORINI E., FABBIO G., 1991 - Ricerche sull’«<strong>in</strong>vecchiamento» dei cedui: riflessioni sul<br />
trattamento <strong>di</strong> conversione. L’Italia Forestale e Montana, XLVI (3): 193-204.<br />
BERNETTI G., 1981 – Ipotesi sullo sviluppo dei boschi cedui e relative considerazioni selvicolturali<br />
e assestamentali. Il Montanaro d’Italia, XXXII (5): 61-66.<br />
FABBIO G., BRUSCHINI S., MANETTI M. C., 1997 - Selvicoltura nelle faggete irregolari: un caso<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Annali <strong>del</strong>l’Istituto Sperimentale <strong>di</strong> Selvicoltura, 28: 75-86.<br />
GAMBI G., 1986 - La conversione dei cedui <strong>di</strong> faggio <strong>in</strong> altofusto sull’Appenn<strong>in</strong>o. Monti e Boschi,<br />
XXXVII (2): 3-19.<br />
IPLA, 2001 - Inventario e Carta Forestale <strong>del</strong>la Regione Marche. I tipi forestali <strong>del</strong>le Marche.<br />
Assessorato Agricoltura e Foreste regione Marche.<br />
PIUSSI P., 1985 - Sempre <strong>in</strong> tema <strong>di</strong> chiarimenti term<strong>in</strong>ologici: i <strong>di</strong>radamenti selettivi. Forestale e<br />
montana, XXXVI (2): 56-57.<br />
PIOVESAN G., HERMANIN L., SCHIRONE B., 1995 – Considerazioni sulla crescita e lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> un ceduo matric<strong>in</strong>ato <strong>di</strong> faggio <strong>di</strong> età avanzata. L’Italia Forestale e Montana, L (4): 404-424.<br />
RENZAGLIA F., 2008 - Struttura, <strong>di</strong>namismi e multifunzionalità <strong>del</strong>le faggete appenn<strong>in</strong>iche <strong>del</strong><br />
limite superiore <strong>del</strong> bosco nel bac<strong>in</strong>o idrografico <strong>del</strong> Tronto. Tesi <strong>di</strong> dottorato, Università<br />
Politecnica <strong>del</strong>le Marche.<br />
SANTINI E., 2008 - Analisi <strong>del</strong>la struttura dei cedui <strong>di</strong> faggio <strong>in</strong> conversione nei Monti <strong>del</strong>la Laga.<br />
Tesi <strong>di</strong> laurea specialistica, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Padova.<br />
SANTINI E., PIVIDORI M., URBINATI C., 2009. Assetto strutturale e qualità dei fusti. Stu<strong>di</strong>o su<br />
cedui <strong>di</strong> faggio <strong>in</strong> conversione <strong>in</strong> un Parco Nazionale. Sherwood, 155: 5-9.<br />
SPIECKER H., 2008 - Specie spora<strong>di</strong>che. Un’opportunità per le specie spora<strong>di</strong>che. Sherwood, 14<br />
(6): 4-8.<br />
WOLYNSKI A., 2002 - Sul trattamento irregolare <strong>del</strong>le fustaie <strong>di</strong> faggio. Numero speciale<br />
Sherwood, 8 (11/2).<br />
WOLYNSKI A., BERRETTI R., MOTTA R., 2006 – Selvicoltura multifunzionale orientata alla<br />
qualità. Sherwood, 12 (1): 5-12.<br />
171
172<br />
Francesco Renzaglia et al.
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
173
174<br />
Francesco Renzaglia et al.
D<strong>in</strong>amismi strutturali e <strong>di</strong> accrescimento <strong>in</strong> boschi cedui abbandonati ed <strong>in</strong> conversione <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o centrale<br />
175
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
UNGULATI E BOSCO CEDUO<br />
GIANLUCA GIOVANNINI<br />
DIP. DEISTAF, UNIVERSITÀ DI FIRENZE
178<br />
INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i<br />
Il problema <strong>del</strong> rapporto tra Ungulati e bosco ceduo non è <strong>di</strong> facile soluzione.<br />
Esistono <strong>in</strong>fatti problemi tecnici (controllo animali, protezione tratti <strong>in</strong> r<strong>in</strong>novazione) e problemi<br />
economici, sociali e culturali, legati alle caratteristiche dei boschi cedui: piccole proprietà spesso<br />
frammentate, scarso legame tra proprietà <strong>del</strong> bosco e utilizzazione, bassa red<strong>di</strong>tività, scarsa<br />
considerazione <strong>del</strong> bosco ceduo nell’ambito <strong>del</strong>le politiche <strong>di</strong>gestione forestale). A questi ultimi si<br />
deve aggiungere la <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>la proprietà <strong>di</strong> boschi cedui e, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>del</strong>l’alto numero –<br />
a parità <strong>di</strong> superficie danneggiata - <strong>di</strong> persone “scontente” (è chiaramente un eufemismo!)<br />
Non si può parlare <strong>di</strong> rapporto tra bosco ceduo e ungulati senza aver prima <strong>in</strong>quadrato, sia pure<br />
brevemente perché ormai il problema è largamente <strong>di</strong>battuto, il problema nel contesto <strong>del</strong>la<br />
gestione selvicolturale dei boschi.<br />
Negli ultimi decenni In Italia, così come <strong>in</strong> molti altri paesi europei, è stata segnalata una<br />
espansione <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> ungulati selvatici, sia <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> areali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, sia <strong>in</strong><br />
term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> consistenza numerica (recentemente, tra gli altri: Apollonio, 2004 <strong>in</strong> Cut<strong>in</strong>i 2006, Motta,<br />
1999). Analoga situazione è osservabile <strong>in</strong> altre nazioni europee, ad es. <strong>in</strong> Francia (Kle<strong>in</strong> et al.,<br />
2008).<br />
Alla base <strong>del</strong>le cause che hanno favorito l’espansione <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> ungulati abbiamo una<br />
serie <strong>di</strong> aspetti socio-economici, ancor prima che ecologici: l’emigrazione dalle zone montane alle<br />
città e le zone <strong>di</strong> pianura, prima, e, <strong>in</strong> seguito, il maggiore <strong>in</strong>teresse per la conservazione<br />
<strong>del</strong>l'ambiente e per tutto quello che, nella percezione comune, rappresentava aspetti <strong>di</strong> naturalità<br />
nell’op<strong>in</strong>ione pubblica.<br />
Il primo ha avuto come conseguenza l’abbandono <strong>del</strong>le pratiche agricole <strong>in</strong> molte zone, qu<strong>in</strong><strong>di</strong><br />
m<strong>in</strong>ore competizione con animali domestici, cambiamento (oltre che <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>l’attività<br />
venatoria), aumento <strong>del</strong>le zone boscate.<br />
Dirette conseguenze <strong>del</strong> secondo aspetto sono <strong>in</strong>vece da considerare le attività <strong>di</strong><br />
re<strong>in</strong>troduzione e ripopolamento operate negli anni e, <strong>in</strong> certi casi, l’opposizione <strong>del</strong>l’op<strong>in</strong>ione<br />
pubblica a <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> contenimento <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> ungulati selvatici.<br />
Anche i cambiamenti <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> attività venatoria sono comunque da considerare effetti <strong>del</strong>le<br />
mutate con<strong>di</strong>zioni sociali: la caratteristica lu<strong>di</strong>co-sportiva ha sempre più preso il sopravvento su<br />
quella legata alla alimentazione.<br />
DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI<br />
L'entità <strong>del</strong> danno causato dalla fauna selvatica <strong>di</strong>pende <strong>in</strong> primo luogo dalla densità e dalle<br />
caratteristiche <strong>del</strong>le specie animali presenti (taglia, <strong>di</strong>eta, <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> popolazione); e la densità, a<br />
sua volta, è positivamente correlata con la quantità e la varietà <strong>del</strong>l'offerta alimentare.<br />
La fase <strong>di</strong> maggiore suscettibilità, corrispondente al periodo <strong>di</strong> maggiore <strong>di</strong>sponibilità<br />
alimentare, è rappresentata dai primi anni successivi al taglio, <strong>in</strong> misura man mano decrescente<br />
con l’aumentare <strong>del</strong>l’età dei polloni. In questo periodo il danno è costituito essenzialmente da<br />
brucature, mentre gli sfregamenti sono limitati e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> decisamente meno <strong>in</strong>fluenti.<br />
I boschi cedui sono particolarmente suscettibili ai danni da ungulati, ed <strong>in</strong> particolare alle<br />
brucature, durante il primo periodo <strong>di</strong> vita dei polloni. Il term<strong>in</strong>e è volutamente generico perché la<br />
durata <strong>del</strong> periodo <strong>di</strong> brucatura <strong>di</strong>pende da svariate cause: l’<strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> brucatura, che a sua volta<br />
<strong>di</strong>pende dalla consistenza <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> cervi<strong>di</strong>, e la capacità, o meglio maggiore o m<strong>in</strong>ore<br />
velocità <strong>di</strong> accrescimento dei polloni e, <strong>di</strong> conseguenza, il rapido raggiungimento <strong>di</strong> un’altezza <strong>del</strong>le<br />
gemme apicali che possa essere <strong>in</strong>accessibile agli animali selvatici. Anche <strong>in</strong> questo caso entrano<br />
<strong>in</strong> gioco <strong>di</strong>versi fattori: la vigoria <strong>del</strong>le ceppaie ma anche la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una più ampia offerta<br />
alimentare, ad esempio nuove tagliate <strong>in</strong> zone vic<strong>in</strong>e negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi.<br />
La brucatura è senza dubbio l’attività che produce gli effetti più importanti. Nel corso <strong>di</strong> ricerche<br />
condotte dal 1988 dall’Istituto <strong>di</strong> Selvicoltura <strong>del</strong>l’Università <strong>di</strong> Firenze <strong>in</strong> boschi cedui <strong>del</strong> Parco<br />
<strong>del</strong>la Maremma è stato osservato che sia i getti apicali che quelli laterali dei giovani polloni, sia <strong>di</strong><br />
caducifoglie che <strong>di</strong> semprever<strong>di</strong>, sono brucati soprattutto nel periodo <strong>del</strong>l’accrescimento, quando<br />
hanno consistenza erbacea, mentre la bucatura <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uisce quando i getti lignificano e sembra che<br />
non venga ripetuta sulla parte restante <strong>di</strong> un getto già brucato <strong>in</strong> precedenza (Rossi, 1995; Ch<strong>in</strong>es<br />
et al., 1997). Considerando che nei primi anni <strong>di</strong> vita i polloni <strong>di</strong> molte specie e producono più getti<br />
prolettici durante l’anno, anche 3 o 4 flussi nel primo anno (Giovann<strong>in</strong>i et al., 1992), si capisce<br />
come giovani polloni rappresent<strong>in</strong>o una importante fonte <strong>di</strong> alimentazione.
Ungulati e bosco ceduo<br />
Una <strong>del</strong>le ipotesi per spiegare il forte aumento <strong>di</strong> da<strong>in</strong>i nel Parco Regionale <strong>del</strong>la Maremma nei<br />
primi 15 anni <strong>di</strong> istituzione, accanto al particolare regime <strong>di</strong> protezione con cessazione <strong>di</strong> attività<br />
venatoria ed una generale <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong> <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e antropica presente, <strong>in</strong><strong>di</strong>cava nella<br />
ripresa <strong>del</strong>le ceduazioni dopo una sospensione quasi ventennale e la conseguente offerta<br />
alimentare le con<strong>di</strong>zioni ottimali per questa specie (Giovann<strong>in</strong>i, 1991).<br />
l taglio <strong>del</strong> ceduo viene effettuato nel periodo <strong>in</strong>vernale ed il ricaccio <strong>del</strong>le ceppaie <strong>in</strong>izia a metà<br />
primavera, con qualche <strong>di</strong>fferenza dovuta al clima e al periodo <strong>di</strong> taglio. L’accrescimento <strong>in</strong>iziale<br />
dei polloni è generalmente rapido, con altezze che possono raggiungere 1-1,5 m già alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong><br />
primo anno <strong>di</strong> vegetazione. In questo periodo, o almeno per alcuni mesi, tutti i ricacci sono<br />
completamente accessibili agli ungulati e la brucatura, rallentando lo sviluppo <strong>in</strong> altezza, prolunga il<br />
periodo <strong>di</strong> vulnerabilità. In questo primo periodo riveste un ruolo importante la fenologia <strong>del</strong>le<br />
<strong>di</strong>verse specie vegetali: una specie che entra <strong>in</strong> vegetazione molto prima <strong>del</strong>le altre si trova per<br />
un certo periodo, anche alcune settimane talvolta, ad essere la pr<strong>in</strong>cipale, se non la sola, fonte <strong>di</strong><br />
alimentazione <strong>di</strong>sponibile. E’ il caso <strong>del</strong>l’orniello, (Frax<strong>in</strong>us ornus) nei cedui <strong>di</strong> macchia<br />
me<strong>di</strong>terranea i cui polloni, a partire dal secondo anno anticipano <strong>di</strong> circa un mese l'entrata <strong>in</strong><br />
vegetazione <strong>del</strong>le altre specie, subendo così una forte brucatura.<br />
Durante i primi mesi dopo il taglio <strong>del</strong> bosco tutti i polloni hanno la possibilità <strong>di</strong> essere brucati (e<br />
talvolta lo sono), questo processo da un lato accelera il fenomeno <strong>del</strong>la <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong> numero,<br />
dall’altro mo<strong>di</strong>fica i rapporti sociali tra i polloni.<br />
Il brucamento avviene qu<strong>in</strong><strong>di</strong> sempre <strong>in</strong> una stagione <strong>in</strong> cui le piante sono particolarmente<br />
sensibili al danno (Kozlowski et al., 1991). Vi sono <strong>del</strong>le notevoli <strong>di</strong>fferenze nella sensibilità e nella<br />
resilienza al danno tra le specie (Eiberle, 1975, Tsiouvaras, 1988) che può venire comunque<br />
<strong>in</strong>fluenzata dall’età <strong>del</strong>la pianta e dalla ripetitività <strong>del</strong>la brucatura.<br />
In un bosco ceduo, benché economicamente più povero <strong>di</strong> una fustaia, il danno può essere<br />
maggiore proporzionalmente, anche dal punto <strong>di</strong> vista ecologico, perché l'eventuale esaurimento<br />
<strong>del</strong>le ceppaie (osservabile <strong>in</strong> casi non più tanto estremi) non è compensabile con <strong>in</strong>terventi tecnici.<br />
La protezione <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale è praticamente impossibile e la rec<strong>in</strong>zione <strong>del</strong>le tagliate improponibile per<br />
i costi.<br />
La reiterazione <strong>del</strong> danno è l’elemento che presenta più <strong>in</strong>cognite.<br />
Se la pressione degli ungulati si riduce (o cessa) prima che sia stata compromessa la vitalità<br />
<strong>del</strong>le ceppaie, anche i polloni brucati hanno la possibilità <strong>di</strong> riprendere un ritmo <strong>di</strong> accrescimento<br />
elevato e se qualche pollone fosse riuscito ad eludere la brucatura potrebbe ad<strong>di</strong>rittura essere<br />
favorito perché la brucatura avrebbe agito quasi come un <strong>di</strong>radamento.<br />
La maggior parte degli stu<strong>di</strong> f<strong>in</strong> qui condotti ha esam<strong>in</strong>ato la situazione venutasi a creare nei<br />
primi anni dopo il taglio, i più critici (Borghetti e Piussi, 1982; Giovann<strong>in</strong>i, 1991; Ratcliffe, 1992 ;<br />
Kay, 1993; Putman, 1994; Ch<strong>in</strong>es et al., 1997; Amor<strong>in</strong>i et. al., 2005; Cantiani et. al., 2007).<br />
E' importante tuttavia riuscire a capire cosa avviene nel lungo periodo, cosa che non è sempre<br />
facile prevedere per le numerose variabili che possono entrano <strong>in</strong> gioco: variazioni <strong>del</strong>le<br />
popolazioni <strong>di</strong> ungulati, offerta alimentare alternativa, resilienza degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui <strong>del</strong>le specie arboree,<br />
evoluzione dei rapporti sociali tra polloni e tra ceppaie. Verificare se le previsioni dei primi anni<br />
possano essere proiettate alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong> turno potrebbe <strong>di</strong>ventare fondamentale anche nell'ipotesi <strong>di</strong><br />
valutare un eventuale risarcimento ai proprietari dei danni prodotti.<br />
Per dare una risposta a queste domande <strong>in</strong> due aree, <strong>in</strong> un tratto <strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea a<br />
prevalenza <strong>di</strong> leccio , nuovi rilievi stati effettuati nell’<strong>in</strong>verno 2008-09 (età dei polloni <strong>di</strong> 22 anni),<br />
nelle stesse aree <strong>di</strong> saggio permanenti ubicate nel Parco Regionale <strong>del</strong>la Maremma <strong>in</strong> boschi<br />
cedui utilizzati durante l’<strong>in</strong>verno 1986-87 e già oggetto degli stu<strong>di</strong> sugli effetti nei primi anni<br />
(Giovann<strong>in</strong>i, 1991; Giovann<strong>in</strong>i e Motta, 2000) 9 . Grazie alla marcatura permanente, <strong>di</strong> ciascuna<br />
ceppaia si è potuta seguire, qu<strong>in</strong><strong>di</strong> l’<strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> brucatura e l’evoluzione dei polloni f<strong>in</strong> dalla prima<br />
stagione vegetativa.<br />
I primi dati evidenziano risultati abbastanza <strong>in</strong>aspettati, anche se ancora da verificare<br />
completamente. Accanto ad una marcata <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione <strong>del</strong>la presenza <strong>del</strong>le specie più appetite<br />
(orniello <strong>in</strong> particolare) per mortalità <strong>del</strong>le ceppaie e ad una conseguente maggiore affermazione <strong>di</strong><br />
specie poco- o non-appetite, non sembra tuttavia che si possa rilevare una <strong>di</strong>fferenza così marcata<br />
9<br />
Le aree furono <strong>del</strong>imitate prima <strong>del</strong> taglio; una <strong>di</strong> esse fu rec<strong>in</strong>tata (e <strong>in</strong> seguito usata come controllo). Nelle due aree, per ogni<br />
ceppaia furono rilevati i pr<strong>in</strong>cipali parametri dendrometrici, oltre alla specie e alla posizione topografica per consentirne la marcatura e la<br />
successiva <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione e permettere il confronto tra la situazione pre- e post- utilizzazione.<br />
179
180<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i<br />
tra le due aree, o almeno non quella che ci saremmo potuti aspettare dopo i primi 5-6 anni <strong>di</strong> vita<br />
dei polloni, caratterizzati da brucature <strong>in</strong>tense.<br />
Esiste una forte <strong>di</strong>fferenza nel numero <strong>di</strong> polloni presenti , ma sembra che la brucatura abbia<br />
<strong>in</strong>fluito soprattutto sulla sopravvivenza dei polloni dom<strong>in</strong>ati, molto forte nell'area rec<strong>in</strong>tata, scarsa<br />
nell'area aperta.<br />
Si potrebbe qu<strong>in</strong><strong>di</strong> ipotizzare che, da un lato la brucatura abbia agito come un <strong>di</strong>radamento, e<br />
che i polloni sopravvissuti siano riusciti a colmare <strong>in</strong> gran parte il gap dei primi anni grazie alla<br />
m<strong>in</strong>ore concorrenza da parte degli altri polloni <strong>del</strong>la ceppaia; dall'altro la rec<strong>in</strong>zione abbia<br />
consentito anche la sopravvivenza <strong>del</strong>le ceppaie più deboli.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> una teorica utilizzazione forestale 10 , si può ad<strong>di</strong>rittura rilevare come tutta o<br />
quasi la <strong>di</strong>fferenza tra le due aree andrebbe persa negli scarti <strong>di</strong> ramaglia, rappresentati dai polloni<br />
con <strong>di</strong>ametro <strong>in</strong>feriore ai 4-5 cm (Fig.1).<br />
Certamente non è possibile generalizzare questi risultati, vuoi perché non tutte le specie dei<br />
boschi cedui hanno la forte capacità <strong>di</strong> ripresa <strong>del</strong>le specie tipiche <strong>del</strong>la macchia, vuoi perché<br />
sicuramente, nel territorio oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, la pressione degli ungulati si è progressivamente<br />
ridotta nel tempo, f<strong>in</strong>o ad annullarsi quasi completamente, per una probabile serie <strong>di</strong> effetti<br />
concomitanti: l'utilizzazione <strong>di</strong> tratti vic<strong>in</strong>i <strong>di</strong> bosco ceduo negli anni successivi alla ceduazione, che<br />
ha determ<strong>in</strong>ato un aumento quantitativo e qualitativo <strong>del</strong>l'offerta alimentare, la sempre m<strong>in</strong>ore<br />
<strong>di</strong>sponibilità alimentare nel bosco <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> crescita e, non ultimo, le azioni <strong>di</strong> contenimento <strong>del</strong>la<br />
popolazione <strong>di</strong> da<strong>in</strong>i operata dal Parco (circa 2000 capi abbattuti o catturati dal 1990 ad oggi).<br />
Fig. 1. Confronto tra la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>ametrica nell’area <strong>di</strong> controllo e <strong>in</strong> quella ad accesso libero a 22<br />
anni dal taglio.<br />
E' evidente tuttavia che nei casi <strong>in</strong> cui non si abbia un allentamento <strong>del</strong>la pressione degli<br />
ungulati o la brucatura sia talmente <strong>in</strong>tensa da non permettere lo sviluppo <strong>di</strong> nessun getto, si può<br />
determ<strong>in</strong>are la degradazione da stato arboreo ad arbustivo <strong>del</strong>le piante, o la forte mortalità <strong>di</strong><br />
ceppaie, con per<strong>di</strong>ta <strong>del</strong>la produzione legnosa anche per <strong>di</strong>versi turni e la sostituzione <strong>di</strong> specie<br />
pregiate - ed adattate all’ambiente e al tipo <strong>di</strong> governo <strong>del</strong> bosco - con altre meno produttive<br />
(Lebboroni e Ricci, 2008)<br />
Oltre alla brucatura, i polloni subiscono spesso danni da scortecciamenti e sfregamenti.<br />
I primi accadono <strong>in</strong> particolare nel periodo <strong>in</strong>vernale e possono provocare danni notevoli. Si<br />
osservano casi, <strong>in</strong> Appenn<strong>in</strong>o, <strong>di</strong> scortecciamenti alla quasi totalità <strong>di</strong> polloni <strong>di</strong> castagno da parte<br />
<strong>di</strong> cervi. (figura 2)<br />
10 Benché il bosco abbia superato l'età <strong>del</strong> il turno m<strong>in</strong>imo previsto dal regolamento forestale <strong>del</strong>la Toscana, non sono <strong>in</strong> previsione<br />
utilizzazioni forestali. Probabilmente il bosco <strong>in</strong> questione, compreso quello <strong>in</strong>terno al rec<strong>in</strong>to, nonostante la buona fertilità data dalle<br />
con<strong>di</strong>zioni stazionali (compluvio, terreno abbastanza profondo) non avrebbe, ora, una vera appetibilità <strong>di</strong> mercato.
Ungulati e bosco ceduo<br />
Fig. 2.Scortecciature da parte <strong>di</strong> cervi <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> castagno sull’Appenn<strong>in</strong>o pistoiese. Foto<br />
G.Giovann<strong>in</strong>i.<br />
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI<br />
In ambiente accademico si <strong>di</strong>scute spesso sull’uso <strong>del</strong> term<strong>in</strong>e “danno” per descrivere gli effetti<br />
<strong>del</strong>l’impatto degli ungulati sulla vegetazione. Gill (1992) propone una def<strong>in</strong>izione oggettiva: “Il<br />
danno è qualunque ferita agli alberi sotto forma <strong>di</strong> rimozione dei tessuti (foglie, corteccia, fiori,<br />
germogli ecc.)”; secondo Berretti e Motta (2005) un danno può essere considerata qualsiasi<br />
alterazione (procurata) <strong>del</strong> normale stato fisiologico tale da compromettere lo sviluppo e la crescita.<br />
Sono def<strong>in</strong>izioni che lasciano tuttavia aperta la <strong>di</strong>scussione sulla soggettività <strong>del</strong>la concezione<br />
<strong>di</strong> danno, che riflette i <strong>di</strong>versi valori che la Società, per le più <strong>di</strong>verse ragioni (economiche, etiche,<br />
politiche) <strong>in</strong> un determ<strong>in</strong>ato momento storico, sociale ed economico, assegna al bosco, ai suoi<br />
prodotti, alla fauna selvatica.<br />
E’ necessaria una valutazione che tenga conto <strong>di</strong> priorità gestionali (che non sono univoche per<br />
forestali, naturalisti, biologi, etc.), che sono importanti non tanto, o non sempre, per quantificare il<br />
danno, ma <strong>in</strong>nanzitutto per def<strong>in</strong>irne l’esistenza e, <strong>in</strong> caso affermativo, la sostenibilità.<br />
Ci sono accorgimenti che possono limitare l’impatto degli ungulati.<br />
Scartando subito ipotesi <strong>di</strong> fatto impraticabili, come le rec<strong>in</strong>zioni, si potrebbe <strong>in</strong>tervenire sulle<br />
superfici <strong>del</strong>le tagliate. Nel Parco <strong>del</strong>la Maremma è stato osservato che i danni tendono a <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire<br />
con l'aumentare <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong>le utilizzazioni (Fig. 3), sia perché l’offerta alimentare può<br />
essere eccedente la domanda, sia perché <strong>in</strong>fluenza <strong>di</strong>rettamente la proporzione <strong>del</strong>le zone <strong>di</strong><br />
marg<strong>in</strong>e con aree <strong>di</strong> bosco non tagliato, che sono quelle che i cervi<strong>di</strong> pre<strong>di</strong>ligono. Nelle tagliate più<br />
gran<strong>di</strong> anche il livello <strong>di</strong> brucatura nelle zone <strong>di</strong> marg<strong>in</strong>e è m<strong>in</strong>ore rispetto a quanto si osserva nelle<br />
aree più piccole (Giovann<strong>in</strong>i et al., 2003).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista economico si potrebbe pensare che il danno arrecato dalle brucature, anche<br />
nei casi più gravi, sia comunque meno importante <strong>di</strong> quello che si può registrare nelle fustaie: il<br />
prodotto è <strong>di</strong> m<strong>in</strong>ore valore commerciale, non ci sono problemi <strong>di</strong> danno tecnologico, lo stesso<br />
mantenimento <strong>in</strong> futuro <strong>del</strong> governo a ceduo è <strong>in</strong>certo. Già oggi non si utilizza quasi mai il bosco<br />
ceduo alla scadenza <strong>del</strong> turno e, nonostante certe grida <strong>di</strong> allarme per i “<strong>di</strong>sboscamenti selvaggi”<br />
(le normali ceduazioni, spesso percepibili visivamente dal turista me<strong>di</strong>o per un paio <strong>di</strong> anni e non<br />
più!) le utilizzazioni dei cedui sono assai ridotte rispetto a 50-60 anni fa ed è presumibile che,<br />
comunque, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> boschi <strong>di</strong> età superiore al turno sia molto superiore alla domanda.<br />
In particolare nelle zone montane, tuttavia, esiste ancora un legame <strong>di</strong>retto tra abitanti, spesso<br />
piccoli proprietari, e bosco che osservano <strong>di</strong>rettamente l’evoluzione dei danni. Si assiste così ad<br />
una progressiva per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> fiducia nelle istituzioni (a <strong>di</strong>re il vero non solo per questo!), reputate<br />
responsabili <strong>del</strong>la <strong>di</strong>ffusione dei selvatici (i “loro” animali, che possono pascolare liberamente i<br />
nostri boschi mentre noi non possiamo mandare i “nostri”.....) e <strong>in</strong>capaci <strong>di</strong> dare una risposta,<br />
affidata ai cacciatori (sempre con qualche sospetto) oppure ai bracconieri, con più <strong>di</strong> un dubbio se<br />
sia giusto affidarsi a meto<strong>di</strong> illegali per (cercare <strong>di</strong>) risolvere il problema. Ed è significativo che<br />
181
182<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i<br />
queste considerazioni si possano leggere sulla letteratura scientifica (Clauser, 2007; Paci, 2009)<br />
come su piccoli giornali locali (Orlan<strong>di</strong>ni, 2009).<br />
Fig. 2 – % <strong>di</strong> ceppaie con danni da brucatura. Legenda: cl. 0 = Assenza <strong>di</strong> danno, cl. I = 1/3 np < 2/3; cl. III = > 2/3 p.b.<br />
A queste considerazioni si aggiungano i danni alle colture agricole e agli orti familiari (possiamo<br />
considerarli l’equivalente dei cedui nell’economia agricola?) e quelli che vengono chiamati “effetti<br />
collaterali” <strong>in</strong> una pubblicazione locale <strong>del</strong>la Prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Pistoia, ovvero “gli <strong>in</strong>cidenti stradali, la<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le zecche, bestie che muoiono vic<strong>in</strong>o alle sorgenti e nei ruscelli, ciglioni franati dal<br />
cont<strong>in</strong>uo passaggio” (Orlan<strong>di</strong>ni, 2009).<br />
In questa situazione verrebbe da chiedersi se sia lecito cont<strong>in</strong>uare le utilizzazioni forestali,<br />
sapendo che la r<strong>in</strong>novazione è a grave rischio. Non solo pensando ai pr<strong>in</strong>cipi <strong>del</strong>la Selvicoltura, per<br />
cui la perpetuazione <strong>del</strong> bosco è la con<strong>di</strong>cio s<strong>in</strong>e qua non per poter raccogliere il prodotto legnoso,<br />
ma anche alle leggi forestali regionali che stabiliscono norme a garanzia (dal versamento <strong>di</strong><br />
cauzioni all’obbligo <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novazione artificiale) a tutela <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione naturale. Ma cosa<br />
succederebbe dal punto <strong>di</strong> vista sociale, ancor prima che economico, se si arrivasse a questo?<br />
E’ vero che sull’altro piatto <strong>del</strong>la bilancia economica è giusto mettere il valore aggiunto che la<br />
presenza <strong>di</strong> una consistente (e visibile) popolazione <strong>di</strong> ungulati rappresenta per il turismo e per<br />
alcune attività <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>dotto; e che è necessario valutare il problema anche dal punto <strong>di</strong> vista etico.<br />
Sicuramente i cacciatori hanno gli strumenti e le conoscenze per operare nel settore <strong>del</strong> controllo e<br />
<strong>del</strong>la gestione degli ungulati, e nella gran parte dei casi lo fanno <strong>in</strong> maniera responsabile, ma è<br />
anche vero che per loro la caccia rappresenta un’attività lu<strong>di</strong>co-sportiva qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, <strong>di</strong> fatto, una<br />
situazione <strong>di</strong> squilibrio va a loro vantaggio. C’è poi l’aspetto <strong>di</strong> una visione <strong>di</strong>sneyana <strong>di</strong> una parte<br />
<strong>del</strong>l’op<strong>in</strong>ione pubblica (Cut<strong>in</strong>i, 2006), che comunque pesa sulle decisioni politiche.<br />
Questo contributo, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, term<strong>in</strong>a esattamente con la frase con cui è <strong>in</strong>iziato, ovvero che “il<br />
rapporto tra Ungulati e bosco ceduo non è <strong>di</strong> facile soluzione”, con un richiamo alla necessità <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>re cosa succede nel me<strong>di</strong>o e nel lungo periodo e con la necessità <strong>di</strong> affrontare il<br />
problema anche dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la comunicazione e <strong>del</strong>l’educazione ambientale, <strong>in</strong>tesa nel<br />
senso <strong>di</strong> aumentare tra la popolazione le conoscenze e le competenze per poter gestire l’ambiente<br />
<strong>in</strong> modo consapevole e partecipato.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Amor<strong>in</strong>i E, Cut<strong>in</strong>i A, Hajny M, Bartolucci S. 2005 - Danni provocati dalla fauna selvatica a boschi <strong>di</strong><br />
orig<strong>in</strong>e agamica. 5° Congresso Nazionale SISEF - Gru gliasco (TO), 27-29 Sep 2005, Contributo<br />
no. #5.5.17 [onl<strong>in</strong>e] URL: http://www.sisef.it/sisef/ma<strong>in</strong>.php?action=cong&k=5&n=5&id=803<br />
Apollonio M. 2004 - Ungulate <strong>di</strong>stribution, consistency, and management <strong>in</strong> Italy. Workshop:<br />
“Ungulate management <strong>in</strong> Europe”, Erice – Sicily: 12-17 November 2004, <strong>in</strong> Cut<strong>in</strong>i A, 2006.
Ungulati e bosco ceduo<br />
Berretti R, Motta R 2005 - Ungulati selvatici e Foresta. I danni prodotti alla r<strong>in</strong>novazione naturale<br />
<strong>del</strong> Parco. Quaderni <strong>del</strong> Parco 5, Ente Parco Naturale Paneveggio-Pale <strong>di</strong> San Mart<strong>in</strong>o.<br />
Borghetti M., Piussi P. 1982 – I Danni da capriolo nei Boschi <strong>di</strong> Carrega. Natura e Montagna,<br />
XXIX, 1: 53-56.<br />
Cantiani P., Amor<strong>in</strong>i E., Piovosi M. 2007. Effetti <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tensità <strong>del</strong>la matric<strong>in</strong>atura sulla<br />
ricostituzione <strong>del</strong>la copertura e sull’accrescimento dei polloni <strong>in</strong> cedui a prevalenza <strong>di</strong> cerro.<br />
Ann. Ist. Sper. Selv. - Vol. 33, 2002-2004: 9 - 20<br />
Ch<strong>in</strong>es A., Giovann<strong>in</strong>i G., Rossi I. 1997 - Offerta alimentare e <strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> brucatura <strong>in</strong> cedui <strong>di</strong><br />
macchia me<strong>di</strong>terranea <strong>del</strong> Parco Regionale <strong>del</strong>la Maremma. Suppl. Ricerche <strong>di</strong> Biologia <strong>del</strong>la<br />
Selvagg<strong>in</strong>a, XXVII, 443-452.<br />
Clauser F. 2007 – Fauna Foreste Interesse pubblico. L’Italia Forestale e Montana, LXII, 1: 51-57<br />
Cut<strong>in</strong>i A. 2006 - Considerazioni sull’assordante silenzio <strong>del</strong> mondo forestale <strong>in</strong> merito alla<br />
questione dei “Bambi<br />
Eiberle, K. 1975 - Ergebnisse e<strong>in</strong>er Simulation des Wildverbisses durch den Triebschnitt. Schweiz.<br />
Z. Fortswes, 126: 821-839.<br />
Gill R.M.A. 1992 - A Review of Damage by Mammals <strong>in</strong> North Temperate Forests: 1. Deer.<br />
Forestry, 65, 2: 145-169<br />
Giovann<strong>in</strong>i G. 1991 - Effetti <strong>del</strong> pascolo <strong>di</strong> ungulati selvatici sulla r<strong>in</strong>novazione agamica <strong>in</strong> un ceduo<br />
<strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea. Monti e Boschi, XLII, 5, 15-22.<br />
Giovann<strong>in</strong>i G., Ch<strong>in</strong>es A., Gandolfo G. 2003 - Danni da ungulati selvatici <strong>in</strong> boschi cedui: effetti<br />
<strong>del</strong>le modalità <strong>di</strong> utilizzazione forestale. Sherwood, 9, 1: 9-16<br />
Giovann<strong>in</strong>i G., Motta R. 2000 - Stima <strong>del</strong>l’impatto degli ungulati selvatici sulla vegetazione<br />
forestale. <strong>Atti</strong> <strong>del</strong> Convegno “Gestione degli ungulati selvatici: problemi e soluzioni”, Perugia<br />
31.3-1.4.2000<br />
Giovann<strong>in</strong>i G., Perulli D., Piussi P., Salbitano F. 1992 - Ecology of vegetative regeneration after<br />
coppic<strong>in</strong>g <strong>in</strong> macchia stands <strong>in</strong> central Italy. Vegetatio, 99-100, 331-343<br />
Kay S. 1993 - Factors affect<strong>in</strong>g severity of deer brows<strong>in</strong>g damage with<strong>in</strong> coppiced woodlands <strong>in</strong> the<br />
south of England. Biological Conservation, 63: 217-222.<br />
Kle<strong>in</strong> F., Rocquencourt A., Ballon P. 2008 -. Pour un meilleur équilibre sylvo-cynégétique. Des<br />
pratiques favorables aux cervidés. ONFS-CEMAGREF<br />
Lebboroni, L., Ricci, G. 2008 - Primo caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o: i boschi cedui <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o Bolognese. - In<br />
ASTER (Ed.), Indag<strong>in</strong>e sull'impatto ambientale ed economico degli ungulati selvatici<br />
nell'Appenn<strong>in</strong>o Bolognese. Fondazione Itaca, Bologna, 174 pp.<br />
Motta R. 1999 – Wild ungulate brows<strong>in</strong>g, natural regeneration and silviculture <strong>in</strong> the Italian Alps.<br />
Journal of susta<strong>in</strong>able forestry, .8, 2, 35-54.<br />
Oliver C. D., Larson B. C. 1990 - Forest Stand Dynamics. Mc Graw-Hill, N. Y.<br />
Orlan<strong>di</strong>ni A. 2009 - Danni da “ungulati” nelle zone coll<strong>in</strong>ari e montane <strong>del</strong>la prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> Pistoia. Il<br />
metato – Trimestrale degli amici <strong>di</strong> Pupigliana e <strong>del</strong>la Valle <strong>del</strong> Brandeglio. Anno 12, n° 54: 5<br />
Paci M. 2009 - Danni da ungulati selvatici: riflessioni. Sherwood, 155: 20-21.<br />
Putman R. J. 1994- Deer damage <strong>in</strong> coppice woodlands: an analysis of factors affect<strong>in</strong>g the<br />
severity of damage and options for management. Quarterly Journal of Forestry, 88: 45-54.<br />
Ratcliffe P.R. 1992 – The <strong>in</strong>teraction of deer and vegetation <strong>in</strong> coppice woods. In Buckley G.P.<br />
(e<strong>di</strong>tor), Ecology and Management of Coppice Woodlands, Chapman & Hall, London: 233-245.<br />
Reimoser F, Gossow H. 1996 - Impact of ungulates on forest vegetation and its dependence on the<br />
silvicultural system. For. Ecol. and Manag. 88: 107-119.<br />
Rossi I., 1995 - Disponibilita` e uso <strong>del</strong>le risorse da parte <strong>del</strong> da<strong>in</strong>o (Dama dama)nel Parco<br />
Regionale <strong>del</strong>la Maremma. Tesi <strong>di</strong> Laurea. Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bologna, facoltà <strong>di</strong> Sc.<br />
Matematiche, Fisische e Naturali. A.A. 1994-95<br />
Tsiouvaras C. 1988 - Long-Term Effects of Clipp<strong>in</strong>g on Production and Vigor of Kermes oak<br />
(Quercus coccifera). Forest ecology and Management., 24: 159-166.<br />
183
184<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i
Ungulati e bosco ceduo<br />
185
186<br />
Gianluca Giovann<strong>in</strong>i
Ungulati e bosco ceduo<br />
187
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
LA SELVICOLTURA D’ALBERO E LE SPECIE SPORADICHE NEI CEDUI 1<br />
FRANCESCO PELLERI<br />
CRA-SEL, CENTRO DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA, AREZZO<br />
1 Il presente lavoro rappresenta una s<strong>in</strong>tesi <strong>del</strong>le seguenti pubblicazioni:<br />
MORI P., BURESTI LATTES E., BRUSCHINI S., GIULIETTI V., GRIFONI F., PELLERI F., RAVAGNI S., BERTI S., CRIVELLARO A., 2007 - Selvicoltura <strong>del</strong>le specie<br />
spora<strong>di</strong>che <strong>in</strong> Toscana. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA) <strong>del</strong>la Toscana, 352 pp.<br />
GIULIETTI V., PELLERI F., 2009 - Caratterizzazione <strong>di</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro ad elevata prevalenza <strong>di</strong> rosacee arboree. Forest@ 6: 289-298.<br />
PELLERI F., GIULIETTI V., SANSONE D., SAMOLA A., NITTI D., 2010 - La valorizzazione <strong>del</strong>le rosacee arboree nella Comunità Montana Coll<strong>in</strong>e Metallifere<br />
(GR). Sherwood, Foreste e Alberi oggi. 160: 5- 11.
190<br />
INTRODUZIONE<br />
Francesco Pelleri<br />
Con il term<strong>in</strong>e selvicoltura d’albero si <strong>in</strong>tende un approccio selvicolturale orientato a valorizzare<br />
s<strong>in</strong>gole piante che risultano più <strong>in</strong>teressanti sotto l’aspetto economico ed ecologico-ambientale. Questo<br />
approccio selvicolturale si è sviluppato agli <strong>in</strong>izi <strong>del</strong> secolo scorso <strong>in</strong> Danimarca, Francia e Germania e<br />
si è <strong>di</strong>ffuso nel centro Europa, negli ultimi 30-40 anni, per risolvere i problemi prevalentemente <strong>di</strong> natura<br />
economica che stavano con<strong>di</strong>zionando la gestione <strong>del</strong>le foreste. Le motivazioni che hanno sp<strong>in</strong>to i<br />
selvicoltori <strong>del</strong> centro Europa a sperimentare nuove forme <strong>di</strong> gestione dei boschi sono derivate dalle<br />
seguenti osservazioni:<br />
• l’elevato costo <strong>del</strong>la manodopera rendeva sempre più onerose le cure colturali;<br />
• il legname proveniente dai <strong>di</strong>radamenti era <strong>di</strong>fficilmente collocabile sul mercato;<br />
• solo il legname <strong>di</strong> grosse <strong>di</strong>mensioni era <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> spuntare prezzi remunerativi;<br />
le piante caratterizzate da chiome gran<strong>di</strong> e fusti relativamente corti (max 30% <strong>del</strong>l’altezza massima<br />
raggiungibile a maturità) erano <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> produrre, <strong>in</strong> tempi brevi, tronchi <strong>di</strong> grosse <strong>di</strong>mensioni richiesti<br />
dal mercato.<br />
le piante con queste caratteristiche, dette piante obiettivo, potevano coesistere, a f<strong>in</strong>e ciclo<br />
produttivo, <strong>in</strong> un numero limitato (50-100 per ettaro).<br />
Partendo da queste osservazioni si è sviluppata la selvicoltura d’albero, cioè un nuovo approccio<br />
selvicolturale che mira a raggiungere i seguenti risultati:<br />
• far crescere la pianta <strong>in</strong> <strong>di</strong>ametro il più rapidamente possibile;<br />
• ottenere dei fusti <strong>di</strong> grande pregio <strong>in</strong> tempi nettamente <strong>in</strong>feriori a quelli tra<strong>di</strong>zionali;<br />
• ridurre i costi concentrando gli <strong>in</strong>terventi colturali solo su pochi esemplari ad ettaro.<br />
Per ridurre i costi <strong>del</strong>la selvicoltura si evitano gli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> educazione collettiva <strong>del</strong> popolamento,<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzando le operazioni colturali prevalentemente a vantaggio <strong>di</strong> un limitato numero <strong>di</strong> soggetti<br />
dom<strong>in</strong>anti, effettivamente meritevoli e <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> produrre assortimenti pregiati, lasciando agire i fattori<br />
naturali <strong>di</strong> autoregolazione <strong>del</strong> bosco sulla restante parte <strong>del</strong> soprassuolo.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> approccio, brevemente descritto, si è sviluppato <strong>in</strong>izialmente per specie sociali (faggio<br />
e querce) ma ben si presta anche per valorizzare le specie spora<strong>di</strong>che (MORI et al. 2007) che, per<br />
def<strong>in</strong>izione, si ritrovano nei popolamenti forestali come piante s<strong>in</strong>gole o aggregate per piccoli gruppi. Tra<br />
queste rientrano tutte le latifoglie nobili ed altre specie che hanno un elevato potenziale produttivo,<br />
ecologico-ambientale (bio<strong>di</strong>versità, avifauna, ecc.) e paesaggistico. Una gestione orientata a favorire le<br />
specie più adatte all’ambiente e ad aumentare la <strong>di</strong>versità specifica nei soprassuoli, permette <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>crementare la resilienza <strong>del</strong>le foreste, anche <strong>in</strong> vista <strong>del</strong> futuro cambiamento climatico, ed è proprio<br />
per questo motivo che la conservazione e la valorizzazione <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che è da favorire<br />
(SPIECKER 2008, HEMERY et al 2008).<br />
Le specie spora<strong>di</strong>che risultano più frequenti <strong>di</strong> quanto comunemente si pensi; ad esempio<br />
l’Inventario regionale <strong>del</strong>la Toscana stima la consistenza <strong>di</strong> 25 specie spora<strong>di</strong>che (tutelate dal<br />
Regolamento Forestale <strong>del</strong> 2003) <strong>in</strong> circa 90 milioni <strong>di</strong> alberi presenti su una superficie forestale <strong>di</strong><br />
circa 1.086.000 <strong>di</strong> ettari con frequenze notevolmente superiori nei boschi cedui rispetto alle fustaie<br />
(HOFMANN et al. 1998). Per questi motivi si è deciso <strong>di</strong> avviare una sperimentazione volta a valorizzare<br />
le specie spora<strong>di</strong>che nei boschi cedui <strong>del</strong>la Toscana, me<strong>di</strong>ante la selvicoltura d’albero, cercando <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>tegrare questo nuovo approccio con la gestione tra<strong>di</strong>zionale <strong>del</strong> ceduo.<br />
SELVICOLTURA D’ALBERO E FASI EVOLUTIVE DEL BOSCO<br />
In questo approccio selvicolturale vengono def<strong>in</strong>ite le seguenti fasi evolutive <strong>del</strong> bosco (BASTIEN e<br />
WILHELM 2003, Wilhelm 2004):<br />
• Inse<strong>di</strong>amento: fase <strong>di</strong> affermazione <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione <strong>in</strong> cui si eseguono, essenzialmente,<br />
ripuliture localizzate per liberare dalla concorrenza i soggetti <strong>del</strong>le specie <strong>di</strong> pregio. Non si realizzano<br />
<strong>in</strong>terventi su tutto il popolamento ma su superfici <strong>di</strong> 20-30 m 2 <strong>di</strong>stanziate 9-12 metri tra loro.<br />
• Qualificazione: fase <strong>in</strong> cui per autopotatura o potatura artificiale si forma un fusto privo <strong>di</strong> rami<br />
lungo almeno 2,5 m. Si selezionano le piante obiettivo e, se necessario, si realizzano <strong>in</strong>terventi per<br />
ridurre la concorrenza <strong>di</strong> piante dom<strong>in</strong>anti o superdom<strong>in</strong>anti che con<strong>di</strong>zionano le piante selezionate. Gli<br />
alberi obiettivo vengono scelti <strong>in</strong> base al vigore (devono essere piante dom<strong>in</strong>anti vigorose), qualità <strong>del</strong><br />
fusto (il fusto deve essere dritto e senza <strong>di</strong>fetti), sviluppo <strong>del</strong>la chioma (la chioma deve essere ben<br />
sviluppata ed equilibrata), <strong>di</strong>stribuzione nell’appezzamento (le piante devono essere selezionate e<br />
marcate permanentemente, considerando una <strong>di</strong>stanza m<strong>in</strong>ima tra loro sufficientemente ampia da
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
impe<strong>di</strong>re che si <strong>in</strong>staur<strong>in</strong>o fenomeni <strong>di</strong> competizione tra le piante obiettivo a maturità, tenendo conto<br />
<strong>del</strong>le <strong>di</strong>mensione raggiungibili dalla chioma <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> crescita libera). In questa fase si deprime<br />
l’accrescimento dei più imme<strong>di</strong>ati concorrenti <strong>del</strong>le piante obiettivo usando il “cassage 11 ” e la<br />
cerc<strong>in</strong>atura 12 ; queste tecniche hanno il vantaggio <strong>di</strong> ridurre progressivamente la vitalità dei concorrenti<br />
che cont<strong>in</strong>uano, per qualche anno, a mantenere un certo grado <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong> suolo e a ridurre i rischi<br />
dovuti al brusco isolamento dei soggetti selezionati (<strong>in</strong>stabilità ed emissione <strong>di</strong> ricacci sul fusto).<br />
• Dimensionamento: si entra <strong>in</strong> questa fase una volta formato, sulle piante obiettivo, un fusto<br />
privo <strong>di</strong> rami <strong>di</strong> lunghezza sufficiente, pari al 25-30% <strong>del</strong>l’altezza totale <strong>del</strong>la pianta a maturità. Questa<br />
fase è caratterizzata dalla realizzazione dei tagli <strong>in</strong>tercalari. Attorno alle piante obiettivo si eseguono<br />
frequenti <strong>di</strong>radamenti liberi, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> mantenere una chioma ampia ed efficiente, adeguatamente<br />
illum<strong>in</strong>ata, così da favorire l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico <strong>del</strong> fusto. Vengono pertanto elim<strong>in</strong>ati i competitori<br />
e preservato, per quanto possibile, un piano dom<strong>in</strong>ato con funzioni <strong>di</strong> protezione dei fusti <strong>del</strong>le piante<br />
selezionate.<br />
• Maturazione: <strong>in</strong> questa fase si assiste ad una progressiva e graduale riduzione<br />
<strong>del</strong>l’accrescimento <strong>del</strong>le piante obiettivo, le cui chiome non sono più <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> espandersi<br />
orizzontalmente. Da questo momento si <strong>in</strong>izia la graduale utilizzazione <strong>del</strong>le piante obiettivo, a partire<br />
da quelle meno longeve e a ciclo produttivo più breve. Per ciascuna pianta è opportuno aspettare il<br />
momento più idoneo alla sua utilizzazione, così da massimizzare il rapporto benefici/costi, <strong>in</strong>tervenendo<br />
non appena si manifest<strong>in</strong>o i primi segni <strong>di</strong> senescenza.<br />
Come <strong>in</strong>tegrare la selvicoltura d’albero con la gestione tra<strong>di</strong>zionale<br />
Una selvicoltura orientata a valorizzare le specie spora<strong>di</strong>che può essere applicata quando si<br />
riscontrano le seguenti situazioni: presenza <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che, buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fertilità, aree<br />
facilmente accessibili, <strong>di</strong>sponibilità e capacità <strong>del</strong> proprietario ad applicare questa tecnica nei cedui e a<br />
<strong>in</strong>tegrarla con quella tra<strong>di</strong>zionale. Semplificando si possono verificare due situazioni <strong>in</strong> cui è necessario<br />
prevedere un <strong>di</strong>fferente approccio per consentire l’<strong>in</strong>tegrazione <strong>del</strong>la selvicoltura d’albero con quella<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente applicata alla particella.<br />
• Aree con presenza <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che raggruppate <strong>in</strong> una o più zone <strong>di</strong> una particella. In<br />
questo caso, data l’elevata densità <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che e la loro concentrazione <strong>in</strong> porzioni<br />
circoscritte (Fig. 1), tutta la superficie <strong>del</strong>le zone considerate viene gestita con la selvicoltura d’albero,<br />
mentre, nella parte restante, si applica la selvicoltura tra<strong>di</strong>zionale senza grossi problemi <strong>di</strong> <strong>in</strong>tegrazione<br />
<strong>di</strong> un sistema con l’altro.<br />
• Area con specie spora<strong>di</strong>che <strong>di</strong>stribuite irregolarmente su tutta la particella (Fig. 2). In questo<br />
caso l’approccio ad albero e quello tra<strong>di</strong>zionale devono essere applicati su tutta la particella ed è<br />
necessario prevedere un <strong>in</strong>tegrazione dei due meto<strong>di</strong>.<br />
Fig. 1 - Specie spora<strong>di</strong>che localizzate Fig. 2 –Specie spora<strong>di</strong>che <strong>di</strong>ffuse<br />
Attorno alle piante obiettivo <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che è necessario mantenere un manicotto <strong>di</strong> piante<br />
(Fig. 3) ampio almeno quanto le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>la loro chioma a maturità, sul quale agire con l’approccio<br />
11 “Cassage”: stroncatura <strong>del</strong>l’apice <strong>di</strong> polloni che ostacolano lo sviluppo dei soggetti scelti. Quest’operazione, consistente<br />
nella piegatura <strong>del</strong> fusto f<strong>in</strong>o a provocare una parziale rottura <strong>del</strong>le fibre, viene fatta sul fusto e/o sui rami <strong>di</strong> piante che ostacolano<br />
lo sviluppo <strong>del</strong>la cacciata apicale <strong>del</strong>le piante selezionate (WILHELM 2004). Si applica su giovani piante aventi <strong>di</strong>ametri <strong>in</strong>feriori a 5<br />
cm (WILHELM 2009).<br />
12 Cerc<strong>in</strong>atura: tale tecnica si effettua asportando lungo l’<strong>in</strong>tera circonferenza <strong>del</strong> fusto una porzione cont<strong>in</strong>ua <strong>di</strong> corteccia e <strong>di</strong><br />
cambio, per un’altezza sufficiente da impe<strong>di</strong>re la formazione <strong>di</strong> calli cicatriziali che portano alla ricostituzione <strong>di</strong> nuovi tessuti<br />
(ROTH et al. 2007, SCHÜTZ 2006). Questa pratica deprime fortemente l’accrescimento e provoca, dopo qualche anno, la morte<br />
<strong>del</strong>la pianta. Si applica a piante <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>ametriche superiori a 5 cm (WILHELM 2009).<br />
191
192<br />
Francesco Pelleri<br />
<strong>del</strong>la selvicoltura d’albero. Nel resto <strong>del</strong>la particella cont<strong>in</strong>uerà ad essere applicata la selvicoltura<br />
tra<strong>di</strong>zionale. Qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, mentre nel caso precedente si agiva su una certa superficie sulla quale erano<br />
concentrate le piante obiettivo, <strong>in</strong> questo caso i pr<strong>in</strong>cipi <strong>del</strong>la selvicoltura d’albero sono applicati su un<br />
manicotto <strong>di</strong> protezione, circostante ciascuna pianta obiettivo.<br />
Fig. 3 - Esempio <strong>di</strong> manicotto <strong>di</strong> protezione con <strong>di</strong>radamento attorno alle piante obiettivo (Mori et al. 2007)<br />
Per mantenere ritmi <strong>di</strong> crescita sostenuti e chiome sempre efficienti è necessario <strong>in</strong>tervenire con<br />
frequenza attorno alle piante obiettivo, con un tempo <strong>di</strong> ritorno generalmente <strong>in</strong>feriore al turno. La<br />
perio<strong>di</strong>cità <strong>del</strong>le operazioni colturali deve essere tale da consentire alle piante obiettivo <strong>di</strong> reagire al<br />
<strong>di</strong>radamento ed occupare gli spazi messi a loro <strong>di</strong>sposizione f<strong>in</strong>o al successivo <strong>in</strong>tervento, permettendo,<br />
nel contempo, la realizzazione <strong>di</strong> tagli economicamente convenienti. Per tale motivo è necessario<br />
prevedere una pianificazione degli <strong>in</strong>terventi, con la sud<strong>di</strong>visione <strong>del</strong>la particella <strong>in</strong> aree che cadranno al<br />
taglio <strong>in</strong> tempi <strong>di</strong>fferenti. In questo modo si faranno co<strong>in</strong>cidere i <strong>di</strong>radamenti localizzati <strong>in</strong>torno a piante<br />
obiettivo con l’utilizzazione f<strong>in</strong>ale <strong>di</strong> porzioni <strong>del</strong> soprassuolo, così da ottimizzare i lavori e ridurre i costi.<br />
Si riportano due esempi <strong>di</strong> pianificazione degli <strong>in</strong>terventi uno applicato ad una particella caratterizzata<br />
da un <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che <strong>in</strong> aree circoscritte (Fig. 4), l’altro <strong>in</strong> cui le specie spora<strong>di</strong>che<br />
sono sparse irregolarmente su tutta la particella (Fig. 5).<br />
Figura 4 - Esempio <strong>di</strong> pianificazione con piante localizzate e tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 6 anni (Mori et al. 2007)<br />
Fig. 5 - Esempio <strong>di</strong> pianificazione con poche piante sparse e tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 6 anni (Mori et al. 2007)<br />
In entrambi i casi la particella viene sud<strong>di</strong>visa <strong>in</strong> sottoparticelle <strong>di</strong> circa 1/3 <strong>di</strong> superficie. Una volta<br />
raggiunto l’età m<strong>in</strong>ima <strong>di</strong> 18 anni viene utilizzata una sottoparticella e, contemporaneamente, realizzati<br />
su tutta la superficie <strong>in</strong>terventi localizzati attorno alle specie spora<strong>di</strong>che. Gli <strong>in</strong>terventi vengono ripetuti<br />
con un tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 6 anni.
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
ESPERIENZE REALIZZATE IN CEDUI DELLA TOSCANA<br />
Le prime esperienze <strong>di</strong> valorizzazione <strong>del</strong>le rosacee arboree nei cedui <strong>del</strong>la Toscana sono state<br />
condotte nella parte <strong>in</strong>terna <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong>la Comunità Montana <strong>del</strong>le Coll<strong>in</strong>e Metallifere (GR).<br />
Secondo i dati <strong>del</strong>la stazione <strong>di</strong> Gerfalco (732 m s.l.m.) la temperatura me<strong>di</strong>a annua raggiunge 11,7° C<br />
e le precipitazioni annue 1047 mm con un moderato deficit estivo. Come riportato nella “Carta dei suoli<br />
<strong>del</strong>la Toscana” (http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/), le aree <strong>in</strong>teressate dalla sperimentazione<br />
sono caratterizzate prevalentemente da suoli poco profon<strong>di</strong> e soggetti ad erosione idrica, appartenenti<br />
all’unità cartografica “Castiglion <strong>del</strong> bosco” (CBO1, “typic ustorthents loamy-skeletal, mixed, calcareous,<br />
mesic, shallow”) orig<strong>in</strong>atesi su argilloscisti siltosi con calcarei silicei ed arenarie calcaree. I boschi sono<br />
caratterizzati prevalentemente da cedui, per gran parte ancora <strong>in</strong> produzione o avviati all’altofusto, a<br />
prevalenza <strong>di</strong> cerro con presenza <strong>di</strong> spora<strong>di</strong>che rosacee arboree.<br />
La sperimentazione ha <strong>in</strong>teressato sia cedui <strong>in</strong> produzione (ceduo giovane, ceduo a ½ turno e<br />
ceduo <strong>in</strong> utilizzazione) che un ceduo <strong>in</strong>vecchiato (Tab. 1).<br />
Tab. 1 – Pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche <strong>del</strong>le aree sperimentali oggetto <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e: abbreviazioni- Qc, cerro; Oc,<br />
carp<strong>in</strong>o nero; Fo, orniello; Cs, castagno; Sd, sorbo domestico; St, ciavar<strong>del</strong>lo; Pa, ciliegio; SA, selvicoltura d’albero;<br />
TE, testimone; TR, trattato; A, area alta; M, area me<strong>di</strong>a; B, area bassa (Pelleri et al 2010).<br />
Nelle parcelle sono stati realizzati <strong>in</strong>terventi orientati a favorire s<strong>in</strong>gole piante, secondo le tecniche<br />
<strong>del</strong>la selvicoltura d’albero, <strong>di</strong>fferenziandoli a seconda <strong>del</strong>la fase <strong>del</strong> ciclo produttivo <strong>in</strong> cui si trova il<br />
popolamento. Un’ulteriore <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e è stata realizzata a Fontalc<strong>in</strong>aldo per caratterizzare la qualità e gli<br />
accrescimenti <strong>del</strong>le “matric<strong>in</strong>e” <strong>di</strong> sorbo domestico e ciavar<strong>del</strong>lo rilasciate al momento <strong>del</strong> taglio (Giulietti<br />
e Pelleri 2009).<br />
La sperimentazione nei cedui <strong>in</strong> produzione<br />
Fontalc<strong>in</strong>aldo: ceduo giovane (età 7 anni) - Il primo <strong>in</strong>tervento è stato realizzato <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro,<br />
caratterizzato da una densità <strong>di</strong> circa 2790 ceppaie ad ettaro, <strong>di</strong> cui il 68% rappresentato dalle specie<br />
querc<strong>in</strong>e (cerro, roverella e, <strong>in</strong> misura m<strong>in</strong>ore, leccio), il 24% da latifoglie nobili (sorbo domestico,<br />
perastro, ciavar<strong>del</strong>lo e ciliegio) e l’8% da altre specie. Si tratta <strong>di</strong> un popolamento fortemente<br />
matric<strong>in</strong>ato, con 220 matric<strong>in</strong>e ad ettaro costituite <strong>in</strong> maggioranza da cerro, ma con una presenza<br />
rilevante <strong>di</strong> rosacee arboree pari a 77 matric<strong>in</strong>e ad ettaro (PELLERI e FERRETTI 2003, GIULIETTI e PELLERI<br />
2009).<br />
Qui l’obiettivo è quello <strong>di</strong> valutare l’efficienza <strong>di</strong> tecniche, <strong>in</strong> Italia ancora poco conosciute, come il<br />
cassage e la cerc<strong>in</strong>atura e <strong>di</strong> verificare la reazione <strong>di</strong> giovani soggetti <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che a questi<br />
<strong>in</strong>terventi (piante obiettivo). Queste tecniche, nell’ambito <strong>del</strong>la selvicoltura d’albero, vengono<br />
generalmente utilizzate nella fase <strong>di</strong> “qualificazione” dei fusti.<br />
La sperimentazione è stata condotta <strong>in</strong> una area <strong>di</strong> 3 ettari dove sono stati cartografati 142 polloni <strong>di</strong><br />
sorbo domestico, ciavar<strong>del</strong>lo e perastro (generalmente polloni ra<strong>di</strong>cali). La scelta è stata effettuata sulla<br />
base <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>di</strong> vigoria e qualità <strong>del</strong> fusto, cercando <strong>di</strong> lasciare una <strong>di</strong>stanza m<strong>in</strong>ima <strong>di</strong> 4-5<br />
m fra le piante selezionate. Su metà dei soggetti è stato realizzato un <strong>in</strong>tervento sperimentale f<strong>in</strong>alizzato<br />
a ridurre la concorrenza, attraverso l’applicazione <strong>del</strong>le tecniche <strong>del</strong> cassage e <strong>del</strong>la cerc<strong>in</strong>atura, mentre<br />
193
194<br />
Francesco Pelleri<br />
l’altra metà è stata rilasciata come controllo. Al momento <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento (giugno 2006) le piante<br />
selezionate presentavano me<strong>di</strong>amente altezze <strong>di</strong> 3,2 m, <strong>di</strong>ametri <strong>di</strong> 1,8 cm e chiome <strong>di</strong> 86 cm <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ametro con <strong>in</strong>serzione a 1,3 m. Si è deciso <strong>di</strong> operare esclusivamente <strong>in</strong>torno alle piante obiettivo per<br />
un raggio <strong>di</strong> circa 2 m, lasciando <strong>in</strong><strong>di</strong>sturbata la restante parte <strong>del</strong> soprassuolo. Sono stati trattati<br />
me<strong>di</strong>amente 7 polloni per pianta obiettivo, riducendo la concorrenza a vario livello: polloni all’<strong>in</strong>terno<br />
<strong>del</strong>la stessa ceppaia <strong>del</strong>la pianta scelta, polloni dom<strong>in</strong>anti <strong>in</strong> ceppaie limitrofe e matric<strong>in</strong>e (<strong>in</strong>tervento<br />
limitato a pochi casi).<br />
L’analisi degli effetti <strong>del</strong> trattamento sui competitori si è focalizzata su cerro e orniello, specie più<br />
rappresentative per numero e vigoria.Nel complesso l’applicazione <strong>del</strong> cassage risulta più facile<br />
sull’orniello: la maggior elasticità <strong>del</strong> legname consente, <strong>in</strong>fatti, <strong>di</strong> rompere solo parzialmente le fibre<br />
legnose, mantenendo così una parte dei vasi ancora efficienti ed <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> alimentare l’apice <strong>del</strong>la<br />
pianta. Al contrario, la maggiore fragilità <strong>del</strong> legno <strong>di</strong> cerro determ<strong>in</strong>a, spesso, una rottura quasi totale<br />
<strong>del</strong>le fibre legnose, con conseguente precoce morte <strong>del</strong>l’apice e successivo m<strong>in</strong>or controllo <strong>del</strong>la<br />
gemma apicale sullo sviluppo dei rami epicormici sottostanti. A <strong>di</strong>fferenza <strong>del</strong> cassage la cerc<strong>in</strong>atura si<br />
è <strong>di</strong>mostrata valida per entrambe le specie, determ<strong>in</strong>ando una progressiva mortalità <strong>del</strong>l’apice <strong>del</strong>le<br />
piante (Tab. 2).<br />
Tab. 2 – Fontalc<strong>in</strong>aldo: mortalità <strong>del</strong>l’apice dei competitori <strong>in</strong> seguito ai trattamenti (Pelleri et al 2010).<br />
orniello cerro<br />
2007 2008 2009 2007 2008 2009<br />
% % % % % %<br />
CASSAGE 43 63 78 81 82 92<br />
CERCINATURA 21 37 58 51 72 84<br />
In seguito a questi <strong>in</strong>terventi la maggior parte dei polloni trattati ha reagito con l’emissione <strong>di</strong> rami<br />
epicormici al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong>la zona <strong>in</strong> cui è stato realizzato l’<strong>in</strong>tervento. I ricacci sono risultati me<strong>di</strong>amente<br />
vigorosi raggiungendo, dopo 4 anni, uno sviluppo <strong>in</strong> altezza <strong>in</strong>torno a 120 cm per il cassage e 180 cm<br />
per la cerc<strong>in</strong>atura (dati settembre 2009). La tendenza ad emettere rami epicormici vigorosi è <strong>in</strong> parte<br />
imputabile al periodo <strong>in</strong> cui è stato realizzato l’<strong>in</strong>tervento (<strong>in</strong>izio giugno) e alla limitata copertura<br />
esercitata dal soprassuolo a questa età.<br />
Per quanto riguarda la crescita <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong> trattamento, l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e ha evidenziato una maggior<br />
capacità <strong>del</strong> sorbo domestico, rispetto alle altre specie, <strong>di</strong> competere <strong>in</strong> altezza con il cerro. A f<strong>in</strong>e 2009,<br />
nell’area testimone, si sono riscontrati i seguenti valori d’altezza me<strong>di</strong>a: cerro 5,6 m (me<strong>di</strong>a dei tre più<br />
<strong>di</strong>retti competitori), sorbo domestico <strong>di</strong> 4,9 m, ciavar<strong>del</strong>lo 3,9 m, pero 4,1 m. Al contrario sono rilevanti le<br />
<strong>di</strong>fferenze <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, considerato che il cerro presenta <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 4,5 cm, rispetto a<br />
valori <strong>in</strong>feriori a 3 centimetri <strong>del</strong>le specie <strong>di</strong> pregio.<br />
Nell’area trattata si osservano modeste risposte <strong>in</strong>crementali rispetto al testimone (Tab. 3): solo i due<br />
sorbi reagiscono all’<strong>in</strong>tervento con un maggior sviluppo <strong>del</strong>la chioma e, negli ultimi due anni, con un<br />
lieve aumento <strong>del</strong>l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico.<br />
In considerazione <strong>del</strong>la modesta <strong>in</strong>tensità degli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> cerc<strong>in</strong>atura e cassage e <strong>del</strong> rapido<br />
sviluppo dei ricacci <strong>del</strong>le piante competitrici trattate, sarà necessario ripetere, al più presto, un secondo<br />
<strong>in</strong>tervento con un aumento notevole dei costi.<br />
Tab. 3 – Fontalc<strong>in</strong>aldo: valori me<strong>di</strong> dei pr<strong>in</strong>cipali parametri dendrometrici (<strong>di</strong>ametro D, altezza H e <strong>di</strong>ametro<br />
chioma Dch) <strong>del</strong>le piante scelte prima <strong>del</strong> trattamento (2005) e relativi <strong>in</strong>crementi (Icr) dopo 4 anni (2009) (Pelleri et<br />
al 2010).<br />
specie D<br />
200<br />
5<br />
IcrD<br />
05-<br />
09<br />
H<br />
2005<br />
TRATTATE TESTIMONE<br />
IcrH<br />
05-09<br />
D Ch.<br />
2005<br />
IcrDCh.<br />
05-09<br />
D<br />
200<br />
5<br />
IcrD<br />
05-09<br />
H<br />
200<br />
5<br />
IcrH<br />
05-09<br />
DCh<br />
2005<br />
cm cm m m m m cm cm m m m m<br />
pero 1,8 1,0 3,1 0,9 1,0 0,3 1,7 0,9 3,0 1,1 1,0 0,0<br />
sorbo dom. 2,0 1,1 3,6 1,4 0,8 0,5 2,0 0,9 3,5 1,4 0,8 0,1<br />
ciavar<strong>del</strong>lo 1,5 1,1 2,7 1,1 0,8 0,6 1,5 0,8 2,7 1,2 0,8 0,2<br />
IcrDCh<br />
05-09
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
Mocai: ceduo a ½ turno (età 15 anni) - In considerazione <strong>del</strong>le problematiche emerse nel<br />
popolamento <strong>di</strong> Fontalc<strong>in</strong>aldo, si è ritenuto utile impostare un protocollo sperimentale sull’applicazione<br />
<strong>del</strong>la cerc<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> un ceduo all’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong>la fase <strong>di</strong> “<strong>di</strong>mensionamento” (fase <strong>in</strong> cui si è già formato un<br />
tronco netto da rami sufficientemente lungo e si deve <strong>in</strong>tervenire favorendo l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico<br />
<strong>del</strong> fusto). L’obiettivo è stato quello <strong>di</strong> applicare la tecnica <strong>del</strong>la cerc<strong>in</strong>atura <strong>in</strong> un soprassuolo <strong>di</strong> età più<br />
avanzata e realizzare un <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> maggiore <strong>in</strong>tensità.<br />
Il popolamento scelto è un ceduo <strong>di</strong> cerro, caratterizzato da una densità <strong>di</strong> circa 2419 ceppaie ad<br />
ettaro, <strong>di</strong> cui l’89% rappresentato dalle specie querc<strong>in</strong>e (cerro e leccio), il 4% da latifoglie nobili<br />
(prevalentemente sorbo domestico) e il 7% da altre specie. Al momento <strong>del</strong> taglio erano state rilasciate<br />
me<strong>di</strong>amente 123 matric<strong>in</strong>e ad ettaro, costituite <strong>in</strong> maggioranza da cerro, con presenza anche <strong>di</strong> rosacee<br />
arboree (16 matric<strong>in</strong>e ad ettaro).<br />
La sperimentazione è stata condotta <strong>in</strong> un’area <strong>di</strong> circa 2 ettari dove sono state cartografate 56<br />
piante <strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che, pr<strong>in</strong>cipalmente sorbo domestico. All’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong> luglio 2009 è stato realizzato<br />
un <strong>in</strong>tervento per favorire lo sviluppo dei soggetti più promettenti (17 su due ettari). Le caratteristiche<br />
<strong>del</strong>le piante obiettivo e <strong>di</strong> quelle lasciate come controllo sono riportate <strong>in</strong> tabella 4.<br />
Tab. 4 – Mocai: valori me<strong>di</strong> <strong>del</strong>le pr<strong>in</strong>cipali caratteristiche dendrometriche <strong>del</strong>le piante spora<strong>di</strong>che selezionate<br />
(Pelleri et al 2010).<br />
TRATTATE TESTIMONE<br />
Polloni Matric<strong>in</strong>e Totale Polloni Matric<strong>in</strong>e Totale<br />
N oss. n 10 7 17 22 12 34<br />
D1,30 cm 4,8 10,7 7,3 5,1 12,1 7,5<br />
H m 6,8 8,6 7,5 6,6 7,9 7,1<br />
H<strong>in</strong>s m 3,5 3,6 3,5 3,1 3,2 3,2<br />
D chioma m 2,1 3,4 2,6 2,0 3,8 2,6<br />
Al momento <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tervento le piante scelte presentavano fusti privi <strong>di</strong> no<strong>di</strong> sufficientemente lunghi e<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>screta qualità con 72 % <strong>di</strong> questi appartenenti alla categoria B e il 28 % alla categoria C: tale<br />
valutazione è stata effettuata seguendo le categorie <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong> fusto <strong>in</strong><strong>di</strong>cate per le piantagioni <strong>di</strong><br />
arboricoltura da legno (NOSENZO et al. 2008). Sono stati cerc<strong>in</strong>ati i polloni concorrenti <strong>del</strong>le piante<br />
obiettivo <strong>in</strong> modo da favorire l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico e lo sviluppo <strong>del</strong>le chiome <strong>di</strong> quest’ultime,<br />
liberandole per circa 2 m oltre la proiezione <strong>del</strong>la chioma. L’<strong>in</strong>tervento ha <strong>in</strong>teressato me<strong>di</strong>amente 11<br />
polloni per pianta obiettivo (<strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 6,7 cm) posizionati a <strong>di</strong>stanze non superiori a 4,5 m dal<br />
piede <strong>di</strong> questa. Con un <strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> tale <strong>in</strong>tensità le piante obiettivo dovrebbero avere spazio<br />
sufficiente per crescere libere dalla concorrenza f<strong>in</strong>o al momento <strong>del</strong> taglio <strong>del</strong> ceduo. A f<strong>in</strong>e stagione<br />
vegetativa (2009) si è riscontrata un modesta mortalità <strong>del</strong>l’apice dei polloni trattati (10%), una limitata<br />
formazione <strong>di</strong> cordoni cicatriziali (3%) e una modesta emissione <strong>di</strong> ricacci (4%) che evidenzia, per il<br />
momento, una maggiore efficacia <strong>del</strong> trattamento realizzato <strong>in</strong> estate <strong>in</strong> soprassuoli più evoluti.<br />
Travale: ceduo <strong>in</strong> utilizzazione (età 37 anni) - Negli ultimi decenni <strong>in</strong> Toscana si è verificata la<br />
tendenza a rilasciare una matric<strong>in</strong>atura eccessiva (PIUSSI 2007); <strong>in</strong>oltre, recentemente, <strong>in</strong> conseguenza<br />
<strong>del</strong>l’entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>l’articolo 12 <strong>del</strong> Regolamento Forestale Regionale (REGIONE TOSCANA 2003), è<br />
consuetu<strong>di</strong>ne preservare dal taglio la maggior parte <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che senza conteggiarle come<br />
matric<strong>in</strong>e. Si orig<strong>in</strong>ano così, spesso, cedui troppo densamente matric<strong>in</strong>ati con rilascio talvolta <strong>di</strong> soggetti<br />
<strong>di</strong> specie spora<strong>di</strong>che senza avvenire. In conseguenza <strong>di</strong> ciò abbiamo ritenuto importante avviare una<br />
sperimentazione anche <strong>in</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro fortemente matric<strong>in</strong>ato (300-400 piante ad ettaro) <strong>in</strong> corso<br />
<strong>di</strong> utilizzazione. L’obiettivo <strong>del</strong>la ricerca è stato quello <strong>di</strong> migliorare la produzione <strong>di</strong> legna da ardere<br />
ottenibile <strong>in</strong> futuro dal popolamento, la cui produttività è stata fortemente con<strong>di</strong>zionata dal trattamento<br />
pregresso, e <strong>di</strong> dare <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni sui criteri <strong>di</strong> scelta <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e valorizzando <strong>in</strong> particolare la<br />
produzione <strong>di</strong> legname <strong>di</strong> pregio. Si è cercato <strong>di</strong> raggiungere tale obiettivo attraverso le seguenti azioni:<br />
• utilizzazione <strong>di</strong> gran parte <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> cerro;<br />
• riduzione <strong>del</strong>l’<strong>in</strong>tensità degli <strong>in</strong>terventi e <strong>del</strong>la copertura complessiva <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e;<br />
• selezione prevalente <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> un turno e/o <strong>di</strong> allievi scegliendo preferibilmente<br />
matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong>verse dal cerro <strong>in</strong> particolare latifoglie nobili.<br />
Nell’<strong>in</strong>verno 2008-2009 sono state realizzate tre aree sperimentali (Tab. 1) corrispondenti a <strong>di</strong>fferenti<br />
<strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura (60, 90 e 130 matric<strong>in</strong>e ad ettaro) ispirandosi ad esperienze realizzate <strong>in</strong><br />
Austria su cedui composti, dove le matric<strong>in</strong>e sono dest<strong>in</strong>ate prevalentemente alla produzione <strong>di</strong><br />
195
196<br />
Francesco Pelleri<br />
legname <strong>di</strong> pregio (GIULIETTI, 2008). Nelle tre aree, <strong>in</strong> relazione alle caratteristiche compositive e<br />
strutturali <strong>del</strong> popolamento è stata rilasciata una matric<strong>in</strong>atura la cui composizione e densità sono<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>cate <strong>in</strong> tabella 5.<br />
Tab. 5 - Travale: Composizione e densità <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e (Pelleri et al 2010).<br />
Alta Me<strong>di</strong>a Bassa<br />
Densità densità densità<br />
n ha -1 n ha -1 n ha -1<br />
aceri 14 8 6<br />
frass<strong>in</strong>o 14 18 4<br />
carp<strong>in</strong>o 10 8 -<br />
querce 71 37 17<br />
sorbi 29 22 37<br />
N totale 138 93 64<br />
copertura 22% 7,3% 5,9%<br />
Nella scelta <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e sono state generalmente selezionate piante s<strong>in</strong>gole; tuttavia per dare più<br />
stabilità ai soggetti <strong>di</strong> pregio meno sviluppati e filati (generalmente allievi) si è rilasciata tutta la ceppaia<br />
o una coppia <strong>di</strong> polloni dom<strong>in</strong>anti. Nei prossimi anni verrà monitorato lo sviluppo <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, <strong>in</strong><br />
particolare <strong>di</strong> quelle a legname pregiato, e il ricaccio <strong>del</strong> ceduo sotto le <strong>di</strong>verse <strong>in</strong>tensità <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura.<br />
Caratterizzazione <strong>del</strong>le “matric<strong>in</strong>e” <strong>di</strong> Rosacee arboree<br />
Nel popolamento <strong>di</strong> Fontalc<strong>in</strong>aldo, precedentemente descritto è stata condotta un’ <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e volta a<br />
valutare le caratteristiche <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> Rosacee arboree e la loro risposta al taglio (GIULIETTI,<br />
PELLERI 2009). Nel 2002 e nel 2006 sono stati effettuati rilievi su <strong>di</strong>ametro, altezza, caratteristiche <strong>del</strong>la<br />
chioma, qualità <strong>del</strong> fusto con presenza <strong>di</strong> danni e <strong>di</strong> rami epicormici. Le osservazioni sono state<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>rizzate sul sorbo domestico e sul ciavar<strong>del</strong>lo per le migliori potenzialità e caratteristiche fenotipiche<br />
mostrate da queste specie rispetto al perastro e al melo selvatico. E’ stata <strong>in</strong>oltre condotta un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />
per valutare l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e prelevando carote da un totale <strong>di</strong> 30 piante,<br />
equamente <strong>di</strong>stribuite tra le tre specie (sorbo domestico, ciavar<strong>del</strong>lo e cerro).<br />
Qualità <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e - Il rilievo sulla qualità <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e ha evidenziato come, con il secondo<br />
<strong>in</strong>ventario, si siano riscontrati una riduzione <strong>del</strong> numero e un peggioramento qualitativo dei rilasci <strong>di</strong><br />
sorbo. Quest’ultimo aspetto è il risultato <strong>di</strong> una selezione poco accurata <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e, che sono state<br />
scelte <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalle loro caratteristiche qualitative, rilasciandole talvolta anche sotto la<br />
copertura <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> cerro. Il peggioramento qualitativo <strong>del</strong>la chioma, riscontrato nel 2006, va messo <strong>in</strong><br />
relazione anche con la presenza <strong>di</strong> un annata particolarmente siccitosa come il 2003, che potrebbe aver<br />
accentuato i <strong>di</strong>sseccamenti dei rami. In ogni caso le piante più gran<strong>di</strong> ed equilibrate hanno reagito<br />
meglio al brusco isolamento <strong>del</strong>la chioma, perché avevano già usufruito <strong>del</strong>l’apertura creatasi dopo il<br />
precedente taglio <strong>del</strong> ceduo mentre, quelle più piccole, hanno risentito maggiormente <strong>del</strong>le forti<br />
variazioni ambientali provocate dall’utilizzazione <strong>del</strong> soprassuolo.<br />
I sorbi sono specie che rispondono con una scarsa emissione <strong>di</strong> rami epicormici alla repent<strong>in</strong>a<br />
esposizione alla luce (DRAPIER 1993, LARRIEU e GONIN 2009). Dalle osservazioni sull’emissione <strong>di</strong> ricacci<br />
sul fusto risulta che i soggetti con chioma meno sviluppata hanno una più spiccata tendenza ad<br />
emettere rami epicormici, mentre <strong>in</strong> soggetti più sviluppati con chiome profonde e ampie si riscontrano<br />
una modesta emissione <strong>di</strong> ricacci (Tab. 8).<br />
Tab. 8 - Presenza <strong>di</strong> associazione tra profon<strong>di</strong>tà chioma e sviluppo rami epicormici<br />
(0 assenti;1:ridotto; 2: me<strong>di</strong>o; 3: elevato sviluppo) χ2= 22,85 p
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
Questa reazione all’imme<strong>di</strong>ata esposizione alla luce, non deve essere considerata sempre un effetto<br />
negativo ma può essere sfruttata per riequilibrare la chioma <strong>di</strong> soggetti troppo filati.<br />
Accrescimento <strong>di</strong>ametrico <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e - L’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e <strong>in</strong>crementale avviata <strong>in</strong> questo popolamento<br />
ha consentito una prima valutazione e un confronto, limitatamente al popolamento <strong>in</strong>dagato,<br />
<strong>del</strong>l’accrescimento <strong>di</strong>ametrico dei due sorbi <strong>in</strong> relazione al cerro. Tale <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e mostra come gli<br />
<strong>in</strong>crementi <strong>di</strong> area basimetrica (ICG) <strong>del</strong>le tre specie analizzate (Fig. 6) siano <strong>in</strong><strong>di</strong>cativi <strong>di</strong> una stazione<br />
non particolarmente favorevole allo sviluppo <strong>del</strong> cerro, che presenta <strong>in</strong>crementi simili a quelli <strong>del</strong><br />
ciavar<strong>del</strong>lo. In figura 4 sono stati riportati gli <strong>in</strong>crementi <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> due turni <strong>del</strong>le tre specie<br />
analizzate, mostrando così il <strong>di</strong>verso andamento <strong>del</strong> sorbo domestico. Quest’ultimo rimane al <strong>di</strong> sotto<br />
dei valori <strong>del</strong> cerro f<strong>in</strong>o al taglio <strong>del</strong> ceduo nel 1999, anno <strong>in</strong> cui è stato utilizzato il ceduo. In seguito al<br />
taglio si nota una forte reazione dei due sorbi all’<strong>in</strong>tervento che passano da valori <strong>di</strong> circa 5 mm 2 a 12 -<br />
15 mm 2 <strong>in</strong> area basimetrica.<br />
ICG (mm 2 )<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1952<br />
1955<br />
1958<br />
1961<br />
1964<br />
1967<br />
1970<br />
1973<br />
1976<br />
1979<br />
1982<br />
1985<br />
1988<br />
SD_2t ST_2t Qc_2t<br />
Fig. 6 – Incremento corrente <strong>di</strong> area basimetrica <strong>di</strong>: cerro (blu), ciavar<strong>del</strong>lo (arancione) e sorbo domestico<br />
(verde) (Giulietti e Pelleri 2009).<br />
In figura 7 si riportano i valori <strong>di</strong> <strong>in</strong>cremento corrente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro (ICD) riguardanti esclusivamente le<br />
migliori matric<strong>in</strong>e, dei due sorbi, 3 per ciascuna specie, quelle cioè che presentano una qualità <strong>del</strong>la<br />
chioma e <strong>del</strong> fusto me<strong>di</strong>a e buona. Il sorbo domestico si mantiene <strong>in</strong>torno a valori <strong>di</strong> 2-4 mm, con picchi<br />
f<strong>in</strong>o a 8 mm <strong>in</strong> seguito all’ultimo <strong>in</strong>tervento; l’andamento <strong>del</strong> ciavar<strong>del</strong>lo sembra meno regolare con<br />
<strong>in</strong>crementi <strong>di</strong> 3-5 mm nei primi 30 anni e successivamente con valori prossimi a quelli <strong>del</strong>l’altro sorbo e<br />
massimi <strong>di</strong> 7 mm dopo il 1999. Nonostante le <strong>di</strong>fficili con<strong>di</strong>zioni stazionali e la forte competizione<br />
esercitata dal ceduo <strong>di</strong> cerro, è comunque <strong>in</strong>teressante notare che, per le due specie considerate, i<br />
valori <strong>in</strong>crementali riscontrati non si <strong>di</strong>scostano molto da quelli <strong>in</strong><strong>di</strong>cati <strong>in</strong> letteratura, cioè <strong>in</strong>torno ai 5-7<br />
mm all’anno (WILHELM 2009).<br />
1991<br />
1994<br />
1997<br />
2000<br />
2003<br />
197
198<br />
ICD (mm)<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1957<br />
1960<br />
1963<br />
1966<br />
1969<br />
1972<br />
1975<br />
Francesco Pelleri<br />
1978<br />
1981<br />
1984<br />
me<strong>di</strong>aSD me<strong>di</strong>aST<br />
Fig. 7 - Incremento corrente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro <strong>del</strong>le migliori matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> ciavar<strong>del</strong>lo (arancione) e sorbo domestico<br />
(verde) (Giulietti e Pelleri 2009).<br />
La sperimentazione nei cedui <strong>in</strong>vecchiati<br />
Troscione: ceduo <strong>in</strong>vecchiato <strong>di</strong> latifoglie da avviare all’altofusto (età 42 anni) - L’<strong>in</strong>tervento è stato<br />
realizzato <strong>in</strong> una stazione <strong>di</strong> buona fertilità. Il soprassuolo, a prevalenza <strong>di</strong> cerro, è caratterizzato dalla<br />
presenza <strong>di</strong> soggetti <strong>di</strong> ciavar<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> notevoli <strong>di</strong>mensioni e <strong>di</strong> bella forma. Considerate le <strong>in</strong>teressanti<br />
caratteristiche <strong>del</strong>le parcella, sono state realizzate due aree sperimentali (testimone e <strong>di</strong>radata). La<br />
composizione specifica è molto ricca; il cerro è accompagnato dal castagno nell’area <strong>di</strong>radata e dal<br />
carp<strong>in</strong>o nero nel testimone. Inoltre, <strong>in</strong> entrambe le aree, sono presenti ciavar<strong>del</strong>lo, acero campestre e<br />
roverella. Nella parcella trattata sono stati scelti i 24 migliori soggetti (76 ad ettaro) selezionati <strong>in</strong><br />
funzione <strong>di</strong> vigoria, forma e qualità <strong>del</strong> legname. Con gli stessi criteri, nel testimone, sono stati<br />
selezionati 17 soggetti (81 ad ettaro). Sono state scelte prevalentemente cerro, ciavar<strong>del</strong>lo e castagno.<br />
E’ stato eseguito un <strong>di</strong>radamento libero che ha riguardato pr<strong>in</strong>cipalmente i soggetti <strong>di</strong>rettamente<br />
concorrenti <strong>del</strong>le piante obiettivo, mettendo <strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> piena illum<strong>in</strong>azione anche il ciavar<strong>del</strong>lo,<br />
spesso relegato nel piano codom<strong>in</strong>ante. Con il <strong>di</strong>radamento si è prelevato il 26% <strong>del</strong>l’area basimetrica<br />
(32% <strong>in</strong> numero) <strong>in</strong>tervenendo pr<strong>in</strong>cipalmente nel piano dom<strong>in</strong>ante. Il piano dom<strong>in</strong>ato è stato<br />
limitatamente <strong>in</strong>teressato dal taglio, essenzialmente per agevolare l’esbosco <strong>del</strong> legname.<br />
Successivamente, sui migliori soggetti <strong>di</strong> specie pregiate, è stata eseguita una leggera spalcatura <strong>del</strong><br />
fusto.<br />
Tab. 6 – Troscione: Valori me<strong>di</strong> dei pr<strong>in</strong>cipali parametri <strong>del</strong>le piante obbiettivo (Pelleri et al. 2010).<br />
specie<br />
N°<br />
osservaz.<br />
D1,30<br />
(cm)<br />
H<br />
(m)<br />
1987<br />
1990<br />
1993<br />
H<strong>in</strong>s<br />
(m)<br />
1996<br />
1999<br />
2002<br />
D chioma<br />
(m)<br />
castagno 4 28,8 22,2 11,7 5,8<br />
cerro 14 27,2 23,3 11,7 5,2<br />
ciavar<strong>del</strong>lo 16 16,9 13,7 4,2 5,2<br />
In questa stazione le piante scelte <strong>di</strong> ciavar<strong>del</strong>lo risultano particolarmente <strong>in</strong>teressanti per la qualità<br />
dei tronchi (54% <strong>di</strong> B e 46% <strong>di</strong> C) e la notevole <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong>le chiome che si sono sviluppate sotto<br />
copertura, cosa riscontrata anche <strong>in</strong> analoghe situazioni (DAMIANI 2010). Questa caratteristica può<br />
essere evidenziata dal confronto dei pr<strong>in</strong>cipali parametri (<strong>di</strong>ametro, altezza e <strong>di</strong>ametro chioma) <strong>del</strong>le<br />
piante obiettivo (Tab. 6); il ciavar<strong>del</strong>lo, <strong>in</strong>fatti, pur presentando <strong>di</strong>mensioni <strong>in</strong> <strong>di</strong>ametro e altezza<br />
notevolmente <strong>in</strong>feriori a cerro e castagno presenta <strong>in</strong>vece <strong>di</strong>ametri <strong>del</strong>la chioma simili.<br />
E’ presto per fare una valutazione sull’effetto <strong>in</strong>crementale <strong>del</strong> <strong>di</strong>radamento sulle piante scelte anche<br />
se il ciavar<strong>del</strong>lo, nei primi due anni, sembra reagire più prontamente rispetto al cerro (Tab. 7).<br />
2005
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
Tab. 7 - Troscione: <strong>in</strong>crementi <strong>di</strong>ametrici <strong>del</strong>le piante scelte (Pelleri et al. 2010).<br />
specie<br />
N°<br />
osservaz.<br />
castagno 4<br />
cerro 5<br />
ciavar<strong>del</strong>lo 12<br />
CONCLUSIONI<br />
DIRADATO TESTIMONE<br />
IcD 2008<br />
(cm)<br />
0,27<br />
0,18<br />
0,43<br />
IcD 2009<br />
(cm)<br />
0,83<br />
0,62<br />
0,65<br />
N°<br />
osservaz.<br />
0<br />
9<br />
IcD 2008<br />
(cm)<br />
-<br />
0,13<br />
IcD 2009<br />
(cm)<br />
Le esperienze condotte nei cedui <strong>in</strong> produzione <strong>del</strong>le Coll<strong>in</strong>e Metallifere sembrano per il momento<br />
evidenziare la possibilità <strong>di</strong> valorizzare, tramite le tecniche <strong>del</strong>la selvicoltura d’albero, le <strong>in</strong>teressanti<br />
potenzialità <strong>del</strong>le rosacee arboree, <strong>in</strong> particolare nelle stazioni <strong>di</strong> buona fertilità. Il momento più<br />
favorevole per <strong>in</strong>tervenire sembra essere l’<strong>in</strong>izio <strong>del</strong>la fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionamento, con <strong>di</strong>radamenti <strong>di</strong> forte<br />
<strong>in</strong>tensità, mentre troppo frequenti risulterebbero gli <strong>in</strong>terventi partendo da cedui <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> qualificazione.<br />
Nelle stazioni con un forte carico <strong>di</strong> ungulati sarà consigliabile l’uso <strong>del</strong>la cerc<strong>in</strong>atura rispetto al taglio<br />
<strong>del</strong>le piante competitrici con rilascio <strong>del</strong> materiale sul letto <strong>di</strong> caduta. L’<strong>in</strong>tensità <strong>del</strong> taglio dovrà essere<br />
forte, <strong>in</strong> modo da creare uno spazio sufficiente per ottenere, con uno o al massimo due <strong>in</strong>terventi, al<br />
momento <strong>del</strong>l’utilizzazione, matric<strong>in</strong>e a legname <strong>di</strong> pregio stabili, con fusti privi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti e chiome ben<br />
equilibrate.<br />
Nei cedui <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> utilizzazione è necessario cont<strong>in</strong>uare ed approfon<strong>di</strong>re la sperimentazione<br />
confrontando <strong>di</strong>verse densità e tipo <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>atura (piante s<strong>in</strong>gole, matric<strong>in</strong>atura a gruppi, rilascio <strong>di</strong><br />
ceppaie <strong>in</strong>tere ”voliere” o gruppi <strong>di</strong> polloni dom<strong>in</strong>anti). L’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e sulla caratterizzazione <strong>del</strong>le matric<strong>in</strong>e<br />
ha evidenziato la necessità <strong>di</strong> mantenere un manicotto a protezione dei giovani soggetti rilasciati al<br />
momento <strong>del</strong> taglio, mentre è possibile il rilascio <strong>di</strong> matric<strong>in</strong>e <strong>di</strong> più turni senza <strong>in</strong>correre <strong>in</strong> un loro<br />
peggioramento qualitativo. In ogni caso anche per quest’ultime una gestione progressiva <strong>del</strong>la luce,<br />
attraverso il rilascio <strong>di</strong> un manicotto <strong>di</strong> protezione, porta ad <strong>in</strong>dubbi vantaggi, riducendo il rischio <strong>di</strong> forti<br />
variazioni <strong>in</strong>crementali <strong>in</strong> seguito alle utilizzazioni f<strong>in</strong>ali <strong>del</strong> ceduo e <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> rami epicormici.<br />
Nei cedui avviati all’altofusto l’applicazione <strong>di</strong> una selvicoltura <strong>di</strong> popolamento, caratterizzata da<br />
<strong>di</strong>radamenti dal basso, ha portato ad una progressiva riduzione <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che <strong>in</strong> particolare <strong>di</strong><br />
quelle più eliofile: <strong>in</strong> mancanza <strong>di</strong> una selvicoltura specifica le con<strong>di</strong>zioni vegetative e lo sviluppo <strong>di</strong><br />
queste specie tendono progressivamente a peggiorare. Altre specie, <strong>in</strong>vece, come il ciavar<strong>del</strong>lo, meglio<br />
si adattano a vivere sotto la copertura <strong>di</strong> grosse piante <strong>di</strong> cerro e castagno e risultando reattive anche a<br />
<strong>di</strong>radamenti tar<strong>di</strong>vi (NICOLESCU et al 2009, RASMUSSEN 2007). Ulteriori approfon<strong>di</strong>menti sono<br />
sicuramente necessari per mettere a punto le tecniche selvicolturali più idonee e per quantificare i costi<br />
degli <strong>in</strong>terventi.<br />
È bene sottol<strong>in</strong>eare che, per valorizzare le specie spora<strong>di</strong>che, sarà necessario acquisire maggiori<br />
<strong>in</strong>formazioni <strong>di</strong> dettaglio sulla loro <strong>di</strong>stribuzione, da <strong>in</strong>serire nei futuri piani <strong>di</strong> gestione. Inoltre sarà<br />
importante pensare ad azioni <strong>di</strong> sensibilizzazione e <strong>di</strong> formazione <strong>del</strong> personale tecnico e operaio<br />
co<strong>in</strong>volto nelle utilizzazioni forestali (imprese forestali e personale <strong>in</strong> amm<strong>in</strong>istrazione <strong>di</strong>retta). Notevoli<br />
sforzi dovranno essere <strong>in</strong>oltre rivolti per sviluppare un mercato locale, che consenta una valorizzazione<br />
artigianale <strong>del</strong> legname <strong>di</strong> queste specie, attualmente assente.<br />
Le esperienze condotte nelle Coll<strong>in</strong>e Metallifere rappresentano un primo esempio <strong>di</strong> applicazione<br />
<strong>del</strong>le tecniche <strong>di</strong> selvicoltura d’albero nei cedui e richiedono una verifica <strong>in</strong> altre realtà territoriali. La<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> questo nuovo approccio selvicolturale si scontra, però, con una certa arretratezza <strong>del</strong>la<br />
normativa vigente, che non prevede questo tipo <strong>di</strong> approccio; tuttavia alcune Regioni, come la Toscana,<br />
si stanno muovendo rendendo f<strong>in</strong>anziabili questi <strong>in</strong>terventi con il Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale, mentre si<br />
auspica un loro futuro <strong>in</strong>serimento nel Regolamento Forestale Regionale.<br />
4<br />
0,30<br />
-<br />
0,54<br />
0,48<br />
199
200<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Francesco Pelleri<br />
BASTIEN Y, WILHELM G.J., 2003 - Selvicoltura d’albero: un approccio per la produzione <strong>di</strong> legname con<br />
buone caratteristiche e <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni. Sherwood, 86: 5-13.<br />
DAMIANI M., 2010 - Indag<strong>in</strong>i sulla presenza <strong>di</strong> latifoglie a legname pregiato i boschi cedui <strong>del</strong> Comune <strong>di</strong><br />
Monticiano (SI). Tesi <strong>di</strong> laurea. <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> laurea specialistica <strong>in</strong> gestione dei sistemi forestali, anno<br />
Accademico 2008-2009: 102 pp.<br />
GAUTHIER A., 2009 - Utilisations et marchés des fruitiers forestiers. Forêt-enterprise184: 50-53.<br />
GIULIETTI V., 2008 - S<strong>in</strong>gle tree oriented management <strong>in</strong> order to improve timber quality and value of<br />
broadleaved forest. Short-Term Scientific Mission <strong>in</strong> COST E42. http://www.valbro.unifreiburg.de/stsm.php<br />
GIULIETTI V., PELLERI F., 2009 - Caratterizzazione <strong>di</strong> un ceduo <strong>di</strong> cerro ad elevata prevalenza <strong>di</strong> rosacee<br />
arboree. Forest@ 6: 289-298.<br />
HEMERY G., SPIECKER H., ALDINGER E., KERR G., COLLET C., BELL S., 2008 - COST Action E42: grow<strong>in</strong>g<br />
valuable broadleaved tree species. F<strong>in</strong>al Report, 40 pp. http://www.valbro.uni-freiburg.de/<br />
HOFMANN A., GORETTI D., MERENDI G.A., TABACCHI G., VIGNOLI M., BERNETTI G. (a cura <strong>di</strong>), 1998 - Boschi<br />
e Macchie <strong>del</strong>la Toscana. L’<strong>in</strong>ventario Forestale. Regione Toscana, Giunta Regionale.<br />
LARRIEU L., GONIN P., 2009 - Autoécologie des fruitiers forestiers: merisier, alisier torm<strong>in</strong>al, cormier,<br />
poirier commun et pommier sauvage. Forêt-enterprise184: 14-21.<br />
MORI P., BURESTI LATTES E., BRUSCHINI S., GIULIETTI V., GRIFONI F., PELLERI F., RAVAGNI S., BERTI S.,<br />
CRIVELLARO A., 2007 - Selvicoltura <strong>del</strong>le specie spora<strong>di</strong>che <strong>in</strong> Toscana. Agenzia Regionale per lo<br />
Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA) <strong>del</strong>la Toscana, 352 pp.<br />
NICOLESCU V.N., HOCHBICHLER E., COELLO J., RAVAGNI S. AND GIULIETTI V., 2009 - Ecology and<br />
silviculture of wild service tree (Sorbus torm<strong>in</strong>alis (L.) Crantz): a literature review. Die Bodenkultur 60<br />
(3):35-44.<br />
NOSENZO A., BERRETTI R., BOETTO G., 2008 - Piantagioni da legno: Valutazione degli assortimenti<br />
ritraibili. Sherwood Foreste ed alberi oggi. 145: 15-20.<br />
PELLERI F., FERRETTI F., 2003 - Valorizzazione <strong>del</strong>le latifoglie nobili nei cedui. Un primo esempio.<br />
Sherwood – Foreste e Alberi Oggi, 93: 1-4.<br />
PELLERI F., GIULIETTI V., SANSONE D., SAMOLA A., NITTI D., 2010 - La valorizzazione <strong>del</strong>le rosacee<br />
arboree nella Comunità Montana Coll<strong>in</strong>e Metallifere (GR). Sherwood, Foreste e Alberi oggi. 160: 5-<br />
11<br />
PIUSSI P., 2007- Considerazioni sul governo a ceduo composto <strong>in</strong> Toscana. Sherwood – Foreste e<br />
Alberi Oggi, 131: 5-11<br />
RASMUSSEN K.K., 2007 - Dendroecological analysis of a rare sub-canopy tree: effects of climate,<br />
latitude, habitat con<strong>di</strong>tions and forest history. Dendrochronologia, 25: 3-17.<br />
REGIONE TOSCANA, 2003. Regolamento Forestale <strong>del</strong>la Toscana. DPGR n.48/R.<br />
ROTH VON B., BUCHER H.U., SCHUTZ J.P., AMMANN P., 2007 - Cerc<strong>in</strong>atura. Vecchi meto<strong>di</strong> nuovamente<br />
utilizzati. Sherwood – Foreste e Alberi Oggi, 135: 19-22.<br />
SPIECKER H. 2008 - Specie spora<strong>di</strong>che. Un’opportunità per foreste multifunzionali. Sherwood - Foreste e<br />
Alberi oggi. 145: 4-8.<br />
SCHÜTZ J.P., 2006 – Opportunities and stategies of biorationalization of forest ten<strong>di</strong>ng with<strong>in</strong> naturebased<br />
management. In “Nature based forestry <strong>in</strong> central Europe. Alternative to <strong>in</strong>dustrial forestry and<br />
strict preservation.” Stu<strong>di</strong>a Forestalia Slovenica (126): 39-46.<br />
WILHELM G.J., 2004 - Qualificazione e <strong>di</strong>mensionamento: la strategia selvicolturale <strong>del</strong>la Regione<br />
Renania-Palat<strong>in</strong>ato. Sherwood – Foreste e Alberi Oggi, 98: 9-12.<br />
WILHELM G.J., 2009 - Gérer l’alisier dans les peuplements mélangés. Forêt-enterprise 184: 31-35.
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
201
202<br />
Francesco Pelleri
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
203
204<br />
Francesco Pelleri
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
ELENCO DEGLI ATTI DEI CORSI DI CULTURA IN ECOLOGIA<br />
ATTI DEL 21° CORSO - 1984<br />
Marches<strong>in</strong>i L. Valutazione <strong>del</strong> grado <strong>di</strong> <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento da piombo tetraetile <strong>in</strong> un'area <strong>in</strong>dustriale: proposta <strong>di</strong> bonifica <strong>in</strong> funzione <strong>del</strong>la<br />
dest<strong>in</strong>azione.<br />
Brechtel L. Relazioni tra precipitazioni e foresta con riferimento alla qualità <strong>del</strong>le acque.<br />
Bagnaresi U. Problemi <strong>di</strong> forestazione nelle aree argillose <strong>del</strong>l'Appenn<strong>in</strong>o.<br />
Baggio P. Telerilevamento: metodo moderno d'analisi territoriale.<br />
Del Favero R. Popolamenti d'alta quota.<br />
ATTI DEL 22° CORSO - 1985<br />
Papanek F. Teoria <strong>del</strong>la gestione polifunzionale <strong>del</strong>la foresta con riferimento specifico all'economia forestale - Theory of polyfunctional forest<br />
management.<br />
Paiero P. Criteri <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>l'ambiente montano: aspetti botanici.<br />
Del Favero R. Problemi <strong>di</strong> assestamento forestale <strong>in</strong> parchi naturali: un'esperienza nel Monte Baldo.<br />
Bagnaresi U., Ros<strong>in</strong>i R. Esperienze <strong>di</strong> pianificazione dei parchi regionali e <strong>del</strong>le riserve naturali <strong>in</strong> Emilia Romagna.<br />
ATTI DEL 23° CORSO - 1986<br />
Shugart H.H. Le <strong>di</strong>namiche degli ecosistemi: illustrazione <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>le <strong>di</strong>namiche forestali tramite l'uso <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> simulazione.<br />
Rapp M. Ciclo <strong>del</strong>la sostanza organica, <strong>del</strong>l'acqua e <strong>del</strong>le sostanze nutritive.<br />
Dell'Agnola G. Evoluzione <strong>del</strong>la sostanza organica al suolo con particolare riferimento al processo <strong>di</strong> umificazione.<br />
ATTI DEL 26° CORSO - 1989<br />
Piussi P. La r<strong>in</strong>novazione <strong>del</strong>la pecceta subalp<strong>in</strong>a.<br />
Paci M. La r<strong>in</strong>novazione naturale <strong>del</strong>l'abete bianco nella foresta <strong>di</strong> Vallombrosa.<br />
Valent<strong>in</strong>i R. Foreste ed atmosfera.<br />
Scarascia Mugnozza G. Alberi forestali per un ambiente sottoposto a rapi<strong>di</strong> cambiamenti su scala globale: applicazioni <strong>del</strong>la fisiologia<br />
ambientale per la selezione <strong>di</strong> cloni <strong>di</strong> Populus spp.<br />
Giordano E. Aspetti ecofisiologici <strong>del</strong>la r<strong>in</strong>novazione naturale.<br />
ATTI DEL 27° CORSO - 1990<br />
Barbieri F. Primi dati sulla presenza <strong>del</strong> lupo (Canis lupus) nell'Appenn<strong>in</strong>o settentrionale.<br />
Viola F., Cattaneo D. Un mo<strong>del</strong>lo operativo per la pianificazione ecologica <strong>di</strong> particolari biotopi.<br />
Chem<strong>in</strong>i C. Lo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>le taxocenosi <strong>di</strong> artropo<strong>di</strong> nella valutazione naturalistica <strong>del</strong> territorio.<br />
Nicol<strong>in</strong>i G., Avanc<strong>in</strong>i G.P., Zambelli F. Sistema automatico per lo stu<strong>di</strong>o bioetologico <strong>del</strong>l'orso bruno (Ursus arcots L.) <strong>del</strong> Trent<strong>in</strong>o.<br />
Stergulc F. Anfibi e rettili <strong>di</strong> ecosistemi forestali e montani <strong>del</strong>le zone temperate.<br />
Masutti L. Zoocenosi ed ecosistemi montani.<br />
Andrighetto I. Il sistema foraggero-zootecnico a tutela <strong>del</strong>l'ambiente montano: alcune considerazioni sugli attuali orientamenti e sulle<br />
prospettive future.<br />
Ramanz<strong>in</strong> M. Considerazioni sull'allevamento <strong>di</strong> cervi<strong>di</strong> nelle zone montane.<br />
ATTI DEL 28° CORSO - 1991<br />
Pasqual<strong>in</strong> M. Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale: aspetti normativi ed operativi nella pianificazione territoriale <strong>del</strong> Veneto.<br />
Sardone A. La V.I.A. <strong>in</strong> USA, <strong>in</strong> Europa ed <strong>in</strong> Italia. L<strong>in</strong>eamenti generali.<br />
Laniado E. Dalla pianificazione territoriale alla prassi <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto.<br />
Colorni A., Laniado E. Silvia: un sistema <strong>di</strong> supporto alle decisioni per la Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale.<br />
Saturn<strong>in</strong>o A. La valutazione degli <strong>in</strong>vestimenti <strong>in</strong>erenti progetti pubblici <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento nel campo ambientale.<br />
ATTI DEL 29° CORSO - 1992<br />
Pubblicati <strong>in</strong> "Il bac<strong>in</strong>o attrezzato <strong>del</strong> Rio Cordon" Quaderni <strong>di</strong> Ricerca n. 13 Segreteria <strong>del</strong> Settore Primario, Dip.to Foreste Regione Veneto<br />
ATTI DEL 30° CORSO - 1993 - <strong>Ecologia</strong> <strong>del</strong>le foreste d'alta quota<br />
Holtmeier F.K. The upper timberl<strong>in</strong>e: ecological and geographical aspects.<br />
Turner H. Alp<strong>in</strong>e microclimates: typology and examples.<br />
Wolf U. Suoli e processi pedogenetici negli ambienti forestali d'altitu<strong>di</strong>ne sulle Alpi.<br />
Masutti L. Faune <strong>di</strong> quote elevate e foreste altomontane.<br />
Roques A. Impacts of <strong>in</strong>sects on natural regeneration of high altitude alp<strong>in</strong>e forests.<br />
Motta R. Ungulati selvatici e foreste <strong>di</strong> montagna <strong>in</strong> Alta Valle <strong>di</strong> Susa.<br />
Havranek H. The significance of frost and frost-drought for the alp<strong>in</strong>e timberl<strong>in</strong>e.<br />
Havranek H., Wieser G. Effects of long-term ozone fumigation on trees of Picea abies and Larix decidua <strong>in</strong> the filed.<br />
Anfo<strong>di</strong>llo T., Casar<strong>in</strong> A. Variazioni stagionali nelle relazioni idriche <strong>di</strong> rametti <strong>di</strong> abete rosso lungo un gra<strong>di</strong>ente altitu<strong>di</strong>nale.<br />
Piussi P. Mixed P<strong>in</strong>us cembra stands on the southern slope of the Eastern Alps.<br />
Dotta A., Motta R. Def<strong>in</strong>izone <strong>del</strong> piano subalp<strong>in</strong>o e dei limiti superiori <strong>del</strong> bosco e degli alberi <strong>in</strong> Alta Valle <strong>di</strong> Susa.<br />
Tessier L., Bell<strong>in</strong>gard C. Dendrochronology at the upper forest limit.<br />
NolaP., Pastorelli C., Pirola A. Uno stu<strong>di</strong>o dendrocronologico <strong>del</strong> larice al limite superiore <strong>del</strong>la vegetazione arborea <strong>in</strong> Valmalenco (Sondrio).<br />
ATTI DEL 31° CORSO - 1994 - Landscape Ecology - Eco logia <strong>del</strong> paesaggio<br />
Naveh Z. Introduction to landscape ecology as a practical trans<strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>ary science of landscape study, plann<strong>in</strong>g and management.<br />
Schaller J. Landscape ecology research and environmental management. Environment and GIS management of a National Park MAB-Project<br />
6 Ecosystem Research Berchtesgaden.<br />
Schaller J. Landscape ecology research and environmental management. GIS for Shang Bai Shan Biosphere Reserve - Ne Ch<strong>in</strong>a - Cerp, cooperative<br />
ecological research program.<br />
Schaller J. Landscape ecology research and environmental management. Environmental impact assessment study for the planned Rh<strong>in</strong>e-<br />
Ma<strong>in</strong>-Danube River Channel (Federal Republic of Germany).<br />
Gourov A.V. Territorial mosaic and the problem of boundaries (<strong>in</strong> case of secondary succession).<br />
Lucas O.W.R. Visual assessment of the landscape and its application of forest design.<br />
Anko B. Application of landscape ecology <strong>in</strong> forestry.<br />
Baggio P. Interazioni sistemiche territoriali: metodologie e approccio <strong>del</strong>l'analisi, <strong>in</strong>terazione <strong>di</strong> mo<strong>del</strong>li <strong>in</strong>terattivi per una pianificazione<br />
territoriale.<br />
Far<strong>in</strong>a A. L'abbandono rurale e suoi effetti sul paesaggio.
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
ATTI DEL 32° CORSO - 1995 - Interazioni albero-ambi ente: meto<strong>di</strong> e strumenti <strong>di</strong> misura<br />
Mart<strong>in</strong>kova M.. General aspects of water relations<br />
Zipoli G. Strumenti e sensori per misure micrometereologiche<br />
Brugnoli E., Scartazza A., Lauteri M. Effetto degli stress abiotici sulla fotos<strong>in</strong>tesi<br />
Jones H.G., Atk<strong>in</strong>son C.J. Possible effects of climate change on trees<br />
Cermak J. Methods for stu<strong>di</strong>es of water transport <strong>in</strong> trees, especially the stem heat alance and scal<strong>in</strong>g.<br />
Cermak J. Transpiration of trees - Variability, relationto structures, water balance and defense mechanisms.<br />
F<strong>in</strong>k S. M<strong>in</strong>eral nutrition of trees: analytical approaches, physiological significances and some applications to the problem of forest decl<strong>in</strong>e.<br />
Huttunen S. Effects of air pollutants on conifer needles.<br />
Valent<strong>in</strong>i R. Dall'albero alla comunità: tecniche per la quantificazione <strong>del</strong>le risposte degli ecosistemi.<br />
Granier A. Measurement of tree and stand sapflow: temporal anda spatial variations.<br />
ATTI DEL 33° CORSO - 1996 - Tutela e controllo dei sistemi fluviali<br />
Viola F., Zanella A. Vulnerabilità e presi<strong>di</strong>o dei sistemi <strong>in</strong>torno all'acqua.<br />
Fattorelli S., Dalla Fontana G., Da Ros D. Valutazione e riduzione dei rischi da piena.<br />
Dalla Fontana G., Borga M. Lo stu<strong>di</strong>o probabilistico <strong>del</strong>le piogge <strong>in</strong>tense per la previsione statistica <strong>del</strong> rischio idraulico.<br />
Lenzi M. A. Criteri <strong>di</strong> classificazione dei sistemi fluviali.<br />
Lasen C. <strong>Ecologia</strong> dei popolamenti vegetali ripari <strong>in</strong> area montana e subalp<strong>in</strong>a.<br />
Paiero P. Il recupero naturalistico <strong>del</strong>la vegetazione ripariale con particolare riguardo all'area planiziale padana.<br />
Boso R. I piani <strong>di</strong> bac<strong>in</strong>o attraverso il contributo <strong>del</strong>la cultura <strong>in</strong>gegneristica e naturalistica.<br />
Saccardo I. La <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong> m<strong>in</strong>imo vitale. Criteri <strong>di</strong> stima idrologici ed idraulici.<br />
D'Agost<strong>in</strong>o V. Analisi quantitativa e qualitativa <strong>del</strong> trasporto solido torrentizio nei bac<strong>in</strong>i montani <strong>del</strong> Trent<strong>in</strong>o orientale.<br />
Anselmo V. La manutenzione degli alvei.<br />
ATTI DEL 34° CORSO - 1997 - Dendroecologia: una sci enza per l'ambiente fra passato e futuro<br />
Tessier L., Edouard J.L., Guibal F. Tree r<strong>in</strong>gs and climate (Dendroclimatology, Dendroecology) - The climatic signal <strong>in</strong> tree r<strong>in</strong>gs.<br />
Nola P. L'analisi dendroecologica <strong>in</strong> formazioni forestali mesofile: il caso dei quesrceti planiziali.<br />
Keller T., Guiot J., Tessier L. The artificial neural network: a new advance <strong>in</strong> responce function calculation.<br />
Nicault A., Tessier L. Intra-annual variations of cambial activity and r<strong>in</strong>g structure.<br />
Stockli V. Physical <strong>in</strong>terctions between snow and trees: dendroecology as a valuable tool for their <strong>in</strong>terpretation<br />
Motta R. La dendroecologia come strumento per l'analisi dei danni provocati dagli ungulati selavtici alle foreste. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o ed esempi <strong>di</strong><br />
applicazione <strong>in</strong> ambiente alp<strong>in</strong>o.<br />
Mor<strong>in</strong> H. Us<strong>in</strong>g dendroecology to <strong>in</strong>vestigate black spruce and balsam fir population dynamics <strong>in</strong> boreal zone of Quebec.<br />
Pividori M. Tecniche dendroecologiche nell'analisi <strong>di</strong> boschi cedui e <strong>di</strong> nuova formazione.<br />
Cherub<strong>in</strong>i P. La dendroecologia nella ricostruzione <strong>del</strong>la storia <strong>di</strong> due popolamenti subalp<strong>in</strong>i <strong>di</strong> abete rosso nella Foresta <strong>di</strong> Paneveggio<br />
(Trent<strong>in</strong>o).<br />
Hugle C.E. Ricostruzione <strong>del</strong>la storia recente <strong>di</strong> tre popolamenti <strong>di</strong> abete rosso (Picea abies Karst.) nella Foresta <strong>di</strong> Paneveggio.<br />
Urb<strong>in</strong>ati C., Carrer M. Ricerche dendroecologiche sui <strong>di</strong>namismi spazio-temporali <strong>in</strong> larici-cembreti <strong>di</strong> "timberl<strong>in</strong>e" nelle Dolomiti orientali.<br />
Urb<strong>in</strong>ati C., Carrer M. Dendroecologia e analisi <strong>del</strong>la struttura spaziale <strong>in</strong> una cenosi <strong>di</strong> "timberl<strong>in</strong>e" <strong>del</strong>le Dolomiti orientali.<br />
Eckste<strong>in</strong> D. The city trees <strong>in</strong> Hamburg: study object for dendroecology over the twenty years.<br />
ATTI DEL 35° CORSO - 1998 - La tipologia <strong>del</strong>le staz ioni forestali - Esempio <strong>di</strong> ecologia applicata<br />
A. Mancabelli, G. Sartori. Roccia madre e suoli <strong>del</strong> Trent<strong>in</strong>o. Metodologia <strong>di</strong> rilievo e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>in</strong>tegrato <strong>del</strong>l'ambiente e risvolti tassonomici.<br />
M. S. Calabrese, S. Nar<strong>di</strong>, Sartori G., D. Pizzeghello, A. Zanella, G. Nicol<strong>in</strong>i. Importanza <strong>del</strong>l'attività ormono-simile <strong>del</strong>la sostanza umica per<br />
una classificazione funzionale degli humus forestali. Applicazione alle faggete ed abieteti trent<strong>in</strong>i.<br />
F. Festi, M. Odasso, G. Pignatti, F. Prosser, L. Sottovia. Sud<strong>di</strong>visione ecologica <strong>del</strong> territorio sulla base <strong>del</strong>la <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le specie<br />
forestali. Applicazioni relative alle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>del</strong>le tipologie forestali.<br />
C. Lasen. Esempi <strong>di</strong> fitosociologia applicata alla tipologia <strong>del</strong>le stazioni forestali.<br />
U. Bagnaresi, G. Fratello. D<strong>in</strong>amica dei popolamenti forestali <strong>in</strong> strutture irregolari e <strong>di</strong>setanee.<br />
R. Del Favero. Tipologie forestali: concetti, metodologia e applicazioni. Le esperienze nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.<br />
G. P. Mon<strong>di</strong>no. Presentazione dei tipi forestali <strong>del</strong> Piemonte.<br />
A. Antonietti. Il metodo fitosociologico applicato alla tipologia <strong>del</strong>le stazioni forestali <strong>in</strong> Svizzera.<br />
R.E. Rosselló. Tipi <strong>di</strong> stazioni forestali <strong>in</strong> Spagna. Stato <strong>del</strong>l'arte e prospettive.<br />
M. Bartoli.Confronto tra le tipologie e gli habitat forestali. L'esempio dei Pirenei centrali.<br />
G. Dumè. Il Gruppo <strong>di</strong> Lavoro sulla tipologia forestale <strong>in</strong> Francia: risultati e prospettive.<br />
G. Bernetti. Presentazione <strong>del</strong>la nuova tipologia forestale <strong>del</strong>la Toscana.<br />
A. Zanella. Intorno al concetto <strong>di</strong> "tipologia forestale". Aspettative e realtà.<br />
C. De Siena, M. Tomasi, G. Nicol<strong>in</strong>i. Gli humus forestali <strong>del</strong> Trent<strong>in</strong>o.<br />
R. Zampedri. Metodologie <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpolazione statistica per una rappresentazione <strong>del</strong> clima a livello regionale.<br />
ATTI DEL 36° CORSO - 1999 - La pianificazione e la gestione <strong>del</strong> verde urbano<br />
T. Barefoed Randrup. Urban forestry research <strong>in</strong> Europe.<br />
Z. Borzan, V. Kusan, R. Pernar. Scientific approach to understan<strong>di</strong>ng and treatment of amenity trees <strong>in</strong> urban forestry.<br />
P. Semenzato, T. Urso. Il rilievo <strong>del</strong>la vegetazione nei giar<strong>di</strong>ni storici.<br />
E. Piutti, C. Poll<strong>in</strong>i, R. Leonar<strong>del</strong>li, L. Pedrotti. La gestione <strong>del</strong>le alberature urbane: il caso <strong>di</strong> Trento.<br />
P. Raimbault. Assess<strong>in</strong>g and manag<strong>in</strong>g urban trees: from scientific concepts to field tecniques.<br />
G. Morelli, G. Poletti. Cenni teorici sulla valutazione <strong>del</strong>la stabilità degli alberi.<br />
L. Benvenuti. Modalità d'<strong>in</strong>tervento e scelta <strong>del</strong>le tecnologie nella realizzazione <strong>del</strong>le opere a verde.<br />
ATTI DEL 38° CORSO - 2001 - Monitoraggio ambientale : metodologie ed applicazioni<br />
M. Ferretti. Ecosystem monitor<strong>in</strong>g. From the <strong>in</strong>tegration between measurements to the <strong>in</strong>tegration between networks.<br />
A. Benassi, G. Marson, F. Liguori, K. Lorenzet, P. Tieppo. Progetto <strong>di</strong> riqualificazione e ottimizzazione <strong>del</strong>le reti <strong>di</strong> monitoraggio <strong>del</strong>la qualità<br />
<strong>del</strong>l'aria <strong>del</strong> Veneto.<br />
S. Fonda-Umani. I sistemi <strong>di</strong> monitoraggio <strong>in</strong> aree mar<strong>in</strong>e costiere e relative problematiche.<br />
P. Nimis. Il biomonitoraggio <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l'aria tramite licheni.<br />
G. Gerosa, A. Ballar<strong>in</strong>-Denti. Techniques of ozone monitor<strong>in</strong>g <strong>in</strong> a mountai forest region: passive and cont<strong>in</strong>uous sampl<strong>in</strong>g, vertical and<br />
canopy profiles..<br />
A. Thimonier, M. Schimitt, P. Cherub<strong>in</strong>i, N. Kräuchi. Monitor<strong>in</strong>g the Swiss forest: buil<strong>di</strong>ng a research platform.<br />
R. Valent<strong>in</strong>i. Metodologie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>la produttività primaria <strong>di</strong> ecosistemi forestali.<br />
C. Urb<strong>in</strong>ati, M. Carrer. L'analisi degli anelli legnosi come strumento per il monitoraggio climatico.<br />
W. Haeberli. Glacier and permafrost monitor<strong>in</strong>g <strong>in</strong> cold mounta<strong>in</strong> areas as part of global climate related observation.<br />
R. Caracciolo. Sistema nazionale <strong>di</strong> monitoraggio e controllo <strong>in</strong> campo ambientale.<br />
V. Carraro, T. Anfo<strong>di</strong>llo, S. Rossi. I siti sperimentali <strong>di</strong> "Col de La Roa" e <strong>di</strong> "C<strong>in</strong>que Torri".<br />
207
208<br />
Gestione multifunzionale e sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive<br />
<strong>46°</strong> <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Cultura</strong> <strong>in</strong> <strong>Ecologia</strong>, 7-10 giugno 2010<br />
ATTI DEL 39° CORSO - 2002 - Il fuoco <strong>in</strong> foresta: ec ologia e applicazioni<br />
Giovanni Bovio. La pianificazione ant<strong>in</strong>cen<strong>di</strong> boschivi<br />
Marco Conedera, Marco Moretti, Willy T<strong>in</strong>ner. Storia ed ecologia degli <strong>in</strong>cen<strong>di</strong> boschivi al sud <strong>del</strong>le Alpi <strong>del</strong>la Svizzera<br />
Thomas W. Swetnam. Fire and climate history <strong>in</strong> the Western Americas from tree r<strong>in</strong>gs<br />
Dom<strong>in</strong>gos Xavier Viegas. Fire behaviour mo<strong>del</strong>s: an overview<br />
Louis Trabaud. Effects of fire on me<strong>di</strong>terranean plants and ecosystems<br />
Pasi Puttonen. Use of prescribed fire <strong>in</strong> <strong>di</strong>versity oriented silviculture<br />
Dom<strong>in</strong>go Mol<strong>in</strong>a. Prescribed burn<strong>in</strong>g to allow for forest susta<strong>in</strong>ability<br />
Giancarlo Cesti. Tipologie e comportamenti particolari <strong>del</strong> fuoco: risvolti nelle operazioni <strong>di</strong> est<strong>in</strong>zione<br />
Jesús San-Miguel-Ayanz. Methodologies for the evaluation of forest fire risk: from long-term (static) to dynamic <strong>in</strong><strong>di</strong>ces<br />
ATTI DEL 40° CORSO - 2004 Reti ecologiche: una chia ve per la conservazione e la gestione dei paesaggi frammentati - Ecological<br />
networks: a key to the conservation and management of fragmented landscapes<br />
Rob Jongman, The concept of ecological networks: European approaches<br />
Roberto Gamb<strong>in</strong>o, Reti ecologiche e territorio<br />
Daniel Franco, Ecological networks: the state of the art from a landscape ecology perspective <strong>in</strong> the national framework<br />
Ilse Storch, Wildlife species as <strong>in</strong><strong>di</strong>cators: a solution for ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong><strong>in</strong>g "ecological networks" <strong>in</strong> fragmented landscapes?<br />
Stefania Zorzi & Silvano Matte<strong>di</strong>, Reti ecologiche e fauna selvatica: limiti alla <strong>di</strong>spersione e loro mitigazione<br />
Duncan McColl<strong>in</strong> & Janet Jackson, Hedgerows as habitat corridors for forest herbs<br />
Margherita Lucch<strong>in</strong>, Genetica nelle reti ecologiche: <strong>in</strong><strong>di</strong>ci e <strong>in</strong><strong>di</strong>catori per la stima <strong>del</strong>la funzionalità<br />
Tommaso Sitzia, La qualità dei corridoi ecologici arborei l<strong>in</strong>eari: <strong>in</strong><strong>di</strong>ci s<strong>in</strong>tetici <strong>di</strong> valutazione <strong>del</strong>le siepi arboree nel paesaggio agrario<br />
Giuseppe De Togni, Reti ecologiche e pianificazione urbanistica: problemi tecnici e amm<strong>in</strong>istrativi<br />
Andrea Fiduccia, Luciano Fonti, Mar<strong>in</strong>a Funaro, Lucilia Gregari, Silvia Rapicetta, Stefano Remiero, Strutture <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazione geospaziale e<br />
processi <strong>di</strong> conoscenza per l’identificazione <strong>del</strong>la connettività ecosistemica potenziale<br />
Giust<strong>in</strong>o Mezzalira, Progettazione esecutiva e conservazione dei corridoi ecologici arborei<br />
Federico Correale Santacroce, Le reti ecologiche e la Legge Regionale <strong>del</strong> Veneto 13/2003: l<strong>in</strong>ee guida per la progettazione dei boschi <strong>di</strong><br />
pianura<br />
ATTI DEL 41° CORSO - 2005 Conoscere il sistema fium e <strong>in</strong> ambiente alp<strong>in</strong>o<br />
Gianfranco Zol<strong>in</strong>, Corsi d’acqua alp<strong>in</strong>i: ecologia e paesaggio<br />
Giancarlo Dalla Fontana, I processi <strong>di</strong> formazione <strong>del</strong> reticolo idrografico<br />
Diego Sonda, Utilizzo <strong>di</strong> gis per l'analisi <strong>del</strong> bac<strong>in</strong>o idrografico<br />
Paolo Paiero e Giovanni Paiero, La vegetazione rivierasca alp<strong>in</strong>a<br />
Antonio Andrich, Conoscere la vegetazione riparia: l’<strong>in</strong>fluenza <strong>del</strong> regime idrologico e <strong>del</strong>la manutenzione<br />
Silvia Degli Esposti, Daniele Norbiato, Roberto D<strong>in</strong>ale,, Marco Borga, Valutazione <strong>di</strong> alcune componenti <strong>del</strong> bilancio idrologico <strong>in</strong> bac<strong>in</strong>i <strong>di</strong> tipo<br />
alp<strong>in</strong>o<br />
Gian Battista Bischetti, Interazione tra vegetazione e deflusso e stabilità <strong>del</strong>le sponde<br />
Paolo Billi, I torrenti come con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> equilibrio morfo<strong>di</strong>namico e la portata formativa<br />
V<strong>in</strong>cenzo D'agost<strong>in</strong>o, Morfologia e <strong>di</strong>namica dei corsi d’acqua <strong>di</strong> montagna<br />
Alessandro Vianello, L’analisi granulometrica dei se<strong>di</strong>menti nei corsi d’acqua montani<br />
Lorenzo Marchi, Il trasporto solido <strong>di</strong> fondo e le colate detritiche: fenomenologia ed effetti sull’assetto dei corsi d’acqua a forte pendenza<br />
Mario Cerato, Il controllo dei torrenti per mezzo <strong>del</strong>le opere <strong>di</strong> sistemazione montana: la ricerca <strong>di</strong> un compromesso fra la tutela <strong>del</strong>la<br />
naturalità e gli obiettivi <strong>di</strong> protezione<br />
ATTI DEL 42° CORSO - 2006 Stima <strong>del</strong> carbonio <strong>in</strong> for esta: metodologie e aspetti normativi<br />
Pettenella D. Inquadramento generale <strong>del</strong> PK, opportunità e limiti per il settore forestale.<br />
Anfo<strong>di</strong>llo T. Stima <strong>del</strong> C stock: meto<strong>di</strong> <strong>in</strong>ventariali, con applicazione <strong>di</strong> equazioni allometriche.<br />
Valent<strong>in</strong>i R. Eddy covariance: potenzialità e limiti applicativi.<br />
Tabacchi G. L’Inventario Nazionale <strong>del</strong>le Foreste e dei serbatoi <strong>di</strong> carbonio: aspetti metodologici.<br />
Mäkipää R. Integrated method to estimate the carbon budget of forests - nation-wide estimates obta<strong>in</strong>ed by comb<strong>in</strong><strong>in</strong>g forest <strong>in</strong>ventory data<br />
with biomass expansion factors, biomass turnover rates and a dynamic soil C mo<strong>del</strong>.<br />
Badeck P. Forest <strong>di</strong>sturbance factors.<br />
Zanchi G. - Art 3.3 and 3.4 of Kyoto Protocol: Afforestation, reforestation, deforestation, revegetation and forest management activities:<br />
requirements and choices.<br />
Pompei E. L'espansione <strong>del</strong>le foreste italiane negli ultimi 50 anni: il caso <strong>del</strong>la Regione Abruzzo<br />
Kloehn S. The role of forest products <strong>in</strong> the carbon cycle.<br />
Rodeghiero M. Stima <strong>del</strong> carbonio nel suolo.<br />
Pilli R. Indag<strong>in</strong>e prelim<strong>in</strong>are sullo stock e sulla fissazione <strong>del</strong> Carbonio nelle foreste <strong>del</strong> Veneto.<br />
ATTI DEL 43° CORSO - 2007 Biomasse forestali ad uso energetico <strong>in</strong> ambiente alp<strong>in</strong>o: potenzialità e limiti<br />
Mario Lividori, Biomassa legnose- La gestione e gli aspetti selvicolturali.<br />
Eliseo Anton<strong>in</strong>i, Le valutazioni economiche nel settore legno-energia.<br />
Stefano Berti, Le biomassa legnose: il legno.<br />
Lucia Recchia, LCA per filiere legno-energia.<br />
Bernardo Hellrigl, Dendroenergia.<br />
Stefano Grigolato, Pianificazione degli approvvigionamenti <strong>in</strong> ambiente alp<strong>in</strong>o.<br />
Alexander Eberhar<strong>di</strong>nger, Performance of alternative harvest<strong>in</strong>g methods us<strong>in</strong>g feller-buncher system <strong>in</strong> early th<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gs of Norway Spruce.<br />
Karl Stampfer, Christian Kanzian, Current state and development possibilities of wood chip supply cha<strong>in</strong>s <strong>in</strong> Ausria.<br />
Walter Hasl<strong>in</strong>ger, Combustion technologies and emissions. State-of-the-art small-scale pellets combustion technologies.<br />
ATTI DEL 44° CORSO - 2008 Disturbi <strong>in</strong> foresta ed ef fetti sullo stock <strong>di</strong> carbonio: il problema <strong>del</strong>la non permanenza - Forest<br />
<strong>di</strong>sturbances and effects on carbon stock:the non-permanence issue<br />
Elena Dalla Valle, Forest <strong>di</strong>sturbances and effects on carbon stock: general overview.<br />
Ana Isabel Miranda, Forest fires and air pollution.<br />
Dom<strong>in</strong>go Mol<strong>in</strong>a, Me<strong>di</strong>terranean fire regimes and impacts on forest permanence cases from northern<br />
California, ne spa<strong>in</strong> and Canary islands.<br />
Jean- Francois Boucher Simon Gaboury, Réjean Gagnon, Daniel Lord, Claude Villeneuve, Permanence of the carbon stocks <strong>in</strong> the north<br />
american boreal forest under natural and anthropogenic <strong>di</strong>sturbance regimes.<br />
Ionel Popa, W<strong>in</strong>dthrow risk management. results from romanian forests.<br />
Giacomom Grassi, Reduc<strong>in</strong>g emissions from deforestation <strong>in</strong> develop<strong>in</strong>g countries: the new challenge for climate mitigation.
La selvicoltura d’albero e le specie spora<strong>di</strong>che nei cedui<br />
ATTI DEL 45° CORSO – 2009 Selvicoltura naturalistic a: basi ecologiche, applicazioni e contesto normativo<br />
Pietro Piussi selvicoltura naturalistica: le vicende <strong>del</strong>le orig<strong>in</strong>i.<br />
Luca Soraruf, Marco Carrer, Aree permanenti e monitoraggio <strong>di</strong> lungo periodo: potenzialità, limiti e approcci metodologici.<br />
Tommaso Anfo<strong>di</strong>llo, Marco Carrer, Filippo Sim<strong>in</strong>i, V<strong>in</strong>icio Carraro, Giai Petit, Amos Maritan, Nuove prospettive per la def<strong>in</strong>izione funzionale<br />
<strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>le foreste.<br />
Massimo Stroppa, Pianificazione forestale e selvicoltura neturalistica: applicazioni <strong>in</strong> regione Friuli Venezia Giulia.<br />
Tommaso Sitzia, Michele Cassol, Selvicoltura naturalistica e conservazione degli habitat forestali a scala <strong>di</strong> popolamento.<br />
Pierantonio Zanchetta, Intervento alla tavola rotonda.<br />
209