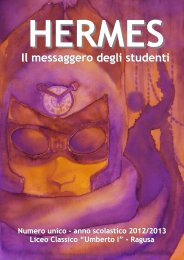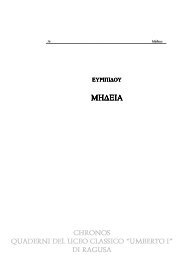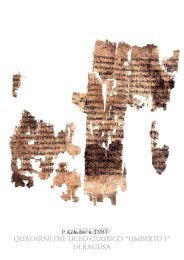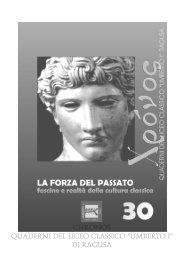Interpretazioni del risorgimento - liceoclassicoragusa.it
Interpretazioni del risorgimento - liceoclassicoragusa.it
Interpretazioni del risorgimento - liceoclassicoragusa.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Le interpretazioni <strong>del</strong> Risorgimento nella storiografia <strong>it</strong>aliana<br />
Nei primi tre decenni dopo l'un<strong>it</strong>à gli studi sul Risorgimento furono la continuazione <strong>del</strong>la polemica fra i<br />
part<strong>it</strong>i risorgimentali, il moderato e il democratico, ed ebbero un carattere prevalentemente apologetico e in parte<br />
addir<strong>it</strong>tura agiografico, poiché mirarono a esaltare l'opera dei maggiori artefici <strong>del</strong>lo Stato un<strong>it</strong>ario, le lotte dei<br />
patrioti e i sacrifici dei martiri. Non mancarono, negli ambienti clericali e reazionari, tentativi di dare una base<br />
storiografica alla tesi secondo cui lo Stato un<strong>it</strong>ario era il risultato di una sopraffazione da parte di una minoranza<br />
rivoluzionaria utilizzata da un governo usurpatore contro la volontà <strong>del</strong>la maggioranza degli <strong>it</strong>aliani. Ma questa<br />
tesi non riuscì ad affermarsi di fronte alla v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à <strong>del</strong> nuovo Stato <strong>it</strong>aliano e finì per essere coltivata, in misura via<br />
via sempre minore, solo in ristretti circoli di cattolici intransigenti.<br />
Dopo l'avvento al potere <strong>del</strong>la Sinistra cost<strong>it</strong>uzionale nel 1876, la posizione storiografica moderata<br />
prevalse su quella democratica, di cui assorbì tuttavia alcuni elementi; essa riconobbe così il valore <strong>del</strong> contributo<br />
dato da Mazzini, da Garibaldi e da altri democratici alla soluzione <strong>del</strong> problema <strong>del</strong>l'un<strong>it</strong>à, e sottolineò come, pur<br />
attraverso aspri contrasti, le varie forze pol<strong>it</strong>iche avessero ag<strong>it</strong>o in senso concom<strong>it</strong>ante per raggiungere un<br />
risultato da accettarsi ormai senza discussione nei suoi aspetti fondamentali: l'un<strong>it</strong>à, la monarchia sabauda, lo<br />
Statuto albertino, il sistema parlamentare attuato da Cavour, Roma cap<strong>it</strong>ale e la legge <strong>del</strong>le guarentigie. Il<br />
Risorgimento fu considerato insomma come un periodo eroico perfettamente concluso in quanto aveva raggiunto<br />
nel 1861 e nel 1870 i fini essenziali <strong>del</strong>l'aspirazione nazionale <strong>it</strong>aliana.<br />
In contrasto con l'interpretazione <strong>del</strong> Risorgimento ispirata dalla storiografia moderata ufficiale fu il libro<br />
di Alfredo Oriani La lotta pol<strong>it</strong>ica in Italia, pubblicato nel 1892: l'autore partiva dall'idea — non nuova peraltro<br />
— che la storia d'Italia fosse caratterizzata da un contrasto tra federalismo e un<strong>it</strong>arismo, e si dichiarava<br />
favorevole a quest'ultimo; cr<strong>it</strong>icava però vivacemente la conclusione <strong>del</strong> Risorgimento, perché l'un<strong>it</strong>à era stata<br />
raggiunta con la «conquista regia», cioè con un compromesso tra una monarchia che non era in grado da sola di<br />
unificare il paese, e un movimento democratico troppo debole per fare una rivoluzione. Da questo compromesso<br />
era nato uno Stato incapace di realizzare una salda democrazia, ma soprattutto di svolgere una pol<strong>it</strong>ica estera<br />
degna di una grande potenza. La cr<strong>it</strong>ica di Oriani muoveva dunque da due esigenze contrastanti, una democratica<br />
e una nazionalista, ma la seconda prevaleva nettamente sulla prima.<br />
Il consolidamento <strong>del</strong> fascismo indusse la storiografia <strong>it</strong>aliana a rivedere le interpretazioni ormai<br />
tradizionali <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>l'un<strong>it</strong>à e <strong>del</strong> Risorgimento. Gli storici fascisti e quelli che accettarono le direttive<br />
culturali <strong>del</strong> regime videro nel Risorgimento essenzialmente il processo di unificazione nazionale: nonostante<br />
alcuni tentativi più cr<strong>it</strong>icamente avvert<strong>it</strong>i (G. Volpe), prevalse largamente una tendenza apertamente<br />
nazionalistica e reazionaria che si identificò con la preesistente tendenza «sabaudistica» tipica di una parte <strong>del</strong>la<br />
storiografia erud<strong>it</strong>a, sicché, privilegiando un approccio prevalentemente pol<strong>it</strong>ico-diplomatico-mil<strong>it</strong>are, fu esaltata<br />
la funzione <strong>del</strong> Piemonte, si indicò nell'espansionismo sabaudo settecentesco l'origine <strong>del</strong>la pol<strong>it</strong>ica di<br />
unificazione nazionale, si cercò di svalutare l'influenza <strong>del</strong>le correnti illuministiche europee insistendo sul<br />
carattere presunto autoctono <strong>del</strong>l'Illuminismo <strong>it</strong>aliano, e si giudicò negativamente l'influenza <strong>del</strong>la Rivoluzione<br />
francese e <strong>del</strong>le correnti liberali e democratiche europee <strong>del</strong>l'Ottocento. Infine, sviluppando la linea nazionalistica<br />
di Oriani, gli storici fascisti misero in luce soprattutto le debolezze <strong>del</strong>l'Italia un<strong>it</strong>a dal 1861 al 1914, salutando<br />
come un elemento pos<strong>it</strong>ivo di grande importanza la nasc<strong>it</strong>a dei movimenti antidemocratici nei primi anni <strong>del</strong><br />
secolo.<br />
1
Di fronte all'interpretazione fascista, gli storici e i pubblicisti antifascisti <strong>del</strong>inearono tre diverse<br />
interpretazioni <strong>del</strong> Risorgimento e <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>l'Italia un<strong>it</strong>a fino alla prima guerra mondiale, che si collegano<br />
alle tre interpretazioni «classiche» <strong>del</strong> fascismo.<br />
L'interpretazione di Piero Gobetti, quale risulta principalmente dalla raccolta di saggi Risorgimento senza<br />
eroi (1926), si ricollega alla polemica antimoderata di Cattaneo e di Mazzini ma al tempo stesso, nella sua cr<strong>it</strong>ica<br />
<strong>del</strong>la classe dirigente liberale, rivela una forte influenza <strong>del</strong>la tesi di Oriani, depurata però <strong>del</strong>l'aspetto<br />
nazionalistico. Secondo Gobetti, il Risorgimento fu l'opera di una minoranza che finì per adattarsi a un<br />
compromesso con le vecchie forze pol<strong>it</strong>iche e rinunciò ad attuare una profonda rivoluzione sociale e<br />
culturale. Da questa «rivoluzione fall<strong>it</strong>a» nacque uno Stato liberale solo esteriormente, incapace di venire<br />
incontro alle esigenze di rinnovamento <strong>del</strong>le masse e di trasformarsi in una democrazia moderna, sicché<br />
era facilmente spiegabile e prevedibile il suo sbocco nel fascismo.<br />
All'interpretazione gobettiana reagì dal punto di vista crociano Adolfo Omodeo che, in una recensione al<br />
libro di Gobetti pubblicata nel corso <strong>del</strong>lo stesso anno, ribadì l'interpretazione liberale riaffermando la valid<strong>it</strong>à<br />
e la fecond<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'opera compiuta dalla minoranza liberale <strong>del</strong> Risorgimento, contrapponendo questo al fascismo.<br />
Poco dopo, Benedetto Croce (Storia d'Italia dal 1871 al 1915, 1928; Storia d'Europa nel secolo decimonono,<br />
1932) <strong>del</strong>ineò un'immagine pos<strong>it</strong>iva <strong>del</strong>l'Italia liberale e <strong>del</strong>la sua classe dirigente, considerando il Risorgimento<br />
<strong>it</strong>aliano come uno dei principali eventi <strong>del</strong>la storia europea ottocentesca, caratterizzata proprio dallo sviluppo<br />
pos<strong>it</strong>ivo <strong>del</strong> liberalismo.<br />
Posizione intermedia è quella occupata dallo storico Luigi Salvatorelli, che vide l'elemento essenziale <strong>del</strong><br />
Risorgimento nell'integrazione dialettica tra Mazzini e Cavour, pur accentuando il ruolo <strong>del</strong> primo rispetto al<br />
secondo; il che implicava un giudizio in parte negativo sull'Italia liberale prefascista in cui riecheggiano motivi<br />
gobettiani.<br />
Antonio Gramsci <strong>del</strong>ineò la sua interpretazione marxista <strong>del</strong> Risorgimento in vari scr<strong>it</strong>ti, ma<br />
soprattutto in una vasta serie di appunti scr<strong>it</strong>ti in carcere tra il 1927 e il 1935 circa, int<strong>it</strong>olati complessivamente<br />
Quaderni dal carcere, dei quali uno, Il Risorgimento, contiene la maggior parte <strong>del</strong>le sue riflessioni in mer<strong>it</strong>o.<br />
L'interpretazione gramsciana nacque dunque contemporaneamente a quella gobettiana e a quella liberale<br />
ortodossa di Croce-Omodeo, ma essendo stata pubblicata solo nel 1949, influì sulla cultura storiografica <strong>it</strong>aliana<br />
soltanto dopo la seconda guerra mondiale, e in particolare negli anni '50. Anch'essa muove da un giudizio<br />
fortemente cr<strong>it</strong>ico sullo Stato liberale usc<strong>it</strong>o dal Risorgimento, ma fonda questo giudizio su un'analisi <strong>del</strong>la<br />
struttura di classe <strong>del</strong>la società <strong>it</strong>aliana durante l'epoca risorgimentale e il primo periodo <strong>del</strong>lo Stato un<strong>it</strong>ario fino<br />
alla prima guerra mondiale. Secondo tale interpretazione, il Risorgimento fu una rivoluzione borghese dettata<br />
dall'aspirazione <strong>del</strong>la borghesia <strong>it</strong>aliana all'unificazione <strong>del</strong> mercato interno, ma rimasta incompleta<br />
soprattutto per la mancata attuazione di una trasformazione rivoluzionaria dei rapporti di classe nelle<br />
campagne. A ciò contribuirono principalmente due circostanze: il fatto che la fase decisiva si fosse svolta<br />
quando già la borghesia europea era in posizione difensiva rispetto a un proletariato sempre più permeato da idee<br />
socialiste; la scarsa autonomia pol<strong>it</strong>ica <strong>del</strong>l'Italia sul piano internazionale. Da tali lim<strong>it</strong>azioni derivarono la<br />
persistenza nella società <strong>it</strong>aliana di forti residui «feudali» 1 , il carattere monarchico-moderato <strong>del</strong>lo Stato un<strong>it</strong>ario,<br />
il persistente “reazionarismo” <strong>del</strong>la classe dominante, evidente soprattutto nei momenti di crisi, l'intrinseca<br />
debolezza <strong>del</strong>le ist<strong>it</strong>uzioni liberali.<br />
1 Si pensi ai rapporti sociali esistenti nel Mezzogiorno fra proprietari e contadini<br />
2
Una svolta negli studi risorgimentali si ebbe quando Rosario Romeo, in una serie di articoli raccolti poi<br />
nel volume Risorgimento e cap<strong>it</strong>alismo (1959), attaccò l'interpretazione gramsciana e marxista affermando<br />
l'insostenibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la tesi <strong>del</strong> Risorgimento come «rivoluzione agraria mancata», a cui egli riduceva in<br />
sostanza il nocciolo di tale argomentazione, sostenendo inoltre che l'accumulazione prim<strong>it</strong>iva 2 in Italia era stata<br />
resa possibile proprio dal forte sfruttamento <strong>del</strong>le masse contadine da parte <strong>del</strong>la borghesia attraverso l'azione<br />
<strong>del</strong>lo Stato, sicché il fatto che il Risorgimento si fosse concluso senza una radicale riforma agraria era stato<br />
semmai una condizione essenziale per il successivo sviluppo cap<strong>it</strong>alistico <strong>del</strong>l'Italia. Da parte marxista si<br />
portarono vari argomenti contro la tesi di Romeo: fra l'altro, si fece notare che l'interpretazione gramsciana non<br />
era riducibile soltanto alla tesi <strong>del</strong>la «rivoluzione agraria mancata», e si aggiunse che l'accumulazione<br />
prim<strong>it</strong>ivaavrebbe potuto essere realizzata anche con una diversa struttura agraria, e che una <strong>del</strong>le condizioni<br />
fondamentali <strong>del</strong>lo sviluppo cap<strong>it</strong>alistico è l'esistenza di un mercato interno capace di assorbire l'offerta di<br />
prodotti industriali (cosa che, realizzandosi in Italia solo nei decenni successivi al Risorgimento, avrebbe<br />
determinato il r<strong>it</strong>ardo e il carattere terr<strong>it</strong>orialmente lim<strong>it</strong>ato <strong>del</strong>lo slancio industriale <strong>del</strong> paese).<br />
Oggi, al di là <strong>del</strong>le singole posizioni storiografiche, è ormai consolidata la collocazione <strong>del</strong><br />
Risorgimento, in quanto movimento per l'indipendenza e l'un<strong>it</strong>à nazionale, nel generale movimento<br />
europeo per l'emancipazione <strong>del</strong>le nazional<strong>it</strong>à, nato dal contraccolpo <strong>del</strong>la Rivoluzione francese (che<br />
direttamente o indirettamente galvanizzò ovunque il sentimento nazionale), alimentato dal Romanticismo<br />
e strettamente legato ai movimenti liberali e democratici che furono l'espressione pol<strong>it</strong>ica <strong>del</strong>le rivoluzioni<br />
borghesi nell'Europa continentale e al processo di sviluppo cap<strong>it</strong>alistico, dapprima agrario-mercantile e<br />
poi industriale, che maturò in Italia dopo l'un<strong>it</strong>à. Il legame con lo sviluppo generale europeo è quindi<br />
essenziale per la comprensione <strong>del</strong> Risorgimento, non meno <strong>del</strong> legame di questo con la precedente storia<br />
<strong>it</strong>aliana.<br />
Bibliografia<br />
Walter Maturi, <strong>Interpretazioni</strong> <strong>del</strong> Risorgimento. Lezioni di storia <strong>del</strong>la storiografia, Torino 1969.<br />
Antonio Gramsci, Il Risorgimento, Einaudi, Torino 1966.<br />
Rosario Romeo, Risorgimento e cap<strong>it</strong>alismo, Laterza, Bari 1970.<br />
Giorgio Can<strong>del</strong>oro, Storia <strong>del</strong>l'Italia moderna, Feltrinelli, Milano 1956 - (i sei volumetti dedicati al periodo<br />
1700-1896).<br />
Luigi Salvatorelli, Pensiero e azione <strong>del</strong> Risorgimento, Torino 1970.<br />
2 Espressione marxiana entrata nel lessico storiografico per indicare il processo di accumulazione di cap<strong>it</strong>ale<br />
necessario a finanziare il decollo di un'economia industriale.<br />
3