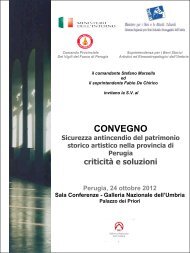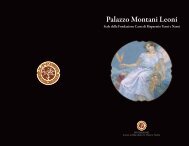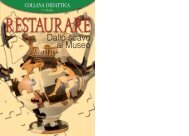Le stele di Bologna di V secolo a.C.: modelli iconografici tra Grecia ...
Le stele di Bologna di V secolo a.C.: modelli iconografici tra Grecia ...
Le stele di Bologna di V secolo a.C.: modelli iconografici tra Grecia ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
Elisabetta Govi<br />
<strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
<strong>Le</strong> <strong>stele</strong> felsinee in arenaria riccamente decorate a bassorilievo costituiscono l'espressione più compiuta<br />
e peculiare della <strong>Bologna</strong> etrusca del V <strong>secolo</strong> a.C. Il corpus, che annovera circa 200 esemplari, metà<br />
dei quali però molto frammentari, è stato a più riprese sottoposto a stu<strong>di</strong> che hanno affrontato l'analisi <strong>di</strong> alcuni<br />
aspetti specifici e <strong>di</strong> singole tematiche delle quali si sono indagati i <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> e culturali 1 . Negli<br />
anni più recenti il <strong>di</strong>battito scientifico ha focalizzato l'attenzione su un gruppo ristretto <strong>di</strong> esemplari, quelli più<br />
elaborati, che meglio si prestano ad un'analisi iconologica. <strong>Le</strong> posizioni maturate nell'ambito <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scussione<br />
proficua e stimolante sono piuttosto <strong>di</strong>vergenti e possono essere sintetizzate in una duplice lettura:<br />
una privilegia il valore altamente simbolico delle scene, finalizzate ad evocare lo status sociale del defunto,<br />
negando il riferimento, se non in forma molto me<strong>di</strong>ata, alla sfera della morte 2 ; l'al<strong>tra</strong> tende ad esaltare il significato<br />
funerario del complesso immaginario offerto dalle <strong>stele</strong>, pur non escludendo l'interpretazione delle<br />
scene anche in chiave sociale 3 . Rispetto a queste proposte <strong>di</strong> esegesi è sembrato necessario ed oltre modo<br />
opportuno affrontare lo stu<strong>di</strong>o complessivo e sistematico della classe, evitando aprioristiche selezioni qualitative<br />
e mirando alla comprensione <strong>di</strong> tutti gli elementi che compongono il monumento, dalle scene figurate<br />
alla decorazione accessoria senza <strong>tra</strong>lasciare l'aspetto morfologico, invece sempre <strong>tra</strong>scurato, nel tentativo<br />
<strong>di</strong> definire il sistema sotteso alla produzione. Pur nell’ innegabile <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cogliere i dettagli, talora illeggibili<br />
a causa della corrosione delle superfici, si è approdati ad una preliminare sistemazione organica del corpus<br />
che ne sottolinea la sostanziale coerenza e la logica compositiva interna. Il linguaggio figurativo delle<br />
<strong>stele</strong> infatti è risultato univoco e risponde ad un sistema coerente che coinvolge i <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> dell'espressione.<br />
Se gli schemi <strong>iconografici</strong> adottati sono numerosi a causa della varietà formale delle scene raramente<br />
reduplicate identiche, pochi al con<strong>tra</strong>rio sono i temi presenti nella classe, riflesso <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ficato sistema <strong>di</strong><br />
valori che qualifica il defunto in base al suo statuto civico e percepisce la morte come un passaggio ad un'al<strong>tra</strong><br />
<strong>di</strong>mensione, un <strong>tra</strong>nsito che assume caratteri <strong>di</strong>versi a seconda della categoria sociale del defunto, prioritariamente<br />
quella sessuale, e del suo personale credo religioso. Infatti uomini e donne sono <strong>di</strong>stinti <strong>di</strong> fronte<br />
alla morte e, come si vedrà, il linguaggio figurativo maschile appare maggiormente co<strong>di</strong>ficato ed ancorato ad<br />
una <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stampo aristocratico.<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista formale nella produzione delle <strong>stele</strong> si in<strong>di</strong>viduano due <strong>di</strong>stinti filoni che rispecchiano<br />
<strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> committenza sul piano sociale e <strong>di</strong>stinti mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> autorappresentazione: uno è quello<br />
più numeroso che comprende le <strong>stele</strong> piccole e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni con immagine del defunto a tutto campo<br />
<strong>Le</strong> foto delle <strong>stele</strong> sono state cortesemente fornite dal Museo Civico Archeologico, ove sono conservati ed esposti i monumenti. <strong>Le</strong><br />
tavole sono dell’autore.<br />
1 Per una breve rassegna degli stu<strong>di</strong> GOVI 2009; SASSATELLI, GOVI 2009.<br />
2 CERCHIAI 1995, 1999; BONAUDO 2002-2003.<br />
3 SASSATELLI, GOVI 2009.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
36
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
Figg. 1-2 – <strong>Bologna</strong>, museo Civico Archeologico, <strong>stele</strong> nn. 109 e 168b.<br />
(fig. 1); l'altro annovera le <strong>stele</strong> meglio note nella letteratura, assai più curate e con esiti monumentali, decorate<br />
con registri e con cornici a tema marino e fitomorfo (fig. 2). L'apparente <strong>di</strong>cotomia <strong>tra</strong> i due filoni, che saremmo<br />
tentati <strong>di</strong> definire l'uno modesto e l'altro d'élite non <strong>di</strong>menticando tuttavia che anche le <strong>stele</strong> più piccole<br />
costituiscono un segnacolo d'eccezione nel panorama generale delle sepolture bolognesi 4 , in realtà è fortemente<br />
attenuata da una serie <strong>di</strong> temi e <strong>di</strong> segni iconici, che risultano <strong>tra</strong>sversali offrendo la possibilità <strong>di</strong><br />
una lettura univoca della classe e prefigurando al contempo fenomeni <strong>di</strong> omologazione <strong>tra</strong> classi sociali <strong>di</strong>fferenti.<br />
Esemplificativo al riguardo è il caso dello schema iconografico della donna che si <strong>di</strong>rige verso la foglia<br />
d'edera presente, verosimilmente nello stesso periodo, sulla piccola <strong>stele</strong> n. 22 e sulla <strong>stele</strong> n. 12, una delle<br />
più elaborate e curate dell'intero corpus. Il gruppo delle <strong>stele</strong> più modeste <strong>di</strong> norma restituisce l'identità sociale<br />
al defunto (l'oplita, il cavaliere, il sacerdote, l'uomo adulto, la giovane donna, la domina, ecc.), ma su<br />
una trentina <strong>di</strong> esemplari l'anonimato <strong>di</strong> questo schema iconografico è <strong>tra</strong>sgre<strong>di</strong>to dalla comparsa <strong>di</strong> elementi<br />
che svelano l'adesione del defunto a particolari forme ideologiche, più spesso nel segno <strong>di</strong> Dioniso (fig. 3).<br />
Alla sfera <strong>di</strong>onisiaca rimandano le ghirlande, i <strong>tra</strong>lci e le foglie d'edera impugnate dal defunto o presenti nel<br />
campo figurativo e nelle cornici, <strong>di</strong> certo non come semplici riempitivi, come <strong>di</strong>mos<strong>tra</strong> l’ interscambiabilità <strong>tra</strong><br />
la foglia e il testone silenico 5 . L'elemento <strong>di</strong>onisiaco, epifania del <strong>di</strong>o, sbuca dalla cornice in<strong>di</strong>cando la meta<br />
verso la quale il defunto si <strong>di</strong>rige in atto <strong>di</strong> orante (fig. 4) compiendo un percorso iniziatico, forse garanzia <strong>di</strong><br />
salvezza ul<strong>tra</strong>terrena o, come vuole il Colonna, prefigurazione <strong>di</strong> un Al<strong>di</strong>là abitato da defunti-satiri 6 . Proprio<br />
l'analisi delle varianti ha consentito <strong>di</strong> sistemare le <strong>stele</strong> appartenenti al primo gruppo all'interno <strong>di</strong> una griglia<br />
(tav. 1) nella quale <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> espressione esplicitano via via in modo più chiaro l'assunto ideologico del<br />
4 <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> in arenaria segnalavano meno del 10% delle sepolture, cf. SASSATELLI 1988.<br />
5 GOVI 2009.<br />
6 COLONNA 2002.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
37
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
Figg. 3-4 – <strong>Bologna</strong>, museo Civico Archeologico, <strong>stele</strong> nn. 174 e 111.<br />
Tav. 1 – Stele con figura a tutto campo.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
38
Fig. 5 – <strong>Bologna</strong>, museo Civico Archeologico, <strong>stele</strong> n. 164.<br />
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
committente: dal grado zero, per così <strong>di</strong>re, rappresentato<br />
da figure prive <strong>di</strong> ogni riferimento simbolico, alla comparsa<br />
<strong>di</strong> elementi <strong>di</strong>onisiaci e del richiamo al mare all'interno<br />
delle cornici, alla presenza <strong>di</strong> animali liminari coi quali il<br />
defunto talvolta si scon<strong>tra</strong>. Purtroppo ogni tentativo <strong>di</strong> valutare<br />
<strong>di</strong>acronicamente questa gamma <strong>di</strong> espressione è<br />
inficiato dalla datazione approssimativa, e il più delle volte<br />
basata su considerazioni <strong>di</strong> natura stilistica, che si può<br />
assegnare a ciascun esemplare. Il sistema <strong>di</strong> autorappresentazione<br />
che domina questo nutrito gruppo <strong>di</strong> monumenti<br />
è dunque fondato principalmente sull'articolazione<br />
sociale, ma la morte spesso è sentita e visualizzata<br />
come esperienza che mo<strong>di</strong>fica la con<strong>di</strong>zione umana<br />
e conduce verso un'al<strong>tra</strong> <strong>di</strong>mensione, sovente <strong>di</strong><br />
natura <strong>di</strong>onisiaca. Ed è proprio il processo <strong>di</strong> mutamento<br />
generato dalla morte me<strong>di</strong>ante il percorso compiuto per<br />
raggiungere l'al<strong>di</strong>là il vero filo rosso che, al <strong>di</strong> là delle <strong>di</strong>versità<br />
<strong>di</strong> redazione, unifica l'intera produzione delle <strong>stele</strong><br />
e che all'interno del secondo filone <strong>di</strong> monumenti, quello<br />
più curato e monumentale, si esplicita secondo modalità<br />
certamente più articolate ma pur sempre coerenti rispetto<br />
ai co<strong>di</strong>ci espressivi in<strong>di</strong>viduati nel gruppo più modesto. Il<br />
tema del viaggio su carro, com’ è noto, con<strong>tra</strong>d<strong>di</strong>stingue<br />
questi monumenti sui quali ha una voluta ambiguità seman-<br />
Tav. 2 – Stele con il tema del viaggio su carro.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
39
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
tica: indubbiamente enfatizza la con<strong>di</strong>zione sociale<br />
elevata del defunto evocando l'immagine <strong>di</strong><br />
antica <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione aristocratica del trionfo nel caso<br />
dell'uomo e della processione nuziale nel caso<br />
della donna 7 (fig. 5), tuttavia il tema sulle <strong>stele</strong> si<br />
carica <strong>di</strong> ulteriori e ben più pregnanti significati,<br />
esplicitati da una serie <strong>di</strong> segni iconici che ne<br />
chiariscono la percezione anche in chiave funeraria<br />
e talora escatologica. Non occorre qui soffermarsi<br />
su tali elementi (demoni psicopompi, cavalli<br />
alati, Caronti e altro) già noti ed in al<strong>tra</strong> sede<br />
meglio esaminati 8 , mentre sembra utile sottolineare<br />
che se si esaminano le 45 redazioni del<br />
viaggio su carro si coglie un articolato sistema <strong>di</strong><br />
schemi <strong>iconografici</strong> (tav. 2) che presuppone una<br />
scala <strong>di</strong> valori non solo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sociale ma<br />
anche ideologico la quale, nel rispetto della primaria<br />
<strong>di</strong>stinzione operata per sessi, rivela i <strong>di</strong>versi<br />
livelli <strong>di</strong> percezione in<strong>di</strong>viduale della morte intesa<br />
come <strong>tra</strong>nsito verso l'al<strong>di</strong>là: dal semplice viaggio<br />
reso senza espliciti riferimenti funerari, al <strong>tra</strong>nsito<br />
assistito da esseri oltremondani, al viaggio metafora<br />
<strong>di</strong> eroizzazione e apoteosi esplicitato dai cavalli<br />
alati, al passaggio verso una <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong>onisiaca<br />
prefigurata dalle <strong>di</strong>verse epifanie del <strong>di</strong>o.<br />
Il modello iconografico funzionale all'elaborazione<br />
<strong>di</strong> questo tema sulle <strong>stele</strong> può essere<br />
ravvisato più che nella <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione figurativa arcaica<br />
etrusca, che pure nella seconda metà del V<br />
<strong>secolo</strong> poteva essere recuperata dall'élite citta<strong>di</strong>na,<br />
nelle scene <strong>di</strong> viaggio su carro, <strong>di</strong> frequente<br />
guidato da cavalli alati, che proprio nel corso del<br />
V <strong>secolo</strong> si <strong>di</strong>ffondono sulla ceramica attica 9 e agli<br />
inizi del <strong>secolo</strong> successivo su quella apula. I protagonisti<br />
<strong>di</strong> questi viaggi celesti, spesso con-<br />
testualizzati dal riferimento al mare e scortati dalla figura <strong>di</strong> Hermes o <strong>di</strong> Nike, sono Nyx, le personificazioni<br />
degli Astri 10 (Selene, Helios) (figg. 6-7), Nike 11 e soprattutto Eos 12 (fig. 8), ma lo schema iconografico è adottato<br />
significativamente anche per l'apoteosi <strong>di</strong> Herakles 13 (fig. 9). Pare quin<strong>di</strong> indubbio che la matrice del linguaggio<br />
figurativo adottato dagli scalpellini bolognesi per il tema del viaggio su carro sia proprio quell'immaginario<br />
greco, veicolato dalla ceramica attica, che come vedremo <strong>tra</strong> breve si prestava assai bene a rendere<br />
l'ideologia funeraria dei committenti posti ai vertici della comunità citta<strong>di</strong>na. Per meglio comprendere il valore<br />
semantico <strong>di</strong> questo tema e l'eventuale processo <strong>di</strong> rifunzionalizzazione in chiave funeraria è necessario va-<br />
7<br />
CERCHIAI 1995, 377; MAGGIANI 2003, 164-165.<br />
8<br />
SASSATELLI, GOVI 2009.<br />
9<br />
MAGGIANI 2003, 167.<br />
10<br />
KARUSU, in LIMC II, 1984, s.v. As<strong>tra</strong>, 904-27, in particolare 907-909 e 912-917.<br />
11<br />
CVA Baltimore 1, 17, fig. 5.1, pl. 21, 1-4.<br />
12<br />
WEISS, in LIMC III, 1986, s.v. Eos, 747-89, in particolare 753-757.<br />
13<br />
BOARDMAN, in LIMC V, 1990, s.v. Herakles, 126-132.<br />
Fig. 6 – Atene, Museo Nazionale, cratere attico a.f.r., inizi del IV <strong>secolo</strong><br />
a.C. (da LIMC II, s.v. As<strong>tra</strong>, 676 n. 40).<br />
Fig. 7 – Detroit, Institute of Arts, cratere attico a. f.r., attorno al 480<br />
a.C. (da LIMCV s.v. 632 Helios, n. 14).<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
40
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
Fig. 8 – Roma, Villa Giulia, cratere falisco a f.r. da Civita Castellana, 380-360 a.C. (da LIMC III, s.v. Thesan, 584 n. 22).<br />
lutarne le associazioni con le altre scene<br />
raffigurate sulle <strong>stele</strong>. L’analisi condotta<br />
sull’intero corpus dei monumenti evidenzia<br />
una logica combinatoria abbastanza fissa e<br />
<strong>di</strong>stinta per sessi 14 , che per la componente<br />
maschile esalta soprattutto la funzione civica<br />
del defunto cui spetta la "bella morte" in<br />
guerra, talora garanzia <strong>di</strong> un destino <strong>di</strong> eroizzazione:<br />
sulle <strong>stele</strong> a più registri pertinenti<br />
a uomini infatti il tema del viaggio su<br />
carro, sempre collocato in alto, è spesso<br />
anticipato visivamente e concettualmente<br />
da scontri armati, un vero e proprio elogium<br />
che prefigura il trionfo esplicitato dai cavalli<br />
alati 15 ; più <strong>di</strong> rado al <strong>di</strong> sotto del viaggio si<br />
trovano agoni atletici e onorificenze tributa-<br />
te a defunti speciali. L'universo femminile è invece meno co<strong>di</strong>ficato ed il viaggio su carro è connotato in senso<br />
<strong>di</strong>onisiaco dalla presenza <strong>di</strong> fronte ai cavalli <strong>di</strong> un'epifania del <strong>di</strong>o (testone silenico o foglia d'edera) e sovente<br />
è scortato da demoni (fig. 10). Sulle <strong>stele</strong> femminili a più registri inoltre il tema si combina con scene<br />
riferibili a momenti <strong>di</strong>versi del viaggio verso l'Al<strong>di</strong>là (la guida <strong>di</strong> un demone (fig. 5); la lotta fra mostri). Ne scaturisce<br />
dunque la possibilità <strong>di</strong> adottare una lettura verticale dei monumenti, sottesa da una sequenza logica<br />
delle scene. In <strong>di</strong>versi casi la logica che regola le associazioni dei registri è ravvisabile nel percorso verso<br />
l'Ade articolato per tappe, un tema <strong>di</strong> recente sviscerato dalla critica con esiti del tutto convincenti che gettano<br />
nuova luce sull'ideologia funeraria etrusca maturata <strong>tra</strong> la fine del VI e il V <strong>secolo</strong> 16 . Non stupisce pertanto<br />
trovare sulle <strong>stele</strong> felsinee una gamma <strong>di</strong> scene, in al<strong>tra</strong> sede meglio esaminate 17 , che si riferiscono all'inizio<br />
del viaggio 18 (fig. 11), alle tappe interme<strong>di</strong>e che comportano il superamento del <strong>di</strong>stretto infernale popo-<br />
14 SASSATELLI, GOVI 2009.<br />
15<br />
MAGGIANI 2003.<br />
16<br />
BONAMICI 2005, 2006; RONCALLI 1997, 2001. Per le ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> questa visione dell'Al<strong>di</strong>là cf. TORELLI 2002.<br />
17<br />
SASSATELLI, GOVI 2009.<br />
18<br />
Stele nn. 28, 69, 116, 169, E (commiato); nn. 43 (riquadri dello spessore), 84a, 106, 168a, B, H, S. Michele in Bosco (prelevamento<br />
da parte <strong>di</strong> un demone).<br />
Fig. 9 – Ferrara, Museo Nazionale, cratere attico a f.r. da Spina Valle Pega,<br />
tomba 376B, 400-380 a.C. (da LIMC V, s.v. Herakles, 121 n. 2923).<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
41
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
Figg. 10-11 – <strong>Bologna</strong>, Museo Civico Archeologico,<br />
<strong>stele</strong> G e H del Polisportivo.<br />
lato <strong>di</strong> mostri 19 (fig. 12) o il passaggio <strong>di</strong> mano <strong>di</strong> demoni<br />
psicopompi 20 (fig. 13), fino alla scena del viaggio su cavalli<br />
alati, evocativa <strong>di</strong> un destino speciale riservato solo a pochi defunti. In quest’ ottica la <strong>di</strong>visione in registri delle<br />
<strong>stele</strong> appare un espe<strong>di</strong>ente teso a rendere nello spazio ristretto del monumento i <strong>di</strong>versi frammenti <strong>di</strong> un<br />
percorso ideologico incen<strong>tra</strong>to sul tema del viaggio verso l'Ade articolato per tappe. La <strong>di</strong>visione in registri<br />
infatti si impone all'interno della classe in concomitanza con la <strong>di</strong>ffusione del tema del viaggio su carro e del<br />
motivo delle onde marine sulle cornici e si coniuga con la co<strong>di</strong>fica della forma cosiddetta a ferro <strong>di</strong> cavallo 21 .<br />
É dunque evidente come forma del monumento, partizione zonale e decorazione accessoria siano elementi<br />
strettamente correlati <strong>tra</strong> loro che concorrono ad esplicitare in maniera coerente un preciso assunto ideologico,<br />
che può essere in<strong>di</strong>viduato soltanto nel viaggio verso l'Al<strong>di</strong>là. Ad esso si riferiscono anche le cornici<br />
che, con il richiamo al mare 22 o al co<strong>di</strong>ce arboreo <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>onisiaca 23 , creano un <strong>di</strong>aframma fisico <strong>tra</strong> il<br />
mondo dei vivi e quello dei morti contribuendo a collocare l'esperienza visualizzata sulla <strong>stele</strong> in un contesto<br />
liminale ed in una precisa <strong>di</strong>mensione ontologica. Ma forse anche la forma del monumento a "ferro <strong>di</strong> cavallo",<br />
così peculiare da non avere confronti, può ricevere una spiegazione coerente con il tema del <strong>tra</strong>nsito verso<br />
la morte, se si recupera la <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione <strong>di</strong> collocare all'interno delle tombe la porta arcuata che, come è noto,<br />
costituisce un <strong>di</strong>aframma carico <strong>di</strong> significati in chiave funeraria 24 . La <strong>stele</strong>, affossata nel terreno, si configurerebbe<br />
come un simbolico varco verso una <strong>di</strong>mensione ul<strong>tra</strong>terrena variamente visualizzata sul monumento<br />
stesso, quasi a voler richiamare l'idea <strong>di</strong> un <strong>tra</strong>nsito at<strong>tra</strong>verso il luogo liminale, quale è la tomba a ca-<br />
19<br />
Stele nn. 130, 188.<br />
20<br />
Stele nn. 76, 105.<br />
21<br />
GOVI, SASSATELLI 2004.<br />
22<br />
PIZZIRANI 2005.<br />
23<br />
GOVI 2009.<br />
24<br />
Sul valore simbolico della porta TORELLI 1997; per la ricorrenza della porta arcuata nella tarda iconografia funeraria SCHEFFER 1994.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
42
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
Figg. 12-13 – <strong>Bologna</strong>, Museo Civico Archeologico, <strong>stele</strong> nn. 130 e 76.<br />
mera in Etruria tirrenica 25 , che qui non poteva essere costruita.<br />
Dunque il tema del viaggio dopo la morte, l'unico che unifica l'intera produzione, è visualizzato con<br />
schemi <strong>di</strong>versi a seconda delle scelte in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> una committenza articolata sul piano sociale: per taluni è<br />
un viaggio che presuppone alcune tappe e comporta il superamento <strong>di</strong> prove o l'ausilio <strong>di</strong> figure demoniache,<br />
per altri è un percorso iniziatico che porta a un mutamento verso una natura <strong>di</strong>onisiaca, e per pochi eletti è<br />
sentito come un <strong>tra</strong>nsito verso un destino <strong>di</strong> eroizzazione e <strong>di</strong> beatitu<strong>di</strong>ne, una rinascita che significativamente<br />
sul piano formale si rifà alla risalita celeste degli astri e <strong>di</strong> Eos o all'apoteosi <strong>di</strong> Herakles.<br />
Se le <strong>stele</strong> più complesse e curate possono essere sottoposte senza <strong>di</strong>fficoltà a questa proposta <strong>di</strong><br />
lettura, risulta obiettivamente più <strong>di</strong>fficile farvi rien<strong>tra</strong>re anche quelle, comprese nel filone più modesto, che<br />
non mos<strong>tra</strong>no alcuna esplicita allusione al tema del viaggio e che abbiamo riconosciuto come "grado zero"<br />
nella scala <strong>di</strong> espressione ideologica. Ma pur avendo ben presente il rischio <strong>di</strong> cadere in letture omologanti<br />
che schiacciano la complessa e variegata realtà figurativa delle <strong>stele</strong> su una preconcetta piattaforma ideologica,<br />
a ben vedere anche lo schema della semplice figura a tutto campo, che come abbiamo visto rende l'identità<br />
civica del defunto, prevede sempre la posa gra<strong>di</strong>ente e con<strong>di</strong>vide con i monumenti più complessi la<br />
forma a "ferro <strong>di</strong> cavallo". Se l'interpretazione <strong>di</strong> quest'ultima come varco dell'Al<strong>di</strong>là ha qualche fondamento,<br />
non è escluso che anche queste piccole e anonime <strong>stele</strong> inserite in un sistema co<strong>di</strong>ficato sul piano semantico,<br />
percepibile nella sua coerenza anche grazie alla vicinanza topografica con i monumenti più elaborati, potessero<br />
veicolare il tema della morte sentita come un <strong>tra</strong>nsito, un ineluttabile viaggio che all'interno della<br />
classe delle <strong>stele</strong> assume caratteri e connotazioni assai <strong>di</strong>fferenti a seconda delle categorie sociali, del ruolo<br />
civico del defunto e del suo personale credo religioso.<br />
Se l'analisi iconologica condotta ha qualche fondamento ne scaturisce una significativa coerenza,<br />
che per la prima volta interessa tutti gli elementi formali e figurativi della produzione, evidenziando una logica<br />
compositiva interna alla classe. Sulle <strong>stele</strong> sono dunque raffigurati frammenti <strong>di</strong> un percorso ideologico che solo<br />
25 TORELLI 1997, 2002.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
43
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
nelle coeve tombe <strong>di</strong>pinte trova una redazione più<br />
compiuta, come mos<strong>tra</strong> ad es. la Tomba dei Demoni Azzurri<br />
26 .<br />
Questa proposta <strong>di</strong> lettura necessita però <strong>di</strong><br />
essere ulteriormente sostanziata me<strong>di</strong>ante il confronto<br />
con l'universo ideologico esplicitato all'interno dei corre<strong>di</strong><br />
felsinei coevi. Purtroppo non è possibile aggiungere<br />
alcunché al tentativo già fatto <strong>di</strong> ricollegare le <strong>stele</strong> ai<br />
contesti funerari 27 , peraltro quasi sempre violati in antico,<br />
e questa lacuna inficia anche la possibilità <strong>di</strong> ancorare<br />
tutti i monumenti ad una griglia cronologica precisa. Il<br />
ricco patrimonio iconografico offerto dalla ceramica attica<br />
rinvenuta nelle tombe costituisce allora l'ideale campo <strong>di</strong><br />
indagine per cogliere la corrispondenza <strong>tra</strong> l'immaginario<br />
delle <strong>stele</strong> e l'ideologia funeraria che regola la composizione<br />
del corredo e la selezione dei vasi importati.<br />
Certamente predominano le variegate e polisemantiche<br />
iconografie <strong>di</strong> stampo <strong>di</strong>onisiaco 28 , che in taluni casi<br />
trovano una significativa equivalenza sulle <strong>stele</strong> (figg. 4 e<br />
14). Ma nelle tombe felsinee <strong>di</strong> pieno V <strong>secolo</strong> non stupisce<br />
trovare anche quegli stessi temi riconosciuti come<br />
fonte iconografica per gli scalpellini bolognesi, ovvero il<br />
viaggio su carro <strong>di</strong> Eos (fig. 15) e l'apoteosi <strong>di</strong> Herakles<br />
(fig. 16). Il primo è attestato da tre vasi attici recuperati nei<br />
sepolcreti Arnoal<strong>di</strong> e De Luca 29 , ma nelle tombe felsinee<br />
la dea compare anche nel più noto schema iconografico<br />
con Kephalos 30 . Discusso il significato <strong>di</strong> queste scene <strong>di</strong><br />
viaggio/rapimento che vedono protagonista Eos, ma la eloquente<br />
contestualizzazione dell'evento, ai margini delle<br />
terre abitate circoscritte da Oceano cui si riferiscono le<br />
onde e gli animali marini, e la natura stessa della dea alata<br />
che quoti<strong>di</strong>anamente sconfigge il buio della notte riportando<br />
la luce, sembrano orientare l'interpretazione verso<br />
una valenza escatologica 31 . La notevole popolarità che<br />
questa figura <strong>di</strong>vina ha nel mondo greco ed in Etruria durante<br />
il V <strong>secolo</strong>, specie nella versione del ratto amoroso,<br />
tuttavia è sottoposta da qualche stu<strong>di</strong>oso ad una lettura<br />
più laica che è ricollegata alla metafora del repentino<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
44<br />
Fig. 14 – <strong>Bologna</strong>, Kylix a f.r.<br />
della tomba 26 <strong>di</strong> Casalecchio <strong>di</strong> Reno,<br />
(da ORTALLI 2002, 88, fig. 19).<br />
Fig. 15 – Cratere attico a f.r.<br />
dalla tomba 152 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong><br />
(da MACELLARI 2002, 243, fig. 233).<br />
26<br />
All'interno della tomba dei Demoni Azzurri il percorso verso il banchetto, prefigurazione dell'eterna beatitu<strong>di</strong>ne e dell'integrazione nel<br />
mondo <strong>di</strong> Dioniso, è reso in modo <strong>di</strong>fferente per l'uomo e per la donna secondo un sistema <strong>di</strong> valori che si ritrova identico sulle <strong>stele</strong><br />
felsinee. TORELLI 2002, 58-59; ADINOLFI ET AL. 2005.<br />
27<br />
SASSATELLI 1989.<br />
28<br />
Si veda il contributo <strong>di</strong> PIZZIRANI in questi stessi Atti.<br />
29<br />
Tombe 132 e 152 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong>, en<strong>tra</strong>mbe femminili e databili <strong>tra</strong> il 450 e il 425 a.C. (MACELLARI 2002, 317-18 n. 2; 368-9 n.<br />
1); tomba II del sepolcreto De Luca (PELLEGRINI 1912, n. 243)<br />
30<br />
Tomba 56 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong> (MACELLARI 2002, 114 n. 1); tomba 85 del sepolcreto De Luca; tomba non precisabile del<br />
sepolcreto dei Giar<strong>di</strong>ni Margherita; provenienza sconosciuta (per tutti PELLEGRINI 1912, nn. 204, 262, 295).<br />
31<br />
CHIRASSI COLOMBO 1973, 26-28; DE LA GENIÈRE 1979; BOTTINI 1990; BOTTINI 1992, 106-115; CALDERONE 2003, ove si sottolinea il<br />
valore della metafora <strong>di</strong> una nuova vita dopo la morte, un tema che ha larga fortuna durante il V <strong>secolo</strong> in concomitanza con la<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> religiosità <strong>di</strong> stampo salvifico.
cambiamento della con<strong>di</strong>zione umana che si<br />
raggiunge in vita con il matrimonio 32 , o alla volontà<br />
<strong>di</strong> propagandare in occidente un certo clima<br />
politico ateniese 33 . Ben più perspicuo il messaggio<br />
veicolato dalla scena dell'apoteosi <strong>di</strong> Herakles,<br />
<strong>tra</strong> l'altro presente a <strong>Bologna</strong> 34 nella rara<br />
versione che vede il carro sorvolare il mare 35 e<br />
che coinvolge Hermes come guida. I contesti<br />
tombali che hanno restituito questi vasi si<br />
<strong>di</strong>stinguono per ricchezza del corredo, posizione<br />
enfatica presso la s<strong>tra</strong>da sepolcrale e struttura<br />
della tomba; al loro interno il vaso in questione<br />
spesso riveste un ruolo primario, come nel caso<br />
del cratere con l'apoteosi <strong>di</strong> Herakles della tomba<br />
a cremazione 75 Arnoal<strong>di</strong> che fungeva da<br />
cinerario. Vale la pena qui solo richiamare la<br />
s<strong>tra</strong>or<strong>di</strong>naria coerenza <strong>di</strong> questa tomba nella<br />
quale rituale funerario e iconografia del cinerario<br />
insistono sul motivo del <strong>di</strong>sfacimento del corpo<br />
sul fuoco, prelu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un ringiovanimento per<br />
Herakles che sale nell'Olimpo 36 .<br />
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
Fig. 16 – Cratere attico a f.r. dalla tomba 75 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong><br />
(da MACELLARI 2002, 101, tav. 91).<br />
Significativamente la tomba 75, databile agli inizi del IV <strong>secolo</strong> a.C. si colloca accanto alla tomba 78, più antica<br />
<strong>di</strong> almeno mezzo <strong>secolo</strong>, che ha restituito il noto cratere con l'introduzione <strong>di</strong> Herakles nell'Olimpo 37 , rivelando<br />
quin<strong>di</strong> un legame forse familiare e certamente ideologico. Lo stesso legame ideologico unisce queste<br />
due tombe 75 e 78 al vicino gruppo delle tombe più antiche 80, 85, 96b che hanno restituito vasi con Herakles<br />
38 . Ciò conferma il grado <strong>di</strong> ricezione dell'élite citta<strong>di</strong>na che, <strong>tra</strong> fine VI e pieno V <strong>secolo</strong>, elabora un'ideologia<br />
funeraria fondata sul concetto del viaggio dopo la morte verso la beatitu<strong>di</strong>ne eterna e la eroizzazione<br />
del defunto. Lo stesso fenomeno <strong>di</strong> rifunzionalizzazione in chiave funeraria <strong>di</strong> questo tema è presente a<br />
Spina nella tomba 376B <strong>di</strong> Valle Pega, databile agli inizi del IV sec. a.C., con ben tre crateri (fig. 9) che esibiscono<br />
l'apoteosi <strong>di</strong> Herakles su carro 39 . Ma anche altri temi presenti sui vasi attici delle tombe bolognesi<br />
vanno nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una prospettiva soteriologica e sono tutti quelli che esibiscono il motivo del rapimento<br />
<strong>di</strong> una giovane da parte della <strong>di</strong>vinità 40 o quelli che si incen<strong>tra</strong>no sulla figura <strong>di</strong> Kore 41 , molti dei quali signi-<br />
32<br />
CONTI 1998, ma la stu<strong>di</strong>osa non esclude che alla fine del V <strong>secolo</strong> il mito del rapimento <strong>di</strong> un giovane da parte della <strong>di</strong>vinità possa<br />
assumere una valenza metaforica della morte. Propende per un significato connesso al matrimonio e al timore che i mortali devono<br />
avere degli dei SOURVINOU-INWOOD 1987, 51. Nega un valore funerario privilegiando invece la lettura che esalta il potere <strong>di</strong>vino <strong>di</strong> fronte<br />
al quale nulla può il mortale LEFKOWITZ 2002.<br />
33<br />
GIUDICE 1999, 273-276.<br />
34<br />
Cratere a colonnette del Pittore <strong>di</strong> Upsala dalla tomba 75 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong> (VOLLKOMMER 1988, 33 n. 228; MACELLARI 2002,<br />
153 n. 1; KATHARIOU 2002, 277, UPS 9).<br />
35<br />
Un altro cratere del Pittore <strong>di</strong> Upsala da collezione esibisce lo stesso tema con analoga ambientazione marina al <strong>di</strong> sotto del carro<br />
(LIMC V, s.v. Herakles, 129-30 n. 2924). La rarità <strong>di</strong> questo schema iconografico, che pone il carro <strong>di</strong> Herakles sulle onde <strong>di</strong> Oceano,<br />
potrebbe suggerire una contaminazione con il tema del viaggio celeste <strong>di</strong> Eos e <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>vinità as<strong>tra</strong>li.<br />
36<br />
VOLLKOMMER 1988, 32-37; LAURENS-LISSARRAGUE 1989; BOARDMAN in LIMC V, 1990, s.v. Herakles, 121-122; KATHARIOU 2002, 203-<br />
4; BRINKMANN 2003.<br />
37<br />
MACELLARI 2002, 160-161.<br />
38<br />
Su queste tombe si veda anche il contributo <strong>di</strong> BRIZZOLARA, BALDONI in questi stessi Atti. Un altro vaso con apoteosi <strong>di</strong> Herakles<br />
proviene dalla tomba 6 del sepolcreto Aureli (RICCIONI 1952-1953, 252 n. 7).<br />
39<br />
BOARDMAN in LIMC V, s.v. Herakles, 129 n. 2923.<br />
40<br />
Zeus rapisce una fanciulla: tombe 56 e 79 del sepolcreto della Certosa; Hermes rapisce una fanciulla: tombe 119 e forse 253 del<br />
sepolcreto della Certosa, tomba 129 del sepolcreto Arnoal<strong>di</strong> e tomba 46 del sepolcreto De Luca; Boreas rapisce Oreithyia: tomba 76 del<br />
sepolcreto De Luca. Per tutti si veda PELLEGRINI 1912.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
45
E. Govi - <strong>Le</strong> <strong>stele</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V sec. a.C.: <strong>modelli</strong> <strong>iconografici</strong> <strong>tra</strong> <strong>Grecia</strong> ed Etruria<br />
ficativamente fungono da cinerari. L'analisi dei contesti, molti dei quali riferibili a donne, evidenzia anche in<br />
questi casi la pregnanza semantica che questi vasi <strong>tra</strong>smettono, a riprova della coerenza <strong>di</strong> fondo che pervade<br />
l'ideologia funeraria della <strong>Bologna</strong> <strong>di</strong> V <strong>secolo</strong>.<br />
In conclusione l'immaginario delle <strong>stele</strong> felsinee, se sottoposto alla lettura qui proposta, risulta incen<strong>tra</strong>to<br />
sul delicato tema del <strong>tra</strong>nsito verso l'al<strong>di</strong>là e del mutamento subito me<strong>di</strong>ante questo percorso in una<br />
gradualità <strong>di</strong> espressione riflesso <strong>di</strong> un'articolazione sociale complessa, che <strong>di</strong>stingue le categorie co<strong>di</strong>ficate<br />
sul piano civico, salvo talora unificarle in una comune prospettiva soteriologica.<br />
Bibliografia<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
46<br />
Elisabetta Govi<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Archeologia<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong><br />
Italia<br />
E-mail: elisabetta.govi@unibo.it<br />
ADINOLFI G, CARMAGNOLA R., CATALDI M., 2005. La tomba dei Demoni Azzurri: le pitture. In F. GILOTTA (a cura<br />
<strong>di</strong>), Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso <strong>tra</strong> Etruria e Campania. Atti della Giornata <strong>di</strong><br />
Stu<strong>di</strong>o (28 maggio 2003), 45-72.<br />
BONAMICI M., 2005. Scene <strong>di</strong> viaggio all'al<strong>di</strong>là nella ceramografia chiusina. In F. GILOTTA (a cura <strong>di</strong>), Pittura<br />
parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso <strong>tra</strong> Etruria e Campania. Atti della giornata <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (28<br />
maggio 2003), 33-44.<br />
BONAMICI M., 2006. Dalla vita alla morte <strong>tra</strong> Vanth e Turms Aita. In B. ADEMBRI (a cura <strong>di</strong>), Aei mnestos. Miscellanea<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> per Mauro Cristofani, 522-538.<br />
BONAUDO R., 2002-2003. Trasmissioni iconografiche e costruzioni immaginarie. Riformulazione <strong>di</strong> <strong>modelli</strong> attici<br />
su alcune <strong>stele</strong> felsinee. AION(archeol), IX-X, 103-113.<br />
BOTTINI A., 1990. Il candelabro etrusco <strong>di</strong> Ruvo del Monte. BA, 59, 1-14.<br />
BOTTINI A., 1992. Archeologia della salvezza.<br />
BRINKMANN V., 2003. Der Tod des Helden auf dem Scheiterhaufen und seine Himmelfahrt zu den Göttern. In<br />
Herakles Hercules (Catalogo della mos<strong>tra</strong>), 283-286.<br />
CALDERONE A., 2003. Eos rapitrice e le arule <strong>di</strong> Gela. In G. FIORENTINI, M. CALTABIANO, A.CALDERONE (a cura<br />
<strong>di</strong>), Archeologia del Me<strong>di</strong>terraneo. Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Ernesto De Miro, 121-130.<br />
CERCHIAI L., 1995. Daimones e Caronte sulle <strong>stele</strong> felsinee. In Caronte. Un obolo per l'Al<strong>di</strong>là. Atti del Convegno<br />
(20-22 febbraio 1994). PP, L, 376-394.<br />
CERCHIAI L., 1999. La rappresentazione <strong>di</strong> Teseo sulle <strong>stele</strong> felsinee. In <strong>Le</strong> mythe grec dans l'Italie antique.<br />
Fonction et image. Actes du Colloque (14-16 novembre 1996), 353-365.<br />
CHIRASSI COLOMBO, I. 1973. La salvezza nell'al<strong>di</strong>là nella cultura greca arcaica. StudClas: 23-39.<br />
COLONNA G., 2002. Celti e celtomachie nell'arte etrusca. In La battaglia del Sentino. Scontro <strong>tra</strong> nazioni e incontro<br />
in una nazione. Atti del Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> (10-13 giugno 1998), 163-187.<br />
CONTI M.C., 1998. Il mito <strong>di</strong> Eos e Kephalos in un pinax da Selinunte. Bollettino <strong>di</strong> Archeologia, 51-52, 33-48.<br />
DE LA GENIÈRE J., 1979. Un faux authentique du Musée du Louvre. In A. CAMPITOUGLOU (a cura <strong>di</strong>), Stu<strong>di</strong>es<br />
in honour of Arthur Dale Trendall, 75-80.<br />
41 Tombe 192 e 365 del sepolcreto Certosa (PELLEGRINI 1912, nn. 30 e 254) e tomba XIII del sepolcreto DeLuca (PELLEGRINI 1912, n.<br />
236).
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008<br />
Session: Testo, immagine, comunicazione: immagine come linguaggio<br />
GIUDICE F., 1999. Il viaggio delle immagini dall'Attica verso l'Occidente ed il fenomeno del rapporto <strong>tra</strong> "pro<strong>di</strong>gi"<br />
e "fortuna iconografica". In F.H. MASSA-PAIRAULT (a cura <strong>di</strong>), <strong>Le</strong> mythe grec dans l'Italie antique.<br />
Fonction et image. Actes du colloque international (14-16 novembre 1996), 267-327.<br />
GOVI E., 2009. Aspetti oscuri del rituale funerario nelle <strong>stele</strong> felsinee. In S. BRUNI (a cura <strong>di</strong>), Etruria e Italia<br />
preromana. Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> G. Camporeale. Pisa e Roma, 455-463.<br />
GOVI E., SASSATELLI G., 2004. Ceramica attica e <strong>stele</strong> felsinee. In I greci in Adriatico, 2. Hesperìa. Stu<strong>di</strong> sulla<br />
Grecità d'Occidente, 18, 227-265.<br />
KATHARIOU K., 2002. The workshop of the Meleager Painter and his era: Remarks on the attic pottery of the<br />
first quarter of the fourth century BC.<br />
LAURENS A.-F. e LISSARRAGUE F., 1989. <strong>Le</strong> bûcher d’Héraclès: l’empreinte du <strong>di</strong>eu. In A.-F. LAURENS (a cura<br />
<strong>di</strong>), Entre hommes et <strong>di</strong>eux. <strong>Le</strong> convive, le héros, le prophète. Annales littéraires de l'Université de<br />
Besançon. Lire les polythéismes, 2, 81-97.<br />
LEFKOWITZ M.R., 2002. "Predatory" Goddesses. Hesperia, 71.4, 325-344.<br />
MACELLARI R., 2002. Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoal<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> (550-350 a.C.).<br />
ORTALLI J., 2002. La "rivoluzione" felsinea: nuove prospettive dagli scavi <strong>di</strong> Casalecchio <strong>di</strong> Reno. Padusa,<br />
38, 57-90.<br />
PELLEGRINI G., 1912. Catalogo dei vasi greci <strong>di</strong>pinti delle necropoli felsinee.<br />
PIZZIRANI C., 2005. Da O<strong>di</strong>sseo alle Nerei<strong>di</strong>. Riflessioni sull'iconografia etrusca del mare at<strong>tra</strong>verso i secoli.<br />
Ocnus. Quaderni della Scuola <strong>di</strong> Specializzazione in Archeologia, 13, 251-270.<br />
RICCIONI G., 1952-1953. Il sepolcreto felsineo Aureli. SE, XXII, 233-285.<br />
RONCALLI F., 1997. Iconographie funéraire et topographie de l'au-delà en Étrurie. In F. GAULTIER, D. BRIQUEL<br />
(a cura <strong>di</strong>), <strong>Le</strong>s Étrusques, les plus religieux des hommes. Actes du Colloque international (1992), 37-<br />
54.<br />
RONCALLI F., 2001. Spazio reale e luogo simbolico: alcune soluzioni nell'arte funeraria etrusca. ActaHyp, VIII,<br />
249-272.<br />
SASSATELLI G., 1988. Topografia e "sistemazione monumentale" delle necropoli felsinee. In La formazione<br />
della città preromana in Emilia Romagna: Atti del Convegno (7-8 <strong>di</strong>cembre 1985), 197-259.<br />
SASSATELLI G., 1989. Problemi cronologici delle <strong>stele</strong> felsinee alla luce dei rispettivi corre<strong>di</strong> tombali. In Secondo<br />
Congresso Internazionale Etrusco. Atti del Convegno (28 maggio-2 giugno 1985), 927-949.<br />
SASSATELLI G., GOVI E., 2009. Ideologia funeraria e celebrazione del defunto nelle <strong>stele</strong> etrusche <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>.<br />
SE, LXXIII, 2007, 67-92.<br />
SCHEFFER C., 1994. The Arched Door in Late Etruscan Funerary Art. In R. D. DE PUMA, J. P. SMALL (a cura<br />
<strong>di</strong>), Murlo and the Etruscans. Art and Society in Ancient Etruria, 196-210.<br />
SOURVINOU-INWOOD C., 1987. Menace and Pursuit: Differentiation and the Creation of Meaning. In C.<br />
BERARD, C. BRON, A.POMARI (a cura <strong>di</strong>), Images et société en Grèce ancienne. L'iconographie comme<br />
méthode d'analyse: Actes du Colloque International (8-11 février 1984), 41-58.<br />
TORELLI M., 1997. "Limina Averni". Realtà e rappresentazione nella pittura tarquiniese arcaica. In M. TORELLI,<br />
Il rito, il rango e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana, 122-151.<br />
TORELLI M., 2002. Ideologia e paesaggi della morte in Etruria <strong>tra</strong> arcaismo ed età ellenistica. In I. COLPO, I.<br />
FAVARETTO, F. GHEDINI (a cura <strong>di</strong>), Iconografia 2001. Stu<strong>di</strong> sull'immagine. Atti del Convegno (30 maggio-<br />
1 giugno 2001), 45-61.<br />
VOLKOMMER R., 1988. Herakles in the Art of Classical Greece.<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D2 / 5 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076<br />
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html<br />
47