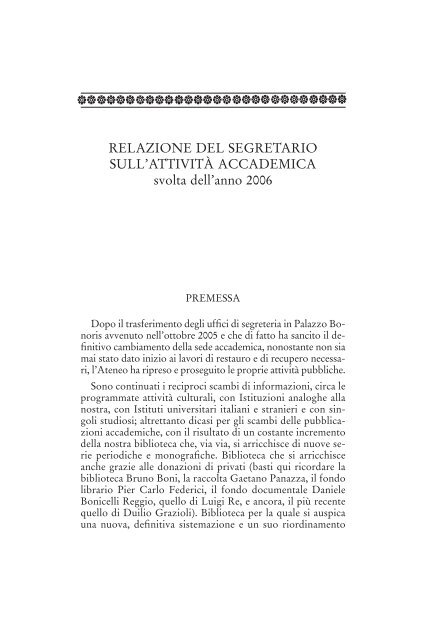02 Relazione del Segretario.pdf - BOLbusiness
02 Relazione del Segretario.pdf - BOLbusiness
02 Relazione del Segretario.pdf - BOLbusiness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA<br />
svolta <strong>del</strong>l’anno 2006<br />
PREMESSA<br />
Dopo il trasferimento degli uffici di segreteria in Palazzo Bonoris<br />
avvenuto nell’ottobre 2005 e che di fatto ha sancito il definitivo<br />
cambiamento <strong>del</strong>la sede accademica, nonostante non sia<br />
mai stato dato inizio ai lavori di restauro e di recupero necessari,<br />
l’Ateneo ha ripreso e proseguito le proprie attività pubbliche.<br />
Sono continuati i reciproci scambi di informazioni, circa le<br />
programmate attività culturali, con Istituzioni analoghe alla<br />
nostra, con Istituti universitari italiani e stranieri e con singoli<br />
studiosi; altrettanto dicasi per gli scambi <strong>del</strong>le pubblicazioni<br />
accademiche, con il risultato di un costante incremento<br />
<strong>del</strong>la nostra biblioteca che, via via, si arricchisce di nuove serie<br />
periodiche e monografiche. Biblioteca che si arricchisce<br />
anche grazie alle donazioni di privati (basti qui ricordare la<br />
biblioteca Bruno Boni, la raccolta Gaetano Panazza, il fondo<br />
librario Pier Carlo Federici, il fondo documentale Daniele<br />
Bonicelli Reggio, quello di Luigi Re, e ancora, il più recente<br />
quello di Duilio Grazioli). Biblioteca per la quale si auspica<br />
una nuova, definitiva sistemazione e un suo riordinamento
14 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[2<br />
secondo i canoni catalografici e ordinativi di nuova generazione,<br />
cosa che diverrà possibile non appena verranno effettuati<br />
i lavori di recupero strutturale <strong>del</strong>lo spazio a essa destinato,<br />
per i quali sono gia stati approntati e approvati i relativi<br />
progetti. Solo così saremo in grado di esprimere al meglio<br />
la nostra potenzialità offrendo alla Città un importante servizio<br />
culturale.<br />
DIARIO DELLE LETTURE<br />
E DEI PUBBLICI INCONTRI<br />
Venerdì 20 gennaio – Si tiene l’Assemblea straordinaria dei<br />
Soci con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazione <strong>del</strong> Presidente;<br />
2. Modifiche degli artt. 6 e 7 <strong>del</strong>lo Statuto, in tema di elezione<br />
di nuovi soci, proposte dal Consiglio di Presidenza; 3. Modifica<br />
<strong>del</strong>l’art. 8 <strong>del</strong>lo Statuto, in tema di elezione dei membri <strong>del</strong><br />
Consiglio di Presidenza, proposta da dieci soci effettivi.<br />
Venerdì 10 febbraio – L’Accademico prof. Gianpietro Belotti,<br />
studioso di Storia economica e sociale, tiene una pubblica<br />
lettura sul tema: L’universo agrario pacificato di Agostino<br />
Gallo.<br />
L’opera di Agostino Gallo ha costituito una tappa fondamentale<br />
nella storia <strong>del</strong>l’agricoltura <strong>del</strong>l’età moderna e le sue<br />
Giornate sono state analizzate per le loro valenze linguistiche,<br />
sociali e per le tecniche agronomiche proposte. Tuttavia<br />
le rappresentazioni <strong>del</strong> paesaggio agrario e <strong>del</strong>la vita rurale,<br />
con influssi e richiami petrarcheschi, non si fermano solo alla<br />
descrizione <strong>del</strong> mondo rurale e <strong>del</strong>le “nuove” pratiche colturali.<br />
Nell’originale concezione <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong>le Giornate,<br />
infatti, persino la descrizione <strong>del</strong>l’ambiente viene fatta con gli<br />
occhi <strong>del</strong>l’anima, lasciando trasparire uno spirito di serenità<br />
che rende questo paesaggio, naturale e umanizzato, una sorta<br />
di paradiso mentale ritrovato, nel quale si dissolvono i conflitti<br />
interiori e sociali. In questa visione fortemente idealizzata<br />
<strong>del</strong> nuovo mondo rurale, si avverte l’influenza dei circoli<br />
<strong>del</strong>la pre-riforma bresciana, a partire dall’evangelismo di
3] Attività accademica<br />
15<br />
Angela Merici che seppe coniugare rinnovamento interiore e<br />
impegno sociale.<br />
Mercoledì 15 febbraio – In occasione <strong>del</strong>la festa dei Santi<br />
Patroni Faustino e Giovita, in collaborazione con la Fondazione<br />
Civiltà Bresciana, alla presenza <strong>del</strong>le autorità civili, militari<br />
e religiose <strong>del</strong>la città, si tiene la cerimonia <strong>del</strong>la consegna<br />
<strong>del</strong> “Premio <strong>del</strong>la Brescianità 2006”. Gli insigniti e le motivazioni<br />
sono: Elena Allegretti, trasfonde le voci <strong>del</strong> Coro<br />
Isca in palpiti, magie, colori <strong>del</strong>la musica; Renzo Capra, esempio<br />
di energia manageriale produttiva nella municipalizzazione<br />
di Brescia; Franco Nardini, cronista <strong>del</strong>la Storia bresciana<br />
nella sua identità interdisciplinare; Alberto Sorlini,<br />
manca solo lo “scatto” di Man Ray al Museo nazionale <strong>del</strong>la<br />
Fotografia.<br />
Venerdì 10 marzo – Il prof. Antonio Chiesa, docente <strong>del</strong>l’Università<br />
degli studi di Brescia e cultore <strong>del</strong>la materia, a presentazione<br />
<strong>del</strong> libro «Parole sulle Pietre» di A. Chiesa e M.<br />
Rigoni Stern, tiene una conferenza su: La memoria storica <strong>del</strong>la<br />
Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago.<br />
Nel maggio di novant’anni fa, a un anno dalla dichiarazione<br />
di guerra all’Austria-Ungheria da parte <strong>del</strong>l’Italia, il generale<br />
A.U. Conrad sferra un poderoso attacco destinato ad occupare<br />
la pianura vicentina e padovana, in modo da isolare il<br />
grosso <strong>del</strong>le truppe italiane schierate sul fronte <strong>del</strong>l’Isonzo.<br />
L’attacco coinvolge il settore occidentale <strong>del</strong> fronte, ma si sviluppa<br />
soprattutto sugli altipiani e sulle montagne posti a cavallo<br />
tra la valle <strong>del</strong>l’Adige e quella <strong>del</strong> Brenta. In quei luoghi<br />
la Grande Guerra si è combattuto, ad intervalli, per quarantuno<br />
mesi. A distanza di novant’anni i segni <strong>del</strong>le battaglie (trincee,<br />
accampamenti, depositi...) sono ormai scomparsi. Rimangono<br />
le scritte sulle pietre (italiane, austriache, ma anche slovene,<br />
croate, bosniache, inglesi e francesi) che, insieme alle strade<br />
e a pochi sopravvissuti cimiteri, segnano le vie sulle quali<br />
passarono gli eserciti, le zone dove questi trascorsero i lunghi<br />
inverni nella neve, e ricordano i caduti tra le decine di migliaia<br />
di morti <strong>del</strong>le due parti.
16 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[4<br />
Venerdì 17 marzo – L’accademico prof. Marco Rossi, docente<br />
di Storia <strong>del</strong>l’Arte Medievale nell’Università Cattolica,<br />
tiene una pubblica lettura su: Le Cattedrali e il Broletto di Brescia<br />
fra XII e XIV Secolo.<br />
Il particolare legame esistente tra le Cattedrali e il Broletto<br />
di Brescia, che contribuisce in maniera decisiva a qualificare il<br />
centro storico <strong>del</strong>la Città, affonda le sue radici nella complessa<br />
articolazione <strong>del</strong>le forze civili e religiose impegnate a definirne<br />
il volto medievale. La rilevanza civica assunta dalle Cattedrali<br />
nel XII secolo lascia spazio in quello successivo al nuovo<br />
Broletto, la cui costruzione e decorazione procede in rapporto<br />
ad alcuni interventi documentabili nel complesso episcopale,<br />
fino a giungere, con Berardo Maggi, vescovo e signore<br />
<strong>del</strong>la Città, a un’unità inscindibile di committenze architettoniche<br />
e pittoriche.<br />
Giovedì 30 marzo – La prof.ssa Simona Gavinelli, docente<br />
di Paleografia presso l’Università Cattolica e il dott. Alberto<br />
Zaina, ricercatore archivista, tengono una pubblica lettura sul<br />
tema: A cinquecento anni dalla prima edizione <strong>del</strong>l’Opera<br />
Omnia di San Lorenzo Giustiniani.<br />
Il 28 marzo 1506 veniva edita in Brescia, per i tipi di Angelo<br />
Britannico, l’Opera omnia di San Lorenzo Giustiniani primo<br />
patriarca di Venezia, edita da Girolamo Cavalli, priore di<br />
San Pietro in Oliveto e generale <strong>del</strong>la Congregazione di San<br />
Giorgio in Alga di Venezia (poi prevosto in Sant’Agata), a cui<br />
appartennero Lorenzo Giustiniani e Gabriele Condulmer (papa<br />
Eugenio IV). La ricerca condotta da Simona Gavinelli e da<br />
Alberto Zaina ha permesso di individuare alcuni dei codici, presenti<br />
in Queriniana, utilizzati per l’edizione a stampa e di porre<br />
in risalto l’opera di Girolamo Cavalli, fornendo su questa<br />
base, e su nuovi dati archivistici, un contributo per conoscere<br />
la vita e l’opera di un prelato umanista <strong>del</strong> Cinquecento, promotore<br />
<strong>del</strong>la costruzione di San Pietro in Oliveto, “terzo polo”<br />
insieme ai “Miracoli” e alla “Loggia” <strong>del</strong>l’architettura e <strong>del</strong>la<br />
scultura <strong>del</strong> primo Rinascimento a Brescia.<br />
Martedì 11 aprile – Si tiene una riunione <strong>del</strong> Consiglio di Presidenza<br />
con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazioni <strong>del</strong> Presidente:<br />
a) biblioteca e archivio Ateneo (stato <strong>del</strong>l’arte), b) di-
5] Attività accademica<br />
17<br />
missioni <strong>del</strong> vice segretario dall’incarico di vice presidenza <strong>del</strong>la<br />
Fondazione “Ugo Da Como”; 2. Esame <strong>del</strong> bilancio consuntivo<br />
2005 e preventivo 2006 con decisioni conseguenti (assemblea<br />
ordinaria dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile);<br />
3. Elezione nuovi soci; 4. Proposta di nuova organizzazione<br />
sociale (inserimento di classi di studio); 5. Convegno foscoliano<br />
(aprile 2007); 6. Convegno <strong>del</strong>l’Associazione di Studi Storici<br />
e Militari di Roma; 7. contributo premio internazionale di<br />
violino “Città di Brescia” (Fondazione Romano Romanini).<br />
Venerdì 21 aprile – Il M.o dott. Giosuè Berbenni, accademico<br />
<strong>del</strong>l’Ateneo di Bergamo, storico <strong>del</strong>l’organologia e responsabile<br />
scientifico <strong>del</strong> Progetto CNR: «Indagine storicodocumentale<br />
sugli organi storici <strong>del</strong>la provincia di Bergamo»,<br />
tiene una pubblica lettura sul tema: L’ammirazione dei celebri<br />
organari Serassi di Bergamo per gli Antegnati di Brescia.<br />
I celebri organari Serassi nella loro intensa ed estesa attività<br />
plurisecolare hanno dimostrato ammirazione e concreta attenzione<br />
verso gli Antegnati – noti organari rinascimentali bresciani<br />
vissuti nei secoli XV-XVI-XVII – presenti nella Bergamasca<br />
per centosettantacinque anni, dove hanno costruito oltre<br />
40 strumenti. Giuseppe II Serassi scrive con particolare considerazione<br />
e stima su Graziadio, Costanzo e Giovanni Francesco<br />
II Antegnati. Sono numerosi gli organi Serassi che hanno<br />
conservato reperti Antegnati, le cui canne erano considerate<br />
inimitabili per vivacità, dolcezza e prontezza di suono. La<br />
comunicazione focalizza e riscopre in modo inedito le metodologie<br />
di fabbricazione che i Serassi hanno preso dagli Antegnati<br />
«tenuti e seguiti per maestri in tale arte».<br />
Venerdì 27 aprile – Si tiene l’Assemblea ordinaria dei Soci<br />
con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazione <strong>del</strong> presidente; 2.<br />
Bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006: discussione e<br />
conseguenti.<br />
Venerdì 5 maggio – L’accademico Giannetto Valzelli, poeta,<br />
prosatore e pubblicista, tiene una pubblica lettura sul tema:<br />
«L’elmo di Scipio» di Arturo Rossato: La guerra 1915-18<br />
vista dalla Valle Sabbia.
18 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[6<br />
L’Elmo di Scipio è il titolo – desunto dall’Inno di Mameli –<br />
che Arturo Rossato ha dettato per il suo “diario di guerra” che<br />
vide la luce nel 1919. In esso la fluidità <strong>del</strong> racconto, dovuta alla<br />
penna <strong>del</strong> poeta, contrasta talvolta con gli argomenti trattati,<br />
che si basano su riflessioni e appunti raccolti nell’immediatezza<br />
<strong>del</strong>le circostanze vissute, là dove l’alta Valle Sabbia si<br />
chiude con il lago d’Idro.<br />
«Opera di passione e di tormento, come passione e tormento<br />
fu la guerra per il letterato... Un libro sincero fino<br />
alla brutalità: la cronaca fe<strong>del</strong>e di un giornalista; il diario intimo<br />
di un poeta; la confessione disperata di un’anima...»<br />
(Gian Capo, 1919).<br />
Venerdì 12 maggio – L’accademico Oliviero Franzoni, storico,<br />
cultore <strong>del</strong>la materia, tiene una conferenza su: L’attività<br />
parlamentare dei deputati di Valle Camonica dal 1860 al 1919.<br />
Dal 1860 al 1919 la Valle Camonica, facente capo elettoralmente<br />
al collegio di Breno, contò sette deputati eletti al Parlamento<br />
nazionale: Giovan Francesco Cuzzetti, Andrea Carganico,<br />
Sigismondo Ignazio Sigismondi, Antonio Taglierini, Oreste<br />
Baratieri, Baldassare Castiglioni e Livio Tovini. Si distinsero,<br />
in particolare, il Cuzzetti, che ebbe parte nei moti risorgimentali<br />
e fu in rapporti di amicizia con Garibaldi; il generale<br />
Baratieri, combattente durante la Campagna d’Africa, giunto a<br />
un passo dalla nomina a Ministro <strong>del</strong>la Guerra; Livio Tovini<br />
uno dei primi esponenti <strong>del</strong> movimento cattolico ad entrare in<br />
Parlamento, diventato segretario <strong>del</strong> gruppo parlamentare <strong>del</strong><br />
Partito Popolare e vice presidente <strong>del</strong>la Camera. Dall’analisi<br />
<strong>del</strong>le loro attività emerge come tutti si siano adoperati, in diversa<br />
misura, per la risoluzione dei problemi valligiani e per favorire<br />
lo sviluppo sociale ed economico <strong>del</strong>l’area alpina.<br />
Venerdì 19 maggio – L’accademico dott. Ennio Ferraglio,<br />
conservatore <strong>del</strong> fondo antico <strong>del</strong>la civica Biblioteca Queriniana,<br />
tiene una pubblica lettura sul tema: Dalle anticaglie<br />
d’archivio all’istoria intiera: Ludovico Antonio Muratori e la<br />
storia di Brescia.<br />
L’impulso dato da Ludovico Antonio Muratori alla storiografia<br />
<strong>del</strong>l’Italia antica ha contribuito grandemente a risveglia-
7] Attività accademica<br />
19<br />
re l’interesse degli studiosi <strong>del</strong>la prima metà <strong>del</strong> Settecento per<br />
la storia <strong>del</strong>la Città e <strong>del</strong> territorio di Brescia. Si è assistito, attraverso<br />
lo stretto rapporto fra lo studioso modenese e l’ambiente<br />
culturale bresciano <strong>del</strong> secolo dei Lumi a un progressivo<br />
lavoro di affinamento <strong>del</strong>le tecniche e dei contenuti <strong>del</strong>la ricerca<br />
e sono state gettate le basi per un ripensamento critico e<br />
modernamente inteso sulla storia di Brescia, la cui “onda lunga”<br />
si percepisce ancora oggi.<br />
Venerdì 26 maggio – L’accademico prof. dott. Pier Carlo<br />
Federici, emerito <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Parma, tiene<br />
una pubblica lettura su: Idrologia e idrotermalismo nel territorio<br />
bresciano.<br />
Nel 2004 il prof. Pier Carlo Federici, bresciano, Emerito<br />
<strong>del</strong>l’Università degli Studi di Parma – Socio <strong>del</strong> nostro Ateneo<br />
dal 1959 – ebbe a donare alla biblioteca <strong>del</strong>la nostra Accademia<br />
la sua ricca raccolta libraria e documentaria riguardante la<br />
Storia <strong>del</strong>la Medicina, l’Idrologia e l’Idro-Termalismo applicato<br />
alla Medicina. Della donazione <strong>del</strong> «Fondo Federici» (ora<br />
in fase di riordino), venne dato conto nel settembre <strong>del</strong>lo scorso<br />
anno, con una pubblica conferenza tenuta dal nostro Socio<br />
prof. Sergio Onger – docente di Storia Economica nell’Università<br />
degli Studi di Brescia –, presente il nostro munifico benefattore<br />
che, fra l’altro, ci regalò un suo brillante intervento,<br />
unitamente all’impegno di tenere, a sua volta, un discorso sugli<br />
argomenti che, per tanti anni, furono oggetto <strong>del</strong>la sua ricerca<br />
scientifica e <strong>del</strong> suo insegnamento universitario.<br />
Venerdì 9 giugno – L’accademico prof. arch. Gianni Mezzanotte,<br />
emerito di Storia <strong>del</strong>l’Architettura presso la Facoltà<br />
di Ingegneria <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Brescia, tiene una<br />
pubblica lettura sul tema: Architetti italianisti alla corte di Caterina<br />
di Russia.<br />
Vengono ricordati architetti di varia origine – italiana, scozzese,<br />
russa – che negli anni di Caterina portarono a San Pietroburgo<br />
un orientamento diverso da quello fino allora praticato,<br />
fortemente segnato da alcune correnti <strong>del</strong> pensiero francese,<br />
razionalistico, dottrinario, impegnato a dedurre da principi<br />
generali includibili i criteri per svolgere i temi suggeriti dal-
20 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[8<br />
le circostanze. Caterina volle esplicitamente chiamare presso di<br />
sé architetti capaci, al contrario, di risolvere duttilmente le difficoltà<br />
di ogni natura sorte in rapporto ai fini ricercati; esperti<br />
in grado di approntare procedure di composizione, espressioni,<br />
tecniche esecutive adatte al variare <strong>del</strong>le circostanze. Architetti<br />
cioè che derivassero i propri comportamenti dalle esperienze<br />
fatte, non da principi onnivalenti precostituiti<br />
Venerdì 16 giugno – La dott.ssa Paola Castellini, cultore <strong>del</strong>la<br />
materia ed esercitatore per la Cattedra di Storia <strong>del</strong>l’Arte<br />
Medievale e Storia <strong>del</strong>l’Arte Lombarda nell’Università Cattolica<br />
sede di Brescia; dottoranda all’Università di Ginevra, tiene<br />
una pubblica lettura su: La presenza di Altobello Melone<br />
nella bottega di Girolamo Romanino.<br />
Altobello Melone è un pittore cremonese <strong>del</strong>la prima metà<br />
<strong>del</strong> Cinquecento di considerevole fama – insieme ai più importanti<br />
esponenti <strong>del</strong>la pittura cremonese, oltre al bresciano<br />
Romanino e al veneto Pordenone – che affrescò la navata <strong>del</strong><br />
Duomo di Cremona intorno al 1520. Il suo apprendistato presso<br />
la bottega <strong>del</strong> Romanino è cosa ormai nota, grazie agli studi<br />
di Francesco Frangi. La Castellini, inoltre, ha rinvenuto la<br />
presenza <strong>del</strong>la “mano” <strong>del</strong>l’Altobello nella Pieve <strong>del</strong>la Mitria<br />
di Nave, nei dipinti a fresco tardo-quattrocenteschi <strong>del</strong>l’abside,<br />
dove avrebbe rifatto le teste di almeno quattro dei Dodici<br />
Apostoli. Rimangono tuttavia ancora alcune questioni da chiarire,<br />
relative alla collaborazione giovanile (entro il 1515) tra i<br />
due pittori; questo sarà l’argomento che verrà affrontato nel<br />
corso <strong>del</strong>la conferenza.<br />
Venerdi 22 settembre – La prof.ssa Maria Luisa Ardizzone,<br />
<strong>del</strong> Dipartimento di Italianistica <strong>del</strong>l’Università di New York,<br />
a presentazione <strong>del</strong> suo recente libro: Guido Cavalcanti: L’altro<br />
Medioevo, tiene una pubblica lettura sul tema: Poesia e storia<br />
intellettuale.<br />
Nel suo libro su Cavalcanti, che ha riscosso un notevole interesse<br />
negli Stati Uniti, la prof.ssa Maria Luisa Ardizzone, rilegge<br />
l’opera <strong>del</strong> primo amico di Dante e ne ricostruisce il profilo<br />
di intellettuale inquieto, partecipe e insieme critico <strong>del</strong> mul-
9] Attività accademica<br />
21<br />
ticulturalismo <strong>del</strong> suo tempo. Esponente di una cultura che cerca<br />
non nella teologia, ma nella filosofia naturale e nella medicina<br />
le risposte intime, il Medioevo che Cavalcanti dischiude è<br />
quello che riformula l’idea di essere umano e <strong>del</strong> suo fine, dando<br />
spazio alla vicenda biologica e terrena <strong>del</strong>l’individuo. Il libro<br />
indaga anche il rapporto tra Dante e Cavalcanti e vede nel<br />
suo divenire (l’amicizia <strong>del</strong>la prima giovinezza che più tardi si<br />
trasforma in dissidio) l’emergere di una spaccatura che segnerà<br />
simbolicamente la cultura occidentale.<br />
Venerdì 6 ottobre – In collaborazione con il Comitato di<br />
Brescia <strong>del</strong>l’Istituto per la Storia <strong>del</strong> Risorgimento Italiano e<br />
<strong>del</strong>l’Associazione Italiana di Studi Storico Militari, si tiene una<br />
giornata di studio sul tema: La Legione Italica e la situazione<br />
italiana fra il 1800 e il 1806. Alle ore 9,30, dopo il saluto <strong>del</strong><br />
presidente <strong>del</strong>l’Ateneo, avv. Angelo Rampinelli Rota, iniziano<br />
i lavori <strong>del</strong>la prima sessione: presiede Gioacchino Gargallo,<br />
storiografo, presidente <strong>del</strong>l’Associazione di Studi Militari;<br />
intervengono: Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, storico, vice<br />
presidente <strong>del</strong>l’Ateneo, su: La Legione Italica e le origini <strong>del</strong><br />
Risorgimento; Bruno Mugnai, esperto di storia militare, collaboratore<br />
<strong>del</strong>l’Ufficio Storico SME e <strong>del</strong>l’Ufficio Storico EI,<br />
su: Gli Stati minori: il caso Lucchese. Alle ore 11 iniziano i lavori<br />
<strong>del</strong>la seconda sessione, presiede Luigi Amedeo Biglione<br />
di Viarigi; intervengono: Niccolò Capponi (riceratore di Storia<br />
militare, membro ASSM, SISM), su: La situazione toscana;<br />
Pier Paolo Ramoino, direttore emerito <strong>del</strong>l’Istituto di Guerra<br />
Marittima di Livorno e dei Corsi ISSMI interforze di Roma,<br />
su: La Marina Italica nel contesto strategico; Ciro Paoletti, storico<br />
militare, direttore <strong>del</strong>l’Associazione di Studi Storici Militari,<br />
su: Gli Stati romani. Alle ore 15, dopo la pausa pranzo,<br />
iniziano i lavori <strong>del</strong>la terza sessione, presiede: Ciro Paoletti;<br />
intervengono: Gioacchino Gargallo, storiografo, su: La storiografia<br />
<strong>del</strong>l’Età Napoleonica; Luciano Faverzani, storico, vice<br />
segretario <strong>del</strong>l’Ateneo, su: Giuseppe Lechi e il Giornale <strong>del</strong>la<br />
Legione Italica; Bernardo Falconi, storico <strong>del</strong>l’arte, su: I<br />
volti dei protagonisti <strong>del</strong>la vittoriosa Campagna <strong>del</strong>la Legione<br />
Italica.
22 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[10<br />
Giovedì 12 ottobre – In collaborazione con l’Associazione<br />
Nuove Settimane di Musica Barocca si tiene presso la nostra<br />
Accademia la tavola rotonda su: Pietro Gnocchi (1689-<br />
1775) musicista bresciano: proposte e prospettive <strong>del</strong>la ricerca.<br />
L’incontro di studi è organizzata nell’ambito <strong>del</strong>la IV edizione<br />
<strong>del</strong> Festival Nuove Settimane di Musica Barocca in Brescia<br />
e provincia. Coordina i lavori: Claudio Toscani, docente<br />
<strong>del</strong>l’Università degli Studi di Milano. Intervengono: Ennio<br />
Ferraglio, accademico <strong>del</strong> nostro Ateneo e consevatore <strong>del</strong><br />
fondo antico <strong>del</strong>la civica Biblioteca Queriniana; Cesare Fertonani,<br />
docente <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Milano; Marco<br />
Mangani, docente <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Pavia; Mariella<br />
Sala, bibliotecaria <strong>del</strong> Conservatorio di Musica “Luca<br />
Marenzio” di Brescia.<br />
Venerdì 13 ottobre – L’accademica prof.ssa Maria Teresa<br />
Rosa Barezzani, docente di Paleografia e Filologia musicale, a<br />
presentazione di un suo studio, tiene una pubblica lettura sul<br />
tema: Il responsorio “Multa Egerunt Iudei” <strong>del</strong> Codice Queriniano<br />
G.VI.7. (Memoriale di S. Salvatore/S. Giulia); al termine<br />
<strong>del</strong>la conferenza, quattro coriste hanno dato voce all’antico<br />
“coro <strong>del</strong>le monache” interpretando, oltre al “responsorio”<br />
musicalmente rinato, altri canti gregoriani propri<br />
<strong>del</strong>le celebrazioni liturgiche <strong>del</strong> Venerdì Santo. Il pubblico incontro<br />
si è tenuto presso l’Auditorium di Santa Giulia concesso<br />
grazie alla collaborazione di Brescia Musei Spa che, fra<br />
l’altro, unitamente alla Fondazione CAB, con il loro determinante<br />
contributo hanno reso possibile la pubblicazione <strong>del</strong>l’accennato<br />
studio apparso col titolo: Annotazioni intorno al<br />
Monastero di San Salvatore/Santa Giulia di Brescia e la lettura<br />
<strong>del</strong> responsorio “Multa Egerunt Iudei” <strong>del</strong> Codice Queriniano<br />
G.VI.7, frutto di approfondite ricerche e comparazioni<br />
fatte dall’autrice Maria Teresa Rosa Barezzani, e pubblicato<br />
nella serie dei Supplementi ai «Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di<br />
Brescia» per l’anno 2006.<br />
Il responsorio Multa Egerunt Iudei riportato alla c.36r <strong>del</strong><br />
codice queriniano G.VI.7 (Memoriale di S. Salvatore/S. Giulia)
11] Attività accademica<br />
23<br />
appariva più o meno contemporaneamente ad altri due manoscritti<br />
<strong>del</strong>l’XI secolo provvisti di notazioni neumatiche adiastematiche:<br />
nel codice bolognese 123 <strong>del</strong>la Biblioteca Angelica<br />
di Roma (Graduale-Tropario) e nel codice XCVIII <strong>del</strong>la Biblioteca<br />
Capitolare di Verona (Antiphonarium). La sua adozione<br />
nel centro bolognese era poi confermata dalla sua presenza<br />
nel Graduale, codice O.I.13 <strong>del</strong>la Biblioteca Capitolare<br />
di Modena (fine secolo XI, inizio XII). Il testo di questo rarissimo<br />
Responsorio, ricavato da frammenti <strong>del</strong>la Passio di Marco<br />
(14,1-15,46) riportata nel medesimo G.VI.7 e dalla Passio di<br />
Luca (23,42), rievoca – nell’episodio <strong>del</strong>la crocifissione di Gesù<br />
– il pentimento <strong>del</strong> “buon ladrone”. La melodia che si offre<br />
all’ascolto è il risultato <strong>del</strong>la paziente collazione <strong>del</strong>le fonti.<br />
Mercoledì 25 ottobre – Si tiene una riunione <strong>del</strong> Consiglio<br />
di Presidenza con il seguente O.d.G.: 1. Problemi immobiliari<br />
(interventi sull’immobile di via Crispi, vendita immobile di<br />
via Apollonio); 2. Varie ed eventuali.<br />
Venerdì 10 novembre – Viene presentato il volume: Enrichetta<br />
Manzoni Blon<strong>del</strong> «Par pièces e morceaux»: Lettere<br />
1809-1833, pubblicato a cura di Fabio Danelon, con una nota<br />
di Marta Morazzoni <strong>del</strong> Centro Nazionale di Studi Manzoniani,<br />
Milano 2006. Dopo il saluto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>l’Ateneo,<br />
intervengono: Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, accademico<br />
vice presidente; Gianmarco Gaspari, direttore <strong>del</strong> Centro<br />
Nazionale Studi Manzoniani e docente nell’Università degli<br />
Studi <strong>del</strong>l’Insubria; Pietro Gibellini, nostro accademico e<br />
docente <strong>del</strong>l’Università di Venezia, e lo stesso curatore <strong>del</strong> volume;<br />
Fabio Danelon, accademico <strong>del</strong>l’Ateneo e docente <strong>del</strong>l’Università<br />
per Stranieri di Perugia.<br />
144 lettere, di cui 21 inedite e 14 «significativamente integrate<br />
grazie al rinvenimento degli autografi», indirizzate dalla<br />
moglie di Alessandro Manzoni, Enrichetta Blon<strong>del</strong>, dal 1809<br />
al 1833, anno <strong>del</strong>la sua morte, ad amiche, alla figlioletta Vittoria<br />
in collegio, ai direttori spirituali, Degola e Tosi, due lettere-testamento<br />
al marito in momenti drammatici <strong>del</strong>la sua breve<br />
vita. Emergono non soltanto i tratti di una vivida persona-
24 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[12<br />
lità, spesso rimasta nell’ombra, ma anche i contorni <strong>del</strong>la società<br />
culturalmente più attiva tra Milano e Parigi in anni di importanti<br />
fermenti italiani ed europei.<br />
Giovedì 16 novembre – Si tiene l’annuale Solenne Adunanza<br />
con il seguente programma: dopo la prolusione <strong>del</strong> presidente<br />
con il saluto alle Autorià; viene data lettura <strong>del</strong>la relazione<br />
<strong>del</strong> segretario sulle attività svolte nel corso <strong>del</strong>l’anno<br />
2005; segue l’orazione ufficiale tenuta <strong>del</strong> prof. Carlo Bertelli,<br />
docente di Storia <strong>del</strong>l’Arte Antica presso l’Accademia di Architettura<br />
<strong>del</strong>l’Università <strong>del</strong>la Svizzera italiana, sul tema: 2000<br />
anni di arte a Brescia; e, in chiusura, è stata fatta la chiamata<br />
dei nuovi soci effettivi nelle persone <strong>del</strong> prof. don Giulio Cittadini<br />
p.d.O (teologo e biblista); <strong>del</strong> M.o Giancarlo Facchinetti<br />
(musicista compositore e direttore d’orchestra); <strong>del</strong> sig.<br />
Bernardo Falconi (storico <strong>del</strong>l’arte); <strong>del</strong> dott. Carlo Fasser (naturalista<br />
geologo); <strong>del</strong> prof. Daniele Montanari (storico, docente<br />
<strong>del</strong>l’Università Cattolica sede di Brescia); <strong>del</strong> M.o Agostino<br />
Orizio (musicista, direttore d’orchestra); <strong>del</strong> prof. Mario<br />
Piotti (italianista filologo, docente <strong>del</strong>l’Università degli<br />
Studi di Milano); <strong>del</strong>l’arch. Filippo Tagliaferri (urbanista e naturalista<br />
botanico); e <strong>del</strong>l’arch. Carlo Zani (storico <strong>del</strong>l’arte e<br />
<strong>del</strong> Risorgimento); a ciascuno di loro è stato consegnato il diploma<br />
di nomina e la medaglia commemorativa <strong>del</strong> bicentenario<br />
accademico.<br />
Giovedì 23 novembre – In collaborazione con l’Associazione<br />
Artisti Bresciani (AAB), gli storici <strong>del</strong>l’arte dott. Luigi<br />
Capretti e prof. Francesco De Leonardis, tengono una pubblica<br />
lettura, nel centenario <strong>del</strong>la morte <strong>del</strong> pittore bresciano,<br />
patriota, accademico <strong>del</strong> nostro Ateneo: Achille Glisenti (Brescia<br />
1848-Firenze 1906); introduce, il prof. Vasco Frati, presidente<br />
<strong>del</strong>l’Associazione Artisti Bresciani.<br />
Mercoledì 29 novembre – In collaborazione con l’Associazione<br />
“Amici di Israele”, in occasione <strong>del</strong>la edizione <strong>del</strong> volume<br />
a cura di Marino Ruzzenenti, La capitale <strong>del</strong>la RSI e la<br />
Shoah, edito nella collana «Studi Bresciani, Quaderni <strong>del</strong>la
13] Attività accademica<br />
25<br />
Fondazione Micheletti», 15 (2006), si tiene un incontro sul tema:<br />
La Shoah durante la Repubblica Sociale Italiana. Documenti<br />
e testimonianze. Intervengono: dott. Enzo Dani, presidente<br />
Associazione “Amici di Israele”, che tratta <strong>del</strong>le Premesse<br />
ideologiche <strong>del</strong>la Shoah; l’autore prof. Marino Ruzzenenti,<br />
docente di discipline storiche, su: Una pagina di storia<br />
da approfondire: Brescia e la Shoah; chiude l’incontro La testimonianza<br />
di una sopravvissuta, raccontata dall’ex deportata<br />
Rebecca Behor Ottolenghi.<br />
Venerdì 1 dicembre – L’accademico prof. Luigi Cattanei,<br />
storico, letterato e critico letterario, tiene una pubblica lettura<br />
sul tema: Montale innamorato. Introduce e presenta, l’accademico<br />
prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi.<br />
Giovedì 7 dicembre – In occasione <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la<br />
sua monografia sullo scultore bresciano (nostro socio fin<br />
dal 1859), la dott.ssa Adriana Conconi Fedrigolli, letterata e<br />
storica <strong>del</strong>l’arte, tiene una pubblica lettura sul tema: Giovanni<br />
Battista Lombardi, scultore bresciano (1822-1880). Intervengono<br />
i professori Luciano Caramel e Francesco Tedeschi,<br />
docenti <strong>del</strong>l’Università Cattolica sedi di Brescia e di Milano.<br />
È la presentazione <strong>del</strong> primo studio monografico, dedicato<br />
allo scultore bresciano, che origina da una ricerca avviata per<br />
la tesi di laurea. Giovanni Battista Lombardi: un interprete raffinato<br />
– fino ad oggi ancora poco conosciuto – <strong>del</strong>la stagione<br />
artistica ottocentesca, la cui opera scultorea si allinea a quella<br />
di già celebrati protagonisti e a cui spetta, a giusto merito, un<br />
ruolo nel panorama nazionale e internazionale.<br />
Venerdì 15 dicembre – La dott.ssa Barbara D’Attoma, storica<br />
<strong>del</strong>l’arte, tiene una pubblica lettura sul tema: “Il punto critico<br />
sul pittore Pompeo Ghitti: ricognizioni artistiche su Pompeo<br />
Ghitti (Marone 1631-Brescia 1703)”; presenta e introduce<br />
l’accademico prof. Luciano Anelli, docente <strong>del</strong>l’Università<br />
Cattolica sede di Brescia.<br />
La compilazione <strong>del</strong>la biografia <strong>del</strong> pittore – che apparirà sul<br />
vol. 51-52 <strong>del</strong>l’Allgemeines Künstlerlexikon, di prossima pub-
26 RELAZIONE DEL SEGRETARIO<br />
[14<br />
blicazione – fornisce l’occasione per indagare ulteriormente e<br />
approfondire lo studio <strong>del</strong>l’artista maronese, figura di transizione<br />
tra il tardo manierismo veneto e il naturalismo lombardo.<br />
Martedì 19 dicembre – Per il 180° anniversario <strong>del</strong> ritrovamento<br />
<strong>del</strong>la Vittoria Alata di Brescia, in collaborazione con la<br />
Direzione dei Civici Musei e Brescia Musei Spa, si tiene un<br />
pomeriggio di studio, presenti: l’avv. Angelo Rampinelli Rota,<br />
presidente <strong>del</strong>l’Ateneo; l’accademico on. prof. Paolo Corsini,<br />
Sindaco di Brescia; l’on. dott. Agostino Mantovani, presidente<br />
di Brescia Musei Spa. Relazionano: la dott.ssa Renata<br />
Stradiotti, accademica <strong>del</strong>l’Ateneo e Direttore dei Civici Musei,<br />
che passa in rassegna le vicende espositive <strong>del</strong>la statua divenuta<br />
simbolo <strong>del</strong>la Città; l’ing. Piero Lechi, accademico <strong>del</strong>l’Ateneo,<br />
che dà lettura di alcune lettere inedite relative al ritrovamento<br />
e alle prime interpretazioni <strong>del</strong> grande bronzo,<br />
conservate nell’archivio di famiglia; il prof. Pierfabio Panazza,<br />
accademico <strong>del</strong>l’Ateneo e docente di Storia <strong>del</strong>l’Arte, che<br />
inquadra il ritrovamento nell’ambito <strong>del</strong>le ricerche archeologiche<br />
intraprese dall’Ateneo di Brescia in collaborazione con<br />
la Municipalità; Francesca Morandini, Ispettore archeologo<br />
dei Civici Musei, che dà conto <strong>del</strong>la ricerca, ancora in corso,<br />
per individuare le copie “storiche” <strong>del</strong>la scultura romana e la<br />
loro presenza nei vari istituti italiani ed europei; l’ing. Franco<br />
Docchio, docente di Ingegneria elettronica nell’Università degli<br />
Studi di Brescia, che illustra le procedure messe a punto<br />
per la rilevazione digitalizzata per una riproduzione virtuale<br />
<strong>del</strong>la statua <strong>del</strong>la Vittoria, per addivenire, poi, alla realizzazione<br />
materiale <strong>del</strong>la scultura, senza mai toccare l’originale,<br />
come quella riprodotta in resina, presente in sala, grazie alla<br />
collaborazione <strong>del</strong>la ditta EOS-Italia, rappresentata all’incontro<br />
dal dott. Vito Chinellato.<br />
PUBBLICAZIONI<br />
Per quanto riguarda l’editoria è iniziata la preparazione dei<br />
«Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di Brescia» per l’anno 2004, e la non
15] Attività accademica<br />
27<br />
facile raccolta dei saggi e dei contributi relativi alle pubbliche<br />
conferenze e letture tenute in quell’anno; mentre hanno visto<br />
la luce i volumi:<br />
«Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di Brescia e Atti <strong>del</strong>la Fondazione<br />
Ugo Da Como» per l’anno 2003.<br />
AA.VV., Brescia e il Risorgimento. I luoghi e la memoria.<br />
Ciclo di conferenze. Brescia, novembre-dicembre 2003. A cura<br />
di L.A. Biglione di Viarigi e L. Faverzani. Supplemento. ai<br />
«Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di Brescia» per l’anno 20<strong>02</strong>.<br />
M.T. ROSA BAREZZANI, Annotazioni intorno al Monastero di<br />
San Salvatore/Santa Giulia di Brescia e lettura <strong>del</strong> Responsorio<br />
«Multa Egerunt Iudei» <strong>del</strong> Codice Queriniano G.VI.7. Supplemento<br />
ai «Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006.<br />
Il quaderno: Premio Brescianità 2006. Supplemento ai<br />
«Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo» per l’anno 2006.<br />
ATTIVITÀ COLLATERALI<br />
Sempre viva e frequentata è stata l’attività <strong>del</strong>la Società dei<br />
naturalisti bresciani denominata «Gruppo Naturalistico “Giuseppe<br />
Ragazzoni”» – emanazione <strong>del</strong>la nostra Accademia –<br />
che si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri<br />
succedutesi con cadenza mensile, sia con escursioni e visite sul<br />
territorio.<br />
Come riportato nel diario <strong>del</strong>le attività svolte, consistente è<br />
stata anche l’opera <strong>del</strong> Comitato di Brescia <strong>del</strong>l’«Istituto per<br />
la Storia <strong>del</strong> Risorgimento Italiano».<br />
Legata statutariamente al nostro Ateneo la «Fondazione<br />
“Ugo Da Como”» di Lonato, ha comunque una sua attività<br />
autonoma, da qualche tempo piuttosto “slegata” da quella <strong>del</strong>la<br />
nostra Accademia anche se i «Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di<br />
Brescia» per l’anno di riferimento, ne raccolgono sistematicamente<br />
gli Atti.
«Commentari <strong>del</strong>l’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.