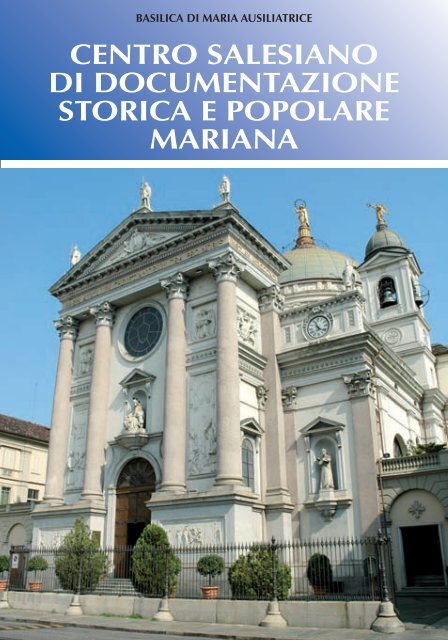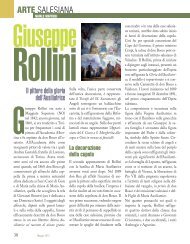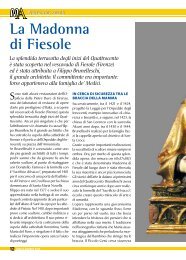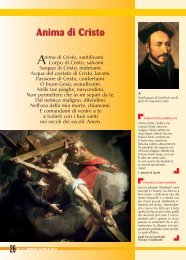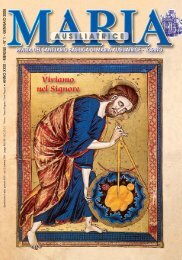â¢Copertina(7)-:Layout
â¢Copertina(7)-:Layout
â¢Copertina(7)-:Layout
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE<br />
CENTRO SALESIANO<br />
DI DOCUMENTAZIONE<br />
STORICA E POPOLARE<br />
MARIANA
CENTRO SALESIANO<br />
DI DOCUMENTAZIONE<br />
STORICA E POPOLARE<br />
MARIANA<br />
A dieci anni<br />
dalla morte di Don Pietro Ceresa<br />
1997-2007<br />
C.S.D.M.<br />
TORINO
PRESENTAZIONE<br />
Il 19 aprile 2007 si sono compiuti dieci anni dalla morte di Don Pietro<br />
Ceresa, creatore ed anima del Centro Salesiano di Documentazione Storica<br />
e Popolare Mariana. Penso sia pertanto doveroso presentare, prima di<br />
tutti a Don Pietro, il suo Centro, con le novità che in esso si trovano e che sicuramente<br />
non mancheranno di incontrare il suo compiacimento, perché<br />
stanno ad indicare che il Centro non si è perduto, ma vive e cresce.<br />
La preoccupazione di noi che siamo subentrati nel suo lavoro, è stata<br />
principalmente quella di conservare quanto lui, con tanto amore e con tanta<br />
passione, lungo tutta la sua vita, ha raccolto e collezionato. Compito nostro<br />
è stato semplicemente quello di ordinare, catalogare e sistemare quanto esisteva<br />
nel Centro. Nel nostro lavoro abbiamo toccato con mano l’enorme<br />
quantità di materiale che Don Ceresa ha saputo raccogliere, in campi più<br />
svariati. E la nostra meraviglia non è ancora terminata, perché tanti sono ancora<br />
i settori che rimangono da esplorare.<br />
Desideriamo pertanto rendere omaggio al lavoro di Don Pietro Ceresa,<br />
dando una panoramica della complessità del Centro di Documentazione,<br />
presentandone gli aspetti più significativi, nella certezza di fare cosa gradita<br />
anche ai devoti di Maria Ausiliatrice, della quale il Centro di Documentazione<br />
testimonia le grandezze.<br />
Don Mario Morra<br />
4
Don Pietro Ceresa.
1. Santuario Basilica Maria Ausiliatrice<br />
2. Cappella Pinardi<br />
3. Chiesa di San Francesco di Sales<br />
4. Camerette di Don Bosco (2º piano)<br />
Mostra storica (1º piano)<br />
5. Centro documentazione mariana
CENTRO SALESIANO<br />
DI DOCUMENTAZIONE STORICA<br />
E POPOLARE MARIANA<br />
ORIGINE E STORIA DEL CENTRO<br />
Il Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana<br />
(CSDM), raccoglie ed offre ai visitatori ed ai ricercatori tutto ciò che<br />
può documentare direttamente o marginalmente, la storia della devozione<br />
del popolo cristiano verso la Madre di Dio, ed in genere tutto ciò<br />
che ha servito e serve alla “pietà popolare”.<br />
Il principale artefice del Centro è stato il salesiano Don Pietro Ceresa,<br />
morto il 19 aprile 1997, al quale il Centro è intitolato. Ecco come<br />
lui stesso ne descrive le origini: «Nel 1918, nella cripta del Santuario<br />
di Maria Ausiliatrice, veniva inaugurato il “Museo del culto di Maria<br />
Ausiliatrice” nel mondo. Le origini di questo museo risalgono al 1915,<br />
allorché il Santuario volle celebrare il primo centenario della festa liturgica<br />
di Maria Ausiliatrice, istituita da Papa Pio VII il 15 settembre<br />
del 1815. Si pensò allora, fra le varie iniziative, di preparare ed allestire<br />
una “Mostra del culto di Maria Ausiliatrice nel mondo”. Ma a causa<br />
dell’imperversare della prima guerra mondiale (1915-1918), non se ne<br />
fece nulla.<br />
Il progetto, ampliato e diventato “Museo del culto di Maria Ausiliatrice”,<br />
si poté realizzare, anche se in forma ancora ridotta, nel 1918,<br />
anno del giubileo cinquantennale della consacrazione del Santuario del-<br />
7
l’Ausiliatrice in Torino. Anima di questa iniziativa fu il Beato Don Filippo<br />
Rinaldi, che poi divenne il terzo successore di Don Bosco e Rettor<br />
Maggiore dell’Opera Salesiana. Il progetto fu realizzato dal missionario<br />
salesiano Don Maggiorino Borgatello.<br />
A questo missionario va il merito di avere documentato la vita e<br />
la civiltà delle popolazioni della Terra del Fuoco, nella punta estrema<br />
del continente americano: gli Onas, gli Alacalufes, i Fueghini, ed<br />
altri rami minori ora estinti. Tornato in Italia, logorato da 26 anni di<br />
lavoro missionario, e divenuto custode del Santuario di Maria Ausiliatrice,<br />
si diede con entusiasmo a raccogliere, studiare e disporre il<br />
materiale che nel frattempo era arrivato da più luoghi. L’inaugurazione<br />
del museo avveniva il 23 maggio 1918, vigilia della solennità<br />
di Maria Ausiliatrice.<br />
Don Borgatello visse ancora 11 anni, durante i quali la sua opera<br />
si accrebbe e fu valorizzata. Dopo la sua morte, tutto entrò nell’ombra<br />
e nel silenzio fino a quando, in seguito ai lavori di ampliamento del Santuario<br />
(1934-1938) ed alle vicende della seconda guerra mondiale<br />
(1939-1945) il materiale divenne irreperibile. Ma la Madonna voleva<br />
accanto al Santuario un “sottosantuario” che documentasse il valore ed<br />
il vigore della pietà popolare mariana. Ciò avvenne nel 1978, sessant’anni<br />
dopo l’inaugurazione della prima raccolta mariana».<br />
Nell’ottobre del 1978, l’ingente materiale documentario mariano,<br />
circa 120 quintali, raccolto in lunghi anni da Don Pietro Ceresa, fu trasportato<br />
da Bologna a Torino e collocato nei locali della cripta del Santuario<br />
di Maria Ausiliatrice. “L’Archivio Storico Mariano” di Bologna divenne<br />
così il “Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare<br />
Mariana” di Torino.<br />
Da quella data, il Santuario di Maria Ausiliatrice tornò ad avere un<br />
centro di documentazione mariana di interesse mondiale.<br />
FINALITÀ DEL CENTRO<br />
8<br />
Il Centro si propone di documentare la devozione ed il culto, sia<br />
antico che moderno del popolo cristiano, tributato a Maria, sulla traccia<br />
delle parole del Papa Paolo VI nella Esortazione Apostolica su “Impegno<br />
di annunciare il Vangelo”: «La religiosità popolare, si può dire,
ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione<br />
di molte deformazioni della religiosità, anzi di superstizioni... ma se è<br />
ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione,<br />
è ricca di valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici<br />
ed i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio<br />
fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede... genera<br />
atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado:<br />
pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli<br />
altri, devozione. A motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri<br />
“pietà popolare”, cioè religione del popolo... Bene orientata, questa<br />
religiosità popolare può essere sempre più, per le nostre masse popolari,<br />
un vero incontro con Dio in Gesù Cristo». (EN 48).<br />
I LOCALI DEL CENTRO<br />
Il Centro Salesiano di Documentazione Mariana è ubicato nei locali<br />
ricavati sotto la Basilica di Maria Ausiliatrice ed è suddiviso in tre<br />
grandi settori: una zona destinata ad Esposizione permanente, una zona<br />
riservata alle Mostre temporanee ed il locale dell’Archivio.<br />
Lungo le scale che portano alle sale espositive, il visitatore può<br />
notare, appesi alle pareti gli ex-voto, alcuni dipinti ed altri a ricamo o<br />
a lavoro di uncinetto. I dipinti votivi sono i pochi conservati all’Ausiliatrice,<br />
e scampati alla quasi totale distruzione avvenuta negli anni<br />
1935-38, durante i lavori di ampliamento del Santuario. Si conserva un<br />
solo ex-voto ad olio su latta risalente al periodo in cui era vivo Don<br />
Bosco.<br />
Zona dell’Esposizione permanente<br />
Il reparto destinato all’esposizione permanente è suddiviso in quattro<br />
settori.<br />
La prima sala potrebbe essere intitolata: Maria nella devozione<br />
popolare. Essa raccoglie quanto si riferisce alla vita di Maria e di<br />
Gesù, a partire dalla Natività (sia di Gesù che della Vergine), fino ai<br />
piedi della Croce. Interessanti sono alcune raffigurazioni del Natale,<br />
Presepi preziosi provenienti da diverse parti del mondo. Immagini<br />
9
della Vergine in pasta di sale, in ceramica, terracotta, legno ed anche<br />
in... francobolli. Campeggia in felice posizione il quadro dell’Immacolata,<br />
fatto dipingere da Don Bosco nel 1882 da Giuseppe Rollini,<br />
il pittore che affrescherà la cupola della Basilica di Maria Ausiliatrice.<br />
Preziosi i cimeli riguardanti la Vergine Addolorata, la Passione in<br />
genere e la Sacra Sindone in particolare: vi è pure il Sacro Chiodo,<br />
con autentica dell’Abate della Basilica di S. Croce in Gerusalemme<br />
di Roma. In vetrine distinte, sono raggruppate le Immagini della Vergine<br />
delle principali Nazioni del mondo, e delle più importanti apparizioni,<br />
quali la Vergine del Pilar, di Lourdes, della Salette, di Fatima,<br />
e di Guadalupe. Una vetrina racchiude grande varietà di Rosari,<br />
usati un tempo dalle diverse Famiglie religiose: vi è pure una corona<br />
del Rosario usata da Don Bosco.<br />
La seconda sala è dedicata a Maria Ausiliatrice e Don Bosco: vi si<br />
possono ammirare il primo disegno ed il bozzetto del quadro di Maria<br />
Ausiliatrice presentati a Don Bosco dal pittore Lorenzone, e, sulla parete<br />
di fronte, una fotografia gigante del medesimo quadro, con l’indicazione<br />
dei nomi degli Apostoli che circondano la Vergine, e dei Santi,<br />
le statue dei quali ornano la cornice dello stesso quadro. Sono pure esposte<br />
le grandi tele di E. Reffo, raffigurante San Francesco di Sales, del<br />
1896, e quella di Mario Caffaro Rore del 1984, raffigurante S. Domenico<br />
Savio circondato da giovani. Le vetrine racchiudono alcuni ricordi<br />
preziosi, come l’Ostensorio regalato da S. Giuseppe Cafasso a Don<br />
Bosco per la Chiesa di S. Francesco di Sales nel 1858; il boccale del<br />
miracolo della bilocazione in Francia di Don Bosco avvenuta il 14 ottobre<br />
1878; la tela di Maria Ausiliatrice con fattezze cinesi, fatta dipingere<br />
a Pechino dal Salesiano Don Mario Acquista-pace. Attira la<br />
curiosità dei visitatori un modellino della Basilica di Maria Ausiliatrice,<br />
costruito in scala, con ben 14.300 fiammiferi, dal sig. Franco Aloardi<br />
di Treviglio (Bergamo); accanto fa bella mostra di sé il modellino<br />
della Casetta nativa di Don Bosco ai Becchi, costruita in perfetta scala,<br />
con mattoni veri, dal sig. Rapolla Michele di Venosa (Potenza).<br />
10<br />
La terza sala è dedicata alla devozione di Maria Ausiliatrice nel<br />
Mondo: vi sono raccolte testimonianze della devozione all’Ausiliatrice<br />
nelle diverse parti del mondo dove lavorano i Salesiani. Le più an-
tiche, sono due documenti autografi del 1659 in lingua Giapponese antico.<br />
In uno, sono riportati l’elenco dei nomi e la dichiarazione di morte<br />
per la fede; nell’altro la dichiarazione di rinuncia alla fede, durante la<br />
medesima persecuzione in Giappone. Accanto a questi documenti si<br />
ammirano una grande spada di Samurai, ed alcune sculture fatte con<br />
radici di albero, raffiguranti gli antenati, del secolo XVIII. Una vetrina<br />
raccoglie le memorie ed alcuni oggetti appartenuti ai due primi Martiri<br />
Salesiani in Cina, Mons. Luigi Versiglia e Don Callisto Caravario, unitamente<br />
ad una Statua di Maria Ausiliatrice donata a Don Egidio Viganò,<br />
nel suo viaggio in Cina nel 1987, da un Vescovo della Cina del<br />
Nord, fedele alla Chiesa di Roma. Si trovano inoltre moltissime immagini<br />
della Madonna, di fatture diverse ed in materiali più svariati, provenienti<br />
dalla Palestina, dall’India, dalle Filippine, dall’America Latina<br />
e dall’Africa.<br />
La quarta sala ospita i libri della Biblioteca del Centro, intitolata<br />
al Cav. Armando Marini, sistemati in armadi compact, in numero di<br />
oltre 17 mila. Essi comprendono opere di consultazione generale sulla<br />
Madonna ed i Santi, con particolare riferimento ai Santuari mariani<br />
presenti in Italia ed all’Estero. Ai volumi si aggiungono le annate di numerose<br />
Riviste mariane, salesiane, di cultura generale. Un ampio settore<br />
della Biblioteca è dedicato ai libri della pietà popolare di questi<br />
ultimi secoli, che costituiscono un patrimonio interessante dal punto<br />
di vista storico, religioso, iconografico ed editoriale.<br />
La sala ospita pure le Icone antiche greche e russe, i Reliquiari, i<br />
Crocifissi ed i Quadri della Donazione dei fratelli Giuseppe ed Ottavio<br />
Gallo. Sulla parete a destra è sistemato il grande Tappeto di m 10<br />
x 5, donato dalle Dame di Firenze a Don Bosco nel 1875 per la Basilica<br />
di Maria Ausiliatrice.<br />
Zona delle Mostre temporanee<br />
La Cripta del Santuario, cioè i locali sottostanti la primitiva Basilica<br />
costruita da Don Bosco, si presta meravigliosamente per le Mostre<br />
temporanee che si allestiscono in determinate occasioni, come il Natale,<br />
la Festa di Maria Ausiliatrice, l’Ostensione della Sacra Sindone, con<br />
il materiale del Centro. Sono state restaurate e collocate, sulle pareti,<br />
11
alcune delle artistiche Vetrate, disegnate dal Prof. Mario Barberis e realizzate<br />
dalla vetreria Janni, che ornavano la Basilica ampliata nel 1938,<br />
e purtroppo distrutte nei bombardamenti del 1943. Nell’ingresso della<br />
Cripta hanno trovato dignitosa sistemazione sei statue restaurate dei<br />
dodici Angeli con lampada, che ornavano dal 1938, in cornice, la grande<br />
pala del Quadro dell’Ausiliatrice, e che nel 1944 sono state sostituite<br />
da quelle attuali di Santi e Sante.<br />
Il locale dell’Archivio<br />
12<br />
Il Centro dispone di Raccolte di vario tipo, tutte catalogate:<br />
— Immaginette devozionali: superano le 30.000 unità e ricoprono<br />
un arco di tempo che va dal 1600 al 1900. Ve ne sono di lavorate ad<br />
ago e forbice, in pergamena o su carta dipinta, in pizzo, di produzione<br />
francese, tedesca ed italiana. Consistenti e svariati i tipi di immagini<br />
per Defunti, per Prime Comunioni e Cresime, per Comunioni pasquali,<br />
divise geograficamente e cronologicamente.<br />
— Litografie, cromolitografie ed incisioni: riguardano le opere dei<br />
maggiori artisti Italiani ed Esteri di tutti i tempi, in riferimento a particolari<br />
fatti della vita di Gesù, della Madonna e di Santi. Sono oltre<br />
5000.<br />
— Cartoline, Calendari, Scapolari, Medaglie, Francobolli: merita una<br />
menzione particolare la raccolta di Filatelia religiosa e mariana.<br />
— Medagliere della Madonna con oltre 900 medaglie, donato dal<br />
Salesiano Don Stefano Cozzi di Ravenna.<br />
— Libretti antichi, anteriori al 1831, riguardanti i Catechismi, Vite di<br />
Santi, Devozione mariana.<br />
— Letture Cattoliche e 46 Collane di Spiritualità, Agiografia, Vita della<br />
Chiesa, ecc.<br />
— Manoscritti antichi.<br />
— Antichi Stendardi Mariani.<br />
— Multimedia: – Cassette audio: Canti (Mariani, Natalizi e Gregoriani)<br />
– Commenti Biblici, Catechesi e Spiritualità mariana, Ecumenismo<br />
– Catechesi e Canti del Movimento del Focolare e del G.A.M. –<br />
Videocassette: Vite di Santi, Santuari mariani, Opere Salesiane – Filmine<br />
Catechistiche – Diapositive: Missioni, Salesianità, Sindone, Terra<br />
Santa – Dischi di Canti Religiosi e Ricreativi – CD e DVD.
Presepio napoletano.<br />
Sala Maria Ausiliatrice.
Modellino della Basilica<br />
di Maria Ausiliatrice<br />
costruito con 14.300<br />
fiammiferi e della<br />
Casetta dei Becchi.<br />
Rosari delle Famiglie<br />
Religiose.
Lavoro su cartoncino Bristol<br />
di Nino Terrana, (Canicattì) (1926).
Bozzetto del quadro<br />
del Lorenzone.<br />
Devozione<br />
all’Ausiliatrice nel<br />
mondo.
Quadri e Messali<br />
antichi.<br />
Decorazioni in<br />
paperol.
Incisioni<br />
su libri liturgici.<br />
Devozione mariana<br />
in Polonia.
ARCHIVIO STORICO<br />
MANOSCRITTI ANTICHI<br />
L’Archivio Storico del Centro racchiude oltre 350 manoscritti. Descriviamo<br />
i più antichi e i più significativi.<br />
Possediamo il Testamento Spirituale del Beato Giovanni Colombini,<br />
(1305-1367) fondatore dei Gesuati, morto il 31-7-1367, cinque<br />
giorni dopo averlo dettato, in rogito del notaio Benedetto Pacis di Città<br />
di Castello, con relativa copia originale e trascrizione del Sac. Tarcisio<br />
Valsecchi.<br />
San Carlo Borromeo (1538-1584) invia al Vescovo di Alba Mons.<br />
Paolo Brizio, in data 18-9-1571, la costituzione di recente editata dal<br />
Papa Pio V sull’approvazione dei confessori. Al Vescovo di Cremona<br />
Mons. Nicolò Sfondrati (poi Papa Gregorio XIV), in data 1-10-1578,<br />
parla del suo imminente viaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone.<br />
Quattro lettere che San Giuseppe Calasanzio (1557-1648) invia a<br />
Confratelli. Lettera a Fratel Carlo della Natività del Signore della casa<br />
di Genova, in data 9-1-1628. Lettere al Padre Arcangelo Sorbino in Cesena,<br />
in data 20-9-1633, in data 24-9-1639, in data 21-12-1644. Sono<br />
tutte con traduzione autentica.<br />
San Camillo De Lellis (1550-1614). Una lettera, senza indicazione<br />
di luogo, datata 27-11-1610. È una lettera di difficile lettura<br />
con firma chiarissima. È stata restaurata dall’Ufficio Restauri dell’Ar-<br />
19
chivio Segreto Vaticano nel 1983. L’autentica è firmata da Antonius<br />
Maria Paganinus, Vicario Generale dell’Arcivescovo di Genova in<br />
data 10-6-1750.<br />
Inquadrata in ricca cornice dorata, possediamo di San Vincenzo De’<br />
Paoli (1581-1660), la lettera a Monsieur Abely Vicario Generale di Bayonne<br />
(testo in francese), spedita da Parigi il 14-1-1640.<br />
San Francesco di Sales (1567-1622). Due Autografi originali riportano<br />
brani di Omelia della 3 a Domenica di Avvento del 1603 (fronteretro)<br />
ed un frammento di scrittura del medesimo con l’autentica dell’Arcivescovo<br />
di Torino Michael Antonius, in data 10-4-1710.<br />
Possediamo una lettera, interamente autografa ed inedita, di Santa<br />
Giovanna Francesca Fremiot di Chantal (1572-1641) scritta da Annecy<br />
in data 2-11 (anno sconosciuto) indirizzata a San Francesco di Sales. È<br />
firmata: Umilissima ed Obedientissima Figlia SR. Giov. Franc. Fremiot.<br />
San Filippo Neri (1515-1595) con lettera, inviata da Roma l’8-12-<br />
1575, presenta alla nipote Suor Maria Vittoria Trievi, Monaca del Monastero<br />
di San Pietro martire a Firenze, le condoglianze per la morte<br />
del padre.<br />
20<br />
Lettera della Beata Giovanna Maria Bonomo (1606-1670), benedettina<br />
del Monastero di San Girolamo in Bassano del Grappa, indirizzata<br />
il 16-12-1638 a suo padre Giovanni, in Vicenza al Carmine.<br />
Cristiani Giapponesi: (1659). Due documenti inviati da Don Mario<br />
Marega sdb (1938) a Don Pietro Zerbino, studiati e tradotti dalla Dr.<br />
Laura Moretti:<br />
— Professione di fede: “Le persone sopra indicate non hanno intenzione<br />
di apostatare. Sigilliamo con le impronte del pollice il fatto che<br />
tale decisione non comporta per noi alcun ripensamento. Di conseguenza<br />
chiediamo disposizioni in merito. Secondo anno dell’era Manji<br />
(1659), decimo mese, primo giorno”.<br />
— Giuramento di Abiura: “Noi rinneghiamo la religione cristiana.<br />
Non diventeremo una seconda volta cristiani. Qui giuriamo solennemente.<br />
Che questo documento serva come atto per il futuro. Quattro<br />
componenti della famiglia Zengoro. Anno del cinghiale, dell’era Manji<br />
(1659), ottavo mese, settimo giorno”.
Sebastiano Valfrè. Lettera del 3-4-1691.<br />
Professione di Fede<br />
dei Martiri Giapponesi,<br />
1659.
San Francesco di Sales.<br />
Brani di omelia<br />
della 3ª Domenica di Avvento, 1603.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,<br />
all’editore Remondini, 3-12-1777.
San Leonardo da Porto Maurizio<br />
alla suora Maria Minima Strozzi.
Silvio Pellico<br />
al fratello Luigi, 27-12-1838.<br />
San Pio X a<br />
Suor Luigina Vertova, 21-6-1914.
Beato Filippo Rinaldi alla Sig.ra Caviglione, 31-7-1916.
San Crispino da Viterbo (1668-1750). Lettera da Roma del<br />
21-9-1744 (?) ad una certa Signora Caterina: “Si assicuri, Signora Caterina<br />
mia, che ogni giorno prego il mio amato Gesù ed in specie la mia<br />
Signora Madre Maria Vergine per lei, acciò le dia pazienza ed a suo<br />
tempo il Paradiso”.<br />
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787). Tra le lettere e scritti<br />
a destinatari vari citiamo la petizione del maggio 1749 inviata, a<br />
nome delle Monache Redentoriste di Napoli, al Re Carlo III da Nocera<br />
dei Pagani e la lettera del 3-12-1777 all’Ill.mo Signore Don Remondini<br />
editore a Venezia.<br />
Di Santa Veronica Giuliani (1660-1727) possediamo cinque lettere<br />
alle sorelle, tra le quali quella da Città di Castello, inviata il<br />
5-1-1710 alla sorella Anna Maria Giuliani, in poesia sul Natale.<br />
San Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Nella lettera, senza<br />
indicazione di luogo e data, alla Suora Maria Minima Strozzi raccomanda<br />
di assicurarsi, con la pazienza e con una perfetta rassegnazione alla<br />
volontà Santissima di Dio, la beata eternità.<br />
Beata Maria degli Angeli (1661-1717). Due lettere indirizzate presumibilmente<br />
al Re Vittorio Amedeo II di Savoia, senza data, ma non<br />
prima del 1713, quando Vittorio Amedeo II divenne Re di Sicilia, e non<br />
dopo l’anno 1717, quando morì Suor Maria degli Angeli.<br />
Beato Sebastiano Valfré (1629-1710). Tra le dieci lettere a destinatari<br />
vari ricordiamo la lettera del 3-4-1691 nella quale dichiara l’ammissibilità<br />
della novizia Suor Maria di Gesù nel Monastero delle Cappuccine.<br />
Le due lettere alla Barona di Villaregia del 1699. La lettera<br />
del 15-3-1708 alla nipote. La lettera del 21-12-1708 con la quale presenta<br />
un libro di meditazioni per ogni giorno dell’anno.<br />
San Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842). Quietanza alle<br />
Regie Dogane (Torino, 28-1-1837): “Dichiaro di aver ricevuto due franchi<br />
e centesimi otto dalle Casse delle Regie Dogane per conto dell’annuale<br />
porzione determinata a favore del fu Coppo Giovanni Battista<br />
di Andezeno”. Due fogli con firme di Giuseppe Benedetto Cottolengo.<br />
San Vincenzo Pallotti (1795-1850). Biglietto al Signor Giovanni<br />
Marchetti (Roma, 18-6-1848): “Prego la sua carità di mettere nelle mani<br />
27
28<br />
di M. G. Vescovo di Gubbio le 100 copie latine e le 200 italiane colla<br />
fiducia che le farà diramare in tutta la Diocesi”.<br />
Silvio Pellico (1789-1854). Tra le sei lettere al fratello Luigi su argomenti<br />
vari, ricordiamo quella del 27-12-1838 nella quale riferisce:<br />
“Ho ricevuto da Parigi una lettera del c.te Confalonieri che mi conferma<br />
l’inutilità delle domande fatte dagli esuli lombardi per rientrare in<br />
patria, e m’annunzia l’arrivo in Francia di parecchi di quelli che erano<br />
in America, fra altri Corsieri, tutti stati illusi dai termini larghi dell’indulto.<br />
I graziati furono assai numerosi, ma gente insignificante di cui<br />
si volevano sbarazzare le prigioni”.<br />
Beato Giuseppe Allamano (1851-1926). Lettera a Ill.mo Signore<br />
(Torino Consolata, 14-11-1902): ringrazia “pel caro regalo delle Reliquie<br />
del nostro santo Patrono delle Missioni d’Africa. Il Signore la rimeriti<br />
della bontà ed insieme della generosità dell’offerta. I miei giovani<br />
missionari pregando ogni giorno davanti alla preziosa Reliquia<br />
non dimenticheranno il buon donatore”.<br />
Beato Luigi Boccardo (1861-1936). Lettera (Torino 1898): invita il<br />
destinatario a collaborare con il Teologo De Alexandris Luigi per un<br />
nuovo Presepio per i giovani della scuola di religione, sezione completa,<br />
sita in via Milano n. 3.<br />
San Giovanni Bosco (1815-1888). Lettera (Torino, 12-8-1871) al<br />
Padre Barrera al quale invia, in allegato, la lettera della Marchesa Cavalletti<br />
Luisa e chiede chiarimenti in proposito. Lettera a Carissimo Signore:<br />
“Mi è giunta a Roma la sua lettera, l’attendo a Torino per parlare<br />
di cose di maggior rilievo. Assicuro preghiere (Roma, Via Sistina,<br />
104, 15-3-1874)”.<br />
Giuseppe Sarto - San Pio X (1835-1914). Lettera del Patriarca al Sac.<br />
Stefano Trione, coordinatore dei lavori di preparazione del Congresso<br />
generale dei Cooperatori Salesiani (14/16-5-1903): il Cardinale si dice<br />
spiaciuto di non poter assicurare la partecipazione al Congresso di un<br />
rappresentante di Venezia. E Benedizione di Papa Pio X a Suor Luigina<br />
Vertova (?) con l’augurio delle migliori grazie da parte del Signore.<br />
Il biglietto è datato due mesi prima della morte del Papa (20-8-1914).<br />
Giacomo Della Chiesa - Benedetto XV (1854-1922). Felicitazioni<br />
ed auguri del Cardinale per il 50º anniversario dell’Ordinazione
Sacerdotale di Don Raffaele Atti (Bologna, 17 maggio 1913). E rescritto<br />
del Papa alla lettera di Don Raffaele Atti nel quale concede<br />
l’autorizzazione ad erigere un altare nella propria camera (Roma, 25<br />
novembre 1919).<br />
Beato Paolo Pio Perazzo (1846-1911). Lettere all’amico Michele<br />
Bert (Torino, 19-12-1887, 11-1-1910, 18-2-1910). Raccomanda alcune<br />
circolari ed iniziative che ha tra le mani riguardanti l’Associazione<br />
dell’Adorazione quotidiana universale perpetua.<br />
Beato Michele Rua (1837-1910). Biglietti a Giulio Barberis del<br />
1883 e 1885 nei quali dà disposizioni varie. Due lettere a Giuseppe Antonio<br />
Musso, banchiere e tesoriere della commissione per la raccolta<br />
delle offerte per il Tempio del Sacro Cuore in Roma (Torino, 28-4-1889,<br />
16-5-1896).<br />
Beato Filippo Rinaldi (1856-1931). Corrispondenza ordinaria<br />
(dal 1916 al 1928) con l’Avvocato Edoardo Caviglione e Signora. Le<br />
lettere sono state consegnate a Don Pietro Ceresa sdb dagli eredi il<br />
20-6-1996. Lettera a Don Rinaldi del Direttore di Barcellona Sarrià<br />
del 23-5-1915.<br />
San Callisto Caravario (1903-1930). Componimento scolastico<br />
di Don Callisto studente liceale a Torino Valsalice, Anno scolastico<br />
1922-1923. Biglietto di Augurio al giovane Carlo Marquez, (Cina,<br />
18-6-1929). Appunto a matita di Orario degli Esercizi Spirituali dell’anno<br />
1929.<br />
San Luigi Orione (1872-1940). Lettera da Reggio Calabria del<br />
7-3-1916 senza destinatario. Lettera da Bra del 28-3-1916 senza destinatario.<br />
Cartolina dall’Abbazia di S. Alberto di Budrio del 1916 a<br />
Don Umberto Pasquale sdb. Lettere a Don Pietro Zerbino sdb, da<br />
Tortona del 2-10-1927 e del 9-7-1928. N. 2 lettere, senza data e<br />
senza destinatario.<br />
Servo di Dio Giuseppe Quadrio (1921-1963). Lettera a Don Pierino<br />
(Roma, 28-6-1947): si scusa di non poter accontentare la sua richiesta<br />
di Benedizioni papali e rimborsa Lire 400.<br />
Venerabile Vincenzo Cimatti (1879-1965). Lettera di obbedienza<br />
a Don Clodoveo Tassinari per la nomina a Direttore della Casa di formazione<br />
(Tokyo, 5-4-1944). È una delle poche lettere di obbedienza in-<br />
29
30<br />
viate da Don Cimatti ai Confratelli dell’Ispettoria. È stata consegnata a<br />
Don Pietro Ceresa sdb l’11-4-1980.<br />
Lettere autografe di Lucia di Fatima (Lucia de Jesus dos Santo)<br />
(1907-2005) a Don Umberto Pasquale. Il Centro di Documentazione<br />
Mariana ha la fortuna di conservare ben 166 lettere autografe scritte da<br />
Suor Lucia al Salesiano Don Umberto Pasquale, il quale è stato dalla<br />
Divina Provvidenza messo in relazione con la sua famiglia e con lei,<br />
come lo fu con la Beata Maria Alexandrina da Costa.<br />
Don Umberto Pasquale, ancora giovane chierico è inviato in Portogallo<br />
dove svolge diverse attività tra le quali, appena ordinato sacerdote,<br />
quella di Maestro dei Novizi. Nello svolgere il suo lavoro di salesiano,<br />
incontra le due figure che segnano profondamente la sua vita, Lucia a<br />
cui è apparsa la Madonna nella Cova di Iria, e una sua quasi coetanea,<br />
Maria Alexandrina da Costa, che egli accompagnerà nella lunga vita<br />
di sofferenza, e della quale descriverà le esperienze mistiche e per la<br />
cui Beatificazione lavorerà con intensità.<br />
Don Umberto scrive «La Provvidenza mi ha coinvolto nell’avvenimento<br />
religioso e mariano più grandioso del nostro secolo: Fatima con il suo<br />
messaggio di salvezza».<br />
Con Lucia Don Umberto entra in relazione attraverso il nipote Giuseppe<br />
Valinho, il primo novizio che egli accoglie nella casa salesiana<br />
di Mogofares, e l’amicizia con Manuel Pedro Marto, padre di Francisco<br />
e Giacinta, per aver accolto gratuitamente in collegio, due suoi nipoti,<br />
Giuseppe Soares e Giulio Rosa, che diventeranno anch’essi Salesiani.<br />
In una lettera, presente nell’archivio del Centro, il buon Nonno<br />
ringrazia Don Umberto per la sua generosità e per avergli procurato la<br />
gioia di incontrare i due nipoti, in una sua visita al collegio.<br />
Sarà proprio in casa di Manuel Pedro Marto che Don Pasquale noterà,<br />
in un angolo della stanza, una rude panchetta, quella sulla quale<br />
Mamma Olimpia, collocava vicino al focolare, per averla sott’occhio<br />
durante le faccende domestiche, la piccola Giacinta inferma, per non<br />
lasciarla sola in camera da letto. A Don Pasquale, che gli chiede quel<br />
ricordo, papà Marto risponde: «che vuol farne di questo rozzo rottame...<br />
di nessun valore?». Ora anche questo prezioso oggetto si trova nel<br />
Museo Mariano dell’Ausiliatrice. Su di essa sedettero tante volte i due<br />
pastorelli con la cugina Lucia a commentare le straordinarie apparizioni<br />
avute nella Cova di Iria.
Ai primi di luglio del 1980, Don Pasquale manda a Suor Lucia la fotografia<br />
della panchetta e le chiede se la ricorda. Il 22 dello stesso<br />
mese Suor Lucia risponde: «Grazie per la fotografia della panca della<br />
casa di Giacinta e Francesco, mi ha fatto ricordare tempi ormai passati!...».<br />
Ringraziando Don Umberto, che le ha inviato la fotografia del Santuario<br />
costruito dal Salesiano Don Mario Castagna in Porto Velho (Brasile),<br />
dedicato al Cuore Immacolato di Maria, Lucia il 26 ottobre 1980<br />
scrive: «è un’altra gloria ed un altro trionfo del suo Cuore Immacolato;<br />
nonostante tutto Ella sta trionfando in ogni parte con la sua protezione<br />
sui figli sparsi per il mondo che Ella percorre, giorno per giorno,<br />
con la luce del suo sguardo verginale di Madre: Madre di Dio e Madre<br />
degli uomini bagnati dal sangue redentore del suo Figlio sospeso in<br />
croce. Così Ella non può tralasciare di amarci».<br />
Fortunati per questi doni e ricordi preziosi, aumentiamo il nostro amore<br />
verso il Cuore Immacolato di Maria, e ci prepariamo con gioia al giorno<br />
in cui anche Lucia sarà dichiarata Beata tra i suoi due cuginetti già<br />
Beati, Francisco e Giacinta. Quel giorno particolarmente radioso sarà<br />
Don Umberto Pasquale che si sentirà attorniato da Beati: i Pastorelli di<br />
Fatima, compresa Suor Lucia, e la Beata Alexandrina Maria da Costa,<br />
che egli ha seguito con tanto amore e devozione.<br />
Deolinda Maria da Costa, sorella di Alexandrina, per incarico di<br />
Don Umberto Pasquale, direttore spirituale della sorella, ha descritto<br />
con molto sacrificio le vicende spirituali di Alexandrina negli ultimi<br />
tredici anni della sua vita, fino al 13 ottobre 1955. Il Centro possiede<br />
n. 68 lettere autografe dal 1938 al 1980.<br />
31
BIBLIOTECA DEL CENTRO<br />
UN INCUNABOLO DEL 1490<br />
Il secolo XV passa alla storia come il secolo delle grandi invenzioni<br />
e scoperte. Giovanni Gutemberg intorno al 1450 inventa la stampa<br />
a caratteri mobili che permetterà la diffusione della cultura attraverso<br />
il libro lungo i secoli, fino a giungere alle attuali possibilità della comunicazione<br />
sociale del nostro tempo, e il 12 ottobre del 1492 Cristoforo<br />
Colombo, sfidando l’oceano aperto, giunge alla scoperta dell’America<br />
ed apre orizzonti nuovi alla civiltà della vecchia Europa.<br />
Il volume più antico, il decano possiamo dire, della Biblioteca del<br />
Centro, porta la data del 1490: “Summula Ioannis de Monte super Petrum<br />
Hispanum”, Edizione Veneziana a cura di Peregrinus Bononiensis<br />
- Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii. È un commento di Giovanni<br />
da Monte, teologo della famosa scuola parigina, sulla logica di<br />
Pietro Hispano, (Pier Giuliani di Lisbona, poi Papa Giovanni XXI),<br />
secondo il pensiero del filosofo Giovanni Scoto. Il volume, anche se<br />
il suo contenuto molto specifico non è oggi di particolare interesse,<br />
è alquanto raro. Non risulta infatti quest’opera nel catalogo del British<br />
Museum – che ne cita altre dello stesso stampatore “Peregrinus<br />
de Pasqualibus bononiensis” – né nello Stillwell (incunaboli in USA).<br />
Il volume manca della prima pagina e necessita di restauro, pur essendo<br />
ancora in discrete condizioni. Si chiude con la dichiarazione<br />
dell’editore: “finem posuit Peregrinus de Pasqualibus bononiensis Venetiis<br />
Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii”, cioè: lo ha conclu-<br />
33
so Peregrino di Pasquale bolognese, in Venezia l’anno del Signore<br />
1490, il giorno 20 luglio.<br />
Abbiamo scarse notizie dell’autore Giovanni da Monte, ma conosciamo<br />
la personalità di Pietro Hispano, Pier Giuliani di Lisbona, cultore<br />
di medicina, che ha lasciato vari libri sull’uso delle erbe medicinali,<br />
come il Thesaurus pauperum, nel quale dà consigli utili per curare<br />
malattie comuni. È però anche filosofo e teologo e lascia diverse<br />
Summulae logicales, trattati cioè di filosofia e di logica in particolare.<br />
Dante Alighieri nel canto XII del Paradiso (vv. 134-135) lo pone tra i grandi<br />
teologi. Dopo l’elogio che San Tommaso, domenicano, fa di San<br />
Francesco amante di Madonna Povertà, San Bonaventura, francescano<br />
creato cardinale da Gregorio X, elogia San Domenico ed i compagni<br />
suoi contemporanei che hanno dimostrato coraggio e profezia: “Ugo<br />
da Sanvittore è qui con elli – e Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano, –<br />
lo qual giù luce in dodici libelli”. Ugo da Sanvittore, canonico regolare<br />
di Sant’Agostino, è un celebre teologo; Pietro Mangiadore, lombardo,<br />
è rinomato per i suoi studi storiografici; Pietro Ispano risplende illustre<br />
(luce) per i suoi dodici libri di logica.<br />
Vescovo di Braga, Pietro Ispano nel 1273 è creato cardinale dal<br />
Beato Gregorio X, e nel 1276 è eletto Papa in Viterbo, come successore<br />
di Adriano V Fieschi, Papa dall’11 luglio al 18 agosto, con il nome<br />
di Giovanni XXI (o meglio XX tenuto conto dell’antipapa precedente).<br />
Egli ha in mente molti progetti da attuare e programma un lungo pontificato,<br />
ma il 20 maggio del 1277 rimane vittima del crollo di una<br />
stanza del palazzo papale di Viterbo.<br />
ALTRE EDIZIONI ANTICHE<br />
Le edizioni del 1500<br />
34<br />
Tra le edizioni del 1500 (sono ben 15) ricordiamo: la • “Bulla S.<br />
D. N. D. Pii Divina Provida Papæ Quinti Extensionis omnium privilegiorum<br />
Ordinibus Mendicantium per S. Sanctitatem concessorum cum<br />
eorum nova concessione... Romæ MDLXVII, Anno Secundo”. È la Bolla<br />
con la quale il Papa S. Pio V, il 15 agosto del 1567 estende i Privilegi<br />
degli Ordini Mendicanti alla Congregazione Lateranense dei Canonici<br />
Regolari di S. Agostino. È un fascicoletto di 18 pagine, con coperti-
Incunabolo del 1490.
Visitazione di Carlo Allet<br />
in Ufficio della B.V. Maria,<br />
Roma 1707.<br />
Natività di Maria<br />
di A. Carracci<br />
in Vita della SS. Vergine<br />
Maria, Firenze 1828.<br />
Annunciazione in Manuale<br />
della donna cristiana,<br />
Milano 1892.
na in cartapecora, legate da sigillo, stampate a Roma presso “Eredi di<br />
Antonio Bladi, impressore, 1567”.<br />
Sette volumi trattano della Madonna: • Lauretanæ Virginis Historia<br />
del 1531, una delle più antiche storie della Santa Casa di Loreto<br />
(pagg. 22);<br />
• Rosario della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, nostra Signora,<br />
“dalle opere del R. P. F. Luigi di Granata de l’Ordine de Predicatori,<br />
raccolto per il R. P. F. Andrea Gianetti da Salò dello stesso Ordine<br />
e Provinciale di Terra Santa, nuovamente ristampato, e di vaghe<br />
figure ornato et abbellito, in Venetia appresso Giovanni Varisco, 1582“<br />
(pagg. 276);<br />
• De vita et laudibus Deiparæ Mariæ Virginis, Meditationes quinquaginta<br />
del P. Francisco Costero, stampato “in Venetia presso Io. Bapt.<br />
Bonfadino, 1588” (pagg. 446 formato tascabile);<br />
• Vita di Maria Vergine e di S. Giovanni Battista. “Scritta dal<br />
Padre Abate Don Silvano Razzi Camaldolense e da lui di nuovo rivista<br />
e ampliata, in Fiorenza per Filippo Giunti, 1590” (pagg. 220,<br />
già restaurato);<br />
• Vita Beatissimæ Virginis, 16 incisioni di Emilia Orsini, “monaca<br />
benedettina del Convento di S. Ambrogio in Roma, 1590”;<br />
• Il Rosario, ovvero Salterio della Sacratissima Vergine e Meditazioni<br />
dei quattro Novissimi: ogni pagina reca la raffigurazione dell’episodio<br />
del singolo Mistero del Rosario con una breve meditazione<br />
e l’indicazione di una virtù da praticare. Stampato in Napoli il<br />
1591 (pagg. 28);<br />
• Delle meditazioni sopra le sette festività principali della B. Vergine<br />
le quali celebra la Chiesa. Parte quarta, “con le Profezie e Figure<br />
del Vecchio Testamento e con i documenti che dall’Evangelo si cavano”,<br />
del P. Vincenzo Bruno, editato in Genova per gli Eredi di Girolamo<br />
Bartoli il 1596 (pagg. 148, formato tascabile).<br />
Nel campo biblico, del 1535 è il volume delle • Concordantiæ Maiores<br />
Sacræ Bibliæ stampato a Lione presso Seb. Gryphium: volume in<br />
8º, (già restaurato), suddiviso in due parti: Concordanze maggiori della<br />
S. Bibbia, e Concordanze delle parti e delle espressioni indeclinabili<br />
di tutta la Bibbia.<br />
37
Sulla vita dei Santi: • Legendario delle vite di tutti li Santi approbati<br />
da la S. Romana Chiesa, tradotto in buona lingua vulgare, comune,<br />
et toscana dal rev. Don Nicolò Manerbio; Volume in 8º, rovinato,<br />
stampato in Venezia presso Girolamo Scotto nel 1562 (pagg. 842): ultimo<br />
Santo di cui parla è S. Nicola da Tolentino.<br />
• Flos Sanctorum, seconda parte, “scritto da Alfonso di Villegas,<br />
e terminato il 1 novembre 1582 a Toledo” (pagg. 676): Volume in 8º,<br />
incompleto; l’ultima vita scritta è quella di S. Lazaro Mendico (mendicante).<br />
Nell’area della Teologia e Spiritualità, del 1586 è il volume • Aureum<br />
Sacræ Theologiæ Rosarium, Tomus tertius, compendio di Teologia<br />
tratto dalla dottrina di S. Tommaso, S. Bonaventura e degli altri sacri<br />
dottori, utile agli studiosi, ai predicatori ed ai curatori d’anime, dedicato<br />
a Papa Sisto V. Volume in 8º rovinato, stampato a Venezia nella Officina<br />
di Damiano Zenario (pagg. 248).<br />
Imponente come mole, è la • Vita di Giesu Christo nostro Redentore<br />
“scritta da Landolfo di Sassonia dell’Ordine Certosino et<br />
fatta volgare da M. Francesco Sansovino”. È un volume in 4º, di pagine<br />
496, molto rovinato, suddiviso in due parti, nelle quali “con<br />
pia et santa dottrina si espongono con facilità gli Evangelii che corrono<br />
tutto l’anno”, utile ai predicatori, ai parrocchiani ed ad ogni<br />
cristiano che desideri vivere secondo la santa fede cattolica. È pubblicato<br />
“in Vinegia presso Altobello Salicato, 1589 alla Libraria della<br />
Fortezza”.<br />
Onora poi la nostra Biblioteca, • Dante con l’espositione di M.<br />
Bernardino Daniello da Lucca, “sopra la sua Comedia dell’Inferno, del<br />
Purgatorio, & del Paradiso; nuovamente stampato, & posto in luce con<br />
privilegio dell’Illustrissima Signoria di Venetia per anni XX”. È la Divina<br />
Commedia ampiamente commentata ed editata “in Venetia, appresso<br />
Pietro da Fino, 1568”. Volume in 8º restaurato (pagg. 717).<br />
38<br />
Corona il nostro patrimonio del 1500, una • Pergamena di Carlo<br />
V “Divina providentia Imperator Romanorum etc.” che concede potere<br />
ed autorità in Bologna a “Petrus de Toledo Marchio Villafranchi”;<br />
è datata 20 dicembre 1534 e misura cm 66 x 58.
Le edizioni del 1600<br />
Le edizioni del 1600 sono 69, non è quindi possibile prenderle<br />
tutte in considerazione; citeremo le più significative. Il Concilio di Trento<br />
(1545-1563) ha portato la riforma liturgica e la revisione dei Libri Liturgici<br />
operata in modo particolare dal Papa S. Pio V (1566-1572). Abbiamo<br />
all’inizio del 1600 diverse edizioni di Messali, riccamente ornati<br />
da incisioni, pubblicate tutte a Venezia nel 1604. Interessante poi<br />
è il • Missale Ambrosianum, “nuovamente rivisto e pubblicato per ordine<br />
dell’Illustrissimo e Reverendissimo D. Federico Cardinal Borromeo,<br />
Arcivescovo della S. Chiesa Milanese”, edito in Milano “presso<br />
gli eredi di Pacifico Pontio, & Giovanni Battista Piccaleo, 1618”.<br />
Sulla Spiritualità di S. Francesco di Sales troviamo: • Le opere di<br />
S. Francesco di Sales, Vescovo e Principe di Geneva, divise in cinque<br />
tomi, pubblicato “in Venetia appresso Girolamo Albrizzi, 1698 (pagg.<br />
384), e • Esercitii spirituali. Per i dieci giorni della Solitudine, conforme<br />
allo spirito di San Francesco di Sales, Vescovo di Geneva, “cavati<br />
la più parte da suoi scritti, e dati alle stampe Italiane dal P. D. Amedeo<br />
Comoto Torinese Chierico Reg. Di S. Paolo. Tomo quinto” edito “in Venetia,<br />
appresso Andrea Poletti, 1688” (pagg. 574).<br />
Sulla vita dei Santi ricordiamo: • Il Nuovo e vero Leggendario<br />
della Vita, e Fatti di N. S. Giesu Christo e di tutti i Santi de’ quali celebra<br />
la festa, e recita l’Officio la Santa Chiesa Cattolica, conforme al<br />
Breviario Romano Riformato, “raccolto da gravi, & approvati Autori; e<br />
dato in luce in lingua Spagnuola dal molto Rever. D. Alfonso Vigliega<br />
di Toledo, Teologo e Predicatore, sotto titolo di Flos Sanctorum. Nuovamente<br />
con diligenza tradotto di Spagnuolo in lingua Italiana da D.<br />
Timoteo da Bagno, Monaco Camaldolese”. Volume in 4º, con piccole<br />
incisioni per ogni festività, edito in Cuneo “appresso Bartolomeo Strabella,<br />
1663” (pagg. 752).<br />
Tra la letteratura riguardante i Santuari, della quale la Biblioteca del<br />
Centro è particolarmente ricca, ricordiamo un libro sicuramente prezioso<br />
in quanto riporta l’iconografia delle tante Chiese dedicate alla Madonna<br />
nella Città di Messina, prima della catastrofe del terremoto: • Iconologia<br />
della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria Protettrice di Mes-<br />
39
sina “divisa in cinque Libri ove si ragiona delle Immagini di Nostra Signora<br />
che si riveriscono nei Tempii, e Cappelle più famose della Città<br />
di Messina; delle loro Origini, Fondationi e singolari avvenimenti. Del<br />
Rev. Padre Placido Samperi Messinese, della Compagnia di Gesù”. È un<br />
volume in 4º, molto rovinato, edito “in Messina, appresso Giacomo<br />
Mattei, stampatore camerale, 1644” (pagg. 640).<br />
Altro volume, con bella incisione di Dom. Barriere, in prima pagina,<br />
è • Primo Trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella Via Lata<br />
da S. Pietro Apostolo, “nel quale si spiegano le prerogative della Chiesa<br />
di S. Maria, Madre di Dio, le glorie della sua miracolosa Imagine. Il<br />
principio, e progressi della sua insigne Collegiata. Li meravigliosi successi<br />
delle Reliquie di S. Ciriaco... da Fioravante Martinelli Romano”.<br />
È un volume formato 8º discretamente conservato, edito “in Roma, per<br />
Nicolangelo Tinassi, 1655” (pagg. 192).<br />
Sui Santuari piemontesi ricordiamo: • Successi della miracolosa<br />
Imagine della Santissima Nontiata, nuovamente scoperta nella Città di<br />
Chieri, “sotto il pastoral Governo di Mons. Illustriss. e reverendiss. Giulio<br />
Cesare Bergera Arcivescovo di Torino. Descritti dal M. R. P. F. Gioseppe<br />
Buonafede, Agostiniano, predicatore di detta Città”. Edito “in<br />
Torino, per Pietro d’Ambrogio, 1655” (pagg. 67); ed il volume, con<br />
bella incisione in prima pagina di N. Auroux, • Historia della Madonna<br />
Santissima d’Oropa ne’ monti della Città di Biella nel Piemonte,<br />
“dedicata A. S. A. R. Anna Borbon d’Orleans Duchessa di Savoia. Divisa<br />
in Libri tre. Nel primo si tratta dell’inventione Figura, e frequenza<br />
della Divotione. Nel secondo de Miracoli, e Gratie concesse ad intercessione<br />
della Beatissima Vergine, colla nuova aggionta de seguiti dell’anno<br />
1659 fin al corrente 1684. Nel terzo d’alcune Orationi, & Essercitii<br />
Spirituali, che si praticano nel Sacro Monte”. È una Guida spirituale<br />
del Santuario di Oropa edita “in Biella per Gio: Giacomo de Giulii,<br />
1684” (pagg. 304).<br />
40<br />
Di più ampio respiro è il volume • Sacra Colchorum Historia del<br />
P. Arcangelo Lamberto della Compagnia di Gesù, che descrive la storia<br />
della conversione al Cristianesimo degli abitanti della Colchide, l’odierna<br />
Georgia. Il Volume in 8º manca della prima pagina di frontespizio,<br />
ma è già stato restaurato. È editato “In Napoli, appresso gl’heredi del Cavallo,<br />
1657” (pagg. 414).
Volume prezioso per la Mariologia è • Bibliotheca mariana alphabetico<br />
ordine digesta, & in duas partes divisa; una bibliografia “degli<br />
Autori che hanno scritto sulla Madre di Dio la Vergine Maria, con recensione<br />
delle opere, e aggiunto un quintuplice indice degli scrittori<br />
mariani”. Il volume è in 16º, autore P. Ippolito Marraccio di Lucca,<br />
edito in Roma “Typis Francisci Caballi, 1648” (pagg. 848).<br />
A coronamento della carrellata sulle edizioni del 1600, possiamo<br />
porre un volumetto originale e prezioso: • Litaniæ Beatæ Mariæ V. in<br />
LVI figuris æneis expositæ, cum Allegoriis ex Sacra Scriptura Desumptis.<br />
È la raccolta di 56 incisioni, formato 16º, su rame di Giovanni<br />
Klauber, che illustrano i diversi titoli mariani delle Litanie, con in calce<br />
un’espressione appropriata desunta dalla Scrittura. È editato in Vienna:<br />
“Viennæ MDCXCVI. Excudebat Joan. Klauber Catholic”.<br />
Volumi editati nel 1700<br />
I volumi editati nel 1700 sono 296; le aree maggiormente presenti<br />
sono: Santuari (52 volumi), Liturgia (76 volumi), Mariologia (44 volumi),<br />
Spiritualità e Patristica (42 volumi), Agiografia (30 volumi). Di questi<br />
settori presentiamo alcuni esemplari.<br />
Tra i volumi riguardanti i Santuari: • Della Sacrosanta Basilica di<br />
San Pietro in Vaticano libri due. “Nel primo de’ quali trattasi delle di<br />
lei Prerogative: Nel secondo ragionasi della nuova struttura della medesima”.<br />
È un volume in 16º, con bella incisione nella prima pagina<br />
dei singoli libri; autori Raffaele Sindone e Antonio Martinetti, editato<br />
“In Roma presso Giovanni Maria Salvioni, Stampator Vaticano, l’Anno<br />
del Giubileo 1750 ” (pagg. 437).<br />
• Memorie istoriche della miracolosa Immagine di S. Maria delle<br />
Grazie esistente in Roma nella V. Chiesa, detta già S. Salvatore in Lauro,<br />
ed ora S. Maria di Loreto della Nazione Picena. È un volume in 16º ancora<br />
ben conservato, con una incisione grande di S. Maria delle Grazie,<br />
Immagine incoronata dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano nel 1654.<br />
L’autore è Gio. Mario Crescimbeni, Maceratese, Canonico di S. Maria<br />
in Cosmedin. Il volume è edito “in Roma, nella Stamperia di Antonio<br />
de’ Rossi alla piazza di Ceri, 1716” (pagg. 131).<br />
• La Miracolosa Immagine della Beatissima Vergine Maria presso<br />
la Città di Mondovì. “Adorata da tutte le Nazioni, con impareggiabili<br />
41
encomi rinomata da più celebri Autori: e co ’l racconto di novi, e maravigliosi<br />
successi, con l’aggiunta dell’Incoronazione”. Volume in 16º,<br />
discretamente ben conservato, pubblicato per ordine del Padre Abate<br />
D. Maurizio Bonaudi, “dedicato a Sua Maestà Vittorio Amedeo Re di<br />
Sicilia, di Gerusalemme e Cipro, & c.”, stampato “in Mondovì appresso<br />
Vincenzo e Gianfrancesco Rossi, 1722” (pagg. 406).<br />
• Descrizione dell’Ottavario per il Miracolo del SS. Sacramento celebrato<br />
dall’Augusta Città di Torino nel terzo anno secolare. Volume in<br />
8º con la cronaca dei festeggiamenti, la raccolta di Sonetti della Contessa<br />
di Grugliasco, e di Componimenti poetici di vari autori. Edito “in<br />
Torino presso Pietro Giuseppe Zappata e Figlio, 1753” (pagg. 108).<br />
Del tutto originale il • Libro III delle B. V. che si venerano in Bologna<br />
e nel Contado. Volume in 4º leg. m. perg. del 1700. “Curiosa<br />
collezione di 178 incisioni a carattere popolare all’acquaforte o in silografia<br />
applicate nel ’700 in album. Stupenda e rarissima raccolta di<br />
stampe del ‘600 e del ’700 raffiguranti ritratti della Madonna che si<br />
venerano in Bologna e nell’Emilia... Incisioni di vari artisti, tra i quali:<br />
Bernardi, Mellini, Moretti, Lelio della Volpe, M. Francia, ... e molte<br />
rare silografie caratteristiche popolari” (dal Catalogo Pregliasco nº<br />
11, 1964).<br />
42<br />
Nell’area liturgica, tra i tanti Messali riccamente istoriati, ricordiamo:<br />
• Missale Romanum edito a Venezia “apud Nicolaum Pezzana<br />
1710”, con il formato eccezionalmente ridotto (8º) e belle incisioni di<br />
Gio Palazzi (pagg. 717); e • Missale Romanum edito in Roma con i tipi<br />
della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, 1714, con formato 4º<br />
e stupende incisioni a tutta pagina di C. Allet ed altri (pagg. 664).<br />
Interessante, per volume e mole di pagine (1319 più aggiunte), è<br />
il • Breviarium Romanum “secondo il Decreto del sacrosanto Concilio<br />
di Trento, pubblicato per ordine di S. Pio V, Clemente VIII & Urbano<br />
VIII, nel quale sono accuratamente disposti i più recenti Offici dei<br />
Santi”. È un volume in 8º, enorme, certo poco maneggevole, molto rovinato,<br />
con bellissime incisioni di “Suor Isabella P. F.”, pubblicato in<br />
Venezia “ex Typographia Balleoniana, 1734”.<br />
Parecchi sono i manuali per la recita dell’Ufficio della Beata Vergine,<br />
rivolti soprattutto ai soci delle tante Confraternite religiose; ne<br />
ricordiamo due soltanto. • Officio della B. Vergine Maria dedicato a
S. Anna Madre dell’istessa Vergine Maria. Con alcune Dichiarationi,<br />
e Pie Meditationi a fin di recitarlo con maggior divotione. Sono quattro<br />
volumi in 8º, con belle incisioni di A. V. Westerhout, pubblicati<br />
in Roma “Ad istanza di Gio: Maria Salvioni, 1707” (pagg. 120); e<br />
• Officium Beatæ Mariæ Virginis, Con l’Uffizio de’ Morti, Sette Salmi,<br />
ed altre diverse Orazioni e Divozioni. È un bel volume in 16º, legato<br />
in pelle nera con fregi e taglio in oro, con belle incisioni di “Suor<br />
Isabella P. F.” Pubblicato in Venezia “a spese di Paolo Balleoni, 1708”<br />
(pagg. 453).<br />
Prezioso • Il Salterio della Beata Vergine composto dal Serafico<br />
San Bonaventura e trasportato in Versi toscani dal Conte Niccolò<br />
Fava. È un libretto in 16º, legato in pelle con fregi in oro, ben conservato,<br />
pubblicato in Bologna “nella Stamperia di Lelio dalla Volpe,<br />
1734” (pagg. 168).<br />
Nell’area della Spiritualità e Patristica, ricordiamo: • Opere Spirituali<br />
della Santa Madre Teresa di Giesù Fondatrice delle Monache, e<br />
Padri Carmelitani Scalzi. Aggiuntovi in questa nuova impressione la<br />
Seconda Parte delle Lettere, con le Annotazioni, tradotte dalla Lingua<br />
Spagnola nella Italiana, e un copioso indice delle cose più notabili.<br />
Nella edizione: “in Venezia presso Antonio Tiuani, 1696” (pagg. 894),<br />
ed in quella: “in Venezia, presso Paolo Baglioni, 1714” (pagg. 635).<br />
• Lettere di S. Francesco di Sales Vescovo e Principe di Ginevra<br />
Istitutore dell’Ordine della Visitazione. Disposte secondo la data<br />
dal 1607 fino al 1612 inclusivamente. Nuova edizione. “Nella quale<br />
si è raccolto un numero grandissimo di Lettere, che non si trovano<br />
nelle precedenti Edizioni; rivedute sugli originali e arricchite di<br />
Sommarj, di Citazioni, di Note, e di Osservazioni”. Quattro Volumi<br />
in 16º (manca il Tomo I) editi in Venezia, presso Simone Occhi,<br />
1777 (pagg. 436).<br />
• Introduzione alla Vita Divota composta da S. Francesco di Sales<br />
Vescovo di Geneva. “In questa nuova Edizione diligentemente corretta,<br />
e riscontrata col Testo Francese”. Volume in 16º con ritratto del<br />
Santo, incisione di “Suor Isabella P. F.”, pubblicato in Venezia presso<br />
l’Erede di Niccolò Pezzana, 1792 (pagg. 353).<br />
• Delle Opere di S. Francesco di Sales Vescovo, e Principe di Geneva.<br />
Opera in sei tomi, formato 16º, con in prima pagina il ritratto<br />
43
del Santo, incisione di B. Falconi, editata in Venezia, presso Giuseppe<br />
Orlandelli “Per la Dita del fu Francesco di Niccolò Pezzana, 1793”<br />
(pagg. 347).<br />
Tra i volumi riguardanti la Vita dei Santi non possiamo dimenticare:<br />
• Il Perfetto Leggendario della vita e Fatti di N. S. Gesù Cristo e di<br />
tutti i Santi..., e Leggendario delle vite de Santi detti Estravaganti, “raccolto<br />
da gravi, ed approvati Autori; e dato in luce dal M. R. D. Alfonso<br />
Vigliega, sotto titolo di Flos Sanctorum con ogni diligenza tradotto<br />
dalla Spagnuola in Lingua Italiana”. Volume in formato 4º, con piccole<br />
incisioni per ogni festività, molto rovinato, edito in Milano nella<br />
Stamperia di Giuseppe Marelli, 1725 (pagg. 688).<br />
• Vita di S. Massimo Vescovo di Torino raccolta da D. Pier Giacinto<br />
Gallizia Canonico dell’Insigne Collegiata di Giaveno dedicata all’Illustrissimo,<br />
e Reverendissimo Capitolo della Metropolitana di Torino.<br />
È un volume in 16º legato in pelle, dai caratteri chiari, ancora ben<br />
conservato, edito in Torino, 1724 “Nella Stampa di Gianfrancesco Mairesse<br />
all’insegna di S. Teresa” (pagg. 182).<br />
• La Vita di S. Francesco di Sales Vescovo, e Principe di Geneva,<br />
Fondatore dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria scritta da Pier<br />
Giacinto Gallitia, Canonico dell’Insigne Collegiata di S. Lorenzo in<br />
Giaveno, e dedicata all’Altezza Serenissima, ed Elettorale di Anna Luisa<br />
de Medici, Principessa di Toscana, Elettrice Vedova Palatina. Volume in<br />
8º legato in pelle, un po’ rovinato, edito in Venezia, 1729 “Presso Nicolò<br />
Pezzana” (pagg. 491).<br />
Volumi editati nel 1800<br />
44<br />
I Volumi editati nel 1800, anteriori al 1831, sono 238. I più numerosi<br />
riguardano la Bibbia. Ben 78 compongono la serie di volumetti, di<br />
200 pagine circa ognuno, • Vecchio e Nuovo Testamento secondo la<br />
Volgata tradotto in lingua Italiana e con annotazioni dichiarato da Monsignore<br />
Antonio Martini Arcivescovo di Firenze ecc. Volumi in 16º,<br />
ognuno dei quali porta in prima pagina una incisione di G. Dala, editati<br />
in Venezia “Tipogr. di Giuseppe Antonelli, 1829”.<br />
Due volumi in 4º, raccolgono le dispense, abbondantemente illustrate,<br />
della Biblioteca Classica Illustrata: • La Bibbia, Volume 1, Disp.<br />
1-104; Volume 2, Disp. 105-240.
Tra le Vite dei Santi e Personaggi della storia: • La Vita del Beato<br />
Oddino Barotto Prevosto della Collegiata di Fossano, sua Patria. Volume<br />
in 8º, legato in pelle, discretamente conservato, con in prima pagina<br />
bella incisione di A. Boucheron, editato in Torino, dalla Stamperia<br />
di Vincenzo Bianco, 1809 (pagg. 177).<br />
• Vie de la Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal.<br />
Fondatrice et Primière Supérieure de l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie.<br />
Volume in 16º, mal conservato, del R. P. G. Beaufils, della<br />
Compagnia di Gesù, edito in Annecy, “Aimé Burdet, Impr.-Libraire du<br />
Clergé, 1826” (pagg. 216).<br />
• Breve compendio della vita del Sommo Pontefice Pio VII felicemente<br />
regnante. Confronti storici e Catalogo ragionato di tutti i Sommi<br />
Pontefici perseguitati, e dei loro Persecutori con Osservazioni relative<br />
del Signor Illevir. Volume in 16º, legato in pelle, un po’ rovinato, edito<br />
in Bologna, Tipografia de’ Franceschi, 1814 (pagg. 146).<br />
Numerosi, come al solito, i volumi riguardanti i Santuari:<br />
• Memorie storiche dell’antica Chiesa del Monte e delle Immagini<br />
da quella trasportate al Cimitero di Bologna. Volume in 16º, editato<br />
in Bologna, 1814, pei tipi del Sassi (pagg. 62).<br />
• Istoriche e fedeli Notizie spettanti al Santuario Parrocchiale della<br />
Madonna del Pilone presso Torino. Compilate dal sacerdote Gaetano<br />
Bologna Parroco della medesima Chiesa. Volume in 16º, legato in pelle,<br />
discretamente ben conservato, con bella incisione del Taurini 1783,<br />
raffigurante l’Annunciazione che richiama il quadro del Defendente<br />
Ferrari in Avigliana. È editato in Torino, 1816, coi tipi di Davico e Picco<br />
(pagg. 134).<br />
• Storia del Santuario Parrocchiale della SS.ma Vergine Incoronata<br />
di Monchiero col ragguaglio della vita del Servo di Dio Andrea Fassini<br />
Preposto del medesimo Santuario. Volume in 16º, rovinato, edito<br />
in Carmagnola, 1817, presso Pietro Barbiè stampatore (pagg. 317).<br />
• Compendio della Storia di Maria Vergine venerata in Torino sotto<br />
il titolo della Consolata e della sua sacra Immagine, e del suo Santuario<br />
con altre particolari nozioni. Opera dedicata A. S. A. R. Carlo Felice<br />
Giuseppe Maria Duca del Genovese. Volume in 8º edito in Torino<br />
dalla Tipografia Davico e Picco, 1819 (pagg.129).<br />
45
• Notizie intorno al celebre Santuario di Maria Vergine posto sul<br />
Monte Berico di Vicenza raccolte da irrefutabili documenti da Don<br />
Ignazio Disconzi Vicentino... Seconda Edizione riveduta, e accresciuta<br />
non solo di nuovi autentici documenti, ma ancora della Narrazione<br />
di tutto ciò che di magnifico si è aggiunto in questo Secolo decimonono<br />
al Santuario medesimo e sue adiacenze. Volume in 8º, con due<br />
belle incisioni della Vera Effigie della Beata Vergine “spoglia dei consueti<br />
ornamenti” e “con i consueti ornamenti”, edito in Vicenza, Tipografia<br />
Mosca, 1820 (pagg. 272).<br />
• Terza Secolare Incoronazione di Maria SS. d’Oropa descritta da<br />
un Sacerdote residente in Biella ed illustrata con alcuni Panegirici analoghi<br />
alla Solennità. Volume in 8º, rovinato, edito “A spese dei Fratelli<br />
Regis orefici e coronari del Santuario di Oropa, 1821” (pagg. 305).<br />
• Relazione del Terzo Centenario di M. ia V. ne d’Oropa ed Origine<br />
genuina dei Simulacri di Oropa e di Crea in confutazione del Biellese<br />
Istorico Ragguaglio. Volume in 16º, con incisione della Statua della<br />
Madonna, editato in Ivrea dai tipi degli Eredi di C. L. Benvenuti, 1821<br />
“A spese di Luigi Regis” (pagg. 450).<br />
• Relazione istorica delle prodigiose traslazioni della Santa Casa<br />
di Nazarette ora venerata in Loreto del Sacerdote D. Vincenzo Murri...<br />
colla descrizione dei più qualificati Doni, che restano presentemente,<br />
e presso la S. Statua e nel rinascente Tesoro di questo Santuario. Quarta<br />
Edizione. Volume in 16º, con bella incisione in prima pagina e, fuori<br />
testo, 4 prospetti dei bassorilievi in marmo che circondano la S. Casa<br />
(Arcangelo Magini 1792), edito in Loreto, nella Tipografia del Giostra,<br />
1825 (pagg. 64).<br />
Interessante la • Guida del Forestiere per la Città di Bologna e suoi<br />
sobborghi divisa in due parti con Tavole in rame. Volume in 16º legato<br />
in pelle, di Girolamo Bianconi, edito in Bologna, per Annesio Nobili,<br />
1820 (pagg. 574).<br />
46<br />
Merita un accenno particolare la Sezione riguardante la Catechetica:<br />
• Catechismus Romanus. Volume in 16º leg. in pelle, con diverse<br />
incisioni all’inizio di ogni capitolo. Manca della prima pagina, per<br />
cui non conosciamo l’Editrice e l’anno di edizione: porta però la Bolla<br />
di Papa Pio IV del 1 novembre 1564, “Super forma juramenti professionis<br />
fidei” ed in copertina, scritto con inchiostro, il nome di colui
Natale di<br />
Jacomo Valeggio<br />
in Missale<br />
Romanum,<br />
Venezia 1608.<br />
Annunciazione di<br />
Suor Isabella<br />
in Ufficio della<br />
B.V. Maria,<br />
Venezia 1708.<br />
Natività di Maria<br />
di A. Carracci<br />
in Vita della<br />
SS. Vergine Maria,<br />
Firenze 1828.
1586.<br />
1582.
che lo usava nel marzo del 1808, un certo Luigi Guidi, erede di tal Telemaco<br />
Guidi (pagg. 639).<br />
• Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini Ad Parochos Pii<br />
V Pont. Max. Jussu editus. Volume in 8º, legato in pelle ben conservato,<br />
con diverse incisioni, pubblicato in Padova, tipografia del Seminario,<br />
1817 (pagg. 534).<br />
• Compendio della Dottrina Cristiana assegnato da Monsignore Fr.<br />
Lodovico Terin Bonesio Vescovo di Bobbio ad uso della sua Diocesi,<br />
pubblicato ed esteso a tutta la Diocesi di Modena. Volume in 16º legato<br />
in pelle, ben conservato. L’esposizione della dottrina è in forma<br />
di domande e risposte ad uso dei Parroci e dei Curati. Pubblicato in Modena,<br />
1803 per gli Eredi Soliani (pagg. 180).<br />
• Dottrina Cristiana estratta da S. Tommaso, dal Catechismo Romano,<br />
dal Cardinal Bellarmino, e da altri buoni Autori. “Opera del<br />
Padre Giuseppe Domenico Boriglioni, Fondatore della Congregazione<br />
della Dottrina Cristiana in Avignone. Edizione novissima - Tomo secondo”.<br />
Volume in 16º, legato in pelle, ma rovinato, editato in Milano,<br />
presso Giacomo Agnelli, 1821 (pagg. 442).<br />
Riassumendo, la situazione della Biblioteca del Centro di Documentazione<br />
Mariana, quanto a libri antichi, è la seguente: i volumi<br />
editati prima del 1831, considerati antichi, sono complessivamente<br />
618 e riguardano in modo particolare materie ecclesiastiche,<br />
secondo la natura propria della Biblioteca. Nella gran maggioranza<br />
essi sono in cattive, per alcuni pessime, condizioni, e necessitano di<br />
essere restaurati.<br />
LIBRI ANTICHI RESTAURATI<br />
In questi ultimi due anni, con il contributo della Soprintendenza<br />
ai Beni Librari della Regione Piemonte e della Conferenza Episcopale<br />
Italiana, si è potuto iniziare il restauro del volume più antico, l’incunabolo<br />
del 1490, e di altri 11 volumi del ’500 e ’600.<br />
Il restauro è stato eseguito con competenza dal Laboratorio dell’Abbazia<br />
dei Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, dei Padri Benedettini.<br />
Il più prezioso è la • Summula Ioannis de Monte super Petrum<br />
49
50<br />
Hispanicum, Edizione Veneziana a cura di Peregrinus Bononiensis –<br />
Anno domini MCCCCXC die vero XX Julii”. È un commento di Giovanni<br />
da Monte, teologo della famosa scuola parigina, sulla logica di Pietro<br />
Hispano (Pier Giuliani di Lisbona, poi Papa Giovanni XXI), secondo<br />
il pensiero del filosofo Giovanni Scoto.<br />
Degli altri 11 volumi riportiamo i dati essenziali:<br />
• Manerbio Nicolò, Leggendario delle vite di tutti li Santi approbati<br />
da la S. Romana Chiesa, tradotto in buona lingua vulgare - Girolamo<br />
Scotto, Venetia 1562;<br />
• Di Villegas Alfonso, Flos Sanctorum. Seconda parte - 1582;<br />
• Gianetti Andrea, Rosario della Sacratissima Vergine Maria madre<br />
di Dio nostra Signora, dalle opere del R. P. F. Luigi di Granata - Giovanni<br />
Varisco & Compagni, Venetia 1582;<br />
• De Themesvuar Pelbarto, Aurum Sacrae Theologiae Rosarium,<br />
Iuxta quatuor Sententiarum libros quadripartitum - Tomus tertius - ex Officina<br />
Damiani Zenarij, Venetiis 1586;<br />
• Costero Francesco, De vita et laudibus deiparae Mariae Virginis,<br />
Meditationes quinquaginta - Tip. Baptista Bonfadinum - Venetiis 1588;<br />
• Landolfo di Sassonia, Vita di Giesu Cristo Nostro Redentore -<br />
Tip. Altobello Salicato - Vinegia 1589;<br />
• P. Vincenzo Bruno, Delle Meditationi sopra le sette festività principali<br />
della B. Vergine le quali celebra la Chiesa et sopra il Comune de’<br />
Santi, parte quarta - Heredi di Girolamo Batoli - Genova 1596;<br />
• Aria Francesco, Profitto Spirituale, Nel quale si insegna a fare<br />
acquisto delle virtù & progresso nello spirito - Editr. Compagnia Bresciana<br />
- Brescia 1602;<br />
• Diez Filippo, Mariale della Sacratissima Vergine Maria nel quale<br />
si contiene molte considerazioni spirituali & ponti principalissimi della<br />
S. Scrittura, sopra tutte le sue festiuità dove si tratta della sua vita e miracoli<br />
- Editr. Giunti - Venezia 1607;<br />
• Vigliega Alfonso, Il perfetto e nuouo Leggendario de’ Santi detti<br />
estravaganti - Barezza Barezzi Libraro alla Madonna, Venetia 1611;<br />
• Saperi Placido, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio<br />
Maria protettrice di Messina, divisa in cinque libri - Giacomo Matthei<br />
Stampatore Camerale - Messina 1644.
Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio,<br />
Protettrice di Messina<br />
Può essere interessante sfogliare il libro “Iconologia della gloriosa<br />
Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, divisa in cinque<br />
libri” e riportare le descrizioni ed i commenti, resi ovviamente in linguaggio<br />
accessibile, di alcune Immagini della Madonna particolarmente<br />
venerate in Messina.<br />
Dopo un’ampia dedica “Agli Illustrissimi Senatori della Città di<br />
Messina”, l’autore in “Avvisi al pio lettore” puntualizza la motivazione<br />
dell’opera e ne indica gli scopi. “La riconoscenza dei ricevuti benefici<br />
suol essere un acuto sprone agli animi generosi dei benefattori<br />
per più benignamente dispensare degli altri, come all’incontro la dimenticanza<br />
di quelli, è a guisa del sale, che rende sterile il campo, fecondo<br />
per altro, d’opportuni favori. Ha la Città di Messina in ogni secolo,<br />
in ogni età dalla Gran Madre di Dio Maria, Unica sua Protettrice, di grazie<br />
singolari copiosissimi frutti ricevuti, onde di tempo in tempo, li ha<br />
in mille tributi di lode, con mille ringraziamenti riconosciuti: ora rizzando<br />
Templi, ora consacrando Altari... con dedicare sotto diversi titoli<br />
antiche e moderne Immagini al Santissimo Nome di lei”. Passa quindi<br />
a dare al pio lettore alcuni avvisi per ben approfittare dell’opera: è<br />
scritta in lingua italiana, e non in latino, perché sia più facile leggerla;<br />
di fronte ad Immagini circondate da tante targhe votive, occorre considerare<br />
l’abbondanza delle grazie concesse dalla Vergine, ecc.<br />
Il primo libro introduce l’argomento del culto delle Immagini, antico<br />
nella Chiesa primitiva, e quindi si ferma a considerare il culto<br />
della Madonna in Messina: “Come per singolare favore della B. Vergine,<br />
sia stata arricchita la Città di Messina di alcune Immagini di lei<br />
antichissime di quella prima antichità”, “La santissima Vergine è universale<br />
benefattrice di tutti i Fedeli, ma in particolare della Città di<br />
Messina”. Dopo un breve prospetto della storia civile e cristiana di<br />
Messina, e l’indicazione di alcuni personaggi illustri messinesi, passa<br />
alla descrizione del “Duomo consacrato alla Vergine Assunta, detto anticamente<br />
S. Maria la Nuova” e “Dell’antica Immagine della Madonna<br />
Assunta, titolo del Duomo, e delle solennità che ad essa si fanno”.<br />
Nella processione del pomeriggio del 15 agosto, viene portata con<br />
grande solennità la “Bara”, una grandiosa macchina a piramide costrui-<br />
51
ta dal “Maestro detto Radese”, abbellita ed accresciuta nel corso degli<br />
anni, che nel 1535 attira l’ammirazione di Carlo V, accolto solennemente<br />
in Messina. Appena la “Bara” appare sulla pubblica via, “si<br />
scarica una buona quantità di mortaretti” a significare le schiere degli<br />
Angeli che accompagnano “quell’anima fortunatissima della Beata<br />
Vergine, quando uscita dal santissimo Corpo, accolta nel beato seno<br />
del suo dilettissimo Figlio, se ne saliva in Cielo”. La piramide poggia<br />
su un basamento ciclopico, tutto costruito su robuste travature di legno<br />
e di ferro, che scivola sul terreno grazie a due enormi slitte. Nel suo<br />
interno parte il movimento del meccanismo della prima metà della<br />
piramide, regolato da quattro uomini che girano la manovella, mentre<br />
altrettanti sono chiusi tra il sole e la luna e girano un’altra manovella<br />
che dà il movimento al resto della macchina. Sulla piattaforma<br />
rotante lentamente, prende posto un gruppo di bambini in funzione<br />
di angioletti, con in mano candidi gigli; nel centro vi è il coro degli<br />
Apostoli attorno alla Madonna giacente sul letto di morte. Quindi una<br />
serie di nuvole, Profeti, Patriarchi e Angeli, stanno a simboleggiare<br />
l’apoteosi della Madonna Assunta in cielo, raffigurata in alto, su un<br />
globo celeste, da una ragazza di 12 anni, sostenuta dalla destra del Cristo<br />
(un ragazzo di 14 anni), in paludamento di gloria “di un ricchissimo<br />
drappo di broccato d’oro”.<br />
Questa grandiosa macchina è così artificiosamente fabbricata che,<br />
le tante persone che sostiene, oltre 150, stanno tutte comodamente e<br />
senza disagio, sostenute da meccanismi nascosti, “tanto che non vi è<br />
persona così erudita e curiosa che, avendola vista una volta, non desideri<br />
vederla ancora, non saziando mai la curiosità, come infatti piacque<br />
moltissimo all’Altezza di Don Giovanni d’Austria, nell’entrata nella<br />
Città di Messina, nell’anno 1571...”.<br />
Maria nel mistero del Natale, in Messina del 1600<br />
52<br />
Nel medesimo volume troviamo la Beata Vergine onorata in due<br />
quadri riguardanti il mistero del Natale: La Madonna del Parto, nella<br />
Chiesa del Convento dei Cappuccini, e S. Maria dell’Epifania, nella<br />
Chiesa di S. Nicolò, della Casa professa della Compagnia di Gesù.<br />
Interessante la storia delle origini, riportata dall’Autore. Sette anni<br />
appena dalla fondazione dell’Ordine dei Cappuccini, uno dei primi<br />
religiosi del nuovo Ordine, Fra Ludovico da Reggio, “uomo di gran-
Iconologia della<br />
Gloriosa Vergine Madre di Dio,<br />
Protettrice di Messina, 1644.
Maria<br />
nel mistero<br />
del Natale.<br />
“La bara”<br />
portata<br />
in processione,<br />
1535.
dissimo zelo, diligente nella primitiva e rigorosa osservanza”, 1 nel 1531<br />
manda Fra Bernardino Giorgio, famoso predicatore, a Messina. La calda<br />
parola dello zelante frate è accolta dalla popolazione con grande devozione<br />
ed entusiasmo; molte sono le conversioni in ogni ceto di persone,<br />
tanto che la Città richiede ed ottiene alcuni frati per la fondazione<br />
di un Convento, in luogo ameno a due miglia dalla Città. Le vicende<br />
dei primi tempi dell’Ordine dei Cappuccini sono tormentose e battagliate,<br />
per cui quando, due anni dopo Fra Bernardino Giorgio ritorna<br />
a Messina e bussa alla porta del Convento, si vede arrestare e rinchiudere<br />
in una cella prigione. La cella però ha una finestrella che permette<br />
di vedere, in lontananza, il Convento di S. Maria di Gesù, “detto<br />
il Superiore” circondato da un ameno bosco. Affacciandosi, un giorno,<br />
Fra Bernardino vede un bellissimo ragazzino che, armato di arco e<br />
frecce, va cacciando uccellini. Il prigioniero gli fa cenno di avvicinarsi,<br />
e lo prega di portare una sua lettera al Viceré Ettore Pignatelli, che<br />
si trova in Messina. In essa spiega la sua ingiusta reclusione ed invoca<br />
aiuto. Il Viceré si trova nel suo studio, ingolfato nei tanti affari, quando<br />
si vede cadere sul tavolo, inaspettata la lettera. Meravigliato, considera<br />
prodigioso il fatto: apre la lettera, la legge e comprende la gravità<br />
del caso. Lascia ogni lavoro, “monta a cavallo e se ne vola al Convento”<br />
2 ed ordina l’immediata liberazione del prigioniero. I Frati del<br />
Convento, che hanno tenuto in rigoroso silenzio il fatto, sono spaventosamente<br />
meravigliati. Fra Bernardino chiede al Viceré come e da chi<br />
abbia ricevuto la sua lettera, ed apprende il fatto straordinario.<br />
“Ora su l’Altare maggiore della divota Chiesa de’ Frati Cappuccini<br />
si venera l’artistico quadro della Madonna del Parto, opera dell’eccellente<br />
pittore Michel Angiolo da Caravaggio”. 3<br />
Nella Chiesa della Casa professa della Compagnia di Gesù, dedicata<br />
a S. Nicolò, si trova poi una copia della Madonna di S. Luca, che<br />
si venera con grande devozione in Roma, fatta dipingere da “il B. Francesco<br />
Borgia Terzo Generale della Compagnia di Giesù, verso l’anno<br />
del Signore 1567, mentre stava propagando, per mezzo dei suoi reli-<br />
1<br />
Padre PLACIDO SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria<br />
Protettrice di Messina (Messina, Giacomo Mattei, 1644).<br />
2<br />
Opera citata.<br />
3<br />
Opera citata.<br />
55
giosi, in tutte le parti della cristianità, la gloria di Dio e la devozione<br />
di Maria Vergine e il sacro culto dei Santi ”. 4<br />
Sotto l’Immagine di S. Maria Maggiore è pure collocata “un’antichissima<br />
Immaginetta di poco meno di due palmi di grandezza col<br />
manto pure d’argento, che con un velo di damasco cremisino si copriva”.<br />
Questa Immagine della Madonna è ritenuta miracolosa in quanto<br />
il 15 di settembre del 1588 incomincia a lacrimare, nella casa privata<br />
di due signore devote. Dato l’afflusso di fedeli che subito si crea, il Vicario<br />
del Vescovo, “D. Thomaso Calvo huomo di singolar prudenza e<br />
virtù, che poi fu Vescovo di Tropea... giudicò che quella Sacra Imagine<br />
non doveva rimanere in casa privata” e la consegna ai Gesuiti che<br />
la collocano nella cappella predetta.<br />
La Pala dell’Altare Maggiore della Chiesa di S. Nicolò è dedicata<br />
alla Madonna dell’Epifania. Il quadro rappresenta “la Santissima Vergine<br />
col Puttino in braccio da tre Magi adorata, opera di Cesare di Milano,<br />
stimata da’ periti la miglior gioia di Europa”. 5<br />
Devozione alla Madonna della Lettera in Messina<br />
La devozione alla Madonna della Lettera è caratteristica della Città<br />
di Messina, ed è avvalorata da una antichissima tradizione. Avendo accolto<br />
con grande entusiasmo l’annuncio del Vangelo predicato da S.<br />
Paolo nei suoi viaggi apostolici, gli abitanti di Messina ardono dal desiderio<br />
di conoscere personalmente la Gran Madre di Dio, e mettersi<br />
sotto la sua protezione. Pensano quindi di inviare una loro delegazione<br />
a Gerusalemme con una lettera, nella quale professano la loro fede<br />
e chiedono la protezione di Maria. Nell’anno 42, S. Paolo in persona<br />
accompagna la delegazione e la presenta alla Madonna, la quale l’accoglie<br />
con materna bontà ed, in risposta della missiva, invia ai Messinesi<br />
una sua Lettera, scritta in ebraico. In essa Maria loda la loro fede,<br />
gradisce la loro devozione, ed assicura loro la sua perpetua protezione.<br />
Così termina la Lettera: “Benediciamo voi e tutta la cittadinanza ed<br />
assicuriamo la nostra perpetua protezione”. Da allora cresce grandemente<br />
la devozione dei Messinesi verso la Madonna; è eretta una chie-<br />
56<br />
4<br />
Opera citata.<br />
5<br />
Opera citata.
sa, poi ampliata, sulla porta della quale viene scritta in lettere greche<br />
la frase: “Velox ad audiendum” (Pronta ad ascoltare) a significare come<br />
nel corso dei secoli Maria sia stata maternamente presente non solo nell’accogliere<br />
le domande degli abitanti di Messina, ma molte volte anche<br />
nel prevenirle. 6<br />
Nella ricostruzione del vecchio Campanile, dopo il terremoto del<br />
1908, la scena è riprodotta in modo spettacolare. Al suono delle campane<br />
a mezzogiorno nella loggia del quarto piano si animano personaggi<br />
alti due metri. Davanti al trono, sul quale siede la Madonna con<br />
il Bambino, appare dapprima un Angelo con nella sinistra una palma<br />
e nella destra una lettera che porge alla Madonna; quindi viene S. Paolo<br />
che si china davanti al trono ed introduce l’ambasceria; il primo Ambasciatore<br />
si china come S. Paolo, viene benedetto e consegna la lettera;<br />
quindi sfilano tutti gli altri Ambasciatori che si chinano davanti al<br />
trono e sono a loro volta benedetti. Al termine della sfilata la Madonna<br />
benedice la Città ed il Popolo di Messina.<br />
È interessante scoprire le tante raffigurazioni della Madonna della<br />
Lettera, riportate nel volume del Rev. Padre Placido Samperi Messinese,<br />
della Compagnia di Gesù, Iconologia della gloriosa Vergine Madre<br />
di Dio Maria Protettrice di Messina.<br />
La prima la troviamo nella Cappella del Palazzo del Senato, opera<br />
del pittore messinese Antonino Barbalonga, nella quale la Madonna,<br />
circondata da Angeli, è rappresentata mentre con la mano destra alzata<br />
benedice gli Ambasciatori, presentati da S. Paolo, e con la sinistra consegna<br />
loro la lettera. Un altro quadro si trova nella chiesa del Monastero<br />
di S. Paolo, dove è custodita con grande devozione. La Madonna<br />
vi è raffigurata non seduta in trono, ma in piedi mentre viene incontro<br />
agli Ambasciatori per consegnare loro la lettera. Un quadro simile<br />
lo troviamo anche nella chiesa “de’ Fanciulli dispersi” cioè abbandonati,<br />
anch’essi raffigurati nel dipinto.<br />
Più interessante ed originale è l’immagine della Madonna della<br />
lettera nella chiesa di S. Nicolò de’ Greci. Tra tanti quadri raffiguranti<br />
la Madonna, tutti antichi e bisognosi di restauro, ve n’è uno al quale<br />
nessuno dà importanza. “Il pittore Paolo Savola, che già ha restaurato<br />
6<br />
FRANCESCO ROZZI in Giardinetto di Maria, serie 1ª, Volume V, pag. 224 (Bologna,<br />
Libreria dell’Immacolata, 1864).<br />
57
gli altri quadri, per la devozione che porta alla Madonna, chiede di<br />
poter restaurare anche quella tavola con la pittura antichissima, tutta<br />
tarlata e in parte scorticata nei colori, e la porta a casa sua. È un’immagine<br />
dipinta all’antica, con un manto come usano le donne egiziane,<br />
con un Bambino in braccio che sta rimirando la madre”. Ripulito<br />
il dipinto, “si scoprì nelle mani del Puttino un foglio sul quale si vedono<br />
scritte alcune lettere greche. ... Il Cappellano, vedendo quello scritto<br />
non si cura di leggerlo, pensando sia una sentenza del Santo Vangelo,<br />
secondo l’uso della Chiesa greca. Ma osservandolo bene, il dottor<br />
D. Leonardo Parè, professore di lingua greca, legge con attenzione<br />
quei caratteri e si accorge che sono il principio della Lettera della Beata<br />
Vergine scritta ai Messinesi: La vergine Maria, figlia di Gioacchino,<br />
umile Ancella di Dio, Madre di Gesù Cristo, della tribù di Giuda, della<br />
famiglia di Davide, a quanti sono in Messina salute e benedizione di<br />
Dio Onnipotente. Questo avviene nel giorno appunto di S. Caterina<br />
Alessandrina 25 di novembre 1643”. 7 La felice scoperta provoca il<br />
pianto del professore Parè e suscita l’entusiasmo dei devoti.<br />
L’omaggio della Congregazione Salesiana al Papa Leone XIII<br />
per il suo Giubileo Sacerdotale (31-12-1887)<br />
Conosciamo tutti la devozione e l’amore di Don Bosco per il Papa,<br />
successore di S. Pietro, per Pio IX, ed in particolare per Leone XIII al<br />
quale ha avuto la gioia di consegnare terminata, nel maggio del 1887,<br />
la Basilica del S. Cuore al Castro Pretorio in Roma, che tanto stava a<br />
cuore al Papa, ma che a lui era costata tante fatiche e sofferenze. Il 31<br />
dicembre 1887 tutta la Cattolicità celebra con grande solennità il Giubileo<br />
Sacerdotale di Leone XIII; Don Bosco è al termine della sua vita.<br />
Frusto e stanco morirà un mese dopo; non vuole però che manchi la<br />
Congregazione Salesiana nel coro di voci che inneggiano al Papa. La<br />
Tipografica Salesiana di Torino offre un elegante ed artistico volume<br />
nel quale sono presentate, riccamente istoriate l’Enciclica Aeterni Patris<br />
e le due Lettere riguardanti gli studi Storici e gli studi delle Lettere.<br />
Il titolo del volume è La Filosofia la Storia e le Lettere nel concetto di<br />
58<br />
7<br />
Padre PLACIDO SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria<br />
Protettrice di Messina (Messina, Giacomo Mattei, 1644).
Leone XIII (Torino, Tipografia Salesiana, 1887). La Biblioteca del Centro<br />
Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana ha la fortuna<br />
di possedere ben due copie di questo Volume, una delle quali<br />
porta la dedica autografa del Beato Michele Rua, primo Successore di<br />
Don Bosco: “Omaggio di stima e riconoscenza degli Allievi dell’Oratorio<br />
di S. Francesco di Sales in Torino. Sac. Michele Rua”.<br />
Il Volume si apre con una finissima Silografia del Papa Leone XIII<br />
benedicente, in abiti pontificali con triregno, a fronte della Dedica incastonata<br />
in una struttura architettonica formata da sovrapposizioni di<br />
fregi con colonne: “A Leone XIII che, preceduto da non peritura fama<br />
di virtù, sapienza e zelo accompagnato dal plauso riverente affettuoso<br />
di tutto l’Orbe, celebra al 31 dicembre 1887 il Giubileo Sacerdotale,<br />
la Pia Società Salesiana, propagatrice volenterosa degli alti intendimenti<br />
Filosofico-Letterarii che Egli testimoniò con la parola e coll’esempio,<br />
consacra”. Segue un’ampia e dotta Introduzione sul Pensiero Filosofico,<br />
Storico e Letterario del Papa, del Sacerdote Francesco Cerruti,<br />
responsabile delle Scuole e degli Studi nella Congregazione Salesiana.<br />
Viene quindi riportata, nel testo originale in Lingua Latina, con a fronte<br />
la traduzione in Lingua Italiana, l’Enciclica Aeterni Patris, seguita<br />
dalla Lettera sugli Studi Storici, e dalla Lettera sugli Studi delle Lettere<br />
da promuovere nel Seminario Romano.<br />
Tipograficamente, il volume, formato “in folio” (cm 29 x 39,5), si<br />
presenta in un’elegantissima e ricchissima edizione; composto a mano<br />
con caratteri tipografici, si sviluppa in 100 pagine numerate con cifre<br />
arabiche e 32 pagine iniziali con numerazione romana. La stampa tipografica<br />
è a più colori con argento, oro e bronzo in polvere. Nelle cornici<br />
delle singole pagine, che mai si ripetono, si alternano oltre venti<br />
colori dalle delicate tinte pastello a colorazioni più forti ed intense.<br />
L’originalità dell’edizione è costituita dalla ricercatezza delle cornici che<br />
inquadrano le pagine del testo, formate da combinazioni innumerevoli<br />
di fregi, di ispirazione rinascimentale e barocca, che vogliono presentare<br />
l’amplissima varietà di tipi della Tipografia di Don Bosco. Ciascuna<br />
parte dell’opera (Introduzione, Enciclica e le due Lettere) è preceduta<br />
da un occhietto e da un frontespizio sontuosi di decorazioni.<br />
Chiude il volume un’immagine originale composta da un ovale,<br />
contornato da otto drappeggi in cui sono menzionate tutte le Tipografie<br />
Salesiane dell’epoca, da quella principale di Via Cottolengo 32, ini-<br />
59
ziata nel 1862, comprendente la fonderia di caratteri, galvanotipia,<br />
stereotipia e Cartiera, a tutte le altre sparse nel mondo.<br />
(Consulenza tecnica di Ottavio Davico)<br />
Un Nuovo Messale Romano in omaggio al Papa Leone XIII<br />
nel suo Giubileo Episcopale<br />
In occasione del Giubileo Episcopale di Papa Leone XIII la Scuola<br />
Tipografica Salesiana di Torino ha preparato, come omaggio di affetto<br />
e devozione della Congregazione Salesiana tutta, una nuova edizione<br />
del Messale Romano. Il Bollettino Salesiano del febbraio 1893<br />
ne dà l’annuncio ufficiale e ne traccia il piano editoriale, basato sulla<br />
edizione tipica di Ratisbona.<br />
“È una splendida edizione elzeviriana riccamente illustrata, la<br />
quale, destinata a ricordare il Giubileo Episcopale di S.S. Leone XIII,<br />
come un omaggio della Pia Società Salesiana al sapiente Pontefice, crediamo<br />
pure possa supplire alla assoluta deficienza che si lamenta in<br />
Italia di lavori di tal fatta... Fu perciò nostra particolare cura che nelle<br />
figure, nei fregi e nei caratteri parlasse, a così dire, l’Italia cattolica, mediante<br />
la riproduzione di tanti bei lavori, i quali resero così gloriosa<br />
l’epoca del millecinquecento...”. 8 Le illustrazioni sono tratte da soggetti<br />
“tutti d’autori i più celebri dell’epoca sopradetta, come il Beato<br />
Angelico, il Mantegna, il Perugino, il Gaudenzio Ferrari ed altri, ma<br />
più specialmente di quest’ultimo, meritamente chiamato il Raffaello<br />
del Piemonte... Tutto fu studiato con cura sulla stupenda pubblicazione<br />
paleografica di Montecassino che riproduce fedelmente ricche pergamene<br />
di quell’abbazia, in cui si ammirano le prime forme d’iniziale<br />
latine da noi adottate... Anche gli ornati sono di purissima e nobile<br />
origine, essendoci serviti a modelli il Breviario del cardinale Grimani<br />
della Biblioteca Marciana di Venezia, gli Antifonari di Papa S. Pio<br />
V, ora nella R. Pinacoteca di Alessandria, e specialmente il Breviario<br />
di Re Mattia Corvino che per miniatura d’ornati costituisce il tesoro più<br />
prezioso della Biblioteca Vaticana.<br />
Ma il primo e speciale ornamento del nostro Messale volemmo<br />
fosse posto al Canone... un bel fac-simile dalla miniatura più grandio-<br />
60<br />
8<br />
Bollettino Salesiano, febbraio 1893.
Omaggio a Leone XIII per<br />
il Giubileo Sacerdotale, 1887.
Nuovo Messale Romano<br />
per il Giubileo<br />
Episcopale<br />
di Leone XIII, 1893.
sa del prezioso Messale del Cardinale Domenico della Rovere, esistente<br />
ora nel civico Museo di Torino”. 9<br />
I ragazzi della Legatoria, nel rilegare il volume con arte, posero ogni<br />
cura perché il lavoro riuscisse degno della circostanza. Ne risultò “una<br />
legatura caratteristica del secolo XV, conforme allo stile delle figure, degli<br />
ornamenti e della stampa. Imitante un lavoro che data dal 1558 su marocchino<br />
nero lacca di una officina veneziana... La legatura è in pelle<br />
color marrone” 10 con le figure in rilievo, bordate oro, di Gesù che consegna<br />
le chiavi a S. Pietro.<br />
Il Bollettino Salesiano del marzo 1894 riporta la lunga lettera di Don<br />
Cesare Cagliero, Procuratore Generale (incaricato cioè delle relazioni<br />
ufficiali della Congregazione con la Santa Sede), nella quale descrive<br />
lo svolgersi dell’udienza del 2 febbraio, durante la quale ha presentato<br />
a nome di Don Rua l’omaggio del Messale. È interessante e commovente,<br />
risentire il dialogo familiare tra il vecchio Papa Leone XIII e Don<br />
Cesare. Il Cerimoniere pontificio annuncia: “Salesiani di Don Bosco”,<br />
ed il Papa ripete con tanto affetto “di Don Bosco”. Don Cagliero inizia:<br />
“Padre Santo, il nostro Superiore Generale...”. “Don Rua nevvero?”.<br />
Interruppe il Papa. “Sì, santo Padre, Don Rua umilia ai vostri piedi questo<br />
Messale stampato pel fausto vostro Giubileo Episcopale”. “E dove<br />
fu stampato?” domanda il Papa. “A Torino, dalla nostra Tipografia”. E<br />
presentandogli il bel lavoro, Don Cesare Lo prega di esaminare le due<br />
facciate del frontespizio con la dedica a Lui fatta. Il Santo Padre, reggendo<br />
da sé il Messale, si degna di leggere la dedica con viva soddisfazione<br />
che gli traspare dal volto, e si ferma ad osservare la Cena di<br />
Gaudenzio Ferrari, così magistralmente riprodotta, e i ricchi fregi dell’una<br />
e dell’altra facciata. Dopo avergli fatto notare le illustrazioni delle<br />
Solennità maggiori e minori, le iniziali grandi e piccole, le forme elzeviriane<br />
dei caratteri, ecc., è presentata alla considerazione del Santo<br />
Padre, come specialità dell’arte della stampa, la Crocifissione preposta<br />
al Canone, tolta dal fac-simile della miniatura che adorna lo storico<br />
Messale del Cardinale della Rovere. Avendogli fatto osservare che è<br />
un lavoro a sedici colori eseguito con mezzi puramente tipografici, il<br />
Papa vi fissa sopra gli occhi mostrandone gran meraviglia, e, quasi ad<br />
9<br />
Bollettino Salesiano, febbraio 1893.<br />
10<br />
Bollettino Salesiano, febbraio 1894.<br />
63
assicurarsi, vi fa scorrere sopra più volte la sua mano, e con vivacità dice:<br />
“è dunque questo Messale un lavoro di pregio?”. “Padre santo – risponde<br />
Don Cesare – abbiamo posto ogni cura perché riuscisse meno indegno<br />
della Vostra Augusta Persona”.<br />
Don Cesare chiede quindi una speciale benedizione per tutti coloro<br />
che direttamente o indirettamente hanno collaborato a realizzare<br />
l’opera, quindi, facendosi coraggio, domanda: “Padre santo, il signor<br />
Don Rua desidererebbe un’altra grazia”. “E quale?”. “Che la Santità<br />
Vostra si degni di usare questo Messale nel giorno 18 febbraio, in cui<br />
celebrerà la Messa in S. Pietro a chiusura dell’anno giubilare”. Il Papa,<br />
volgendosi ai Monsignori presenti, sorridendo con allusione ai Canonici<br />
del Capitolo Vaticano, dice: “Ma, S. Pietro non si offenderà? Ad ogni<br />
caso, domanderemo i debiti permessi. Questo Messale mi è caro e intendo<br />
tenerlo proprio per me”. 11<br />
Un esemplare di questo Messale, in Edizione Salesiana, dopo<br />
tante peripezie, è approdato al Centro Salesiano di Documentazione<br />
Storica e Popolare Mariana, dove è gelosamente custodito a testimonianza<br />
dell’affetto al Papa del Beato Don Michele Rua e dei Salesiani,<br />
e della abilità, nel campo dell’arte tipografica e libraria, della<br />
Scuola Tipografica di Valdocco ed in genere delle Scuole Professionali<br />
Salesiane dell’epoca.<br />
64<br />
11<br />
Bollettino Salesiano, marzo 1894.
MUSEO<br />
DELLA DEVOZIONE MARIANA<br />
Lavori per facilitare ai disabili l’accesso al Museo<br />
La Mostra sulla Devozione a Maria Ausiliatrice e su Gli Arredi sacri<br />
della Basilica, allestita dal Centro di Documentazione Storica e Popolare<br />
Mariana, in occasione del primo centenario dell’ Incoronazione<br />
della Madonna (17 maggio 1903), ha suscitato grande interesse ed è<br />
stata visitata, per la prima volta, anche da persone che avevano difficoltà<br />
nello scendere e salire le scale. Un moderno Montascale rettilineo,<br />
modello RP, è stato installato proprio sulla scalinata che immette al salone<br />
delle Mostre, nella Cripta della Basilica, a sinistra guardando la<br />
facciata, ed ha fatto già un ottimo servizio per diverse persone.<br />
Per eliminare le barriere che impedivano l’accesso allo Scalone, è<br />
stata aperta, nel vano della finestra, una nuova porta che dal piazzale<br />
antistante immette direttamente nell’atrio.<br />
Ottenute le non poche autorizzazioni da parte delle Autorità competenti,<br />
terminata la Mostra dell’Ausiliatrice, nel mese di giugno del<br />
2003 sono iniziati i lavori di ripristino degli stipiti e soglia in granito,<br />
e la sistemazione del pesante portone in legno Rovere di Slavonia dello<br />
spessore di 56-58 mm.<br />
Giustamente la Sopraintendenza ai Beni Architettonici richiede<br />
che siano salvaguardate le caratteristiche strutturali del prospetto della<br />
facciata che circonda la Basilica. Pertanto i materiali usati e le linee architettoniche<br />
seguite devono corrispondere alle preesistenti, come pure<br />
65
Accesso al Museo mariano.
la tinteggiatura, in modo da non rompere l’armonia dell’insieme.<br />
Ad opera completata, non possiamo che complimentarci con il<br />
direttore dei lavori, Arch. Gian Piero Zoncu, l’impresa costruttrice F.lli<br />
Franco, la falegnameria Campari, e rispettive maestranze, per la professionalità<br />
e competenza con cui hanno eseguito il tutto. Siamo loro<br />
riconoscenti, ma i primi a dir loro grazie sono le tante persone fisicamente<br />
impedite che, grazie a loro, possono partecipare con facilità alla<br />
gioia dei numerosi visitatori, piccoli e grandi.<br />
Cristo alla colonna<br />
L’artistica riproduzione di Gesù legato alla colonna per la flagellazione<br />
è un gruppo scolpito in legno decorato, alto un metro circa, che<br />
rappresenta Gesù curvo, dal volto sofferente, con le mani legate su di<br />
una colonna alta 60 cm circa. L’espressione viva del volto, la riproduzione<br />
anatomica perfetta delle membra, fanno propendere a collocare<br />
l’opera tra le sculture di fine secolo XVIII. Purtroppo non conosciamo<br />
l’autore. È un dono a Don Pietro Ceresa, per il Centro, del rev. Don<br />
Secondino Micca, Parroco di Palera (frazione di Moncalieri) defunto<br />
nei primi anni novanta, che lo aveva ereditato dal padre, avvocato e cultore<br />
di antichità.<br />
S. Giovanni descrivendoci nel Vangelo (cap. 19, 1) il processo di<br />
Gesù ci dice che Pilato, convinto dell’innocenza di Gesù, vuole liberarlo,<br />
ma che di fronte all’ostinazione dei Giudei, che preferiscono libero<br />
Barabba, cede alle loro richieste: “Allora Pilato prese Gesù e lo<br />
fece flagellare”.<br />
Gli artisti si sono sbizzarriti nel raffigurare la scena della flagellazione.<br />
Alcuni, tra i quali il Tiziano, rappresentano Gesù con le mani legate<br />
in alto sopra il capo, ad una colonna imponente. Forse questa è<br />
la raffigurazione che meglio risponde al vero. Anche gli studiosi della<br />
sacra Sindone propendono per essa, perché dall’analisi delle piaghe,<br />
impresse sul sacro telo, non si trovano sugli avambracci impronte del<br />
flagello, che pure si trovano sui fianchi, sulle reni, sul petto e sugli arti<br />
inferiori, con diverse inclinazioni.<br />
Altri artisti, come il Guercino, preferiscono raffigurare Gesù curvo<br />
legato ad una colonna bassa. Si riferiscono tutti alla colonna della flagellazione,<br />
di diaspro sanguigno, che si conserva nella Basilica di Santa<br />
Prassede in Roma, vicino alla Cappella di Zenone, splendente di mo-<br />
67
Cristo alla colonna,<br />
prima e dopo il restauro.
saici bizantini. È una colonna alta 63 cm appena, portata a Roma nel<br />
1223 dal Cardinale Giovanni Colonna, da Gerusalemme, come Reliquia<br />
alla quale si riteneva fosse stato legato Gesù durante la flagellazione.<br />
Anche il Bernini si riferisce ad essa nel rappresentare un Angelo,<br />
posto sul ponte che conduce a Castel Sant’Angelo, con in braccio<br />
la colonna di S. Prassede. Così pure il nostro artista si è voluto riferire<br />
a quella colonna rappresentando il Cristo che si trova nel Centro di<br />
Documentazione.<br />
L’usura del tempo ha inciso non poco sulla struttura lignea: profonde<br />
crepe si sono aperte in diverse parti. Anche la tinteggiatura posteriore<br />
dell’opera risentiva del gusto del passato per cui si è reso necessario<br />
un restauro totale di conservazione e di ripristino.<br />
Per interessamento della Circoscrizione VII della Città di Torino, all’interno<br />
del progetto “Adottiamo il Passato”, l’abilità tecnica degli artisti<br />
dell’Associazione Piemontese dei Restauratori d’Arte (A.P.R.A.) ha<br />
provveduto a riportare l’opera al suo splendore primitivo. Con lavoro<br />
paziente da certosino sono state stuccate le non poche spaccature lignee<br />
e completate le parti mancanti; è stata asportata la patina del colore<br />
su tutta la struttura riportandola alla tinta originale del legno. Il risultato<br />
finale è pregevole e ci riporta un Cristo dal volto espressivo e<br />
dai tratti anatomici perfetti.<br />
Altro capolavoro abilmente restaurato dall’ A.P.R.A. è l’Angelo in<br />
adorazione, statua in legno colorato di cm 35 x 55, risalente a fine Ottocento.<br />
Calato su sottile nuvoletta, l’Angelo vestito di tunica rosea, è<br />
inginocchiato, con le mani giunte in atto di adorazione, il volto giovanile<br />
e sorridente. Il restauro è consistito nel rafforzare le parti lignee indebolite<br />
o mancanti, come le ali, e nel ripulire e ravvivare i colori ed<br />
i tratti dorati.<br />
Lavori in “Paperole”<br />
Nella prima metà del 1500 la devozione popolare in Italia ed in<br />
Europa è profondamente sconvolta dalla riforma protestante di Lutero<br />
che nega il culto della Beata Vergine e dei Santi. Il Concilio di<br />
Trento (1545-1563) ha il compito di ristabilire la dottrina cattolica, con<br />
l’aiuto degli Ordini religiosi ed in particolare della Compagnia di<br />
Gesù (i Gesuiti) fondata proprio nel 1540. Si intraprende un ampio<br />
programma di riconquista e di missioni per riavvicinare le popolazio-<br />
69
ni alla religione dalla quale erano state allontanate. Nasce un nuovo<br />
stile nell’arte che fa leva sul gusto del bello e dello scenografico, facendo<br />
grande uso dello spazio, dell’oro, dell’incenso e delle volute;<br />
nasce lo stile “Barocco” che si sviluppa in tutta Europa, ed in particolare<br />
in Italia, e che dà grandi artisti come Lorenzo Bernini e Francesco<br />
Castello, detto Borromini. È riabilitato il culto della Madonna<br />
e dei Santi, rinasce il gusto delle processioni e dei pellegrinaggi, si diffondono<br />
medaglie ed immagini. E se Roma risplende per le grandi<br />
Chiese barocche, altrove “piccole mani” lavorano nell’ombra dei<br />
conventi, per la gloria di Dio, e creano “lavori divini” o “lavori delle<br />
carmelitane” che si diffondono nei luoghi di pellegrinaggio della Provenza,<br />
di Marsiglia, della Normandia, di Roma, di Vienna e di Norimberga.<br />
Sono opere di fede, immagini dipinte a mano, scatole decorate<br />
all’interno con tempere ed acquerelli, autentici capolavori d’arte<br />
naïf, non sempre apprezzati.<br />
Nella grande varietà di questi lavori incontriamo quelli che in francese<br />
vengono chiamati “paperole” formati cioè da piccoli rotoli di carta<br />
da 1 a 5 millimetri, dorati sul taglio, che vogliono imitare i lavori degli<br />
orafi, e che circondano le immagini o le Reliquie, ne esaltano la bellezza<br />
conferendo loro un aspetto splendido. 12<br />
Nel Museo Mariano si trovano diversi “Lavori in paperole” che desideriamo<br />
presentare.<br />
Quadrofondo con al centro un dipinto ovale di Giovanni Battista<br />
fanciullo accanto all’agnello. Il vano interno del quadro, circondato<br />
da finissima e doppia cornice in paperole, è diviso trasversalmente in<br />
due settori da motivi floreali; al centro domina l’ovale con la figura del<br />
Battista incorniciata da fiori stilizzati. Nel settore superiore due grandi<br />
festoni, mentre in quello inferiore due corbeilles di fiori fanno da cornice<br />
a diverse Reliquie sparse tra i motivi di decorazione. L’effetto è<br />
ricco e armonioso.<br />
Reliquiario di S. Francesco di Sales, in cornice scura con rilievi di<br />
edera dorati. Sullo sfondo di velluto rosso, circondato da una delicata<br />
cornice a foglie, in carta dorata, emerge al centro l’ovale della figura<br />
del Santo Patrono dei giornalisti, nel tradizionale atteggiamento di scrittore<br />
con la penna in mano, in cornice di gocce di perle. Quattro ele-<br />
70<br />
12<br />
Cfr. ALAIN VIRCONDELET, Le Immaginette (Torino, Ulisse Edizioni, 1989).
Lavori in “Paperole”.
Lavori in<br />
“Paperole”.
ganti volute in paperole occupano gli angoli ed incorniciano le Reliquie<br />
di altri Santi.<br />
Reliquiario di S. Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars, in<br />
cornice rettangolare dorata a motivo floreale in rilievo. L’ovale del<br />
Santo, ritratto in devota preghiera, è circondato da volute e rosoni in<br />
rilievo, tutti in finissimo paperole.<br />
Reliquiario con S. Ignazio di Lojola ed altri Santi, in una triplice<br />
cornice massiccia dorata, a fogliame. La figura del Santo è collocata in<br />
un ovale circondato da perline dorate ed argentate; volute a motivo<br />
floreale circondano le diverse Reliquie legate da cartigli.<br />
In una cornice barocca, oscura e frastagliata, è racchiusa la Reliquia<br />
di Santa Vittorina. Sullo sfondo chiaro risalta con finezza la grande<br />
croce in paperole affiancata da un tralcio dorato con grappolo di uva.<br />
Ovale con l’immagine del Sacro Cuore di Gesù in una cornice<br />
oscura con a sbalzo un motivo che richiama la corona di spine, dorata.<br />
La figura di Gesù benedicente, a colori tenui, è collocata al centro<br />
di un lavoro finissimo in paperole a motivo floreale, oro con fiorellini<br />
bianco perla. Nelle volute sono racchiuse otto Reliquie di Santi particolarmente<br />
devoti del Sacro Cuore di Gesù.<br />
Reliquiario di S. Margherita Maria Alacoque. In una cornice ovale<br />
oscura, su sfondo di velluto rosso, è collocata l’immagine, in colore seppia,<br />
della Santa, circondata da una duplice corona di piccoli rotoli e<br />
bianche perle. L’insieme risulta un semplice, ma delicato lavoro.<br />
Reliquiario di S. Francesco di Assisi. La cornice rettangolare oscura<br />
pone in bel risalto un delicato lavoro paperole a festoni, con al centro<br />
l’ovale del Santo in adorazione del Crocifisso, sormontato da croce<br />
e circondato da finissime volute e gocce.<br />
Finissimo lavoro in paperole a motivo eucaristico. Una massiccia<br />
cornice scura ovale racchiude l’Ostensorio con la sacra Ostia circondato<br />
da spighe di grano, da tralci con grappoli di uva e da fiori di<br />
campo, in oro.<br />
Una triplice pesante cornice dorata, scolpita a fogliame, racchiude<br />
le Reliquie di S. Luigi Gonzaga. L’ovale con l’immagine del Santo,<br />
in contemplazione del Crocifisso, è collocata al centro, circondata da<br />
perline argentate e dorate; agli angoli sottili volute in paperole completano<br />
l’ornamento che nel suo insieme risulta assai elegante e delicato.<br />
In una massiccia cornice dorata, a fogliame, sono racchiuse le Reliquie<br />
di 365 Santi, un Santo per ogni giorno dell’anno. È un quadro<br />
73
di grandi dimensioni (125 x 85 cm); su sfondo di velluto rosso riporta<br />
le varie Reliquie, con rispettivo cartiglio, suddivise a seconda del mese<br />
e del giorno in cui ricorre la festa del Santo; alcune sono disposte lungo<br />
i lati del quadro, altre sono raggruppate in un grande rosone centrale<br />
ed in quattro rosoni minori collocati negli angoli. Festoni di spighe dorate,<br />
di fiori e campanule bianche, circondano il tutto; in alto campeggia<br />
la Croce con due palme e la corona di gloria, mentre nel basso un<br />
mazzo di grappoli d’uva sta a simboleggiare, insieme con le spighe, l’Eucaristia,<br />
fonte di ogni santità. La composizione armonica dell’insieme<br />
rivela l’abilità dell’artista e la sua profonda devozione. Il quadro è stato<br />
donato al Museo Mariano dalla Comunità Salesiana dell’Istituto “G.<br />
Morgando” di Cuorgnè.<br />
Una bellissima cornice in stile Carlo X, recentemente restaurata<br />
dalla Associazione Piemontese Restauratori d’Arte (A.P.R.A.), racchiude<br />
un Reliquiario in filigrana d’argento. Le numerose Reliquie racchiuse<br />
in teche a filigrana d’argento, sono contornate da volute e da infiorescenze<br />
in paperole dorate e bianche.<br />
Ovale con cornice dorata racchiude un medaglione in cera della<br />
Vergine Addolorata circondato da un ricco lavoro in paperole di spighe,<br />
fiori, grappoli e foglie. Il medaglione in cera è chiamato “Agnus Dei”,<br />
formato con cera benedetta dal Papa il Sabato Santo e raffigurante normalmente<br />
l’Agnello pasquale oppure la Madonna o qualche Santo.<br />
Un paperole a fogliame dorato ed a colori, a forma di stemma gentilizio<br />
sormontato da corona, racchiude, in una cornice quadrata, il<br />
medaglione di cera raffigurante un santo Abate, S. Antonio o S. Benedetto.<br />
Reliquie della Passione, sistemate in una croce metallica sono attorniate<br />
da paperole a forma di fiori e di grappoli; il tutto è racchiuso<br />
in una cornice barocca dorata.<br />
Un delicato quadretto con sfondo azzurro e cornice chiara racchiude<br />
un ovale della Madonna con Bambino, circondato da festoni di<br />
fogliame dorato e fiori bianchi. Un rombo in carta bianca attorcigliata,<br />
suddivide ulteriormente la superficie del quadro.<br />
Cartoncini Bristol lavorati a mano<br />
74<br />
Nella Galleria degli Ex-voto del Museo Mariano vi sono quadri<br />
dalle svariate fatture che testimoniano la riconoscenza alla Madon-
Lavori<br />
su cartoncino Bristol.
Lavori su cartoncino Bristol.
na per le grazie ricevute. Oltre ai quadri dipinti, di norma su ordinazione,<br />
da artigiani competenti, vi sono svariati lavori di ricamo, con<br />
le diverse tecniche, fatti dalle medesime persone beneficate, segni<br />
di maggiore riconoscenza alla Madonna, in quanto frutto di sacrificio<br />
personale.<br />
Vi sono poi quadri su cartoncino Bristol, lavorato a mano con certosina<br />
pazienza, da sembrare ricami su seta. Penso che meritino di essere<br />
conosciuti ed ammirati, perché sono vere opere d’arte, e più ancora<br />
perché sono opere frutto di un grande amore per la Madonna. Ne<br />
vogliamo presentare alcuni.<br />
La facciata della Basilica di Maria Ausiliatrice, in scala, con l’interno<br />
illuminato. È un lavoro di precisione e di pazienza di Nino Terrana<br />
di Canicattì (Girgenti) offerto il 1º marzo 1926.<br />
Un grande quadro (66x85 cm) con al centro un’antica fotografia<br />
della Madonna Consolata, presenta un lavoro finissimo di ricamo, tutto<br />
su cartoncino. La Vergine è circondata da stelle e da serti di spighe; tre<br />
cornici progressive di stelle di varia fattura, completano il quadro. È<br />
dono della Comunità Salesiana “S. Domenico Savio” di Torino.<br />
Una oleografia dell’Immacolata Assunta del Murillo, con la luna<br />
sotto i piedi, attorniata da Angeli, è al centro di un grande ricamo su<br />
cartoncino oscuro, che ripete il motivo delle stelle a più punte e di cristalli<br />
di neve. È un ricordo di famiglia, dono alla Madonna di Necco<br />
Giuseppe e Vignale Luisella, del 4 maggio 1996.<br />
Suor Margherita Fiore, Figlia di Maria Ausiliatrice, ha donato nel<br />
1983 alla Madonna un lavoro, frutto di tanto amore e pazienza della<br />
propria Mamma Comoglio Maria. L’Immacolata, un’immagine su raso<br />
della Medaglia miracolosa, è contornata da un finissimo ricamo di cartoncino,<br />
con serto floreale, su sfondo azzurro, di bellissimo effetto.<br />
L’Addolorata con la corona di spine stretta al petto, un’oleografia<br />
ovale, è contornata da un pizzo di trine forate e da rami di olivo dalle<br />
foglioline verdi, di ottimo gusto. È dono all’Ausiliatrice della Famiglia<br />
Palladino di Guarene, in ricordo del papà Filippo e della Mamma Ida<br />
Ceppa.<br />
Altri quadri, purtroppo, sono di donatori anonimi, dei quali non conosciamo<br />
né nome né provenienza; sono parimenti ammirevoli.<br />
L’Immacolata di Lourdes con Santa Bernadetta, una originale litografia<br />
di Giordana e Salussolia (Torino), è contornata da un pizzo di<br />
77
cartoncino lavorato in rilievo a spighe. Il quadro è databile del 1800.<br />
Un quadrofondo, con doppia cornice nera e dorata, racchiude una<br />
oleografia della Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina<br />
su fondale damascato rosa, attorniata da un finissimo pizzo in<br />
cartoncino a punta e da ornamenti di fiori e foglie in rilievo sempre su<br />
cartoncino; una stella in carta dorata, in alto sulla destra, completa il<br />
quadro.<br />
Un’incisione antica di Maria nel Cenacolo circondata dagli Apostoli<br />
nella Pentecoste, poggia su fondo di cartoncino bristol finemente<br />
ricamato a colori e attorniato da un pizzo in rilievo sempre di cartoncino,<br />
su sfondo rosa. È un lavoro di finissima fattura di fine ‘800.<br />
Una antica fotografia, un po’ sbiadita, ritraente la Madonna Assunta<br />
tra Angeli è circondata da un delicato pizzo in cartoncino traforato<br />
ed in rilievo su sfondo argentato. Il lavoro risente dell’età (1800).<br />
Un grande quadrofondo (70 x 80 cm) in una splendida cornice<br />
dorata Vincenti (Torino), racchiude una oleografia della Immacolata<br />
Assunta del Murillo circondata da Angeli, su una trine in cartoncino bristol<br />
finissimo, su sfondo dorato. Una ghirlanda di fiori artificiali, in lamelle<br />
argentate e foglie in stoffa, circonda l’immagine. È un dono a<br />
Maria Ausiliatrice di un’anima devota rimasta nascosta che ha voluto<br />
tramandare, con il quadro, questa preghiera “Sotto la tua protezione noi<br />
troviamo rifugio e aiuto o Santa Madre di Dio. Nelle nostre difficoltà<br />
non respingere le nostre suppliche, ma da ogni pericolo liberaci Tu, la<br />
Sola Pura, la Gloriosa, la Benedetta”.<br />
Maria Ausiliatrice e le Anime del Purgatorio<br />
78<br />
Nel Museo Mariano si trova un quadro, piccolo nelle dimensioni,<br />
ma significativo. È del tempo di Don Bosco! Porta infatti la scritta: “Vera<br />
Immagine di Maria SS. Ausiliatrice canonicamente eretta nella chiesa<br />
a lei dedicata dal Sacerdote Giovanni Bosco in Torino”. È stato rinvenuto<br />
sulla bancarella di un mercatino rionale.<br />
La figura di Maria Ausiliatrice, con il Bambino sul braccio sinistro<br />
e lo scettro nella mano destra, ha ai lati un papà ed una mamma con<br />
un bambino che la invocano, ed ai suoi piedi le anime tra le fiamme<br />
del Purgatorio. Sta quindi ad indicarci che la Madonna, nella devozione<br />
di Don Bosco, è l’Ausiliatrice anche della Famiglia e delle Anime<br />
del Purgatorio.
Noi siamo soliti contemplare sull’Altare della Basilica l’Ausiliatrice<br />
circondata dagli Apostoli ed Evangelisti; nella Cupola grande la vediamo<br />
trionfante nella battaglia di Lepanto, nell’assedio di Vienna e<br />
nella liberazione del Papa Pio VII dalla prigionia di Napoleone. Siamo<br />
portati a venerarla come aiuto del popolo cristiano pellegrinante in<br />
questo mondo, in continua lotta contro le forze del male per il trionfo<br />
del bene.<br />
Don Bosco con l’Immagine del quadretto ci ricorda che la Madonna<br />
è Ausiliatrice anche del popolo cristiano che, dopo le battaglie<br />
della vita per essere fedele al Signore, si trova in Purgatorio per purificarsi<br />
e rendersi degno di partecipare alla gioia del Paradiso.<br />
Significativo è poi il fatto che Don Bosco accanto all’Ausiliatrice<br />
metta un papà ed una mamma, per dirci che Maria è l’aiuto particolare<br />
della Famiglia, piccola Chiesa!<br />
Possiamo quindi mettere questo piccolo quadro accanto al grande<br />
quadro del Lorenzoni, posto sull’altare della Basilica, a completamento<br />
della devozione di Don Bosco per l’Ausiliatrice.<br />
Maria è Ausiliatrice, è Aiuto della Chiesa in senso pieno: del Papa<br />
e dei Vescovi, raffigurati dagli Apostoli ed Evangelisti, del popolo cristiano<br />
che lotta in questa vita per la vittoria del bene sul male, del popolo<br />
cristiano che attende nella purificazione, (le Anime del Purgatorio),<br />
il giorno della gioia del Paradiso, e della Famiglia cristiana che<br />
lotta contro le forze dissolutrici del male per essere fedele alla sua missione<br />
di bene.<br />
Pertanto teniamo prezioso questo piccolo quadro e ringraziamo il<br />
donatore che vuole essere anonimo.<br />
“Cosa aspettate ad incoronarmi?”<br />
Il 17 maggio 1903 il Quadro di Maria Ausiliatrice, durante il Congresso<br />
mondiale dei Cooperatori Salesiani, viene solennemente incoronato.<br />
Mentre il cardinale di Torino Agostino Richelmy, preceduto da<br />
Don Secondo Marchisio che reca le sacre corone, sale il palco fino all’altezza<br />
della figura della Madonna, la schola “canta dolcemente l’antifona<br />
Regina coeli laetare, Alleluia nel ritmo soavissimo del canto gregoriano.<br />
Tutti hanno lo sguardo fisso al Cardinale ed alla Immagine<br />
della Madonna. Molti piangono di tenerezza. Intanto, attraverso la<br />
79
porta maggiore, la folla che gremisce la piazza, vede il Cardinale che<br />
ascende ad incoronare la Vergine, e scoppia in un grande applauso. Nel<br />
Santuario invece cresce il silenzio! L’Eminentissimo Delegato giunge alla<br />
sommità del palco, piega le ginocchia, prende con venerazione la<br />
prima corona e pronunciando con voce sonora e commossa la formula<br />
rituale l’impone sulla fronte del S. Bambino che siede sul braccio di<br />
Maria Ausiliatrice. È un momento di commozione indescrivibile!...<br />
L’Eminentissimo prende la seconda corona e ponendola sulla fronte di<br />
Maria Ausiliatrice, con voce ancor più forte e commossa, pronuncia frase<br />
a frase, la sacra formula, scoppiando infine in un grido di letizia e di<br />
pianto. Subito, grave e solenne, dalle tribune, dal Tempio e dalla piazza<br />
scoppia un irrefrenabile applauso... Dall’alto della cupola squillano<br />
le trombe annunzianti il compimento del rito solenne, e le campane<br />
del Santuario, cui fanno eco cento e cento altre della città, suonano<br />
a gloria; mentre dodici colombi lanciati dall’alto della cupola, si<br />
levano dapprima timidamente a volo, ma poi volgono rapidamente a<br />
sud, al mare, al Vaticano, per annunziare al Papa che, con tutta la grandiosità<br />
possibile, secondo il suo decreto, Maria SS. Ausiliatrice era stata<br />
fregiata di auree corone”. 13<br />
Subito dopo, il Card. Richelmy, alla presenza di una folla di fedeli<br />
stipati sulla piazza e nelle vie adiacenti, procede “di sua autorità”<br />
ad incoronare anche la bella statua dell’Ausiliatrice, posta su un palco<br />
davanti alla Basilica. E quando il Cardinale ed i Vescovi con il Clero<br />
rientrano in Basilica, dall’alto della cupola lo squillo di trombe si rinnova<br />
ed il coro, formato da più di cento cantori, intona l’antifona “Corona<br />
aurea super caput Eius... Finalmente risplende sul capo di Lei un<br />
aurea corona...”. Questa la descrizione dell’evento fatta dal Bollettino<br />
Salesiano.<br />
È interessante conoscere come si è giunti alla decisione di incoronare<br />
Maria Ausiliatrice.<br />
Don Secondo Marchisio, un salesiano di Castelnuovo, aveva ricevuto<br />
in dono da Don Bosco stesso una statuetta di Maria Ausiliatrice.<br />
Nel consegnargliela Don Bosco gli aveva detto: “Tu dovrai molto lavorare<br />
per Maria Ausiliatrice!”. Ora, nell’autunno del 1902, Don Marchisio<br />
è responsabile del servizio liturgico nel Santuario, ed un pensie-<br />
80<br />
13<br />
Bollettino Salesiano, giugno 1903.
o lo occupa e lo preoccupa: che cosa fare di straordinario in onore di<br />
Maria Ausiliatrice, in occasione del Congresso Mondiale dei Cooperatori<br />
Salesiani, in programma a Torino-Valdocco nella primavera del<br />
1903? Una sera sente con certezza partire dalla statua una voce che gli<br />
dice: “Cosa aspettate ad incoronarmi?”. La voce si ripete una seconda<br />
ed una terza volta. Meravigliato ed impressionato, Don Marchisio riferisce<br />
l’accaduto a Don Rua che lo ascolta molto attentamente, lo<br />
calma e gli dice di non divulgare la cosa, ma di pregare secondo la sua<br />
intenzione.<br />
Qualche tempo dopo, il Beato Don Rua, in udienza dal Papa Leone<br />
XIII chiede l’autorizzazione a procedere alla Incoronazione del Quadro<br />
dell’Ausiliatrice nel Santuario di Torino, anche se non sono ancora<br />
passati i cento anni richiesti dalla consuetudine per questo solenne<br />
segno di distinzione. Il Papa aderisce immediatamente alla richiesta e<br />
vuole che l’incoronazione venga fatta “A suo nome”.<br />
Così, per precisa indicazione della Madonna stessa, il 17 maggio<br />
1903, durante il Congresso Mondiale dei Cooperatori Salesiani, viene<br />
fatta l’incoronazione del quadro di Maria Ausiliatrice.<br />
Al presente la storica statuetta è gelosamente custodita nel Centro<br />
di Documentazione Mariana. Essa è stata riportata a Valdocco dal salesiano<br />
Don Claudio Bolla, attualmente nell’Istituto di Verona, ed ultimo<br />
erede di essa, il 30 novembre 1985, come ringraziamento per una<br />
grande grazia ottenuta dalla Madonna.<br />
La Madonna “Aiuto dei Cristiani” di La-Vang (Vietnam)<br />
Il Museo Mariano ha avuto un prezioso regalo da parte dell’Ispettore<br />
Salesiano del Vietnam, Don Giovanni Nguyen Van Ty: una bellissima<br />
statua, in legno Banglang alta 65 cm, dell’Ausiliatrice di La-Vang<br />
che viene ad arricchire ed a completare la nostra raccolta.<br />
Nel lontano 1798 la Madonna appare su di un albero ad un gruppo<br />
di cristiani perseguitati, presentandosi come una dama di corte e dichiarandosi<br />
“Aiuto dei Cristiani”.<br />
Il Papa Giovanni Paolo II, la domenica 19 giugno del 1988, dopo<br />
aver proclamato Santi ben 117 Martiri Vietnamiti, nella preghiera dell’Angelus,<br />
descrive così le apparizioni della Madonna di La-Vang e la<br />
fede dei pellegrini al suo santuario.<br />
81
82<br />
«Oggi il nostro consueto viaggio ideale tra i San tuari mariani del<br />
mondo non può non fare una sosta in Vietnam, la terra fecondata dal<br />
sangue dei 117 martiri, appena canonizzati.<br />
Ci fermeremo a ricordare il Santuario di La-Vang, appartenente all’arcidiocesi<br />
di Hue, nel Vietnam cen trale. Il nome “La-Vang” viene da<br />
quello di una foresta, alla quale giungevano, nel passato, per raccogliere<br />
legna, alcune piccole comunità cristiane della zona.<br />
La nascita di questo centro mariano è anch’essa legata alle prove<br />
subite da quelle comunità, giacché là i cristiani si rifugiarono nel 1798<br />
per scampare alla persecuzione del Re Canh-Thinh, senza curarsi dei<br />
rischi delle bestie feroci, della fame e delle malattie. Essi si raccoglievano<br />
attorno ad un grande albero, recitando il Santo Rosario ed implorando<br />
l’assistenza del Cielo. La tradizione popolare narra che la Beata<br />
Vergine Maria apparve più volte, tenendo in braccio Gesù Bambino,<br />
esortando alla perseveranza ed assicurando la sua pro tezione.<br />
Ritornata la pace, ben presto sul luogo sorse una modesta chiesetta<br />
di legno, che divenne luogo di pellegrinaggi. Ma nuove e più violente<br />
persecuzioni si abbatterono sui credenti intorno alla metà del secolo<br />
decimonono; la devozione alla Madonna restò uno dei punti di<br />
appoggio della fede dei Martiri, che spesso si presentavano al supplizio<br />
con la corona del Rosario al collo.<br />
Nel 1886, ritornata di nuovo la calma, la chiesina di legno della<br />
Madonna di La-Vang, fatta bruciare dai perse cutori, fu sostituita da una<br />
costruzione in muratura; venne inaugurata solennemente nel 1901 dal<br />
Padre Morineau, delle Missioni Estere di Parigi, in presenza di numerosi<br />
fedeli.<br />
La cappella fu restaurata ed ampliata nel 1924 da Mons. Eugenio<br />
Allys, Vescovo di Hue, ma a causa dei successivi eventi bellici, di essa<br />
oggi purtroppo non ri mangono che dei resti bruciati, attorno ai quali,<br />
tuttavia, nonostante le difficoltà, ancor oggi si raccolgono dei pellegrini<br />
a pregare per rinvigorire la loro fede.<br />
Nel 1961, pochi anni prima che il Santuario fosse distrutto, la Conferenza<br />
Episcopale Vietnamita, con una lettera pastorale, lo aveva proclamato<br />
Santuario Mariano Nazionale, e nel medesimo anno la Santa<br />
Sede lo eresse al rango di Basilica Minore.<br />
Possiamo pensare che questi atti così significativi dell’Autorità Ecclesiastica<br />
siano di buon auspicio per la ricostruzione del Santuario, che
noi speriamo possa avvenire quanto prima, in un clima di libertà e di<br />
pace, e di gratitudine a Colei che «tutte le generazioni chia mano beata»<br />
(cfr. Lc 1, 48). In tal modo il Santuario, per l’intercessione della Regina<br />
dei Martiri, potrà espli care tutte le sue virtualità spirituali a favore<br />
non solo dei cattolici Vietnamiti, ma anche dell’unità nazionale, nonché<br />
del vero progresso civile e morale del Paese». 14<br />
Oggi il Santuario, ricostruito e consacrato nel 1998, è ritornato ad<br />
essere il centro della devozione mariana dei cattolici e dei Salesiani,<br />
presenti con numerose opere in Vietnam.<br />
La Madonnina di Suor Isabella<br />
Suor Isabella Bestazzi, Figlia di Maria Ausiliatrice, è piena di vita<br />
ed animata da grande desiderio di bene per le giovani, sulla scia di<br />
Don Bosco e di Madre Mazzarello, quando il 25 settembre del 1910<br />
a Chieri si consacra al Signore con la Professione religiosa. Ha conseguito<br />
il Diploma di Insegnante per la Scuola Elementare ed inizia con<br />
grande entusiasmo il suo apostolato educativo a Re, in Val d’Ossola. Ben<br />
presto però un semplice raffreddore la blocca. Nello slancio giovanile<br />
non vi dà grande peso, forse lo trascura anche un po’, ma il raffreddore<br />
le lascia gravi conseguenze: entrambi i timpani rimangono lesi,<br />
ed Isabella rimane sorda, priva completamente dell’udito. Per questa<br />
totale sordità è costretta con sommo rincrescimento a lasciare l’insegnamento,<br />
ed impegnarsi in lavori di ordine amministrativo e di segretariato.<br />
A Torino, nell’Istituto di piazza Maria Ausiliatrice 27, le viene<br />
affidato anche il lavoro apostolico della ”Opera del Sacro Cuore”, che<br />
ha il compito di animare nelle famiglie la devozione e la consacrazione<br />
al Cuore di Gesù.<br />
Per provvedere alle piccole spese richieste dal buon funzionamento<br />
di questa opera, Suor Isabella organizza e prepara ogni anno un<br />
banco di beneficenza. Un anno, tra gli oggetti che le vengono donati,<br />
vi è pure una statuetta in gesso, alta 55 cm, di Nostra Signora di Luján,<br />
detta l’Immacolata dell’Argentina.<br />
Ovunque in Argentina, nelle stazioni, nelle case, negli uffici pubblici<br />
si trova questa caratteristica immagine della Madonna, il cui im-<br />
14<br />
Da L’Osservatore Romano, Lunedì-Martedì 20-21 giugno 1988.<br />
83
ponente Santuario si trova a circa 60 km da Buenos Aires. Ed interessante<br />
è la storia di questa devozione tanto diffusa tra gli Argentini.<br />
Verso il 1630 giunge nel porto di Buenos Aires una caravella guidata<br />
da un marinaio che porta con sé dal Brasile due statuette di terracotta,<br />
una di N. Signora della Consolazione e una dell’Immacolata Concezione,<br />
destinate ad un portoghese abitante a Sumampa (oggi Santiago<br />
del Estero). Dopo tre giorni di viaggio, la carovana diretta verso<br />
il Tucumán giunge al rio Luján, dove pernotta. All’alba i carrettieri si<br />
dispongono a riprendere il cammino, ma i buoi, per quanti sforzi facciano,<br />
non riescono a smuovere i carri. Tirano giù le casse, ed i carri<br />
si muovono senza fatica. Ripetono più volte l’operazione e si accorgono<br />
che solo alla presenza di una cassa il carro non parte. Aprono<br />
la cassa ed appare la piccola statua di 58 cm dell’Immacolata Concezione,<br />
rivestita di una tunica rossa e di un manto azzurro seminato di<br />
stelle, le mani giunte dinanzi al petto e i piedi sopra delle nuvole, tra<br />
le quali spuntano la luna e quattro testoline di angeli. Il disegno di<br />
Dio è chiaro! La statua rimane in quel luogo dove viene costruito il<br />
primo Santuario, al quale accorrono i fedeli a venerare la Vergine di<br />
Luján. 15<br />
Suor Isabella espone, tra le tante cose, anche la bella statua della<br />
Madonna, che però non viene sorteggiata, e rimane sola a fare bella mostra<br />
di sé. Terminato il banco di beneficenza, si ripone in una cesta<br />
quanto è rimasto, in attesa di quello dell’anno seguente. La statua viene<br />
incartata con cura e riposta con le altre cose che finiscono nell’ufficio<br />
di Suor Isabella.<br />
Dopo qualche tempo, ecco il fatto straordinario! Una sera, Suor<br />
Isabella mentre sta scrivendo, e tutto intorno è silenzio, sente distintamente,<br />
per tre volte: “Apri... Togli...!”. Profondamente sorpresa,<br />
data la sua totale sordità, guarda verso la porta se è entrato qualcuno,<br />
ma alla terza volta si sente spinta a guardare nella cesta delle<br />
cose del banco di beneficenza. L’apre, prende l’involucro della statua<br />
della Madonna, lo svolge ed esclama: “Ah! Sei tu, Mammina!<br />
Non ti piace stare chiusa così!...” Da quel giorno la statua è collocata<br />
sul comò dell’ufficio, e le sono rivolte con fiducia tutte le richie-<br />
84<br />
15<br />
BENVENUTO GIACON, La Madonna nell’America Latina (Padova, Edizioni Messaggero,<br />
1959).
ste di grazie. “Tutte le grazie che chiedo alla Mammina, Ella me le concede”<br />
assicura Suor Isabella.<br />
Dopo tanti anni, la statua di Nostra Signora di Luján è donata al<br />
Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana perché<br />
venga conservata e tenuta in venerazione. Don Ceresa la colloca<br />
sull’altare della Cappella nella quale espone l’immagine della Madonna<br />
venerata ogni giorno nei diversi Santuari del mondo. E lì ancora<br />
oggi si trova ed è venerata.<br />
Tappeto delle Dame Fiorentine<br />
Il 9 giugno 1868, ultimati i lavori, l’arcivescovo di Torino Mons.<br />
Alessandro dei conti Riccardi di Netro consacra la Chiesa di Maria Ausiliatrice.<br />
Don Bosco, con gioia ineffabile e con lacrime di consolazione,<br />
assiste al rito e celebra con grande emozione la S. Messa ai<br />
piedi della sua cara Madonna. Egli vede finalmente realizzato il sogno<br />
nel quale Maria Ausiliatrice gli ha indicato la grande Chiesa con la<br />
scritta “Questa la mia casa, di qui la mia gloria”. A chi si congratula con<br />
lui per la grandiosa realizzazione, Don Bosco, con la sua solita umiltà<br />
e semplicità, risponde: “È il Signore, è Maria Santissima che si degnarono<br />
di servirsi di un povero prete per compiere tali opere. Di mio<br />
non ci ho messo proprio nulla, perché aedificavit sibi domum Maria,<br />
la Madonna si è fabbricata la sua casa”. 16<br />
In quegli anni Don Bosco fa la spola tra Firenze, la nuova capitale<br />
del Regno, e Roma ancora del Papa, per aiutare a risolvere non piccoli<br />
problemi riguardanti la nomina di Vescovi per le Diocesi che ne<br />
sono prive; è perciò molto conosciuto e stimato in entrambe le città.<br />
Le Dame di Firenze fanno una colletta per offrire a Don Bosco sei magnifici<br />
candelieri per l’altare maggiore. Una principessa romana lo<br />
viene a sapere e, radunate numerose nobili Dame, propone loro: “Noi<br />
Dame Romane ci lasceremo vincere in generosità dalle Dame Fiorentine?<br />
Mai no; facciamo vedere che nessuno può superarci in grandezza<br />
d’animo!”. E tutte insieme decidono di offrire a Don Bosco un magnifico<br />
tappeto per l’altare maggiore, “tale che sia un capo d’opera di<br />
16<br />
FEDELE GIRAUDI, Il Tempio di Maria SS. Ausiliatrice in Torino, in AA. VV. L’Ausiliatrice<br />
della Chiesa e del Papa (Torino, SEI, 1953).<br />
85
lavoro romano”. Purtroppo il progetto rimane semplice desiderio che<br />
non va oltre il solo disegno dell’opera. 17<br />
Invece, durante la Festa di Maria Ausiliatrice del 24 maggio 1875,<br />
nel presbiterio della Basilica si ammira un ampio tappeto, “lavoro e<br />
dono di nobili signore fiorentine che, nel mezzo dell’orlo anteriore,<br />
hanno ricamato questa iscrizione: Mariae Auxiliatrici in suam suorumque<br />
tutelam Matronae Florentinae dedicarunt Anno MDCCCLXXV”. 18<br />
È un lavoro paziente di ricamo a punto croce, in lana policroma, eseguito<br />
a riquadri, cuciti insieme in un secondo tempo. Il bordo è in<br />
pezzi rettangolari; le cornici dei singoli quadrati sono a spina di pesce.<br />
Misura m 5 x 10, e reca la scritta: «A Maria Ausiliatrice - le Matrone<br />
Fiorentine - a protezione propria e dei familiari - 1875».<br />
Don Bosco, in una lettera traboccante di riconoscenza, in data<br />
1 ottobre 1875 così scrive: “Una scelta di nobili Signore Fiorentine,<br />
mosse da spirito di carità e di devozione verso l’augusta Regina del<br />
cielo, dopo aver cooperato con generosi sussidi alla costruzione del<br />
tempio dedicato a Maria Ausiliatrice in Torino, volendo aggiungere un<br />
segno pubblico e stabile della sincera loro venerazione a questa celeste<br />
benefattrice, diedero opera ad un elegante tappeto... Compiuto<br />
il lavoro nel 15 maggio 1875 lo spedivano a sua destinazione in<br />
Torino. Io per tanto colla massima gratitudine ricevo il dono prezioso<br />
con formale promessa che alle donatrici sarà riservata la proprietà<br />
in perpetuo, contento io di poterlo usare a decoro del tempio del<br />
Signore e ad onore di Colei che la Chiesa proclama potente Aiuto<br />
dei Cristiani”. 19<br />
Don Ceria riporta in nota la seguente osservazione: “Il superbo<br />
tappeto, logoro dal tempo e dall’uso, faceva ancora mostra di sé appena<br />
due volte all’anno, nelle feste dell’Immacolata e del Natale. Quest’anno<br />
(scrive nel 1930) l’abile solerzia delle Figlie di Maria Ausiliatrice<br />
l’ha ripulito e rammendato in modo che sono riapparse le straordinarie<br />
bellezze del lavoro”.<br />
Al presente, dopo tanti anni di dimenticanza, il Tappeto donato<br />
86<br />
17<br />
GIOVANNI BATTISTA LEMOYNE, Memorie biografiche del Venerabile Don Giovanni<br />
Bosco Volume VIII (Torino, SAID, 1912) pagg. 667 e 837.<br />
18<br />
EUGENIO CERIA, Memorie biografiche del Beato Giovanni Bosco 1875, Volume<br />
XI (Torino, SEI, 1930) pag. 244.<br />
19<br />
Idem.
Tappeto donato dalle Dame Fiorentine a Don Bosco<br />
nel 1875, per la Basilica di Maria Ausiliatrice.
Olio su tela.<br />
Dono di Don Bosco a Don<br />
Giuseppe Campi.<br />
San Giuseppe.<br />
Statua in cera.
Maria Ausiliatrice<br />
e le anime del Purgatorio.<br />
L’Ausiliatrice<br />
di La-Vang (Vietnam).
La Madonna<br />
di Don Giovanni<br />
Battista Branda.<br />
La Madonna<br />
di Suor Isabella.
dalle Dame Fiorentine a Don Bosco, è nuovamente bisognoso di restauro,<br />
ma ha trovato degna sistemazione nella Biblioteca del Centro Salesiano<br />
di Documentazione Storica e Popolare Mariana, sull’ampia parete<br />
di fronte ai 13 armadi compactabili su rotaia, nei quali sono disposti<br />
i libri.<br />
La Madonnina di Don Giovanni Battista Branda<br />
Nel Museo di Devozione mariana, tra le tante statue di Maria Ausiliatrice,<br />
vi è pure la Madonnina che Don Bosco ha benedetto e consegnato<br />
a Don Giovanni Battista Branda inviandolo come primo Direttore<br />
in Spagna. Don Branda l’ha molto cara, la porta con sé nelle sue<br />
tante peregrinazioni e la sente sempre maternamente vicina, protettrice<br />
e testimone di tanti fatti straordinari.<br />
Quando Don Bosco lo manda in Spagna ad aprire la prima Casa<br />
salesiana, ad Utrera nel 1879, gli dice: «Per ora va’ ad aprire la casa<br />
di Utrera, ma vi starai poco tempo perché una signora di Barcelona ci<br />
chiamerà e ci darà tutto il necessario per fondare una grande casa». 20<br />
Infatti, nel 1885 Don Branda riceve una lettera da Donna Dorotea da<br />
Chopitea, prima Cooperatrice Salesiana di Spagna, ora Venerabile, ed<br />
inizia la nuova Casa di Sarrià presso Barcelona. Ed è proprio a Sarrià<br />
che, nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio del 1886 Don Branda è testimone<br />
di una apparizione di Don Bosco. Già nella notte precedente la<br />
festa di S. Francesco di Sales ha sentito chiara la voce di Don Bosco che<br />
lo invita ad alzarsi ed a seguirlo, ma pensando ad un sogno, preferisce<br />
voltarsi dall’altra parte e continuare a dormire. Nella notte del 6 febbraio<br />
però un’altra chiamata lo sveglia: «Don Branda! Adesso non<br />
dormi! Alzati e vieni con me!». Un chiarore intenso illumina la camera<br />
e sulla cortina del letto si staglia la figura di Don Bosco. Don Branda<br />
si alza, si veste e, spostata la cortina, si trova davanti Don Bosco in<br />
persona, che gli dice: «Vieni, conducimi a visitare la casa. Ti farò vedere<br />
cose delle quali tu non sospetti nemmeno, eppure sono cose che<br />
fanno spavento». 21<br />
Passano di corridoio in corridoio, entrano nel dormitorio dei gio-<br />
20<br />
EUGENIO CERIA, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco 1886-1888, Volume<br />
XVIII (Torino, SEI, 1937).<br />
21<br />
Idem.<br />
91
vani. Don Bosco indica tre giovani: sono riconoscibilissimi, anche se<br />
hanno il volto brutalmente sfigurato. «Vedi questi tre disgraziati? Li ha<br />
guastati uno che tu non crederesti, se non fossi venuto io a dirtelo... Tu<br />
te ne sei fidato, tu lo credi buono e tale sembra all’esterno. È il tale...<br />
(e dice nome e cognome). Mandalo subito via dalla casa. Non tollerare<br />
che si fermi ancora in mezzo ai giovani. Sarebbe capace di rovinarne<br />
altri». 22 Don Bosco scompare e Don Branda rimane di sasso! Ma<br />
come risolvere il caso? Come chiamare quei ragazzi, come far loro<br />
confessare la colpa e denunciare il colpevole? Esteriormente non danno<br />
motivo di rimprovero! Nella grande incertezza, Don Branda sente interiormente<br />
una voce che continua a ripetergli: agisci, agisci subito!<br />
Chiama i collaboratori, gli assistenti e raccomanda loro di intensificare<br />
la sorveglianza per scoprire tra i giovani i meno buoni. Ma parla in<br />
generale, senza rivelare nulla di quanto udito quella notte. Pensa di<br />
aver così fatto quanto prudentemente è richiesto in attesa di indizi validi.<br />
Mentre è in questo stato d’animo, riceve una lettera da Torino da<br />
parte di Don Rua che scrive: «Stasera io passeggiavo con Don Bosco<br />
ed egli mi disse che ti ha fatto una visita. Ma tu forse a quell’ora dormivi».<br />
Anche Donna Dorotea dice di aver sognato Don Bosco in quella<br />
notte. Qualche giorno dopo, iniziando la celebrazione della S. Messa,<br />
mentre bacia l’altare, Don Branda, invaso da terrore e tremore, sente<br />
imperiosa dentro di sé una voce che dice: «Fa’ subito quello che ti ha<br />
ordinato Don Bosco, altrimenti questa è l’ultima Messa che celebri».<br />
Allora Don Branda sconvolto decide di agire. Ordina a Don Aime,<br />
suo Vicario, di convocare quei ragazzi separatamente, all’insaputa l’uno<br />
dell’altro; faccia loro capire di essere a conoscenza di tutto e li convinca<br />
a confessare e a denunciare il colpevole primo. Don Branda intanto<br />
scrive su di un foglio il nome del corruttore, pronunciato da Don<br />
Bosco, che lascia piegato sulla scrivania. Don Aime riesce a far confessare<br />
i colpevoli ed a denunciare il corruttore, il nome del quale corrisponde<br />
a quello scritto sul foglio! Finalmente i colpevoli, a breve distanza<br />
l’uno dall’altro, sono allontanati dalla Casa.<br />
Rientrato in Italia, Don Branda si vede affidata la direzione dell’Oratorio<br />
femminile di Chieri, quindi passa a Zurigo per l’assistenza agli<br />
92<br />
22<br />
EUGENIO CERIA, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco 1886-1888, Volume<br />
XVIII (Torino, SEI, 1937).
emigrati Italiani e poi in Lorena, portando sempre con sé la Madonnina<br />
benedetta da Don Bosco, verso la quale è grandemente devoto.<br />
Chiude la sua vita, ricca di anni e di meriti, in Torino Valdocco, accanto<br />
alla Basilica di Maria Ausiliatrice, nel 1927.<br />
San Giuseppe<br />
Non è certo possibile immaginare il Museo di Devozione mariana<br />
senza la presenza di San Giuseppe. La Madonna non può sicuramente<br />
separarsi dal suo casto Sposo Giuseppe. Infatti San Giuseppe è presente,<br />
in modo discreto, secondo il suo stile silenzioso, in tanti modi:<br />
con statue, quadri e numerose immaginette, talvolta di non rilevante importanza,<br />
tal’altra invece di valore. Due presenze in particolare meritano<br />
di essere segnalate.<br />
La prima è un quadro ad olio su tela, delle dimensioni di cm 35 x<br />
45, raffigurante San Giuseppe dall’aspetto sereno e giovanile, anche<br />
se con barba brizzolata, con l’immancabile verga fiorita, che tiene delicatamente<br />
in braccio il Bambino Gesù, biondo, paffutello, dallo sguardo<br />
gioioso, con nella mano destra una semplice croce di legno. Il vestito<br />
di San Giuseppe è costituito dalla tunica verde scuro e dal manto<br />
di colore marrone, mentre Gesù Bambino è nudo con un abbondante<br />
perizoma bianco. L’insieme della raffigurazione ispira una grande serenità<br />
e devozione. La pittura è stata leggermente ritoccata in alcuni<br />
punti marginali, nel 1923. Nel retro si leggono chiare le iniziali dell’autore<br />
F. R. e la data 1870, che purtroppo non sono sufficienti a fornire<br />
ulteriori informazioni. Potrebbe essere uno dei bozzetti fatti eseguire da<br />
Don Bosco, in vista del grande quadro posto sull’altare di San Giuseppe<br />
nella Basilica di Maria Ausiliatrice, eseguito dal Lorenzone proprio<br />
in quegli anni.<br />
Sul retro del quadro un cartiglio, in chiara grafia a penna, dice:<br />
«Dono del Ven.le D. Bosco a Don Giuseppe Campi. Don Campi a Bernasconi<br />
per ricordo dei servizi fatti durante la sua infermità. Mathi 19<br />
marzo 1920».<br />
Don Giuseppe Campi è nato a Mornese nel 1844 ed è morto a<br />
Mathi il 26 febbraio 1922. Egli è ricordato diverse volte nelle Memorie<br />
Biografiche di Don Bosco, e nella Cronistoria dell’Istituto delle Figlie<br />
di Maria Ausiliatrice. È presente e partecipa ai primi Esercizi Spi-<br />
93
ituali dei Salesiani, a Trofarello dal 2 al 6 agosto del 1866, predicati<br />
per le istruzioni da Don Bosco e per le meditazioni dal can. Lorenzo<br />
Gastaldi, che sarà poi Arcivescovo di Torino. È proprio il giovane Campi<br />
a scrivere i Ricordi, lasciati da Don Bosco al termine degli Esercizi, e<br />
riportati da Don Lemoyne nelle Memorie Biografiche alla pag. 445 del<br />
Volume VIII.<br />
Antonio Bernasconi, salesiano Coadiutore, maestro in arte grafica,<br />
è morto a Torino Casa Madre nel 1952.<br />
Una seconda presenza di San Giuseppe nel Museo Mariano che<br />
merita di essere segnalata è la statua in cera raffigurante San Giuseppe,<br />
seduto su sedile di gesso con il Bambino in braccio. Anch’essa è<br />
del 1800. Il volto, i capelli, come pure le mani ed i piedi di San Giuseppe<br />
sono in cera; il corpo è di canapa retto da apposito sostegno e<br />
coperto con abito di tela e di taffetà di seta. Il Bambino è totalmente<br />
in cera, eccetto i capelli che sono in canapa fine, coperto da semplice<br />
perizoma in raso. Racchiude il gruppo una teca in noce e vetro, di<br />
cm 45 x 45 x 70. Apparteneva ad una famiglia torinese ed è stata donata<br />
al Museo dal salesiano Don Romeo Tavano.<br />
La Medaglia Miracolosa<br />
94<br />
La devozione all’Immacolata della Medaglia Miracolosa è presente<br />
in modo considerevole nel Museo Mariano. Numerose sono le Immaginette,<br />
italiane ed estere, anche pregiate, che rappresentano l’Immacolata<br />
in diverse forme: con i raggi e la corona, con i raggi senza la<br />
corona, circondata da gigli o da rose, con la Medaglia Miracolosa,<br />
ecc.; tutte molto belle che favoriscono la devozione. Una statua alta<br />
80 cm, in terracotta colorata, è Preziosa non tanto per bellezza delle<br />
forme, quanto per la sua età che l’avvicina all’epoca delle apparizioni.<br />
Infatti è databile nella seconda metà dell’800, e le apparizioni della<br />
Madonna a S. Caterina Labouré sono del 1830. Caratteristici sono poi<br />
due Quadrifondi di dimensioni diverse (cm 75 x 105 uno, e cm 60 x<br />
75 l’altro) che rappresentano l’Immacolata nel tipico atteggiamento,<br />
con le braccia abbassate e con i raggi che si dipartono dalle mani; il<br />
volto è tratto da una bella litografia ed il corpo è rivestito di seta bianca<br />
con manto azzurro, ricamata e punteggiata in oro; il capo ricoperto<br />
da un velo di tulle bianco, con la corona, è circondato dalle 12 stel-
le; i piedi poggiano sulla sfera del mondo, sostenuto da nuvole in carta<br />
stagnola, e schiacciano la testa dell’insidioso serpente. Rose e gigli di<br />
seta, in rilievo, completano la decorazione del quadro, sullo sfondo<br />
del quale campeggia, a caratteri dorati, l’invocazione: “O Maria Concepita<br />
senza peccato pregate per noi che ricorriamo a Voi”. Nel quadro<br />
più grande sono incastonate, nell’ornamentazione, le Reliquie di<br />
S. Benigno, di S. Clemente, di S. Colomba, di S. Bonifacio, di S. Massimino<br />
e di S. Giusto. Entrambi i quadri sono stati confezionati da Suor<br />
Giuseppa Ceresa (parente di Don Pietro Ceresa?), Figlia della Carità e<br />
donati l’uno al “Dott. Carlo Rocchietti, presidente, nel 50º di fondazione<br />
dell’Associazione delle Figlie di Maria, il 2 febbraio 1909”; l’altro<br />
donato al “Novello Teologo Don Antonio Minellono il 15 maggio 1910”.<br />
Collegati con la Medaglia Miracolosa sono lo Scapolare Verde del<br />
Cuore Immacolato di Maria, e lo Scapolare Rosso della Passione, ossia<br />
del S. Cuore di Gesù e del Cuore amantissimo ed addolorato della<br />
Beata ed Immacolata Vergine Maria.<br />
L’8 settembre del 1840, a dieci anni dalle apparizioni della Madonna<br />
a S. Caterina Labouré, suor Giustina Bisqueyburu, giovane novizia<br />
delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, in rue du Bac, in una<br />
visione vede la Madonna con nella mano destra il suo cuore sormontato<br />
da fiamme, e nell’altra una specie di Scapolare di stoffa verde; su<br />
una parte, l’Immagine di Maria che tiene nelle mani il suo Cuore trafitto<br />
e sull’altra parte un cuore trafitto da una spada, tutto acceso di<br />
raggi più brillanti del sole e trasparenti come cristallo. Il cuore è circondato<br />
dalla scritta: «Cuore Immacolato di Maria, pregate per noi, adesso<br />
e nell’ora della nostra morte». Una voce interna le dice che questa<br />
immagine dovrà contribuire alla conversione dei peccatori e procurare<br />
loro una buona morte; la faccia eseguire al più presto e la distribuisca<br />
con fiducia.<br />
Sei anni dopo, il 26 luglio 1846, un’altra Figlia della Carità, suor<br />
Luigia Apollina Andriveau, in visione vede sull’altare N. Signore, vestito<br />
di rosso con il manto blu, che tiene nella mano destra uno Scapolare<br />
rosso: su di una facciata è raffigurato Gesù in croce circondato<br />
dagli strumenti della Passione e dalla scritta: «Santa Passione di N. Signor<br />
Gesù Cristo, Salvateci!», sull’altra è impressa l’immagine dei sacri<br />
Cuori di Gesù, incoronato di spine, e di Maria, trapassato dalla spada;<br />
fra i due cuori una croce ed attorno la scritta: «Sacri Cuori di Gesù e<br />
95
Maria, proteggeteci!» Nel 1847 il Papa Pio IX approva lo Scapolare, lo<br />
arricchisce di indulgenze ed autorizza i Preti della Missione a benedirlo<br />
e diffonderlo.<br />
Bassorilievi di Don Bosco<br />
96<br />
Nel Museo Mariano incontriamo numerosi bassorilievi, riproducenti<br />
Don Bosco in vari atteggiamenti, che meritano di essere segnalati<br />
per il loro significato e per il merito degli autori.<br />
Un bassorilievo in bronzo rettangolare (19 x 29 cm) riproduce la<br />
statua di Don Bosco, dello scultore Gaetano Cellini, posta sul monumento<br />
antistante la Basilica di Maria Ausiliatrice. Il Santo, sorridente è<br />
circondato da tre ragazzi e pare scherzare con uno di essi; alla base,<br />
la scritta “Beatus Joannes Bosco” ci dice che la fusione, di S. Johnson,<br />
è stata effettuata tra il 1929, data della Beatificazione ed il 1934, data<br />
della Canonizzazione di Don Bosco. Dello stesso Gaetano Cellini, perché<br />
firmato, è un tondo in bronzo (ø 24 cm) che riproduce il volto sorridente<br />
di Don Bosco, già magistralmente da lui modellato per il corpo<br />
adagiato nell’Urna del Santo.<br />
Il 1988, centenario della morte di Don Bosco, è stato una felice<br />
occasione per riprodurre il Santo in svariate posizioni; moltissimi artisti<br />
hanno impegnato le loro migliori doti per rendere omaggio a<br />
Don Bosco ed alla sua opera. Lo scultore Giorgio Fogliani di Modena,<br />
in un bassorilievo in rame (46 x 66 cm) ritrae Don Bosco sul letto<br />
di Morte con il crocifisso tra le mani ed, in alto a sinistra, la Basilica<br />
di Maria Ausiliatrice ed il Tempio del Colle dei Becchi. Del medesimo<br />
scultore è l’ovale in rame scolpito, con cornice (50 x 60 cm),<br />
opera unica, raffigurante Don Bosco a mezzobusto in atteggiamento<br />
di preghiera.<br />
Un tondo del diametro di 40 cm, in rame battuto, fissa il momento<br />
storico della Congregazione nel 1988, ritraendo Don Bosco circondato<br />
dal volto dei suoi Successori, del B. Michele Rua, di D. Paolo Albera,<br />
di D. Filippo Rinaldi (non ancora beatificato), di D. Pietro Ricaldone,<br />
di D. Luigi Ricceri e di D. Egidio Viganò; al centro lo stemma dei<br />
Salesiani e la scritta “1º Centenario Morte S. G. Bosco”.<br />
Un bassorilievo in bronzo dorato, con cornice, (16 x 22 cm) dello<br />
scultore Pietro Rocchi, ritrae Don Bosco a mezzobusto con sullo sfon-
La Medaglia miracolosa.<br />
Bassorilievi di Don Bosco.
Bassorilievi di Don Bosco.<br />
Boccale in cotto (1878).
do la Basilica di Maria Ausiliatrice e la scritta “1888-1988 Tivoli 27<br />
marzo”. È dono delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore al Rettor Maggiore<br />
D. E. Viganò.<br />
Lo scultore Paolo Ciaccheri con un bassorilievo in bronzo ramato<br />
(ø 15 cm) ritrae Don Bosco attorniato da giovani artigiani, studenti e<br />
sportivi.<br />
Dalla Congregazione sparsa nel mondo provengono: dalla Francia,<br />
un bassorilievo in rame battuto (47 x 36 cm) raffigurante Don Bosco a<br />
mezzobusto, sul modello della fotografia scattata a Nizza nel 1885;<br />
dagli alunni delle Scuole Professionali del Vietnam, un bassorilievo in<br />
legno pesante scolpito (28 x 50 cm) che ritrae Don Bosco a tre quarti,<br />
con le mani giunte appoggiate al piano del tavolo, sul modello del dipinto<br />
di Mario Caffaro Rore che a sua volta si rifà alla fotografia di Michele<br />
Schemboche, del 1880; ed in fine, dall’Africa Centrale, un bassorilievo<br />
in rame sbalzato e colorato (45 x 65 cm) con in alto a destra<br />
il volto giovanile di Don Bosco, in basso a sinistra il Rettor Maggiore<br />
D. Juan E. Vecchi, al centro, sul contorno della regione Centro Africana,<br />
figure di giovani intenti nelle diverse attività di studio, lavoro, pietà<br />
e tempo libero. Ricorda i 40 anni di presenza Salesiana in Centro Africa<br />
(1959-1999).<br />
Boccale in cotto, bianco cerchiato di argento,<br />
usato da Don Bosco nella bilocazione del 1878<br />
Nel Museo Mariano, si conserva un prezioso cimelio di Don Bosco,<br />
che ha un’interessante storia: un boccale in terracotta, bianco, cerchiato<br />
d’argento che veniva usato per l’acqua.<br />
La storia di questo boccale è riportata dalle Memorie Biografiche<br />
di Don Bosco nel volume XIV alle pagine 681-684. Si tratta di un caso<br />
di bilocazione: Don Bosco si trova contemporaneamente a Torino ed<br />
a Saint-Rambert d’Albon, dipartimento della Drôme, in Francia. Era il<br />
14 ottobre 1878. «Quel giorno – dicono le Memorie Biografiche – nella<br />
casa della signora Adele Clément… entrò un prete sconosciuto, che<br />
parlava francese né volle mai dire il proprio nome, ma alle reiterate<br />
insistenze rispose: – Di qui ad alcuni anni il mio nome sarà stampato<br />
sui libri e quei libri vi capiteranno tra mano. Allora saprete chi sono io».<br />
Lo aveva condotto in casa il marito della signora, negoziante di olio<br />
99
100<br />
e carbone. Stava rientrando, dopo aver scaricato la sua merce, quando<br />
all’improvviso vide un prete che camminava a gran fatica; ne ebbe<br />
compassione, gli si avvicinò e gli disse: – Signor curato, lei mi ha l’aria<br />
di essere molto stanco. – Oh, sì, bravo uomo, gli rispose il prete; ho fatto<br />
un lungo viaggio. – Signor curato, io le offrirei ben volentieri un passaggio,<br />
ma su questa carretta, non oso! – Voi mi fate un gran piacere.<br />
Io accetto perché non ne posso proprio più.<br />
Ciò detto, aiutato da quel bravo uomo, il prete salì sul carro. Dimostrava<br />
un’età tra i trenta ed i quarant’anni, ed aveva una bella presenza.<br />
«Una particolarità – precisano ancora le Memorie – alla quale lì<br />
per lì quell’uomo non aveva badato, ma di cui si rese ben conto in seguito,<br />
fu che quantunque il prete seduto sul fondo della carretta sporgesse<br />
in alto dalle bande con tutta la testa e col suo bravo tricorno,<br />
pure nessuno, anche passando vicino, aveva fatto il menomo segno di<br />
accorgersene».<br />
Giunti a casa, il signor Clément corse ad avvertire la moglie che<br />
aveva condotto un prete stanchissimo e bisognoso di ristoro. La signora,<br />
caritatevole e pia, gli offrì di pranzare con loro, ed il prete accettò.<br />
Durante il pranzo la signora raccontò le sue disgrazie, ed in particolare<br />
la dolorosa storia di un figlio che, improvvisamente, per un malore,<br />
era diventato cieco, sordo e muto. Avevano pregato tanto, ma inutilmente.<br />
«Pregate, buona signora, e sarete esaudita» le disse il prete. «Vuol<br />
dire, signor curato?… Vada a vederlo».<br />
Sulla tavola, accanto alla bottiglia del vino, c’era un boccale di<br />
cotto, come si usava allora, per l’acqua, bianco e cerchiato d’argento.<br />
Il prete disse: «Conservate questo boccale per mio ricordo». Così fecero,<br />
come attesta la figlia, allora piccina, che lo ebbe dal padre: «è una<br />
Reliquia di quel santo prete». Ora quel boccale è conservato con tanta<br />
cura nel Centro di Documentazione Mariana di Valdocco.<br />
Terminato il pranzo, mentre il signor Clément è intento ad abbeverare<br />
il cavalli, il prete, alzatosi, disse alla signora: «Una voce mi chiama,<br />
e bisogna che io parta», e partì.<br />
La signora si precipitò dal marito, attaccarono i cavalli e gli volarono<br />
dietro, sicuri di raggiungerlo quanto prima, ma più non lo videro.<br />
Quando però arrivarono alla casa dove si trovava il figlio malato,<br />
la balia raccontò loro che era venuto un prete ed aveva guarito il bam-
ino. Dai calcoli fatti risultò che il momento in cui il prete era entrato<br />
là coincideva con quello in cui era uscito da casa Clément.<br />
Sette anni dopo il fatto straordinario, da una fotografia, pubblicata<br />
su un libro, i coniugi Clément vengono a scoprire che quel prete era<br />
Don Bosco.<br />
Da una lettera della figlia, allora bambina, poi vissuta a Lione e deceduta,<br />
«quasi senza sofferenza», il 23 gennaio 1933, conosciamo la<br />
storia della famiglia Clément. La madre morì nel 1914, dopo essere<br />
stata devotissima di Don Bosco, il papà morì nel 1925. Il fratello del<br />
miracolo visse fino al 1928, e morì in seguito ad un tumore al cervello.<br />
«I medici ne pronosticavano una morte straziante; invece si spense<br />
placidamente, cosa che fu ritenuta una nuova grazia del Beato Don<br />
Bosco» (Memorie Biografiche, XIV, p. 684).<br />
Nel 1954 Don Francis Desramaut, Professore di Storia Ecclesiastica<br />
nel Centro Salesiano di Lione, è riuscito a rintracciare i nipoti<br />
dei signori Clément, i quali gli hanno confermato, a grandi linee,<br />
quanto è detto nelle Memorie Biografiche. Viene pure a sapere che<br />
il Boccale era, allora, custodito presso il Sig. Barnasson, locatario di<br />
Maddalena Touvron, nata Clément, a Saint-Rambert d’Albon. Gli fu<br />
subito portato: «Era avviluppato in un sacco di carta, e leggermente<br />
abraso. Ho comunicato subito la mia scoperta a Don Ceria, ed inviato<br />
agli archivi di Valdocco una fotografia del pezzo. Ho poi consegnato<br />
l’oggetto stesso al Rev. Padre Fedele Giraudi, Economo Generale<br />
della Società Salesiana, il 10 luglio, perché lo depositi, se giudica<br />
bene, nel museo di Valdocco. 13 luglio 1959» (dalla dichiarazione<br />
firmata di D. Desramaut).<br />
Ricordi del Beato Filippo Rinaldi<br />
La vera anima del Museo Mariano, chi ha sostenuto la sua realizzazione,<br />
è stato il Beato Filippo Rinaldi che divenne poi il terzo successore<br />
di Don Bosco e Rettor Maggiore dei Salesiani (1922-1931).<br />
Egli, attraverso l’opera dell’architetto Ceradini e di parecchi Salesiani,<br />
aveva fissato «i criteri fondamentali circa la sistemazione del<br />
Museo; ne fu così fissato nelle linee generali l’ordinamento, in modo<br />
che, come disse allora Don Rinaldi, riuscisse per se stesso, anche ai<br />
meno intelligenti, chiara espressione della sua ragione di essere, cioè<br />
101
una solenne prova di fatto del favore di Maria Ausiliatrice all’opera<br />
di Don Bosco e dell’espansione che questa diede al suo culto, rendendolo<br />
universale». 23<br />
Con grande amore e cura, pertanto, il Museo conserva alcuni cimeli<br />
che rendono viva la memoria del Beato Filippo Rinaldi.<br />
1. Statuina del Sacro Cuore di Gesù, alta cm 40 circa, in gesso; apparteneva<br />
al B. Filippo Rinaldi, che la teneva con grande venerazione<br />
nella propria camera. È nota la grande devozione di Don Rinaldi per<br />
il Sacro Cuore di Gesù: la viveva personalmente e la inculcava con insistenza,<br />
nei suoi scritti, a Salesiani e non. Chiudeva sempre ogni sua<br />
lettera, sia privata che ufficiale, dichiarandosi, prima della firma, in<br />
Corde Jesu. Ricordiamo solamente due monumenti, chiamiamoli così,<br />
del suo amore al Sacro Cuore. Egli era stato pars magna nella progettazione<br />
della Chiesa che i Salesiani avevano eretto in Casale Monferrato,<br />
dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1922 si trattava di inaugurarla.<br />
Don Rinaldi, appena eletto Rettor Maggiore, volle che, a coronamento<br />
dei festeggiamenti si tenesse un Congresso nazionale del Sacro<br />
Cuore. È stato il primo ed ha meritato i rallegramenti che il Santo Padre<br />
con un Breve del 10 ottobre, indirizzava «al diletto figlio Don Filippo<br />
Rinaldi, Rettor Maggiore della Pia Società Salesiana, presidente effettivo<br />
del primo Congresso nazionale del Sacro Cuore di Gesù in Casale<br />
Monferrato».<br />
L’altro monumento è il Tempio del Sacro Cuore sul Tibidabo sopra Barcelona<br />
che Don Rinaldi ha caldeggiato fin dai tempi della sua permanenza<br />
in Spagna, ma che non ha avuto la soddisfazione di vedere ultimato.<br />
L’Ispettore Don Giuseppe Calasanz, tre anni prima di cadere vittima<br />
dei comunisti, confermava: «nessuna opera della Spagna salesiana<br />
stette tanto a cuore a Don Rinaldi, nessuna raccomandò con maggior<br />
insistenza come l’opera del Tibidabo». 24<br />
Ora la statuina del Sacro Cuore di Gesù, testimone della devozione di<br />
Don Rinaldi, si trova nel Museo Mariano. Il Salesiano coadiutore Ghezzi<br />
Battista, nel consegnarla, così ha dichiarato: «Questa statuetta del<br />
Sacro Cuore di Gesù apparteneva a Don Filippo Rinaldi. Era nella camera<br />
del servo di Dio, anche nel giorno della sua morte, sopra il tavo-<br />
102<br />
23<br />
E. CERIA, Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi, Torino, SEI, 1951, pag. 313.<br />
24<br />
Idem, pag. 328.
lino. Il Rettor Maggiore Don Luigi Ricceri la tenne sempre nella sua camera.<br />
Quando egli partì per Roma, la statuetta rimase ancora nella camera<br />
di Don Ricceri, e la ereditò e custodì Don Giuseppe Giliberti,<br />
Direttore. È stata poi ritirata dal confratello Ghezzi Battista... La statua<br />
era molto scolorita. Ora, restaurata, viene consegnata al Centro di Documentazione.<br />
In fede di quanto qui dichiarato, firmato Ghezzi Battista.<br />
Torino, 14 gennaio 1989».<br />
2. Statuina di Maria Ausiliatrice, esposta in un quadro profondo ed<br />
adornata. D. E. Ceria, nell’opera citata, così sintetizza la devozione di<br />
Don Rinaldi a Maria Ausiliatrice: «E quanto fosse allora da lui sentita<br />
la divozione a Maria Ausiliatrice, non si scorge chiaramente dalla candida<br />
e quasi infantile semplicità, con la quale metteva ai piedi della statuetta<br />
i bigliettini contenenti invocazioni di aiuto in momenti critici o<br />
per affari delicati?». 25<br />
Nel consegnare la statuina a Don Pietro M. Ceresa, responsabile del<br />
Centro, Don Romeo Tavano sottoscrive la seguente dichiarazione: «Questa<br />
mattina, 1° marzo 1985, Don Romeo Tavano, a nome del Rettor<br />
Maggiore Don Egidio Viganò, ha portato al Centro Salesiano di Documentazione<br />
storica e popolare mariana, questa immaginetta della Madonna.<br />
Egli, Don Tavano, dichiara: “è quella di Don Rinaldi”: a) è stata<br />
sulla scrivania di Don Filippo Rinaldi, che sotto di Lei metteva, con<br />
piena fiducia di figlio, i suoi bigliettini con domande e suppliche; b) alla<br />
morte di Don Rinaldi fu ritirata da Don Fedele Giraudi; c) alla morte<br />
di Don Giraudi, fu ritirata da Don Romeo Tavano. Il Rettor Maggiore<br />
Don E. Viganò la fece consegnare a Don Pietro M. Ceresa. Firmato<br />
D. R. Tavano».<br />
Il Museo conserva ancora altri segni della devozione di Don Rinaldi a<br />
Maria Ausiliatrice: due statuine della Madonna, alte 15 cm circa, benedette<br />
da Don Rinaldi e conservate con grande religiosità dalle persone<br />
alle quali le aveva donate; ma soprattutto la corona del Rosario<br />
donata da Don Bosco a Don Rinaldi, e a sua volta donata da Don Rinaldi<br />
a Suor Pierina Sutto, Figlia di Maria Ausiliatrice, che conferma la<br />
cosa di proprio pugno.<br />
3. Lettera autografa alla Signora Emma Caviglione: è una bella testi-<br />
25<br />
E. CERIA, Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi, Torino, SEI, 1951, pag. 308.<br />
103
monianza dello stile paterno, ma fermo, pieno di dolcezza e di fiducia,<br />
che Don Rinaldi usa nel suo apostolato, attraverso le numerose<br />
lettere scritte a confratelli salesiani ed a persone di ogni ceto. Trascriviamo<br />
le parole centrali della lettera: «Le impongo che viva con maggior<br />
fiducia ed abbandono quale si addice ad una creatura che avendo<br />
bisogno di riposare, obbedisce piega il suo capo e dorme. Così fa<br />
la bambina coperta dalla mano benefica e buona della mamma. Dorma<br />
adunque, Emma, e non pensi ad altro che questa è volontà di Dio»<br />
(31-7-1916).<br />
La lettera è stata inviata a Don Ceresa dal Sac. Vendel Fenyö, incaricato<br />
dell’Archivio centrale salesiano di Roma, con queste parole: «Reverendo<br />
Don Ceresa, affido a Don Fiora una lettera di Don Rinaldi per<br />
consegnarla a lei per il Museo mariano. Lo faccio per via eccezionale,<br />
per il Museo. Se avessi trovato una di contenuto mariano, forse<br />
avrebbe maggior pregio. Questa si trova tra altre lettere inviate da Don<br />
Rinaldi alla Signora Emma Caviglione - Via Carmine, 4 - Torino. Per favore,<br />
mi avverta se la lettera verrà realmente utilizzata nel Museo. In<br />
caso contrario ne chiederò la restituzione. Mi ricordi alla Madonna. Sac.<br />
Vendel Fenyö».<br />
Le preziose Corone della Madonna dei Laghi di Avigliana<br />
104<br />
La Mostra allestita per il Natale 2006, dedicata ai Presepi ed alla<br />
Devozione popolare nei più noti Santuari mariani d’Italia, è stata impreziosita<br />
dalla esposizione delle bellissime e preziose Corone della Madonna<br />
dei Laghi di Avigliana. Sono le Corone usate per la seconda incoronazione<br />
del 1752 e per la terza del 1852. Purtroppo quella usata<br />
per la prima incoronazione del 1652 è stata rubata in uno dei frequenti<br />
saccheggi subiti dall’allora Convento dei Cappuccini.<br />
È pertanto interessante, oltre che doveroso, informare gli Amici<br />
del Centro di Documentazione sulle gloriose vicende storiche che<br />
hanno portato le Corone della Madonna di Avigliana ad approdare felicemente<br />
nel Museo della Devozione mariana dell’Ausiliatrice. Sarà<br />
questo finalmente, ultimato il restauro della Basilica, un ulteriore motivo<br />
per una dignitosa sistemazione del Museo stesso Mariano.<br />
La Madonna della rondine<br />
Sulla sponda destra del Lago grande di Avigliana, nei primi anni del<br />
1300 esisteva un semplice Pilone di campagna, espressione della de-
Ricordi<br />
del Beato Filippo Rinaldi.
1752<br />
Corone della Madonna dei<br />
Laghi di Avigliana.<br />
1852
vozione degli abitanti del luogo verso la Beata Vergine, alla quale rivolgersi<br />
tra le tante difficoltà della vita: per la salute dei bambini e degli<br />
anziani, per la prosperità degli animali domestici, contro il flagello<br />
delle infezioni che tanto frequentemente distruggevano le viti e le altre<br />
colture. 26 La Madonna vi era raffigurata in atteggiamento materno, seduta<br />
con in braccio, nel dolce atto di allattarlo, il Bambino che tiene<br />
tra le manine, trastullo innocente, una rondine. Di qui il titolo di Madonna<br />
della rondine.<br />
Da questo semplice Pilone ha origine il Santuario della Madonna<br />
dei Laghi che domina la ridente conca del Lago grande di Avigliana.<br />
Tra le tante grazie ottenute per intercessione della Madonna della<br />
rondine, forse la più insigne, è quella ricevuta dalla contessa di Savoia,<br />
Bona di Borbone, sposa di Amedeo VI, tanto desiderosa di poter<br />
stringere anche lei al proprio seno un bambino ed erede. La Madonna<br />
accoglie il suo desiderio di mamma ed il 24 febbraio 1360 nasce Amedeo<br />
VII, il Conte Rosso.<br />
La riconoscenza verso la Madonna, di Bona di Borbone, di tante<br />
altre mamme felici e di tutte le persone beneficate, fu grande e continua:<br />
il Pilone si trasformò in piccola Cappella e quindi in Santuario<br />
con annesso il Convento per i Padri Cappuccini.<br />
La Madonna Annunziata<br />
Nel corso dei secoli la bontà della Madonna continuò a manifestarsi<br />
ad un numero sempre maggiore di devoti e la riconoscenza dei<br />
beneficati non venne meno. Benefattori grandi ed umili abbellirono<br />
sempre più il Santuario che si impreziosì di vere opere d’arte. Nel 1615<br />
il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, fece dono al Santuario del bellissimo<br />
trittico posto sulla pala dell’Altare maggiore, che separa il Coro<br />
dal resto della Chiesa. Al centro, il trittico rappresenta la Vergine in<br />
atto di ricevere l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele, sotto il globo luminoso<br />
dello Spirito Santo, a sinistra è raffigurato S. Sebastiano e, a<br />
destra, S. Rocco. Questo bellissimo quadro tradizionalmente è stato<br />
attribuito al pittore Defendente Ferrari (1488-1535), mentre ora pare<br />
debba essere ritenuta opera di Amedeo Albini. 27<br />
Così la materna figura della Madonna della rondine, che allatta il<br />
26<br />
ANTONINO DA TORINO, Cenni storici intorno al Santuario della Madonna de’<br />
Laghi presso Avigliana ... (Torino, Tip. di Giulio Sperani e Figli, 1867).<br />
27<br />
PAOLO RISSO, La “Madonna dei Laghi” Avigliana.<br />
107
piccolo Gesù, viene sostituita, nella devozione popolare, dalla dolce<br />
immagine della Vergine Annunziata.<br />
Il Santuario, sotto la cura zelante dei PP. Cappuccini, diventa centro<br />
di intensa vita cristiana e di devozione mariana. La Madonna è la<br />
mamma premurosa alla quale tutti ricorrono nelle tante situazioni difficili<br />
del tempo, turbato da frequenti guerre, scorribande ed epidemie.<br />
Proprio nell’infuriare della terribile pestilenza che ha mietuto tante vittime,<br />
specialmente nelle terre dell’Italia settentrionale, negli anni<br />
1630/31, si è manifestata la materna protezione della Madonna che a<br />
tutti veniva in aiuto, attraverso lo zelo e la carità eroica dei Figli di S.<br />
Francesco.<br />
La Prima Corona<br />
Passata la bufera, cessato il contagio e tornata relativamente normale<br />
la vita, la riconoscenza dei beneficati si manifesta ponendo sul<br />
capo della Vergine Annunziata una preziosa Corona. È il 14 aprile del<br />
1652, giorno veramente solenne di festa. Sono presenti tutte la autorità<br />
civili e religiose del tempo, e soprattutto una grande folla di fedeli<br />
riconoscenti per le grazie ricevute.<br />
«La corona era tutta di argento, ornata di pietre preziose, offerta per<br />
voto dal sig. Giuseppe Gallina, figlio di Giovanni Domenico, orefice<br />
in Torino, già stato liberato da una mortale infermità per grazie di questa<br />
beatissima Vergine». 28 La Madonna ora è Regina, ma resta sempre<br />
Madre!<br />
I tempi però continuano tristi; la seconda metà del 1600 è segnata<br />
dalla guerra di Francia contro il Ducato di Savoia. L’esercito di Luigi<br />
XIV, proveniente da Pinerolo e dalla Valle di Susa, punta sul castello di<br />
Avigliana, per avere libero passo su Torino, e tutto travolge. Anche il Santuario<br />
della Madonna dei Laghi ed il Convento dei Cappuccini vengono<br />
travolti e saccheggiati. La guerra porterà distruzione in tutto il Piemonte,<br />
fino alla battaglia di Torino del 7 settembre 1706, dopo il voto<br />
alla Madonna, fatto dal duca Vittorio Amedeo, di erigere la Basilica di<br />
Superga.<br />
La seconda Corona<br />
Ma la miseria, le rapine, le violenze non si placano! Una notte,<br />
mentre infuria la tempesta, nel 1711, alcuni malviventi si introducono<br />
108<br />
28<br />
PAOLO RISSO, La “Madonna dei Laghi” Avigliana.
nel Santuario e rubano, con calici e argenti votivi, anche la preziosa Corona<br />
della Madonna.<br />
Per riparare il sacrilego furto ed accrescere la devozione alla Madonna,<br />
il 30 aprile 1752 si provvede alla seconda incoronazione della<br />
taumaturgica Immagine con un diadema d’oro. Le feste durarono otto<br />
giorni, ma sono caratterizzate non solo da solennità esteriori, quanto<br />
piuttosto da entusiasmo di conversione spirituale. Le cronache riportano<br />
che da venticinque a trenta Cappuccini ogni giorno attesero alle<br />
Confessioni dei fedeli, e che le sacre Comunioni distribuite nel Santuario<br />
furono oltre ventiduemila. La riparazione non poteva desiderarsi<br />
migliore.<br />
Una devota iscrizione volle quasi ricambiare tanto affetto con<br />
le benedizioni e grazie da parte della Madonna: «Voi mi incoronate<br />
di gemme e di oro, Io vi circonderò del mio aiuto. Con la corona<br />
mi avete eletto Regina, Io mi mostrerò a voi Madre e vi proteggerò<br />
come figli».<br />
La terza Corona<br />
Con la fine del secolo, sorgono all’orizzonte dell’Europa nubi nerastre,<br />
foriere di tempesta e di rovina che tutto travolgono e distruggono,<br />
nel nome della dea Ragione. Nel 1802, in base al decreto della<br />
Rivoluzione Francese di soppressione generale degli Ordini religiosi,<br />
anche i PP. Cappuccini devono lasciare il Convento di Avigliana, ed il<br />
Santuario della Madonna dei Laghi viene incamerato e spogliato di<br />
ogni prezioso ornamento.<br />
Occorrerà attendere il passaggio della bufera napoleonica,<br />
per mettere mano alla ricostruzione di ogni cosa. I PP. Cappuccini,<br />
ritornati al Santuario, riprendono il loro lavoro di pastori d’anime<br />
e di ricucitori degli strappi provocati nelle anime dei fedeli<br />
dalla mentalità illuministica, ravvivando la devozione alla Madonna.<br />
Il 22 agosto 1852, ottavo giorno dopo la festa dell’Assunta,<br />
con grandissima solennità, tra una folla immensa esultante di<br />
popolo, viene posta sul capo della Madonna la triplice corona in<br />
argento e pietre preziose donata da don Pietro Vinassa, prevosto<br />
di Chiavrie (Caprie). Nella lettera inviata da Lione, dove si trova<br />
esule, l’Arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni autorizza i Vescovi<br />
presenti «a porre, con rito solenne, sul capo dell’Immagine della<br />
Beatissima Vergine Maria, del titolo della Santissima sua Annun-<br />
109
ciazione, la Corona argentea da me benedetta, in forma di triregno...».<br />
29<br />
Ora il Museo Mariano dell’Ausiliatrice, in Torino, ha il compito<br />
altamente onorifico, di conservare le due preziose Corone, segno della<br />
grande devozione verso la Madonna, dei fedeli, dei PP. Cappuccini di<br />
Avigliana, e dei Figli di Don Bosco che li hanno sostituiti nella cura del<br />
Santuario.<br />
L’amore alla Madonna nelle Ceramiche emiliane<br />
Nel Museo Mariano troviamo numerose ceramiche devozionali<br />
rappresentanti in modo particolare la Madonna. Sono di diversa<br />
provenienza, ma le più numerose provengono dalla zona di Faenza<br />
(Emilia-Romagna). Penso sia gradito presentarne alcune tra le più significative:<br />
La Madonna del Piratello. L’immagine della Madonna del Piratello<br />
(di Imola) è riprodotta in diverse forme. Il tipo originale di questa raffigurazione<br />
si rifà alla icona bizantina della tipologia “Glicophilousa”<br />
(della tenerezza). È l’immagine dell’affetto materno tra Maria e il Bambino<br />
attraverso l’abbraccio e il bacio vicendevoli. Ceramica moderna<br />
(secolo XX) su stampo del 1700.<br />
Un’altra targa devozionale, in terracotta lucida, raffigura la Beata<br />
Vergine del Piratello di Imola con il Bambino sul braccio destro e tre<br />
angioletti che sorreggono la corona della Madonna e del Bambino.<br />
La Beata Vergine del Monticino è raffigurata in una targa devozionale<br />
in maiolica: la Madonna è ritratta con il Bambino ritto sul lato sinistro.<br />
Proviene dallo Studio Poggi di Faenza.<br />
La Beata Vergine di San Luca. Targa devozionale in ceramica policroma<br />
raffigurante la Madonna di San Luca tra un serto di fiori. Sul davanti<br />
reca la scritta “B.V.D. S. Luca - 1856” .<br />
Una targa caratteristica del XIX secolo, raffigura la “B.V. di S. Luga”<br />
(?) in maiolica policroma inserita in un tabernacolo di legno con il tetto<br />
di latta. Si trovava sopra un albero nel comune di Lizzano in Belvedere<br />
(Bologna). Il proprietario ne fece dono al Museo Mariano di Torino,<br />
sostituendola con un’altra moderna.<br />
110<br />
29<br />
PAOLO RISSO, La “Madonna dei Laghi” Avigliana.
Una targa devozionale (secolo XIX) con la scritta “B.V. di S. Lucca”<br />
(?) è in maiolica policroma di origine bolognese. È circondata da una<br />
ghirlanda di fiori e da due Angeli che sostengono la corona. La ghirlanda<br />
di fiori in questo caso non è soltanto un particolare ornamentale,<br />
ma è un elemento che vorrebbe riprodurre la cosiddetta “fioriera”,<br />
il trono processionale in cui sono esposte le immagini della Madonna<br />
nei Santuari bolognesi.<br />
La Madonna delle Grazie. Targa devozionale (secolo XIX) in ceramica<br />
colorata raffigurante la Beata Vergine delle Grazie di Faenza con<br />
in mano le frecce spuntate dell’ira di Dio e ai lati i quattro Santi protettori:<br />
San Savino, San Emiliano, San Pier Damiani e San Terenzio. In<br />
basso la scritta “Maria Madre di grazie protettrice di Faenza” tra le due<br />
chiavi decussate.<br />
La Madonna di Fognano. Targa devozionale (secolo XX) in ceramica<br />
di Danilo Melandri raffigurante la Madonna con il Bambino e la<br />
scritta: “B.V. delle Grazie che si venera nella Chiesa Arcipretale di Fognano<br />
(Ravenna)”.<br />
Ceri votivi storici<br />
Accendere una candela davanti all’altare della Madonna, di Don<br />
Bosco o di un Santo, è segno di devozione, esprime ringraziamento<br />
per una grazia ricevuta, o richiesta di una particolare protezione; i<br />
grandi Santuari come Lourdes, Fatima, ed altri hanno infinità di candele<br />
che ardono tutto l’anno davanti alla Madonna per dirle l’affetto dei<br />
fedeli e raccomandare alla sua bontà tante persone care.<br />
Il cero di dimensione variabile, semplice o artisticamente decorato,<br />
indica una particolare riconoscenza, od un particolare affidamento,<br />
alla Madonna o ad un Santo, da parte di una comunità, in occasioni<br />
speciali. A Monteveglio, ad esempio, ogni anno il 25 marzo il Sindaco<br />
della Città offre al Parroco dell’Abbazia un Cero in riconoscenza<br />
alla Madonna per la liberazione dai Lanzichenecchi nel 1527. Così<br />
avviene a Como in occasione della festa di S. Abbondio, Patrono della<br />
Città. Così pure a Grosseto e a Siena prima della corsa del Palio. Persino<br />
all’inizio del Carnevale di Chiasso, l’Abate offre nella cappella di<br />
S. Sebastiano un grande Cero ad invocare la protezione del Santo.<br />
Nel Museo dell’Ausiliatrice vi sono alcuni Ceri votivi veramente sto-<br />
111
112<br />
rici, perché richiamano avvenimenti cari ed importanti. Ne ricordiamo<br />
alcuni.<br />
Nella sua visita a Torino, la sera del 2 settembre 1988, il Papa Giovanni<br />
Paolo II ha voluto offrire a Don Bosco, come segno della sua<br />
stima e devozione, il grande Cero, di m 1,40 con incise le Insegne<br />
della Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore, a lui offerto in occasione<br />
della Festa del 2 febbraio dello stesso anno.<br />
Nella solenne funzione per la Beatificazione di Domenico Savio,<br />
nel marzo 1950, è stato offerto al Papa Pio XII un bellissimo Cero di m<br />
1,80 tutto decorato a motivi floreali con in alto la figura di Domenico.<br />
Il Papa lo ha voluto inviare ai Salesiani, da conservare a ricordo del<br />
solenne rito di Beatificazione.<br />
Un Cero di m 1,10 formato a sua volta da quattro ceri fusi insieme,<br />
con decorazioni di fiori in rilievo che fanno corona a S. Domenico<br />
Savio, è il grazie di Maria Grazia e Domenico Ferraro di Ristretta,<br />
Messina.<br />
Un altro Cero di m 1,30 con l’immagine in alto dell’Ausiliatrice e<br />
al centro di Domenico Savio, è stato offerto “a Maria Ausiliatrice ed a<br />
Don Bosco in ricordo del 150º della nascita di S. Domenico Savio,<br />
1842 - 2 aprile - 1992”, da Rosaria Urzi nel luglio 1992.<br />
Molti sono i Ceri offerti in onore di Don Bosco! Il più antico è certamente<br />
quello che ci ricorda l’anno in cui Don Bosco è stato dichiarato<br />
Santo, l’anno della sua Canonizzazione: “Don Bosco 1815-1888<br />
- Santo 1934”. Numerosi quelli nell’anno centenario della morte 1888:<br />
il grande Cero offerto dalla Confraternita di Maria Aiuto dei Cristiani in<br />
S. Pietro Lüftelberg, Renania; Don Bosco e i ragazzi; Don Bosco in<br />
Mexico; 100 Jaar Don Bosco, Vlaanderen (Fiandre); Da mihi animas -<br />
Selbst-hingabe im bestiment (Germania); Visita d’insieme - Slovenia<br />
1999; Fedeltà e Omaggio a Don Bosco con le firme di numerose Figlie<br />
di Maria Ausiliatrice.<br />
Sono presenti anche i Ceri di Pellegrinaggi a Maria Ausiliatrice<br />
provenienti da altri Santuari mariani: dalla Madonna del Lares (Balbeno),<br />
Trento; dal Santuario di Pettenhofen, Baviera; dal Santuario di Mariazell,<br />
Austria; dal Santuario di Engen, Germania; dalla Comunità di<br />
Lavarone, Trento; un pellegrinaggio tedesco: “con affetto a Maria Ausiliatrice<br />
- 4 giugno 1993”.<br />
A conclusione, due Ceri ci portano sbalzati i volti di Don Bosco e
di S. Massimiliano Maria Kolbe i due Santi innamorati della Madonna<br />
Immacolata ed Ausiliatrice.<br />
Donazione dei Fratelli Giuseppe ed Ottavio Gallo<br />
Il 6 maggio del 2003, Festa di S. Domenico Savio, è giunta a Torino<br />
la preziosa Donazione che i fratelli Giuseppe e Ottavio Gallo, Sacerdoti<br />
Salesiani, hanno voluto fare al Museo di Devozione mariana.<br />
I fratelli Gallo, oriundi della provincia di Padova, hanno iniziato nel<br />
1953, per incarico del Card. Adeodato Piazza, Patriarca di Venezia, la<br />
Mission Catholique a Saint-Etienne per l’assistenza degli emigrati italiani<br />
in Francia, che hanno diretto per 50 anni. Don Giuseppe, laureato<br />
in Lettere ed in Storia dell’Arte, dirigeva pure un Laboratorio per il<br />
restauro di opere d’Arte, per cui era in relazione con artisti di ogni<br />
parte d’Europa ed ha potuto collezionare dei veri gioielli artistici. Ora,<br />
raggiunta la bella età dei novant’anni, desidera donare all’Ausiliatrice<br />
il frutto di tanti anni di lavoro e di passione per l’Arte.<br />
La donazione al Museo di Devozione mariana comprende:<br />
La Vergine con il Bambino, statua lignea policroma alta 95 cm, in stile<br />
Barocco veneziano di fine ’500 inizio ’600: la veste è in stucco argentato<br />
ed il manto in stucco dorato, secondo l’uso del tempo che riservava<br />
i colori argento e oro per le raffigurazioni del Signore e della Madonna.<br />
Le icone: una collezione di 50 icone di dimensioni varie, e di diversa<br />
provenienza, dalla Russia e addirittura dal Monte Athos. Oltre a quelle<br />
preziose, ricoperte con lamina d’argento e di oro, ve ne sono alcune<br />
originali e rare. Una ad esempio rappresenta la Sacra Famiglia, tema<br />
difficilmente raffigurato dalle Icone, per cui è rarissima. Tavola 29 x 24<br />
cm, presenta, a sinistra, la Vergine con in braccio, seduto il Bambino<br />
Gesù benedicente, a destra, S. Giuseppe che accompagna Giovanni Battista,<br />
piccolo, ma già grandicello rispetto a Gesù. Tutte le figure sono<br />
aureolate e la Vergine porta le classiche tre stelle, sulla fronte, sulla<br />
spalla destra e su quella sinistra, ad indicare la sua purità di mente, di<br />
cuore e di volontà; i colori sono pacati, in gradazione dal rosa al marrone.<br />
Originali sono poi altre due Icone da viaggio, che potremmo<br />
chiamare tascabili, di 7 x 6 cm, e di 5,50 x 6 cm, con custodia in ottone,<br />
apribile in modo da formare un trittico. Il primo trittico rappre-<br />
113
114<br />
senta al centro i tre Angeli a tavola sotto la quercia di Mambre, con in<br />
secondo piano Abramo e Sara; alla destra il battesimo nel fiume Giordano<br />
di Gesù assistito dagli Angeli; alla sinistra la Dormitio Mariae con<br />
figure di Apostoli; i colori sono vivi, con prevalenza di oro. Il secondo<br />
trittico rappresenta tre atteggiamenti della Vergine: al centro la Vergine<br />
sola, in atteggiamento di preghiera, con la stella sulla fronte, sulla<br />
spalla destra e su quella sinistra; a destra la Vergine incoronata, con il<br />
Bambino ritto in braccio: è la Vergine del cammino; a sinistra la Vergine<br />
che indica con la mano il Bambino che tiene in braccio, il quale a<br />
sua volta indica la Vergine, a voler significare che Maria porta a Gesù,<br />
e Gesù porta a Maria. Di tutte queste belle Icone è stata allestita una<br />
Mostra nel Periodo Natalizio del 2003.<br />
Crocifissi in legno ed in avorio: una collezione di 90 pezzi, di dimensioni<br />
varie e di diversa provenienza ed età. Il più grande, e forse il più<br />
antico (1400 c.), misura cm 68 in altezza e cm 60 in apertura di braccia;<br />
è in legno dipinto color carne, con perizoma color oro, dal volto<br />
molto espressivo. Alcune croci poi sono in onice, o in metallo con artistici<br />
smalti. Le Croci per lo più reggono il Crocifisso, di dimensioni e<br />
materiali diversi, in stile romanico, barocco o rinascimentale. Numerosi<br />
sono i Crocifissi, in legno prezioso od in avorio, senza il sostegno<br />
della Croce, alti anche 70 cm. Alcuni di essi sono adagiati su velluto<br />
con cornice dorata barocca. Molti Crocifissi sono monchi, mancano di<br />
braccia, ma conservano un’intensa espressività, scolpiti in legno, ebano<br />
o avorio. Preziose alcune Acquasantiere a forma di croce in metallo<br />
smaltato, su sfondo in onice, con il Cristo in avorio, di stile barocco.<br />
(vedi didascalie).<br />
Reliquiari: una collezione di 47 pezzi, in bronzo ed in metallo prezioso,<br />
con teche in legno e materiale vario dalle forme più svariate ed<br />
artistiche. Provengono, per la maggior parte, da diverse comunità di<br />
Gesuiti, concentrate a Saint-Étienne, e definitivamente chiuse. Vorremmo<br />
presentarne alcuni, raggruppandoli secondo la loro forma.<br />
Vi sono quelli in bronzo fuso dorato, con le guglie che fanno pensare<br />
alle grandi Cattedrali del Medioevo francese e tedesco. Il più grande,<br />
dalle dimensioni di cm 40 x 25 x 65, che richiama la facciata della<br />
Cattedrale di Chartres, racchiude un frammento della Culla di Betlemme,<br />
ed altre Reliquie.Un cofanetto a guglie contiene le Reliquie di<br />
S. Francesco d’Assisi e di numerosi Santi Francescani. Un tempietto
Ceri votivi.
Icona<br />
da viaggio.<br />
Statua<br />
lignea<br />
policroma.<br />
Fine ’500<br />
inizio ’600.<br />
Sacra Famiglia.<br />
Donazione dei fratelli Giuseppe e Ottavio Gallo (2003).
Reliquiari.
Donazione dei<br />
fratelli Giuseppe<br />
e Ottavio Gallo<br />
(2003).<br />
Croce<br />
in bronzo smaltato<br />
con acquasantiera<br />
cm 48 x 28.<br />
Croce in legno<br />
lavorato con fregi<br />
barocchi cm 54 x 34,<br />
con Cristo in legno<br />
laccato.<br />
Crocifisso in legno<br />
con stucco colorato<br />
cm 70 x 60,<br />
romanico.<br />
Crocifisso in avorio<br />
cm 8 x 14<br />
adagiato su velluto<br />
con cornice dorata<br />
barocca.<br />
Croce<br />
in bronzo smaltato<br />
e Acquasantiera<br />
su sfondo in onice<br />
cm 43 x 26.<br />
Crocifisso in avorio<br />
su croce in onice con<br />
bordo e<br />
Acquasantiera<br />
in bronzo smaltato<br />
cm 38 x 24.<br />
Croce di legno di<br />
noce massiccio<br />
cm 95 x 50 con Cristo<br />
in legno e stucco<br />
colorato barocco.<br />
Crocifisso<br />
in legno chiaro<br />
cm 28 privo<br />
di braccia in stile<br />
barocco.<br />
Crocifisso in legno<br />
laccato cm 14 privo<br />
di braccia e monco<br />
negli arti inferiori.
gotico porta le Reliquie di S. Flaviano, Monaco eletto nel 498 Patriarca<br />
di Antiochia. Due piccole guglie con le Reliquie di S. Aude e di S.<br />
Regina, entrambe Vergini e Martiri. Due bellissimi ostensori, in stile<br />
gotico, con le Reliquie di S. Urbano, S. Francesco Regis, S. Fausto, S.ta<br />
Cristina e di altri Santi.<br />
Quattro Reliquiari in bronzo fuso, a forma di ostensori di stile barocco,<br />
racchiudono Reliquie di vari Santi, tra i quali S.ta Clara, S.ta Irene,<br />
S.ta Barbara, S. Pietro, S. Paolo, S. Marcello, S. Clemente, S. Ignazio di<br />
Lojola, S. Francesco Saverio, ed altri. Un massiccio Reliquiario in bronzo<br />
fuso dorato racchiude le Reliquie del B. Francesco-Regis Clet della<br />
Congregazione della Missione, martirizzato in Cina il 17 febbraio 1820,<br />
proclamato Beato da Leone XIII il 27 maggio 1900, e Santo da Giovanni<br />
Paolo II, con tutti i Martiri Cinesi, il 1° ottobre 2000.<br />
Numerosi sono poi i Reliquiari a forma di croce, in bronzo fuso dorato<br />
e variamente lavorati, contenenti frammenti della Santa Croce. Caratteristico<br />
quello che nei bracci della croce riporta, quasi in traforo, gli<br />
strumenti della Passione di Gesù.<br />
Diversi Reliquiari sono a forma di quadrifondi in legno pregiato, riccamente<br />
ornati, con le Reliquie di Santi eccellenti. Quello contenente<br />
le Reliquie di S. Luigi Gonzaga è stato trasferito da un Reliquiario<br />
del 1760, di forma ovale, nell’attuale di forma quadrata nel 1896; proviene<br />
dal Monastero della Visitazione di Saint-Étienne. Originale quello<br />
in bronzo fuso dorato a forma di croce gigliata contenente la Reliquia<br />
di Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes. Prezioso<br />
è quello con le Reliquie di S. Francesco di Sales e di altri Santi, tra i<br />
quali S.ta Margherita Maria Alacoque, dotato di autentica vescovile del<br />
1890. Come pure quello con le Reliquie di S. Francesco di Assisi attorniato<br />
da quelle di altri Santi, e quello a forma di croce con fregi e<br />
pietre dure, contenente la Reliquia di S. Giuliano martire e di S. Esuperio<br />
vescovo di Toulouse, lodato da S. Girolamo per la sua carità<br />
“che non ha confini”.<br />
Merita una menzione particolare il prezioso Reliquiario, a quadrofondo<br />
su velluto rosso in cornice di legno dorato, contenente Reliquie di<br />
diversi Santi, tra i quali S. Pietro, S. Giuseppe Labre, S.ta Caterina, ecc.<br />
Porta la seguente autentica: «Questo Reliquiario è stato donato al Rev.<br />
Padre Languet, prete dell’Oratorio di Digione, da M. de Renty; è stato<br />
composto delle medesime Reliquie avute dalle casse di diverse chiese<br />
119
120<br />
per fare il grande Reliquiario della Regina Anna d’Austria, incinta di Luigi<br />
XIV nel 1638».<br />
All’inizio del mese di giugno 2004 abbiamo avuto la gradita visita<br />
dei fratelli Don Giuseppe e Don Ottavio Gallo, giunti in devoto<br />
pellegrinaggio al Santuario di Maria Ausiliatrice. Con l’occasione<br />
hanno visitato, ancora una volta, il Museo Mariano arricchito della<br />
loro generosa donazione e sono stati molto soddisfatti della sistemazione<br />
data alle loro Icone antiche Greche e Russe, ai Reliquiari in<br />
bronzo dorato ed ai Crocifissi in avorio. Il loro dono è valorizzato e<br />
degnamente esposto all’ammirazione dei visitatori. Questo li ha convinti<br />
per una nuova donazione di oggetti preziosi a completamento<br />
della prima.<br />
• Placca in rame, che potrebbe essere la copertina di un Evangeliario<br />
antico; richiama i tipi dell’arte Longobarda. Rappresenta, su due fasce,<br />
i dodici Apostoli, al centro l’Agnello, ai lati i simboli dei quattro Evangelisti,<br />
e i simboli dell’eternità e dell’infinito. È un raro gioiello del secolo<br />
VIII.<br />
• Ovale con Crocifisso in avorio puro. Intatto e molto prezioso; alla<br />
estremità del perizoma porta due R con una crocetta, firma dell’autore,<br />
scultore tedesco del ’600. Dolce l’espressione del volto e finissimi<br />
i lineamenti del corpo.<br />
• Quadretto con Pio IX. Miniatura finissima su carta da lettera resistente,<br />
in una cornice dorata del ’800; proviene dall’Umbria o dalla bassa<br />
Toscana.<br />
• 11 Tele di Nicola Grassi (1682-1748), pittore della Carnia, nato a Formeaso<br />
di Zuglio UD, che dal 1712 lavora in prevalenza nelle Chiese<br />
di Venezia, esercitando una notevole influenza sugli artisti friulani. Le<br />
Tele ritraggono la Madonna, S. Giuseppe, S. Giacomo, S. Simone, S. Bartolomeo,<br />
S. Girolamo, un Prelato, l’Autoritratto.<br />
• Pastorale del ’700, in argento, di stile gotico finemente cesellato,<br />
con figure sbalzate di draghi, nella parte terminale ricurva, ed al centro<br />
la statua della Madonna con Bambino. Richiama la pagina dell’Apocalisse<br />
che descrive la lotta e la vittoria della Donna e del suo Figlio<br />
sul dragone infernale alato.<br />
• 2 Cavalletti-Leggii in legno noce del ’700. Interessanti la praticità,<br />
la funzionalità e l’ingegnosità dell’artista.
Donazione dei<br />
fratelli Giuseppe<br />
e Ottavio Gallo<br />
(2003).
Dipinti di Nicola Grassi.
• Cristo alla colonna: bozzetto su tela incollata a tavola di legno, di<br />
Maria Robusti, detta Marietta (1560 - 1590), figlia ed allieva del padre<br />
Jacopo, il Tintoretto. Celebre ritrattista del suo tempo, aiutante ed imitatrice<br />
del padre fino a raggiungerne la perfezione tecnica, Marietta<br />
lascia opere a Venezia ed a Firenze. Il bozzetto rappresenta il Cristo flagellato<br />
alla colonna, secondo l’iconografia tradizionale, con delicata<br />
espressione del dolore; sullo sfondo è ritratto il palazzo dei Tintoretto.<br />
• Presentazione di Maria Bambina al Tempio: quadro ad olio su tela,<br />
in massiccia cornice barocca, rappresentante Maria Bambina condotta<br />
al Tempio e affidata al Gran Sacerdote dai genitori Gioacchino ed<br />
Anna, di Laurent de la Hire (o Hyre), nato a Parigi nel 1606 e morto nel<br />
1656, autore di numerose tavole a soggetto religioso, per diverse Chiese<br />
di Parigi. Una Vergine con Bambino (1642) si trova al Louvre. Il nostro<br />
quadro è probabilmente un bozzetto per una tela di maggiori proporzioni<br />
realizzato nel 1650.<br />
• Madonna in trono con Bambino e Madonna che allatta: due affreschi<br />
(strappo) provenienti da un’antica Abbazia benedettina dell’alta<br />
Lombardia, d’inizio 1400, dai tratti delicati ed affascinanti.<br />
• Madonna con in braccio il Bambino benedicente che regge il mondo:<br />
statua in legno policromo e dorato, alta cm 53, di autore borgognone<br />
del 1600, dai lineamenti delicati ed espressivi.<br />
• Madonna con Cristo morto (Pietà): statua in legno chiaro di ulivo,<br />
alta cm 38, di scultore ignoto lombardo del 1600.<br />
• 4 Statue in legno scuro, alte cm 50, di autore borgognone (forse<br />
Simon de Montfort) di fine 1700, rappresentanti il Redentore (Sacro<br />
Cuore), San Francesco di Assisi, Santa Teresa d’Avila e San Giovanni<br />
Evangelista.<br />
Nicola Grassi ritrattista<br />
Il Centro di Documentazione Storica e Popolare Mariana ha la<br />
grande gioia di partecipare alla Mostra su NICOLA GRASSI RITRATTI-<br />
STA, allestita a Tolmezzo dal Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari<br />
“Luigi e Michele Gortani” dal 23 settembre al 27 novembre<br />
2005, con il ritratto del Cardinale Daniele Dolfin, donato al Centro<br />
dai fratelli Don Giuseppe ed Ottavio Gallo.<br />
123
124<br />
Il pieghevole illustrativo della Mostra, curato da Enrico Lucchese<br />
e Marialisa Valoppi Basso, descrive le caratteristiche del pittore Nicola<br />
Grassi e gli scopi della Mostra con queste parole:<br />
«L’immagine che oggi abbiamo di Nicola Grassi (Formeaso di Zuglio,<br />
1682 - Venezia, 1748) è, dopo ottant’anni di studi e due mostre<br />
monografiche all’attivo, quella di un pittore impegnato prevalentemente<br />
nell’arte sacra. In realtà, Nicola era conosciuto dai suoi contemporanei<br />
soprattutto quale specialista affermato nel genere ritrattistico,<br />
com’è provato dalle lusinghiere parole di Anton Maria Zanetti (“pittore<br />
valente nei ritratti”) e di Luigi Lanzi (“competitore della Rosalba”)».<br />
Scopo della Mostra<br />
«Scopo di questa esposizione è quindi presentare al pubblico sette<br />
degli undici ritratti che la critica in varia misura attribuisce a Nicola Grassi,<br />
maestro del Settecento veneto, raccolti per la prima volta assieme,<br />
in una sala di palazzo Campeis, sede del Museo Carnico “Luigi e Michele<br />
Gortani”.<br />
Provenienti dalla nostra regione, ma pure da Venezia e da Torino,<br />
le sette tele proposte una vicina all’altra, inquadrano l’intera attività di<br />
Grassi, dagli esordi di marca ancora tardo barocca alla tavolozza dell’ultima<br />
fase creativa, ricca di spumosità e leggerezze rococò.<br />
Dal vecchio, ma ancora arzillo procuratore di San Marco, all’ultimo<br />
patriarca di Aquileia con in mano l’agognata berretta cardinalizia,<br />
dal volto rubizzo dell’imprenditore tessile al culmine del successo personale,<br />
a quello scavato dalla fatica della contadina di Ampezzo, nobili<br />
borghesi e popolani si allineano in una galleria unica di effigi, capace<br />
di ritrarre con realismo e qualità pittorica una società, le sue regole<br />
e le sue ambizioni».<br />
Opere esposte:<br />
1. Ritratto di Federico Marcello. Venezia, Gallerie dell’Accademia<br />
2. Ritratto di Alessandro Pandolfo. Venezia, I. R. E.<br />
3. Ritratto di vecchio. Udine, Civici Musei<br />
4. Ritratto di sacerdote. Trieste, Civici Musei di storia ed arte<br />
5. Addolorata e devota. Ampezzo, Parrocchiale<br />
6. Ritratto di Jacopo Linussio. Tolmezzo, Museo carnico<br />
7. Ritratto del cardinale Daniele Dolfin. Torino, Centro Salesiano di<br />
Documentazione Storica e Popolare Mariana.
È per il Centro Salesiano un grande onore poter contribuire a questa<br />
importante Mostra, grazie alla generosità dei fratelli Don Giuseppe<br />
ed Ottavio Gallo, Salesiani, cultori di arte, studiosi ed ammiratori<br />
di Nicola Grassi.<br />
Il Museo di Devozione mariana è orgoglioso per il dono e riconoscente<br />
per la generosità dimostrata dai fratelli Don Giuseppe e Don<br />
Ottavio Gallo e si impegna a valorizzare al massimo tanto prezioso<br />
materiale che è già stato diligentemente inventariato, catalogato ed<br />
esposto convenientemente all’ammirazione dei visitatori. Maria Ausiliatrice,<br />
alla quale per prima è rivolto il dono, non mancherà di gradire<br />
l’omaggio dei fratelli Gallo e di ricompensarli con le sue abbondanti<br />
benedizioni.<br />
Don Giuseppe Gallo è mancato il 13 febbraio 2005. Don Ottavio<br />
Gallo è mancato il 14 marzo 2006 nella Residenza Salesiana di<br />
Tolone.<br />
125
INDICE<br />
Centro Salesiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
di Documentazione Storica e Popolare Mariana . . . . . . pag. 7<br />
Archivio storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19<br />
Biblioteca del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33<br />
Museo della Devozione Mariana . . . . . . . . . . . . . . pag. 65
A cura del Centro Salesiano “Maria Ausiliatrice”<br />
Testo di Mario Morra<br />
Foto di: Franco e Ilda Nani, Teofilo Molaro, Mario Notario, Natale Maffioli<br />
Impaginazione di Guido Bombarda<br />
Stampa: SGS Torino - 2007