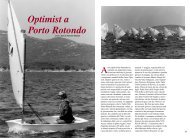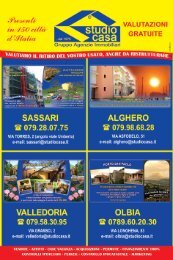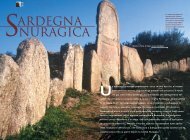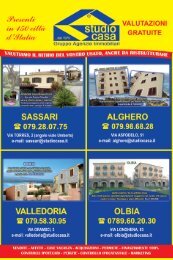Impaginato RIVISTA n 20 DEF - Sardegna
Impaginato RIVISTA n 20 DEF - Sardegna
Impaginato RIVISTA n 20 DEF - Sardegna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
provincia<br />
OR<br />
ORISTANO<br />
LEGENDA LEGENDE LEGEND<br />
LA PROVINCIA DI ORISTANO<br />
superficie 303.999 ettari, comuni 88, abitanti 167.971<br />
Presidente Pasquale Onida<br />
sede: Via Carboni - 09170 Oristano tel. 0783 7931<br />
Abbasanta<br />
Aidomaggiore<br />
Albagiara<br />
Ales<br />
Allai<br />
Arborea<br />
Ardauli<br />
Assolo<br />
Asuni<br />
Baradili<br />
Baratili San Pietro<br />
Baressa<br />
Bauladu<br />
Bidonì<br />
Bonarcado<br />
Boroneddu<br />
Bosa<br />
Busachi<br />
Cabras<br />
Cuglieri<br />
Curcuris<br />
Flussio<br />
Fordongianus<br />
Genoni<br />
Ghilarza<br />
Gonnoscodina<br />
Gonnosnò<br />
Gonnostramatza<br />
Laconi<br />
Magomadas<br />
Marrubiu<br />
Masullas<br />
Milis<br />
Modolo<br />
Mogorella<br />
Mogoro<br />
Montresta<br />
Morgongiori<br />
Narbolia<br />
Neoneli<br />
Norbello<br />
Nughedu S. Vittoria<br />
Nurachi<br />
Nureci<br />
Ollastra<br />
Oristano<br />
Palmas Arborea<br />
Pau<br />
Paulilatino<br />
Pompu<br />
Riola Sardo<br />
Ruinas<br />
S. Nicolò Arcidano<br />
Sagama<br />
Samugheo<br />
San Vero Milis<br />
Santa Giusta<br />
Santulussurgiu<br />
Scano Montiferro<br />
Sedilo<br />
Seneghe<br />
Senis<br />
Sennariolo<br />
Siamaggiore<br />
Siamanna<br />
Siapiccia<br />
Simala<br />
Simaxis<br />
Sini<br />
Siris<br />
Soddì<br />
Solarussa<br />
Sorradile<br />
Suni<br />
Tadasuni<br />
Terralba<br />
Tinnura<br />
Tramatza<br />
Tresnuraghes<br />
Ula Tirso<br />
Uras<br />
Usellus<br />
Villa S. Antonio<br />
Villanova Truschedu<br />
Villaurbana<br />
Villaverde<br />
Zeddiani<br />
Zerfaliu<br />
superstrada, con uscita Schnellstraße, mit<br />
Ausfahrt motorway, with exit<br />
strada a percorrenza veloce, senza spartitraffico<br />
Einbahnige Schnellstraße rapid way<br />
strada statale Bundesstraße<br />
hightway<br />
strada asfaltata Asphaltierte Straße<br />
paved road<br />
strada non asfaltata Nicht asphaltierte Straße<br />
unpaved road<br />
distanze chilometriche Entfemungen in<br />
Kilometer<br />
distances in km<br />
traghetto Fähre<br />
ferry-boat<br />
linea di navigazione Schiffahrtslinie<br />
motorship-line<br />
faro, fanale Leuchtturm, feuer<br />
lighthouse, beacon<br />
porto Hafen<br />
port<br />
ferrovia, con stazione Einsenbahn, mit Bahnohof<br />
railway, with station<br />
aeroporto Flughafen<br />
airport<br />
campeggio Zeltplatz<br />
camping<br />
rifugio montano Berghütte<br />
mountain hotel<br />
nuraghe nuraghe<br />
nuraghe<br />
zona archeologica Ausgrabungsstätte<br />
archeological excavation<br />
torre Turn<br />
tower<br />
rocca Schloß, Burg<br />
castel, fortress<br />
Abbazia Abtei<br />
abbey<br />
grotta Höhle<br />
cavern<br />
spiaggia attrezzata Bewachter<br />
strand guarded beach<br />
confine di provincia<br />
Provinzgrenze<br />
provincial boundary<br />
acque Gewässer<br />
waters<br />
monte Berg mount<br />
altitudine Höhe<br />
spot elevation<br />
bosco Wald<br />
wood<br />
parco naturale Naturpark<br />
natural park<br />
© Copyright Mare nostrum editrice. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata dalla legge. Nessuna parte di questa cartina può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dell’editore.<br />
87
I T I N E R A R I<br />
nenti colate laviche. Le caratteristiche del terreno,<br />
una sorta di immenso anfiteatro naturale, hanno<br />
determinato l’ubicazione delle costruzioni facendo si<br />
che la pianta dell’antico abitato risulti estremamente<br />
articolata, al punto che non è difficile perdersi fra i<br />
suoi meandri. La nascita dell’insediamento pare<br />
databile successivamente all’anno mille quando un<br />
primo nucleo si stabilì nella parte orientale della<br />
conca, a breve distanza da dove sorge la chiesa più<br />
antica dell’abitato, San Lussorio, consacrata nel 1185<br />
ed oggi chiamata Santa Croce.<br />
Per comprendere ciò che sono e sono stati i lussurgesi<br />
è utile visitare il Museo della Tecnologia<br />
Contadina, nato nel 1976 dalla caparbia volontà di<br />
Francesco Salis, recentemente scomparso e mai<br />
abbastanza compianto. “Su mastru”, così veniva<br />
chiamato e come tale era stimato, considerava la raccolta<br />
di oggetti e strumenti di lavoro d’uso quotidiano,<br />
come punto di ancoraggio per una comunità caratterizzata da un’identità dinamica, poco incline alla<br />
nostalgia e capace di misurarsi con le sfide della contemporaneità. Il museo è situato presso i locali<br />
dell’U.N.L.A., centro di Cultura Popolare, in una casa padronale del XVIII secolo, “sa 'omo de donna Rofella”,<br />
e conta ben 23 ambienti nei quali sono esposti e catalogati oltre duemila oggetti e strumenti, testimoni concreti<br />
di vicende ormai lontane nel tempo. Gli artigiani lussurgesi sono stati indispensabile<br />
supporto all’evoluzione del modello economico negli ultimi due secoli, segnata<br />
dallo sviluppo di attività agro-industriali favorite dalla presenza di torrenti la cui forza<br />
era sfruttata con mulini ad acqua costruiti in serie. Parallelamente si ebbe un significativo<br />
incremento nelle attività legate all’agricoltura ed all’allevamento di ovini e bovini.<br />
La misura dello sviluppo economico e sociale in quel periodo è data dal numero di abitanti<br />
che raggiunse le seimila unità e dalla presenza di una scuola fin dalla metà dell'ottocento.<br />
La scuola fu seguita in un primo momento dagli Scolopi e quindi dai<br />
Salesiani e formò personaggi che ebbero importanti incarichi nelle istituzioni sarde. In<br />
questa scuola, dal 1905 al 1908 Antonio Gramsci frequentò il ginnasio.<br />
Anche se l’attività dei mulini e delle gualchiere è cessata da tempo, le macchine agricole hanno soppiantato i<br />
buoi nel lavoro dei campi e per gli spostamenti si usa l’automobile e non più l’asino o il cavallo, alcune attività<br />
artigianali, grazie all’eccellenza dei loro prodotti, sono riuscite nel difficile intento non solo di sopravvivere<br />
ma anche di affermarsi su mercati più ampi come quello regionale e nazionale.<br />
Se per spostarsi l’automobile è certamente la più usata, a Santu Lussurgiu la cultura del cavallo è rimasta<br />
comunque immutata e vitale, le feste importanti sono tutte segnate dalla presenza di cavalli e arditi cavalieri;<br />
nella frazione di San Leonardo de Siete Fuentes si svolge la più importante mostra mercato del cavallo a livello<br />
regionale. Gli artigiani producono ai massimi livelli tutto ciò che è legato alle attività equestri, morsi, speroni,<br />
staffe, selle, briglie e finimenti, stivali in cuoio e pantaloni in velluto. In passato alcuni fabbri lussurgesi,<br />
nei momenti liberi dall’attività di costruzione e manutenzione di strumenti e utensili di uso domestico o lega-<br />
Testo e foto di Giampiero Dore<br />
SANTU<br />
LUSSURGIU<br />
C<br />
amminando per le vie strette e tortuose del borgo antico, può capitare di sentirsi catapultati<br />
in un'altra epoca, di dimenticare il presente e vivere una dimensione di sogno.<br />
Santu Lussurgiu ha infatti conservato integre identità ed unicità, potendo vantare uno dei<br />
centri storici meglio mantenuti della <strong>Sardegna</strong>. Lungo i vicoli pavimentati con l’acciottolato<br />
originale si affacciano belle case dai muri di pietra a vista o intonacate e dipinte<br />
a vivaci colori, come nell’uso antico, con stipiti ed architravi in pietra lavorata e portali<br />
ornati da batacchi e maniglie di varia forma, opera degli artigiani lussurgesi. Di tanto in<br />
tanto si aprono degli archi, “sas bovedas”, che mettono in comunicazione fra loro i vicoli.<br />
Adagiato sul versante sud orientale del massiccio del Montiferru a 500 metri di altitudine, il<br />
paese si è accresciuto nel tempo seguendo quelli che sono i contorni della fusione fra due impo-<br />
Di tanto in tanto si aprono<br />
degli archi, “sas bovedas”,<br />
che mettono in comunicazione<br />
fra loro i vicoli.<br />
Lungo i vicoli pavimentati<br />
con l’acciottolato<br />
originale si affacciano<br />
belle case dai muri di<br />
pietra a vista o intonacate<br />
e dipinte a vivaci<br />
colori, come nell’uso<br />
antico, con stipiti ed<br />
architravi in pietra<br />
lavorata e portali ornati<br />
da batacchi e maniglie<br />
di varia forma, opera<br />
degli artigiani lussurgesi.<br />
88 89
I t i n e r a r i<br />
ti alle attività agricole e di allevamento, si dedicavano alla costruzione dei coltelli. La tradizione è ancora viva<br />
ed oggi, grazie a due aziende artigiane (F.lli Salaris e F.lli Mura), la resolza lussurgesa è famosa nel mondo del<br />
collezionismo a livello mondiale. Altri prodotti caratteristici che prendevano forma nelle botteghe dei fabbri<br />
erano i macinini per caffè, dei quali rimangono numerosi esemplari di squisita fattura e con soluzioni costruttive<br />
di grande ingegno, ed ancora serrature per i portali delle abitazioni ed “antifurto” per i cavalli, sorta di<br />
lucchetti uniti da uno spezzone di catena che venivano serrati sui garretti.<br />
Anche nella lavorazione del legno ed in particolare<br />
nella costruzione delle cassapanche i falegnami lussurgesi<br />
godevano di buona fama in tutta l’isola.<br />
Oltre alle attività artigianali che sopravvivono grazie<br />
alle capacità degli ultimi depositari di un sapere antico,<br />
l’economia lussurgese è basata sull’agricoltura e<br />
l’allevamento di ovini e bovini. Particolare è la razza<br />
Sardo-Modicana (bue rosso), estremamente rustica<br />
ed allevata allo stato brado, con grande attitudine al<br />
lavoro e carni dal gusto inconfondibile (non perdetevi<br />
il filetto di bue rosso in crosta di casizolu del ristorante<br />
Bellavista). Del bue rosso si ha notizia fin dal<br />
1263 quando il templare Nicolao De Borges presso<br />
il convento di San Leonardo de Siete Fuentes, descrive<br />
alcune ricette a base di “bovin rouge”. La Sardo-<br />
Modicana, prima molto diffusa, nasce dall’incrocio<br />
del bue rosso con la modicana arrivata in <strong>Sardegna</strong><br />
nella seconda metà dell’800. Il declino di questa<br />
razza a favore di altre pur meno adatte al territorio, è<br />
imputabile al costante sviluppo dei caseifici industriali<br />
e del relativo incremento nella richiesta di<br />
latte, la sardo-modicana infatti non è grande produttrice.<br />
Per la sua salvaguardia, grazie all’impegno di<br />
alcuni allevatori, nel <strong>20</strong>02 è stato costituito il<br />
Consorzio del Bue Rosso composto da circa 40 allevatori.<br />
La produzione del formaggio segue le più antiche tradizioni<br />
ed è compito quasi esclusivo delle donne.<br />
“Su casizolu”, tipico di Santu Lussurgiu, è un formaggio<br />
a pasta filata prodotto con latte bovino che si può<br />
consumare fresco o dopo lunga stagionatura.<br />
Camminando per le vie del paese ne vedrete appesi<br />
alle finestre delle case. I resti della lavorazione de “su<br />
casizolu”, la cosiddetta “abba casu” è ancora utilizzata<br />
nella preparazione di alcuni piatti tipici.<br />
Mentre la produzione del formaggio è a totale appannaggio<br />
delle donne, quella del vino è un’attività tutta<br />
al maschile. Santu lussurgiu ha ottimi vigneti anche<br />
se gli antichi vitigni sono stati nel tempo rimpiazzati<br />
con altri importati da varie zone della <strong>Sardegna</strong>.<br />
La produzione non è mai particolarmente abbondante<br />
ma in compenso la qualità del vino, soprattutto del<br />
rosso, è di ottimo livello. Derivato di gran nome è il<br />
fil ‘e ferru, nomignolo con il quale viene chiamata<br />
l’acquavite. Quasi tutti i produttori di vino distillano<br />
artigianalmente una certa quantità di acquavite, aromatizzandola<br />
in vari modi.<br />
Come si è detto il cavallo segna con la sua presenza<br />
le feste importanti. L’evento di gran lunga più spettacolare<br />
si svolge negli ultimi tre giorni del carnevale,<br />
domenica, lunedì e martedì. E’ “sa carrela ‘e nanti”<br />
una serie di pariglie mozzafiato lungo la Via Roma,<br />
parata a festa per l’occasione e pavimentata in terra<br />
battuta. Nel primo pomeriggio i cavalli vengono strigliati con cura, code e criniere pettinate e quindi raccolte<br />
in eleganti acconciature. Poco più tardi si inizia a sentire il rumore degli zoccoli sull’acciottolato e nei dintorni<br />
de “s’iscappadrorzu”, il piccolo slargo dal quale i cavalli prendono la discesa, iniziano a radunarsi le<br />
pariglie. I cavalieri sono abbigliati nei modi più diversi, con fantasiose maschere carnevalesche o con il costume<br />
tradizionale. Il pubblico intanto inizia a prender posto lungo il tracciato, “s’istranzos”, ovvero chi non è<br />
del paese, sulle tribune, i lussurgesi ai bordi de “sa carrela”. La tensione<br />
sale e lo starter, figura storica de “sa carrela” tramite l’altoparlante<br />
invita a – liberare la pista, cavalli in partenza – liberare la<br />
pista. In realtà non si capisce a chi l’avviso sia rivolto dal momento<br />
che gli unici ad occupare il tracciato sono i lussurgesi e nessun lussurgese<br />
che si rispetti accetterà mai di “vivere” la corsa dietro una<br />
transenna. Questo non significa che siano imprudenti o temerari,<br />
semplicemente sanno in quali punti il percorso è sicuro e in quali<br />
invece stazionare è semplice suicidio. La voce dello starter sovrasta<br />
il brusio – Partiti, uniti, veloci, disuniti, riuniti –, descrivendo la partenza.<br />
La folla si apre e dal varco esplode il galoppo dei cavalli in<br />
pariglia accompagnato dal clamore degli incitamenti. Subito dopo<br />
il passaggio il muro di gente si richiude e gli sguardi seguono la discesa dei cavalieri fino all’ultima svolta.<br />
Ci sono commenti, apprezzamenti o perplessità. Le pariglie si susseguono senza tregua fino all’annuncio –<br />
cavalli in rientro -. Questo è il momento in cui i lussurgesi si spostano, entrano nelle case che danno sulla via<br />
per l’invito di un bicchiere di vino o un goccio di fil ‘e ferru, per scambiare due chiacchiere in allegria. Cavalli<br />
e cavalieri intanto tornano verso la partenza percorrendo al passo “sa carrela ‘e segusu”, rivivendo la discesa<br />
appena fatta e pensando già alla prossima in un fluire continuo di adrenalina. Le pariglie a due o a tre si ripetono<br />
fino all’imbrunire quando i cavalieri fanno l’ultima<br />
risalita a passo percorrendo la via Roma dal<br />
basso verso l’alto ed accettando gli inviti di un bicchiere<br />
o di un dolcetto che gli vengono offerti lungo<br />
il percorso. Il lunedì c’è la variante della corsa a “sa<br />
pudda”, la gallina. Sullo stesso percorso, all’altezza<br />
della penultima curva, viene teso un cavo sul quale<br />
sono agganciate due galline di pezza che i cavalieri<br />
devono colpire e far cadere per mezzo di lunghi<br />
bastoni, il tutto al galoppo sfrenato. Vince chi totalizza<br />
il maggior numero di galline “abbattute”. E’ una<br />
prova di grande abilità e precisione ma la competizione<br />
non diventa mai lo scopo finale della corsa. Un<br />
tempo al cavo venivano appese delle galline vive che<br />
dopo la corsa erano donate in beneficenza. Questa<br />
tradizione oggi non appare più in linea coi tempi e,<br />
senza nulla togliere alla spettacolarità, si è preferito<br />
la cultura del cavallo è rimasta<br />
comunque immutata e vitale,<br />
le feste importanti sono tutte<br />
segnate dalla presenza di<br />
cavalli e arditi cavalieri<br />
Il feretro con il simulacro<br />
del Cristo deposto<br />
esce da Santa Maria<br />
degli Angeli e percorre<br />
le vie del borgo antico.<br />
Nella pagina accanto:<br />
un evento spettacolare<br />
che ha come protagonista<br />
il cavallo: è’ “sa<br />
carrela ‘e nanti” una<br />
serie di pariglie mozzafiato<br />
lungo la Via<br />
Roma, parata a festa<br />
per l’occasione.<br />
Santu Lussurgiu ha<br />
conservato integre<br />
identità ed unicità,<br />
potendo vantare uno<br />
dei centri storici<br />
meglio mantenuti della<br />
<strong>Sardegna</strong>.<br />
La chiesa di San<br />
Leonardo de Siete<br />
Fuentes<br />
(stile romanico-pisano<br />
del XII secolo).<br />
91
I t i n e r a r i<br />
Verso le vette di monte<br />
Urtigu, monte Acuzzu<br />
e monte Palagalchera<br />
la vegetazione si dirada<br />
progressivamente<br />
lasciando il campo alla<br />
nuda roccia vulcanica.<br />
Dall’alto il paesaggio<br />
che si gode in ogni<br />
direzione è superbo.<br />
un simulacro all’animale vivo. La festa prosegue nelle cantine dove si chiacchiera, si beve del buon vino e si<br />
canta. Già, il canto, altra grande passione dei lussurgesi, tanto dall’aver ideato e promosso il progetto Hymnos.<br />
Progetto ambizioso e lungimirante che si prefigge da una parte lo studio ed il recupero di tradizioni popolari<br />
del canto liturgico e paraliturgico e dall’altra la creazione di un sistema di scambi fra le comunità sarde dove<br />
queste tradizioni sono ancora vive. Il canto proposto anche come veicolo per la valorizzazione delle comunità<br />
coinvolte. A Santu Lussurgiu esistono numerosi gruppi, alcuni dei quali molto antichi: Su Cuncordu<br />
Lussurzesu, Su Cuncordu ‘e su Rosariu, Sette Dolores, Santa Rughe e Don Bosco.<br />
Di particolare suggestione è la manifestazione “Cantigos in carrela” che si svolge a ridosso della corsa di “sa<br />
carrela”. I vari gruppi di canto lussurgesi o invitati da altri paesi animano le vie e gli slarghi del centro storico<br />
con canti della tradizione. Ultimamente la manifestazione ospita anche gruppi esteri, legati comunque alla<br />
musica tradizionale. L’usanza di cantare per le vie, serenate alle fanciulle o in occasione di feste e sagre, era<br />
un tempo molto diffusa in tutta la <strong>Sardegna</strong> e questa manifestazione ha l’obiettivo di vivificare una tradizione<br />
che rischierebbe di perdersi per sempre. Dopo gli eccessi del Carnevale inizia la Quaresima, 46 giorni di penitenza<br />
e astinenza prima della Pasqua di Resurrezione. Con la Domenica delle Palme che ricorda l’ingresso di<br />
Cristo in Gerusalemme ha inizio la Settimana Santa. A Santu Lussurgiu è di particolare importanza il Venerdì<br />
Santo che con il rito de “s’incravamentu” (la crocefissione) e de “s’iscravamentu” (la deposizione) commemora<br />
la passione e morte del Cristo. La processione, organizzata da secoli dalla Confraternita del Santo Rosario,<br />
esce dalla chiesa di Santa Croce e percorrendo i vicoli accompagnata dal canto struggente del Misere giunge<br />
a Santa Maria degli Angeli, una bella chiesa in stile gotico-aragonese edificata nel 1473 dai Frati Minori<br />
Osservanti. Dopo la sacra rappresentazione il feretro con il simulacro del Cristo deposto esce da Santa Maria<br />
degli Angeli e percorre le vie del borgo antico accompagnato dalle confraternite, dai fedeli raccolti in preghiera<br />
e dai cori che risuonano nel buio della sera creando una grande suggestione.<br />
Nel mese di giugno si svolge la festa di San Leonardo de Siete Fuentes, oggi frazione di Santu Lussurgiu, che<br />
ebbe la gestione di quel territorio durante il governo Piemontese. I festeggiamenti si svolgono attorno alla chiesa<br />
(stile romanico-pisano del XII secolo), fra fonti di acqua ghiacciata e pura ed alberi secolari. All’atto della<br />
sua edificazione la chiesa faceva parte del monastero e dell’ospedale dei monaci ospedalieri dell’Ordine di<br />
San Giovanni di Gerusalemme che vi operarono fino al XVI secolo. Successivamente i monaci vennero privati<br />
di beni e terre fino ad arrivare alla chiusura dell’ospedale. L’area subì un progressivo impoverimento, tanto<br />
che gli abitanti abbandonarono il borgo scegliendo di trasferirsi per la maggioranza a Santu Lussurgiu.<br />
Altre feste che vedono il cavallo in primo piano sono l’ardia de “Su Coro ‘e Zesus” (il cuore di Gesù), fra la fine<br />
di giugno e gli inizi di luglio e l’Ardia di San Lussorio che apre i festeggiamenti del patrono dal 21 al 24 agosto.<br />
Il Territorio<br />
Il comune di Santu Lussurgiu si estende su una superficie di circa 10.000 ettari, fra collina e montagna. Le<br />
zone pianeggianti sono davvero poche. Sul territorio esistono numerose testimonianze della presenza umana<br />
fin dal neolitico. Esistono varie sepolture a “Domus”, fra le altre “bau 'e nughes”, “mandra 'e caddos”, “badde<br />
urgu”, alcune Tombe dei Giganti e due importanti nuraghe, “elighe onna” e “piricu”, il primo di tipo complesso<br />
con un mastio centrale e due torri laterali unite da un murale, il secondo del tipo monotorre su due piani.<br />
Questo quanto meno è ciò che è censito ma si sa dell’esistenza di numerosi altri siti mai indagati.<br />
I rilievi alle spalle dell’abitato sono raggiungibili<br />
anche con l’automobile su sterrati o fondi in cemento<br />
ma il modo migliore per godere delle mille bellezze<br />
che questa zona del Montiferru sa offrire è certamente<br />
quella del trekking a piedi o a cavallo.<br />
Esistono varie strutture in grado di offrire servizi e<br />
logistica di ottimo livello, la più accreditata è il<br />
Centro Trekking <strong>Sardegna</strong> che opera sul territorio dal<br />
1989 ed ha sperimentato negli anni una serie di itinerari<br />
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.<br />
Tutta l’area è ricca di sorgenti, “s’ena ‘e alinu”, “sa<br />
funtana ‘e sos grabalzos”,”elighes uttiosos”, ruscelli,<br />
laghetti, “su foiu de tiu Panne Dente”, torrenti “su riu<br />
‘e sos molinos” che marca il confine fra il territorio di<br />
Santu Lussurgiu e di Bonarcado e cascate, alcune<br />
delle quali davvero molto belle come “s’istrampu ‘e<br />
sos molinos” e “bia ‘e iosso”. Nella parte più elevata,<br />
il paese è praticamente attorniato dai boschi mentre<br />
verso valle predominano gli oliveti intervallati da<br />
vigne e coltivi. Man mano che si sale verso le cime<br />
la vegetazione cambia in un susseguirsi di lecci,<br />
roverelle, castagni, aree con una fitta macchia predominata<br />
da corbezzolo, cisto, mirto ed erica, e felce<br />
aquilina, esiti dei rovinosi incendi che hanno devastato<br />
intere porzioni di bosco. Su alcune di queste<br />
aree è in atto un tentativo di riforestazione.<br />
Durante l’autunno si può godere dello spettacolo<br />
degli agrifogli che si ricoprono di bacche scarlatte,<br />
dei corbezzoli carichi di frutti nelle varie fasi di<br />
maturazione e delle sfumature rosso bruno delle bacche<br />
di rosa selvatica. Non mancano, e segnalano la<br />
loro presenza colpendo l’olfatto, le essenze come il<br />
timo. Più in alto, verso le vette di monte Urtigu,<br />
monte Acuzzu e monte Palagalchera la vegetazione si<br />
dirada progressivamente lasciando il campo alla<br />
nuda roccia vulcanica. Dall’alto il paesaggio che si<br />
gode in ogni direzione è superbo. Fino ai primi del<br />
‘900 l’area era diffusamente popolata dal muflone e<br />
dal cervo sardo poi scomparsi a causa degli incendi<br />
e della caccia, al tempo ancora consentita.<br />
Queste due specie sono state di recente reintrodotte.<br />
Oggi vedere i mufloni è piuttosto frequente, mentre<br />
per i cervi occorre avere un po’ di fortuna. Altra specie<br />
reintrodotta nel Montiferru è il grifone, anch’esso<br />
una volta volatore abituale di quei cieli. Oltre al cinghiale<br />
che può dirsi padrone incontrastato delle forre,<br />
sopravvivono ancora rari esemplari di gatto selvatico<br />
e di lepre sarda, volpi e donnole. Padroni del cielo<br />
sono poiane e corvi imperiali che si esibiscono in<br />
improvvise acrobazie. Frequenti sono anche le ghiandaie<br />
con il loro piumaggio variopinto e le pernici<br />
sarde. Una natura ancora in buona parte integra e<br />
che regala grandi emozioni.<br />
Santu Lussurigiu è come un vino prezioso, va assaporato<br />
con tutta calma e merita ogni attenzione.<br />
Provare per credere.<br />
Dall’alto:<br />
tutta l’area è ricca di<br />
sorgenti e cascate,<br />
alcune delle quali davvero<br />
molto belle come<br />
“s’istrampu ‘e sos<br />
molinos” e “bia ‘e<br />
iosso” (nell’immagine).<br />
Uno scorcio del paesaggio<br />
che si gode nei<br />
pressi della fonte di<br />
“elighes uttiosos”.<br />
92<br />
93
LA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS<br />
provincia<br />
CI<br />
superficie 149.495 ettari, comuni 23, abitanti 131.890<br />
Presidente Pierfranco Gaviano<br />
sede provvisoria: Via Fertilia, 40 - 09013 Carbonia tel. 0781 66951-2 fax 0781 670821<br />
CARBONIA-IGLESIAS<br />
Bugerru<br />
Calasetta<br />
Carbonia<br />
Carloforte<br />
Domusnovas<br />
Fluminimaggiore<br />
Giba<br />
Gonnesa<br />
Iglesias<br />
Masainas<br />
Musei<br />
Narcao<br />
Nuxis<br />
Perdaxius<br />
Piscinas<br />
Portoscuso<br />
San Giovanni Suergiu<br />
Santadi<br />
Sant’Anna Arresi<br />
Sant’Antioco<br />
Tratalias<br />
Villamassargia<br />
Villaperuccio<br />
LEGENDA LEGENDE LEGEND<br />
superstrada, con uscita Schnellstraße, mit<br />
Ausfahrt motorway, with exit<br />
strada a percorrenza veloce, senza spartitraffico<br />
Einbahnige Schnellstraße rapid way<br />
strada statale Bundesstraße<br />
hightway<br />
strada asfaltata Asphaltierte Straße<br />
paved road<br />
strada non asfaltata Nicht asphaltierte Straße<br />
unpaved road<br />
distanze chilometriche Entfemungen in<br />
Kilometer<br />
distances in km<br />
traghetto Fähre<br />
ferry-boat<br />
linea di navigazione Schiffahrtslinie<br />
motorship-line<br />
faro, fanale Leuchtturm, feuer<br />
lighthouse, beacon<br />
porto Hafen<br />
port<br />
ferrovia, con stazione Einsenbahn, mit Bahnohof<br />
railway, with station<br />
aeroporto Flughafen<br />
airport<br />
campeggio Zeltplatz<br />
camping<br />
rifugio montano Berghütte<br />
mountain hotel<br />
nuraghe nuraghe<br />
nuraghe<br />
zona archeologica Ausgrabungsstätte<br />
archeological excavation<br />
torre Turn<br />
tower<br />
rocca Schloß, Burg<br />
castel, fortress<br />
Abbazia Abtei<br />
abbey<br />
grotta Höhle<br />
cavern<br />
spiaggia attrezzata Bewachter<br />
strand guarded beach<br />
confine di provincia<br />
Provinzgrenze<br />
provincial boundary<br />
acque Gewässer<br />
waters<br />
monte Berg mount<br />
altitudine Höhe<br />
spot elevation<br />
bosco Wald<br />
wood<br />
parco naturale Naturpark<br />
natural park<br />
© Copyright Mare nostrum editrice. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata dalla legge. Nessuna parte di questa cartina può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dell’editore.<br />
95
UN’OASI SARDA<br />
A<br />
M B I E N T E<br />
Un dirupo nei pressi<br />
della Borrona, che evidenzia<br />
il contrasto tra<br />
la terra ed il mare.<br />
PER ILFALCO DELLA<br />
REGINA<br />
Nido con piccolo e<br />
adulto a custodia della<br />
preziosa covata.<br />
96<br />
Testo e foto di Simone Repetto<br />
C’<br />
è un'unica oasi avifaunistica attivata dalla Lipu in <strong>Sardegna</strong>. E’ quella di Capo<br />
Sandalo, nel territorio occidentale dell’isola di San Pietro. La Lega Italiana<br />
Protezione Uccelli, ha scelto questo particolare areale per dare una casa sicura<br />
e protetta ad una specie di rapace rara e biologicamente sensibile: il falco della<br />
Regina, per la tassonomia Falco eleonorae, in omaggio alla giudicessa sarda<br />
Eleonora d’Arborea, che nel XIV secolo, nella sua “Carta de Logu”, inserì un articolo<br />
in cui si vietava la cattura dei falchi adulti e dei piccoli dai nidi. Questo vispo<br />
e gagliardo falconide, da secoli trova nelle falesie a picco sul mare di San Pietro e<br />
delle altre isole minori dell’arcipelago sulcitano (ma<br />
anche della costa orientale sarda, come negli alti dirupi del<br />
golfo di Orosei), un sito privilegiato per trascorrervi quasi un semestre all’anno,<br />
con l’istinto irrefrenabile di nutrirsi e riprodursi. Per portare a termine questa missione,<br />
ogni anno si prodiga in un dispendio enorme di energie, che si estrinsecano,<br />
per la maggiore, nella lunghissima traversata migratoria che compie<br />
dall’Africa al Mediterraneo e viceversa. Con l’obiettivo di valorizzare adeguatamente<br />
questi spettacolari spostamenti, Birdlife International si è fatta promotrice<br />
di Eurobirdwatch, iniziativa a carattere europeo coinvolgente ventotto paesi continentali,<br />
tra i quali anche l’Italia. Nella circostanza, la Lipu, nella prima settimana<br />
di ottobre, ha focalizzato l’attenzione su quel fenomeno di massa che ogni anno si ripete nelle prime settimane<br />
autunnali: la migrazione di milioni di uccelli, che lasciano le coste europee e mediterranee per svernare<br />
verso zone più miti, in particolare in Africa. Nel grande continente hanno diverse mete, abbracciando larghe<br />
fette del territorio africano, da nord a sud, da est ad ovest. Un appuntamento imperdibile per appassiona-<br />
Il falco della Regina<br />
in perlustrazione<br />
sull’ambiente marino<br />
sottostante.<br />
Il falco della Regina, per la<br />
tassonomia Falco eleonorae<br />
in omaggio alla giudicessa<br />
sarda Eleonora d’Arborea<br />
97
A<br />
M B I E N T E<br />
La costa e l’isolotto<br />
di Cala Vinagra,<br />
limite nord orientale<br />
dell’oasi.<br />
Gabbiani in volo<br />
sul promontorio di<br />
Capo Sandalo.<br />
L’Oasi Lipu di Carloforte.<br />
L’Oasi Lipu dell’isola di San Pietro, comprende un territorio di circa 284 ettari a ovest di Carloforte, delimitato,<br />
sul fronte mare, tra le punte Senoglio e Capodoglio. L’importante area di tutela avifaunistica ed ambientale,<br />
è operativa fin dal 1979, ma è negli anni seguenti che ha preso la forma e la consistenza attuali, con il fondamentale<br />
contributo offerto dalla convenzione tra Lipu ed istituzioni locali (Provincia e Comune), che ne permette<br />
il funzionamento e lo sviluppo, anche in termini di contributi, personale, attrezzature e strutture impiegate.<br />
Col passare degli anni, si è arricchito il patrimonio strutturale ora disponibile, in primis costituito dal centro<br />
visite della piazzola di Capo Sandalo e dal campo base a Cala Fico, capace di ospitare un piccolo numeti<br />
e curiosi, che si sono potuti dilettare con la pratica del birdwatching, cioè l’osservazione dei volatili, mentre<br />
si spostano in stormi e gruppi compatti. Nel caso del falco della Regina, l’arrivederci alle coste nord occidentali<br />
dell’isola di San Pietro avviene in piccoli gruppi, a scaglioni e per tutto ottobre, per cui i nuovi nati e<br />
gli adulti lasciano i dirupi e le falesie a picco, dove in precedenza avevano nidificato, per dirigersi verso il mare<br />
aperto, con rotta meridionale e destinazione finale<br />
L’incerto destino del falco, ubicata nelle coste sud orientali africane, in particolare<br />
nel Madagascar, coprendo oltre 8 mila chilometri.<br />
Per la verità, come ha dimostrato un recente stu-<br />
si decide durante<br />
dio scientifico sull’argomento, i gagliardi rapaci spesso<br />
non si spostano linearmente, ma seguendo dire-<br />
la lunga migrazione<br />
zioni diverse e non complementari, per cui alcuni si<br />
dirigono dalle colonie del mare nostrum verso le<br />
coste atlantiche africane (esistono importanti siti<br />
nidificatori, ad esempio, in Marocco e nella Canarie),<br />
altri verso il Mar Rosso e l’Egitto. Potendo coprire<br />
anche oltre 400 chilometri in poco meno di 3 ore.<br />
Grazie all’ausilio di trasmittenti satellitari e radio<br />
segnalatori, è stato possibile monitorare con precisione<br />
questi fenomeni migratori, anche se resta da<br />
dimostrare l’eventuale influenza di fattori esterni ai<br />
nuovi modelli di spostamento osservati, quali i cambiamenti<br />
climatici ed ambientali in atto a livello planetario.<br />
Più comunemente, sembra che l’orientamento<br />
migratorio sia influenzato dal magnetismo terrestre,<br />
dalla disponibilità di cibo, dai venti predominanti<br />
e dalle correnti in quota. Falco eleonorae, da<br />
secoli ha scelto San Pietro tra i siti mediterranei preferiti<br />
per nidificare, giungendo dall’Africa in primavera,<br />
da aprile. A quel punto, sceglie i punti migliori per<br />
organizzare il nido (spesso ricercando e ritrovando<br />
quello dall’anno precedente) e si dedica alla caccia,<br />
mentre la sua dieta, con l’avanzare dell’estate, passa<br />
da insettivora a carnivora, puntando piccoli uccelli e<br />
passeriformi, ghermendoli in spettacolari agguati e<br />
picchiate ad altissima velocità. A fine agosto si notano<br />
i primi “pulli”, che vanno ad arricchire una popolazione<br />
stimata in un centinaio di coppie. Nelle settimane<br />
successive, essi si preparano ad affrontare l’involo,<br />
dovendo affrontare la prima vera sfida, quella della<br />
vita, per non cadere nelle grinfie di altri predatori o<br />
nello scorrere impetuoso delle prime acque piovane,<br />
che spesso spazzano via intere covate. L’incerto destino<br />
del falco, si decide durante la lunga migrazione,<br />
per tutto il mese di novembre. Il viaggio di ritorno dei<br />
rapaci, anche a Carloforte si incrocia con quello di<br />
altri migratori, che toccano l’isola intraprendendo rotte<br />
per altre destinazioni ed offrendo uno spettacolo inedito<br />
ed accattivante. In proposito, il responsabile dell’oasi<br />
carolina Luciano Durante, insieme a ricercatori<br />
e volontari, hanno segnalato specie quali cicogne nere, nibbio bruno, falco pescatore, pecchiaiolo e airone<br />
rosso. Affiancando la presenza di queste specie non stanziali a quelle autoctone, l’isola può essere considerata<br />
una sorta di piccolo paradiso ornitologico. Nel suo territorio, si trovano anche altri rapaci (quali poiane,<br />
gheppi e falchi pellegrini), gabbiani (il reale ed il raro corso), berte, marangoni dal ciuffo, lo splendido gruccione<br />
e vari passeriformi (tra cui occhiocotto, magnanina, sterpazzolina, passero solitario). Senza considerare<br />
l’altra importante area avifaunistica di San Pietro, racchiusa dalle ex saline di Stato, una zona umida dove sono<br />
di casa i fenicotteri rosa, ma anche aironi, garzette ed altri trampolieri.<br />
Il falco della Regina<br />
ed il faro: un connubio<br />
caratteristico ed inscindibile<br />
dell’Oasi Lipu<br />
di San Pietro.<br />
L’ingresso nel territorio<br />
dell’Oasi Lipu<br />
di San Pietro.<br />
98 99
A<br />
M B I E N T E<br />
Un maturo esemplare<br />
ha individuato<br />
una preda e sta per<br />
lanciarsi in picchiata<br />
per catturarla.<br />
ro di visitatori e ricercatori. Poi c’è la segnaletica, che oltre ai pannelli stradali, esprime numerosi cartelli esplicativi<br />
sulle specie animali e vegetali osservabili, con l’indicazione dei variegati sentieri per l’osservazione naturalistica.<br />
La fruizione dell’Oasi, è disciplinata da un apposito regolamento, che vieta comportamenti atti a<br />
modificare o stravolgere l’assetto biologico e naturale preesistente. Considerata l’importanza europea di questo<br />
sito, dal punto di vista ambientale ed avifaunistico, è stata la stessa Lipu ad inserirlo prioritariamente tra le<br />
aree italiane tutelate dalla Rete Natura <strong>20</strong>00, comprendenti Sic e Zps. Mentre tutta l’isola di San Pietro è stata<br />
classificata sito di importanza comunitaria, per l’Oasi Lipu si è prevista una zona di protezione speciale, dedicata<br />
alla protezione e valorizzazione di quelle specie<br />
di volatili considerate a rischio: falco della Regina,<br />
i gagliardi rapaci spesso non berte, gabbiano corso e marangone dal ciuffo. L’oasi,<br />
oltre a costituire un punto fermo nella lotta contro il<br />
si spostano linearmente, ma bracconaggio ed il saccheggio dei nidi, un tempo<br />
molto in voga tra i cultori di discipline quali la falconeria<br />
ed oggi rigorosamente vietati, funge da elemen-<br />
seguendo direzioni diverse e<br />
to catalizzante per il sociale ed il turismo. Negli anni,<br />
non complementari l’area della Lipu ha conquistato fama e presenze,<br />
attirando turisti ed appassionati provenienti da oltre<br />
<strong>Sardegna</strong> ed Italia, pronti a seguire le visite guidate o<br />
partecipare agli annuali campi di osservazione al<br />
falco della Regina. Non mancano, altresì, gli arrivi di<br />
scienziati e ricercatori, di troupe televisive e fotografi<br />
affermati, per rilevare dati biologici, immortalare<br />
scenari incantevoli e circostanze mozzafiato.<br />
Notevole, è il ruolo che svolge l’oasi nell’educazione<br />
ambientale e nella gestione sostenibile della risorsa<br />
naturalistica, aprendo le sue porte a partire dai<br />
bambini e dalle scuole, primi anelli di una catena<br />
cruciale nell’azione di tutela e corretta fruizione del<br />
territorio.<br />
Tre superbi esemplari<br />
di gabbiano reale,<br />
specie diffusa nell’oasi,<br />
in particolare tra<br />
l’autunno e l’inverno.<br />
100