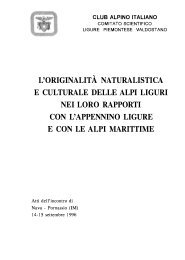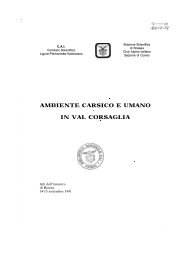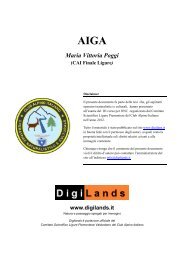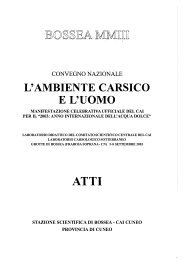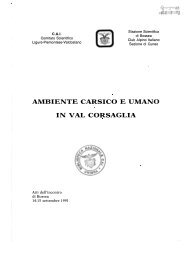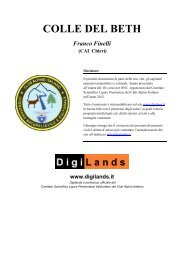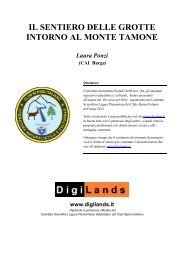AMBIENTE CARSICO E UMANO IN VAL CORSAGLIA - DigiLands
AMBIENTE CARSICO E UMANO IN VAL CORSAGLIA - DigiLands
AMBIENTE CARSICO E UMANO IN VAL CORSAGLIA - DigiLands
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
C.A.I.<br />
Comitato Scientifico<br />
Ligure-Piemontese-Valdostano<br />
Stazione Scientifica<br />
di Bossea<br />
Club Alpino Italiano<br />
Sezione di Cuneo<br />
<strong>AMBIENTE</strong> <strong>CARSICO</strong> E <strong>UMANO</strong><br />
<strong>IN</strong> <strong>VAL</strong> <strong>CORSAGLIA</strong><br />
Atti dell'incontro<br />
di Bossea<br />
14-15 settembre 1991
PIETRO MAIFREDI*<br />
L'ACQUIFERO <strong>CARSICO</strong> DI BOSSEA<br />
E L'IDROGEOLOGIA DELL'AREA<br />
L'alta Val Corsaglia presenta fenomeni carsici di grande<br />
interesse che condizionano tutta la circolazione delle acque<br />
sotterranee dell'area.<br />
Tra Bossea e Colla dei Termini affiorano estesamente terreni<br />
calcarei, e pertanto carsificabili, con caratteristiche diverse,<br />
passando dai calcari quasi puri di età giurassica a quelli<br />
scistosi di età cretaceo-oceanica o ai calcari dolomitici e alle<br />
dolomie di età triassica.<br />
La caratteristica più rimarchevole della nostra area, che<br />
sarà ben osservabile anche sul terreno durante l'escursione,<br />
è però una complessa storia tettonica che ha portato i sedimenti<br />
calcarei, originariamente sedimentatisi sopra ad un substrato<br />
antico di età permo-carbonifera, a trovarsi invece<br />
segmentati in grandi affioramenti separati tra di loro da imponenti<br />
superfici di dislocazione, fratture e faglie, che delimitano<br />
compartimenti idrogeologici indipendenti, talora<br />
interconnessi tra di loro in modo particolarmente complesso.<br />
Il substrato permo-carbonifero, è rappresentato da porfiroidi<br />
praticamente impermeabili, abbastanza deformabili, e<br />
da quarziti che sono invece rocce molto fragili: è facile capire<br />
come, durante i movimenti tettonici che hanno portato all'attuale<br />
disposizione delle formazioni geologiche che costituiscono<br />
la valle, le quarziti, sottoposte a tensioni notevolissime,<br />
invece di deformarsi plasticamente si siano fratturate in modo<br />
evidentissimo e addirittura, lungo i piani più importanti<br />
di scorrimento, si siano formate ampie fasce in cui la roccia<br />
* Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Genova.<br />
1
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
è stata tanto frantumata, cataclasata, da essere paragonabile<br />
agli effetti idrogeologici ad una roccia permeabile.<br />
Vedremo più avanti che questo fenomeno ha una rilevante<br />
importanza nella circolazione delle acque sotterranee di tutta<br />
l'area.<br />
Schematizzando, le grandi faglie, dirette all'incirca da Sud<br />
Est verso Nord Ovest e quasi verticali, che hanno interessato i<br />
la zona, hanno interposto agli affioramenti calcarei grandi masse<br />
di porfiroidi e quarziti che dividono la valle in due aree carsiche<br />
principali.<br />
Quella verso la testata della valle, più meridionale, scende<br />
dalle pendici del M. Mondolé ed è caratterizzata dalla presenza<br />
di un fenomeno carsico di notevolissimo interesse, la<br />
Grotta della Mottera.<br />
Questa grotta, scoperta a 1300 metri di quota nel Vallone<br />
di Sottocrosa, sotto Cima Verzera, esplorata per la prima volta<br />
solo nel 1961, si sviluppa per oltre 8000 metri (con un dislivello<br />
complessivo di 403 metri).<br />
È un esempio classico di come si sviluppa il carsismo nella<br />
nostra zona: la grotta si apre infatti nei calcari giurassici<br />
al contatto con i porfiroidi permiani.<br />
I calcari, all' origine solo fessurati, si sono progressivamente<br />
incarsiti con allargamento delle fessure per dissoluziòne del<br />
carbonato di calcio aggredito dalle acque che s'infiltrano nelle<br />
fessure e che sono per diversi motivi quasi sempre leggermente<br />
acide.<br />
Le acque meteoriche sino dai tempi più remoti, da quando<br />
queste terre sono emerse, si sono infiltrate nelle fessure<br />
della roccia, allargandole e scendendo per gravità sinché non<br />
hanno incontrato un ostacolo impermeabile e non aggredibile<br />
facilmente dall'acqua.<br />
Nel nostro caso questo ostacolo è costituito dagli affioramenti<br />
di porfiroidi, sopra ai quali le acque sotterranee hanno<br />
dovuto accumularsi, saturando dapprima le fratture e poi, nel<br />
punto più basso dell'affioramento, trovando una via di deflusso<br />
verso la superfice.<br />
2
Ambienle Carsico e UI1lCI110 ill Val Corsaglia<br />
Ubicazione dell'area di alimentazione del sistema carsico di Bossea (indicato<br />
con la freccia) e degli altri sistemi carsici delle Alpi Liguri. Le sorgenti<br />
principali sono indicate dai circoli neri.<br />
La circolazione dell' acqua sotterranea si è cosÌ concentrata<br />
lungo una direttrice preferenziale, dove il più rapido ricambio<br />
di acqua ha esasperato lo sviluppo del carsismo dando origine<br />
a condotte ben gerarchizzate che costituiscono la grotta<br />
della Mottera.<br />
Questo reticolo carsico è ancora attivo e pertanto la grotta<br />
è percorsa da un suggestivo corso d'acqua sotterraneo, con<br />
laghi e cascate di rara bellezza.<br />
3
Ambiente Carsico e Umano in Val<br />
.t.<br />
M.FANT<strong>IN</strong>O<br />
• 3<br />
Carta idrostrutturale dei principali sistemi carsici nella zona Monte Mondolè,<br />
Cima Artesinera, Bossea. In bianco sono indicati gli acquiferi carsici,<br />
in puntinato i complessi impermeabili; 2) sorgenti con portata media<br />
50 l/s; 4) inghiottitoi attivi; 5) inghiottitoi<br />
semiattivi; 6) cavità attive; 7) linee di deflusso; 8) collegamenti accertati<br />
con traccianti (Vigna B., 1990).<br />
Più a Nord l'erosione ha profondamente inciso i diversi<br />
affioramenti, compresi quelli calcarei, generando ripidissime<br />
falesie, come quelle che caratterizzano la valle del Rio Sbornina.<br />
Qui i fenomeni di distensione degli ammassi rocciosi, conseguenti<br />
al diminuito carico statico dovuto all'allontanamento<br />
di milioni di tonnellate di roccia asportata dai fenomeni erosivi,<br />
4
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
ha aperto numerose fratture subverticali nelle quali penetra<br />
l'acqua meteorica sviluppando complessi reticoli carsici.<br />
La maggior parte di queste fratture non è direttamente<br />
esplorabile; solo in alcune di esse gli speleologi hanno potuto<br />
mettere piede, ma l'esplorazione di queste "finestre" sulla circolazione<br />
sotterranea è stata particolarmente fruttifera d'informazioni<br />
preziose.<br />
Tra questi punti di accesso ai misteri del carsismo della<br />
zona vi sono l'Abisso Bacardi e l'abisso dell'Artesinera.<br />
Fra i due abissi è stata recentemente accertata l'esistenza<br />
di un collegamento, anche se il primo è sul versante della<br />
Val Corsaglia, o meglio del suo affluente Rio Sbornina, ed il<br />
secondo sul versante della Valle Maudagna.<br />
È un'impressionante serie di pozzi e gallerie che sprofondano<br />
per oltre 450 metri in prossimità di una precipite falesia<br />
calcarea che domina il vallone di Sbornina la cui esistenza pone<br />
in risalto l'importanza della fessurazione nello sviluppo del reticolo<br />
carsico.<br />
Ma ancora più interessante per noi, è l'area carsica che<br />
si estende a nord degli affioramenti impermeabili permiani,<br />
il cui baricentro è proprio nella zona di Bossea.<br />
Qui i fenomeni tettonici sono esasperati: gli sforzi di compressione<br />
a cui sono stati sottoposti questi terreni durante la<br />
genesi della catena alpina (e che hanno sviluppato le grandi<br />
faglie di cui si è parlato prima), hanno originato estese.' linee<br />
di dislocazione in due direzioni principali.<br />
Una delle due direzioni, approssimativamente da Ovest<br />
Nord-Ovest a Est Sud-Est mette in contatto alternanze di porfiroidi<br />
e affioramenti calcarei. L'altra, praticamente perpendicolare<br />
a questa, interrompe e disturba la continuità degli<br />
affioramenti.<br />
Entro un ridotto lembo di calcare, largo in alcuni punti non<br />
più di 250 metri, costituito da scaglie molto fratturate "strizzate"<br />
tra la linea di dislocazione detta linea di Prel, a Nord ,<br />
e la linea di Fontane a Sud, si sviluppa un interessante reticolo<br />
carsico sotto il profilo della circolazione idrica sotterranea ed<br />
una delle maggiori cavità turistiche italiane, la grotta di Bossea.<br />
ì<br />
5
Amhiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
Le falesie calcaree<br />
che precipitano dalla<br />
Cima Artesinera<br />
nel vallone del rio<br />
Sbornina. Qui si<br />
apre l'Abisso Bacardi,<br />
la grotta più profonda<br />
dell'area.<br />
Con i suoi enormi saloni, il suo dislivello di quasi 200 metri,<br />
uno sviluppo che si avvicina ai tre chilometri, percorsa integralmente<br />
da un torrente molto suggestivo e di notevole<br />
portata è anche una grotta di tutto rispetto nel panorama del<br />
carsismo italiano, di particolare interesse per gli studi approfonditi<br />
che si sono sviluppati sull'idrogeologia dell'area.<br />
Prima di addentrarci però nel complesso problema della<br />
circolazione idrica sotterranea dell'area di Bossea, è opportuno<br />
fare mente locale su quali sono le caratteristiche di una<br />
6
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
circolazione carsica e, soprattutto in che cosa questa circolazione<br />
si differenzia da quella che si verifica in una normale<br />
falda in rocce porose, come ad esempio le sabbie.<br />
Abbiamo già visto che nei terreni carsificabili, come i nostri,<br />
sulle fratture generate dai fenomeni tettonici s'imposta<br />
una circolazione che tende ad allargare le fratture e a collegarle<br />
tra di loro.<br />
I<br />
Grotta di Bossea<br />
o a <br />
SO 100m<br />
! !<br />
DCALCAR'oDoLOM'E<br />
A B C D E F PORFIROIDI<br />
Caratteristiche geologiche della cavità di Bossea (Olivero G., Vigna B., 1990).<br />
Vi sono due situazioni particolari che possono coesistere<br />
nello stesso reticolo carsico: una circolazione in condotte ben<br />
drenate, in cui l'acqua circola liberamente e dove il reticolo<br />
si organizza in modo molto simile a quello dell'idrografia di<br />
superficie; una circolazione in zone completamente sommerse<br />
dove ogni fessura viene aggredita dalle acque in modo uniforme<br />
in modo tale da generare condotte a sezione quasi<br />
circolare che si collegano tra di loro con complesse anastomosi<br />
formando labirinti oppure disgregando le zone molto fratturate<br />
che pian piano si svuotano del materiale roccioso dando<br />
origine a giganteschi saloni. Questa situazione di saturazione<br />
7
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
"-<br />
I<br />
'.<br />
t<br />
' :<br />
,I<br />
I<br />
Schema di terreno carsico: la permeabilità è legata sia a fessure molto piccole<br />
(leptoclasi) che a diaclasi e condotti di grandi dimensioni (qui disegnati<br />
molto ampi).<br />
TUIUO POIIOSO<br />
UlUlO <strong>CARSICO</strong><br />
In un terreno poroso omogeneo (per esempio una sabbia) l'acqua filtra lentamente<br />
e qualsiasi pozzo incontra la falda, ad adatta profondità. In un terreno<br />
carsico la velocità di filtrazione è in genere molto maggiore; due pozzi,<br />
anche vicini, incontrano o meno l'acqua a seconda che intercettino o meno<br />
cavità e fratture (Maifredi P., Perna G., 1978).<br />
8
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
può essere perenne, quando la quota del substrato impermeabile<br />
si trova al di sotto del livello di base locale (che è la quota<br />
di sfioro delle sorgenti carsiche, in questo caso), oppure può<br />
essere temporanea, limitata ai periodi di piena.<br />
Un altro fatto notevole è che, a causa della grande quantità<br />
di fessure di notevole dimensione, il ruscellamento superficiale<br />
nelle zone carsiche è normalmente molto ridotto e quasi<br />
tutta l'acqua che non evapora durante una pioggia s'infiltra<br />
nel sottosuolo: questa è un'altra caratteristica peculiare delle<br />
aree carsiche con un'infiltrazione che normalmente è di gran<br />
lunga superiore a quella di un normale terreno poroso.<br />
La portata delle sorgenti carsiche è in genere rilevante rispetto<br />
a quella delle sorgenti in rocce porose, con variazioni<br />
di portata molto rapide e percentualmente molto rilevanti; può<br />
così accadere che una sorgente passi in poche ore da una portata<br />
di qualche litro al secondo a quella di alcune migliaia di<br />
litri al secondo.<br />
L'acqua che raggiunge il reticolo carsico proviene normalmente<br />
dalle precipitazioni liquide e solide, pioggia e neve, ma<br />
vi è un'altra preziosa fonte da cui proviene l'acqua che alimenta<br />
le sorgenti carsiche e che, pur non essendo caratteristica solo<br />
delle aree carsiche, ha in queste il suo massimo sviluppo: la<br />
condensazione.<br />
In ambiente carsico infatti un'enorme quantità di aria circola<br />
nelle fessure a causa della differenza di temperatura tra<br />
ambiente interno e quello esterno.<br />
In estate l'aria calda scende nelle fessure e, raffreddandosi<br />
bruscamente, può contenere meno vapore d'acqua di quello<br />
che conteneva alla temperatura esterna. L'aria si satura in<br />
umidità ed è costretta a cedere l'acqua in esubero che si deposita<br />
per condensazione sulle pareti delle fessure. Un carattere<br />
tipico delle sorgenti carsiche, in certe condizioni di<br />
esposizione ai venti umidi di parti importanti del bacino di alimentazione,<br />
è infatti quella di mantenere discrete portate anche<br />
in estate, spesso superiori a quelle che sono giustificate<br />
dal bacino di alimentazione della sorgente, proprio per merito<br />
della condensazione.<br />
9
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
Di questo fatto si accorsero anche gli antichi, che, a Teodosia,<br />
costruivano grandi condensatori fatti con cumuli di pietre<br />
esposti alla brezza marina; i nostri contadini d'altra parte<br />
evidenziano il fenomeno sostenendo, anche in zone molto lontano<br />
dalla catena alpina, che le sorgenti carsiche sono alimentate<br />
dai ghiacciai: la logica è stringente, se le sorgenti<br />
aumentano la portata in estate, è evidente che sono alimentate<br />
da un ghiacciaio che sta fondendo!<br />
Anche se oggi sappiamo che è un fenomeno di condensazione,<br />
questo non toglie nulla alla saggezza e allo spirito di osservazione<br />
di chi è abituato ad un diuturno contatto con la<br />
natura da molte generazione .<br />
•'.l''I.Cfl''lli''. 14' •••• I •• lc.<br />
ap.rU.cClu. del bacl"o Iflllb,lfe"<br />
Nelle aree carsiche ben raramente vi è coincidenza tra bacino imbrifero e<br />
bacino idrogeologico. Nella figura è illustrato il caso di un bacino idrogeologico<br />
più ampio di quello imbrifero (Maifredi P, Perna G., 1978).<br />
Un'altra conseguenza di una circolazione attraverso grandi<br />
condotti è quella che non si ha di norma nessuna filtrazione<br />
naturale; almeno una parte dell'acqua che attraverso il reticolo<br />
carsico penetra nella montagna e ne fuoriesce nel giro di poche<br />
ore, ben poca cosa se confrontata con i diversi mesi od anni che<br />
servono all' acqua per coprire la stessa distanza in rocce porose.<br />
Da un lato questo è un difetto grave, poiché la protezione<br />
di una sorgente carsica richiede la tutela di tutto il bacino di<br />
alimentazione, ma dall'altra è paradossalmente un pregio,<br />
lO
Quando il substrato impermeabile si spinge al di sotto del livello di base,<br />
può esistere una zona satura con tutti i condotti allagati (olocarso o carso<br />
profondo): l'acqua dei condotti profondi viene chiamata acqua di fondo.<br />
Quando il complesso è fortemente carsificato, la superficie di separazione<br />
tra zona aerata (o zona vadosa) e zona satura (o zona freatica) è praticamente<br />
orizzontale; è inclinata (da sinistra a destra) più o meno a seconda dello<br />
sviluppo minore o maggiore del carsismo.<br />
oa:l.r1. con<br />
acqua aoap ••• o penalle<br />
Quando il substrato impermeabile si trova sopra il livello di base (rappresentato<br />
dal fondovalle),manca la zona satura. Si può verificare anche il caso,<br />
non certo frequente, di gallerie con acqua pensile (Maifredi P., Perna G., 1978).
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
poiché, essendo facilmente inquinabili, le acque carsiche sono<br />
rimaste ai giorni nostri tra le poche non sfruttate e quindi particolarmente<br />
appetibili.<br />
Nei punti dove si concentra l'assorbimento delle acque si<br />
generano particolari forme di corrosioni carsiche superficiali,<br />
paragonabili ad un imbuto o in altri casi ad un'ampia tazza<br />
con il fondo coincidente con il punto di assorbimento più importante,<br />
costituito in genere da un inghiottitoio: sono le doline<br />
e le valli carsiche, depressioni chiuse da tutti i lati, con<br />
deflussi che sono di norma sotterranei.<br />
In alcuni casi anche un corso d'acqua superficiale che scorre<br />
su terreni non carsici può raggiungere il contatto con le rocce<br />
carsificabili: può originarsi così una perdita che va ad<br />
alimen tare un reticolo carsico.<br />
Studiare la complessa circolazione delle acque in zona<br />
carsica impegna qui a Bossea molte energie degli speleologi<br />
cuneesi, del Politecnico e dell'Università, catalizzati dalla<br />
Una grande dolina alle falde della Cima Artesinera.<br />
12
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
IIStazione Scientifica" della grotta di Bossea, un attrezzatissimo<br />
laboratorio sotterraneo che da decenni tiene sotto controllo<br />
tra le altre cose le portate, il chimismo e la temperatura<br />
del corso d'acqua che attraversa la grotta.<br />
Si è cominciato con lo studio del corso d'acqua, evidenziando<br />
portate che vanno da poco meno di 50 litri al secondo<br />
in magra a poco oltre i milleduecento litri al secondo in piena.<br />
La portata media annua oscilla tra 120 e 200 litri al secondo,<br />
e questo significa che il sistema carsico drena una quantità<br />
di acqua variabile nei diversi anni da quattro a sei milioni<br />
di metri cubi circa.<br />
Evoluzione temporale<br />
del sistema di<br />
Bossea: A) Fase iniziale<br />
con circolazione<br />
profonda che<br />
caratterizza tutto il<br />
sistema; B) Sollevamento<br />
e relativa<br />
disattivazione di<br />
numerose cavità<br />
(Garbo del Crociato,<br />
Garbo della Raina);<br />
inizia a delinearsi la<br />
paleo-Bossea; C) Situazione<br />
attuale.<br />
(Olivero G., Vigna<br />
B;, 1990).<br />
13
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
CIMA ARTES<strong>IN</strong>ERA( 1922)<br />
PUNTA DEL<br />
MONTE MERDENZONE(1767)<br />
Rio Roccia Bianca<br />
I<br />
. T.Corsaglia BOSSEA<br />
Blocco-diagramma relativo alla morfologia dell'area di alimentazione del<br />
sistema carsico di Bossea (Olivero G., Vigna B., 1990).<br />
Si tratta di una quantità di acqua notevole che testimonia<br />
l'importanza del sistema carsico ma ha posto anche non pochi<br />
problemi ai ricercatori che hanno studiato il suo bacino<br />
di alimentazione.<br />
In questi casi si procede, dopo un attento esame della geologia<br />
della zona, per successive approssimazioni immettendo,<br />
nelle zone dove si presume s'infiltrino le acque, coloranti o sali,<br />
innocui (traccianti in linguaggio idrogeologico), che vengono<br />
poi rivelati nel torrente di Bossea con opportuni metodi.<br />
Le ricerche iniziate già nel 1968, proseguite poi nel 1975<br />
e nel 1986 e 1989, da parte del G.S.P. e del G.S.A.M. prima, dalla<br />
Stazione Scientifica di Bossea e dal Politecnico di Torino poi,<br />
14
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
Il vallone del Rio<br />
Rocciabianca Inizia<br />
con un'ampia conca<br />
carsica sospesa fra<br />
i due versanti (Valle<br />
Maudagna e Valle<br />
Sbornina).<br />
hanno messo in evidenza che la zona di alimentazione si spinge<br />
sino al Rio Rocciabianca ed al Rio Bertino, superando persino<br />
il Colle del Prel e raggiungendo la dolina di Prato Nevoso,<br />
già in Val Maudagna.<br />
Le esperienze su quest'ultima area di assorbimento hanno<br />
fatto conoscere un fatto interessante: in periodo di magra<br />
le acque di Prato Nevoso alimentano le sorgenti di case Bergamino<br />
sul versante della Val Maudagna; in periodo di piena<br />
una parte delle acque defluisce anche verso il sistema carsico<br />
di Bossea.<br />
15
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
CIMA ARTES<strong>IN</strong>ERA( 1 922)<br />
MONTE MERDENZONE(1767)<br />
COLLA DEL PREL<br />
Blocco-diagramma relativo all'idrostruttura dell'area di alimentazione del<br />
sistema di Bossea. In bianco è indicato l'acquifero carsico, in grigio la serie<br />
basale (Olivero G., Vigna B., 1990).<br />
È un caso di diffluenza che si può presentare in sistemi<br />
carsici complessi come il nostro, quando l'evoluzione del reticolo<br />
carsico mette in contatto condotte perennemente attive<br />
relativamente piccole, come quelle che vanno verso Case Bergamino,<br />
con condotte più ampie ma a quota diversa, ormai attive<br />
solo in condizioni particolari, come quelle che vanno verso<br />
Bossea. Quando si verifica una piena idrologica, le condotte<br />
piccole non riescono a smaltire tutta la piena, il massiccio carsico<br />
si satura e le acque "traboccano" verso le condotte più<br />
ampie normalmente ormai abbandonate.<br />
16
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
w<br />
E<br />
Colle del Flrel<br />
Rla Berf;lno<br />
Rio di Rocclll<br />
....<br />
..................:::::: . :::::................... :..............- ...,---...<br />
Sezione interpretativa dei deflussi sotterranei, accertati per mezzo dei traccianti,<br />
nel settore compreso fra la Val Maudagna, a sinistra, e la Val Corsaglia,<br />
a destra. Il Colle del Prel è posizionato sullo spartiacque superficiale.<br />
(Olivero G., Vigna B., 1990).<br />
3-.--<br />
o<br />
,<br />
250 500<br />
, ,<br />
m<br />
Schema tettonico dell'area Prato Nevoso - Bossea (da Vanossi, 1974, mod.).<br />
1) copertura carbonatica; 2) successione basale vulcano-clastica; 3) principali<br />
linee tettoniche (Olivero G., Vigna B., 1990).<br />
17
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
Le ricerche hanno messo anche in luce che esiste un altro<br />
importante circuito carsico che, nella valle del Rio Sbornina<br />
tende ad alimentare una grande sorgente, quella di stalle<br />
Buorch, molto interessante per la valle ma che non contribuisce<br />
al bilancio idrico della grotta di Bossea.<br />
Alla ricerca dei confini della zona di alimentazione della<br />
Grotta di Bossea le analisi, eseguite anche su modello numerico<br />
da parte del Politecnico di Torino, hanno riconfermato che<br />
parte dell'acqua di Bossea proviene da aree adiacenti agli affioramenti<br />
carsificabili, dove sono presenti rocce poco permeabili.<br />
Dopo un percorso in superficie le acque raggiungono la<br />
zona carsica, dove s'infiltrano.<br />
Quasi un terzo dell' acqua che transita per il torrente sotterraneo<br />
di Bossea proviene da zone non carsiche ed un contributo<br />
importante viene dato dalle già citate quarziti che<br />
funzionano come una gigantesca opera di drenaggio spesso interposta<br />
al contatto tra substrato e affioramenti calcarei.<br />
Un altro interessante dato che scaturisce dallo studio idrogeologico<br />
del sistema carsico è che esistono vaste zone completamente<br />
allagate dove l'acqua immagazzinata impiega tempi<br />
relativamente lunghi a transitare.<br />
In genere solo una parte del tracciante immesso arriva alla<br />
risorgente dopo tempi che possono variare in funzione della<br />
portata tra un giorno e dodici giorni.<br />
La restante parte fuoriesce in occasione di piene successive,<br />
molto diluita, evidentemente immagazzinata in vaste zone<br />
sature.<br />
Questi risultati ci hanno portato a cercare di sciogliere un<br />
altro dilemma: sono zone sature costituite da fessure sottili molto<br />
estese, cioè roccia fratturata ma non incarsita, o si tratta anche,<br />
almeno in parte di un vero reticolo carsico, forse esplorabile<br />
È stata cosÌ organizzata una nuova sezione del laboratorio<br />
della stazione scientifica che si occupa di prelevare campioni<br />
di acqua con continuità durante la piene e poi di<br />
analizzare i campioni per vedere le variazioni nel contenuto<br />
di sali di calcio.<br />
18
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
Mettendo in relazione l'andamento delle pioggie con quello<br />
delle portate, le oscillazioni della temperatura dell'acqua ed<br />
il suo contenuto salino, si cerca di valutare se esistono o meno<br />
importanti rami ancora sconosciuti.<br />
Come si vede la sfida tra gli speleologi, i ricercatori e la<br />
montagna continua e, ne siamo quasi sicuri, sarà prodiga di<br />
altre interessanti sorprese.<br />
i<br />
La conca di Prato Nevoso, grande valle carsica intensamente antropizzata.<br />
19
N N ° s<br />
Sezioni interpretative dell'idrostruttura di Bossea. 1) acquifero carbonatico;<br />
2) basamento indifferenziato .<br />
•<br />
3 \l 4<br />
o<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
., •<br />
5 •••<br />
6<br />
I<br />
o<br />
!<br />
250<br />
Schema idrogeologico del sistema di Bossea. 1) acquifero carbonatico; 2) basamento<br />
indifferenziato; 3) inghiottitoi attivi; 4) sorgenti carsiche; 5) limiti<br />
dell'idrostruttura; 6) collegamenti accertati con traccianti (Olivero G., Vigna<br />
B., 1990).<br />
20
Ambiente Carsico e Umano in Val Corsaglia<br />
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE<br />
Autori vari, 1990, Atti della Stazione Scientifica della grotta di<br />
Bossea. G.S.A.M. CAI Cuneo, Politecnico di Torino,<br />
Dipartimento Georisorse e Territorio.<br />
Calleris V., 1988, Abisso Bacardi, Mondo ipogeo, n. 12, G.S.A. M .<br />
CAI Cuneo.<br />
Maifredi P. e Perna G., 1978, La scienza della terra, geologia<br />
e idrogeologia (con particolare riferimento alle aree carsiche)<br />
in "Manuale di Speleologia", Longanesi, Milano.<br />
Peano G., 1975, Il fenomeno carsico nel Cuneese, Montagne Nostre,<br />
C.A.I. Cuneo.<br />
Peano G., 199 1, L'acquifero carsico di Bossea, Mondo Ipogeo,<br />
G.S.A.M. C.A.I. Cuneo.<br />
21