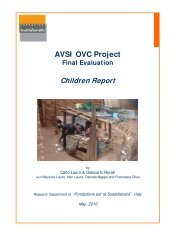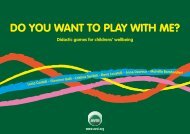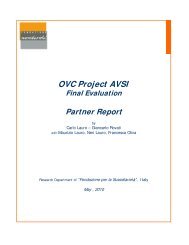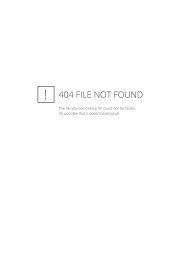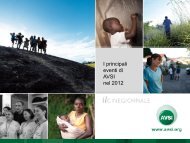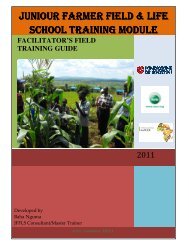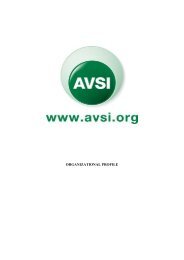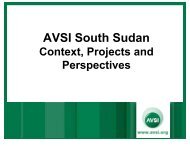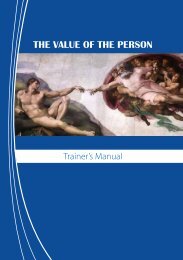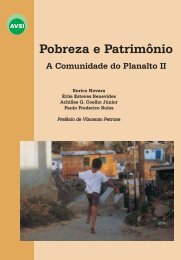Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PUNTO DI FUGA • COLLANA DELLA FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ <<br />
e<br />
s<br />
p<br />
LO SVILUPPO<br />
HA UN VOLTO<br />
Riflessioni su un’esperienza<br />
a cura di<br />
Roberto Fontolan<br />
introduzione di<br />
Alberto Piatti<br />
e<br />
r<br />
i<br />
e<br />
n<br />
z<br />
e
Punto di fuga verso una cultura e una società per l’uomo, basata sul progresso e sulla carità.<br />
Punto di fuga di un uomo che sa di non salvarsi da solo, che sbaglia,<br />
ma continua a credere e a sperare.<br />
Progresso e carità perché ogni uomo è unico e irripetibile e ha diritto a una vita dignitosa.<br />
È la tradizione cattolica che ha condizionato positivamente un socialismo<br />
amante dell’uomo e un liberalismo amante del bene comune.<br />
La collana della Fondazione per la Sussidiarietà intende affrontare in questa ottica<br />
temi cruciali per la vita culturale, sociale, economica e politica, non solo italiana.<br />
Da un lato, analizzando le prospettive che si aprono con la valorizzazione della centralità<br />
e della creatività della persona e con l’applicazione del principio di sussidiarietà;<br />
dall’altro, raccontando esperienze concrete che offrono ulteriori spunti di approfondimento.<br />
1. Giorgio Vittadini (a cura di ), Capitale Umano. La ricchezza dell’Europa<br />
2. Graziano Tarantini, Banche e finanza. La transizione incompiuta<br />
3. Paola Olivelli, Mario Mezzanzanica, A qualunque costo Lavoro e pensioni:<br />
tra incertezza e sicurezza<br />
4. Luca Antonini, Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia<br />
5. Raffaello Vignali, Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa<br />
6. Giorgio Vittadini (a cura di), Che cosa è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà<br />
7. Antonio Intiglietta (a cura di ), Nelle mani dell’artigiano. Una realtà si racconta<br />
8. Javier Prades (a cura di), All’origine della diversità. Le sfide del multiculturalismo<br />
9. Roberto Fontolan (a cura di), Lo sviluppo ha un volto. Riflessioni su un’esperienza
punto<br />
9di fuga
2008 Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA<br />
viale Filippetti 28, 20122 Milano<br />
http://www.guerini.it<br />
e-mail: info@guerini.it<br />
Prima edizione: novembre 2008<br />
Copertina e progetto grafico di: Giovanna Gammarota<br />
In copertina: photo courtesy by Fabio Cuttica per AVSI-Brasile, Salvador de Bahia, Algados<br />
Photo courtesy by: Fabrizio Arigossi, Fabio Cuttica, Renzo Faleschini,<br />
Silvia Morara, Brett Morton, Paolo Pellegrin, AVSI World Staff<br />
Segreteria di redazione: Dario Chiesa, Carlo Melato, Michele Pirotta<br />
Ristampa: V IV III II I 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Printed in Italy<br />
ISBN 978-88-6250-088-3<br />
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo<br />
di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e<br />
5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale,<br />
economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate<br />
a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano,<br />
e-mail: segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.<br />
Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto di Educazione allo<br />
sviluppo di AVSI con il contributo della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo<br />
del Ministero degli Affari Esteri italiano.
LO SVILUPPO<br />
HA UN VOLTO<br />
Riflessioni su un’esperienza<br />
a cura di<br />
Roberto Fontolan<br />
introduzione di<br />
Alberto Piatti<br />
GUERINI<br />
E ASSOCIATI
INDICE<br />
11<br />
13<br />
21<br />
23<br />
23<br />
23<br />
25<br />
26<br />
28<br />
28<br />
32<br />
32<br />
33<br />
34<br />
37<br />
37<br />
37<br />
40<br />
42<br />
43<br />
45<br />
47<br />
48<br />
PRESENTAZIONE<br />
di Roberto Fontolan<br />
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
di Alberto Piatti<br />
RIFLESSIONI SU UN’ESPERIENZA<br />
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA.<br />
TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
di Piergiorgio Lovaglio<br />
Introduzione<br />
Definizioni<br />
I riferimenti teorici<br />
Politiche diffuse di scolarizzazione e loro effetti<br />
I risultati: efficacia sulla riduzione della povertà<br />
Le ragioni<br />
Capitale umano e sviluppo<br />
Una definizione allargata di capitale umano<br />
Il capitale umano intangibile: il desiderio<br />
Bibliografia<br />
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
di Giuseppe Folloni e Gabriella Berloffa<br />
Diverse traiettorie<br />
Finanziare l’investimento in capitale fisico<br />
Investire in capitale umano. Cosa significa<br />
Complessità e specificità<br />
Le determinanti fondamentali della crescita: ma senza finire nel determinismo<br />
I grandi piani e il loro attore: lo Stato<br />
Educazione dell’Io, fattore dello sviluppo<br />
Bibliografia<br />
7
51<br />
51<br />
51<br />
52<br />
53<br />
53<br />
54<br />
55<br />
55<br />
57<br />
57<br />
58<br />
58<br />
61<br />
63<br />
67<br />
73<br />
81<br />
89<br />
97<br />
101<br />
107<br />
111<br />
119<br />
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
di Emilio Colombo<br />
Chi sono i poveri<br />
Come misuriamo la povertà<br />
Il fallimento della misura<br />
Povertà, sviluppo e desideri<br />
Lo sviluppo riguarda anche noi<br />
Le politiche dello sviluppo<br />
La sussidiarietà e la solidarietà nello sviluppo<br />
Il caso dell’aiuto allo sviluppo<br />
L’ideologia delle politiche allo sviluppo<br />
Il ruolo dello Stato<br />
L’idea della trappola della povertà<br />
Un primo cambiamento dall’aid all’aid for trade<br />
LO SVILUPPO HA UN VOLTO<br />
PRIMA LE DONNE E I BAMBINI<br />
Una casa nella steppa<br />
Quell’invito andato a vuoto<br />
Gli ospedali dell’orrore<br />
Nella terra delle emergenze<br />
PERSONE E COMUNITÀ<br />
Il Quarto Mondo dei CaraibI<br />
La cittadella dell’amore<br />
Il segreto per costruire sull’acqua<br />
LAVORARE SALVA<br />
8
123<br />
131<br />
137<br />
143<br />
149<br />
153<br />
157<br />
161<br />
165<br />
167<br />
Un fiume per ricominciare<br />
Duemila giovani in mezzo all’Asia<br />
Il cuore pulsante di una baraccopolI<br />
L’industria, la favela e un nuovo albero<br />
SOSTEGNO A DISTANZA<br />
Una scuola tira l’altra<br />
Crescita a tre dimensioni<br />
Denutrizione nel mirino<br />
GLI AUTORI<br />
FONDAZIONE AVSI<br />
9
PRESENTAZIONE<br />
di Roberto Fontolan<br />
I numeri si sa sono molto spesso contrastanti. Prendiamo la povertà estrema nel Terzo<br />
e Quarto mondo, quella del «reddito» da un dollaro al giorno. Un paio d’anni fa era<br />
stato calcolato che nonostante i massicci trasferimenti di aiuti da parte dei Paesi ricchi,<br />
in dieci anni il numero di quei poveri non era diminuito in cifre assolute, anzi, veniva<br />
stimato un aumento di oltre cento milioni di persone, mentre le percentuali restavano<br />
mutate di poco a causa dell’incremento demografico. Recentemente uno studio del<br />
Fondo Monetario ha rilevato come nell’intera Africa sub-sahariana la povertà stia lentamente<br />
calando, anche in percentuale: oltre il 47% della popolazione era registrata come<br />
povera nel 1990, nel 2001 era diventata il 41% e, calcolando i vari trend, si abbasserà<br />
al 37 % nel 2015. Numeri veri, certo, segnalano evoluzioni diverse, addirittura contrastanti.<br />
Certe faccende, come il cammino dalla miseria al progresso, restano per molto<br />
tempo indecifrabili.<br />
In questo volume raccontiamo una storia di sviluppo che non è fatta di numeri. Ci<br />
sono anche quelli, dai bambini aiutati dal Sostegno a distanza alle mamme in difficoltà<br />
accolte nella casa di Novosibirsk; come ci sono i riferimenti al quadro di dichiarazioni<br />
e regolamenti definito dalle istituzioni mondiali e nel quale si riconoscono coloro che<br />
operano nella cooperazione internazionale. Ma abbiamo provato a rendere lo sviluppo<br />
decifrabile secondo un altro codice.<br />
In questo volume troverete innanzitutto fatti. Fatti che racchiudono persone – le<br />
singole vicende di singoli nomi che vivono in luoghi geografici precisi; e che tracciano<br />
una storia d’insieme – come un percorso unico capace di avvicinare le distanze dei continenti<br />
e dei decenni. Impossibile dare senso all’idea di «capitale umano» se dentro di<br />
essa non si scorgono i volti della malata ugandese e dello scolaro paraguayano. Ugualmente,<br />
parlare di sviluppo resta inesorabilmente astratto se non si compie una visita ai<br />
Novos Alagados o alle cooperative agricole libanesi. E perciò le due parti del volume<br />
non vivono l’una senza l’altra, anzi si possono realmente comprendere soltanto come<br />
11
PRESENTAZIONE<br />
approfondimento e svolgimento l’una dell’altra. Leggendole, potrete visitare i luoghi,<br />
incontrare i protagonisti e camminare in loro compagnia, ascoltare la riflessione dello<br />
studioso, condividere il giudizio sui temi più decisivi per il bene comune del mondo che<br />
abitiamo tutti insieme.<br />
L’intero racconto contiene, nel suo sottofondo, un itinerario che può essere espresso<br />
così: persona, educazione, sviluppo; come il tempo nelle partiture musicali, queste<br />
tre «battute» ne costituiscono l’architettura nascosta. Tutto il lavoro descritto in queste<br />
pagine, che sia progetto sul campo o elaborazione intellettuale, non starebbe in piedi<br />
se non si appoggiasse al loro ritmo.<br />
Perché l’AVSI 1 l’abbia adottato nella sua azione in tutto il mondo è appunto quel che<br />
si scoprirà pagina dopo pagina.<br />
1<br />
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, Onlus, nata nel 1972 e impegnata con<br />
oltre cento progetti di cooperazione allo sviluppo in 39 Paesi del mondo. Oggi AVSI è presente in<br />
Africa, America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera nei settori della sanità, igiene, cura<br />
dell'infanzia in condizioni di disagio, educazione, formazione professionale, recupero delle aree<br />
marginali urbane, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed emergenza<br />
umanitaria.<br />
12
IL VOLTO DELLO SVILUPPO.<br />
PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
di Alberto Piatti<br />
Negli ultimi anni, lo sviluppo è entrato nel dibattito quotidiano: la globalizzazione, le<br />
migrazioni, il terrorismo internazionale hanno forzato nella comoda vita di noi occidentali<br />
le questioni dei Paesi in via di sviluppo.<br />
Così l’agenda internazionale ha acquisito gli obiettivi del millennio, per cui il 2015 è<br />
un traguardo che sempre più persone e istituzioni conoscono come traguardo dello sviluppo,<br />
il G8, più o meno allargato, pone tra i suoi temi principali lo sviluppo dell’Africa,<br />
e migliaia di iniziative si organizzano in tutto il globo per far fronte alle emergenze<br />
dei più poveri, dai global fund ai live aid. Tra entità degli aiuti e sviluppo, l’immaginario<br />
collettivo ha costruito un rapporto di proporzione diretta.<br />
In questo turbinio, molte energie sono spese per organizzare adeguatamente la macchina<br />
degli aiuti. In particolare dal 2005, dalla conferenza di Parigi, il dibattito sullo sviluppo<br />
nei paesi più poveri si è molto concentrato sull’efficienza, efficacia, trasparenza,<br />
ownership, misurabilità e prevedibilità degli aiuti.<br />
Fin qui il tema visto «dall’alto».<br />
Tuttavia, leggendo la vitalità che ribolle tra le righe delle esperienze progettuali raccolte<br />
da Roberto Fontolan, pare emergere qualche fattore che non si riesce a incasellare<br />
nelle tradizionali misurazioni.<br />
C’è l’avventura umana della condivisione e del desiderio, della libertà e dell’intelligenza<br />
creativa, dell’amore per l’altro e della riscoperta della dignità.<br />
Sarebbe però troppo riduttivo insinuare una contrapposizione tra «due culture»,<br />
tra un nuovo umanesimo e sapere economico. O rassegnarsi al fatto che un conto è<br />
l’esperienza delle iniziative di sviluppo, un conto è la teoria dello sviluppo, che in fondo<br />
la prima appartiene a una sfera umana, di esperienze buone, ma poco incidenti<br />
nella dinamica storica dei popoli, la seconda alla dura realtà. Ovvero ridurre le situazioni<br />
di difficoltà a palestre per allenare o svagare spiriti, dove va bene un po’ tutto,<br />
13
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
si sperimenta, si gioisce, si fanno belle cose, spiriti che poi invece saliranno sul palco,<br />
quello vero, dove le regole sono diverse e soprattutto quelle vere.<br />
In questo senso è particolarmente interessante la lettura di Folloni e Colombo delle<br />
esperienze e delle teorie dello sviluppo, da economisti che lasciano penetrare nella<br />
teoria economica anche i fattori di un agire che ha molte dimensioni dell’umano. Perché<br />
un errore imperdonabile sarebbe sottrarre le questioni del progresso umano alla<br />
lettura scientifica, interpretandola ipocritamente come insufficiente.<br />
Forse in realtà questa è la sfida oggi più interessante per chi si occupa di ricerca sui<br />
problemi dello sviluppo: adeguare la teoria all’esperienza anche in questo ambito, come<br />
in ogni ambito del sapere, superando luoghi comuni, mode, ideologie e pregiudizi,<br />
per capire i fattori determinanti dello sviluppo.<br />
Esprimendo in termini non tradizionalmente economici cos’è lo sviluppo nell’esperienza<br />
di un’organizzazione non governativa che opera negli angoli sperduti del pianeta<br />
con persone in carne ed ossa, si può definire la mossa di una persona che dopo aver<br />
lavorato con te, vissuto con te, affrontato con te questioni talvolta di vita o di morte,<br />
riconosce in se stessa e nella vita un valore e una dignità inestimabili. Valore e dignità<br />
che non sono in alcun modo dipendenti dalla situazione di maggior o minore difficoltà,<br />
maggiore o minore benessere. Percependo il valore di se stessa come indipendente<br />
dalla situazione storico-sociale in cui si trova, la persona diventa libera, e normalmente<br />
si muove prendendo iniziativa per migliorare la situazione stessa.<br />
In una parola, diventa «protagonista».<br />
L’educazione cristiana che ha dato origine alle esperienze raccontate in questo libro<br />
è basata sulla coscienza, che l’esperienza dell’incontro con Cristo rende evidente,<br />
che le necessità dell’uomo, così come il suo desiderio, sono sempre infiniti, e che,<br />
quindi, anche le risposte materiali che i progetti possono offrire, sono limitate.<br />
Quando però le azioni, le strutture, i progetti nascono da un «io» cosciente ed educato<br />
a riconoscere in ogni realtà umana, anche nella più degradata, un nesso con l’infinito,<br />
allora queste azioni o progetti diventano «opere», diventano gesti, diventano<br />
occasioni di incontro con persone con le quali si inizia un cammino comune di con-<br />
14
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
divisione, non solo di problemi o di difficoltà, ma anche del senso ultimo della vita.<br />
È interessante come si svolge la dinamica di questa scoperta radicale nei progetti di<br />
cooperazione. Il primo passo è un incontro tra due persone, di cui, secondo lo schema<br />
della relazione di aiuto, una ha il ruolo del «dare», l’altra del «ricevere».<br />
Questo rapporto ha in sé il rischio di una ambiguità, vera nel «micro» degli interventi<br />
di cooperazione allo sviluppo, ma tranquillamente trasponibile a livello di rapporti<br />
istituzionali internazionali e nazionali.<br />
La persona «che riceve» si aspetta tutto dal suo interlocutore, secondo l’immagine<br />
che ha del proprio bisogno, mentre quella che «dà» percepisce se stessa come mandata<br />
a portare il bene per l’altro, secondo l’immagine che ha del bisogno dell’altro.<br />
Questo gioco delle parti dominato dal ricatto del bisogno può permanere fino alla<br />
fine del progetto, progetto che può anche essere di successo, raggiungere tutti gli obiettivi<br />
e risultati.<br />
Ma lo sviluppo è qualcosa in più, non solo tecnicalità.<br />
C’è qualcosa che accade quando una persona aiuta l’altra prima di tutto a capire che<br />
non coincide con il suo stato di necessità da un lato né con l’aiuto che porta dall’altro.<br />
Il bisogno, la malattia, la povertà possono tenerti in scacco se non li percepisci come<br />
una contingenza che non può scalfire la sostanza della tua persona. E, d’altra parte, l’illusione<br />
di poter rendere felici gli altri ti chiude in una arida altalena tra delirio di onnipotenza<br />
e delusione.<br />
Accade che il bisogno smette di essere l’essenza del rapporto. La persona gradualmente<br />
percepisce il proprio valore, la propria consistenza al di là della circostanza,<br />
per cui inizia a fidarsi dell’altro, ad amare l’altro, nel senso di condividere l’avventura<br />
della vita.<br />
Ma cosa rompe questo circolo vizioso che ingabbia la persona in uno schema di ruoli,<br />
l’uno del dare e l’altro del ricevere<br />
Un gesto di solidarietà che abbraccia la realtà integrale delle persone verso cui si va.<br />
E proprio questa esperienza insegna a chi svolge il ruolo di «aiutare» che se è vero che<br />
il bisogno è enorme, è ancora più vero che nessuna soluzione, nessun aiuto, case nuo-<br />
15
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
ve, lavoro, o servizi, lo possono soddisfare compiutamente, perché il vero bisogno di<br />
quelle persone è il bisogno di un significato. «È la scoperta del fatto che proprio perchè<br />
li amiamo, non siamo noi a farli contenti; e che neppure la più perfetta società, l’organismo<br />
legalmente più saldo e avveduto, la ricchezza più ingente, la salute più di ferro,<br />
la bellezza più pura, la civiltà più educata li potrà mai fare contenti. È un Altro che<br />
li può fare contenti.» 1<br />
Quindi il metodo più realistico della cooperazione tra popoli sembra essere quello<br />
della «condivisione», che permette un processo molto simile a quello che Edith Stein<br />
chiama empatia, un comprendere, «un afferrare, ossia un intendere del valore della<br />
persona.»<br />
La vicinanza affettiva permette di leggere il bisogno parziale espresso dalle persone<br />
in funzione della totalità dell’essere umano. Ogni necessità, quand’anche essa fosse solo<br />
materiale o limitata, rimanda sempre ad un desiderio che la supera e che, con la condivisione,<br />
può essere ascoltato e dilatato in altre direzioni per una sua utilizzazione più<br />
edificante sul piano della crescita individuale e sociale. Una presenza esterna, amicale e<br />
autorevole, quindi educativa, ha una funzione essenziale 2 , determinante perché l’altro<br />
diventi soggetto protagonista.<br />
Allora fondamentale per l’aiuto allo sviluppo è un rapporto umano basato sulla coscienza<br />
che tutte le persone hanno qualcosa in comune: lo stesso cuore 3 e lo stesso desiderio<br />
di felicità.<br />
Incontrare l’altro con questo sguardo vuol dire essere presenti come soggetti attivi,<br />
con una umanità totale, fatta di cuore, di ragione. Questa vera e propria esperienza di<br />
«allargamento della ragione» permette poi di trovare i mezzi operativi e progettuali adeguati<br />
per rispondere alle necessità che via via si manifestano. Nelle storie raccontate si<br />
va dagli asili famigliari alle scuole professionali, da centri per l’inserimento lavorativo<br />
di persone altrimenti emarginate alla creazione di luoghi aggregativi per donne malate<br />
di AIDS.<br />
In questo senso, è impressionante la capacità operativa e creativa che si legge tra le<br />
righe delle esperienze raccontate, l’intelligenza di trovare soluzioni alle problematiche<br />
16
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
più complesse, spesso mettendo mano in quello zainetto di patrimonio di saperi che<br />
ciascuna persona ha ricevuto da chi l’ha educata. Nel rapporto con l’altro, si dischiude<br />
un «positivo», un patrimonio di cui ciascuno è portatore, che attraverso una reciproca<br />
responsabilità si sviluppa in modo sorprendente.<br />
Le energie che alimentano lo sviluppo sono insite nel portato della persona e della<br />
comunità e il processo educativo che si instaura in una «sana» relazione di aiuto permette<br />
di «attivare» questo patrimonio, valorizzando la tradizione cui la persona e la comunità<br />
appartengono. L’intervento esterno può aggiungere tecnicalità, strumenti,<br />
competenze. Questo è un altro fattore fondamentale dell’aiuto allo sviluppo: l’investimento<br />
sul capitale umano, centrato da Lovaglio come elemento essenziale per dotare<br />
la persona, consapevole e cosciente del proprio valore, di strumenti e conoscenze utili<br />
a interagire efficacemente con la realtà. Questa è quella che comunemente si chiama<br />
capacity building degli attori locali: incontro tra persone e contaminazione tra tradizioni<br />
e accrescimento dei saperi.<br />
Ciò che accende la miccia di questo «carburante» è la libertà del soggetto, la persona,<br />
che cerca e usa delle risorse per far fronte a un bisogno che non è più una condanna,<br />
ma una situazione che può essere superata. Cioè il perno dello sviluppo non è l’attore<br />
esterno, non sono le risorse, non sono le regole. È la consapevolezza di un soggetto<br />
che, proprio per amore di sé e della vita, cerca e costruisce.<br />
Nell’asilo di Novos Alagados a Salvador Bahia dedicato al papa Giovanni Paolo II,<br />
costruito nel 1993, primo atto di una presenza in quest’area che ha generato oggi opere,<br />
progetti e programmi di sviluppo, è riportata a grandi lettere una frase di Luigi Giussani<br />
che ne ricorda l’origine:<br />
Il cuore dell’uomo è sete d’infinito. Per questo educhiamo, lavoriamo, costruiamo.<br />
L’empowerment più efficace, per usare un linguaggio da addetti ai lavori, parte dal riconoscimento<br />
di sé come creatura unica e irripetibile.<br />
Dalla lettura che i ricercatori svolgono nella prima parte del libro sulle esperienze<br />
descritte da Fontolan, quattro fattori emergono dunque come essenziali nell’aiuto allo<br />
sviluppo: la dignità della persona, l’educazione come processo che la rende protagoni-<br />
17
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
sta, il desiderio come tensione alla realizzazione di sé, il capitale umano come bagaglio<br />
di attrezzi e saperi per concretizzare un cammino di sviluppo.<br />
A questo punto sorgono le domande tipiche degli operatori del settore. Ma si può<br />
davvero dire che questi fattori generano processi di sviluppo, o sono condizioni specifiche<br />
non replicabili Cosa suggeriscono all’efficacia, efficienza, trasparenza, misurabilità<br />
tanto fondamentali in tutti i documenti sull’aiuto allo sviluppo Le politiche di aiuto<br />
allo sviluppo possono trovare in questi elementi indicazioni chiare<br />
Vediamo nuove sfide apparire all’orizzonte, per affrontare le quali non possiamo più<br />
solo «marciare sul posto» come «europei impagliati 4 ». Abbiamo anzitutto la necessità<br />
di investire su una nuova generazione di persone che raccolga la sfida di questi fattori<br />
come qualcosa di reale. Ciò significa investire su una generazione di giovani sia dei cosiddetti<br />
Paesi in Via di Sviluppo, sia dei cosiddetti Paesi evoluti, per cui è necessario<br />
pensare a strumenti legislativi, relazionali, progettuali flessibili, di lungo termine, calati<br />
nel reale.<br />
Può sembrare una banalità, ma la portata culturale di questa svolta è decisiva e radicale.<br />
Significa superare il nichilismo che serpeggia e prende la fisionomia della religione<br />
umanitaria, delle regole, del denaro come elemento risolutorio dei problemi<br />
dell’umanità.<br />
Occorre una generazione di persone che rispolveri lo sviluppo come progresso (parola<br />
che oggi ha smarrito la sua origine, progredior, corro in avanti), ovvero come tensione<br />
in avanti, verso una meta, verso cui c’è la strada ma a cui mai si arriva definitivamente,<br />
come dice San Bernardo: «La nostra perfezione consiste nel non illuderci mai di essere<br />
arrivati, ma nel protenderci sempre in avanti».<br />
Occorre una generazione di persone educate a riconoscere nell’essere umano un valore<br />
e dal potenziale infinito, in quanto creature a immagine e somiglianza di Dio.<br />
18
IL VOLTO DELLO SVILUPPO. PERSONA, EDUCAZIONE E DESIDERIO<br />
NOTE<br />
1<br />
Luigi Giussani, Il senso della caritativa, in «Tracce», ristampa del 2006 del documento del 1961, p. 10.<br />
2<br />
«La prima condizione della comprensione – osserva Hans Urs von Balthasar – è l’accettazione<br />
del dato così come ci si dà. La prima cosa di cui abbiamo bisogno per vedere obiettivamente è lasciare<br />
essere quello che si mostra. La prima cosa non è impadronirsi, attraverso le categorie del soggetto,<br />
del materiale pronto per la percezione, ma mettersi al servizio dell’oggetto, adorare… L’imponenza<br />
della realtà non lascia indifferente la ragione… la realtà agisce sulla ragione come un invito inaggirabile<br />
a scoprire il significato», cit. in Julián Carrón, L’urgenza della ragione, in «Allargare la Ragione», V&P,<br />
2006, p. 33.<br />
3<br />
«L’esigenza della verità, dell’amore, della giustizia, della felicità: queste domande costituiscono il<br />
cuore dell’uomo, costituiscono l’essenza della ragione, cioè della coscienza che l’uomo ha della realtà<br />
secondo la totalità dei suoi fattori», Luigi Giussani, L’io, il potere, le opere, Marietti, 2000, p. 36.<br />
4<br />
Cfr. T.S. Eliot, Gli uomini vuoti, in ID., «Poesie», Oscar Mondadori, Milano 1971, p. 249.<br />
19
RIFLESSIONI<br />
SU UN’ESPERIENZA
INTRODUZIONE<br />
CAPITALE UMANO<br />
E CRESCITA ECONOMICA.<br />
TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
di Piergiorgio Lovaglio<br />
Secondo una consolidata tradizione di pensiero, una delle cause fondamentali del mancato sviluppo<br />
di un paese risiede nell’insufficiente dotazione di capitale fisico (accumulazione di impianti,<br />
macchinari, materie prime ecc.), dovuta all’incapacità a risparmiare a causa del basso livello dei<br />
redditi pro-capite. L’investimento in infrastrutture e in impianti è infatti considerata la base della crescita<br />
(qui la parola sviluppo è considerata sinonimo di crescita).<br />
Questo approccio al problema non ha riscontrato evidenze empiriche soddisfacenti ed è stato oggetto<br />
di crescenti critiche negli anni Settanta e Ottanta. Tale (almeno parziale) fallimento è servito a evidenziare<br />
l’importanza del fattore umano per mettere a frutto le potenzialità economiche delle risorse<br />
disponibili e della dotazione in fattori produttivi. In effetti, il capitale fisico è formato da beni che sono<br />
a loro volta il frutto del lavoro umano e della sua produttività. Quest’ultima è legata al livello del capitale<br />
umano.<br />
DEFINIZIONI<br />
Già dalla metà degli anni Cinquanta, il concetto di capitale umano è stato variamente definito e analizzato.<br />
Non si è tuttavia giunti a una teoria completamente condivisa.<br />
Molteplici sono le definizioni adottate di capitale umano. Una definizione implica una possibilità di misurare;<br />
perciò spesso le definizioni di capitale umano sono legate ai problemi di misurazione dello stesso,<br />
che non sono di facile soluzione, in relazione sia alla natura multidimensionale dello stesso, sia al livello<br />
di analisi (micro o macro) nel quale ci si pone.<br />
Nella letteratura due grandi approcci hanno inteso misurare il capitale umano: il primo stima il valore<br />
dello stock di capitale umano ai costi di mantenimento, di istruzione e di formazione degli individui<br />
dalla nascita fino all’ingresso nel mondo del lavoro (metodo retrospettivo); l’altro fa coincidere tale stima<br />
con la quantità di reddito da lavoro percepita da un individuo di una determinata età fino alla morte<br />
o all’età pensionabile (metodo prospettivo).<br />
Si noti che tali metodologie sono state criticate perché più che una definizione di capitale umano, esse propongono<br />
metodi per una sua misura o contabilizzazione, attraverso i costi di mantenimento e di istruzione<br />
di un individuo (a patto che i costi coincidano con gli investimenti) o i redditi da lavoro nel ciclo vitale.<br />
Infatti, l’ammontare di capitale umano non coincide necessariamente con i costi sostenuti in capitale<br />
23
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
umano (approccio retrospettivo), né con i suoi benefici monetari per i lavoratori (approccio prospettivo).<br />
A fronte della crescente attenzione al capitale umano come fattore che sostiene la crescita economica,<br />
verso la metà degli anni Cinquanta il Department of Economic Affairs delle Nazioni Unite definì investment<br />
in human capital l’investimento compiuto per accrescere la produttività della forza lavoro e dunque da<br />
una parte gli investimenti in educazione e formazione professionale, dall’altra le politiche di immigrazione,<br />
di acquisizione di conoscenza, di miglioramento della salute dei lavoratori, infine azioni connesse<br />
ad altri fattori intangibili (miglioramento degli standard sociali e familiari), fenomeni tutti collegati<br />
alla produttività del lavoro.<br />
Sulla scia di tale approccio, negli anni Sessanta un gruppo di studiosi della Scuola di Chicago cercò di chiarire<br />
teoricamente il concetto di capitale umano dal punto di vista dell’analisi economica: esso veniva definito<br />
come lo stock di conoscenze e competenze, riassunto nel patrimonio di istruzione (anni di scolarità),<br />
di formazione ricevuta direttamente sul lavoro (anni di esperienza professionale e/o durata dei periodi di<br />
training) e di attività tese al miglioramento delle condizioni psicofisiche, aventi un effetto diretto sulla capacità<br />
di produrre reddito da parte dei lavoratori nel corso della vita lavorativa (Mincer 1958, Becker 1962).<br />
In seguito, la letteratura economica ha allargato il concetto di capitale umano evidenziandone il ruolo<br />
anche nella produzione di capitale sociale (Coleman, 1988). Si sostiene infatti che l’investimento in capitale<br />
umano può avere un forte impatto sociale oltre a quello misurato in termini economici sulla produttività<br />
dei lavoratori, avendo riflessi positivi sulla salute pubblica, sul livello di criminalità e sulla coesione<br />
sociale di una comunità. In particolare il capitale umano diventa un fattore fondamentale del sistema<br />
delle relazioni interpersonali che generano il capitale sociale di una comunità o di un paese, definibile<br />
come l’insieme delle relazioni interpersonali formali e informali essenziali anche per il funzionamento<br />
di società complesse e altamente organizzate.<br />
Al lettore attento non sarà sfuggito che le varie definizioni fin qui presentate non forniscono necessariamente<br />
un’accezione univoca e concorde del concetto di capitale umano.<br />
Per questo motivo, ancor oggi gli organismi internazionali (in particolare Nazioni Unite, OECD, Eurostat)<br />
evitano di scegliere univocamente una delle definizioni e preferiscono invece pubblicare un’ampia<br />
informazione riferibile ai più importanti indicatori di capitale umano (es. percentuale di giovani diplomati,<br />
tassi di laurea in discipline scientifico-tecnologiche, quota di lavoratori adulti che fruiscono di<br />
formazione continua ecc.). Molti di tali indicatori sono inseriti tra gli indicatori strutturali, decisi sulla<br />
base degli obiettivi di Lisbona 1 , su cui l’Europa ha scelto di misurare la propria evoluzione economico-sociale.<br />
Tra le varie definizioni di capitale umano presenti nei documenti delle istituzioni internazionali, ci sembra<br />
interessante citare quella generale riportata in un Rapporto dell’OECD (OECD, 1998) che tratta della<br />
relazione tra capitale umano, capitale sociale e benessere delle nazioni. Il capitale umano è definito<br />
come «l’insieme di conoscenze, capacità e competenze e di attributi individuali che facilitano il benessere<br />
personale, sociale e economico.»<br />
24
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
Già in tale definizione, che fa riferimento alle molteplici caratteristiche del capitale umano 2 e ai fattori<br />
che ne influenzano il livello e l’evoluzione, si riflette la complessità di tale concetto, che non può coincidere<br />
con nessuno di tali aspetti presi singolarmente.<br />
Questo allargamento del modo di concepire il valore del capitale umano, non più solo sulla produttività<br />
del lavoratore, ma anche come fattore di miglioramento sociale, ha fatto breccia anche nella riflessione<br />
delle istituzioni internazionali.<br />
Oggi le istituzioni internazionali affermano che il capitale umano è la principale risorsa di cui dispone<br />
un sistema paese per il proprio sviluppo sociale ed economico ed è indubbio che la valorizzazione del<br />
capitale umano, inteso non solo come bagaglio di scolarità acquisita, ma soprattutto come l’insieme di<br />
conoscenze, capacità, motivazioni dei singoli individui, possa determinare benefici sotto il profilo della<br />
qualità della vita, dell’occupazione e della coesione sociale. Il capitale umano viene considerato una<br />
delle espressioni fondamentali della cittadinanza europea, poiché concorre alla coesione sociale, alla<br />
tolleranza e trova riscontro normativo in molti atti politici dell’Unione Europea (OECD, 1998), dal Trattato<br />
di Amsterdam (1997) ai documenti della Strategia di Lisbona (e successivi approfondimenti), sulle<br />
nuove prospettive di rilancio dell’idea di Europa, traducendosi nell’obiettivo di arrivare a un tasso<br />
globale di occupazione pari al 70% e a un tasso di occupazione femminile pari al 60% nei paesi dell’Unione,<br />
di migliorare le attività di ricerca, la spesa per le quali dovrebbe raggiungere l’obiettivo del 3%<br />
del PIL; si tratta di obiettivi già raggiunti, ad esempio negli USA, in Giappone, Inghilterra, Olanda e nei<br />
paesi scandinavi.<br />
I RIFERIMENTI TEORICI<br />
Il modello teorico di riferimento per la spiegazione di come si accumula il capitale umano, in una definizione<br />
abbastanza ristretta che lo lega alla decisione di proseguire gli studi, è proprio di Gary Becker<br />
(1962), uno degli esponenti, insieme a Schultz, del filone di studi in materia all’interno della Scuola di<br />
Chicago. Il modello di Becker ipotizza che gli agenti economici decidono di investire una quota della<br />
propria vita in istruzione, formazione professionale e altre forme di acquisizione della conoscenza sulla<br />
base di un bilancio fra benefici e costi. I primi includono gli incrementi nelle retribuzioni legate a un<br />
maggior livello di istruzione, i secondi includono sia i costi legati alla scolarità, sia i costi da mancato guadagno<br />
durante gli anni spesi in istruzione e formazione.<br />
Jacob Mincer, della Columbia University, tradusse operativamente il modello teorico di Becker ipotizzando<br />
una forte relazione tra redditi individuali e abilità (Mincer 1958, 1974). Egli introdusse il concetto<br />
di capitale umano (misurato dagli anni di scolarità e dal livello di esperienza professionale) come fonte<br />
di produttività sul lavoro. In termini semplici, egli assume che i redditi da lavoro di un individuo siano<br />
legati positivamente al suo livello di scolarità (a livello micro) e quindi, a livello macro, abbiano ricadute<br />
positive sul prodotto nazionale e la sua crescita.<br />
25
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
Sulla base di tali argomentazioni, da circa un trentennio, studi empirici hanno valutato le relazioni esistenti<br />
tra capitale umano personale e retribuzioni da lavoro, a livello micro e tra livelli pro-capite di capitale<br />
umano e redditi nazionali a livello macro.<br />
L’applicazione del modello minceriano su dati individuali (approccio micro) ha dato risultati convergenti<br />
in pressoché tutti i paesi (per una rassegna si veda Psacharopoulos, 1985), confermando che la<br />
relazione tra scolarità e redditi da lavoro è significativa ed elevata.<br />
A livello macro gli studi empirici hanno mostrato che differenze nell’accumulazione di capitale umano<br />
(misurato generalmente a livello di paese con il tasso di scolarizzazione della scuola secondaria)<br />
riuscivano a spiegare una quota abbastanza ampia (circa 2/3) della variabilità dei livelli nel prodotto<br />
nazionale pro-capite fra le diverse economie. Tale decisivo ruolo del capitale umano è spiegato anche<br />
dal fatto che mentre il capitale fisico può trascinare la crescita solo fino a un certo punto (rendimenti<br />
decrescenti), il capitale umano è un motore inesauribile di aumento della produttività 3 .<br />
Recentemente Camilo Dagum, uno dei pionieri degli studi sul capitale umano e autore di rilevanti contributi<br />
sulla relazione fra disuguaglianza economica e differenze nella dotazione di capitale umano a livello<br />
individuale, è giunto a risultati analoghi. A differenza di molti altri autori, che fanno coincidere il<br />
capitale umano con gli anni di scolarità attraverso metodologie raffinate, Dagum fu il precursore di una<br />
stima quantitativa dello stesso a livello micro, di lavoratori e famiglie. Le considerazioni dello studioso<br />
argentino confermano che le differenze di redditi tra lavoratori sono determinate largamente dai differenziali<br />
di capitale umano previsti per svolgere tali occupazioni e che una parte elevata della disuguaglianza<br />
dei redditi si deve alla disuguaglianza esistente nei livelli di istruzione dei lavoratori. Questo si<br />
traduce, a livello macro, nel fatto che la disuguaglianza tra paesi in termini di reddito pro-capite dipende<br />
largamente dalla diseguale dotazione di capitale umano.<br />
POLITICHE DIFFUSE DI SCOLARIZZAZIONE E LORO EFFETTI<br />
Vi sono molti studi che hanno cercato di mettere in evidenza come la disponibilità di una forza lavoro<br />
adeguatamente istruita sia una condizione cruciale del miracolo economico di alcuni paesi (Lucas,<br />
1992). Di conseguenza, sul piano delle politiche per lo sviluppo, sono stati fatti notevoli sforzi da parte<br />
dei governi nazionali, fin dagli anni Sessanta, per favorire la scolarità, allo scopo sia di eliminare l’analfabetismo<br />
sia di aumentare la partecipazione ai cicli più elevati di istruzione da parte dei giovani. Tali<br />
politiche di scolarizzazione avevano indirettamente come obiettivo la riduzione della povertà e la crescita<br />
economica.<br />
Ma le evidenze empiriche confermano le aspettative in termini di crescita di produttività e di riduzione<br />
della povertà suscitate da tali politiche<br />
Indubbiamente, paesi più ricchi hanno una dotazione di forza lavoro più istruita rispetto a paesi più<br />
poveri, tuttavia molti economisti dubitano se l’istruzione sia una chiave della strategia di sviluppo di al-<br />
26
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
cuni paesi oppure se essa stessa sia solo una delle conseguenze di tale strategia. Vari autori (Pritchett,<br />
1995) hanno mostrato che la crescita dell’istruzione in alcuni casi non è correlata con la crescita del<br />
prodotto nazionale e, in alcuni casi, quando un effetto significativo è presente, è negativo; ovvero i paesi<br />
in cui la scolarità media è cresciuta di più negli ultimi venti o trenta anni sono anche quelli in cui il<br />
reddito è cresciuto meno. Pritchett illustra la relazione tra tassi di crescita annua dell’istruzione e della<br />
produttività tra il 1960 e il 1985 per diverse aree geografiche, sintetizzata in tabella 1.<br />
TABELLA 1 – Tassi di crescita medio-annua dell’istruzione e del PIL nel mondo<br />
(periodo 1960/1985).<br />
REGIONE<br />
CRESCITA %<br />
(ANNI ISTRUZIONE)<br />
CRESCITA ASSOLUTA<br />
(ANNI ISTRUZIONE)<br />
CRESCITA % PIL<br />
(PRO-LAVORATORE)<br />
Africa<br />
sub-sahariana<br />
4,56 1,97 0,75<br />
Nord Africa 4,74 3,19 3,99<br />
Asia<br />
meridionale<br />
America<br />
Latina<br />
Asia<br />
orientale<br />
2,54 1,66 1,05<br />
2,74 2,44 1,58<br />
4,00 2,83 3,66<br />
OECD 0,60 0,97 2,45<br />
Essa mostra che la crescita relativa dei livelli di istruzione della forza lavoro nei paesi africani è stata più<br />
elevata di qualunque altra regione del mondo (derivante dal fatto che essi partivano da condizioni più<br />
svantaggiate). Ciononostante, il tasso di crescita della produttività del lavoro (PIL per lavoratore) in tali<br />
paesi (0,75% annuo) è stato fra il 1960 e il 1985 pari alla metà di quello dei paesi dell’America Latina<br />
(1,58%), e circa un quinto di quello dei paesi del Sud-Est asiatico (3,66%). Inoltre nei paesi OECD il tasso<br />
di crescita della scolarità è stato inferiore a un quarto rispetto a quello del Sud dell’Asia, ma la dinamica<br />
del PIL per lavoratore è stata pari a due volte e mezzo (2,45 contro 1,05). Vi sono dunque traiettorie<br />
diverse: l’efficacia della scolarizzazione sembra dipendere fortemente da altri fattori 4 .<br />
27
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
I RISULTATI: EFFICACIA SULLA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ<br />
In sintesi, rispetto alla questione se il divario tra paesi industrializzati e in via di sviluppo sia aumentato<br />
o diminuito a seguito del processo di massiccio investimento in istruzione negli ultimi 50 anni, i dati<br />
non sono confortanti. Secondo un recente studio della Banca Mondiale (Chen e Ravallion, 2004),<br />
sebbene nel periodo 1981-2001 la quota di individui che viveva con meno di un dollaro al giorno (estremamente<br />
poveri) si sia quasi dimezzata passando dal 40,3% al 21,3% della popolazione mondiale, i dati<br />
aggregati celano importanti differenze sull’andamento del numero dei poveri nelle varie parti del pianeta.<br />
Se si esclude la performance della Cina (nell’Asia orientale gli estremamente poveri al 2001 erano<br />
il 15% della popolazione, contro il 60% del 1980, mentre nell’Asia meridionale tale quota è scesa al<br />
30% della popolazione, contro il 50% del 1980), il numero dei poveri estremi è addirittura aumentato,<br />
specialmente nell’Africa sub-sahariana, in America Latina e addirittura in Europa orientale. Inoltre, al<br />
2001 più della metà della popolazione dei paesi in via di sviluppo viveva con meno di due dollari al giorno<br />
e nel ventennio considerato il numero assoluto di persone con meno di due dollari al giorno è aumentato<br />
di circa 300 milioni, mostrando che il tenore di vita di coloro che si trovavano in prossimità<br />
della soglia dei due dollari non è cambiato in modo significativo.<br />
Gli investimenti in capitale umano, misurati dall’ammontare di risorse che le nazioni destinano (in termini<br />
di sanità pubblica, risorse in istruzione ecc.) come quota del prodotto nazionale, non hanno mostrato<br />
un significativo impatto sulla riduzione della povertà e dell’indigenza: in particolare la spesa pubblica<br />
per la sanità non ha effetti significativi sugli indicatori di salute nei paesi in via di sviluppo, mentre<br />
in altri contesti si è osservata una debole relazione tra spesa pubblica destinata all’istruzione e indicatori<br />
di privazione relativi ad alcuni beni primari.<br />
LE RAGIONI<br />
Cerchiamo di capire perché, come già osservato, i risultati empirici forniscono indicazioni contrastanti<br />
circa il ruolo della scolarizzazione nella riduzione della povertà e nella crescita di un paese.<br />
L’aumento della scolarità e il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione hanno benefici<br />
economici per il lavoratore, come visto, ma possono avere anche ricadute positive sul resto della<br />
società attraverso quelle che gli economisti chiamano «esternalità». Da un lato, la scelta degli individui<br />
di aumentare il proprio livello di istruzione (e di salute) ha ricadute positive sulla vita civile, sulla coesione<br />
sociale, sulla fiducia e capacità di dialogo, con effetti che vanno ben oltre il mondo del lavoro e<br />
della produzione. In sostanza, il capitale umano produce effetti sia a livello personale sia per gli altri.<br />
Dall’altro, il rendimento individuale – anche in termini economici – dipende dalle scelte fatte dagli altri.<br />
Se gli altri non hanno investito in capitale umano, il mio stesso investimento può subire effetti negativi:<br />
sono come un «pesce fuor d’acqua» in un contesto che non valorizza il capitale umano. In luo-<br />
28
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
go di simili esternalità, può essere che il rendimento dell’investimento in capitale umano sia legato a investimenti<br />
complementari. In un’economica ferma e chiusa studiare non paga, la scelta di investire in<br />
capitale umano si rivela poco efficace dal punto di vista economico per chi ha investito. Inoltre si ingenera<br />
sfiducia verso tali forme di investimento, con pesanti ricadute sul benessere sociale delle generazioni<br />
esistenti e future.<br />
Insomma è verosimile che una relazione «positiva» fra capitale umano e sviluppo esista, ma la sua forza<br />
dipende da una serie di fattori non secondari. Occorre valutare in maniera più approfondita quali<br />
condizioni rendono il capitale umano (in particolare la scolarizzazione) un fattore di crescita. Nei seguenti<br />
paragrafi verranno esplorati tre fattori che ben mettono in luce sotto quali condizioni l’investimento<br />
in capitale umano produce effetti sulla crescita: il contesto tecnologico, la qualità della scolarizzazione<br />
e l’apertura commerciale di una economia.<br />
Il contesto tecnologico<br />
Indubbiamente, in un’era di economia globalizzata come l’attuale, l’economia di un paese in via di sviluppo<br />
potrebbe avere dei vantaggi nella produzione di merci «mature»; tuttavia se si trascura la formazione<br />
del capitale umano necessario a gestire il progresso tecnologico si corrono nel lungo periodo forti<br />
rischi di declino. Vi sono evidenze che il processo di crescita, e più in generale di sviluppo, è tanto<br />
più forte quanto più elevata è la capacità del lavoro di creare tecnologia e di utilizzarla in modo appropriato.<br />
In particolare l’investimento in capitale umano dovrebbe coincidere con l’investimento in formazione<br />
tecnica, professionale e scientifica in quei settori ad alto valore aggiunto che di per sé costituiscono<br />
stock di capitale umano di alta qualità (es. Ricerca e Sviluppo). Gli autori di tale scuola di pensiero<br />
sostengono che la vera potenzialità economica dei PVS sta nella conoscenza e nel capitale umano<br />
applicato alla produzione, ovvero nella tecnologia e nella capacità di utilizzarla. Per molti paesi, soprattutto<br />
i più poveri e meno dotati sul piano tecnologico, è cruciale la capacità di imitare tecnologie sviluppate<br />
altrove e di adattarle alle proprie specifiche esigenze.<br />
La diffusione di tecnologie importate richiede in primo luogo competenze tecnologiche autoctone,<br />
perché le tecnologie non sono pronte all’uso in qualunque momento e in qualunque luogo. Hanno bisogno<br />
al contrario di essere adattate alle caratteristiche locali del paese importatore. Ma, anche a prescindere<br />
da questo aspetto, l’uso quotidiano di nuove tecnologie richiede competenze tecniche superiori<br />
a quelle generalmente esistenti in un’economia arretrata. Di qui l’importanza di disporre di una<br />
forza lavoro adeguatamente istruita, ma inserita in contesti produttivi e settori fortemente dinamici. Il<br />
Giappone storicamente ha rappresentato l’esempio più significativo di crescita attraverso l’imitazione,<br />
ma un ampio gruppo di paesi in via di sviluppo, localizzati soprattutto in Asia, è entrato in questi ultimi<br />
anni nei mercati globali riuscendo a trasformare l’abbondanza di lavoro – qualificato – in un fattore<br />
competitivo nelle produzioni industriali; l’ulteriore investimento in capitale umano, aumentando la<br />
produttività, ha generato circoli virtuosi e veri e propri miracoli economici, come è accaduto in Corea,<br />
29
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
Taiwan e altri paesi. È un esempio di complementarietà: occorre dinamismo nel sistema per valorizzare<br />
il capitale umano; se questo paga, l’ulteriore investimento in capitale umano favorirà ulteriore crescita.<br />
Se invece non esiste questa virtuosa relazione tra investimento in capitale umano, dinamismo dei settori<br />
ad alto valore aggiunto e creazione di infrastrutture adatte (poli scientifici, distretti dell’informazione<br />
ecc.), anche l’offerta di capitale umano altamente specializzato, specie in ambito scientifico, potrebbe<br />
essere scoraggiata ed emigrare in altri paesi, come già successe a diversi paesi europei prima e a<br />
molti PVS ancor oggi.<br />
In senso opposto, il caso Egitto rappresenta un’anomalia eclatante, ma offre anche utilissime indicazioni<br />
per spiegare perché, in alcuni casi, promuovere l’istruzione tout court da sola può non essere<br />
un valido contributo allo sviluppo economico. Negli anni Settanta e Ottanta, il governo egiziano<br />
prestò particolare attenzione alle politiche dell’istruzione promuovendo la scolarizzazione di<br />
massa e garantendo un posto di lavoro nel settore pubblico a tutti coloro che avessero ottenuto un<br />
titolo di studio da una delle scuole statali. Il risultato fu un’esplosione dell’occupazione nel settore<br />
pubblico, che si tramutò in un forte deficit della spesa governativa a fronte di impatti inesistenti o,<br />
addirittura, negativi sulla produttività della pubblica amministrazione.<br />
In sostanza, pur essendo la forza lavoro egiziana fra le più istruite nell’ambito dei paesi in via di sviluppo,<br />
il tasso di crescita dell’economia egiziana negli anni Ottanta è stato fra i più bassi in assoluto a causa<br />
di una politica che, di fatto, ha trasferito le tasse dei cittadini verso il finanziamento dell’istruzione<br />
di coloro che – poi – sarebbero diventati remunerati dipendenti in settori a dinamica nulla in termini<br />
di produttività.<br />
La qualità del capitale umano e le sue determinanti<br />
Come abbiamo visto, politiche che mirino genericamente all’accrescimento dei livelli d’istruzione e di<br />
formazione non sono sufficienti se avvengono in contesti e in strutture istituzionali/economiche che<br />
non consentono di sfruttare il potenziale produttivo del capitale umano.<br />
Vi è tuttavia un secondo elemento, non meno importante, quello della «qualità» del capitale umano<br />
(misurata in termini di apprendimenti e abilità). Un anno di scolarità infatti può avere un valore enormemente<br />
differente in termini di apprendimento a seconda di fattori quali l’istituzione erogante e il<br />
contesto sociale in cui è inserita, i servizi forniti, i docenti, il clima stesso che si respira all’interno<br />
delle classi.<br />
Seguendo tali considerazioni, uno dei filoni di studio relativamente nuovi del capitale umano, l’Accountability<br />
Theory, mira a valutare quali condizioni (fattori istituzionali, politici, sociali) sono associate a<br />
un’elevata «qualità di capitale umano» di una nazione, spostando l’attenzione non sulla quantità di capitale<br />
umano ma sulla sua effettiva qualità, misurata dagli apprendimenti degli studenti delle scuole superiori<br />
nelle discipline fondamentali, matematica, lingua e scienze (in indagini campionarie – PISA,<br />
30
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
TIMSS – standardizzate tra i vari paesi), ritenute un buon paradigma dell’apprendimento in generale.<br />
Il principale risultato che emerge è che i tassi di sviluppo economico dei diversi paesi sono fortemente<br />
correlati con la qualità del capitale umano (Hanushek, 2001), giustificando dunque l’ipotersi che misurare<br />
la qualità del capitale umano prodotto in un paese è cosa differente dalla pura contabilizzazione<br />
della quantità di istruzione.<br />
Tra le variabili che significativamente influenzano la qualità del capitale umano prodotto (via processi<br />
di scolarizzazione) in una nazione spicca quella relativo alla qualità, alla capacità e alla motivazione degli<br />
insegnanti. Le politiche pensate per la crescita di capitale umano dovrebbero andare, innanzitutto,<br />
nella direzione di «educare» e preparare il corpo docente.<br />
L’importanza dell’apertura commerciale<br />
Un terzo fattore che incide fortemente sul valore del capitale umano è il grado di apertura dell’economia<br />
al commercio internazionale.<br />
L’apertura al commercio internazionale ha come esito quello di rendere più produttiva la forza lavoro<br />
istruita, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in primo luogo perché la produzione per mercati internazionali<br />
coincide con l’utilizzo di tecnologie più avanzate che richiedono abilità lavorative che implicano<br />
una più elevata istruzione. Inoltre, mercati più ampi consentono di remunerare meglio il capitale<br />
umano, creando così incentivi all’investimento in tale direzione. L’apertura agli scambi internazionali<br />
da parte dei paesi in via di sviluppo facilita il trasferimento di tecnologie, l’aumento della produttività<br />
dei fattori per effetto delle economie di scala derivanti dall’allargamento dei mercati, il miglioramento<br />
dell’efficienza dell’organizzazione economica.<br />
Vi sono critici della globalizzazione (intesa qui come sinonimo di apertura commerciale) che, anche<br />
con ragioni, affermano che l’accettazione indiscriminata della pura apertura commerciale da parte di<br />
paesi con strutture fragili (tecnologie, tasso d’accumulazione, produttività del lavoro non appropriati)<br />
non è favorevole all’aumento del benessere e delle condizioni di vita. Come è noto, in tutti i processi<br />
di cambiamento – e l’apertura al commercio internazionale è un tale caso –, c’è chi immediatamente<br />
guadagna e chi perde. Recenti rapporti della Banca Mondiale mostrano che il processo di integrazione<br />
internazionale negli ultimi anni si è associato a un aumento dell’ineguaglianza interna in taluni paesi in<br />
via di sviluppo (la Cina è il caso più evidente). Tuttavia, molte analisi affermano che a questo tipo di<br />
costi si contrappongono benefici di maggiore crescita per i paesi che sono capaci di accettare la sfida<br />
dell’apertura commerciale. Le considerazioni avanzate fanno emergere una visione complessa del ruolo<br />
della globalizzazione come processo che, se da un lato può favorire il trasferimento di tecnologie<br />
dalle economie ricche a quelle arretrate, dall’altro può causare anche flussi di forza lavoro qualificata<br />
in direzione contraria. Il dibattito è aperto. Certamente, dal punto di vista che qui ci interessa una posizione<br />
chiusa e la mancanza di capacità di dialogo e competizione sui mercati internazionali hanno effetti<br />
deleteri sulle scelte individuali e sociali quanto alla crescita del capitale umano.<br />
31
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
CAPITALE UMANO E SVILUPPO<br />
Le considerazioni addotte evidenziano che, specialmente nelle economie arretrate, la disponibilità di<br />
una massa critica di forza lavoro istruita è solo una pre-condizione perché il processo virtuoso che lega<br />
capitale umano a crescita e riduzione della povertà possa verificarsi.<br />
Per fare in modo che la formazione e l’accumulazione del capitale umano contribuiscano all’aumento<br />
della produttività del lavoratore e alla riduzione della disuguaglianza dei redditi, favorendo infine un clima<br />
di pace sociale, occorre un investimento in capitale umano non genericamente inteso, ma qualificato,<br />
contestualizzato in settori ad alto valore aggiunto e affiancato al potenziamento di infrastrutture<br />
adatte a recepirlo. In secondo luogo, non va sottovalutata l’importanza del contesto socio-politico entro<br />
cui tale processo di investimento si attua. È auspicabile un contesto che possa valorizzare il capitale<br />
umano e favorire attività di ricerca e sviluppo rendendole più appetibili per i giovani talenti, prevedendo<br />
una struttura di incentivi in grado di orientare gli investimenti in capitale umano verso attività imprenditoriali<br />
innovative e verso quei settori dove il contributo alla crescita è maggiore. Infine occorre<br />
scoraggiare nello stesso tempo le attività che tendono al conseguimento di rendite e al mantenimento<br />
di privilegi.<br />
Questo rinnovato clima sociale aperto allo sviluppo non deve essere limitato esclusivamente alle attività<br />
imprenditoriali, al mondo produttivo o della ricerca, ma dovrebbe essere esteso anche a contesti<br />
come la qualità della pubblica amministrazione e la scuola, attraverso politiche e atteggiamenti che diano<br />
maggiore riconoscimento «sociale» (ed economico) a chi (scuole, insegnanti, dirigenti) si fa carico<br />
di progetti che vadano nella direzione della creazione di capitale umano di qualità.<br />
UNA DEFINIZIONE ALLARGATA DI CAPITALE UMANO<br />
L’idea di capitale umano più diffusa e condivisa nei rapporti della Commissione Europea si riferisce al<br />
potenziale di produttività di un individuo, al suo stato di salute e di benessere come elementi che contribuiscono<br />
alla produttività della forza lavoro. Tuttavia, anche in seno agli organismi internazionali si<br />
sta affermando un concetto di capitale umano più ampio, meno legato al binomio scolarità-crescita<br />
economica.<br />
Alla fine degli anni Novanta, il presidente della Commissione Europea Jacques Delors, che aveva chiuso<br />
la sua presidenza nel 1994 con il Libro Bianco sull’occupazione, argomentava che l’educazione formale<br />
sembrava aver perso legittimità nel mondo occidentale non solo in relazione all’esistenza di un<br />
sapere diffuso, disponibile attraverso i media e i computer, ma anche in relazione a una situazione nella<br />
quale l’istruzione non produceva necessariamente occupazione. Lo stesso Delors, presidente della<br />
Commissione incaricata della stesura del rapporto UNESCO ultimato nel 1996 e avente l’obiettivo di<br />
identificare quale progetto educativo potesse rispondere al modello di sviluppo che si andava affer-<br />
32
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
mando a livello planetario, indicava che, ai consueti due pilastri dell’educazione (imparare a conoscere,<br />
imparare a fare) se ne dovessero considerare altri due, di cui uno poteva essere riassunto nella formula<br />
«educare ad essere» (il quarto pilastro riguardava «educare a vivere insieme»), elevando così il concetto<br />
di capitale umano a un’accezione più ampia, legata alla crescita della personalità nel suo complesso.<br />
In tal senso il capitale umano perde la sua connotazione strumentale-tecnica, che identifica la persona<br />
come risorsa produttiva funzionale alla produzione, e diviene esso stesso lo scopo di ogni processo<br />
umano: ha un valore oggettivo che svela la scoperta del valore di ciascuna persona 5 .<br />
IL CAPITALE UMANO INTANGIBILE: IL DESIDERIO<br />
L’enfasi posta sui concetti di «educare ad essere» e di «collocare le persone al centro dello sviluppo»<br />
sottende indirettamente un aspetto immateriale, non misurabile, ma non per questo meno reale, del capitale<br />
umano.<br />
Questo capitale umano immateriale è il desiderio che l’uomo ha di verità, di giustizia e di bellezza e ha<br />
riflessi non solo sulla vita personale, ma anche sulla vita sociale. Molti economisti, tra cui anche il premio<br />
Nobel Arrow, sostengono che il raggiungimento di un «massimo sociale» non può che essere basato<br />
su valori condivisi che rispecchiano tutti i desideri degli individui, compresi gli importanti desideri<br />
socializzanti che sono nel cuore di ciascuno. Questo desiderio per sé e per la società permette alle<br />
persone di essere coscienti di una scoperta di sé che le rende protagoniste nella società.<br />
Questo desiderio spalancato al reale, questa gratuità volta al bene comune, sono il dinamismo costitutivo<br />
e ispiratore di tutte le forze umane e costituiscono il nous profondo e nascosto del capitale umano.<br />
Il desiderio, definito da Luigi Giussani «la scintilla con cui si accende il motore», è frutto di un processo<br />
di educazione del cuore dell’uomo da cui è stata generata in tantissimi, nella storia dei nostri paesi –<br />
in Italia, in Europa – una capacità di rischio, un senso di solidarietà, entusiasmo e intelligenza di creatività<br />
sociale che sono sotto gli occhi di tutti.<br />
Ne sono esempio moltissime realtà educative, associative, caritative, tra le quali possiamo citare associazioni<br />
non-profit impegnate nell’ambito dei progetti di aiuto ai paesi poveri, che continuano una tradizione<br />
di carità che ha avuto già nei passati millenni tantissime espressioni e incarnano quotidianamente<br />
quella che, secondo una felice espressione, Giovanni Paolo II definiva «una nuova fantasia della<br />
carità, […] cioè forme nuove di solidarietà, a livello bilaterale e multilaterale che si dispieghino non<br />
tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre,<br />
così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione»<br />
(Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001).<br />
33
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Becker G. (1962), «Investment in Human Capital: a Theoretical Analysis», The Journal of Political Economy,<br />
70, 5.<br />
Chen S., Ravallion M. (2004), «How Have the World’s Poorest Fared Since the Early 1980s», Policy Research<br />
Working Paper, 3341, World Bank, Washington, D.C.<br />
Coleman J. (1988), «Social Capital in the Creation of Human Capital», American Journal of Sociology, 94,<br />
pp. 95-120.<br />
Hanushek E.A.(2001),«Deconstructing RAND»,Education Next,www.educationnext.org/2001sp/65.html.<br />
Lucas R.E. (1992), «Making a Miracle», Econometrica, Vol. 61(2), pp. 251-272.<br />
Mincer J. (1958), «Investment in Human Capital and Personal Income Distribution», Journal of Political<br />
Economy, 66, pp. 281-302.<br />
Mincer J. (1974), Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New<br />
York.<br />
OECD (1998), Human Capital Investment. An International Comparison, UNESCO Press, Paris.<br />
Pritchett L. (1995), «Where Has All the Education Gone», World Bank working paper, n. 1581.<br />
Psacharopoulos G. (1985), «Returns to Education: A Further International Update and Implications»,<br />
The Journal of Human Resources, Vol. 20, N. 4, Autumn, pp. 583-604.<br />
Unione Europea (2004), DG Regio, Third Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications<br />
of the European Communities, Luxembourg.<br />
NOTE<br />
1<br />
La Strategia di Lisbona, sviluppata nel corso di diversi consigli europei successivi a quello di Lisbona,<br />
si fonda su tre pilastri. In particolare il pilastro economico si riferisce alla transizione verso un’economia<br />
competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza. L’accento è posto sulla necessità di adattarsi<br />
continuamente alle evoluzioni della società dell’informazione e sulle iniziative da incoraggiare in<br />
materia di ricerca e di sviluppo.<br />
2<br />
In questo ambito si noti che una delle dimensioni di maggiore incertezza circa la misurazione del<br />
capitale umano consiste nella possibilità, da un lato, di misurare lo stock di capitale umano in un deter-<br />
34
CAPITALE UMANO E CRESCITA ECONOMICA. TEORIE, EVIDENZE E CONDIZIONI<br />
minato istante temporale e dall’altro di valutare l’incremento relativo tra due istanti consecutivi (riferiti<br />
a due differenti coorti di popolazioni).<br />
3<br />
Sebbene la relazione fra il livello di capitale umano e livello del PIL pro-capite sia sempre positiva<br />
e statisticamente significativa, meno chiare appaiono le evidenze empiriche sulla relazione fra accumulazione<br />
di capitale umano e tassi di crescita dei prodotti nazionali lordi o pro-capite. La differenza fra<br />
le due relazioni ha portato a domandarsi quale sia la relazione di causalità: è il capitale umano accumulato<br />
che favorisce la crescita o è la crescita che favorisce l’accumulazione di capitale umano<br />
4<br />
Un altro esempio (stavolta riferito allo stock di scolarità e non alla crescita relativa nel periodo considerato)<br />
è quello dei paesi dell’Est europeo che, a fronte di livelli d’istruzione molto più alti di quelli<br />
delle regioni del Sud Europa negli anni Ottanta, hanno evidenziato una crescita del prodotto nazionale<br />
pro-lavoratore inferiore della metà.<br />
5<br />
Anche nel dibattito sulla formulazione di politiche volte a favorire lo sviluppo dei paesi poveri negli<br />
organismi istituzionali di cooperazione internazionale è recentemente emerso che troppo spesso è<br />
stata posta eccessiva enfasi sul concetto di crescita economica, identificandola come sviluppo, trascurando<br />
invece aspetti e conseguenze sociali dello sviluppo. Il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni<br />
Unite (UNDP) si propone di seguire un approccio che «colloca le persone al centro dello sviluppo»,<br />
intendendo che il vero obiettivo dello sviluppo dovrebbe essere quello di creare un ambiente in grado<br />
di consentire una vita più lunga, sana e creativa.<br />
35
L’EDUCAZIONE<br />
È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
di Giuseppe Folloni e Gabriella Beroffa<br />
DIVERSE TRAIETTORIE<br />
Alla fine del ventesimo secolo 34 paesi (Europa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti,<br />
Canada e Giappone), comprendenti il 14% della popolazione mondiale, producevano più<br />
della metà del PIL mondiale (53%) 1 .<br />
Un secondo gruppo di paesi, che alcuni chiamano «Asia in rinascita» (Cina, Hong Kong, Malaysia, Singapore,<br />
Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, India, in particolare), ha conosciuto negli ultimi decenni<br />
una forte crescita, anche se molti dei paesi che lo compongono sono ancora ad un livello basso di PIL<br />
pro-capite (fra questi le due nazioni più grandi, Cina e India). Essi rappresentano oltre la metà della popolazione<br />
mondiale (51%) e producono circa un quarto del prodotto complessivo mondiale.<br />
Per quanto riguarda le altre regioni del mondo, si evidenziano traiettorie diverse, ma nessun gruppo di<br />
paesi ha mostrato una crescita robusta.<br />
Nell’ultimo trentennio la crescita è stata molto bassa per i paesi dell’America Latina (meno dell’1% annuo)<br />
e gli altri paesi asiatici (0,5% annuo); è stata negativa per le economie in transizione (che non hanno<br />
ancora recuperato la forte diminuzione del prodotto nazionale legata ai cambiamenti politico-istituzionali<br />
degli anni Novanta); infine la variazione del PIL pro-capite è sostanzialmente nulla per i paesi<br />
dell’Africa sub-sahariana (0,01% annuo).<br />
Queste differenti traiettorie di sviluppo fra paesi hanno fatto sì che l’ineguaglianza fra le diverse società<br />
sia aumentata. Nel 1820 la grande parte dell’ineguaglianza a livello mondiale era spiegata da differenze<br />
(fra ricchi e poveri) «interne» ai singoli paesi; attualmente gran parte dall’ineguaglianza è spiegata<br />
da differenze «fra i paesi» e solo una quota minore da differenze interne agli stessi 2 .<br />
L’esistenza di diversi sentieri di crescita nelle differenti regioni ha acceso un forte dibattito sulle determinanti<br />
della crescita. Ha anche posto dei dubbi sull’efficacia degli aiuti internazionali concessi ai paesi<br />
meno sviluppati. Vi sono paesi che hanno ricevuto aiuti internazionali pari a diversi punti percentuali<br />
del PIL ogni anno e che non hanno conosciuto alcuna dinamica di crescita. Perché<br />
È interessante ripercorrere, anche se sommariamente, tale dibattito, le conclusioni a cui esso è giunto<br />
e le domande che ancora restano aperte e senza convincente risposta.<br />
FINANZIARE L’INVESTIMENTO IN CAPITALE FISICO<br />
Le due grandi idee che hanno dominato per decenni il dibattito sull’uso delle risorse internazionali per<br />
l’aiuto allo sviluppo si possono sintetizzare nel modo seguente:<br />
37
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
1. Lo sviluppo presuppone la crescita economica. Aiutando un paese a svilupparsi economicamente, se ne aiuta<br />
lo sviluppo. Che cosa debba intendersi per sviluppo è ancora da chiarire; tuttavia, qualunque cosa<br />
si voglia indicare con questa parola (prospettive di salute e condizioni di vita migliori per tutti, un sistema<br />
politico più libero e democratico, istituzioni capaci di coinvolgere attivamente gran parte della<br />
popolazione in processi di cambiamento ecc. – si veda su questo l’intervento di Colombo in questo<br />
stesso volume), l’idea forte era che la crescita economica avrebbe «trascinato» con sé lo sviluppo.<br />
2. La crescita economica è guidata dall’investimento in capitale fisico e umano. L’investimento, poi, dipende<br />
dalla capacità di risparmio di un paese. Se questa capacità manca, l’aiuto internazionale può supplire<br />
ad essa fino a quando, avviata la crescita, anche la capacità di risparmio aumenterà e ogni paese<br />
sarà capace di camminare sulle proprie gambe. L’idea di una forte relazione fra risparmio (o il suo<br />
sostituto, l’aiuto), l’investimento e la crescita si appoggia su modelli teorici largamente condivisi.<br />
Di fatto, se si cerca di verificare empiricamente la relazione fra le dimensioni indicate (aiuto, investimento<br />
e crescita), si trovano risultati ambigui e non concludenti: le analisi non permettono di confermare<br />
quanto suggerito dalla teoria. Molto spesso la relazione fra aiuti e crescita è nulla (o persino negativa).<br />
Perché Le ragioni sono diverse. Spesso gli aiuti spiazzano il risparmio (i governi e le amministrazioni,<br />
ad esempio, sapendo che riceveranno aiuti, aumentano le spese correnti e con ciò diminuisce la quota<br />
risparmiata del PIL al netto degli aiuti) per cui non è detto che a maggiori aiuti corrispondano maggiori<br />
investimenti. In altri termini, gli aiuti possono suggerire (ai diversi attori, gli stati e le amministrazioni<br />
in primis) comportamenti sbagliati, che annullano l’effetto delle risorse aggiuntive. A volte tali comportamenti<br />
possono anche essere giustificati: di fronte a catastrofi naturali viene spontaneo «spostare»<br />
risorse per rispondere alle urgenze che si generano. Tuttavia, simili «spostamenti di risorse» (che la letteratura<br />
chiama fungibilità degli aiuti) avvengono molto spesso anche senza ragioni evidenti come<br />
quella citata. Inoltre, dal punto di vista che qui interessa, l’effetto di simili comportamenti è quello di<br />
annullare l’efficacia diretta degli aiuti sulla crescita.<br />
Anche la presenza di forme di corruzione, una burocrazia inefficiente, un sistema istituzionale non<br />
adeguato sono fattori che contribuiscono ad abbattere l’efficacia degli aiuti per la crescita. Proprio perché<br />
i comportamenti delle amministrazioni pubbliche sono decisivi nel definire l’efficacia degli aiuti<br />
ufficiali, che passano in gran parte dalle loro mani, negli ultimi decenni si è insistito continuamente sulla<br />
necessità di orientare il comportamento degli stati, favorire forme di buon governo e l’eliminazione<br />
della corruzione e di comportamenti basati su bad policies. Le politiche di aiuto condizionale attuate dalle<br />
istituzioni internazionali negli anni Ottanta e Novanta sono nate dall’idea di «controllare» il comportamento<br />
dei governi.<br />
Ma le cause della mancata efficacia possono addebitarsi anche ad altri attori, ad esempio i gruppi sociali<br />
o le etnie.<br />
38
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
Forme di polarizzazione sociale o di frazionamento etnico generano comportamenti redistributivi: le<br />
priorità di un paese non vengono definite sulla base di un principio di bene comune, ma si attuano pressioni<br />
affinché le risorse vengano distribuite fra i diversi gruppi sociali per mantenere il bilancio delle<br />
forze fra le diverse componenti. È evidente che spesso chi è al potere ha interesse a cedere a simili pressioni<br />
per garantire stabilità al sistema (e quindi al proprio potere). Oppure, viceversa, il ceto al potere<br />
distribuisce in maniera ineguale le risorse e in tal modo accentua la polarizzazione sociale e le potenziali<br />
forme di conflitto.<br />
L’effetto negativo di simili comportamenti non si ferma alle conseguenze dirette prima accennate, perché<br />
induce comportamenti non favorevoli alla crescita anche in altri attori. Se un ceto burocratico è<br />
corrotto e ha un comportamento orientato alla ricerca di rendite di posizione, gli altri attori saranno<br />
indotti a fare scelte inefficienti pur di sottrarsi alla «spoliazione» da parte della burocrazia. Se, ad esempio,<br />
la decisione di passare a coltivazioni orientate al mercato (in sé più redditizie e con un maggiore<br />
potenziale di crescita nel tempo) abbandonando forme di agricoltura di sussistenza mette i contadini<br />
nelle mani di burocrati che chiedono il «pizzo» e rendono difficile la vita, i contadini sceglieranno di<br />
continuare un’agricoltura di sussistenza non interessante per chi cerca rendite e quindi non sottoposta<br />
a controllo, inchiodando però le aree rurali di molti paesi a condizioni di marginalità e povertà. È un<br />
esempio di trappola della povertà generata dalle caratteristiche del contesto istituzionale: tutto il sistema<br />
viene «bloccato» in un equilibrio di basso livello, di mancato sviluppo 3 .<br />
Simili trappole di povertà sono molto diffuse e possono annullare l’efficacia di determinati progetti o,<br />
a livello aggregato, di intere politiche. Il caso precedente relativo alle scelte dei prodotti da coltivare è<br />
un esempio di comportamento che può portare al fallimento di politiche di crescita in ambiente rurale.<br />
A livello di progetto è noto, a chi opera nell’ambito della cooperazione internazionale, che possono<br />
accadere fenomeni non cooperativi che conducono a situazioni non efficienti: una volta assicurate le<br />
risorse per il progetto, gli attori tendono a minimizzare gli sforzi o le possibilità di essere sanzionati.<br />
Per quanto riguarda il comportamento delle ONG, ad esempio, si risponde agli obiettivi «formali» del<br />
progetto, perché questo è ciò che importa per avere un buon rapporto con i finanziatori, ma non si fa<br />
lo sforzo ulteriore di incontrare veramente la gente e concordare con essa il cammino comune del progetto.<br />
La gente si mette in moto per la speranza suscitata da un incontro: se questo incontro non c’è,<br />
se non si genera un soggetto «diverso», l’efficacia del progetto è molto bassa: si costruiscono muri o<br />
strade, ma non cambia la posizione della gente. Senza un incontro, inoltre, gli stessi beneficiari facilmente<br />
rimangono in una posizione rivendicativa: chiedono (e la lista di bisogni è potenzialmente infinita)<br />
e pretendono, ma non si mettono in moto veramente.<br />
39
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
INVESTIRE IN CAPITALE UMANO. COSA SIGNIFICA<br />
L’altra grande politica legata agli aiuti, accanto all’investimento in capitale fisico, è coincisa con l’nvestimento<br />
in capitale umano, attraverso massicce forme di scolarizzazione. Il «capitale umano» di per sé<br />
non coincide con la semplice scolarizzazione: ha diverse altre dimensioni (sulle definizioni di capitale<br />
umano si veda l’intervento di Piergiorgio Lovaglio in questo stesso volume). Le abilità cognitive hanno<br />
genesi diverse, non derivano solo dall’istruzione formale, ma anche da percorsi di esperienza non<br />
scolastici: la famiglia e il tipo di educazione in essa, il contesto sociale in cui si cresce, l’esperienza lavorativa<br />
contribuiscono a definire il rapporto con la realtà sociale anche nei suoi aspetti economicamente<br />
rilevanti (la concezione del lavoro, ad esempio). Le differenze nelle abilità possono essere innate, tuttavia<br />
gli aspetti sociali, familiari e di qualità del sistema scolastico sono spesso decisivi nel definire in<br />
media le abilità individuali e, sinteticamente, il tipo di comportamento e di assetto nei confronti dei dati<br />
di realtà (lavoro, legami sociali ecc.); ne segue che una corretta misura del capitale umano dovrebbe<br />
opportunamente misurare tali dimensioni.<br />
Tuttavia, in letteratura, spesso si identifica il capitale umano con il livello di studi raggiunto (in quantità)<br />
e con la qualità di esso. Nel presente paragrafo commenteremo la relazione fra capitale umano e<br />
crescita secondo questa ridotta definizione di capitale umano.<br />
Ci sono almeno tre meccanismi attraverso cui l’istruzione (considerata come dimensione rilevante del<br />
capitale umano) incide sulla crescita.<br />
Innanzitutto l’istruzione, aumentando le abilità individuali, permette un aumento di produttività del<br />
lavoro e questo si riflette sulla crescita del paese.<br />
Inoltre, elevati e diffusi livelli di istruzione favoriscono la capacità innovativa di un’economia nel suo<br />
complesso (e quindi dinamiche di crescita migliori).<br />
Infine, l’istruzione facilita la diffusione di conoscenze necessarie a comprendere i nuovi processi e le<br />
nuove tecnologie e – anche per tale via – favorisce la crescita.<br />
L’istruzione è certamente un fattore importante per la crescita: non esiste paese sviluppato senza un<br />
elevato livello medio di istruzione. Esistono tuttavia paesi che hanno investito pesantemente nella scolarizzazione<br />
senza ottenere risultati. Gli investimenti in scolarizzazione di molti paesi poveri, spesso<br />
sulla base di aiuti internazionali, hanno dato risultati controversi e non sembrano aver inciso sulle dinamiche<br />
di crescita. L’Africa, uno dei continenti in cui lo sforzo di scolarizzazione negli ultimi trenta<br />
anni è stato fra i maggiori, ha avuto tassi di crescita nulli.<br />
I risultati delle ricerche empiriche confermano solo in maniera parziale e debole le ipotesi avanzate sulla<br />
relazione fra livello di istruzione e crescita.<br />
Qui occorre distinguere fra effetti a livello individuale ed effetti aggregati, a livello dell’intera società e<br />
delle sue dinamiche di crescita.<br />
A livello individuale, i risultati delle indagini mettono in evidenza un impatto sostanzialmente positivo<br />
40
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
del livello di istruzione sulla retribuzione dei lavoratori, sia pure con forte variabilità dei rendimenti fra<br />
le diverse situazioni. La retribuzione del lavoro è una proxy della sua produttività e quindi è collegata<br />
positivamente con le dinamiche di crescita. Dunque, dal punto di vista delle scelte individuali, andare<br />
a scuola paga.<br />
Tuttavia, se si analizza la relazione macroeconomica fra livello medio di istruzione della forza lavoro e<br />
dinamiche di crescita del paese, l’attesa relazione positiva non emerge in modo chiaro. Le cause sono<br />
diverse 4 : la qualità del sistema scolastico, le caratteristiche del mercato del lavoro, la qualità delle istituzioni<br />
presenti nella società.<br />
Per quanto riguarda il sistema scolastico, è sotto accusa la qualità dell’istruzione, che può essere così<br />
bassa da non incrementare veramente le abilità e la produttività dell’individuo. Andare a scuola allora<br />
è un segnale di appartenenza a un determinato ceto sociale, o di un temperamento individuale più deciso<br />
e determinato (è più facile che siano gli individui con determinate capacità a investire maggiormente<br />
in istruzione), ma non ha effetti di per sé sulle abilità della gente.<br />
Perché allora nei trenta anni che abbiamo alle spalle si è speso molto in scolarizzazione spesso di bassa<br />
qualità, se questa non paga Una possibile spiegazione è che ciò che vale politicamente sono la costruzione<br />
di scuole e l’assunzione di insegnanti, non il lavoro molto meno «visibile» di crescita della<br />
qualità scolastica. Inoltre, mentre spesso la costruzione delle scuole può essere finanziata dall’aiuto internazionale,<br />
la loro manutenzione e la formazione degli insegnanti gravano sugli sforzi locali, che<br />
spesso sono intermittenti e – appunto – di bassa qualità.<br />
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’incremento dell’offerta di forza lavoro istruita, in un contesto<br />
in cui la domanda di lavoro qualificato è bassa e stagnante, può causare una riduzione delle retribuzioni;<br />
il rendimento ex-post sarà minore di quello che le aspettative ex-ante avrebbero suggerito.<br />
Un paese «bloccato» e sottratto agli stimoli del progresso tecnico e dell’innovazione non avrà reale bisogno<br />
di manodopera più istruita formalmente e con maggiori capacità sul piano del lavoro. Se il mercato<br />
del lavoro non valorizza l’investimento in istruzione, la scoraggia. A Lima tanti ingegneri e letterati<br />
fanno i tassisti con retribuzioni bassissime: evidentemente costoro non saranno propensi a investire<br />
sulla scuola per i figli, se qualcosa non cambia. Una scuola di bassa qualità non invoglia a investire<br />
sull’istruzione in futuro. Per questo la politica che è stata abbracciata dalle istituzioni internazionali<br />
(finanziare nuove scuole in paesi «fermi» perché ciò li avrebbe messi in movimento) non basta. Occorre<br />
che chi ha rischiato investendo in istruzione trovi delle opportunità.<br />
È il problema della direzione di causalità: è l’aumentata istruzione che induce la crescita (come le politiche<br />
di scolarizzazione suggeriscono) o è la crescita che, richiedendo forza lavoro più skilled, induce<br />
maggior investimento in istruzione Probabilmente entrambe le direzioni causali sono vere. Ma questo<br />
significa che le politiche per il capitale umano, anche solo definito in termini di più elevata scolarità,<br />
devono essere pensate in modo diverso, più adeguato alle dinamiche della società nel complesso, e<br />
devono essere capaci di coinvolgere diversamente gli attori. Ciò è tanto più vero in quanto la questio-<br />
41
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
ne decisiva per l’effettiva crescita del capitale umano non è la pura scolarizzazione, ma l’educazione,<br />
come vedremo.<br />
L’istruzione può essere usata per scopi redistributivi e non produttivi. Se le abilità acquisite attraverso<br />
l’istruzione sono applicate ad attività non produttive, i rendimenti privati possono essere positivi e contemporaneamente<br />
l’impatto sullo sviluppo del paese può essere nullo. Il problema può essere riassunto<br />
dalla metafora dei pirati (North 1990) 5 . La scelta su come «usare» il capitale umano acquisito dipende<br />
dal contesto: in un contesto istituzionale in cui dominano ceti che vivono sulla redistribuzione e<br />
hanno bisogno di un ceto istruito che li sostenga, comportamenti che attuano forme di redistribuzione<br />
saranno facilitati. In molti paesi in via di sviluppo il settore pubblico è considerato un settore che<br />
assorbe la crescente offerta di forza lavoro istruita, rispondendo a pressioni politiche 6 . Nel contributo<br />
di Piergiorgio Lovaglio, in questo stesso volume, si ricorda come nel caso egiziano i ceti «scolarizzati»<br />
in forza delle politiche di istruzione trovarono sbocchi sostanzialmente nella pubblica amministrazione.<br />
In Egitto il settore pubblico occupava, nel 1998, il 70% di tutti i laureati e il 63% dei lavoratori con<br />
livelli medi di istruzione.<br />
Dunque, l’efficacia per la crescita dell’accumulazione di capitale umano, anche nel significato ridotto<br />
di una maggiore scolarizzazione, dipende da diversi elementi, mette in gioco una pluralità di attori e il<br />
modo in cui questi si pongono di fronte all’educazione dei più giovani. La scuola sarà «di qualità» se le<br />
famiglie e gli insegnanti sono effettivamente motivati nell’aiutare i ragazzi a vivere l’avventura scolastica.<br />
L’efficacia della scolarizzazione, poiché dipende dalle opportunità offerte sul mercato del lavoro,<br />
implica un ceto imprenditoriale attento al bene comune e capace di coinvolgere larghi strati della popolazione<br />
nelle dinamiche di cambiamento. Lo stesso si dica di un ceto politico e di una burocrazia<br />
orientate al benessere comune e non ancorate a comportamenti redistributivi. Si tratta di comportamenti<br />
e di modi di fare che sono l’esito di un’educazione. È l’educazione – non la semplice scolarizzazione<br />
– il motore dello sviluppo.<br />
COMPLESSITÀ E SPECIFICITÀ<br />
L’evidenza empirica ha messo in luce che i fattori che contribuiscono alla crescita sono numerosi e –<br />
soprattutto – che la mancanza di alcuni può inficiare il ruolo e l’apporto di altri (vi è cioè interdipendenza).<br />
In altri termini, il governo della crescita è assai più complicato di quanto non si pensasse e coinvolge<br />
diverse dimensioni. Qualsiasi modello interpretativo che pretenda di basarsi su poche determinanti<br />
non resiste alla prova dei fatti.<br />
È il tema della complessità, messo in luce da vari recenti rapporti della Banca Mondiale e di altre istituzioni.<br />
Implicato nel tema della complessità vi è quello della specificità. Molti dei fattori di contesto<br />
rilevanti per l’efficacia delle politiche sono specifici dei singoli paesi e variano fortemente fra un paese<br />
e l’altro: non esiste una ricetta «uguale per tutti» 7 . Sul piano metodologico, dall’evidenza della specifi-<br />
42
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
cità discende il principio della titolarità (ownership): sono i singoli paesi i titolari e responsabili delle proprie<br />
strategie di sviluppo; senza titolarità non vi può essere efficacia.<br />
La consapevolezza d’essere di fronte a una sfida complessa è alla base dello strumento principale che<br />
da circa un decennio le istituzioni internazionali, Banca Mondiale e Fondo Monetario, hanno proposto<br />
ai paesi non sviluppati per controllare tutti i fattori rilevanti nel definire politiche di successo per la<br />
crescita e lo sviluppo. I Poverty Reduction Strategy papers (PRSP) – cioè tale strumento – sono la raccolta ragionata<br />
delle politiche che si ritiene debbano essere adottate (sia in ambito strettamente economico sia<br />
in ambito sociale ed istituzionale) per l’efficacia delle azioni. È come un «grande piano» che non dovrebbe<br />
dimenticare nulla di quanto è rilevante.<br />
Ma i grandi piani funzionano Su questo ritorneremo.<br />
Nell’incontro fra i rappresentanti di oltre 100 paesi, svoltosi a Parigi nel 2005, su come riguadagnare<br />
efficacia alle attività di cooperazione internazionale, il principio della titolarità è stato identificato come<br />
pilastro fondamentale nella ridefinizione delle politiche di aiuto 8 . L’evidenza degli insuccessi ha<br />
condotto a riconoscere che bisogna «avvicinare» le risorse alle specifiche realtà e conferirle direttamente<br />
agli attori; tuttavia, come vedremo più avanti, ci si ferma all’attore «stato» e al livello politico di gestione<br />
delle risorse, senza arrivare ad un vero approccio sussidiario.<br />
LE DETERMINANTI FONDAMENTALI DELLA CRESCITA:<br />
MA SENZA FINIRE NEL DETERMINISMO<br />
La complessità rende confusi. Un modo con cui si è cercato di affrontarla è individuare, nella numerosa<br />
lista di fattori correlati alla crescita, quelli che hanno il carattere di determinanti fondamentali (da cui<br />
gli altri cioè dipendono). È stato osservato che la mancanza di capitale umano, una tecnologia arretrata,<br />
mercati deboli e mal funzionanti (tutte «cause» di mancata crescita), sono da considerarsi cause<br />
«prossime» della crescita, ma non cause «originanti» l’incapacità a crescere. Perché infatti un paese non<br />
è stato capace di acquisire tali fattori Che cosa genera tale incapacità La risposta starebbe nella mancanza<br />
o nella debolezza delle determinanti fondamentali della crescita (si veda per una sintesi divulgativa<br />
del dibattito Acemoglu 2003).<br />
Vi sono due principali candidati al ruolo di «determinanti fondamentali», la geografia e le istituzioni. I<br />
sostenitori del determinismo geografico sono molti: e in effetti, se si guarda una mappa del mondo, si<br />
nota che gran parte dei paesi più poveri si trova nella zona equatoriale, dove il clima e il regime delle<br />
piogge non sono favorevoli a un’agricoltura sviluppata e dove la presenza di malattie diffuse genera effetti<br />
sfavorevoli sulla produttività del lavoro.<br />
Tuttavia, se il determinismo geografico fosse vero, dovremmo aspettarci che un paese con geografia<br />
sfavorevole sia stato sempre e sia ancora nella parte bassa della scala dello sviluppo; viceversa, paesi<br />
con clima favorevole dovrebbero essere stati fin dall’inizio all’avanguardia. Non è così: ci sono nume-<br />
43
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
rosi casi di «mutamenti di fortuna» (reversal of fortune): regioni e paesi un tempo sviluppati, come l’India<br />
dell’impero Mughal o il Centro America sotto gli Aztechi, sono divenuti aree molto più povere di<br />
altre. Viceversa, regioni povere come il Nord America sono divenute fra le più ricche del globo.<br />
Simili cambiamenti sono favorevoli all’altra ipotesi: che siano le istituzioni il fattore fondamentale che<br />
plasma, nel lungo periodo, le opportunità di crescita. Basta guardare a quell’«esperimento» naturale che<br />
fu la colonizzazione del mondo da parte di popoli europei a partire da cinquecento anni or sono. L’espansione<br />
europea condusse talvolta alla colonizzazione diretta, con insediamento da parte di coloni<br />
europei (in aree geograficamente adatte: con terra abbondante, popolazione indigena scarsa, assenza<br />
di agenti epidemici come la malaria o altre malattie). Qui i coloni generarono «buone istituzioni» perché<br />
le pensarono per sé, per la propria avventura umana.<br />
Si intende per buone istituzioni un sistema di difesa dei diritti di proprietà per una quota consistente<br />
della popolazione, vincoli chiari ed efficaci all’azione del ceto politico o di determinate élites (salvaguardia<br />
delle forme di democrazia e delle libertà fondamentali), un certo grado di eguaglianza nelle opportunità<br />
sociali.<br />
In altri casi (in aree non adatte all’insediamento diretto dei coloni, con presenza di malattie diffuse, terreni<br />
non adatti all’agricoltura di tipo europeo, piogge torrenziali ecc.) gli europei svilupparono istituzioni<br />
legate ad attività di piantagione o di miniera basate sulla forza lavoro indigena spesso ridotta in<br />
schiavitù; in altri termini si formarono istituzioni finalizzate all’estrazione del surplus e al mantenimento<br />
di una netta differenza fra l’élite dominante e la popolazione locale. In tali aree non ci fu sviluppo,<br />
anzi, poiché il passato largamente decide delle possibilità future di cammino, tali aree furono «bloccate»<br />
in un assetto istituzionale non favorevole ai cambiamenti e rese incapaci di cogliere le opportunità<br />
di crescita. In tali paesi, anche dopo l’indipendenza (nel XIX o XX secolo), il sistema istituzionale rimase<br />
assai spesso e in gran parte quello impostato in quel periodo.<br />
La geografia entra anche in tali vicende: sono fattori geografici quelli che stanno alla base delle decisioni<br />
iniziali di comportamento dei colonizzatori e quindi del sistema di istituzioni che è venuto instaurandosi.<br />
Si torna dunque al determinismo geografico<br />
In realtà, se ci si fermasse qui si dimenticherebbe l’elemento più importante. Quando i gesuiti iniziarono,<br />
alla fine del Cinquecento nell’attuale Bolivia e poi più compiutamente nel XVIII secolo in Paraguay,<br />
l’esperienza delle reducciones, fecero una scelta culturale precisa: la loro avventura umana e quella della<br />
gente che stavano incontrando era sentita come una stessa avventura. Non c’era una divisione tra «noi<br />
e voi», c’era un «noi»: con tutti i limiti e i difetti che qualsiasi tentativo porta con sé, ma questa posizione<br />
era chiara, e in pochi decenni generò istituzioni capaci di mettere «in movimento» la gente fino a farla<br />
diventare capace di esportare in Europa cereali, vino, strumenti musicali e bestiame. In ambienti geograficamente<br />
sfavorevoli si ebbe la stessa dinamica che emerse in aree «geograficamente adatte». Fu<br />
ancora una decisione delle potenze coloniali che, distruggendo simili esperienze, costrinse a reintrodurre<br />
la divisione fra élite dominante e popolazioni locali, fra «noi e voi». È dunque una decisione cul-<br />
44
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
turale, un giudizio sulla realtà che si incontra la causa determinante il modo con cui le istituzioni si formano<br />
e avvengono. È dunque il soggetto che viene formandosi che decide della direzione di cammino:<br />
può essere un soggetto diviso oppure unitario, può essere un incontro che costituisce un «noi» oppure<br />
una separazione fra «noi e voi». È una scelta che, dapprima come concezione personale di sé, poi<br />
anche a livello sociale, spetta sempre alla libertà di ciascuno.<br />
Chi vive l’esperienza della cooperazione internazionale e dei progetti sa benissimo che la questione decisiva<br />
è la stessa, anche a livello «micro», di singoli progetti. Costruire una scuola, con muri, materiali<br />
didattici e volontari non basta. Coinvolgere la gente nell’avventura della scuola per i propri figli, fino a<br />
farla diventare protagonista del percorso educativo dei ragazzi (e, a questo punto, del loro stesso percorso<br />
educativo: di genitori, madri e padri), è la condizione perché la scuola abbia veramente efficacia<br />
e perché la gente possa fare esperienza di un cambiamento possibile per sé, per la propria famiglia e<br />
comunità. Si genera un soggetto – dall’incontro tra persone, anche diverse – che riconosce di vivere<br />
una stessa avventura. È qui che «accade» l’originarsi dello sviluppo. I casi riportati nella seconda parte<br />
di questo libro lo documentano con impressionante semplicità ed evidenza.<br />
I GRANDI PIANI E IL LORO ATTORE: LO STATO<br />
Se la precedente posizione riguardava un tentativo di «semplificare» dal punto di vista interpretativo la<br />
complessità dei sentieri di crescita, altre proposte si propongono di superare l’ostacolo della complessità<br />
sul piano delle politiche da attuare.<br />
Nel mondo delle istituzioni internazionali e dei grandi donors (i governi dei paesi sviluppati, alcune grandi<br />
fondazioni), ad esempio, si sta imponendo come politica quella dei grandi piani contro la povertà e<br />
per la crescita.<br />
Di fronte alla complessità, la soluzione è considerare simultaneamente le diverse variabili rilevanti per<br />
la crescita e tenerle sotto controllo. Solo gli stati, allora, sono nella posizione di poterlo fare: essi quindi<br />
non solo restano, come nel passato, i partner principali nelle attività di cooperazione internazionale,<br />
ma lo divengono ancor più.<br />
È una direzione giusta o sbagliata<br />
A nostro avviso ci sono due errori in questa posizione.<br />
Il primo è che non si tiene in considerazione il fatto che quanto più una politica è complessa e, necessariamente,<br />
indiretta (cioè filtrata dal sistema di governo, amministrativo e istituzionale), tanto più è<br />
soggetta al rischio che i diversi attori (anche e in primo luogo gli attori pubblici) assumano comportamenti<br />
sbagliati: decidano cioè non secondo criteri di bene comune, ma per favorire élites o ceti specifici,<br />
generando forme di corruzione e comportamenti inefficienti. Atteggiamenti prevaricatori da parte<br />
delle élites, per catturare quote rilevanti del valore aggiunto a proprio favore, non vengono cambiati perché<br />
il «piano» sulla cui base si distribuiscono risorse è integrato, intersettoriale, con obiettivi globali e<br />
45
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
riguarda sia gli aspetti economici che i soggiacenti aspetti sociali, come richiesto dallo strumento del PRSP.<br />
Anzi, accade il contrario. La stessa complessità, in forza della quale è difficile stabile rapporti di causa<br />
ed effetto fra input e risultati, perché le ragioni di questi ultimi possono essere varie, è una tentazione<br />
a «firmare» contratti impegnativi, perché un governo che non ha intenzione di onorarli può addurre<br />
motivi a propria scusa se i risultati non sono quelli attesi.<br />
Vi sono numerose evidenze che la presenza di forme di corruzione «politica» (cioè la corruzione a livello<br />
degli organi di governo: si contrappone alla corruzione amministrativa che può esistere nel sottostante<br />
ceto burocratico) abbatte l’efficacia degli aiuti che passano al filtro delle decisioni politiche e<br />
può condurre a risultati netti negativi.<br />
L’Unione Europea sta attuando da alcuni anni una politica di cooperazione internazionale che ha come<br />
principio cardine il sostegno al bilancio degli stati beneficiari, perché attuino politiche concertate,<br />
condivise e con un continuo monitoraggio dei risultati per evitare comportamenti devianti e di azzardo<br />
morale come quelli precedentemente descritti: la politica del budget support. È il tentativo di garantire<br />
stabilità e chiarezza nell’uso delle risorse concesse dai donors internazionali, educando gli attori pubblici<br />
dei paesi beneficiari a comportamenti corretti. Questo tipo di politica non pretende di attuare<br />
grandi piani, ma di usare «bene» le risorse, almeno a livello settoriale (di politiche sanitarie, ad esempio,<br />
o scolastiche), e in questo è certamente più realista dei grandi pianificatori. Tuttavia, a nostro avviso<br />
anche questa politica dimentica che la stabilità dello sviluppo si ha quando le persone e i gruppi sociali<br />
sono coinvolti in un rapporto diverso con la realtà. In tali politiche manca un coinvolgimento reale<br />
degli attori di base – una mancanza che è già stata fatta notare all’Unione e che dovrà essere corretta se<br />
si vuole giungere a modalità di utilizzo delle risorse della cooperazione veramente efficaci 9 . Le famiglie<br />
mandano i figli a scuola (sacrificando un loro potenziale immediato apporto al reddito familiare attraverso<br />
il lavoro) non innanzitutto per una politica governativa, ma per un’esperienza (che le politiche<br />
possono facilitare) che conferma che vale la pena fare tale sacrificio.<br />
Il secondo errore è appunto la mancanza di sussidiarietà. Le persone, i gruppi sociali, la società civile<br />
non vengono coinvolti: l’esperienza che la gente fa, se vige la politica dei grandi piani, è che è possibile<br />
aspettarsi qualche vantaggio da determinati comportamenti dello stato. Ne consegue un atteggiamento<br />
di dipendenza e rivendicativo che non mette veramente in moto la gente, persone e realtà sociali.<br />
L’intervento di Colombo in questo volume sottolinea alcune conseguenze negative, in termini di<br />
efficacia, di tale errore di metodo consistente nel partire da «obiettivi» e non dalle persone e dalle realtà<br />
sociali. Chi fa così pensa lo sviluppo come soluzione di problemi (ad esempio nutrizionali o sanitari)<br />
e non come educazione di persone e gruppi sociali a un atteggiamento responsabile e adeguato, da<br />
protagonista, di fronte alla realtà.<br />
46
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
EDUCAZIONE DELL’IO, FATTORE DELLO SVILUPPO<br />
Il principio del coinvolgimento della società civile, per divenire pratica effettiva dei governi dei singoli<br />
paesi, partner privilegiati nel metodo dei «grandi piani», ha bisogno di due elementi che spesso<br />
mancano.<br />
Uno è l’effettiva propensione dei governi al dialogo con la società civile. Questo si impara per esperienza,<br />
non per dichiarazione di principio: è cioè il termine di un cammino educativo degli stessi governi<br />
e delle amministrazioni.<br />
L’altro è l’esigenza di un equilibrio di strumenti e di potere fra governo e società civile. Se questo equilibrio<br />
manca, le dichiarazioni di intenti si fermano alle parole o ai documenti e non diventano esperienza<br />
quotidiana di dialogo. Non basta dunque il «controllo» dei donors sull’uso delle risorse, anche se può<br />
essere utile, perché avvenga un cammino educativo. Occorre – come alcuni dei casi che verranno presentati<br />
nel libro documentano con chiarezza – l’esperienza di un reale dialogo fra dimensione politica<br />
e società civile, che è tra l’altro l’essenza della democrazia. È il principio della partnership. Questo è da<br />
chiedere alle politiche di budget support, non solo la trasparenza contabile e amministrativa.<br />
Tuttavia, anche queste due «regole» di comportamento da sole non sono sufficienti, sarebbero «sospese<br />
sul vuoto». Occorre che la società civile sia fatta di persone consapevoli delle opportunità, attive e<br />
in cammino. Che cosa permette questo<br />
In un provocatorio articolo apparso sul Financial Times lo scorso maggio 10 , Easterly critica aspramente<br />
il paradigma dello sviluppo basato sui grandi piani che, ritiene, porta a danni enormi e a ingenti<br />
sprechi e afferma che l’unica possibilità per uno sviluppo effettivo è lasciare all’indipendenza dei molti<br />
(la gente, quelli che Easterly chiama provocatoriamente i searchers) e alla loro ricerca competitiva delle<br />
opportunità che via via si presentano il compito di trovare la strada per un uso efficiente delle risorse.<br />
Così, a mo’ di sfida, Easterly sottolinea che vi sono al mondo 7 miliardi di esperti (i singoli individui)<br />
a cui bisogna lasciare libertà d’azione. Gli stati, invece di fare grandi piani, dovrebbero garantire<br />
lo spazio per l’iniziativa.<br />
Questa posizione liberista è parziale. Come si è accennato nell’esempio dei piccoli coltivatori nelle aree<br />
rurali dei paesi in via di sviluppo, vi possono essere comportamenti dei singoli che sono bloccati in forme<br />
di auto-sussistenza e in condizioni di povertà perché il contesto non è favorevole e non si ha esperienza<br />
di un altro ragionevole e più opportuno cammino: manca l’esperienza di un percorso possibile.<br />
I movimenti dei Senza Terra in Brasile, ad esempio, restano spesso rivendicativi e quindi dipendenti<br />
dal potere politico, se non c’è l’esperienza (per un incontro, per la testimonianza di amici e conoscenti)<br />
che vi sono altre vie, più libere, più responsabilizzanti (per certi aspetti più faticose) e possibili, che<br />
rendono persone e gruppi sociali protagonisti del proprio cammino. È il costituirsi del soggetto dello<br />
sviluppo. Non basta l’iniziativa degli individui.<br />
Può essere altrettanto parziale e ideologico un approccio di tipo partecipativo come nella tradizione<br />
47
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
communitarian. Se l’approccio liberista ritiene l’individuo già «formato» e pronto a reagire agli stimoli del<br />
reale, la tradizione «partecipazionista» a volte afferma che è la comunità il soggetto già costituito: essa,<br />
che si auto-conosce, è soggetto adeguato dello sviluppo. È vero che ogni comunità umana, con le sue<br />
esperienze e la sua cultura, può sapere meglio di altri ciò di cui ha bisogno e ciò che sente consono al<br />
proprio cammino. Tuttavia, come sa chi opera in attività di cooperazione internazionale, questa conoscenza<br />
si amplia e si approfondisce nell’esperienza che si fa, può arricchirsi e inverarsi proprio nell’incontro<br />
con altri soggetti e con l’esperienza di cui questi sono tramite. In un simile incontro, lo stesso<br />
bisogno e le stesse esigenze di un individuo o di un gruppo sociale possono ritrovarsi definite meglio<br />
di quanto individui e gruppi sappiano fare da soli. La singola persona, la comunità, con le loro esperienze<br />
passate, con la loro cultura e il loro modo di fare, sono sfidati da un incontro con una tale esperienza<br />
e spalancati ad una nuova ipotesi e a un assetto più adeguato di fronte ai dati di realtà. Così, non<br />
si cancella solo un bisogno da una «lista» (in sé inesauribile) di carenze e mancanze, ma si riconosce<br />
possibile una propria mossa – sviluppo – per il bene proprio e comune.<br />
È questa l’idea di educazione, un’introduzione più piena e profonda alla realtà, nel suo significato e nel<br />
suo valore per il cammino umano. E vale sia per le comunità che sono aiutate da una politica e da un<br />
progetto, sia da chi intende attuare le azioni di aiuto. Per entrambi è l’avventura di una introduzione più<br />
adeguata al reale e al suo significato, da cui nasce l’avventura del cammino, dello sviluppo. È l’educazione<br />
– non la semplice scolarizzazione – il motore dello sviluppo.<br />
Mi ha sempre colpito il fatto che chi opera in progetti di sviluppo, in campo sanitario – un centro di<br />
nutrizione ad esempio –, se è intelligente ed «educato» nel senso detto è attento non solo a curare i piccoli<br />
(pesarli, stabilire una dieta, fornire il necessario per la stessa) ma soprattutto a dialogare con le madri<br />
perché nel cambiamento del modo di vivere e di guardare la realtà delle stesse madri (modo di abitare,<br />
igiene, rapporti con altre madri) il bisogno che esse hanno – curare i figli – si chiarisce e diventa<br />
più adeguato. È un cammino educativo che approfondisce la conoscenza dei propri stessi problemi, se<br />
chi dialoga con loro sente realmente simpatia per il loro cammino e lo condivide «a tutto campo». Come<br />
afferma il «principio» bellissimo e vero che ha sempre guidato l’attività dell’AVSI: occorre condividere<br />
a tutto campo, fino al senso della vita, perché la condivisione del bisogno sia reale e concreta e generi<br />
una mossa stabile di cambiamento, cioè sviluppo.<br />
48
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Acemoglu D. (2003), «Root Causes. A historical Approach to assessing the Role of Institutions in<br />
Economic Development», Finance & Development, June, pp. 27-30.<br />
Bourguignon F., Morrison C. (2002), «Inequality among World Citizens: 1820-1992», American Economic<br />
Review, 92, pp. 727-744.<br />
Gelb A., Knight J.B., Sabot R.H. (1991), «Public Sector Employment, Rent Seeking and Economic<br />
Growth», Economic Journal, 101, 408, pp. 1186-1199.<br />
Lavergne R., Wood J. (2006), «Aid Effectiveness and non-State partnerships: analytical considerations»,<br />
CIDA Working Papers, December.<br />
Maddison A. (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre Studies, OECD,<br />
Paris.<br />
Murphy K., Shleifer A., Vishny R. (1989), «Industrialization and the Big Push», Journal of Political Economy,<br />
97, 5, pp. 1003-1026.<br />
North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University<br />
Press, Cambridge.<br />
Pritchett L. (2001), «Where Has All the Education Gone», The World Bank Economic Review, 15, 3, pp.<br />
367-391.<br />
World Bank (2005), Economic Growth in the 1990s- Learning from a Decade of Reforms, Washington, D.C.<br />
NOTE<br />
1<br />
Dati relativi al 1998. Il riferimento è Maddison (2001).<br />
2<br />
Vedi Bourguignon e Morrison (2002), anche se altri affermano che attualmente stanno recuperando<br />
spazio le differenze di reddito interne ai paesi (disuguaglianza within) rispetto a quelle fra paesi.<br />
3<br />
Si veda a tale proposito il famoso lavoro di Murphy, Schleifer e Vishny (1989).<br />
4<br />
Vedi Pritchett (2001).<br />
5<br />
«Per essere un pirata di successo è necessario conoscere a fondo i metodi di combattimento navale,<br />
le rotte commerciali, le armi, le attrezzature e l’equipaggio delle potenziali vittime, nonché le opportunità<br />
di rivendere il bottino. Per essere un industriale di successo nel settore chimico agli inizi del<br />
secolo ventesimo negli Stati Uniti, era necessaria la conoscenza della chimica, dell’uso dei prodotti chimici<br />
nella produzione dei diversi beni intermedi e finali e dei problemi propri delle organizzazioni di<br />
49
L’EDUCAZIONE È IL MOTORE DELLO SVILUPPO<br />
larga scala. Se il sistema istituzionale di base fa dell’attività redistributiva (pirateria) l’opportunità economica<br />
preferibile, possiamo attenderci uno sviluppo molto differente delle conoscenze e delle abilità<br />
rispetto a un sistema dove è la crescita della produttività che paga economicamente (come per un<br />
imprenditore chimico del ventesimo secolo). Gli incentivi generati dal sistema istituzionale hanno un<br />
ruolo decisivo nel plasmare il tipo di abilità e conoscenze che danno migliore remunerazione» (North,<br />
1990; nostra traduzione).<br />
6<br />
Gelb, Knight e Sabot (1991).<br />
7<br />
Vedi le dichiarazioni di Gobind Nankani, vice presidente della Banca Mondiale per l’Africa, nella<br />
prefazione al rapporto della Banca su Economic Growth in the 1990s – Learning from a Decade of Reforms,<br />
del 2005.<br />
8<br />
Vedi la Paris Declaration on Aid Effectiveness, Parigi, 2005. Ad Accra in Ghana, nel settembre 2008, si<br />
è svolto l’incontro che dà continuazione alla Conferenza di Parigi del 2005, il «3 rd High Level Forum<br />
on Aid Effectiveness».<br />
9<br />
Si veda al riguardo Lavergne e Wood (2006).<br />
10<br />
W. Easterly, «Trust the development experts - all 7bn», Financial Times, May 28, 2008.<br />
50
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
di Emilio Colombo<br />
CHI SONO I POVERI<br />
Tutti noi, quando pensiamo ai paesi in via di sviluppo, pensiamo a paesi caratterizzati da un livello<br />
di PIL pro-capite relativamente basso; allo stesso modo, quando pensiamo al «povero» pensiamo<br />
a qualcuno che sia economicamente o materialmente povero, ovvero che non abbia di<br />
che sussistere. L’identificazione di sviluppo e povertà con i propri corrispettivi economici è una semplificazione<br />
a cui non riusciamo mai a sottrarci.<br />
Eppure, se ci pensiamo bene, questa semplificazione è profondamente errata.<br />
In fondo chi è il povero È chi ha un reddito basso È evidente che questa risposta non solo è parziale,<br />
ma potrebbe essere anche fuorviante.<br />
Consideriamo infatti una persona non economicamente povera che vive in un paese (si pensi ai paesi<br />
dell’Africa sub-sahariana) in cui vi sono numerose malattie infettive (si pensi alla malaria) che riducono<br />
fortemente l’aspettativa di vita alla nascita. Dovremmo considerare questa persona come povera<br />
Certamente sì, non tanto con riferimento alla propria condizione economica quanto al suo potenziale<br />
stato di salute.<br />
Oppure la stessa persona potrebbe non aver avuto alcun livello di istruzione. Anche in questo caso sarebbe<br />
povera di qualcosa di fondamentale anche se non facilmente quantificabile dal punto di vista economico 1 .<br />
Infine potremmo pensare che questa persona non economicamente povera viva in un ambiente in cui<br />
le condizioni sanitarie siano adeguate, il livello di istruzione sufficiente ma molte libertà individuali e<br />
sociali (libertà di espressione, libertà religiosa, democrazia ecc.) vengano di fatto represse. Non sarebbe<br />
difficile definire questa persona come povera!<br />
I semplici esempi di cui sopra fanno emergere due elementi fondamentali e tra loro correlati. Il primo<br />
elemento è evidente dagli esempi riportati: non possiamo analizzare il tema dello sviluppo né quello<br />
della povertà in un’ottica unidimensionale, ovvero considerando solamente l’aspetto economico, quello<br />
sanitario, quello educativo ecc. Sviluppo e povertà hanno infatti caratteristiche multidimensionali,<br />
sono fenomeni complessi che devono essere affrontati ed analizzati da molti punti di vista.<br />
COME MISURIAMO LA POVERTÀ<br />
Questo primo elemento pone immediatamente un problema pratico: come misuriamo la povertà Utilizziamo<br />
solamente indicatori di carattere economico oppure li integriamo con indicatori di altra natu-<br />
51
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
ra Il primo approccio è ancora quello maggiormente utilizzato, tanto è vero che moltissime organizzazioni<br />
e istituzioni internazionali definiscono i paesi come poveri in relazione al livello del PIL pro-capite<br />
oppure con riferimento alla quota della popolazione che vive con meno di 1 o di 2 dollari al giorno.<br />
Negli ultimi anni sono stati fatti molti tentativi per allargare la misurazione ad altri elementi: le Nazioni<br />
Unite (in particolare lo UNDP) elaborano da anni l’Indice di Sviluppo Umano calcolato come media<br />
ponderata tra PIL pro-capite, aspettativa di vita alla nascita e un indice di educazione (tasso di analfabetismo<br />
e media del livello di istruzione). Sempre le Nazioni Unite, nel 2000, con la cosiddetta «Dichiarazione<br />
del Millennio» hanno definito i Millennium Development Goals (MDG) che, se raggiunti,<br />
porterebbero una sostanziale riduzione della povertà nel mondo entro il 2015. Gli MDG definiscono<br />
una serie di indicatori raggruppati in 8 aree tematiche diverse (riduzione povertà, aumento livello di<br />
educazione, superamento delle discriminazioni di genere, riduzione mortalità infantile, miglioramento<br />
delle condizioni di salute delle donne madri, riduzione dell’incidenza delle malattie – AIDS e malaria<br />
in particolare –, miglioramento della sostenibilità ambientale, promozione della cooperazione e delle<br />
politiche per lo sviluppo). Sia l’Indice di Sviluppo Umano che gli MDG costituiscono due tentativi di<br />
dare alla misurazione della povertà e dello sviluppo caratteristiche di multidimensionalità.<br />
IL FALLIMENTO DELLA MISURA<br />
Nonostante i tentativi doverosi e interessanti volti ad allargare ed approfondire le modalità di misurazione<br />
dello sviluppo e della povertà, è immediato realizzare come essi siano destinati all’insuccesso. Qui<br />
entra in gioco il secondo elemento citato precedentemente, strettamente correlato al primo. È vero che<br />
sviluppo e povertà hanno caratteristiche multidimensionali, ma è altrettanto vero che esse non sono<br />
definibili con precisione.<br />
Possiamo dire che la povertà ha tre dimensioni: quella economica, quella educativa e quella sanitaria<br />
Probabilmente sì, ma che dire di quella politica (democrazia) E se aggiungessimo la dimensione della<br />
libertà di espressione Potremmo indicare decine e decine di diversi indicatori di sviluppo, qualitativi<br />
e quantitativi, eppure non riusciremmo a definire con precisione lo sviluppo stesso.<br />
In altri termini potremmo stilare un elenco dettagliato di tutte le dimensioni che caratterizzano il concetto<br />
di povertà e quello di sviluppo; in questo modo arriveremmo ad una definizione maggiormente<br />
completa, tuttavia mai realmente esaustiva.<br />
Perché ogni tentativo di misurare esaurientemente la povertà o lo sviluppo è destinato a fallire Senza<br />
dubbio non per mancanza di dati o di appropriate tecniche statistiche. Se ci pensiamo bene il motivo è<br />
più profondo e va alla radice stessa del concetto di sviluppo.<br />
52
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
Se andiamo alla radice del problema ci rendiamo conto che in ultima analisi la povertà e lo sviluppo<br />
hanno a che fare con i desideri della persona. Possiamo dire che ultimamente una persona è povera se<br />
non è in grado di soddisfare i propri desideri più profondi, originari e costitutivi (il desiderio di verità,<br />
di giustizia, di bellezza ecc.). Ne consegue che lo sviluppo non è una questione che riguarda solo le economie,<br />
i governi, le istituzioni internazionali o le ONG, è principalmente una questione che riguarda la<br />
persona umana che, all’interno di una trama di rapporti, si muove per soddisfare le proprie esigenze<br />
costitutive (i desideri di cui sopra). Non possiamo pensare allo sviluppo se non mettiamo la persona<br />
umana al centro e da essa partiamo.<br />
«L’uomo, nella sua singolare realtà (perché è ‘persona’), ha una propria storia della sua vita e, soprattutto,<br />
una propria storia della sua anima. L’uomo che, conformemente all’interiore apertura del suo spirito<br />
ed insieme a tanti e così diversi bisogni del suo corpo, della sua esistenza temporale, scrive questa<br />
sua storia personale mediante numerosi legami, contatti, situazioni, strutture sociali, che lo uniscono<br />
ad altri uomini, e ciò egli fa sin dal primo momento della sua esistenza sulla terra, dal momento del suo<br />
concepimento e della sua nascita» (Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, n. 14).<br />
Questo uomo è il soggetto dello sviluppo ed è a questo uomo, nella sua complessità ma soprattutto<br />
nella sua interezza, che devono essere indirizzate le politiche di sviluppo.<br />
LO SVILUPPO RIGUARDA ANCHE NOI<br />
A molti queste considerazioni potrebbero sembrare ovvie e scontate, ma in realtà le implicazioni di<br />
questo approccio sono profonde ed estremamente interessanti.<br />
La prima implicazione è che se lo sviluppo ha a che fare con i desideri della persona non può essere un<br />
problema circoscritto ai poveri (intendendo quelli economicamente poveri). È invece una questione<br />
che riguarda tutti, anche noi che viviamo in condizioni economiche favorevoli e agiate. Infatti poiché<br />
i desideri e le esigenze fondamentali sono infiniti e non pienamente realizzabili (almeno non in questa<br />
vita) siamo tutti sempre «in sviluppo». Detto in altri termini, mettere la persona umana al centro dello<br />
sviluppo significa in primo luogo riconoscere che lo sviluppo è un percorso da seguire piuttosto che<br />
un obiettivo da raggiungere. Questo riconoscimento costituisce il primo fondamentale elemento nel<br />
passaggio dalla teoria alla pratica, ovvero nella definizione ed implementazione delle azioni atte a promuovere<br />
lo sviluppo, cioè le politiche dello sviluppo.<br />
La seconda implicazione è più operativa ma altrettanto importante. La frase di Giovanni Paolo II riportata<br />
sopra suggerisce che nel declinare le politiche di sviluppo partire dalla persona non basta, occorre<br />
fare un passo in più. Si corre infatti il rischio di commettere l’errore, evidente nelle società avanzate, di<br />
confondere la persona con l’individuo singolarmente inteso e avulso dalla realtà sociale in cui è inseri-<br />
53
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
to. Le parole del Papa ci ricordano con forza che l’uomo è sì «apertura di spirito» e «bisogni» (ovvero i<br />
desideri di cui sopra) ma è anche «legami, contatti, situazioni, strutture sociali, che lo uniscono ad altri<br />
uomini». Le politiche per lo sviluppo devono soprattutto valorizzare i corpi sociali intermedi in cui la<br />
persona umana cresce, permettendole di esprimere la dimensione relazionale che la costituisce dalle<br />
fondamenta. D’altronde, se ci pensiamo bene, è stato proprio il ruolo dei corpi intermedi e in particolare<br />
della famiglia che ha permesso alle economie avanzate di svilupparsi ben prima che una errata concezione<br />
del welfare state instillasse la falsa convinzione che di essi si potesse fare a meno.<br />
LE POLITICHE DELLO SVILUPPO<br />
Le considerazioni appena effettuate relative alla misurazione delle povertà e alle difficoltà nella sua definizione<br />
possono sembrare sterili o quantomeno inutili. In fondo, si dice, è evidente che certi popoli<br />
stiano soffrendo e, al di là delle disquisizioni circa quanto stiano soffrendo (il problema della misura),<br />
è urgente intervenire per fare qualcosa. In realtà è proprio a questo livello che viene spesso compiuto<br />
l’errore più importante, perché la logica dell’interventismo finisce con il «tagliar fuori» la riflessione di<br />
fondo arrivando a commettere gravi errori di metodo. Se lo sviluppo riguarda la persona umana e i suoi<br />
desideri, le politiche per lo sviluppo, per essere realmente efficaci, devono permettere l’espressione e<br />
la realizzazione di questi desideri, aiutando le persone nel compimento del proprio percorso di sviluppo.<br />
Sino ad ora al contrario le politiche per lo sviluppo, sia quelle realizzate dai governi dei paesi interessati<br />
che quelle realizzate dalla istituzioni internazionali o dai paesi ricchi, si sono limitate a definire<br />
una lista di obiettivi da raggiungere. L’errore di metodo è sostanziale: anziché porre l’enfasi sul soggetto<br />
che intraprende il percorso di sviluppo ci si focalizza sull’obiettivo da raggiungere lasciando al soggetto<br />
un ruolo marginale. La storia degli ultimi decenni è piena di esempi di obiettivi di sviluppo mai<br />
raggiunti: ad esempio nel 1977 le Nazioni Unite avevano fissato per il 1990 il termine per l’accesso universale<br />
ad acque pulite, nel 1990 è stato invece fissato per il 2000 l’obiettivo della fornitura universale<br />
dell'istruzione primaria. Ora entrambi gli obiettivi sono parte degli MDG e sono fissati per il 2015, ma<br />
già si sa che molti paesi non riusciranno a rispettare i tempi previsti.<br />
Il caso dell’istruzione merita un piccolo inciso, anche se è l’oggetto di analisi maggiormente approfondite<br />
negli altri contributi di questo libro. Tutti sanno che istruzione e capitale umano sono un elemento<br />
cruciale per la crescita e lo sviluppo. Allo stesso modo è evidente che l’uomo ha bisogno non tanto<br />
di istruzione, intesa come insieme di nozioni, quanto di educazione, intesa come introduzione al significato<br />
della realtà. Fermarsi alla prima equivale a compiere l’errore di metodo di cui sopra, mentre se<br />
vogliamo mettere il soggetto al centro dello sviluppo è necessario disegnare le politiche che favoriscono<br />
il capitale umano, orientate alla promozione di una maggiore educazione della persona. È certamente<br />
semplice fissare obiettivi di istruzione, molto di meno se ci riferiamo all’educazione, ma è pur vero<br />
che è quest’ultima che determina in modo decisivo lo sviluppo di una società.<br />
54
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
Questo significa che non devono essere più fissati obiettivi nelle politiche di sviluppo Certamente no,<br />
essi sono un importante e utile strumento, tuttavia non possono esaurire l’orizzonte di definizione delle<br />
politiche divenendo l’unico parametro secondo il quale esse debbano essere valutate.<br />
Se infatti lo sviluppo riguarda i desideri delle persone, definire le politiche fissando obiettivi da raggiungere<br />
equivarrebbe a conoscere già la risposta ai problemi degli individui, con il rischio concreto di fare<br />
grossolani errori e di raggiungere scarsi risultati.<br />
LA SUSSIDIARIETÀ E LA SOLIDARIETÀ NELLO SVILUPPO<br />
L’esempio dei progetti che AVSI ha realizzato, alcuni dei quali sono rappresentati in questo libro, testimonia<br />
invece come è possibile ribaltare l’approccio mettendo la persona al centro dei progetti di sviluppo.<br />
L’efficienza (e quindi gli obiettivi raggiunti) è la logica conseguenza di un approccio che, proprio<br />
perché parte dalla persona, riesce ad essere più adeguato alle sue esigenze e quindi a risultare più<br />
efficiente, dato che l’uomo si muove in ultima analisi per soddisfare le proprie esigenze e i propri desideri.<br />
Nel realizzare i progetti, AVSI non fa altro che dare compimento al principio di sussidiarietà nello<br />
sviluppo.<br />
Infatti affrontare lo sviluppo come un percorso centrato sulla persona suggerisce di definire le politiche<br />
per lo sviluppo sulla base di un principio sussidiario, secondo il quale le politiche devono essere disegnate<br />
al fine di mettere la persona nelle condizioni di esprimere e di fare fruttare i propri talenti.<br />
Per tanti anni invece le politiche di sviluppo si sono fermate alla dimensione della solidarietà tralasciando<br />
quella relativa alla sussidiarietà. Le due dimensioni non sono alternative, bensì complementari. La<br />
dimensione della solidarietà è principalmente quella dei cosiddetti donatori (governi, istituzioni internazionali<br />
o semplici cittadini) che, con un atto di liberalità e di generosità, cercano di soddisfare i bisogni<br />
dei più poveri. Senza la scintilla della solidarietà non ci sarebbero le numerose iniziative che tutti<br />
conosciamo a favore dei più bisognosi. Tuttavia la solidarietà non basta, essa deve essere resa operativa<br />
per poter essere realmente efficace. Qui entra in gioco la sussidiarietà, che definisce una modalità<br />
con la quale la solidarietà è resa operativa. Non solo. Essa definisce la modalità più appropriata proprio<br />
perché parte da chi è il principale protagonista dello sviluppo, ovvero la persona.<br />
IL CASO DELL’AIUTO ALLO SVILUPPO<br />
Un chiaro esempio di come la solidarietà senza una declinazione sussidiaria comporti un approccio errato<br />
alla questione della povertà e dello sviluppo e in definitiva una chiara perdita di efficienza è costituito<br />
dagli aiuti allo sviluppo erogati ai paesi poveri.<br />
Per anni i paesi maggiormente sviluppati hanno finanziato, direttamente o indirettamente tramite le<br />
istituzioni internazionali, iniziative più o meno grandiose di aiuto allo sviluppo; tra le più recenti e no-<br />
55
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
te possiamo ricordare l’iniziativa di Gleneagle effettuata dai paesi del G8 nel 2005, l’iniziativa legata al<br />
Giubileo nel 2000 e l’iniziativa HIPC (highly indebted poor countries) avviata nel 1996 dal Fondo Monetario<br />
Internazionale e dalla Banca Mondiale per ridurre il debito ai paesi poveri.<br />
Per dare un’idea della dimensione del fenomeno, negli ultimi cinquant’anni i paesi sviluppati e le istituzioni<br />
internazionali hanno speso circa 2300 miliardi di dollari in aiuto allo sviluppo (aid). A fronte di<br />
questa considerevole cifra (si consideri che il PIL di tutto il continente africano nel 2007 è stato pari a<br />
circa 1000 miliardi di dollari) i risultati prodotti sono stati inferiori alle aspettative. Al di là dell’evidenza<br />
aneddotica sui fallimenti degli aiuti umanitari in Africa, esiste un’ampia letteratura scientifica che<br />
mostra come i flussi di aid non abbiano comportato alcun guadagno in termini di crescita da parte dei<br />
paesi riceventi. In altri termini, a livello macro l’aid non è correlato con la crescita.<br />
Come è possibile che flussi di aiuti così consistenti non abbiano portato benefici tangibili Perché allora<br />
i progetti di AVSI (e di altre organizzazioni non governative) funzionano La differenza sta largamente<br />
nell’approccio. I flussi di aiuti ufficiali non seguono un approccio sussidiario, ma tendono a trasferire<br />
i fondi direttamente ai governi dei paesi poveri saltando completamente tutti i corpi intermedi<br />
della società civile, che sono espressione concreta dei bisogni degli individui. Così da una parte i flussi<br />
di aiuto finiscono per seguire logiche spesso politiche (se i referenti sono i governi e non le persone, i<br />
donors preferiscono indirizzare i flussi di aiuto verso governi più «vicini») e dall’altra vengono indirizzati<br />
a stati in cui corruzione e clientelismo ne riducono fortemente l’efficacia.<br />
La logica sussidiaria invece ribalta completamente l’approccio: le iniziative di aiuto allo sviluppo sono<br />
costrette a confrontarsi con i protagonisti dello sviluppo stesso, le persone e la società civile. Questo<br />
confronto da una parte palesa i desideri e i bisogni delle persone facilitando così l’efficacia delle iniziative<br />
e dall’altra permette un maggiore controllo (eseguito dal basso) dell’iniziativa stessa favorendo una<br />
maggiore efficienza.<br />
Ecco spiegato perché se da una parte gli aiuti hanno una scarsa efficacia a livello macro, esiste una corposa<br />
evidenza di successi di iniziative micro.<br />
Un esempio emblematico, tra i tanti presentati nel prosieguo del libro, è quello del progetto «Ribeira<br />
Azul». L’iniziativa è un cosiddetto progetto di urban upgrading che contempla una riqualificazione urbanistica,<br />
ma anche sociale ed economica, di un’area fortemente depressa. Si può fare urban upgrading semplicemente<br />
costruendo nuove abitazioni funzionali, magari firmate da qualche architetto di grido, per<br />
la popolazione locale. L’esempio dei quartieri popolari di numerose città italiane mostra che da queste<br />
premesse non possono che nascere conseguenze disastrose.<br />
AVSI è partita invece dal presupposto che il valore della persona umana non può essere ridotto nemmeno<br />
dalle condizioni di estremo disagio e povertà come quelle riscontrate nell’area del progetto. La<br />
scommessa principale è stata dunque la valorizzazione di tutte le esperienze esistenti offerte dalla comunità<br />
locale e principalmente dai suoi corpi intermedi, che costituivano un primo tentativo di risposta<br />
ai bisogni esistenti. «Partire dalla realtà» è già di per sé un’azione educativa che testimonia come pro-<br />
56
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
prio le persone più povere e disagiate possono essere protagoniste del cambiamento. È intorno ad esse<br />
che viene costruito il percorso di sviluppo, il che permette di raggiungere una forte efficacia, ma soprattutto<br />
ne garantisce la sostenibilità nel tempo.<br />
L’IDEOLOGIA DELLE POLITICHE ALLO SVILUPPO<br />
Partire dalla persona per definire le politiche di sviluppo permette anche di evitare le derive ideologiche<br />
che spesso caratterizzano le iniziative di aiuto internazionale. Questo aspetto è curioso, dato che la<br />
comunità internazionale è sempre molto attenta (almeno sulla carta) a dare spazio a tutti senza discriminare<br />
alcuno. Prendiamo due esempi eclatanti: ad oggi, nell’Africa sub-sahariana, circa il 50% dei malati<br />
di AIDS è curato dalle cosiddette faith based organisations (organizzazioni confessionali) 2 ; allo stesso<br />
tempo queste organizzazioni sono responsabili per l’erogazione di circa il 50% dell’istruzione primaria<br />
nella stessa regione. Ovviamente le organizzazioni confessionali ricevono scarsissimi aiuti «ufficiali»<br />
da parte di governi o istituzioni internazionali, ma devono raccogliere fondi per le proprie iniziative<br />
tramite donatori privati. Il motivo è evidente: essendo queste organizzazioni confessionali, esse sono<br />
da un certo punto di vista «di parte», e non possono ricevere finanziamenti da istituzioni internazionali<br />
che sono super partes. Queste ultime infatti erogando fondi a una organizzazione cattolica potrebbero<br />
essere accusate di discriminazione nei confronti di organizzazioni di altre confessioni, e preferiscono<br />
implementare iniziative direttamente rivolte ai governi locali.<br />
Proprio per salvaguardare un atteggiamento non discriminatorio i governi e le istituzioni internazionali<br />
finiscono per assumere una posizione ideologica e discriminatoria in cui le persone discriminate<br />
sono proprio i beneficiari delle iniziative di sviluppo che hanno un trattamento sub-ottimale. L’inefficienza<br />
dell’approccio è infatti evidente: come possiamo valutare positivamente gli scarsi progressi nella<br />
lotta all’AIDS e nell’innalzamento del livello di istruzione primaria sapendo che i grandi progetti finanziati<br />
dalle istituzioni internazionali sono indirizzati solo al 50% delle persone bisognose<br />
Partire dalla persona elimina questo circolo vizioso. Non importa se chi cura il malato di AIDS sia un<br />
frate comboniano piuttosto che un missionario protestante. Ciò che importa è che il servizio risponda<br />
effettivamente a un bisogno e che sia erogato in modo adeguato. In questo modo solidarietà e sussidiarietà<br />
concorrono ad accompagnare le persone nel loro percorso di sviluppo.<br />
IL RUOLO DELLO STATO<br />
Anche in questo caso, esattamente come avviene in altri campi dell’economia, l’approccio sussidiario<br />
non riduce il ruolo del governo o delle istituzioni internazionali, anzi ne valorizza il compito. Essi non<br />
sono più infatti direttamente responsabili dell’erogazione del servizio (istruzione, sanità), ma ne divengono<br />
i controllori. Inoltre a loro viene demandato il compito di definire le linee guida in cui inserire le<br />
57
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
singole iniziative affinché il servizio erogato da organizzazioni diverse sia uniforme nel paese (si tratta<br />
di definire e far rispettare i programmi nazionali nel campo dell’istruzione e gli standard sanitari nel<br />
campo sanitario) di modo da dare a tutti un eguale trattamento e pari opportunità.<br />
L’IDEA DELLA TRAPPOLA DELLA POVERTÀ<br />
Se i flussi di aid non producono il beneficio sperato, per quale motivo essi costituiscono ancora il principale<br />
strumento di solidarietà verso i paesi poveri I motivi sono numerosi, alcuni fondati sulla teoria<br />
economica. Infatti le politiche per lo sviluppo basate su massicci afflussi di aiuti non nascono dal caso,<br />
ma hanno un chiaro fondamento teorico. Esiste una vasta letteratura che sottolinea come i paesi possano<br />
rimanere bloccati in una «trappola di povertà» che rende persistente il loro stato. Le cause della<br />
trappola della povertà sono molteplici e vanno dalla crescita della popolazione alla cattiva struttura istituzionale.<br />
Quale che sia la causa, è teoricamente possibile uscire dalla trappola della povertà con una<br />
grossa spinta (il cosiddetto big push) che indrizzi questi paesi verso un equilibrio più virtuoso. Il big push<br />
può ovviamente essere determinato o favorito da un massiccio programma di aiuti.<br />
Nonostante il fatto che teoricamente una soluzione di questo tipo sia realizzabile, in pratica non si conosce<br />
un singolo caso in cui un paese sia riuscito a emergere dalla povertà grazie agli aiuti allo sviluppo.<br />
Recentemente si sono registrati timidi segnali di cambiamento da parte delle principali istituzioni multilaterali,<br />
che hanno riconosciuto l’inefficacia delle politiche di aiuto allo sviluppo tout court.<br />
UN PRIMO CAMBIAMENTO DALL’AID ALL’AID FOR TRADE<br />
Nel mondo globalizzato in cui viviamo non potremmo mai pensare che il commercio internazionale<br />
sia un fenomeno dannoso per lo sviluppo. In effetti una delle più solide determinanti della crescita dei<br />
paesi è proprio costituita dal loro grado di apertura commerciale (misurato dal rapporto tra importazioni<br />
ed esportazioni rispetto al PIL). Tuttavia l’analisi empirica mostra un aspetto molto interessante a<br />
questo proposito: noi osserviamo una correlazione positiva tra apertura commerciale e crescita quando<br />
misuriamo l’apertura come l’esito del processo di scambio (ovvero quanto esportiamo o quanto importiamo).<br />
Se invece misuriamo l’apertura in termini di politiche adottate (misurate dal livello di tariffe<br />
e dazi doganali) la correlazione scompare. In altri termini osserviamo i paesi che commerciano di<br />
più crescere anche di più, ma non necessariamente osserviamo i paesi che liberalizzano gli scambi crescere<br />
di più. Queste semplice evidenza empirica suggerisce che il commercio è un potente motore di<br />
sviluppo ma la liberalizzazione di per sé non è sufficiente, occorre implementare le politiche affinché<br />
i paesi che hanno liberalizzato gli scambi commerciali possano effettivamente commerciare di più. Il<br />
caso dell’Africa sub-sahariana è emblematico: i paesi di quest’area, tra i più poveri al mondo, hanno di<br />
fatto un accesso duty-free (ovvero privo di dazi) nei confronti del mercato europeo e americano, in vir-<br />
58
POVERTÀ, SVILUPPO E DESIDERI<br />
tù di un trattamento di favore che Stati Uniti ed UE offrono ai paesi poveri. Tuttavia, nonostante questo<br />
vantaggio commerciale, questi paesi riescono ad esportare nei nostri mercati ben pochi beni. Possiamo<br />
paragonare il conferimento dell’accesso duty-free ai propri mercati da parte dei paesi ricchi come<br />
una sorta di aiuto allo sviluppo. Che di per sé non è sufficiente. Occorre che nella fattispecie i paesi africani<br />
siano messi nelle condizioni di sfruttare l’opportunità che viene loro concessa dalle preferenze<br />
commerciali. Nel dicembre 2005 alla conferenza interministeriale di Hong Kong è stato istituito un<br />
programma di lavoro sotto la supervisione del WTO chiamato Aid for trade, finalizzato ad orientare i flussi<br />
di aiuti ai paesi poveri verso quelle attività ed iniziative che possano favorire lo sviluppo del commercio<br />
(ad esempio costruzione di porti, della rete dei trasporti ecc.). Questo costituisce un primo tentativo<br />
di finalizzare gli aiuti allo sviluppo verso iniziative che mettano le persone e le istituzioni nelle condizioni<br />
di giocare i propri talenti e le proprie capacità, e, in ultima analisi, la propria libertà.<br />
NOTE<br />
1<br />
Peraltro, come sottolineato dagli altri contributi in questo libro, il capitale umano ha implicazioni<br />
formidabili per lo sviluppo di un paese.<br />
2<br />
Il termine faith based organisation è assolutamente generico e racchiude iniziative di varie confessioni,<br />
anche se, almeno per quanto riguarda il continente africano, sono per la maggioranza cattoliche.<br />
59
ESPERIENZE
PRIMA LE DONNE E I BAMBINI
PRIMA LE DONNE E I BAMBINI<br />
Se non ci fossero le donne... qui tutto poggia su di loro. Per chi frequenta<br />
realtà e società del mondo povero è un’esperienza<br />
abituale riconoscere questo dato di fatto: alla precarietà maschile<br />
si oppone la stabilità femminile. Gli uomini lavorano poco<br />
(se lavorano), sono infedeli, fanno la guerra, si abbandonano all’alcol<br />
e alla violenza, fanno figli senza assumersene la responsabilità,<br />
e infine fuggono, con la mente anche se non lo fanno con il<br />
corpo. Tocca alle donne riempire il vuoto lasciato da uomini fragili.<br />
Curando la microeconomia domestica, badando ai figli, garantendo<br />
un ordine nella giornata familiare. Spesso è la genealogia<br />
delle mamme ad assicurare la piattaforma vitale. Nonne e bisnonne<br />
in età ancora attiva vivono circondate da figli e nipoti,<br />
contribuiscono al reddito familiare, cucinano e puliscono, mantengono<br />
i legami con la comunità.<br />
Tutto ciò si acuisce quando scoppiano le crisi: guerra, epidemie,<br />
carestie costringono le donne a un impegno ancora più grande, a<br />
una responsabilità ancora più incessante. Nei campi degli sfollati<br />
acholi del Nord Uganda la situazione più normale vedeva gli uomini<br />
giocare e bere all’ombra degli alberi e le donne e i bambini in<br />
fila davanti alle pompe d’acqua e in coda per gli aiuti alimentari. In<br />
un progetto AVSI sulle mine antiuomo che prevedeva la «tournée»<br />
di una compagnia teatrale dilettante nei campi dei rifugiati per allestire<br />
piccole pièces di vita quotidiana, il momento forte era lo<br />
scontro tra nonna e nonno, sempre risolto a favore della prima: un<br />
uomo dai capelli appena imbiancati ma tanto indolente e poco lucido<br />
per via delle gran bevute veniva coperto di contumelie tra il<br />
finto compatimento dei nipoti. Scena che strappava entusiastici<br />
applausi da parte di tutto il pubblico, femminile, maschile e infantile,<br />
poiché tutti vi si specchiavano.<br />
Nel caso dell’Uganda poi, come si vedrà nelle pagine successive,<br />
occorre parlare di una doppia vulnerabilità delle donne, dovuta al<br />
concatenarsi di guerra al Nord e diffusione dell’AIDS in tutto il<br />
paese. Si possono facilmente immaginare i fattori di questo fenomeno,<br />
con soldati regolari e miliziani della guerriglia come primi<br />
agenti del dilagare dell’epidemia.<br />
Se tante volte la distruzione del tessuto sociale dipende dagli uomini,<br />
la sua tenuta dipende dalle donne; e ciò è ancora più vero<br />
nelle situazioni estreme. Questo fa capire l’importanza dei progetti<br />
centrati sull’aiuto alle donne in una logica che le veda trasformarsi<br />
da oggetti (della violenza, delle malattie, dell’abbandono) in<br />
soggetti (della vita quotidiana, della salute, del benessere dei figli).<br />
È l’esperienza di Novosibirsk, nel cuore del deserto siberiano.<br />
Qui non si parla di Terzo Mondo né di paesi in via di sviluppo, ma<br />
di un mondo apparentemente sviluppato uscito da una catastrofe<br />
ideologica che ha provocato incalcolabili danni culturali e sociali.<br />
Per alcuni anni successivi al crollo del comunismo l’aspettativa di<br />
vita dei russi era addirittura diminuita, il nucleo fondante di ogni<br />
società, la famiglia, era stato sottoposto a decenni di bombardamento<br />
ideologico, al punto che era difficile parlare di «società» in<br />
Russia. Nel terreno della vita comune erano disseminati ordigni<br />
antiuomo, pronti a deflagrare se appena sfiorati, devastando anime<br />
e psicologie così come in Afghanistan le bombe vere, nascoste<br />
tra i campi, distruggono gambe e braccia. La vita ricomincia se<br />
ricominciano i gesti semplici, quelli che nessuno faceva più, a causa<br />
del furore ideologico o dell’inaridimento del cuore: accogliere,<br />
ascoltare, condividere le giornate, prendersi qualche responsabilità,<br />
guardare a chi ti sta vicino, imparare cose antiche e cose nuove.<br />
Una riabilitazione, così come accade dopo un intervento chirurgico<br />
e occorre riaffermare i movimenti e i tempi di reazione.<br />
Una riabilitazione delle madri, per ritrovarsi dentro se stesse e per<br />
65
PRIMA LE DONNE E I BAMBINI<br />
ritrovarle dentro la vita pubblica: donne e ragazze in compagnia<br />
dei propri figli, ma sole nelle responsabilità di costruire con loro<br />
una storia positiva.<br />
La catastrofe si era abbattuta sulla Romania in modo ancor più<br />
grave. Non solo niente famiglia, ma persino niente più madri.<br />
Bambini abbandonati negli istituti e orfani si sono ritrovati figli<br />
dello stato. L’idea di una paternità più alta, priva di sentimenti e di<br />
cedimenti, che avrebbe portato a un uomo nuovo, si è rivelata un<br />
incubo popolato di morte e malattia. È nata anche una formula<br />
per definire la nuova mostruosità: AIDS pediatrico. Cioè l’epidemia<br />
si diffonde non per via sessuale e non per via genetica, ma per<br />
«altre cause». Vaccinazioni con aghi infetti, trasfusioni: il virus arriva<br />
dal camice bianco, da chi ti sta curando, da chi esegue ordini.<br />
Una storia che ha fatto della Romania un caso mondiale. Migliaia<br />
di bambini che innanzitutto dovevano riscoprirsi amati, magari<br />
anche per solo una parte della vita, l’ultima. Dovevano trovare una<br />
casa, una mamma, una famiglia, amici. In questo caso i «progetti»<br />
hanno un carattere del tutto speciale, perché in fondo coincidono<br />
con un elenco di nomi propri, la loro riuscita contempla un fattore<br />
non misurabile: la speranza.<br />
È diverso essere orfani in Romania o in Rwanda ed esserlo altrove,<br />
nel «nostro mondo». Ci sono situazioni capaci di aggravare<br />
terribilmente una condizione che per definizione è di fragilità e<br />
di debolezza. A causa della guerra, della povertà, delle malattie<br />
la vulnerabilità di certi bambini si estende a dismisura. Puoi curare<br />
dalla malaria, ma non basta se l’acqua dei pozzi non è sicura<br />
e se la guerriglia minaccia il villaggio. In certi posti del mondo<br />
occorre affrontare tutto, e tutto insieme; nessun progetto<br />
funziona se occupa soltanto un segmento. È il caso della regione<br />
africana dei Grandi Laghi, che in questi decenni ha conosciuto<br />
ogni tipo di emergenza. Qui occuparsi dei bambini orfani e<br />
vulnerabili significa misurarsi con bisogni che sorpassano le distinzioni<br />
e le definizioni: salute, cibo, sicurezza. Si opera secondo<br />
una misura che è il bambino-persona intera (un tema che riprenderemo<br />
nel prossimo capitolo): una dinamica che porta a<br />
scoperte meravigliose in mezzo a difficoltà enormi.<br />
66
UNA CASA NELLA STEPPA<br />
Viste da Novosibirsk, Mosca e San Pietroburgo sono due<br />
punti lontanissimi, raggiungibili dopo diversi giorni di<br />
Transiberiana, la linea ferroviaria che attraversa la Federazione<br />
Russa da est ad ovest. Novemila chilometri di binari realizzati<br />
in poco più di un ventennio a cavallo tra Otto e Novecento.<br />
A metà strada, tra San Pietroburgo e Vladivostock, si incontra<br />
Novosibirsk. Siamo oltre gli Urali, nel cuore del deserto siberiano,<br />
a 400 chilometri dal confine con il Kazakhstan. Una distanza che<br />
andrebbe percorsa sette volte per raggiungere la capitale. Qualcuno<br />
l’ha soprannominata «Chicago della Siberia», perché in meno<br />
di settant’anni ha raggiunto il milione di abitanti. Oggi, Novosibirsk<br />
ha doppiato quel numero e, secondo tutti i parametri, risulta<br />
la terza città russa dopo le due «capitali».<br />
Grazie alla centralità della sua posizione si trova ad essere un pun-<br />
67
RUSSIA<br />
to nodale per i trasporti della Federazione. Questo fattore<br />
l’ha resa, durante il regime sovietico, una città di<br />
grande importanza scientifica e industriale.<br />
Negli anni Novanta, dopo la caduta del muro di Berlino<br />
e il crollo del regime, anche Novosibirsk è stata raggiunta<br />
dall’onda lunga della crisi. Le fabbriche sono fallite o<br />
sono state chiuse e la gente si è trovata tutto d’un tratto<br />
senza soldi e prospettive. Per sopravvivere le persone<br />
sono costrette a svolgere più lavori contemporaneamente.<br />
Tutti piccoli, tutti saltuari. Le case di una volta,<br />
quelle di migliaia di operai, si sono ridotte a fatiscenti casermoni.<br />
Una crisi aggravata dall’inadeguatezza delle strutture assistenziali,<br />
che tuttora non riescono a rispondere ai bisogni<br />
crescenti dei cittadini. Ma il dramma più grande rimane<br />
quello della mancanza di un’idea di famiglia. Dell’amore<br />
per un progetto comune. Un’attenzione alla famiglia<br />
centrale per Chiesa Ortodossa e Chiesa Cattolica,<br />
punto nodale sul quale anche lo stato sta lavorando.<br />
La crisi economica, la mancanza di opportunità lavorative,<br />
la fragilità dei legami tra le persone hanno favorito<br />
la creazione di un cortocircuito che ha nella disgregazione<br />
familiare il risultato principale. «Fate figli – si diceva<br />
in Russia come in tutti i paesi dell’Est – la Nazione se ne<br />
occuperà!» Ma non è stato così. Oggi, a distanza di anni<br />
dal crollo sovietico, la situazione è cambiata in meglio,<br />
ma i problemi sono rimasti e difficilmente saranno risolvibili<br />
nell’immediato. La sanità e molti servizi sono ancora<br />
fragili. Il liberismo ha spazzato via il comunismo,<br />
favorendo in realtà un consumismo sfrenato dove l’uomo<br />
è ridotto a merce di scambio a basso costo. Nulla di<br />
più. Ecco le ragioni che hanno portato e portano molte<br />
donne, abbandonate dal compagno e dalle famiglie, ad<br />
interrompere la gravidanza o a lasciare il bambino in orfanotrofio.<br />
Nel 2001 sorge a Novosibirsk – con il partner locale Mak-<br />
68
UNA CASA NELLA STEPPA<br />
69
RUSSIA<br />
sora – la Casa di accoglienza Golubka. Golubka vuol dire colomba.<br />
Forse a testimoniare – come quella del racconto biblico – la vicinanza<br />
di una terra cui approdare. Testimonianza di una vita che<br />
rinasce.<br />
Rosalba Armando è la responsabile di AVSI in Siberia. È arrivata<br />
negli anni Novanta: «Non capivo e non conoscevo la lingua. Ero<br />
disperata!». Poi la telefonata dall’Italia. Gli amici di AVSI volevano<br />
aiutarla e rispondere alle domande che quelle ragazze le ponevano.<br />
Donne giovanissime. Con un passato drammatico e un marchio<br />
che la società difficilmente perdona e dimentica. Ma nonostante<br />
tutto protagoniste di un cambiamento visibile, perché<br />
sinceramente amate e accolte.<br />
«Casa Golubka – spiega Rosalba – è nata per curare questa ferita.<br />
Per combattere contro l’abbandono dell’essere umano, in modo<br />
semplice e concreto.» Con lei lavorano una decina di persone e sono<br />
48 le madri che Casa Golubka ha ospitato dal 2001.<br />
Karina è una di queste. Aveva sedici anni quando ha scoperto di<br />
essere incinta. Non voleva abortire e l’orfanotrofio dov’era cresciuta<br />
l’ha espulsa. Arriva a Casa Golubka senza neppure aver terminato<br />
la scuola dell’obbligo e pochi mesi più tardi nasce suo figlio.<br />
Maksora le ha permesso di iscriversi a una scuola professionale<br />
e di trovare lavoro. È una delle tante storie che si conoscono<br />
visitando la casa di accoglienza. Un appartamento all’interno di<br />
un condominio in cui le mamme hanno una loro camera privata.<br />
Ci accompagna Vladimir, l’amministratore sociale della casa. Si<br />
occupa di rimettere in ordine i documenti delle «donne di Maksora»,<br />
permettendo loro di usufruire dei servizi sociali gratuiti. Arriviamo<br />
verso sera. Nadja è una delle mamme ospiti della Casa. Sta<br />
stirando un vestitino rosa. Quello della figlia che però – ci avvisa<br />
– «sta dormendo». Non dobbiamo fare rumore.<br />
Le donne si occupano quotidianamente dei lavori domestici. Hanno<br />
dei turni. Qualcuno pulisce e mette ordine le stanze, qualcuno<br />
cucina. Una serie di attività utili a sensibilizzare il livello di responsabilità<br />
di queste giovani madri.<br />
Ma il progetto italo-russo non si ferma con l’accoglienza. Le donne<br />
non sono abbandonate una volta divenute madri. Le si aiuta a<br />
trovare lavoro, ad essere indipendenti e a trovare una casa. Tante<br />
sono diventate brave sarte, altre parrucchiere. E quando serve si interviene<br />
economicamente attraverso il sostegno a distanza di AVSI.<br />
Asel è arrivata dal Kazakhstan per studiare a Novosibirsk. Rimasta<br />
incinta e cacciata dalla scuola, povera, senza un soldo e nemmeno<br />
cittadina russa, non avrebbe potuto partorire il suo bambino.<br />
Un’assistenza invece la trova grazie al lavoro di Vladimir. Ottiene<br />
la cittadinanza e con questa la possibilità di partorire gratuitamente.<br />
Casa Golubka l’ha accolta, le ha insegnato un lavoro e<br />
grazie al sostegno a distanza di AVSI una famiglia italiana le permette<br />
di mantenere il bambino.<br />
L’equipe di Rosalba è composta da diversi tecnici, tutti molto giovani.<br />
Anastasia è la psicologa e pedagoga del gruppo. Quella che<br />
insegna alle mamme come prendersi cura dei propri figli. Ma è anche<br />
responsabile della casa e controlla che i vari compiti siano assolti.<br />
Zhenia è la «cuoca», l’esperta di cucina e alimentazione che<br />
ogni due, tre giorni a settimana insegna alle neo-mamme come cucinare<br />
correttamente. Un medico segue costantemente la salute<br />
dei bambini e tre assistenti si occupano a turno delle donne con le<br />
doglie e di quelle che hanno appena partorito.<br />
Da anni Maksora collabora in stretto contatto con i servizi sociali<br />
di Novosibirsk, per i quali Casa Golubka è un modello da favorire<br />
e replicare. E proprio per questo, recentemente, hanno dato<br />
la propria disponibilità a fornire un appartamento più spazioso<br />
capace di accogliere un numero maggiore di mamme. Il più delle<br />
volte, poi, sono gli stessi servizi sociali a segnalare le ragazze madri<br />
in difficoltà che per vari motivi necessitano di un luogo che le<br />
accolga e le aiuti. Le alternative sono l’aborto o l’abbandono del<br />
bambino.<br />
Non c’è una regola per lasciare la casa. Il momento viene definito<br />
individualmente. Ogni donna ha i suoi tempi.<br />
Iemilija è nata in un villaggio del nord siberiano. Un posto in cui<br />
la temperatura scende tutti gli inverni a 40 gradi sottozero. La madre<br />
e il padre, alcolizzati, l’hanno lasciata in orfanotrofio. A 16 anni<br />
esce dall’istituto. È incinta e cerca un appartamento. Il padre del<br />
bambino, però, l’abbandona.<br />
70
UNA CASA NELLA STEPPA<br />
La svolta coincide con il suo arrivo a Casa Golubka. Il bambino<br />
nasce, la mamma trova un lavoro e anche una nuova casa. Il figlio<br />
viene inserito in uno degli asili statali con cui collabora in<br />
città Casa Golubka, sostenuto a distanza da AVSI. Ma la storia di<br />
Iemilija non finisce qui. Incontra un ragazzo, semplice e onesto,<br />
con il quale decide di sposarsi. La sua festa di nozze A Casa Golubka,<br />
naturalmente. Nuovamente tra gli amici che non ha più<br />
abbandonato.<br />
71
QUELL’INVITO ANDATO A VUOTO<br />
La chiamavano slim disease, malattia del dimagrimento, per la<br />
sistematicità con cui provocava ingenti perdite di peso. Solo<br />
negli anni Ottanta si capì che era una nuova malattia e<br />
che al momento non c’era alcuna cura. Era l’AIDS, la Sindrome da<br />
Immunodeficienza Acquisita. Il morbo presto si trasformerà nella<br />
più rapida pandemia mondiale, raggiungendo ogni angolo della<br />
terra in meno di un decennio.<br />
Sono 25 milioni i morti dal 1981 e 33,2 milioni – stando al rapporto<br />
UNAIDS del 2007 – i sieropositivi nel mondo. Ogni anno cinque<br />
milioni di persone contraggono il virus e l’Africa subsahariana,<br />
con il 90% dei casi di AIDS, è la regione più colpita.<br />
«L’epidemia si è diffusa con una serie di ondate distruttive – spiega<br />
Filippo Ciantia, medico in Uganda da 25 anni e rappresentante<br />
di AVSI nel paese –. La prima onda anomala è data dal vastissimo<br />
numero di persone raggiunte dal virus. Una sciagura che ha<br />
causato enormi difficoltà nelle famiglie, chiamate ad avere cura<br />
dei malati, spaventate e provate dalla sofferenza. Poi l’ondata delle<br />
innumerevoli morti e quella di milioni di orfani dell’AIDS. Ora il<br />
difficilissimo compito di aumentare i servizi a milioni di persone<br />
malate, garantendo loro l’accesso alla terapia antiretrovirale. Solo<br />
un malato su dieci in Africa e uno su sette in Asia riceve realmente<br />
la terapia.»<br />
Dal 1986 ad oggi la malattia, che ha colpito pesantemente l’Uganda,<br />
ha provocato oltre 900.000 morti infettando 2 milioni di persone.<br />
L’Uganda, però, viene spesso citata come success story nella lotta contro<br />
l’AIDS, avendo ridotto la prevalenza del virus HIV da circa il 21%<br />
della popolazione verso la fine degli anni Ottanta al 6,4% di oggi.<br />
Infatti, mentre in molti paesi africani la diffusione dell’epidemia veniva<br />
tenuta nascosta, arrivando in modo paradossale a negarne l’esistenza,<br />
lo stato ugandese ha affrontato diversamente il problema.<br />
«Si tratta di una malattia fatale, che potrebbe devastare il nostro<br />
paese – dicevano voci di governo –. Ma la malattia può essere prevenuta.<br />
I malati possono essere accuditi, possono continuare a vivere<br />
e poi morire con dignità.» Una peculiarità rintracciabile anche<br />
nelle parole pronunciate dal Presidente dello stato africano, Yoweri<br />
Museveni, durante la conferenza internazionale sull’AIDS di Firenze:<br />
«Ho sempre sottolineato la necessità di tornare alle nostre<br />
tradizioni culturali provate dal tempo, che enfatizzano la fedeltà e<br />
denunciano i rapporti prima e fuori dal matrimonio. Credo che la<br />
miglior risposta alla minaccia posta dall’AIDS e dalle altre malattie<br />
trasmesse per via sessuale sia riaffermare pubblicamente e senza<br />
esitazioni il rispetto e la venerazione che ogni persona deve al suo<br />
prossimo. I giovani devono essere educati alle virtù dell’astinenza,<br />
del sacrificio, dell’autodisciplina e della rinuncia al piacere.»<br />
Era il 1991. Da allora ha iniziato a svilupparsi la ABC strategy. Una<br />
strategia fondata sulla prevenzione dell’infezione attraverso un<br />
cambiamento delle abitudini sessuali delle persone, alle quali era<br />
consigliato di astenersi dai rapporti (Abstinence), di essere fedeli al<br />
proprio partner (Being faithful) oppure – in casi particolari e per<br />
certe categorie di persone – di usare correttamente il profilattico<br />
(Condom use). In vent’anni di applicazione del metodo ABC l’incidenza<br />
della malattia nel paese si è dimezzata.<br />
Dunque, lo stato sembrava aver capito che la migliore strategia contro<br />
l’AIDS è «culturale», ma c’è un altro pilastro che insieme alla risposta<br />
governativa ha permesso di ottenere risultati significativi: il<br />
fattore comunitario. Una serie numerosissima di organizzazioni<br />
che si sono fatte carico della responsabilità di sostenere la rete di solidarietà<br />
della famiglia estesa, accudendo malati, prendendosi cura<br />
degli orfani e indirizzando l’educazione delle giovani generazioni.<br />
Un contributo fondamentale senza il quale non sarebbe stato<br />
possibile combattere il primo grande dramma che la malattia portava<br />
con sé: il marchio dell’AIDS e la conseguente emarginazione.<br />
73
UGANDA<br />
All’inizio degli anni Novanta, quando la malattia aveva cominciato<br />
la sua espansione, questo stigma era una barriera invalicabile.<br />
L’ignoranza e la paura portavano a credere che una stretta di mano<br />
o la condivisione dello stesso piatto, la puntura di una zanzara<br />
o una semplice conversazione potessero essere vie di contagio. I<br />
parenti malati venivano nascosti dai propri familiari e lasciati morire<br />
in condizioni di totale abbandono. Una situazione che non riuscirono<br />
a migliorare neanche i diversi tentativi di sensibilizzazione<br />
volti a spiegare le modalità reali di trasmissione del contagio.<br />
Sono tante le organizzazioni che si sono fatte carico di questa responsabilità.<br />
Tante come le persone che hanno cercato di rompere<br />
questo muro. È il caso di Noerine Kaleeba, fondatrice dell’organizzazione<br />
TASO (The AIDS Support Organization), una delle prime<br />
realtà comunitarie a combattere l’AIDS, e di Elly Ongee, fondatore<br />
del Meeting Point di Kitgum. Storie di speranza fiorite nella più<br />
cupa desolazione.<br />
74
QUELL’INVITO ANDATO A VUOTO<br />
Elly era malato di AIDS. È Irene, sua moglie morta dopo pochi mesi,<br />
a presentargli padre Alfonso Poppi, missionario di Modena nel<br />
paese, e con lui alcuni volontari di AVSI. Un incontro che ha vinto<br />
la malattia riportando la speranza nelle loro vite.<br />
Era il luglio del 1990. Tutto inizia con un volantino appeso sulla parete<br />
di una piccola stanza nell’ospedale pediatrico di Kitgum. Un volantino<br />
che terminava con le firme del prete modenese, di Elly Ongee,<br />
di George William, studente ugandese di medicina, e di tre italiani<br />
di AVSI. Una storia che nessuno si immaginava e che nel giro di<br />
qualche anno ha visto il Meeting Point di questa città occuparsi di<br />
2000 pazienti sieropositivi, ma anche di 500 orfani dell’AIDS.<br />
C’era scritto che un gruppo di amici colpiti dalla malattia direttamente<br />
o indirettamente aveva deciso di incontrasi. Che quell’amicizia<br />
li aveva aiutati ad affrontare il dramma dell’AIDS e a scoprire<br />
al suo interno una libertà e una gioia mai provate prima. Era un invito<br />
per tutti: ammalati e non. «Se vuoi puoi incontrarci al ‘Meeting<br />
Point’ ogni venerdì pomeriggio nella nuova ala dell’ospedale<br />
governativo di Kitgum. Firmato: Alfonso, Elly, George...»<br />
Un invito che inizialmente nessuno accoglie. La paura di essere<br />
contagiati era molto forte, ce lo conferma padre Poppi. «Quando<br />
portavo Elly sul motorino per le strade della città gli occhi di tutti<br />
non erano rivolti al ‘pallido bianco’ che guidava, ma allo ‘scheletro’<br />
che trasportava sul sellino. Elly spesso mi chiedeva se la gente<br />
lo odiasse. Gli rispondevo che il problema era la morte: le persone<br />
davanti a lei sono vuote. Non hanno niente da offrire perché<br />
non hanno nessuna spiegazione, nessuna risposta.»<br />
Oggi Meeting Point è partner di AVSI in Uganda e insieme collaborano<br />
a molti progetti di cura e prevenzione dell’AIDS. Un’esperienza<br />
d’amore più contagiosa del virus. E in breve tempo anche<br />
Kampala e Hoima – altre due città del paese – hanno avuto il loro<br />
Meeting Point.<br />
«Quando Rose Akumu, la mia giovane segretaria, risultò sieropositiva<br />
– spiega Filippo Ciantia – volle partecipare a un incontro nel<br />
quale Elly Ongee offriva la sua coraggiosa testimonianza. Quella<br />
di un modo di affrontare l’AIDS pieno di significato, tentando di<br />
trasmettere ad altri la convinzione che la vita potesse avere senso<br />
ed essere positiva, nonostante la malattia mortale che lo aveva colpito.»<br />
Rose decise di dedicare il suo tempo libero all’aiuto delle<br />
persone affette e infettate dal virus. Così l’ufficio di AVSI si trasforma<br />
nelle ore di pausa in luogo d’incontro con decine di persone.<br />
Akumu muore nel maggio del 1992 dopo una lunga lotta con la<br />
malattia. Nello stesso anno, in ottobre, è un’altra Rose a raccogliere<br />
il testimone. Con Rose Busingye, giovane infermiera all’ospedale<br />
Nsambya, nasce il Meeting Point di Kampala, oggi una delle<br />
più note organizzazioni della città e della sua periferia.<br />
«Un paziente mi chiese di seguirlo fino a casa – racconta Rose –.<br />
Quello che vidi fra le foglie piangenti era uno spettacolo squallido.<br />
Persone ammassate in piccole case di fango, servizi igienici completamente<br />
assenti. Bambini che giocavano in mezzo alla spazzatura<br />
e gente che moriva.» A pochi metri dalle case una strada portava<br />
alla cava. Qui donne e bambini passavano intere giornate sotto<br />
il sole cocente a spaccare pietre da rivendere ai costruttori.<br />
«Negli occhi di quelle donne vedevo il mio sguardo di qualche<br />
anno prima, alla ricerca di qualcosa che mi rendesse felice, ma<br />
che mi sfuggiva. L’incontro con un prete italiano mi cambiò la<br />
vita. Per la prima volta mi sentii guardata e amata solo per il fatto<br />
di esistere con tutte le debolezze e i difetti che mi portavo<br />
dietro. Volevo che anche loro potessero essere guardate così.»<br />
Oggi l’Acholi Quarter dove abitano le «donne di Rose» non è più<br />
squallido come allora. Molte case sono di mattoni, non c’è più il<br />
colera e le donne ogni giorno puliscono il quartiere.<br />
Sono circa 500. Tutte malate di AIDS. Il Meeting Point International<br />
offre corsi di alfabetizzazione, corsi d’igiene e di salute. Ma anche<br />
lezioni per imparare a cucire, a «fare la maglia» e a ricamare.<br />
Distribuisce cibo e favorisce prestiti per le attività lavorative. Molte<br />
di queste donne hanno cominciato il trattamento antiretrovirale,<br />
aiutandosi a vicenda a prendere le medicine. Se una di queste<br />
muore, i figli vengono presi in casa da un’altra. «Io vivo perché<br />
qualcuno mi ha voluto bene. Adesso anche io voglio voler bene»,<br />
dicono a Rose le sue «pazienti».<br />
È con partner come Meeting Point che AVSI ha affrontato la sfida<br />
dell’AIDS secondo un approccio olistico. Il virus rappresenta in<br />
75
UGANDA<br />
molti casi un «entry point» per un supporto integrato al malato, alla<br />
sua famiglia e alla comunità. Con questo metodo si svolgono da<br />
anni le attività di AVSI nel campo della prevenzione, dell’assistenza<br />
e della cura delle persone.<br />
Attraverso i propri partner AVSI porta aiuto ai casi più isolati e trascurati.<br />
L’assistenza a domicilio dei malati, infatti, è stata la prima<br />
risposta. Una risposta che ha coinvolto immediatamente anche i<br />
figli di queste persone: gli orfani lasciati da parenti o amici. Sono<br />
2,4 milioni questi bambini; una famiglia su quattro vive con un orfano<br />
in casa, e la metà a causa dell’AIDS. Settemila di questi hanno<br />
potuto o possono frequentare le scuole grazie al progetto di sostegno<br />
a distanza che AVSI, insieme a Meeting Point e ad altre organizzazioni,<br />
ha realizzato.<br />
In Uganda ogni anno 77.000 donne sieropositive danno alla luce<br />
bambini. In un paese colpito da un virus che si propaga per l’80%<br />
tramite rapporti sessuali e per il 15% con trasmissione maternofetale,<br />
prevenire significa soprattutto lavorare con le donne. Come<br />
spiega Luciana Bassani, medico AVSI in Uganda da un venten-<br />
76
QUELL’INVITO ANDATO A VUOTO<br />
nio: «La scoperta che la Nevirapina riduce il rischio di trasmissione<br />
del virus HIV del 70% se somministrata alla donna durante le<br />
doglie e al neonato entro 72 ore dalla nascita, ha spinto nel 2000<br />
il Ministero della Salute ugandese a lanciare il programma Prevention<br />
of Mother To Child Transmission in quattro ospedali». Programma<br />
esteso a tutto il paese due anni più tardi. Un’applicazione a largo<br />
raggio virtuale dato che solo il 30% dei servizi prenatali offre<br />
tale programma. Nel 2002, con il sostegno in termini di personale,<br />
medicine, strumenti e alimenti, AVSI inaugura il programma in<br />
due ospedali di Kitgum, in quello di Kolongo e Hoima nel distretto<br />
di Pader e in 30 nuclei sanitari specifici.<br />
I numeri sono sorprendenti: nei centri seguiti da AVSI 38.000 donne<br />
incinte ricevono servizi prenatali, il 99% è stato raggiunto da<br />
messaggi di prevenzione e il 95% si sottopone al test. Per queste<br />
donne – conclude Luciana – sottoporsi al PMTCT coincide con<br />
l’entrare a far parte della famiglia di AVSI: «La scoperta della propria<br />
sieropositività da parte di una madre non coincide più necessariamente<br />
con l’inizio della fine».<br />
77
UGANDA<br />
78
QUELL’INVITO ANDATO A VUOTO<br />
79
GLI OSPEDALI DELL’ORRORE<br />
Aportare AVSI in Romania è l’incontro «casuale» con un prete<br />
ortodosso. Siamo nella primavera del Novanta, qualche<br />
mese dopo la caduta di Ceausescu, il padre-padrone comunista<br />
che per 24 anni aveva retto con pugno di ferro, in un’atmosfera<br />
paranoica, il paese.<br />
L’incontro con padre Pop e la sua richiesta d’aiuto costituiscono i<br />
primi passi di questa storia. Una storia di cooperazione nella cooperazione<br />
che vede il lavoro di AVSI intrecciarsi con quello di altre<br />
organizzazioni non governative in progetti di sostegno allo<br />
sviluppo per l’ex repubblica socialista.<br />
Tra il 1991 e il 1995 sono più di mille i bambini che hanno passato<br />
le loro vacanze in Italia grazie all’ospitalità dell’associazione Fa-<br />
81
ROMANIA<br />
miglie per l’Accoglienza. Una novantina gli adulti. La miseria<br />
che traspariva dai racconti di quei ragazzi, la familiarità con la<br />
Romania e l’idea del giornalista Mino Damato di realizzare un<br />
padiglione per bambini sieropositivi nell’ospedale Victor Babes<br />
di Bucarest spingono alcune persone di queste famiglie legate ad<br />
AVSI a interessarsi della proposta lanciata durante una trasmissione<br />
televisiva.<br />
Il reparto viene realizzato in pochissimo tempo. Petru Calistu –<br />
allora direttore dell’Ospedale – si ricorda benissimo<br />
com’è andata. «I lavori per la ristrutturazione sono iniziati<br />
il 2 maggio del 1995 e sono terminati nel dicembre<br />
dello stesso anno. Ero stupito dalla velocità dell’intervento,<br />
ma soprattutto dalla passione per l’uomo<br />
che muoveva l’organizzazione italiana.»<br />
A questo intervento, finanziato con donazioni private<br />
italiane, tra cui Barilla, Moschino e l’ospedale Bambin<br />
Gesù di Roma, AVSI, con il contributo dell’Unione Europea<br />
e della Regione Lombardia, ha fatto seguire altri<br />
progetti come quello della formazione del personale<br />
medico e paramedico, amministrativo e di volontari operanti<br />
al Victor Babes e in altri ospedali della capitale.<br />
L’efficienza di queste costruzioni e di questi progetti si<br />
scontra subito con una terribile scoperta, quella dei bambini<br />
rinchiusi negli ospedali e negli istituti: la tragedia<br />
dell’AIDS pediatrico.<br />
Qui fra il dicembre 1985 e lo stesso mese del 2003 i casi<br />
di AIDS sono stati 14.387. 11.153 bambini, solo 3.234<br />
gli adulti (dati attualizzati al 31 dicembre 2007: 15.085 i<br />
casi, di cui 9.737 bambini e 5.348 adulti; fonte: univ.<br />
cnlas.ro, Commissione Nazionale Anti SIDA).<br />
La Romania è il paese in cui i casi di HIV o AIDS dovuti a<br />
trasmissione orizzontale non sessuale rappresentano<br />
ancora oggi, 25 anni dopo l’inizio della pandemia, la<br />
maggior parte dei casi registrati. È l’unico paese al mondo<br />
dove il numero di bambini morti a causa di AIDS supera<br />
quello degli adulti e la maggioranza assoluta degli<br />
infettati in vita è costituita da adolescenti tra i 15 e i 19<br />
anni. Il 60,1% del totale.<br />
Un dato allarmante che non trova cause in trasmissioni di tipo<br />
sessuale né materno-fetale – meno di 500 sono stati i casi di questo<br />
tipo in 18 anni –, ma nell’abbandono e nell’incuria del sistema<br />
sanitario nazionale durante gli ultimi anni, quelli fra il 1984 e<br />
il 1988, del regime di Ceausescu.<br />
Insomma, verso la fine degli anni Ottanta le strutture sanitarie<br />
82
GLI OSPEDALI DELL’ORRORE<br />
della Romania, incluse quelle interne alle scuole e agli<br />
orfanotrofi, da presidi della salute si sono trasformate<br />
velocemente nel loro contrario. Un’iniezione, una vaccinazione,<br />
una trasfusione di sangue, una microtrasfusione<br />
per trattare una immaturità alla nascita o per «rinforzare<br />
la debole costituzione fisica del bambino» sono divenute<br />
un «biglietto per l’inferno» a causa di aghi contaminati<br />
o di prodotti ematici importati dal Sud del mondo<br />
sui quali non si era effettuato il test anti-HIV.<br />
Lo raccontano le statistiche del Ministero della Sanità<br />
rumeno. Nel 1990 sono stati 1.123 i nuovi casi riscontrati<br />
di AIDS pediatrico. 589 attribuiti a «trasmissione nosocomiale»,<br />
vale a dire durante un’ospedalizzazione, 361<br />
legati a «trasfusione o ad assunzione di prodotti ematici»<br />
e 129 di «causa sconosciuta», ma non riferibile alla<br />
trasmissione materno-fetale.<br />
L’AIDS, quarta causa di morte al mondo, si è diffuso sempre<br />
più rapidamente in questi ultimi anni soprattutto<br />
nelle repubbliche dell’ex Unione Sovietica e nell’Europa<br />
dell’Est.<br />
Secondo il rapporto 2006 dell’UNAIDS – il programma<br />
delle Nazioni Unite per la lotta contro l’epidemia –, in<br />
quest’area, dove l’infezione interessa già 1,6 milioni di<br />
persone, il tasso di crescita dei nuovi casi è il più alto al<br />
mondo, con l’80% dei sieropositivi al di sotto dei 25 anni.<br />
In seguito a questo allarme il governo russo – insieme a<br />
Fondo Globale MTA (Malaria, TBC, AIDS), UNAIDS, Banca<br />
Mondiale e ambasciata di Francia in Russia – ha organizzato<br />
a Mosca nel maggio 2006 la prima conferenza<br />
internazionale sull’HIV/AIDS per l’Est Europa e l’Asia Centrale.<br />
Per Fundatia – partner rumena di AVSI – a raccontare la decennale<br />
esperienza di sostegno ai bambini malati e abbandonati in<br />
istituti c’era Calin Pop.<br />
Un filo rosso lega le vicende di AVSI a Novosibirsk con quelle di<br />
Bucarest in Romania, come di tanti altri centri dell’Est. Quello<br />
della deistituzionalizzazione seguita, con la spinta dell’Occidente,<br />
al crollo dei regimi sovietici. Ma anche quello di famiglie costrette<br />
dalla povertà ad abbandonare i propri figli in orfanotrofi e istituti<br />
che con la caduta del muro hanno assistito alla fine dei propri<br />
finanziamenti e dei mezzi di sussistenza.<br />
Una storia che si ripete e che vede AVSI in prima linea insieme a diversi<br />
partner locali. È il caso di Maksora e di Casa Golubka in Russia,<br />
ma anche quello di Sotas – l’ONG che collabora con AVSI – in<br />
Lituania.<br />
83
ROMANIA<br />
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor nasce nel 1996. Conta cinquanta<br />
dipendenti e progetti per un budget annuo di oltre un milione di euro.<br />
In 10 anni di attività 1900 bambini e 1300 famiglie hanno beneficiato<br />
degli interventi, sono stati realizzati sette servizi sociali accreditati<br />
o riconosciuti dallo stato e sono stati aperti, oltre alla sede<br />
centrale di Bucarest, tre filiali di Fundatia a Cluj, Arad e Cojasca.<br />
L’avventura nell’ospedale della capitale è solo la prima. In poco<br />
tempo si viene a conoscenza di un’ulteriore realtà drammatica.<br />
Quella di un centinaio di bambini sieropositivi abbandonati in un<br />
ospedale a venti chilometri da Bucarest, l’ospedale per distrofici Vidra.<br />
Una struttura fatiscente in cui personale sottopagato e senza<br />
nessuna competenza deve prendersi cura dei bambini.<br />
Nel 1998, in collaborazione con UNICEF, AVSI e Fundatia danno vita<br />
a un nuovo progetto finalizzato al sostegno di famiglie con il problema<br />
AIDS pediatrico a rischio abbandono. Contemporaneamente<br />
avviano la ricerca della famiglie d’origine di molti ragazzi dimenticati<br />
negli ospedali. È un’impresa ardua, bisogna affrontare la diffidenza<br />
degli operatori ospedalieri e la mancanza dei dati anagrafici<br />
utili per risalire ai genitori.<br />
Poche famiglie vengono rintracciate, il più delle volte con storie<br />
drammatiche di povertà e desolazione. Ma anche storie di «bugie di<br />
stato»: figli dichiarati morti e rapiti dal regime, come nel caso che ci<br />
racconta la madre di una ragazza. «Una volta nata mia figlia era stata<br />
trattenuta in ospedale perché prematura… ero tornata a casa e in<br />
ospedale mi avevano detto che mi avrebbero avvisata quando la situazione<br />
sarebbe migliorata. Dopo un mese sono tornata a chiedere<br />
informazioni e mi hanno fatto capire che mia figlia non era sopravvissuta.<br />
Da allora non ho saputo più nulla.»<br />
Dopo nove anni Giovanna – è il nome che le abbiamo dato – ha potuto<br />
riabbracciare per la prima volta la madre. Ma le storie a lieto fine<br />
sono pochissime: una su cento. Tra il 2001 e il 2002 vengono<br />
aperte attorno a Bucarest tre case d’accoglienza: Casa Emilia, Casa<br />
Joy e Casa Edimar.<br />
L’attività di Fundatia e AVSI non termina qui. C’è la collaborazione<br />
con la Regione Lombardia ad Arad finalizzata alla prevenzione dell’abbandono<br />
di minori in orfanotrofi e il grande impegno con la comunità<br />
rom del villaggio di Iazu, a 45 chilometri da Bucarest. Un<br />
impegno nato dal lavoro negli ospedali con i bambini sieropositivi<br />
che ha permesso di conoscere le storie e i figli malati della comunità<br />
rom. «Avevamo incontrato alcune famiglie che andavano periodicamente<br />
in ospedale – ricorda Calin Pop – per far curare i loro figli<br />
sieropositivi. Come gli altri, anche questi erano malati, ma la cosa<br />
che ci stupì fu che i loro genitori non li avevano abbandonati.»<br />
Storie lontane dalle cronache rumene dei nostri giornali. «Uno di<br />
questi bambini, dopo pochi mesi dal nostro incontro in ospedale,<br />
torna a casa e muore. Muore in casa, accompagnato, accudito e voluto<br />
fino all’ultimo istante della sua breve vita dalla madre.» Gli operatori<br />
di Fundatia vanno a trovare la donna e per la prima volta entrano<br />
nel villaggio rom. Un luogo poverissimo dove non esiste<br />
asfalto sulle strade. Non ci sono automobili, ma carri trainati da cavalli,<br />
le case non hanno i servizi, per l’acqua bisogna andare al pozzo<br />
e per l’elettricità ci si attacca informalmente al palo della luce più<br />
vicino. Una comunità molto coesa che non concepisce l’abbandono<br />
e l’emarginazione a causa della malattia.<br />
Fundatia decide di aiutare queste famiglie. Risale al 2000 il progetto<br />
di sostegno a distanza finalizzato all’educazione dei bambini in<br />
età scolare e prescolare grazie al partenariato con l’ONG spagnola<br />
CESAL. Si costruisce una scuola materna con mensa scolastica in<br />
grado di accogliere 150 alunni e se ne ristruttura una elementare con<br />
il contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano. Viene organizzata<br />
e curata la formazione degli insegnanti, si coinvolgono i genitori<br />
nella crescita dei figli con attività extrascolastiche e sportive e<br />
insieme si promuovono corsi d’igiene e salute. Nello stesso tempo<br />
a scuola viene avviato un ambulatorio medico, si realizzano laboratori<br />
professionali e, in collaborazione con il Comune di Milano, i ragazzi<br />
più meritevoli vengono sostenuti da borse di studio per scuole<br />
superiori e stage aziendali.<br />
«Dieci anni fa non c’era nulla – conclude Pop – solo un gruppo di<br />
persone che cominciava a sperimentare l’amicizia, malgrado situazioni<br />
difficili senza risposte adeguate. Tutte queste opere oggi<br />
non sarebbero potute crescere senza la fede, il coraggio e l’entusiasmo.»<br />
86
NELLA TERRA DELLE EMERGENZE<br />
«<br />
Avevo nove anni quando i ribelli mi hanno catturato. Stavo<br />
ritornando a casa da scuola. Mi hanno fatto marciare fino<br />
in Sudan, nei campi di addestramento. Per strada mancava<br />
l’acqua. Molti bambini sono morti.»<br />
Odung Sunday ha 22 anni e 7 li ha passati con la guerriglia del<br />
Nord Uganda. La sua storia è come quella di Charles e di tanti altri<br />
bambini. «Ci hanno rapito e dicevano che ci avrebbero ucciso<br />
con i ‘panga-panga’ se fossimo fuggiti. Poi un giorno mi hanno<br />
chiesto di uccidere un mio amico come esempio per chiunque<br />
avesse tentato di scappare. Mi hanno detto che se mi fossi rifiutato<br />
mi avrebbero ucciso. Ho dovuto prendere il bastone e ammazzare<br />
il mio amico e poi altre persone.»<br />
89
PROGETTO OVC<br />
Siamo nel cuore dell’Africa, nella regione dei Grandi Laghi.<br />
Dal 1986 i guerriglieri della Lord’s Resistance Army<br />
(LRA), capeggiati dal famigerato Joseph Kony, combattono<br />
una guerra civile contro il governo ugandese.<br />
I villaggi del Nord, quelli al confine con il Sudan, primo<br />
sostenitore della guerriglia, sono vuoti. Il 95% della popolazione<br />
dell’area ha lasciato il proprio villaggio dopo un attacco<br />
o un assedio. Solo negli ultimi tempi, dopo vent’anni<br />
di saccheggi, rapimenti e un numero di morti che supera<br />
le 20.000 unità, la situazione ha accennato a mutare.<br />
La presenza di AVSI risale alla fine degli anni Ottanta,<br />
qualche anno dopo la scoperta di un nuovo terribile virus:<br />
l’AIDS.<br />
L’Uganda è il primo paese al mondo per la percentuale di<br />
abitanti tra gli 0 e i 14 anni (49,4%), un dato che condiziona<br />
l’età media della popolazione (15,3 anni) e il numero di<br />
ragazzi iscritti alle scuole elementari (quindicesimo paese<br />
al mondo). 77 bambini ogni mille abitanti non superano<br />
l’infanzia: tubercolosi e AIDS sono ancora molto diffusi.<br />
Gli orfani sono una vera e propria emergenza: orfani dell’AIDS,<br />
ma anche orfani come Charles. Orfani di guerra, rapiti,<br />
sequestrati e costretti ad uccidere.<br />
Odung è stato ferito e arrestato in un’imboscata del governo.<br />
Gli hanno amputato una gamba, quella sinistra, e<br />
con l’amnistia ha guadagnato la libertà. Cammina grazie<br />
alla protesi che gli hanno messo nel laboratorio ortopedico<br />
nel Nord dell’Uganda, quello di Gulu, sostenuto da<br />
AVSI. Ora sta meglio. Ha imparato a fare il sarto e con il<br />
microcredito ha aperto un negozio nella città dove vive<br />
con la famiglia. Ha due figli e può pagare loro la scuola<br />
grazie al contributo di AVSI.<br />
Sono più di un milione gli orfani in questo stato. Per aiutarli<br />
AVSI crea all’inizio degli anni Novanta il sostegno a<br />
distanza. Un progetto che fino al 2005 ha interessato<br />
circa 7000 bambini tra Uganda, Kenya e Rwanda, aiutati<br />
a vivere e a crescere nel proprio ambiente.<br />
90
NELLA TERRA DELLE EMERGENZE<br />
Il progetto funziona. Viene scelto e finanziato da USAID<br />
– la cooperazione americana – nell’ambito di una grande<br />
iniziativa globale voluta e lanciata dal presidente George<br />
W. Bush per sconfiggere l’AIDS in Africa e nei Caraibi.<br />
Nasce così una nuova iniziativa. I finanziamenti del President’s<br />
Emergency Plan For Aids Relief (PEPFAR) si sviluppano<br />
intorno a tre componenti principali: prevenzione,<br />
trattamento e cura. E proprio all’interno di quest’ultima<br />
si colloca l’Annual Program Statement (APS). Il piano, finalizzato<br />
all’assistenza di OVC affetti da HIV/AIDS, ha permesso<br />
ad AVSI di vincere nell’aprile 2005 un progetto di<br />
quattro anni intitolato: Increased Care and Support for Orphans<br />
and Vulnerable Children in East-Africa.<br />
OVC significa Orphans and Vulnerable Children, bambini<br />
orfani e vulnerabili. Un progetto iniziato nel 2005 che<br />
terminerà nell’aprile 2009, finanziato dal sostegno a<br />
distanza di AVSI e da USAID. Un’esperienza che permette<br />
di assistere 12.400 bambini facendo terminare loro<br />
un ciclo scolastico, ma anche di rafforzare le capacità<br />
delle loro famiglie e delle comunità con piccole attività<br />
generatrici di reddito e cessioni di microcredito e, allo<br />
stesso tempo, di far crescere e trasferire know how alle<br />
associazioni locali (corpi intermedi) che già operano<br />
sul territorio.<br />
«Quando conosci questi bambini non puoi chiamarli<br />
vulnerabili – spiega Lucia Castelli di AVSI, medico e responsabile<br />
del progetto nei tre paesi –, vuoi dire che<br />
ognuno di loro ha valore. Così l’abbiamo ribattezzato<br />
Our Valuable Children, i nostri bambini di valore.»<br />
L’educazione è l’anello centrale del progetto, che comprende<br />
anche doposcuola, cure sanitarie, attenzione ai bisogni<br />
psico-sociali. Un progetto che tiene insieme ragazzi<br />
e famiglie, facendo crescere la comunità. Aiutando<br />
sempre di più questi gruppi a svilupparsi, a prendersi cura<br />
dei propri bisogni e degli stessi figli. La chiave del progetto<br />
è il coinvolgimento di partner locali. Una soluzione<br />
91
PROGETTO OVC<br />
vincente: più di cento associazioni e realtà comunitarie impegnate,<br />
piccole e fragili a volte, ma con grande sensibilità e conoscenza del<br />
territorio. Scolarizzazione, ma anche formazione e sostegno economico<br />
per gli adulti sono una realtà. Rose ne sa qualcosa. Cinquant’anni,<br />
di Gulu, la guerra le ha portato via la famiglia. È stata ferita.<br />
Vive come la maggior parte della popolazione del Nord Uganda in<br />
uno dei tanti campi per sfollati. Con i soldi ricevuti ha acquistato<br />
una bicicletta per andare al mercato a vendere la verdura. Simon, invece,<br />
ha perso una gamba nell’esplosione di una mina e deve prendersi<br />
cura dei suoi sette figli. Il denaro di AVSI gli serve per comperare<br />
carbone e poi rivenderlo. Non si tratta di grandi guadagni, ma<br />
sufficienti per tornare ad avere fiducia e ricominciare davvero.<br />
A Kitgum AVSI sostiene un centro di recupero per ex ribelli. La cosa<br />
più traumatica «è quando sono costretti a fare del male ai loro<br />
amici… ed è uno dei metodi con cui i ribelli catturano il loro volere<br />
e la loro persona. Spesso sono costretti a picchiare fino alla<br />
morte un compagno che è scappato. Questo – continua Lucia Castelli<br />
– genera un senso di colpa da cui è difficile tirarsi fuori». Il<br />
bambino ucciso viene tagliato per mostrarne il sangue. Gli viene<br />
rotto il cranio e i bambini sono costretti a calpestarne i pezzi. Lo<br />
raccontano gli stessi fuggitivi. Immagini che ritornano negli incubi<br />
notturni e nei loro disegni.<br />
Nell’ospedale missionario St. Joseph di Kitgum la vera grande sfida<br />
in corso è l’AIDS: fare nascere figli sani da madri sieropositive<br />
grazie alle terapie antiretrovirali è possibile. Da anni AVSI porta finanziamenti<br />
e conoscenze, mettendo insieme progetti e donatori<br />
in base alle necessità reali della popolazione. Qui mamme incinte<br />
partecipano a corsi di formazione sanitaria e accettano di sottoporsi<br />
al test dell’AIDS. Le donne che risultano positive entrano<br />
fin da subito nel programma di prevenzione materno-fetale che le<br />
accompagnerà durante la gravidanza – ma anche dopo il parto –<br />
attraverso cure mediche, psicologiche e nutrizionali. I figli, invece,<br />
una volta cresciuti andranno a scuola grazie all’aiuto a distanza:<br />
«Oltre ad accompagnare nella quotidianità le persone malate,<br />
con diverse attività, sosteniamo gli orfani – spiega Ketty Opoke,<br />
direttrice del Meeting Point di Kitgum, un partner locale –. Abbiamo<br />
iniziato nel 1993 con 13 bambini. Oggi ne seguiamo 447».<br />
Abbandoniamo il Nord e scendiamo fino a Kampala, nel quartiere<br />
di Kireka, su una delle sette colline della capitale. Qui si incontra l’Acholi<br />
Quarter. «Sosteniamo circa 2000 bambini, quasi tutti orfani, e<br />
lavoriamo con altrettanti adulti.» A parlare è Rose Businguye, direttrice<br />
del Meeting Point International, ONG locale impegnata nella cura<br />
dei malati di AIDS. Sono donne del Nord, scappate dalla guerra, ferite<br />
dalla vita e dalla malattia (Cfr. «Un invito andato a vuoto», p. 69).<br />
Lasciamo l’Uganda per Nairobi, la capitale del Kenya, secondo paese<br />
del progetto. La popolazione in cerca di benessere ha abbandonato<br />
la campagna riversandosi ai bordi delle città, luogo dove il desiderio<br />
di vita migliore si è arenato.<br />
Kibera è una delle più grandi baraccopoli del mondo, in cui vivono<br />
oltre 750.000 persone. L’ambiente è degradato. Manca tutto:<br />
servizi, luce, acqua potabile e sistema fognario. La spazzatura è<br />
ovunque. Le case Plastica, avanzi di legno e tante lastre arrugginite.<br />
Ed è proprio qui, in questa foresta di lamiere, che è nata una<br />
scuola tutta particolare.<br />
Little Prince, costruita nel 1999 per soli nove bambini, oggi accoglie<br />
circa 200 studenti. In brevissimo tempo è divenuta un punto di riferimento<br />
per le famiglie della comunità e nel maggio 2005 è stata<br />
inaugurata ufficialmente dal ministro dell’Educazione keniota. Leonida<br />
Capobianco è il responsabile di AVSI in Kenya. Ci racconta del<br />
progetto nato per educare bambini, a cui sono seguiti corsi di alfabetizzazione<br />
per adulti e prestiti per le famiglie che volessero iniziare<br />
piccole attività.<br />
Nelle zone rurali la dispersione scolastica è molto alta. Andare a<br />
prendere l’acqua, per aiutare i genitori, significa camminare mezza<br />
giornata e non avere tempo per lo studio. Ma c’è un’altra difficoltà:<br />
il sovraffollamento. Classi di 120 studenti con un solo insegnante.<br />
Una situazione difficile da gestire. A spiegarlo è Cyprian Kaliunga,<br />
direttore della Don Bosco Association, una ONG con cui AVSI lavora<br />
dal 1999 nella zona di Mutuati. La sua scuola conta 1757 ragazzi e<br />
«riusciamo a mantenere un’educazione di qualità».<br />
Il terzo paese coinvolto nel progetto OVC è il Rwanda, la terra del genocidio<br />
del 1994 e oggi delle epidemie che uccidono 17 persone ogni<br />
92
NELLA TERRA DELLE EMERGENZE<br />
mille abitanti. Un dato che ha fatto salire il paese al tredicesimo posto<br />
nella classifica mondiale per tasso di mortalità.<br />
Con le violenze il valore della vita si è offuscato. AVSI ha iniziato a<br />
lavorare per riaffermarlo e il tentativo più significativo è quello che<br />
i volontari della ONG chiamano «Tende»: le attività itineranti per la<br />
prevenzione e la sensibilizzazione sull’AIDS. È un paese caratterizzato<br />
da colline dove molti villaggi sono isolati. «Non si può pretendere<br />
che la gente cammini interi giorni per raggiungere un centro di<br />
salute o una scuola.» Siamo a Kigali, la capitale, con Riccardo Bevilacqua,<br />
responsabile di AVSI in Rwanda. «Per vincere la povertà – di-<br />
93
NELLA TERRA DELLE EMERGENZE<br />
ce – è necessario che sia l’educazione a raggiungere la popolazione<br />
e non viceversa. Serve stimolare un fattore educativo affinché le<br />
persone si mettano in moto insieme.»<br />
Così è successo a Humure. Qui la «tenda» mobile è diventato un centro<br />
nutrizionale in pianta stabile a cui si sono aggiunti un reparto di<br />
maternità dove le mamme possono partorire i propri figli senza paure<br />
e un centro per combattere la malattia.<br />
La filosofia delle «tende» è proprio questa: assistenti sociali, educatori<br />
e animatori tengono insieme bambini, uomini e donne. Giocano<br />
con i primi, sensibilizzano i secondi. Filmati, rappresentazioni<br />
teatrali, balli e canti fanno da contorno.<br />
Eric ha 17 anni. È reduce da un corso sul valore della vita. Aveva<br />
messo incinta una ragazza e l’aveva abbandonata. Il corso gli ha<br />
fatto capire le conseguenze del suo gesto. Ora anche se ancora non<br />
l’ha sposata ha deciso di aiutarla a crescere il loro bambino. Marceline<br />
ha 24 anni, il sostegno a distanza le ha permesso di studiare. La<br />
sua famiglia, povera e numerosa, si era rifugiata nella Repubblica<br />
Democratica del Congo durante il genocidio. Con molte difficoltà<br />
è riuscita ad ottenere un diploma di assistente sociale. «Ho potuto<br />
crescere e uscire dalla povertà, imparando quanto sia rilevante<br />
avere accanto delle persone che ti sostengono.» Ha deciso di lavorare<br />
nel suo paese in un progetto insieme all’AVSI.<br />
95
PERSONE E COMUNITÀ
PERSONE E COMUNITÀ<br />
Tempo fa un articolo dello scrittore israeliano David Grossman<br />
raccontava della disperata invidia per la riuscita del<br />
negoziato di pace tra repubblicani e unionisti nell’Irlanda<br />
del Nord. Come hanno fatto, si chiedeva lo scrittore E qual è la<br />
ricetta Non possiamo applicarla anche qui da noi per trovare una<br />
soluzione alla guerra israelo-palestinese Come facciamo ad imparare<br />
il cammino Fateci un corso, diceva Grossman, fateci partecipare<br />
alle vostre riunioni. E aggiungeva: dobbiamo cominciare<br />
dalle cose semplici: rivolgerci la parola con interesse reciproco (e<br />
non soltanto per affermare la propria posizione), «spendere» del<br />
tempo insieme, essere disponibili, manifestare una sincera volontà<br />
di incontro, anche personale (forse soprattutto personale). Perché<br />
non ne siamo capaci<br />
Qualche anno dopo, l’intervento pronunciato al Meeting di Rimini<br />
2007 dal giornalista irlandese John Waters (e pubblicato in La<br />
verità, il nostro destino, Mondadori Università, Milano 2008) pareva<br />
involontariamente rispondere alle questioni poste dolorosamente<br />
da Grossman. Waters parlava del premier e del vice premier<br />
nord-irlandesi, che per anni erano stati acerrimi nemici e che ora<br />
sedevano insieme al governo: «Eppure per molti anni non sono<br />
stati capaci di pronunciare i reciproci nomi senza tremare d’odio<br />
e di disprezzo. Non si tratta semplicemente di buona educazione:<br />
sembra davvero che si stimino reciprocamente, dimostrano una<br />
sintonia reciproca fatta di affetto e di rispetto. Forse è l’immagine<br />
più forte che abbiamo visto in una vita di cronache del conflitto.<br />
È vera. È umana. Si avvicina molto all’impossibile, ma si sta riproponendo<br />
quasi quotidianamente. Di rado una immagine è stata<br />
capace di modificare la pubblica percezione, di farci riflettere profondamente<br />
sulla natura del conflitto che portò protestanti a massacrare<br />
cattolici e cattolici a spezzare giovani vite protestanti. Perché<br />
suggerisce che è successo qualcosa di trascendente, qualcosa<br />
che supera il normale ambito d’azione della politica». Più avanti<br />
Waters prova a descrivere questo «qualcosa di trascendente»:<br />
«Non si è trattato di una riconciliazione sdolcinata realizzata nell’interesse<br />
della pacificazione, ma di un profondo rapporto umano<br />
che ha superato le barriere ideologiche, storiche e politiche tra<br />
questi due uomini… Questa riconciliazione umana è stata alimentata<br />
da un contesto assai più ampio, da un profondo mutamento<br />
nella cultura circostante e questa riconciliazione personale, di due<br />
persone, ha a propria volta alimentato i mutamenti che le hanno<br />
dato vita». Ci sono stati pensieri e bisogni che hanno toccato la volontà,<br />
che si sono tramutati in parole e decisioni, in programmi<br />
condivisi: Waters racconta bene il processo che lui definisce simile<br />
«allo sbrinamento di un frigorifero», in cui la pazienza e la determinazione<br />
si sono alleate per un lungo tempo.<br />
Le prossime pagine di questo capitolo non hanno alcuna relazione<br />
storica, politica e nemmeno geografica con il Medio Oriente o<br />
con l’Irlanda del Nord. Ma c’è una profondissima relazione culturale.<br />
«Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano<br />
il cuore dell’uomo» diceva don Luigi Giussani: è esattamente quello<br />
che John Waters descrive a proposito della pace di Belfast, un<br />
cammino che si dipana dal cuore alla storia e viceversa; viene da<br />
pensare che se la pace in Medio Oriente non arriva è perché non<br />
riesce compiere lo stesso itinerario.<br />
Ma in che senso si parla qui di una relazione culturale tra realtà<br />
tanto distanti È nel senso della frase di don Giussani. Nelle<br />
esperienze di Haiti, del Brasile e del Paraguay emerge il tema della<br />
persona. Di quella singola, inimitabile, irripetibile, unica persona.<br />
E del suo rapporto con la comunità, con l’ambiente (con<br />
la «storia»). Rinascita della persona è rinascita della comunità,<br />
poiché la persona rinasce nella comunità, rinasce per la comunità.<br />
Un principio che vale in tutto il mondo, in tutti i mondi. In Ir-<br />
99
PERSONE E COMUNITÀ<br />
landa del Nord come tra le devastazioni di Haiti, in Medio Oriente<br />
come nelle favelas di Salvador de Bahia. Attenzione: si tratta<br />
di un principio, non di una ricetta. Nelle cose umane non ci sono<br />
garanzie a priori, né tempi predeterminati. Tutto parte dalla<br />
persona, dalla sua centralità, dalla sua indispensabilità, dal suo<br />
mistero. È incredibile l’energia di cui una persona è capace, il suo<br />
cuore come una batteria pronta a ricaricarsi al sole di ogni giorno.<br />
Nelle pagine successive si vedrà cosa accade quando si mette<br />
la persona al centro. La persona e la comunità di persone. Non<br />
sono concetti astratti o simbolici. Si tratta di quella madre di Novos<br />
Algados, di quel malato della parrocchia di San Rafael, di quel<br />
giovane di Cité Soleil (che a dispetto del nome è uno dei quartieri<br />
urbani più tristi e poveri del pianeta). Sono loro e i loro amici<br />
che iniziano a «sbrinare» il frigorifero e così come hanno fatto<br />
gli antichi nemici di Belfast, da una goccia si può arrivare alla pace<br />
o a risanare una intera favela. Cambiano i contesti e le condizioni,<br />
quel principio è all’opera dovunque ci sia qualcuno che lo<br />
fa suo.<br />
100
IL QUARTO MONDO DEI CARAIBI<br />
«<br />
Abbiamo fame!» gridava la gente marciando con violenza<br />
nella zona più rurale di Haiti. Sedie scagliate sulle vetrine<br />
dei negozi, auto bruciate ed echi di spari ovunque. Migliaia<br />
di persone riversate sulle strade.<br />
Carlo Maria Zorzi – rappresentante di <strong>Avsi</strong> – non dimenticherà<br />
mai quel mese di rivolta. Era l’aprile 2008: «Interi quartieri distrutti,<br />
caos totale su tutta l’isola. Il Palazzo Nazionale quasi assaltato<br />
dai manifestanti, fermati dalla sicurezza con mezzi da controguerriglia<br />
urbana. La situazione a Les Cayes, nel Sud-ovest del<br />
Paese, era terribile.»<br />
Il prezzo di riso, fagioli e latte condensato – non c’è quello fresco<br />
ad Haiti – era cresciuto del 50%, quello della pasta raddoppiato.<br />
Le persone si scatenavano contro gli aumenti: gli ennesimi in pochi<br />
anni. Volevano che il presidente René Preval se ne andasse, così<br />
come l’ONU e il contingente della Minustah, la missione delle<br />
Nazioni Unite con il compito di riportare ordine nel paese. «Il Ministero<br />
del Commercio è stato distrutto da lanci di pietre, il senatore<br />
del Sud – racconta Zorzi – è stato picchiato e salvato dal linciaggio<br />
dalla polizia. La sua casa data alle fiamme, stessa sorte riservata<br />
all’auto del ministro dell’Agricoltura.»<br />
Haiti è uno dei paesi più poveri al mondo, il più povero dell’America<br />
Latina. Insomma il quarto mondo dei Caraibi. Nota come<br />
«perla delle Antille» negli anni Sessanta, è il primo stato a ottenere<br />
l’indipendenza nell’America centro-meridionale e da sempre<br />
protagonista di una storia tormentata.<br />
Il 78% della popolazione vive con meno di due dollari al giorno,<br />
mentre il 47% è analfabeta. 23 bambini su cento sotto i cinque anni<br />
sono denutriti, il 46% dei ragazzi non termina la scuola primaria<br />
e solo il 2% completa quella secondaria.<br />
Nel febbraio 2004 il capo di stato di Haiti, l’ex-prete cattolico Jean<br />
Bernard Aristide, è costretto a lasciare il paese squassato da scioperi<br />
e fazioni in lotta. Da allora una missione dell’ONU a guida brasiliana<br />
ha il compito di riappacificare l’isola. Preval, ministro dal<br />
1995 al 2000 e politicamente vicino ad Aristide, vince le elezioni<br />
nel 2006. Si trova ad affrontare una situazione troppo complessa<br />
dove la povertà non è il solo grave problema. C’è quello della ripresa<br />
economica e di un apparato pubblico inesistente, la sicurezza<br />
dei cittadini, la lotta al narcotraffico e quello della crisi alimentare.<br />
E se la crescita di prezzo degli alimenti di base è dovuta a cause<br />
più internazionali che interne al paese, la crisi alimentare ha<br />
messo in luce un altro dato negativo: quello di un potere d’acquisto<br />
debolissimo.<br />
<strong>Avsi</strong> arriva ad Haiti nel 1999. A chiamare l’ONG italiana è il nunzio<br />
apostolico Cristophe Pierre per un progetto di supporto alla Facoltà<br />
di Agraria dell’Università Cattolica di Les Cayes. Sull’isola, infatti,<br />
il sistema economico si regge sul settore agricolo, che impiega<br />
il 67% della forza lavoro del paese. Un sistema ancora orientato<br />
verso la sussistenza secondo quello che i tecnici chiamano mixed<br />
cropping, vale a dire la coltivazione simultanea di diverse colture in<br />
un unico appezzamento di terra. Ciò che caratterizza questo settore<br />
però è un’arretratezza cronica che vede di anno in anno sempre<br />
più ridotto il livello di autosufficienza alimentare. Dal 1985 al 2003<br />
questo indice è passato dall’85 al 50%. Un deficit solo in parte coperto<br />
da aiuti alimentari e da importazioni, che inevitabilmente genera<br />
un aumento dei tassi di malnutrizione.<br />
Un paese, quindi, dai grandi primati negativi a cui si deve aggiungere<br />
l’allarme sulla mortalità infantile e giovanile, oggi rispettivamente<br />
intorno all’80‰ e al 119‰.<br />
<strong>Avsi</strong>, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di<br />
Milano, l’Università Notre Dame di Haiti e con l’aiuto dei fondi<br />
8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, dà vita in pochi mesi<br />
ad un’azienda agricola sperimentale dove ricerca universitaria e<br />
cultura contadina potessero incontrarsi. Una compenetrazione<br />
che ha consentito ad alcuni agricoltori, con il favore del clima tro-<br />
101
HAITI<br />
picale, di raggiungere i tre raccolti annui, quadruplicando la produzione<br />
di riso.<br />
L’azienda è divenuta un riferimento per lo sviluppo agricolo locale<br />
e nei prossimi anni è prevista una progressiva meccanizzazione<br />
delle coltivazioni che consentirà ai contadini di migliorare ulteriormente<br />
la produzione.<br />
La diffusione di nuove conoscenze tecniche e le competenze acquisite<br />
dagli studenti della Facoltà di Agraria di Les Cayes costituiscono<br />
un fattore importantissimo di innovazione per la lavorazione<br />
della terra e il corretto sfruttamento delle risorse naturali<br />
al fine di garantire alimenti sufficienti al fabbisogno della popolazione.<br />
La dilatazione di tecniche agricole e di allevamento anche minima<br />
si è dimostrata fondamentale per la crescita del paese. Nasce così<br />
il secondo programma di sviluppo rurale.<br />
Siamo nel 2004 e decisivo si rivela il contributo economico<br />
dell’8‰ dello Stato italiano volto a sostenere 200 famiglie con<br />
bambini denutriti. Il lavoro di UNICEF e FAO, coordinato da AVSI,<br />
fa sì che nel 2007, attraverso centri nutrizionali creati ad hoc per<br />
l’occasione, le madri di 350 ragazzi venissero coinvolte in attività<br />
102
103
104
IL QUARTO MONDO DEI CARAIBI<br />
di formazione ed educazione. Un intervento globale che contemporaneamente<br />
ha interessato – attraverso un supporto tecnicostrumentale<br />
– anche l’attività agricola dei padri di questi bambini.<br />
Haiti occupa un terzo dell’isola di Hispaniola, sugli altri due terzi<br />
sorge la Repubblica Dominicana. Un territorio in prevalenza<br />
montuoso, fortemente soggetto a disboscamento e desertificazione.<br />
Un fattore che – secondo stime dell’United Nations Development<br />
Programme (UNDP) – dal 1987 al 2000 ha ridotto della<br />
metà – dal 9 al 4% – il tasso di copertura forestale, con una diminuzione<br />
annua delle riserve legnose pari al 3,25%.<br />
Il problema è vastissimo, in gran parte dovuto alla cattiva gestione<br />
delle risorse naturali (suolo, acqua, copertura vegetale ecc.), a<br />
cui vanno aggiunte la crescente richiesta di legna necessaria a<br />
soddisfare il fabbisogno energetico delle famiglie, l’assenza di<br />
una politica e di un quadro legislativo specifici, e gli esiti degli<br />
uragani che annualmente colpiscono l’area.<br />
Per contribuire alla riforestazione del territorio AVSI, in collaborazione<br />
con le organizzazioni contadine, ha preparato vivai a crescita<br />
rapida di piante da foresta e da frutto formando, insieme alle autorità<br />
pubbliche in loco, organizzazioni di base per la piantumazione.<br />
105
HAITI<br />
Spesso agli haitiani si rimprovera scarsa capacità di iniziativa,<br />
una certa apatia dovuta al clima ma soprattutto a progetti di sviluppo<br />
assistenzialistici, caratterizzati da una grande distribuzione<br />
di prodotti alimentari che azzerano lo spirito d’intrapresa e<br />
generano dipendenza verso le organizzazioni umanitarie. Non è<br />
il caso delle tredici famiglie di Houck, famiglie con bambini denutriti<br />
coinvolti nel secondo progetto di <strong>Avsi</strong>. Siamo in una zona<br />
della costa vicino a Les Cayes dove le persone sono dedite<br />
principalmente alla pesca, una pesca primitiva che si avvale di canoe<br />
ricavate da tronchi d’albero. Imbarcazioni molto fragili con<br />
cui non è possibile allontanarsi dalla costa. Questi tredici nuclei<br />
familiari avevano deciso di organizzarsi in cooperativa di pesca<br />
e con il sostegno di <strong>Avsi</strong> hanno potuto recuperare tutto il materiale<br />
necessario per la costruzione di una barca a vela, un mezzo<br />
robusto con cui pescare in alto mare.<br />
Risale al 2000 il progetto di sostegno a distanza nella capitale Port<br />
au Prince. Un progetto realizzato insieme all’organizzazione SA-<br />
PHA e finalizzato alla scolarizzazione e alla cura di circa 400 bambini.<br />
Quattro anni più tardi <strong>Avsi</strong> ha favorito il reintegro nella società<br />
di 25 giovani legati a gruppi armati. Un’esperienza positiva<br />
che ha portato l’ONG italiana ad estendere la sua missione in uno<br />
dei quartieri più poveri della capitale: Cité Soleil.<br />
Qui <strong>Avsi</strong> realizza diversi progetti per i diritti umani di adolescenti<br />
ed ex combattenti, come l’abbandono delle armi in cambio di<br />
un’educazione e di un’istruzione: attività svolte insieme alla Commissione<br />
Episcopale Giustizia e Pace di Haiti, finanziate dall’Unione<br />
Europea e realizzate in collaborazione con realtà locali come<br />
scuole, centri educativi e parrocchie, a cui <strong>Avsi</strong> fornisce testi<br />
scolastici e tutto il materiale necessario a rinforzare le strutture e<br />
la formazione del personale.<br />
Nella stessa capitale, questa volta con UNICEF, l’ONG interviene<br />
nelle carceri. Si occupa di programmi educativi per giovani donne<br />
provenienti da contesti di profondo disagio attraverso attività<br />
scolastiche, corsi di formazione professionale e sostegno psicologico<br />
per superare i traumi vissuti.<br />
Quella di <strong>Avsi</strong> ad Haiti è una presenza recente. Una sfida che incarna<br />
le parole di Benedetto XVI del giugno 2008 durante il vertice FAO<br />
di Roma: «Occorre incrementare la disponibilità del cibo valorizzando<br />
l’industriosità dei piccoli agricoltori e garantendone l’accesso<br />
al mercato. L’aumento globale della produzione agricola potrà,<br />
tuttavia, essere efficace, solo se sarà accompagnato dall’effettiva<br />
distribuzione di tale produzione e se essa sarà destinata primariamente<br />
alla soddisfazione dei bisogni essenziali. Si tratta di un cammino<br />
certamente non facile, ma che consentirebbe, fra l’altro, di riscoprire<br />
il valore della famiglia rurale: essa non si limita a preservare<br />
la trasmissione, dai genitori ai figli, dei sistemi di coltivazione, di<br />
conservazione e di distribuzione degli alimenti, ma è soprattutto<br />
un modello di vita, di educazione, di cultura e di religiosità.»<br />
106
LA CITTADELLA DELL’AMORE<br />
In tutta Asunción è difficile trovare qualcuno che non conosca<br />
la parrocchia San Rafael. Recentemente il parroco, l’italiano<br />
padre Aldo Trento, è stato insignito delle «chiavi della città»<br />
con una cerimonia che ha stupito persino la CNN. Ma la fama della<br />
parrocchia non si limita alla capitale del Paraguay. A quattrocento<br />
chilometri c’è Ciudad del Este, città contrabbandiera e selvaggia<br />
per antonomasia. Capita spesso che i giudici del tribunale locale si<br />
rifacciano alla legge che concede ai condannati per reati pecuniari<br />
di espiare la pena versando denaro alle iniziative di carità (in alternativa<br />
il carcere): le opere parrocchiali sono tra le più gettonate.<br />
San Rafael è un posto che vuole assomigliare a una «riduzione», reducción,<br />
le comunità degli indios guaraní create nel 1600 dai missionari<br />
gesuiti. A loro (Ruiz de Montoya, Antonio Sepp, che sono tra<br />
i preferiti qui) sono dedicate molte delle scritte che decorano il recinto<br />
parrocchiale, così come molti dei libri della piccola casa editrice<br />
omonima.<br />
Il Paraguay, che prima delle varie guerre era molto più esteso, è la<br />
terra delle reducciones. Oggi non ne rimangono che rovine, da pochi<br />
anni disseppellite e restaurate, così come solo da pochi anni la<br />
lontana memoria di quei centocinquanta anni di «cristianesimo fe-<br />
107
PARAGUAY<br />
lice» – come scrive Ludovico Antonio Muratori – sta tornando a<br />
galla. Le reducciones sono state un luogo di vita comunitaria eretto<br />
per l’evangelizzazione, la libertà e la difesa degli indios, altrimenti<br />
destinati alla schiavitù o alla morte. Esperienza di straordinaria intensità<br />
cristiana, le riduzioni vennero spazzate via a metà del 1700<br />
con la ferocia di un potere invidioso e inumano. Una civiltà sepolta<br />
troppo presto e che ai più resta purtroppo sconosciuta.<br />
Quattro secoli dopo quei gesuiti (che il film Mission con Robert<br />
De Niro e Jeremy Irons rese celebri), la parrocchia San<br />
Rafael si presenta come una reducción. Padre Aldo viene da<br />
Belluno e alle orecchie di un italiano il suo spagnolo è reso allegro<br />
e comprensibile dalla movenze della parlata veneta.<br />
Appartiene alla Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San<br />
Carlo Borromeo, una delle esperienze più tipiche e originali<br />
nate dal movimento di Comunione e Liberazione. Fu proprio<br />
don Giussani a parlare ad Aldo delle reducciones nel momento<br />
in cui gli propose di partire nel 1989.<br />
Il Paraguay è un paese pieno di tanti mondi diversi. I pochi<br />
ricchissimi e i tanti poveri, gli indios e gli spagnoli, le donne,<br />
moltissime senza marito, e gli uomini che una sociologia a<br />
buon mercato dipinge come sfaccendati buoni a nulla. Ma<br />
soprattutto la città e la campagna. E cioè Asunción, fondata<br />
nel Cinquecento dagli spagnoli sulle rive del rio Paraguay, e<br />
un paio di altri centri degni di nota, accanto a tutto il resto del<br />
paese. Dalla piazza della Cattedrale di Asunción, sulla quale<br />
campeggia il grande stemma della Repubblica, lo sguardo si<br />
perde verso il Chaco, che comincia al di là del fiume: una<br />
grande steppa tropicale. Come le altre realtà urbane dell’America<br />
Latina anche Asunción si trova a cavallo tra Terzo<br />
Mondo e Duemila, ma è più modesta, più provinciale delle<br />
cugine del Cono Sur, priva di slanci architettonici e strade<br />
maestose.<br />
Nel 1870, alla fine di un spaventoso conflitto con Argentina,<br />
Uruguay e Brasile, il rapporto tra donne e uomini in Paraguay<br />
era di tre a uno, la popolazione era diminuita di una percentuale<br />
oscillante tra il venti e il cinquanta per cento. Secondo i<br />
paraguaiani risalgono a quel momento le difficoltà del paese,<br />
mai più risolte, tra cui anche quella delle famiglie rette dalla sola<br />
forza delle donne.<br />
La vita di San Rafael offre un contrasto spettacolare con i ritmi e<br />
le immagini del resto del paese. La gente che popola gli spazi parrocchiali,<br />
i volontari, la quantità e varietà di opere di carità, di cultura<br />
e missione. La scuola, il caffè letterario, il coro polifonico, la<br />
108
LA CITTADELLA DELL’AMORE<br />
pizzeria, il Centro di aiuto alla vita, l’ambulatorio, il sistema<br />
di assistenza medica, la distribuzione di cibo e vestiti e poi il<br />
«gioiello» della clinica per malati terminali, lo scrigno che racchiude<br />
il cuore di padre Aldo e padre Paolino, che l’hanno voluta<br />
sfidando tutto e tutti: la «Casa della Divina Provvidenza»<br />
dedicata a San Riccardo Pampuri. È già stata l’ultima casa per<br />
centinaia e centinaia di malati, raccolti dalle strade e dagli altri<br />
ospedali che non volevano più tenerli. Un addio alla vita<br />
dato tra lenzuola candide e infermiere amorevoli, soccorsi e<br />
medicati come in nessun altro luogo, circondati di amore e<br />
tenerezza.<br />
La clinica dipende dalla parrocchia, dalla sua storia recente<br />
e da quella di padre Aldo. Nasce nel maggio 2004 e col passare<br />
degli anni si è trasformata e allargata più volte. Oggi sono<br />
in costruzione nuovi spazi. Da allora sono quasi 600 i<br />
malati di AIDS (18%), cancro (63%) o altre patologie ospitati<br />
dalla clinica, 500 dei quali accompagnati alla morte. Ridare<br />
dignità umana a questi poveri abbandonati è una delle sfide<br />
principali della clinica «di modo che – dice uno dei volontari<br />
– quando arriva il momento finale, quello della morte,<br />
possano essere pronti e riposare veramente in pace».<br />
Ma la San Riccardo non è l’unica opera nata in seno alla parrocchia<br />
San Rafael. Da essa si dipana una lunga catena di<br />
opere caritatevoli realizzate grazie al contributo privato e<br />
personalissimo della gente. La casa di accoglienza Padre<br />
Pio, ad esempio, raccoglie malati di AIDS emarginati e abbandonati<br />
che, non necessitando di stare nella clinica perché<br />
«nonostante tutto in buone condizioni», non hanno un<br />
luogo dove vivere.<br />
Il policonsultorio Juan Pablo II, invece, nasce nel 2002. Qui,<br />
con la carità di alcuni amici medici che offrono il proprio tempo<br />
libero, viene fornita un’assistenza sanitaria gratuita. Dalla cardiologia<br />
alla ginecologia, dalla pediatria alla psicologia o all’odontoiatria,<br />
passando per la chirurgia vascolare, sono 14.872 le persone assistite<br />
dall’ambulatorio tra il 2003 e l’aprile 2008. Si distribuiscono farmaci<br />
e si effettuano visite o si accerta la necessità di interventi specialistici<br />
presso studi convenzionati. Poi la distribuzione di indumenti<br />
e alimenti legata all’attività del Centro di aiuto alla vita, grazie<br />
al quale 70 famiglie della parrocchia sono aiutate, e quella del<br />
Centro di Formazione Umana Integrale grazie al quale centinaia di<br />
persone vengono formate e informate per quel che concerne salute,<br />
cultura ed evangelizzazione. Così può capitare di visitare la parrocchia<br />
mentre è in corso un seminario sulla salute riproduttiva o<br />
109
PARAGUAY<br />
sull’educazione sessuale e, un’altra volta, sulla cura della salute e<br />
sulla vita spirituale. Ma la lista di iniziative è difficile da esaurire. La<br />
parrocchia San Rafael è un luogo vivo, un movimento che genera<br />
in continuazione cultura. Il bollettino settimanale della parrocchia<br />
ricorda tutto questo. È il suo XI anno di pubblicazione e quando<br />
abbiamo visitato San Rafael stavano stampando il numero 533.<br />
Con esso si affrontano i principali temi d’attualità, si ricordano gli<br />
appuntamenti e le iniziative della parrocchia. Un altro strumento<br />
culturale è l’«Observador Semanal», un inserto del quotidiano Ultima<br />
Hora, curato da una redazione di parrocchiani i quali, oltre a<br />
pubblicare la catechesi di Benedetto XVI, offrono commenti, analisi<br />
e giudizi sulla realtà politica e sociale del paese.<br />
Ultima arrivata è la Casita de Belén, creata per accogliere i bambini<br />
a rischio, innanzitutto gli orfani di mamme e papà morti nella<br />
Casa della Divina Provvidenza. Fondata l’8 febbraio 2008, la casa<br />
ospita 20 bambini tra i 3 e gli 11 anni. Qui hanno trovato nuovi genitori,<br />
persone che si occupano della loro salute, dell’alimentazione<br />
e del loro sviluppo integrale. Padre Aldo li saluta tutte le mattine<br />
prima di andare a scuola, il cuore giovane della parrocchia,<br />
frequentata da duecento bambini di famiglie povere, aiutati dal sostegno<br />
a distanza dell’AVSI. La scuola, prende il nome da padre Alberto,<br />
altro missionario della Fraternità, per dieci anni parroco ad<br />
Asunción, ora in Ecuador; è stata riconosciuta e abilitata dal Ministero<br />
dell’Educazione nel 2003.<br />
110
IL SEGRETO PER COSTRUIRE SULL’ACQUA<br />
ANovos Alagados le «case» sono costruite su palafitte. Baracche<br />
sul mare che hanno il vantaggio di non essere proprietà<br />
di nessuno. Un luogo dove installarsi abusivamente,<br />
in cui il degrado sociale, ambientale e urbano si fa compagno<br />
alle decine di migliaia di persone che ci vivono.<br />
Arrivando a Novos Alagados la prima immagine che si impressiona<br />
nella mente è quella di tanti pali di legno incastonati nell’acqua<br />
immobile, quasi stagnante e verdastra, non azzurra come quella<br />
della famosissima costa di Copacabana. Pali di legno: resti di vecchie<br />
capanne sul mare; sorelle delle baracche ricostruite poco a lato<br />
con assi che ricordano tanto quelle utilizzate dai muratori italiani<br />
nei ponteggi delle impalcature negli anni Settanta.<br />
Queste passerelle primitive circoscrivono le abitazioni, si incrociano<br />
sull’acqua che riaffiora incorniciata dal legno mentre ci si<br />
addentra nella favela galleggiante. Gli specchi d’acqua sono in buona<br />
parte rivestiti di spazzatura, sacchetti di plastica e nylon abbandonati.<br />
Manca tutto in queste zone.<br />
Salvador de Bahia, Brasile. Una città con cinque secoli di storia.<br />
111
BRASILE<br />
Fondata dai portoghesi nel 1549 e divenuta subito capitale del loro<br />
impero coloniale. Oggi Salvador è la quarta città brasiliana per<br />
numero di abitanti, 3,5 milioni, di cui il 45% abita in aree povere.<br />
L’Università Federale di Bahia ne ha individuate più di quattrocento<br />
e Novos Alagados è una di queste.<br />
La palafitta normalmente è abitata da tre, quattro persone. Difficilmente<br />
si trovano nuclei familiari completi, composti da marito,<br />
moglie e figli. Quasi sempre è la donna che gestisce ed è attenta ai<br />
problemi familiari.<br />
Anche le baracche sono di legno, di due stanze le più spaziose,<br />
separate da tendaggi improvvisati e mai più sistemati. Entrando<br />
troviamo letti ammassati uno accanto all’altro, oggetti sparsi,<br />
pentole appoggiate su mobili rudimentali. Sedie di plastica bianca,<br />
quelle dei nostri giardini per intenderci, incastrate una sull’altra.<br />
Gli «accampamenti» si caratterizzano per il disordine.<br />
Nell’«atrio» c’è una vecchia poltrona di pezza, qualche foto e disegno<br />
affissi alla parete. Una TV 16 pollici e uno stereo ci riportano<br />
al mondo contemporaneo: quello di un Brasile dalle mille<br />
contraddizioni.<br />
I 796 miliardi di dollari di PIL mettono il Brasile all’undicesimo posto<br />
nel mondo. Ma anche terzo, dopo Cina e Russia, nella classifica<br />
dei paesi con il maggiore debito estero. Al quarantanovesimo,<br />
invece, per il tasso di disoccupazione e ancora undicesimo per<br />
produzione industriale.<br />
Il primo tentativo di recupero dell’area Novos Alagados risale agli<br />
anni Settanta. Fasi di risanamento si alternano a fasi di sviluppo,<br />
ma l’esperimento fallisce e la gente torna ad abitare le palafitte. Sono<br />
i «nuovi allagati», appunto.<br />
Nel 1987 diventa arcivescovo di Salvador di Bahia il futuro cardinale<br />
Moreira Neves. È lui, colpito dal degrado degli alagados, a<br />
chiedere il soccorso di AVSI.<br />
L’ONG italiana arriva a Bahia negli anni Novanta. Non è una new<br />
entry nel grande paese. Da anni, 1300 chilometri più a sud, AVSI collabora<br />
con la pastorale delle favelas di Belo Horizonte. L’esperienza<br />
decennale maturata sul campo attraverso progetti di legalizzazione<br />
e miglioramento delle condizioni di vita dei favelados facilita<br />
la sua immedesimazione con la popolazione di quest’area degradata<br />
tutta particolare.<br />
In poco tempo, il primo gruppo di «volontari» guidati da don<br />
Giancarlo Petrini, oggi vescovo ausiliare di Salvador, riesce ad entrare<br />
nella vita delle famiglie locali, individuandone le esigenze.<br />
Da lì a poco sorge un asilo per l’infanzia, destinato ad ampliarsi<br />
nel centro educativo Giovanni Paolo II quando i ragazzini cominciano<br />
ad entrare nell’età scolastica. Questa prima opera, inaugurata<br />
nel 1993 dal cardinale di Bahia, viene ampliata nel 1999 grazie<br />
alla collaborazione con la Federazione Italiana Umano Progresso.<br />
Tre anni prima, nel 1996, gli interventi di Salvador Bahia e di Belo<br />
Horizonte vengono presentati tra le migliori 100 best practices alla<br />
Seconda Conferenza delle Nazioni Unite Habitat II di Istanbul,<br />
finalizzata ad approfondire le tematiche legate al fenomeno dell’urbanizzazione.<br />
«Parallelamente alla crescita dei ragazzi era evidente – racconta<br />
uno dei ‘volontari’ – che il momento critico dei 12-14 anni diventava<br />
uno scoglio talvolta insormontabile. Il richiamo della violenza,<br />
della droga, dell’illegalità è spesso irresistibile». Da questa consapevolezza<br />
è sorto poi, con il contributo della Regione Lombardia,<br />
un centro di formazione professionale nel settore edile. È<br />
proprio «la mancanza di speranza – spiega monsignor Giancarlo<br />
Petrini, anche direttore dell’Istituto di Studi per la Famiglia a Salvador<br />
– che fa crescere tanto gli indici della violenza, soprattutto<br />
nelle città. I ragazzi di 15, 16, 17 anni cominciano a rendersi conto<br />
che difficilmente, attraverso il sacrificio e lo sforzo, riusciranno<br />
a superare le loro circostanze di miseria e questo, forse, è il dramma<br />
più grande del Brasile attuale: la difficoltà di trovare la vera<br />
strada della speranza.»<br />
Il 1993 è la data di inaugurazione del progetto pilota, quello che i<br />
tecnici chiamano di urban upgrading, o riqualificazione urbana. Un<br />
piano che avrebbe dovuto interessare 500 famiglie, ma che in realtà<br />
ha coinvolto tutta la comunità di Novos Alagados. 3713 nuovi<br />
nuclei abitativi per un totale di 14.415 abitanti coinvolti, di cui il<br />
38% proveniente da palafitte. Questi alcuni numeri del Progetto<br />
ampliato grazie alle sovvenzioni del governo di Bahia, del Mini-<br />
112
113
BRASILE<br />
stero degli Affari Esteri italiano e della Banca Mondiale. Le infrastrutture,<br />
il progetto di urbanizzazione, quello di rimozione delle<br />
palafitte e di costruzione e miglioramento delle case fatiscenti, ma<br />
anche quello di riduzione della povertà, sarebbero state tuttavia insufficienti<br />
se non fossero stati accompagnati da un supporto per lo<br />
sviluppo delle comunità coinvolte, necessario per garantire la sostenibilità<br />
dei miglioramenti acquisiti con gli interventi.<br />
Nelle comunità, anche le più carenti, si celano capacità e risorse<br />
umane e sociali che per AVSI costituiscono il loro vero patrimonio<br />
nascosto. Il progetto pilota, chiuso nel 1999, lo ha dimostrato. E<br />
in forza di questo, mantenendo al centro delle proprie azioni la dignità<br />
della persona, AVSI ha deciso di estendere a tutta l’area intorno<br />
a quella di Novos Alagados il proprio intervento.<br />
Nasce così il programma «Ribeira Azul», un insieme di aree situate<br />
nella zona del suburbio: quattro chilometri quadrati di superficie<br />
per 135 mila abitanti, considerata fra le aree più degradate<br />
della città. Qui il 45% della popolazione in età attiva<br />
non genera reddito, il 59% ha un reddito familiare di<br />
45 dollari al mese, la metà del salario minimo, il 21% della<br />
popolazione in età scolare ha abbandonato la scuola e<br />
il 71% è in ritardo con il piano di studi. C’è poi un altro<br />
45% che dichiara di avere difficoltà ad accedere ai servizi<br />
di salute pubblica e un 20% che pratica l’automedicazione.<br />
Si tratta di un progetto da 60 milioni di dollari, quasi tutti<br />
reperiti nel 1999 grazie al contributo di enti come il<br />
Banco interamericano di sviluppo, la Cassa Economica<br />
e Federale, la Banca Mondiale, il governo dello stato e la<br />
Municipalità di Bahia. Ma decisivo si rivela l’intervento<br />
del Ministero degli Esteri italiano che nel 2000 decide in<br />
favore del progetto lo stanziamento di 5 milioni di euro<br />
alla Banca Mondiale, con il coinvolgimento della giovane<br />
«Cities Alliance», l’ONG che ha come testimonial Nelson<br />
Mandela.<br />
Siamo nel 2000. Ha inizio la prima fase del programma.<br />
Vale a dire quella serie di indagini censorie e a campione,<br />
che attraverso il contatto diretto con le famiglie e le organizzazioni<br />
del territorio si rivela utile a definire le caratteristiche<br />
socio-economiche, antropologiche ed educative delle persone. Un<br />
«ritratto» costantemente condiviso, attraverso diversi incontri, con<br />
la popolazione che ha permesso di individuare i principali campi di<br />
intervento: innanzitutto infrastrutture e area socio-educativa. Ma<br />
l’indagine ha anche un altro merito. Quello di mostrare – come peraltro<br />
l’esperienza precedente – una trama, seppur fragile, di aggregazioni<br />
della società civile, soprattutto in ambito educativo, per far<br />
fronte alle necessità quotidiane. Asili, luoghi di educazione informale<br />
come di aggregazione per adolescenti. E doposcuola, case di<br />
accoglienza e di sostegno per ragazze madri, associazioni per il diritto<br />
alla casa. Insomma, una serie lunghissima di «corpi intermedi»<br />
già operativi su servizi alla persona, che si sono rivelati attivi<br />
protagonisti del progetto «Ribeira Azul».<br />
114
IL SEGRETO PER COSTRUIRE SULL’ACQUA<br />
Il miglioramento urbano, lo sviluppo economico e sociale,<br />
il coinvolgimento e il rafforzamento di questi «corpi<br />
intermedi» come quello delle istituzioni non sono un<br />
discorso astratto. Un rafforzamento anche in termini finanziari<br />
verso i progetti – selezionati attraverso processi<br />
competitivi – gestiti e realizzati dalle associazioni locali,<br />
con l’assistenza tecnica di AVSI. Una modalità che ha<br />
offerto opportunità di sviluppo e di curriculum alle ONG<br />
locali, favorendone il processo di crescita e consolidamento.<br />
Questa forma di assistenza tecnica ha garantito<br />
l’apertura dei finanziatori (Banca Mondiale, governo<br />
ecc.) verso le associazioni comunitarie e un dialogo sempre<br />
più aperto e costruttivo che tanto ha contribuito alle<br />
valutazioni positive, in termini di partecipazione comunitaria,<br />
date dalle associazioni stesse.<br />
Dopo cinque anni dall’avvio del Progetto di Appoggio Tecnico<br />
e Sociale (PATS) sono 73 le organizzazioni comunitarie<br />
rafforzate e 13 le strutture (asili, scuole ecc.) costruite<br />
o ristrutturate. 78 i progetti sociali realizzati<br />
nell’ambito di educazione, famiglia e salute. 7 le cooperative<br />
di lavoro costituite e/o formate nel settore tessile,<br />
alimentare e di costruzione civile e altrettante le<br />
opere educative realizzate o ampliate. 1268 palafitte<br />
sono state rimosse, 373 le nuove case costruite e 221<br />
quelle migliorate. Dal 2000 al 2006, inoltre, il collegamento<br />
alla rete idrica è passato dal 36,6% al 70,7%,<br />
quello della rete elettrica dal 72,2% all’ 88,4%. Ancora<br />
più sorprendente è il dato relativo al sistema fognario, se<br />
si pensa che all’inizio era quasi del tutto assente. Nel<br />
2006 è passato dal 21,4% all’84,4% e nello stesso anno<br />
la percentuale di abitazioni senza unità sanitaria si è notevolmente<br />
ridotta, dal 30,6% al 3%.<br />
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la valorizzazione<br />
e il finanziamento di quei «corpi intermedi»<br />
– veri e propri stakeholder del progetto – , principali<br />
interlocutori comunitari protagonisti dalla pianificazio-<br />
115
BRASILE<br />
ne all’attuazione delle azioni, in un processo intenso di riunioni,<br />
visite e incontri.<br />
«L’aiuto di un popolo – ha detto Giovanni Paolo II – non deriva<br />
né dal denaro, né dagli aiuti materiali […], bensì dalla maturazione<br />
della mentalità e dei consumi. È l’uomo il protagonista dello<br />
sviluppo non il denaro o la tecnica.» Sono 1339 gli operatori sociali<br />
con una formazione qualificata acquisita nel corso del progetto<br />
e 306 le persone formate in corsi professionalizzati. 204<br />
quelle delle comunità locali che hanno lavorato per la costruzione<br />
di opere e cooperative, 114 i giovani formati in corsi professionali,<br />
562 quelli coinvolti in attività ricreative e 79 gli operatori educativi<br />
che hanno ricevuto il titolo necessario secondo la legge sull’educazione<br />
infantile.<br />
José Eduardo Ferriera Santos è uno di questi. La sua famiglia fino a<br />
dieci anni fa viveva su una palafitta. Oggi, dopo la laurea in pedagogia<br />
e il dottorato in psicologia dello sviluppo, opera come professionista<br />
all’interno della componente socio-educativa del programma<br />
di Ribera. Ma è anche il coordinatore di un asilo,<br />
quello dedicato a don Giussani, nato nell’area. Nessuno<br />
meglio di lui può testimoniare il valore di una presenza<br />
creativa e operativa che cambia la vita.<br />
José è uno dei primi adolescenti coinvolti dal «Progetto<br />
Novos Alagados» dei primi anni Novanta. Per noi ritorna<br />
a quegli anni. Ricorda che l’arrivo di iniziative sociali<br />
ed educative ha permesso agli adolescenti dell’area di fare<br />
esperienza di qualcosa di nuovo e diverso. Di conoscere<br />
il mondo esterno. «L’urbanizzazione – continua –<br />
ha portato opportunità di lavoro. La mobilitazione sociale,<br />
indotta dagli interventi, ha creato vincoli tra le persone<br />
e le famiglie.» Ha trovato una via di speranza e si è<br />
fatto compagno di tanti ragazzi della sua comunità. Lo<br />
scrive nella sua pubblicazione Travessias, a adolescência em<br />
Novos Alagados. Con l’arrivo delle prime iniziative educative<br />
informali gli adolescenti hanno trovato adulti che<br />
iniziavano a diventare riferimenti. Riferimenti che avevano<br />
perduto. Queste iniziative hanno favorito la scolarizzazione<br />
fino a portare diversi gruppi di giovani all’università. E<br />
questa possibilità ha cambiato la vita di molti adolescenti abituati<br />
alla violenza. Di fronte a due possibilità – racconta – «da un lato<br />
lo sport, la cultura e l’educazione, dall’altro la droga e il furto, alcuni<br />
hanno seguito la speranza, altri la marginalità».<br />
Eduardo ci racconta questa alternativa attraverso le storie di quattro<br />
ragazzi che ha seguito come educatore. Uno di questi ha passato<br />
un’adolescenza tra la vita regolare e la delinquenza. Determinante<br />
fu il rapporto con un adulto del centro educativo che frequentava.<br />
La musica e lo sport, la proposta di una vita orientata al<br />
bello lo portano, una volta concluso il percorso educativo, intorno<br />
ai 18 anni, a desiderare un lavoro regolare che trova. A 24 anni<br />
però, mentre si precipita in soccorso al cognato ferito da un aggressore,<br />
viene colpito e muore. La madre, con cui aveva avuto un<br />
rapporto di rispetto e amore, certo, ma molto conflittuale, ha detto<br />
che il desiderio di suo figlio, quello di uscire dalla marginalità,<br />
116
IL SEGRETO PER COSTRUIRE SULL’ACQUA<br />
in fondo si era realizzato. «Giovane elettricista ucciso» titolava il<br />
giornale locale. Non uno sbandato, ma un lavoratore era stato ucciso<br />
dalla violenza.<br />
Come questa sono tante le storie che parlano di persone la cui vita<br />
cambia attraverso l’incontro con adulti e proposte che rispondono<br />
al desiderio umano. I ragazzi, ma anche gli adulti, di fronte<br />
ad una proposta di bellezza e di bene, anche se immersi nella violenza,<br />
nell’emarginazione e nella precarietà ne sentono il fascino.<br />
La sfida sta nel metterli in condizione di poter fare la scelta. Questa<br />
è la valenza educativa di ogni progetto.<br />
117
LAVORARE SALVA
LAVORARE SALVA<br />
Una recente indagine ha rivelato che per il 75% degli americani<br />
la paura più profonda – un vero incubo – non riguarda<br />
il terrorismo, ma la perdita del lavoro e di conseguenza<br />
la perdita della propria posizione sociale. Il dato contiene<br />
due elementi interessanti. Primo, il senso di assoluta precarietà<br />
con cui si vive la dimensione del lavoro nelle società industrializzate.<br />
Nell’era della globalizzazione ogni giorno milioni di persone<br />
si svegliano nel timore che quello potrebbe essere l’ultimo giorno<br />
di un impiego in fabbrica o in ufficio. Quello che per molti anni<br />
nel dopoguerra è stato un quadro stabile di esistenza e relazioni,<br />
un percorso chiaro e quasi «garantito», ciò che appunto veniva assicurato<br />
al lavoro, da un lavoro, da tempo si è sbiadito e ingrigito.<br />
Del resto, uno scenario al 2030 delineato nel 2006 dalla Banca<br />
Mondiale metteva in chiaro che nel grande sommovimento planetario<br />
della globalizzazione ci sarebbero stati certamente dei perdenti:<br />
i lavoratori privi di specializzazione nei paesi ricchi a causa<br />
della concorrenza di una forza lavoro che preme sulle economie<br />
avanzate e che da 3 miliardi di individui aumenterà (entro venticinque<br />
anni) a 4,1 miliardi. Uomini e donne, ma con particolare<br />
gravità per le donne. Il secondo elemento di interesse di quell’indagine<br />
è il legame indissolubile tra lavoro e posizione sociale. Non<br />
dobbiamo intendere posizione sociale nel senso dell’onorabilità e<br />
della rispettabilità (almeno non in primo luogo), ma nel senso del<br />
rischio concreto che la perdita dell’impiego trascini con sé la perdita<br />
della casa, poiché non si può pagare il mutuo o l’affitto, della<br />
scuola per i figli, poiché non si può più pagare la retta, dell’assicurazione<br />
sanitaria, poiché non si può più pagare il premio. Il timore<br />
di essere risucchiati nella povertà: un fenomeno sociale che negli<br />
Stati Uniti è stato ben studiato e raccontato sia dal linguaggio<br />
scientifico, sia da quello simbolico del cinema o del romanzo.<br />
Questi due elementi, l’arbitrarietà cui è sottoposto il lavoro e il peso<br />
che ha rispetto a tutto il complesso dell’esistenza, suggeriscono<br />
fattori reali, veri, evidenti. È quasi ovvio riconoscere il valore<br />
del lavoro nella vita dell’uomo. Il fatto è che questo valore ha<br />
subìto una trasformazione mostruosa, passa attraverso gli specchi<br />
deformanti della non cultura, della non educazione, e ci viene<br />
restituito come un mero espediente per restare agganciati al<br />
treno che passa. Un mestiere, un contratto, un salario, un orario:<br />
la povera umiliante nevrosi con cui nel nostro mondo si vive il<br />
lavoro e che inevitabilmente genera gli incubi (così come il sonno<br />
della ragione).<br />
Scriveva l’allora cardinale Ratzinger: «La persona umana non è<br />
mai sola, essa viene plasmata da una comunità che le offre le forme<br />
del pensare, dell’agire, del sentire. Questo insieme di forme di<br />
pensare e di rappresentare, che plasma in antecedenza l’essere<br />
umano, la chiamiamo cultura […] Nel mondo greco al nostro<br />
concetto di cultura corrisponde quale termine più adeguato la parola<br />
paideia – educazione nel senso più alto in quanto conduce<br />
l’uomo alla vera umanità; i latini hanno espresso la stessa cosa con<br />
la parola eruditio: l’uomo viene di-rozzato, viene formato quale vero<br />
essere umano». Se il valore del lavoro è stato distrutto è per la<br />
mancanza di paideia e di eruditio. E se vogliamo ricostruirlo è da qui<br />
che occorre partire. Ciò risulta più chiaro nelle situazioni estreme,<br />
nei deserti (anche umani) del Kazakhstan o nelle baraccopoli del<br />
Kenya. Un mestiere non basta a riempire il bisogno, nemmeno<br />
quello materiale. Perché qualunque mestiere, anche il più semplice<br />
e modesto, è legato indissolubilmente non alla «posizione sociale»,<br />
ma al modo con cui si pensa a se stessi, alla propria dignità,<br />
alla responsabilità verso la famiglia e la comunità, all’intero spazio<br />
della propria esistenza.<br />
A Nairobi, per progettare l’avviamento al lavoro serve paideia, serve<br />
cultura, serve una connessione con il tutto, serve uno sguardo<br />
121
LAVORARE SALVA<br />
integrale sulla persona. E lo stesso ad Almaty, la vecchia capitale<br />
kazakha, per poter coinvolgere duemila giovani nel processo di<br />
costruzione del proprio futuro. E come si sarebbe potuto fare diversamente<br />
a Belo Horizonte, in Brasile, per far crescere quell’«Albero<br />
della vita» che ha visto protagonista addirittura la Fiat Automobili<br />
Brasile Così nel sud del Libano è possibile (possibile, non<br />
garantito) stemperare conflitti e tensioni tra le comunità, aiutando<br />
l’attività dei contadini, ricreando condizioni materiali e morali<br />
del vivere insieme. Ecco quello che si coglie nella lettura delle<br />
prossime pagine. Ogni singolo progetto è frutto di eruditio, di una<br />
cultura, di una «forma del pensare, dell’agire, del sentire». Cioè:<br />
nelle società «altre», povere o in via di sviluppo, si fa l’esperienza<br />
del lavoro che le nostre società hanno fatto all’origine e che ha<br />
permesso loro di raggiungere livelli di progresso e benessere senza<br />
pari. Solo che oggi non riescono più a fare quell’esperienza e temono,<br />
come registra la Banca Mondiale, la «concorrenza» che<br />
porterà via impieghi e posizioni sociali. Ma c’è un’altra possibilità:<br />
tornare alla cultura, alle parole del greco e del latino, che oggi<br />
occorre imparare di nuovo, magari attraverso l’esempio di una<br />
scuola africana o di una cooperativa nella valle della Bekaa.<br />
122
UN FIUME PER RICOMINCIARE<br />
Baalbek – la città sacra dei regni fenici – ha una storia antica<br />
e tormentata. Qui venivano consumati i sacrifici umani<br />
pretesi dai sacerdoti del crudele Baal, il dio del sole. Qui i<br />
romani edificarono gli imponenti templi di Bacco, Giove e Venere,<br />
sopravvissuti alle guerre e ai secoli.<br />
Oggi questa città leggendaria è centro dell’integralismo sciita, culla<br />
di Hezbollah – il partito di Dio –, protagonista negli ultimi anni<br />
degli scontri con Israele e della tumultuosa vita politica libanese.<br />
Da Baalbek seguiremo il flusso di solidarietà, impegno e finanziamenti<br />
che contribuisce a trasformare fiumi e corsi d’acqua in<br />
frutto di benessere e convivenza.<br />
Siamo in Libano, nella valle della Bekaa, settanta chilometri circa<br />
a nord-est di Beirut. In questa fertile pianura, sulle rive del fiume<br />
Litani, si sono stabilite decine di migliaia di persone delle più diverse<br />
comunità. Sciiti, cristiani, sunniti e drusi vivono della stessa<br />
risorsa, l’acqua, fondamentale per il loro fabbisogno e per quello<br />
dei loro campi. E ci sono anche contadini o lavoratori stagionali<br />
provenienti dalla vicina Siria. A spiegarcelo è uno di loro: «Venia-<br />
123
124
125
LIBANO<br />
mo all’inizio dell’estate e ce ne andiamo quando comincia<br />
a fare inverno. Guadagniamo 400 lire libanesi, mentre<br />
in Siria ce ne danno 300».<br />
L’acqua non è solo una risorsa indispensabile. In un paese<br />
diviso fra comunità e confessioni religiose, lacerate in<br />
passato da sanguinosi conflitti, questa fonte primaria<br />
può divenire facilmente un pericoloso fattore di divisione.<br />
Farla scorrere, strapparla a montagne e rocce, portarla<br />
a irrigare campi e piantagioni contribuisce a favorire<br />
il benessere delle diverse comunità, sviluppando un’equilibrata<br />
e pacifica convivenza.<br />
A Baalbek vivono più di centomila persone. Dipendono<br />
da due fonti – le sorgenti del fiume Litani sulle alture<br />
circostanti – e da altrettanti depositi idrici.<br />
Nell’estate 2006 esplode la guerra. Hezbollah invade il<br />
territorio israeliano distruggendo un’unità militare. La<br />
controffensiva non si fa attendere. Hassan Nasrallah,<br />
leader del partito di Dio, è obiettivo delle operazioni<br />
israeliane: i centri di Hezbollah vengono bombardati e<br />
con essi gran parte delle infrastrutture. A farne le spese,<br />
insieme alla popolazione, è anche una cisterna da tre milioni<br />
di litri d’acqua. Un capolavoro ingegneristico, costruito<br />
sulle ceneri di un antico acquedotto romano, finalizzato<br />
all’approvvigionamento idrico di 150.000 abitanti<br />
nella valle della Bekaa.<br />
In meno di un anno AVSI, con il contributo di ECHO, il<br />
programma europeo per l’emergenza umanitaria, ha<br />
portato a termine la ricostruzione del deposito idrico<br />
che rifornisce di acqua potabile Baalbek. Ma per riportare<br />
l’acqua nei canali è stato necessario riabilitare il<br />
complesso sistema di imbrigliamento delle sorgenti sulle<br />
creste montagnose a poche centinaia di metri dalla<br />
frontiera siriana.<br />
La sorgente di Juini è una di queste. Si trova a meno di<br />
un chilometro dal confine con la Siria. «A pochissimi<br />
metri dalla fonte – spiega Marco Perini di AVSI in Liba-<br />
126
UN FIUME PER RICOMINCIARE<br />
no – abbiamo trovato tracce di fortificazioni romane<br />
ancora intatte.» I vecchi gradini utilizzati in passato per<br />
ridurre in modo naturale la pressione dell’acqua sono<br />
stati sostituiti da moderni centri di depressurizzazione<br />
collocati tra la fonte e la città di Baalbek e collegati da un<br />
sofisticato sistema di tubature. Insomma, un complesso<br />
lavoro di ripristino che ha permesso la ripresa dell’agricoltura<br />
e delle coltivazioni anche nella pianura della Bekaa<br />
a sud di Baalbek.<br />
«Quando è stata colpita questa valle – racconta un pastore<br />
– siamo rimasti senz’acqua, non potevamo irrigare<br />
i campi. Non potevamo più coltivare e raccogliere<br />
nulla.» L’acqua pompata dal lago Karaoun al Canale<br />
900, appena riabilitato, attraversa per 45 chilometri la<br />
pianura permettendo l’irrigazione di tutta l’area sotto ai<br />
900 metri d’altitudine.<br />
Ma irrigare a volte non basta. Nelle zone della Bekaa gli<br />
agronomi devono riuscire a coniugare acqua e nuove<br />
tecnologie. Mescolare tradizioni agricole con nuove conoscenze<br />
per trasformare argilla in zolle fertili e rigogliose.<br />
Per questo motivo a Kartaba, grazie a fondi del<br />
Ministero degli Affari Esteri italiano, della Conferenza<br />
Episcopale Italiana e dell’Unione Europea (Programma<br />
MEDA), è stato creato un centro di formazione e di assistenza<br />
tecnica per più di 100 agricoltori e allevatori della<br />
regione di Jbeil-Byblos. Centro che, dal giugno 2006,<br />
è divenuto partner del progetto per la «Promozione dell’Agricoltura<br />
sostenibile in Libano» finanziato dalla Regione<br />
Lombardia. L’introduzione di questo centro per<br />
lo studio dei terreni, di nuove tecniche agricole e d’allevamento<br />
con la conseguente produzione e commercializzazione<br />
di prodotti tipici per il mercato locale, ha permesso<br />
che a beneficiarne fossero indirettamente 100<br />
mila persone.<br />
A Beirut incontriamo Fedi Khomair, direttore del Ministero<br />
libanese delle Acque e delle Risorse Energetiche.<br />
127
LIBANO<br />
Da anni collabora con AVSI e Unione Europea per trasformare le<br />
risorse idriche del paese in fonte di sviluppo e convivenza. «Nella<br />
Bibbia – ci dice –, nel Nuovo Testamento e pure nel Corano, l’acqua<br />
è usata per purificare. È usata per annunciare quello che chiamiamo<br />
vita. Con le attività di AVSI è stata data l’acqua a libanesi<br />
sciiti, cristiani, sanniti o drusi, senza alcuna differenza.»<br />
Nel sud del paese le rovine della recente guerra sono ancora uno<br />
scenario consueto. Bunker, fortificazioni e bandiere ricordano come<br />
esercito israeliano e miliziani di Hezbollah continuino a studiarsi<br />
e a fronteggiarsi. È in queste terre, dove il fiume Litani piega<br />
a ovest per sfociare nel Mediterraneo, che sono stanziati dall’estate<br />
2006 i 13 mila caschi blu delle Nazioni Unite della missione<br />
UNIFIL.<br />
Nei villaggi a ridosso di questa frontiera la vita deve comunque<br />
andare avanti: i campi devono venire irrigati e coltivati, e i raccolti<br />
incrementati. «La sorgente di Dardara si trova proprio nel mezzo<br />
della piana di Marjayoun e serve a irrigare molti terreni – spiega<br />
Maya Aoun –. La sua acqua viene utilizzata dai contadini di entrambe<br />
le comunità: da quelli di Khiam, musulmani sciiti, e da<br />
quelli di Klaya e Bourj al Muluk, cristiani.» Proprio qui AVSI, con i<br />
fondi della Cooperazione Italiana (Programma ROSS) e la collaborazione<br />
tecnico-scientifica della Facoltà di Agraria dell’Università<br />
degli Studi di Milano, sta riabilitando il sistema di distribuzione<br />
della fonte lungo oltre 5000 metri.<br />
Ripartire dalle sponde del Litani, il ribattezzato «fiume della convivenza»,<br />
per rilanciare il Libano dopo i sanguinosi combattimenti<br />
di luglio e agosto 2006 ha significato e significa quindi sostenere<br />
decine di migliaia di persone delle diverse comunità. AVSI, attiva<br />
in Libano dal 1996, è presente con uffici a Beirut, Jounieh, Marjayuon<br />
e in West Bekaa, e un’equipe composta da cinque esperti<br />
italiani e una ventina di persone reclutate in territorio libanese.<br />
Oggi sono cinque i progetti realizzati nel paese, alcuni dei quali<br />
con i finanziamenti della Cooperazione Italiana. Progetti di grandi<br />
dimensioni come quello denominato «Acqua sorgente di convivenza:<br />
interventi di sviluppo socio-economico e agro-ambientale<br />
nella Kaza di Marjayoun e in West Bekaa», l’ultimo di cui abbiamo<br />
parlato. Un progetto che vedrà 4700 beneficiari diretti e<br />
20.650 indiretti, attraverso la gestione del sistema irriguo della piana,<br />
la creazione di un network di commercializzazione dei prodotti<br />
agricoli, la riduzione della filiera commerciale e un sistema di<br />
monitoraggio dei prezzi. Ma anche il sostegno scolastico e sanitario<br />
di 300 bambini vulnerabili, attività socio-educative (pubbliche<br />
e private) in 10 scuole e quelle psicosociali in altrettante, la formazione<br />
di 40 insegnanti e di 30 assistenti sociali e la redazione e diffusione<br />
di un giornalino interscolastico sono alcuni dei tanti interventi<br />
previsti e in via di completamento.<br />
«Acqua sorgente di convivenza: fiume Nahr El Kalb» è la denominazione<br />
di un altro progetto, iniziato nel 2007 con il contributo<br />
della Regione Lombardia. E questa volta a beneficiarne saranno<br />
circa un milione di persone tra la regione del Kesrouan e la capitale.<br />
La descrizione generale delle caratteristiche del bacino per<br />
le acque superficiali e sotterranee, l’individuazione delle aree sensibili<br />
e vulnerabili e la mappa delle reti di monitoraggio, l’indicazione<br />
degli obiettivi di qualità e quella delle misure per il loro raggiungimento<br />
sono solo una parte delle azioni previste da questo<br />
intervento, che durerà fino all’aprile 2009.<br />
Nel 2006, durante il conflitto, era scattato un progetto d’emergenza<br />
per sfollati con la distribuzione di cibo e generi di prima necessità.<br />
Dopo il conflitto, oltre ad azioni di post-emergenza, AVSI ha<br />
sostenuto la ripresa delle attività nel settore agricolo, fonte di sostentamento<br />
di gran parte della popolazione libanese. È il progetto<br />
di «Promozione dell’Agricoltura sostenibile in Libano», in collaborazione<br />
con Regione Lombardia, di cui hanno beneficiato direttamente<br />
250 persone, ma che ne ha coinvolte indirettamente altre<br />
1250. L’intervento ha visto la formazione di 40 tecnici sulle<br />
metodologie Integrated Pest Managemant (IPM), 15 Farmers Field<br />
Schools, la realizzazione di tre Protocolli di Produzione (patata,<br />
melo e pesco) e l’accompagnamento degli agricoltori alla commercializzazione<br />
di tali prodotti.<br />
Insomma, progetti recentissimi e di lunga data come quello del<br />
sostegno a distanza, con 1800 bambini delle diverse comunità aiutati<br />
attraverso il pagamento delle rette scolastiche e la fornitura di<br />
128
UN FIUME PER RICOMINCIARE<br />
materiali didattici, l’assistenza sanitaria e attività generatrici di<br />
guadagno per le famiglie. Attività ricreative e socio-culturali utili a<br />
ricostruire una speranza messa a dura prova da decenni di scontri<br />
e conflitti.<br />
La casa di Fatima, nel villaggio di Khiam, è stata colpita almeno<br />
tre volte durante il conflitto del 2006. «Certo che ho paura che torni<br />
la guerra. Ho paura di dover scappare, lasciare la mia casa e andarmene<br />
di nuovo.» A casa di Laila, una bambina cristiana di Klaya,<br />
le paure e le ansie sono le stesse: «Ho trent’anni. Sono nata durante<br />
la guerra, mi sono sposata con la guerra, ho partorito mentre<br />
c’era la guerra – afferma la mamma –. Non riesco proprio a<br />
sperare nella pace.»<br />
Qui a sud, per ridare speranza alle famiglie AVSI investe nell’educazione<br />
e nella creazione di microimprese familiari. I fondi del sostegno<br />
a distanza, messi a disposizione di circa 150 bambini di<br />
questa zona, servono soprattutto a coprire i costi dell’istruzione.<br />
Vengono pagate le spese a Laila, iscritta alla scuola delle suore nella<br />
cittadina di Klaya, e a Fatina, che frequenta la scuola pubblica di<br />
Khiam. Ma il sostegno più importante è quello al lavoro: «Sono<br />
venuti a trovarci e ci hanno fatto avere una mucca, poi è nato il vitello<br />
e ora la mucca ci dà latte e yogurt. Papà li vende, ci guadagna<br />
dei soldi e può comperare da mangiare per noi». A casa di Faris sono<br />
invece arrivate cinque arnie di api: «A sud c’è molto da fare. Ci<br />
vive poca gente e non c’è lavoro. Avevo perso il mio perché non<br />
c’era più richiesta. Mi hanno offerto un’opportunità, pagandomi<br />
cinque arnie e aiutandomi a far partire questo piccolo progetto.<br />
Assieme a un nuovo lavoro ho trovato anche la possibilità di un<br />
futuro migliore».<br />
129
DUEMILA GIOVANI IN MEZZO ALL’ASIA<br />
Almaty, Alma-Ata in russo, è la città più popolata del Kazakhstan;<br />
è la capitale della Repubblica Socialista Sovietica<br />
dal 1929 al 1991 e poi della Repubblica kazaka fino al<br />
1998, quando le sedi governative vengono trasferite nella più centrale<br />
Astana. Il nome significa «padre delle mele» quasi a suggerire<br />
il luogo d’origine leggendaria del frutto. Qui nel 1991 venne firmato<br />
il trattato che pose fine all’Unione Sovietica e qui abitano oltre<br />
un milione di persone, poco meno del 10% di tutto il paese.<br />
Siamo nel Kazakhstan sudorientale, in Asia centrale, a poche centinaia<br />
di chilometri dalla muraglia cinese. Una terra di deserti e rari<br />
agglomerati urbani. Luoghi bruciati dal sole d’estate e ricoperti<br />
di neve nei mesi invernali. Posti in cui le temperature possono<br />
sfiorare i quaranta gradi e precipitare al di sotto dello zero di 20,<br />
25 gradi durante l’inverno.<br />
Nella seconda metà del XIX secolo queste terre vengono conquistate<br />
dagli eserciti zaristi, diventano parte dell’impero russo e della<br />
sua colonia meridionale, quel Turkestan che prendeva il nome<br />
dalle parlate dialettali turche della popolazione locale.<br />
Nel 1917 una rivolta antizarista viene sobillata dagli stessi coloni<br />
russi e tutta la regione entra definitivamente nell’orbita bolscevica;<br />
nel 1924 viene divisa in cinque repubbliche: Turkmenistan,<br />
Tadzikistan, Uzbekistan, Kirghizistan e – a tappe successive –,<br />
Kazakhstan. Abbandonate le repressioni di massa, Kruscev e poi<br />
Breznev adottano una nuova politica di dominazione: «A capo di<br />
ogni istituzione stava di regola un obruscony locale – scrive il giornalista<br />
polacco Ryszard Kapuscinski, in Imperium – ma il suo vice<br />
era sempre un russo che prendeva ordini da Mosca. Un obruscony<br />
era un russo dell’Asia centrale che aveva preso il posto dell’esigua<br />
intelligencija, vittima delle repressioni staliniane assieme alle masse<br />
contadine e al clero musulmano. A capo di ogni repubblica stava<br />
un visir, primo segretario del Comitato Centrale del partito locale.<br />
Una carica a vita, secondo la tradizione orientale. Diumuchammed<br />
Kunaev fu primo segretario del Kazakhstan per ventisei anni,<br />
ci volle Gorbachev per destituirlo.»<br />
Un paese – nono al mondo per superficie quadrata – lacerato dalla<br />
corruzione, utilizzato per esperimenti nucleari e per lanci spaziali.<br />
Un paese sincopato, a tante – troppe – velocità, con un sottosuolo<br />
ricco di petrolio e minerali, ma con la maggior parte della<br />
società dilaniata da povertà.<br />
Almaty è una città scomposta, dal panorama caotico, caratterizzata<br />
da un complesso snodo di condotti nei quali scorrono, per interminabili<br />
chilometri, le risorse energetiche del sottosuolo. Un<br />
groviglio di tubi, linee argentate che sembrano determinare la fisionomia<br />
degli edifici, così disomogenei gli uni dagli altri. Paradigma<br />
di una popolazione dai tratti somatici differenti.<br />
Una città ai confini del mondo in un paese distante e isolato: vicina<br />
alla Cina, ma con radici nella lontanissima Mosca.<br />
In questo «sobborgo del pianeta» il problema dei minori – orfani<br />
naturali o sociali – è di notevole rilievo. I collegi e le «scuole internato»<br />
dello stato hanno l’obbligo di accogliere i minori fino all’età<br />
di 16 anni e non oltre i 18. Ma una volta fuori da queste strutture la<br />
maggior parte di loro, anche se maggiorenni, non è pronta a camminare<br />
da sola e si perde per strada. Aiutare questi giovani con la<br />
formazione per introdurli nel mercato del lavoro è fondamentale.<br />
Stare con loro, non farli sentire soli, sostenerli nella crescita mostrando<br />
diverse opportunità e aiutarli nella scoperta dei propri talenti<br />
è uno stimolo che accende la scintilla dello sviluppo. Un’attività<br />
che AVSI svolge dal 2002 attraverso diversi progetti realizzati<br />
insieme al partner locale International Association for Social Projects,<br />
(MASP).<br />
Oggi troppi giovani faticano a inserirsi nel mondo del lavoro.<br />
Qualcuno abbandona la scuola non riuscendo poi a trovare un’occupazione,<br />
altri lasciano il lavoro per la mancanza di motivazioni<br />
adeguate. Gli operatori le chiamano «porte verso il disagio», che<br />
131
132
DUEMILA GIOVANI IN MEZZO ALL’ASIA<br />
tradiscono la fatica delle persone nel concepirsi utili, importanti,<br />
insomma un valore. Ecco il motore delle iniziative<br />
in Kazakhstan: la convinzione che a ogni essere<br />
umano deve essere fornita la possibilità di accedere a<br />
percorsi formativi e trovare un lavoro.<br />
«All’origine del lavoro, infatti – spiega Elmira Frizorger,<br />
responsabile di MASP –, c’è la convinzione che i fattori<br />
costitutivi della persona emergano solo dentro l’azione<br />
nei confronti della realtà. Per questo il lavoro è un bisogno<br />
fondamentale della persona, non semplicemente<br />
un dovere o un diritto.»<br />
Già da diversi anni MASP si occupa prevalentemente di<br />
giovani provenienti da esperienze di abbandono o con<br />
situazioni familiari molto difficili. Situazioni nelle quali<br />
è assente il concetto di famiglia, in cui il tasso di istruzione<br />
è estremamente basso e il lavoro manca.<br />
Mentre una fetta della società kazaka sta scoprendo il<br />
«benessere» legato alle attività delle industrie del gas e<br />
del petrolio, l’altra parte sembra andare sempre più alla<br />
deriva: niente istruzione, niente lavoro… e lo stato Lo<br />
stato c’è, ma distratto dai benefici di una nuova e frenetica<br />
economia, non si impegna per consolidare le fragili<br />
basi di una società in cui i cittadini – soprattutto i giovani<br />
– faticano a trovare un futuro e servizi adeguati alla<br />
persona.<br />
Le attività sono diverse, mirano a costruire ponti tra i<br />
giovani e il mondo della scuola o quello del lavoro, seguendo<br />
la scia dello sviluppo urbano che richiede in numero<br />
sempre maggiore nuove aziende, nuove strutture<br />
alberghiere e servizi per accogliere gli investitori. Formare<br />
in queste nuove professioni è un compito fondamentale<br />
e necessario.<br />
L’avventura, incominciata grazie ai primi aiuti economici<br />
provenienti della campagna di AVSI legata alle Tende<br />
del 2002, ha visto differenziarsi diversi progetti, e con<br />
questi i finanziamenti provenienti successivamente an-<br />
133
KAZAKHSTAN<br />
che dalla Commissione Europea, dal governo austriaco e da diverse<br />
associazioni tedesche.<br />
AVSI inizia a lavorare in Kazakhstan nel 1997, dove un sacerdote<br />
italiano era stato nominato direttore della Caritas. Don Adelio<br />
Dell’Oro propone il sostegno a distanza a favore di bambini e famiglie<br />
molto povere della città di Karagandà. Da qui, attraverso il<br />
percorso del sacerdote e di alcuni suoi confratelli, AVSI approda ad<br />
Almaty.<br />
Tre i progetti fondamentali. Il primo è quello che i tecnici chiamano<br />
«Sportello di orientamento e di aiuto all’inserimento lavorativo».<br />
A beneficiarne sono state già 1400 persone. Lo sportello di<br />
Almaty vuole offrire un servizio di orientamento e accompagnamento<br />
scolastico/professionale ai giovani della città e, in particolare,<br />
a quelli provenienti da situazioni difficili. Così, attraverso criteri<br />
suggeriti dal contesto locale e dai singoli utenti, lo sportello<br />
organizza un servizio di accoglienza e un primo colloquio. Crea e<br />
134
DUEMILA GIOVANI IN MEZZO ALL’ASIA<br />
propone un pacchetto individuale di orientamento prodotto da<br />
personale specializzato e, allo stesso tempo, divulga presso istituti<br />
e realtà operanti con ragazzi disagiati informazioni relative alle<br />
possibilità di percorsi di studio. Collabora con istituti, scuole professionali<br />
e strutture pubbliche e organizza seminari di orientamento<br />
per gli studenti. Eroga borse di studio o stipendi per garantire<br />
la frequenza scolastica.<br />
Tra gli scopi c’è anche l’assistenza agli utenti nel processo di inserimento<br />
al lavoro. E sono circa 100 le persone che ne hanno beneficiato<br />
dal 2002. Colloqui, raccolta dati, orientamento occupazionale,<br />
divulgazione informativa e stesura del curriculum. Ma anche consultazione<br />
di giornali e collaborazioni con aziende fino all’organizzazione<br />
di periodi formativi sul campo sono alcune delle azioni<br />
principali. Da anni poi i rapporti con alcune scuole professionali di<br />
Almaty sono sfociati in una collaborazione che vede questi istituti<br />
accogliere ragazzi che MASP invia loro per effettuare percorsi triennali<br />
con specializzazioni richieste dal mercato del lavoro.<br />
Una seconda attività, strettamente connessa alla funzione dello<br />
sportello, è quella dei «Seminari di orientamento e di supporto ai<br />
giovani nella ricerca del lavoro»: seminari per l’orientamento scolastico,<br />
frequentati da almeno 150 ragazzi, e seminari per l’inserimento<br />
lavorativo (100 beneficiari). Si tratta, nello specifico, di una<br />
serie di incontri offerti a ragazzi provenienti da situazioni di abbandono,<br />
disagio e povertà. Un’iniziativa nata dall’esperienza maturata<br />
in questi anni e che ha mostrato la necessità di interventi più<br />
intensivi e specializzati per i giovani che vengono dagli orfanotrofi,<br />
dalle «scuole internato» e dagli istituti speciali. Luoghi estremamente<br />
difficili, veri «deserti umani», nei quali hanno vissuto fin da<br />
bambini e nei quali sono cresciuti. Luoghi che hanno lasciato un<br />
profondo disagio.<br />
I seminari durano 14 giorni e si organizzano in due parti. Nella<br />
prima sezione, «autosviluppo della personalità», gli adolescenti<br />
vengono accompagnati in una maggiore conoscenza di sé, «nell’individuazione<br />
dei propri punti di forza e dei propri punti di debolezza,<br />
focalizzando una strada da percorrere», dice Elmira. La<br />
seconda parte, invece, vuole fornire tutte le informazioni necessarie<br />
sulle possibilità di formazione scolastica e professionale presenti<br />
ad Almaty.<br />
C’è infine il progetto – il terzo, finalizzato alla formazione-lavoro<br />
– legato all’attività del Centro Giovanile di cui hanno beneficiato<br />
circa 100 ragazzi. I corsi – di informatica, segreteria e quelli per<br />
camerieri-barman e aiuto cuoco – terminano con la stesura di un<br />
curriculum vitae e con la preparazione seminariale a un colloquio di<br />
lavoro.<br />
135
KAZAKHSTAN<br />
136
IL CUORE PULSANTE DI UNA BARACCOPOLI<br />
Inurbamento, crescita vertiginosa e squilibrata della popolazione<br />
sono fenomeni di moda a Nairobi da almeno 15 anni.<br />
Da quando, cioè, la città si è trovata protagonista di un clamoroso<br />
sviluppo industriale favorito dagli investimenti di numerosi<br />
paesi occidentali.<br />
Rispetto a dieci anni fa la capitale del Kenya ha triplicato il numero<br />
di abitanti – sono tre milioni le persone che vivono in questa metropoli<br />
africana. Vivono negli slums, le baraccopoli, che circondano il<br />
centro cittadino. Qualcosa del genere era successo in Europa nel XIX<br />
secolo, quando folle di uomini abbandonavano le campagne per riversarsi<br />
nelle catapecchie cittadine vicino alle fabbriche.<br />
In questi insediamenti miseria e precarietà della vita sono condizioni<br />
normali. L’alimentazione insufficiente – pesanti sono le ripercussioni<br />
sulla crescita di bambini e ragazzi –, le condizioni igieniche<br />
e sanitarie precarie, la disgregazione sociale e familiare spesso<br />
causata dall’assenza di lavoro, la mancanza di adeguata formazione<br />
scolastica per i giovani caratterizzano la quotidianità di chi<br />
vive negli slums e nelle zone periferiche della città.<br />
137
KENYA<br />
«Nei giovani – ci spiega Leo Capobianco, country representative di<br />
AVSI in Kenya – il senso di frustrazione e di ribellione è alimentato<br />
dall’impossibilità di trovare un lavoro che assicuri una vita dignitosa.»<br />
Pochi terminano le scuole primarie – un ciclo di studi<br />
dura otto anni – e pochissimi hanno una formazione tecnica professionale.<br />
Vivono di espedienti e di furti, diventano facile preda<br />
della delinquenza.<br />
Chi accede alla scuola secondaria spesso l’abbandona prima dell’esame<br />
finale e solo il 10% di chi completa gli studi può permettersi<br />
anche l’università. Alcuni trovano un’occupazione, la maggioranza,<br />
però, resta disoccupata e tra le cause c’è la scarsa qualifica professionale<br />
– tranne per indirizzi tecnici specifici – offerta dalla<br />
scuola secondaria, mentre la manodopera specializzata è richiestissima<br />
nel settore terziario e nella produzione artigianale.<br />
138
IL CUORE PULSANTE DI UNA BARACCOPOLI<br />
A Nairobi, e in tutto il Kenya, la formazione è certificata dagli esami<br />
«Grade III, II e I» organizzati dal Ministry of Education, Science and<br />
Technology attraverso il National Industrial Vocational Training and<br />
Trade Test Centre. Un livello superiore di istruzione tecnica è costituito<br />
dai corsi professionali «Artisan» e «Craft» a conclusione dei<br />
quali vengono rilasciati dal Ministero dell’Educazione i corrispondenti<br />
titoli di studio. Questi corsi, accanto a una buona formazione<br />
pratica, offrono un’approfondita preparazione teorica.<br />
Oggi in Kenya i corsi di formazione tecnico-professionale (Nairobi<br />
Politechnic) sono offerti da alcuni importanti istituti statali, ma<br />
soprattutto da circa 800 scuole gestite da enti privati, organizzazioni<br />
non governative e ordini religiosi. Il St. Kizito Vocational Training<br />
Institute è una di queste.<br />
La sua storia inizia nel 1991 grazie all'impegno di alcuni volontari<br />
139
KENYA<br />
dell’AVSI e al suggerimento dell’arcivescovo di Nairobi, il cardinale<br />
Maurice Michael Otunga: «Il Kenya e particolarmente Nairobi<br />
hanno un urgente bisogno di luoghi di educazione – scriveva il<br />
cardinale –, specialmente nel settore tecnico: molti sono preoccupati<br />
dei giovani che sono senza lavoro e che spesso rischiano di cadere<br />
nella disperazione o nella criminalità. La nostra preoccupazione<br />
e il nostro impegno verso questo fondamentale bisogno ci<br />
spingono a cercare continuamente delle risposte e sono contento<br />
che AVSI possa offrire assistenza per costruire una scuola tecnica<br />
a Nairobi, che raccolga quei giovani che vivono nella periferia della<br />
città. Sono sicuro che in questa iniziativa saranno presi in considerazione<br />
non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli umani.»<br />
Nello stesso anno comincia la costruzione degli edifici del centro<br />
di formazione che sorge nell’area periferica di Githurai-Kimbo,<br />
con l’urbanizzazione di oltre 20.000 metri quadrati e la realizzazione<br />
di capannoni, aule ed uffici per circa 8000 metri quadrati.<br />
Una superficie utilizzata per le attività della scuola che ospiterà laboratori<br />
di produzione completamente attrezzati e concepiti per<br />
consentire agli studenti di svolgere attività pratiche inerenti al tipo<br />
di corso a cui sono iscritti. Nel 1994 vengono completati i lavori.<br />
Prendono il via i primi corsi di formazione: quelli per falegname,<br />
meccanico ed elettricista. L’anno d’esordio vede 65 iscritti<br />
e otto docenti.<br />
Due anni più tardi, è il 1996, iniziano i corsi per segretaria d’azien-<br />
140
141
KENYA<br />
da e quelli di sartoria rivolti alle giovani donne, nello stesso periodo<br />
con il contributo dell’Unione Europea, la scuola viene ampliata<br />
e nasce la succursale di Roysambu, un quartiere a metà strada<br />
tra Istituto e centro città. Nel 1997, seguendo il consiglio del Ministry<br />
of Technical Training, viene avviato il secondo anno di corsi<br />
per elettricisti, falegnami e meccanici. È l’anno del corso per elettrauto<br />
e quello di computer. Un anno significativo anche dal punto<br />
di vista del partenariato. Dal 1997, infatti, nasce la collaborazione<br />
con Companionship of Work Association (CoWa), una realtà locale<br />
che ha lo scopo di mettere in contatto studente e mercato del<br />
lavoro aiutando nella ricerca di un’occupazione. Ma la lista delle<br />
collaborazioni non termina qui: ci sono anche AREP (Association<br />
Refugee Program), DOSRA (Domenican Sisters Refugee Agency)<br />
e AMECEA (Association of Members of Episcopal Conference of<br />
Eastern Africa).<br />
Nel 2000 si avvieranno i percorsi destinati alla formazione di idraulici<br />
e di tecnici elettricisti, nel 2002 quelli riservati alla preparazione<br />
di tecnici per reti informatiche, Internet e macchine d’ufficio.<br />
La scuola festeggia il decimo anniversario nel 2004. In quell’occasione<br />
gli iscritti sono 350 e 25 gli insegnanti. Tra questi molti dei<br />
primi studenti dell’istituto. I percorsi per meccanici ed elettricisti<br />
vengono riformulati l’anno seguente in modo da preparare i ragazzi<br />
alla prova finale: quella per il titolo di Artisan e Craft rilasciato<br />
dal Ministero dell’Educazione o quella rilasciata dall’ente internazionale<br />
City & Guilds. Il dato è sorprendente. Nel 2006 l’80%<br />
dei ragazzi che ha frequentato i corsi consegue i certificati, richiesti<br />
dalle aziende e utili per chi volesse studiare all’università. Nasce<br />
(e siamo nella storia recente) l’associazione St. Kizito voluta<br />
per dare stabilità alla gestione dell’Istituto Professionale.<br />
C’è una peculiarità che caratterizza la scuola. Rispondendo alla richiesta<br />
dell’allora cardinale di Nairobi, quella di offrire un luogo<br />
educativo soprattutto per i giovani con maggiori difficoltà, economiche<br />
e non, l’istituto ha da sempre aperto le proprie porte anche<br />
a ragazzi che hanno superato l’età scolare. Si tratta per lo più<br />
di ex ragazzi di strada, adolescenti che, grazie al lavoro di alcune<br />
organizzazioni internazionali, hanno abbandonato la strada per<br />
una vita regolare. Ma si trovano spesso anche tanti rifugiati provenienti<br />
da zone e paesi martoriati dalla guerra come Sudan, Congo<br />
o Rwanda. La loro età non supera i vent’anni, a volte sono già<br />
padri di famiglia. La St. Kizito li accoglie offrendo loro l’opportunità<br />
di migliorare la propria condizione di vita.<br />
Gli studenti partecipano alle spese della scuola, versando una<br />
quota pari a 10 euro mensili. Un importo simbolico sufficiente a<br />
motivare e responsabilizzare la loro partecipazione alle attività<br />
proposte. Ciononostante è solo grazie al progetto di sostegno a<br />
distanza che i ragazzi possono far fronte al pagamento dell’intera<br />
retta scolastica, permettendo all’istituto di offrire loro una formazione<br />
completa.<br />
142
L’INDUSTRIA, LA FAVELA E UN NUOVO ALBERO<br />
Il comune di Betim si trova nell’area metropolitana di Belo Horizonte<br />
in Brasile. Qui Fiat Automobili dà lavoro direttamente<br />
a 15.000 persone e indirettamente ad altre 8000. La presenza<br />
di questa zona industriale ha riacceso la speranza di trovare lavoro<br />
e fortuna in una grandissima fetta della popolazione. Così, nel corso<br />
degli anni, l’area limitrofa agli stabilimenti del gruppo torinese<br />
ha visto il sorgere di una baraccopoli di 35.000 abitanti: la favela di<br />
Jardim Terezopolis, un’area molto povera e violenta.<br />
L’immaginario collettivo degli ultimi tempi mostra un’interpretazione<br />
controversa sul ruolo delle imprese nello sviluppo dei paesi<br />
poveri. Le aziende, infatti, sarebbero da una parte soggetti indispensabili<br />
alla soluzione delle situazioni di povertà e dall’altra causa<br />
di conflitti sociali tra ricchi e poveri. Molte imprese hanno voluto<br />
ricollocarsi decisamente dalla parte positiva del dilemma avviando<br />
programmi di responsabilità sociale, cioè azioni visibili<br />
che potessero dimostrare un impegno reale anche nello sviluppo<br />
della società: Fiat è una di queste.<br />
Nel 2004 l’azienda italiana si orienta verso un’azione organica e integrata<br />
sul territorio: un’intuizione di Marco Lage, direttore della<br />
comunicazione Fiat Brasile, consistente nell’entrare con la propria<br />
specificità d’impresa nel paese, mobilitando tutte le risorse tipiche<br />
di un’azienda vincente. Nel frattempo Clodorvino Bellini,<br />
presidente della Fiat e premiato nel 2005 come imprenditore,<br />
mette a disposizione le proprie capacità per favorire la riduzione<br />
della violenza nell’area citata. È in questo momento che Fiat e AV-<br />
SI entrano in contatto grazie all’allora ambasciatore italiano in<br />
Brasile, Vincenzo Petrone: presente a Belo Horizonte da vent’anni,<br />
AVSI risultava un partner solido e affidabile.<br />
Fiat propone un progetto pilota, utile a verificare la sostenibilità<br />
della partnership. Un primo anno di azioni di studio territoriale e,<br />
in un secondo frangente, operative (corsi di formazione, sostegno<br />
alle strutture educative e sportive) in un confronto serrato, ricco<br />
e produttivo.<br />
«L’impresa, abituata a lavorare per obiettivi tutti raggiungibili pagando<br />
un prezzo, ha dovuto aprirsi a un nuovo mondo, con i suoi<br />
ritmi – ci dice Giorgio Capitanio, per oltre 11 anni in Brasile con<br />
AVSI – dettati dalla necessità di un approccio educativo alla questione<br />
della povertà e dalla necessità di un rapporto positivo con<br />
la comunità locale.»<br />
Arvore da vida, cioè «Albero della vita», è il nome del progetto<br />
inaugurato nel 2004. Una collaborazione fatta di incontri costanti<br />
e di confronti continui sulle azioni da intraprendere. Un<br />
progetto che è andato focalizzandosi intorno alla formazione<br />
professionale, al rafforzamento delle realtà educative, scolastiche<br />
e ricreative dell’area. Ma che ha visto anche l’avvio di una cooperativa<br />
di gadget prodotti con gli scarti di produzione, di maglie<br />
e tute da lavoro destinate principalmente alla rete di concessionari<br />
Fiat o alle numerose imprese del territorio. Il progetto<br />
prende il bel nome dal fatto che la crescita è lenta e progressiva,<br />
richiede cura e nutrimento. Insomma, non basta il denaro per lo<br />
sviluppo. Occorrono un lavoro con le persone e la scoperta della<br />
vita come valore.<br />
Il piano ha preso le mosse dalla radiografia socio-economica di<br />
Jardim Terezopolis, dai suoi punti di forza e da quelli vulnerabili.<br />
Una comunità molto complessa dove il 29,2% delle adolescenti<br />
tra i 15 e i 20 anni è protagonista di una gravidanza precoce, dove<br />
il tasso di mortalità infantile è pari all’11‰, dove i bambini colpiti<br />
da denutrizione sfiorano il 45% e dove il 31% delle morti avviene<br />
per cause esterne legate ad incidenti, omicidi e suicidi.<br />
Qui il 9% degli adulti sopra i 15 anni era analfabeta, il 55% della<br />
popolazione non era in possesso di un diploma di scuola dell’obbligo,<br />
solo il 27% degli adolescenti terminava gli studi di secondo<br />
grado e il ritardo scolastico medio dei ragazzi era di tre anni.<br />
L’educazione è uno dei fattori di intervento più significativi. A Jardim<br />
Terezopolis il 57% delle famiglie si trovava sotto la soglia di<br />
povertà, solo un componente lavorava nel 40% dei nuclei familia-<br />
143
BRASILE<br />
ri (composti in media da quattro persone) e dei 1800 giovani tra i<br />
16 e i 24 anni, il 26% si trovava disoccupato.<br />
In questo contesto la strategia ha dovuto privilegiare azioni inerenti<br />
a sviluppo umano, educazione e lavoro, attraverso il coinvolgimento<br />
globale di tutti gli attori presenti sul territorio. Gli 11 operatori<br />
implicati nel 2004 sono diventati 29 nel 2007, 19 dei quali<br />
aziende fornitrici di Fiat. Una partnership che ha interessato società<br />
civile, sistema pubblico e imprese private e che ha permesso<br />
di incidere su tutti i fattori in modo significativo: educazione e<br />
scolarizzazione in primis.<br />
Da allora si sono susseguiti programmi di alfabetizzazione e formazione<br />
professionale per migliorare l’accesso al mondo del lavo-<br />
144
145
146
L’INDUSTRIA, LA FAVELA E UN NUOVO ALBERO<br />
ro di migliaia di adulti, ma anche per le giovani generazioni. Partenariati<br />
con imprese finalizzati all’inserimento dei ragazzi nel<br />
mercato del lavoro a partire dalle esigenze delle imprese stesse,<br />
come per esempio i sistemi di alternanza. Microimprenditorialità<br />
e microcredito per sviluppare il reddito delle famiglie. E ancora:<br />
sostegno personale, familiare e sviluppo umano attraverso<br />
gli attori della società civile.<br />
La proposta fatta a giovani e adolescenti, in gran parte con casi<br />
di violenza alle spalle, è un «ciclo educativo» che inizia al termine<br />
della scuola media (13-14 anni) attraverso attività complementari<br />
(musica, sport, danza) in nesso con la scuola dell’obbligo.<br />
In tal modo si punta a fare emergere nei ragazzi la propria<br />
creatività e le proprie potenzialità. Successivamente si collocano<br />
i corsi di professionalizzazione del centro di formazione<br />
Fiat, gli stage in azienda e la contrattazione definitiva nelle varie<br />
imprese legate all’industria automobilistica.<br />
Ma c’è un ultimo aspetto da sottolineare: favorire lo sviluppo<br />
del territorio significa favorire le iniziative presenti sul territorio.<br />
Questo concetto, fatto proprio dall’azienda torinese, ha permesso<br />
fin da subito il coinvolgimento e la collaborazione con<br />
diversi «corpi intermedi», quella rete di associazioni locali – statali<br />
e non – che hanno potuto allargare le proprie strutture e acquistare<br />
nuove attrezzature grazie a un contributo economico.<br />
Il sostegno ai giovani, l’accompagnamento della famiglia e il rafforzamento<br />
delle 35 associazioni o istituzioni locali rappresentano<br />
la sfida di una comunità-favela che sta iniziando a camminare<br />
da sola. Sono 850 i ragazzi che hanno svolto corsi professionali<br />
dal 2004 e il 55% si è inserito nel mercato del lavoro. Il<br />
92% dei bambini oggi ha migliorato il proprio comportamento<br />
frequentando attività socio-educative, 160 educatori delle 6<br />
scuole di Jardim Terezopolis hanno fatto corsi di aggiornamento<br />
e l’indice di permanenza nella scuola è passato dall’83%<br />
(2004) al 98% (2006). Le gravidanze precoci si sono ridotte da<br />
169 a 148.<br />
Non è un caso, allora, se lo United Nations Development Program<br />
(UNDP) ha inserito il progetto, che dal 2007 ha visto anche<br />
il coinvolgimento di Cooperazione Italiana, tra le migliori pratiche<br />
brasiliane relative all’obiettivo del millennio «partnership<br />
per lo sviluppo». Si può dire senza tema di smentite che l’albero<br />
fiorito a Belo Horizonte rappresenta un esempio sorprendente<br />
di che cosa può fare l’alleanza tra una organizzazione di volontariato<br />
e una grande impresa, due mondi che uno schema ideologico<br />
superficiale e antistorico vuole per forza nemici. È ora di<br />
esportare questo nuovo modello brasiliano.<br />
147
SOSTEGNO A DISTANZA
IL PARTITO DEI SIGNORI SCHMIDT<br />
Numeri nascosti racchiudono forze potenti. Numeri che<br />
non si conoscono. O che quando si conoscono non stupiscono,<br />
se la testa non è disposta a leggerli per bene.<br />
Ora, è decisivo sapere, non solo per il nostro benessere mentale,<br />
ma soprattutto per il benessere sociale, che in Italia ci sono due<br />
milioni di sostegni a distanza. Dietro l’espressione Sostegno a Distanza<br />
(SAD, che ha preso il posto della più ambigua eppure più<br />
eloquente «adozione a distanza») c’è un bambino in povertà. È orfano,<br />
oppure la sua famiglia è in condizioni di estrema indigenza.<br />
Due milioni di bambini che noi italiani sosteniamo. Sostenere è<br />
una azione più precisa e diretta di un generico aiuto. Sostenere è<br />
un verbo che dice di un portare, di un sorreggere, di un accompagnare<br />
solido, fattivo. Altri numeri: il valore globale del SAD è di seicento<br />
milioni di euro (ma diventa incalcolabile se consideriamo<br />
l’indotto di un bambino che può andare a scuola, mangiare in modo<br />
decente, vestirsi ecc.), quattrocento le organizzazioni promotrici<br />
(ma ci sono diverse altre realtà meno formalizzate), sei milioni<br />
gli italiani coinvolti tra singoli, famiglie, aziende, gruppi. Ci si<br />
potrebbe fare un partito… Sono o non sono bei numeri, è o no<br />
un indice di benessere, tra i tanti che declamano la ultradecennale<br />
paralisi nazionale È vero che questi nostri tempi sono ritmati dai<br />
numeri della decrescita: di figli, di stipendi, di aria pulita; mai o<br />
quasi mai da quelli della crescita: del 5 per mille, del sostegno a distanza,<br />
dei progetti andati a buon fine.<br />
Perché fare questa scelta Perché spendere 312 euro all’anno per<br />
sostenere Meriem, Joseph, Fernando, Natalia Impossibile raccontare<br />
le singole vicende dei 35 mila bambini sostenuti a distanza<br />
dall’AVSI. Ma si sappia che per ognuno di loro, e 35 mila sono<br />
tanti, il SAD è stato un’ancora per la vita. Lo descrivono bene i tre<br />
esempi proposti nelle prossime pagine: Nigeria, Ecuador, Brasile,<br />
ecco il rendimento pazzesco ottenuto da una (buona) azione immessa<br />
in un mercato che non si misura a dividendi annuali ma a<br />
malattie guarite, classi frequentate, famiglie ritrovate. Un’azione<br />
semplice, diretta, efficace. Diceva un grande uomo, capace di stupire<br />
con verità elementari (don Giussani): «Bisognerebbe essere<br />
un sasso per non accorgersi del bisogno che ti circonda.» Già, ci<br />
hai mai pensato, sasso che non sei altro Di là dal mondo (dall’oceano,<br />
dalla nostra vita quotidiana, dalla nostra mente) c’è un<br />
bambino che ti aspetta, aspetta che tu gli renda la vita migliore, almeno<br />
un po’. Aspetta (anche da te) la soddisfazione di un diritto<br />
fondamentale, l’educazione. In che senso<br />
Quando a un bambino manca la famiglia, quando gli manca chi gli<br />
assicura il cibo, quando non c’è la scuola che lo istruisce, la comunità<br />
che lo accoglie, il medico che lo cura, il libro che lo aiuta o l’amicizia<br />
che lo consola; quando al posto di tutto questo trova lo<br />
sfruttatore, il rapitore, il ladro, l’assassino, il pedofilo, il plagiatore,<br />
quando trova il disprezzo e l’odio; che cosa manca, che cosa non<br />
trova Noi pensiamo che gli manchi l’educazione, che non trovi<br />
l’educazione. Educazione non è camminare impettiti in fila per<br />
due in un cortile né entrare in un edificio pieno di corridoi e di lavagne,<br />
non è superare un test e nemmeno rispondere a una serie<br />
di domande. Educazione è essere presi per mano da un amore che<br />
apre alla realtà; è camminare con qualcuno che si affeziona al tuo<br />
destino. Chi ama il bene del bambino vuole anche assicurargli anche<br />
il cibo e la protezione, lottare per la sua salute e la sua istruzione,<br />
inserirlo in una comunità di affetti, impegnarsi per il suo futuro.<br />
Ecco cosa fa chi educa. Quando manca questo viene meno un<br />
diritto fondamentale, uno dei pochi diritti davvero fondamentali.<br />
Non possiamo confonderlo con gli altri, annegarlo nel mare dei<br />
tanti diritti di prima, seconda o terza generazione (qualcuno già<br />
151
SOSTEGNO A DISTANZA<br />
parla della «quarta serie») che investono a ondate le organizzazioni<br />
internazionali e l’opinione pubblica mondiale. Infatti c’è un gioco<br />
a confondere e ad annacquare, a mettere tutto sullo stesso piano<br />
come se il diritto alla vita e quello all’igiene, il diritto all’educazione<br />
e quello alla mobilità fossero più o meno la medesima cosa.<br />
Lavorare per il diritto all’educazione significa dunque (ri)trovare<br />
delle gerarchie, tracciare distinzioni, stabilire priorità in un mondo<br />
che ha più voglia di mescolare che di selezionare. Il che vuol dire<br />
assumersi grandi e nuove responsabilità in ordine al mondo e al<br />
suo futuro. Lo sviluppo è innanzitutto un processo educativo.<br />
Attraverso il SAD, con un gesto di attenzione e pochi soldi si accende<br />
un motore potente, capace di arrivare chissà dove, come si<br />
vedrà. Ne sono testimonianza emozionante le lettere che due volte<br />
all’anno arrivano all’«amico a distanza». In esse i bambini, questi<br />
nostri bambini, narrano vicende semplici insieme mirabolanti,<br />
proprio come è la vita guardata con i loro occhi: un bel voto a<br />
scuola, una amicizia, un sogno, un sorriso della mamma, un cielo<br />
azzurro. L’esistenza come un prodigio.<br />
Qualche anno fa il Sostegno a Distanza è stato anche protagonista<br />
di un film, interpretato da Jack Nicholson: A proposito di Schmidt,<br />
la storia struggente di un uomo normale arrivato alla pensione e<br />
con i figli lontani. È solo, e tra giornate tutte vuote e tutte tristi, si<br />
domanda disperatamente come quell’assoluta normalità sia potuta<br />
coincidere con un’assoluta insensatezza. Ma un giorno arriva<br />
una lettera dall’Africa: il suo bambino, per il quale tempo prima<br />
aveva distrattamente firmato l’adesione a una proposta di sostegno,<br />
lo ringraziava. Era andato a scuola ed era prossimo alla laurea,<br />
grazie a lui, a quell’uomo qualunque che si sentiva così inutile.<br />
Nicholson-Schmidt sorride, era tanto tempo che non gli riusciva,<br />
ha combinato qualcosa di buono, gli è arrivato il segno di un<br />
Senso. In molti ci possiamo ritrovare in questa storia di un sasso<br />
che diventa uomo. Il nostro partito, quello dei sostenitori a distanza<br />
dell’AVSI (che, come vedrete nelle prossime pagine, aiuta 35 mila<br />
bambini in tutto il mondo), lo ha scelto come film-culto. Chiunque<br />
può iscriversi, la tessera costa 312 euro, in cambio si ricevono<br />
due lettere all’anno e un sorriso per sempre.<br />
152
UNA SCUOLA TIRA L’ALTRA<br />
Tutto inizia nel 1988 quando un gruppo di amici italiani si<br />
ritrova nella periferia di Lagos per aiutare gli abitanti di<br />
un piccolo villaggio di pescatori immigrati in Nigeria dal<br />
vicino Benin.<br />
Vivono in capanne erette sulla sabbia e molti su palafitte. Le loro<br />
imbarcazioni sono strette e lunghe. L’etnia Egun, cui appartengono,<br />
ha una storia travagliata di continui spostamenti, nomadi sempre<br />
in fuga.<br />
I più anziani della comunità raccontano con chiarezza l’esperienza<br />
dello sradicamento dai loro villaggi da parte del governo e dei<br />
proprietari delle terre. Negli anni Trenta i loro padri erano stati costretti<br />
ad abbandonare i villaggi a causa della costruzione di un<br />
153
154
UNA SCUOLA TIRA L’ALTRA<br />
ponte che collega Lagos all’isola Victoria. Da allora un continuo<br />
peregrinare fino a questa periferia, Ikate Waterside. L’impegno,<br />
che comincia in quel periodo grazie agli sforzi del prete della locale<br />
parrocchia, è quello di rendere stabile quel precario insediamento.<br />
Si comincia dalla scuola, la Ss. Peter and Paul, che accoglie<br />
i cento bambini del villaggio dei pescatori. È una struttura informale,<br />
senza pareti, un fragile tetto appoggiato sui pali, due insegnanti<br />
qualificati e cinque traduttori. Nessuno di loro è pagato.<br />
Nel 1991, riconoscendo il valore dell’iniziativa, AVSI stanzia i primi<br />
finanziamenti e aiuta i bambini con il sostegno a distanza. Intanto<br />
le «scuoline» arrivano a quattro. È il 1996. Il sostegno a distanza<br />
consente di fornire ai bambini anche l’assistenza sanitaria,<br />
usufruendo della preziosa esperienza e vicinanza della Clinica St.<br />
Kizito di AVSI che cura principalmente la denutrizione infantile e<br />
svolge intensi programmi contro l’AIDS. È un punto di svolta. I<br />
bambini vengono seguiti uno a uno, le loro mamme coinvolte con<br />
attività per migliorare la conoscenza dell’alimentazione e dell’igiene<br />
personale e, se sieropositive, curate con programmi e farmaci<br />
ad hoc. Oggi alcuni di quei bambini sono arrivati alle scuole superiori<br />
e all’università: il sostegno a distanza si trasforma per loro in<br />
una sorta di borsa di studio.<br />
Nel 2003 viene inaugurata la nuova scuola Ss. Peter and Paul, grazie<br />
alla campagna Tende AVSI e a un finanziamento dell’Unione Europea.<br />
L’edificio accoglie gratuitamente 800 bambini ed è un punto<br />
di riferimento per tutta la zona. Ma la storia continua. Un gruppo<br />
di pescatori decide di acquistare un terreno per mettere la parola<br />
fine a quasi un secolo di peregrinazioni. Nel nuovo villaggio al di<br />
là della laguna nasce nel 2007 la scuola St. John. E si ricomincia.<br />
155
CRESCITA A TRE DIMENSIONI<br />
AVSI approda in Ecuador nel 2000, per aiutare con un<br />
progetto di sostegno a distanza le attività educative di<br />
un sacerdote italiano, don Dario Maggi, oggi vescovo<br />
ausiliare di Guayaquil, missionario in America Latina da molti<br />
anni.<br />
Il progetto comincia con le attività di educazione prescolastica<br />
di bambini provenienti da famiglie molto povere delle aree rurali<br />
della Provincia di Manabì. Si tratta di un lavoro di grande<br />
importanza dal momento che riguarda un’età decisiva, dove si<br />
compiono i primi passi per lo sviluppo completo della persona.<br />
Si pensi alla rilevanza che l’educazione prescolastica sta assumendo<br />
nel mondo e in particolare nei paesi più poveri, grazie<br />
157
ECUADOR<br />
158
ECUADOR, CRESCITA A TRE DIMENSIONI<br />
159
ECUADOR<br />
anche alle iniziative legate agli obiettivi del Millennio, e all’enfasi<br />
che l’Unesco ha iniziato a dare a questo segmento educativo.<br />
Il programma si fonda sul riconoscimento che la famiglia è il principale<br />
ambito educativo del bambino. Perciò il progetto mira a sostenere<br />
la famiglia in questo compito, affinché possa offrire le<br />
condizioni per uno sviluppo sano e integrale del bambino, intervenendo<br />
nelle tre dimensioni fondamentali della crescita (educazione,<br />
salute e nutrizione).<br />
Iniziato come «prescolar en la casa», ovvero come attenzione alla<br />
prima infanzia realizzata presso le famiglie, si è gradualmente<br />
esteso anche alla fascia di età scolare coinvolgendo oggi complessivamente<br />
oltre 1.300 bambini, ciascuno dei quali è seguito personalmente<br />
in una delle modalità in cui si articola il programma.<br />
Questi interventi educativi si attuano sia nelle aree rurali sia in<br />
quelle delle periferie urbane di Quito.<br />
Sono state rivitalizzate due scuole pubbliche rurali, dove le famiglie<br />
hanno ricominciato a portare i propri figli perché sia l'ambiente<br />
che la qualità dell'insegnamento è migliorato. Sono stati avviati<br />
una decina di asili famigliari, dove una mamma si occupa di altri<br />
5-6 bambini, permettendo alle altre mamme di lavorare ed avendo<br />
lei stessa una fonte di ricavo.<br />
È stato aperto un asilo che fa da punto di riferimento sia per le<br />
mamme che per gli altri asili della zona periurbana di Quito.<br />
È stato avviato un doposcuola per i ragazzini che dopo la fase prescolare<br />
hanno iniziato le scuole.<br />
Infine per alcuni adolescenti espulsi dal percorso scolastico formale<br />
si è avviato il reinserimento ed il recupero.<br />
Grazie al sostegno a distanza ciascun bambino è seguito in modo<br />
personalizzato.<br />
160
DENUTRIZIONE NEL MIRINO<br />
Alla fine degli anni Ottanta, un gruppo di giovani professionisti<br />
del settore sanitario inizia ad andare in favela a<br />
prendersi cura delle famiglie maggiormente a rischio. La<br />
questione della denutrizione si presenta come la più evidente ed<br />
urgente. Sorge così l’idea di un’opera che stabilmente si occupi<br />
di questi bambini. Il gruppo studia il problema e, sulla base di<br />
esperienze già svolte in Indonesia e Cile, identifica un centro in<br />
cui svolgere un «semi-internato», soluzione che permette un recupero<br />
uniforme, rapido e a un costo 10 volte inferiore rispetto<br />
a un ricovero. Quel gruppo informale di professionisti si costituisce<br />
in associazione e nel 1993 inizia un progetto per la costruzione<br />
di un Centro de recuperaçao e educaçao nutricional<br />
(CREN), il suo start-up con il contributo della campagna<br />
Tende AVSI e un finanziamento del Ministero degli<br />
esteri italiano.<br />
Da allora ad oggi l’esperienza del CREN si è confermata<br />
e ampliata: ha realizzato due ulteriori centri e<br />
decine di progetti specifici in alcune aree povere delle<br />
grandi città, ha fatto formazione in 40 asili di San<br />
Paolo, svolge formazione nei contesti in cui si presenta<br />
la piaga della denutrizione – in Perù, Haiti, Mozambico<br />
–, e formazione specialistica anche attraverso<br />
master in collaborazione con l’Università Federale<br />
di San Paolo.<br />
Nel 2004 il CREN ha preso in carico le attività che la<br />
Fondazione Parmalat stava svolgendo all’epoca della<br />
crisi a favore di bambini denutriti in un’area limitrofa<br />
a San Paolo, Hundaì. Questo anche grazie al sostegno<br />
a distanza di AVSI, che ha permesso che il CREN si potesse<br />
prender cura di circa 80 bambini.<br />
Oggi i numeri sono significativi: in un anno, il CREN visita<br />
oltre 1600 bambini, cura in semi-internato circa 150 bambini,<br />
e ne segue circa un migliaio in ambulatorio.<br />
Con il programma Vencendo a desnutriçao ha realizzato una serie di<br />
strumenti editoriali per mamme, educatori e operatori del settore<br />
socio-educativo, per fornire un metodo di affronto dell’aspetto<br />
nutrizionale.<br />
La questione chiave del metodo di lavoro riguarda la mamma o comunque<br />
la figura più prossima al bambino e il recupero della sua dignità<br />
personale. Le altre componenti riguardano il bambino e le sue<br />
relazioni. Oltre al recupero alimentare vero e proprio del bambino,<br />
si punta al rafforzamento delle sue risorse personali, psico-motorie,<br />
161
162
BRASILE, OBIETTIVO DENUTRIZIONE<br />
di apprendimento, relazionali. Si tenta inoltre di rafforzare i rapporti<br />
con gli adulti che si possono prendere cura di lui, dai parenti ai vicini,<br />
alle strutture della società civile, asili e centri educativi anzitutto.<br />
Perciò, delle varie componenti del lavoro del CREN, quella con<br />
le famiglie è forse la più delicata e determinante. Le mamme<br />
fanno anzitutto l’esperienza di qualcuno che si prende cura di<br />
loro, poi dei loro bambini, e quindi iniziano a comprendere il<br />
rapporto affettivo con i loro figli. Imparano a prendersi cura dei<br />
bambini, e, attraverso l’esperienza di essere accolte nel Centro, il<br />
valore della vita e delle cose, anche quelle della vita quotidiana: cucinare<br />
con cibi che costano poco, alimentare adeguatamente i figli,<br />
le basilari norme igenico-sanitarie.<br />
163
GLI AUTORI<br />
GABRIELLA BERLOFFA<br />
Professore di Scienze economiche e statistiche – Università degli Studi di Trento<br />
EMILIO COLOMBO<br />
Professore di Economia politica – Università dell’Insubria<br />
GIUSEPPE FOLLONI<br />
Professore di Scienze economiche e statistiche – Università degli Studi di Trento<br />
ROBERTO FONTOLAN<br />
Giornalista<br />
PIERGIORGIO LOVAGLIO<br />
Professore di Statistica – Università degli Studi di Milano-Bicocca<br />
ALBERTO PIATTI<br />
Segretario Generale di <strong>Avsi</strong><br />
LUCA PEZZI<br />
Giornalista<br />
165
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti<br />
di cooperazione allo sviluppo in 39 paesi del mondo.<br />
Oggi AVSI è presente in Africa, America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera nei settori della<br />
sanità, igiene, cura dell’infanzia in condizioni di disagio, educazione, formazione professionale, recupero delle<br />
aree marginali urbane, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed emergenza<br />
umanitaria.<br />
La sua missione è promuovere la dignità della persona attraverso attività di cooperazione allo sviluppo con<br />
particolare attenzione all’educazione, nel solco dell’insegnamento della Dottrina Sociale Cattolica.<br />
AVSI è associata alla Compagnia delle Opere Impresa Sociale, che con le sue oltre 1000 realtà non profit<br />
in tutta Italia, offre ad AVSI una grande possibilità di attingere know how per i progetti e i partner nei paesi in<br />
cui opera.<br />
AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Esteri italiano come organizzazione non governativa di<br />
cooperazione internazionale (ONG); è registrata come Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo<br />
Internazionale degli Stati Uniti (USAID); è accreditata dal 1996 presso il Consiglio Economico e Sociale delle<br />
Nazioni Unite di New York (ECOSOC); è accreditata con Status consultivo presso l’Organizzazione delle Nazioni<br />
Unite per lo Sviluppo dell’Industria di Vienna (UNIDO) e presso il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia<br />
di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle organizzazioni non governative dell’Organizzazione<br />
Internazionale dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (ILO); è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come organizzazione<br />
non lucrativa, per il 5 per mille. AVSI è anche un Ente autorizzato dalla Commissione del governo<br />
italiano per le Adozioni internazionali a curare le procedure di adozione internazionale.<br />
I suoi maggiori finanziatori sono Unione Europea, Agenzie delle Nazioni Unite, Ministero degli Esteri<br />
Italiano e istituzioni governative italiane, enti locali, aziende private e singoli cittadini.<br />
Molte storie dei protagonisti raccontate in questo libro sono state promosse e sostenute, negli anni, dalla<br />
Campagna delle Tende.<br />
Un importante gesto di carità nato nel 1990 per sostenere i primi volontari di <strong>Avsi</strong>, raccogliendo fondi e facendo<br />
conoscere il loro lavoro nel mondo a favore delle popolazioni più fragili. La «prima Tenda» era un semplice<br />
banchetto allestito fuori da un supermercato in Lombardia, ricalcando la fine degli Anni Cinquanta quando<br />
i giovani studenti guidati da don Giussani andavano nella «Bassa», la periferia povera di Milano, a portare gratuitamente<br />
attenzione e compagnia alle famiglie indigenti, senza il pretesto di trovare risposte, né realizzare<br />
azioni filantropiche, bensì imparare attraverso un gesto esemplare che la legge ultima dell’esistenza è la gratuità,<br />
la carità, contro ogni possesso egoistico.<br />
Da allora nel periodo natalizio le Tende sono diventate una campagna di sensibilizzazione e raccolta<br />
fondi realizzata grazie al coinvolgimento di una rete di oltre 12 mila sostenitori volontari, AVSI Point, in Italia e all’estero.<br />
Ogni anno viene presentato un tema specifico, con uno slogan che vuole far riflettere sulla condizione<br />
dell’essere umano nel mondo, e che detta anche la scelta di progetti che hanno particolare necessità di essere<br />
sostenuti.<br />
167
Finito di stampare nel mese di novembre 2008<br />
presso grafiche GECA
In questo volume raccontiamo una storia di sviluppo che non è fatta di numeri. Ci sono anche<br />
quelli, dai bambini aiutati dal Sostegno a distanza, alle mamme in difficoltà accolte nella casa di<br />
Novosibirsk.<br />
Troverete innanzitutto fatti, che racchiudono persone – le singole vicende di singoli nomi che vivono<br />
in luoghi geografici precisi e che tracciano una storia d’insieme – come un percorso unico<br />
capace di avvicinare le distanze dei continenti e dei decenni.<br />
(Fontolan)<br />
Negli ultimi anni, lo sviluppo è entrato nel dibattito quotidiano: la globalizzazione, le migrazioni,<br />
il terrorismo internazionale hanno forzato nella comoda vita di noi occidentali le questioni dei<br />
Paesi in via di sviluppo. Leggendo la vitalità che ribolle tra le righe delle esperienze progettuali<br />
raccolte, pare emergere qualche fattore che non si riesce a incasellare nelle tradizionali misurazioni.<br />
C’è l’avventura umana della condivisione e del desiderio, della libertà e dell’intelligenza<br />
creativa, dell’amore per l’altro e della riscoperta della dignità.<br />
(Piatti)<br />
Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto di Educazione<br />
allo sviluppo di AVSI con il contributo della Direzione Generale Cooperazione allo<br />
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano.<br />
Copia omaggio<br />
euro 18,00 (i.i.)<br />
www.guerini.it